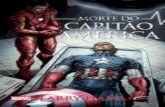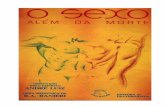Poster Session 1-La regola dell'eccezione. La morte atipica, il defunto atipico, il rito atipico.
Transcript of Poster Session 1-La regola dell'eccezione. La morte atipica, il defunto atipico, il rito atipico.
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
1
POSTER SESSION
I SESSIONE
LA REGOLA DELL’ECCEZIONE: LA MORTE ATIPICA, IL DEFUNTO ATIPICO, IL RITO ATIPICO
Susanne Moraw, Deviant or Adequate? A Case Study on a Late Antique Infant Cemetery
Located in the ruins of a deserted Roman villa in rural Umbria, there was an infant cemetery containing 47 burials of infants, from prenatal to 2-3 years, that has been termed an «abnormal cemetery» by its excavator, David Soren. The infants had been interred over a brief period about A.D. 450, as a result of a malaria epidemic. Associated with this mass grave were 13 puppies, most of them dismembered, the skeleton of a toad, and a raven’s talon. Two stones had been placed over the hands of the oldest child in the cemetery while his feet had been ‘weighed down’ by a large roof tile. The archaeological record has been interpreted as evidence of apotropaic magical practices, stimulated partly by fear of fatal disease, partly by necrophobia. By contrast, the interments of the youngest children, mostly fetuses, had the character of discards – as the excavator called it –, with almost no attention given to burial form and no significant offerings. Using this record as a starting point, the paper will address the following questions: What exactly makes a burial a «deviant» one? Is there really anything like a «normative» or «typical» burial, an identical code of ritual for all members of a given community, regardless of factors such as gender, age, social and legal status, circumstances of death, etc.? And if there are different kinds of burial in one and the same community, which one should be considered the typical one? The burial of an adult male belonging to the elite and having died a peaceful death? And all other members of the community would have been buried in deviant ways? Acting as a kind of advocatus diaboli, this paper will argue for a reconsideration of terms like «atypical death» or «deviant burial», asking if it wouldn’t be more fitting to talk about «adequate burials», i. e. adequate for a given individual and given circumstances of death. After establishing that, the kind of burial given to an individual still could be used as evidence for his or her place/status in society. English Abstract This paper argues for a paradigm shift in the approach to so called deviant burials. Refering to research from the last few years, the paper challenges the dichotomous notion of norm and deviance in burial practice. The suggestion is to replace this dichotomy in favour of the allowance of a plurality of burial norms, each norm according to specific factors like age, gender, social position, circumstances of death etc. A late Roman cemetery for children died from malaria provides the test case: The mortuary treatment found here is not deviant, but fully in accordance with Roman burial norms and attidudes. A further suggestion is to focus research not so much on assumed deviances from different periods/societies, but on the plurality of mortuary treatment in one and the same society. Keywords Late Roman Empire/Late Antiquity, child burial, malaria, witchcraft/magic, methodology, deviant burial, necrophobia. Read at: http://www.calameo.com/read/0042837473ba5094ee75b
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
2
Francesco Ghilotti, La reversibilità del non ritorno. Considerazioni su alcuni sillogismi accadici
L’Aldilà come “terra del non ritorno” è un’immagine diffusa, come ben mise in luce Martin West in The West face of Helicon (1997), tanto nelle culture di radice indoeuropea, come in quelle di radice semitica. È un immaginario che, intrecciato ad altri immaginari (la separazione, anche architettonica, la lontananza dell’Aldilà), riposa sulla concezione di una separazione (fisica e rituale) rigida, ontologica tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Questo sistema concettuale ovviamente entra in contraddizione con un altro sistema di credenze altrettanto diffuso e altrettanto radicato: quello della reciproca influenza tra i due mondi. I confini tra “aldiquà” e “aldilà” sono al contempo rigidi e porosi, e in un certo senso non stupisce che la “strada senza ritorno” sia affollata, per riprendere un’ironica immagine di Jean Bottéro (1980) da un perpetuo va-et-vient di morti. Nella discussione ci si focalizzerà sul mondo accadico (in minor misura verranno considerate le fonti in lingua sumerica) mettendo brevemente in luce la dialettica rigidità/porosità dei confini tra mondo dei vivi e mondo dei morti (dialettica che emerge, a livello cosmologico, dallo stesso conflitto centrale della struttura mitica del Nergal e Ereškigal), verranno messe in luce le radici di questa dialettica (si accennerà al processo di “verticalizzazione” dell’Aldilà, avvenuto a cavallo del III e del II millennio, precedentemente localizzato in un’alterità puramente geografica) e infine verrà esaminato con attenzione l’immaginario del “ritorno dei morti”. Si analizzeranno le “regole” di questa eccezione (e alcune eccezioni di questa regola), mostrando chi tornava, perché, e a quali condizioni. Si affronterà l’atipicità per eccellenza, gli “spiriti erranti” (eṭemmu murtappidu / muttaqqisu) e la loro condizione liminale e pericolosa, derivante da un non corretto mantenimento del complesso wide web of obligations instaurato tra morti e vivi (IN PARTICOLARE l’assenza o la distruzione della sepoltura). Si discuterà dell’immagine dell’aiuto o “invito” del defunto dall’esterno (da parte umana o divina). L’atipico viaggio post mortem bidirezionale verrà letto infine attraverso la chiave di lettura del rito di passaggio, ossia prestando attenzione alle modificazioni dello status del defunto. Attraverso questa prospettiva sarà possibile mettere in luce diversi aspetti della dialettica tipicità/atipicità del defunto nelle credenze funerarie mesopotamiche. Nel fluido e poco sistematizzato insieme di credenze riguardanti il post mortem, tuttavia, un elemento rimane (quasi sempre) stabile: dal punto di vista rituale, la “terra dei morti” (Erṣetu mītūti) è a tutti gli effetti una terra “senza ritorno”. Se lo spirito può tornare in superficie, il cambiamento di status è definitivo e irreversibile. Dalla vita, secondo un percorso ritualmente ben strutturato, si passa alla morte, ma non viceversa: tra i due fiumi era totalmente assente, almeno fino al periodo medio assiro, qualsiasi lettura ciclica o escatologica del post mortem. English Abstract In this article I will analyze an (apparent?) paradox regarding the Akkadian post mortem: the figure of him who comes back from the Land of No Return. To explore this figure, its rules and its exceptions, I will discuss in particular two central aspects in Mesopotamian religious beliefs: the dialectic rigidity / porosity of the boundaries between the world of the dead and world of the living, and the conception of the irreversibility of the (rite of passage of) death. Keywords Land of No-Return, Akkadian Religion, Mesopotamian Religion, Chthonic Passages, Liminal Figures. Read at: http://www.calameo.com/read/004283747270fa2929962
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
3
Reine-Marie Bérard, Wartime Mass Graves in the Ancient Greek World: History, Archaeology and Anthropology Within the framework of the first session of the congress, I would like to submit a paper on wartime graves, and in particular wartime mass graves in the Ancient Greek World. Wars are indeed remarkable events, not only from a historical point of view but also from an archaeological one, in so much as theygreatly affect territories and causehigh number of deaths – and thus produce numerous graves that can be considered atypical compared to peacetime burials. Wartime funerary practices are indeed exceptional in two ways. Firstly, because of the unusually high number of corpses (most of them being young men aged between 20 and 40)to be taken care of in a very short period of time, which demands a quick and effective reaction from the community. Secondly because soldiers’ funerals are often taken care of not by thefamilies – as it is usually the rule – but by military or political authorities, embodying the community as a whole in order to strengthen its feeling of unity in front of a massive threat. War graves are thus atypical both from a material and a symbolic point of view and deserve a peculiar attention, especially in the troubled Ancient Greek World. Many sources can be used to study war graves in the Archaic and Classical Greek world: from the great Homeric poems to the famous funeral orations such as the one Pericles delivered for the soldiers killed during the first year of the Peloponnesian War, numerous literary and historical sources indeed discuss wartime funerary rites and burials. Wartime funerary monuments have also been studied, but mostly for themselves, by epigraphists or specialists of funerary architecture. Last but not least, various archaeological excavations (for example in Athens, Pydna, Paros, or lately Himere) have brought to light wartime mass graves for which biological and taphonomic data, drawn from anthropological analyses, are available, giving a precise and precious insight into the reality of ancient war and wartime death. By combining all these data that are still too often examined separately, we thus plan to establish the main characteristics of wartime mass graves in the Ancient Greek World, and examine their symbolic significance by evaluating the role of the community in their setting up and taking care of. This analyse will benefit from the great movement for an Archaeology of War and Violence that has developed recently, notably on the occasion of the commemoration of the First World War Centenary (1914-2014); various studies on battlefield archaeology and the psychology of wartime burial practices in general will be used to shed a new light on the perception of wartime death and burial in the Ancient Greek World. English Abstract Wartime funerary practices are exceptional in two ways: firstly because of the unusually high number of dead to deal with and secondly because of the tension that exists between the private event of death and the public dimension of war. In this poster, we propose some methodological tracks to study and analyse wartime mass graves in the Ancient Greek worldin order to apprehend their causes and possible meanings. By crossing material characteristics and causal criteria and by taking into consideration the chronological, social and political context each mass grave belongs to, we try to evaluate the possible symbolical and political uses of wartime mass grave in the Ancient Greek World, inside and outside Attic. Keywords Ancient Greece, mass graves, warfare, funerary practices, soldiers’ graves. Read at: http://www.calameo.com/read/0042837476b230d4b59dc
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
4
Victoria Russeva, Thracian pits with human remains Material
The archaeological investigations in Bulgaria present cases of human remains, deposited in pits, which, after their construction, resemble pits, used in the everyday life with wide spectrum of functions: from garbage containers to storage places. Such are connected both, to the sacral and profane uses, but burial pits (graves), known from studied periods.These appear first in the late Neolithic period, but show highest concentration in the Iron Age monuments, being part from so called fields with ritual pits for which no clear profane function could be proposed. These complexes remain explicable with the orphic myths of interaction between the worlds of the physically defined space of life and un-definable place of after-death/before life, in the dialectics of the metaphysic existence of matter, which passes throw the border between life and death, equally in both directions, after satisfying specific conditions. Human remains in these pits are rare but constant find. This study concentrates on the complexes investigated on field, the earliest dated in the last phase of the early Iron Age by Svilengrad, VIII-VIc. BC. Other two complexes from Thrace come from the classical period from the site near Malko Tranovo, dated in theV c. BC and the latest complex from the area of South East Bulgaria by Kapitan Andreevo. From North Bulgaria are studied two close standing sites, studied in the area of the quarter Makaque of Shoumen. These still remain with no clear dating, but again are broadly attributed to the Late Iron Age.
Results and Discussion
Highest number of pits containing human remains, are registered in the field of pits by Svilengrad, where in 18 pits are found human skeletal fragments. In Malko Tranovo human remains are registered in four pits (three investigated in the present study). The rest of presented sites provide occasional pits with human remains. In the earliest complex, pits, which contain human remains are generally divided into two groups after presentation of the human skeleton – one, with relatively completely presented skeletons, approximately in situation of anatomical position and second, with singular fragments from human skeleton. The first group isn’t homologous as concerns to the age group of found individuals, but presents mostly skeletons of children, most of them at the age of newborns, with exceptions of adults. The second group consists only with fragments from grown-up individuals. The pits from the site from the classical period contain mostly skeletons from sub-adults - children, but in difference to the younger site – with no newborns. For this site as main characteristic appears incompleteness of skeletons, being disturbed with some parts remaining on place, in anatomical position, some being found disturbed in the pit and other totally missing. The rest of the studied sites present relatively complete skeletons of young adults and adults in anatomical position. Here is found a variety of positions, some pointing to neglecting of dead body, or even punishment actions on the dead body or living person.
Conclusion
The possibility that the territory of pithfields could have had a significance of place for storage of deaths of special social status, given to them by birth (including newborns) arises after the analysis of anthropological material in its archaeological context. After some period of time, in which the soft tissues got decomposed some of placed individuals could have been taken away in which procedure only small singular fragments could have remained on place. It appears that the smallest children (newborns) weren’t subjected to this action. The rituals could be reconstructed as a complex of purification of dead body to resurrection of the member of special meaning for the society with collecting of un-decayed bones. With time the territory of the fields of pits could have preserved the meaning of a purification space, used for remains of special dead, who could have
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
5
encountered death in un-natural circumstances, including wide range of possibilities from human sacrifice to crime and dead penalty and could have had a dangerous influence to the world of living society. English Abstract Highest number of pits containing human remains, are registered in the field of pits by Svilengrad. In Malko Tranovo human remains are registered in lower number. The rest of presented sites provide occasional pits with human remains. In the earliest complex, pits, which contain human remains are generally divided into two groups – one, with relatively completely presented skeletons, approximately in situation of anatomical position and second, with singular fragments from human skeleton. The first group isn’t homologous as concerns to the age group of found individuals, but presents mostly skeletons of children, most of them at the age of newborns. The second group consists only with fragments from grown-up individuals. The pits from the site from the classical period contain mostly skeletons from sub-adults with no newborns. For the latter site as main characteristic appears incompleteness of skeletons, being disturbed with some parts remaining on place, in anatomical position, some being found disturbed in the pit and other totally missing. The rest of the studied sites present relatively complete skeletons of young adults and adults in anatomical position. A variety of positions has been confirmed, some pointing to neglecting of dead body. Keywords Pits, Thracian tribes, human remains. Read at: http://www.calameo.com/read/0042837477150531e933b Llorenç Alapont, Stephen Kay, Rosa Albiach, I fuggiaschi della necropoli di Porta Nola. Progetto di indagine: archeologia della morte a Pompei All’esterno di Porta di Nola a Pompei si trova una zona sepolcrale delimitata da un recinto funerario con un ingresso. Per prima è una tomba a schola semicircolare, realizzata in tufo di Nocera, con le estremità terminanti a zampa di leone alato. Al centro dell’emiciclo, su alto podio, è una colonna ionica terminante con una loutrophoros marmorea con intorno tridenti in ferro per impedire la nidificazione degli uccelli. La tomba, come si legge dall’epigrafe, è dedicata da N. Herennins Celsus alla moglie ventiduenne A. Aesquillia Polla. Accanto alla tomba di Aesquillia Polla è localizzata un’area sepolcrale anonima. Più avanti, scoperta e scavata solo nel 1976 (De Caro 1979) è la tomba a recinto di forma quadrangolare dell’edile e duoviro M. Obellius Firmus, una delle figure più potenti degli ultimi decenni di Pompei: all’interno del recinto furono scoperti una stele, il foro per le libagioni, l’urna di vetro per le ceneri, alcuni resti del rogo. Accanto alle tombe monumentali bisogna menzionare il rinvenimento di un’area sepolcrale anonima e alcune umili sepolture segnalate da semplici iscrizioni sul muro di cinta (Senatore 1999), un tipo di sepoltura attestata a Pompei solo nella necropoli fuori Porta Nola. Lungo la scarpata delle mura quattro cippi segnalavano la deposizione dei resti di alcuni pretoriani. Nello scavo del 1976-1978 (De Caro 1979) furono, infine, trovati 15 cadaveri di fuggitivi nel fango dell’eruzione del 79 d.C. di cui è stato possibile fare il calco. L’analisi antropologica dei questi calchi, l’osservazione della loro gestualità, dell’aspetto e della posizione ci fornisce informazioni eccezionali di ciò che accadde negli ultimi istanti di Pompei e in che modo e perché morirono i suoi sfortunati abitanti. Grazie allo studio dei calchi possiamo
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
6
avvicinarci alla mentalità, alle decisioni e alle azioni che intrapresero gli abitanti nel corso di quegli eventi drammatici, è inoltre possibile capire come affrontarono il momento critico dell’eruzione e scoprire ciò che realmente accadde negli ultimi istanti della loro vita. Inoltre, i calchi sono,di fatto l’involucro in gesso dei resti umani di queste persone, quindi si tratta di un rivestimento che ha protetto e conservato gli scheletri e i componenti ossei di coloro che sono vissuti e morti a Pompei. Pertanto i calchi conservano al loro interno una grande fonte di informazioni circa l’aspetto, la condizione fisica, tipo di attività svolta e malattie degli individui contenuti al loro interno. Dunque l’analisi antropologica, paleopatologica e radiologica dei calchi ci fornisce dati eccezionali sulle modalità e le condizioni in cui vivevano gli abitanti di Pompei. Per tale ragione la nostra analisi, la prima realizzata sui resti conservati all’interno dei calchi di Pompei, fa emergere informazioni essenziali per interpretare la società pompeiana e rappresenta una rivalorizzazione dei calchi, aggiungendo al suo valore attuale importanza sia per quel concerne la ricerca archeologica che quella antropologica. Nel contributo si presenta la prima fase dello studio antropologico e paleopatologico dei calchi di Porta Nola a partire dalla registrazione e dall’osservazione minuziosa dell’aspetto e delle caratteristiche esterne visibili. In questo modo si effettua un esame metrico, quantitativo, morfologico e patologico delle componenti anatomiche di ciascun individuo. Con i dati desunti ci si prefigge di ricostruire il corpo, di stimare sesso ed età, le caratteristiche morfologiche e la prossimità biologica, di determinare le patologie ossee e dentali. Il nostro studio analizza anche il modus vivendi esaminando i segni dello stress posturale derivati dall’esercizio di una determinata attività fisica e le patologie sofferte sia a causa dell’attività fisica che in conseguenza di puntuali eventi traumatici o infezioni. Infine, dall’analisi di tutti i dati ottenuti, si può determinare quali furono le cause e le circostanze che portarono alla morte il soggetto. English Abstract The Pompeii Project: Porta Nola was established in 2014 with the aim of better understanding the necropolis of Porta Nola, through an examination of the numerous different types of burial. The necropolis offers an exceptional opportunity to study the population of Pompeii, as well as more broadly wider trends in the Roman population. An initial study season focused on the 15 casts of the fugitives from the necropolis at Porta Nola excavated by Di Caro (1979), which will combine with a wider project directed by the Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia for the conservation and presentation of all of the casts from Pompeii. The project began by defining a methodology for studying the casts, which contain within them a rich source of information regarding the characteristics of the individual, such as their physical condition, diet, illnesses and types of activities undertaken. Keywords Pompeii, Porta Nola, casts, x-ray, laser scan Read at: http://www.calameo.com/read/00428374722d55d3dfb74
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
7
Paola Pagano, La morte atipica attraverso le testimonianze epigrafiche del mondo romano Discite: dum vivo, morsinimica venit Questo breve componimento graffito da un anonimo “poeta di strada” su un muro della città di Pompei esprime, in modo incisivo ed emblematico, il pensiero dell’uomo romano dinanzi alla morte. Con questa consapevolezza si cercava di assaporare il tempo concesso e si tentava di lasciare traccia e memoria di sé prima di abbandonare per sempre il mondo dei vivi. Obiettivo principale della presente ricerca sarà indagare, attraverso lo studio delle testimonianze epigrafiche del mondo romano,quei casi di morte improvvisa, violenta, atipica per l’appunto, che gli antichi hanno deciso di eternare sulla pietra. Il criterio con il quale saranno trattati questi documenti non sarà cronologico o geografico, ma tematico. Sarà sufficiente ricordare alcuni di questi defunti e la loro sorte avversa per comprendere come le iscrizioni comunichino al lettore, di ieri e di oggi, tutta la loro carica emotiva: è il caso del pittore Hermas (II sec. d.C.) morto cadendo dall’impalcatura durante la realizzazione di un mosaico di Aulus Iunius Faustus (I sec. a.C.)deceduto per mano della propria mater impia scelerata. Sono tante le testimonianze di vite brutalmente interrotte come ricorda la stele funeraria del piccolo delicatus Festius (I-II sec. d.C.), prematuramente scomparso cadendo in un pozzo e, ancora, il caso di Prima Florentia (II sec. d.C.), ab Orfeu marito in Tiberi decepta est, vittima di violenza domestica e della piaga del femminicidio. La coscienza sociale affrontava con timore le morti improvvise proprio perché inaspettate e quindi in aperto contrasto con lo scorrere quotidiano degli eventi. Su queste anime restavano impressi in modo indelebile i segni di una fine repentina e violenta, la cui ingiustizia rendeva i morti anzitempo, specie se giovani, particolarmente temibili, in quanto insoddisfatti e assetati di vendetta. In casi come questi, i parenti dei defunti non affidavano il ricordo dei cari estinti limitandosi a farne incidere il nome su una “fredda lastra di marmo”, ma desideravano render loro una parvenza di giustizia proclamando nel testo funerario l’iniquità della sorte. Le espressioni di dolore e di rimpianto, oltre a onorare il defunto, sembravano dunque, rappresentare una misura di difesa per i vivi poiché i morti prematuri, se non si sentivano sufficientemente rimpianti, potevano diventare un reale pericolo. I nomi delle persone sopra ricordati, con le disgrazie a loro legate, sono presi in considerazione in quanto emblema di una realtà epigrafica ben più ampia dalla quale emergono diverse categorie di morti: 1- Sul lavoro. 2- Causate da omicidi (compiuti da barbari, latrones o altri). 3- Legati ai soprusi domestici (sia quelli inerenti l’ambito matrimoniale, sia quelli relativi il nucleo familiare in senso stretto). 4- Autoindotte (suicidi), considerate come atti di violenza contro se stessi. 5- Causate dalla figura del medicus. 6- Provocate dalle maledizioni e dai sortilegi (defixiones e devotiones). 7- Dovute alla forza incontrastabile della natura. 8- Provocate da imprevedibili incidenti. Come le morti ritenute “normali”, anche quelle avvenute in maniera insolita, improvvisa o tragica, che avevano sicuramente lasciato tracce durature nella memoria collettiva, sono di norma mimetizzate entro formule convenzionali; in altri punti, invece, le iscrizioni tendono soprattutto a rendere giustizia al defunto e ad acquietare la sua anima interrotta e sconvolta da una fine inaspettata: in caso contrario ci sarebbe stato il rischio di un regolamento di conti tra il defunto e il parente in vita che avrebbe dovuto rendergli onore nell’epitaffio.
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
8
La fine cruenta di un individuo doveva essere inevitabilmente ricordata utilizzando un formulario specifico, proprio perché funzionale al dovere del dedicante, attraverso l’adozione di verbi e di terminologie costanti e insostituibili, quali: • interficere; • deficere; • occidere; • occidere/interficere/deficere/perire (spesso utilizzati in riferimento alla vittima e quindi al suo ruolo passivo e alla sua soccombenza). L’intervento sulle morti atipiche verterà, dunque, su alcune delle tipologie di decessi ritenuti violenti dalla società del passato; si cercherà, nello specifico, di porre in evidenza come l’uomo romano si relazionasse ad essi ricorrendo al messaggio scritto, affrontando al tempo stesso problematiche comuni tanto ai nostri predecessori quanto alla società contemporanea. English Abstract What about the violent deaths in the roman society? We can find a great number of statements in the Latin and funerary inscriptions. First of all, these epigraphies use particular languages to mystify the horrible end of their loved ones. It seems that the expressions of sorrow and regret featured on this kind of inscriptions not only honored the deceased, but also represent a measure of protection for the living from those who passed away: if they did not feel sufficiently regretted, they could become a real danger, and there would be the risk of a settling of scores between the deceased and those who survived, that were supposed to honor them in their epitaphs. Keywords Violent death, Latin inscriptions, fireman in ancient Rome, interfectus a latronibus, ScerviaedusSitus, Prima Florentia, in Tiberideceptaest, TelesinaCrispinilla, vivere abominavit, delicates Festius, putei detulit, Euhelpistus Manes, medici secarunt, Ursinio Filio naufragio obito. Read at: http://www.calameo.com/read/00428374786486cec78c3 Cecilia Rossi, Alessandro Canci, Una “sepoltura” atipica in contesto rurale di età tardo-romana: l’inumazione in procubitus di Massaùa di Villabartolomea (Verona). Dall’analisi interdisciplinare all’interpretazione della devianza Nella maggior parte delle popolazioni, sia antiche che moderne, il seppellimento in procubitus non corrisponde alla norma ed è convinzione sempre più condivisa che la sua adozione non sia frutto di una tumulazione affrettata (fatta eccezione per i casi legati a epidemie in atto), bensì di una scelta ben ponderata: l’intenzionalità del gesto traspare spesso dalla stessa giacitura del corpo, talora composto in maniera ordinata e accompagnato da elementi di corredo, talaltra costretto all’interno della tomba con vari espedienti di legatura e coercizione, in parte connessi alle contingenze del decesso, in parte rivolti a prevenire in modo scaramantico un eventuale ritorno sulla terra. Questo contributo si inserisce nel filone di ricerca volto a far luce sui risvolti semantici e sui meccanismi ideologici alla base delle deposizioni prone, facendo leva su un approccio interdisciplinare, basato sulla ricostruzione del contesto archeologico di contorno e su uno studio puntuale dei resti scheletrici, dal dato tafonomico all’analisi antropologica. Il lavoro nasce dalla “ri-scoperta” di un contesto sepolcrale inedito di età medio-tardo imperiale, portato alla luce negli anni ‘70 nelle Valli Grandi Veronesi, il tratto di Pianura Padana compreso tra Adige, Tartaro e Po, in età romana diviso tra i municipia di Este e Verona. Il nucleo di deposizioni faceva capo a un complesso rustico e si componeva di inumazioni semplici sul piano strutturale, con
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
9
corredo assente o minimale. L’analisi dei reperti scheletrici restituisce l’immagine di un gruppo sociale sicuramente non benestante, verosimilmente fittavoli, di estrazione libera o servile, dediti ad attività lavorative logoranti e costretti a vivere di una dieta povera e in condizioni d’igiene molto precaria. Una sepoltura spiccava tra le altre per la giacitura non convenzionale dello scheletro, deposto in procubitus, con le mani legate dietro la schiena e gli arti inferiori appaiati in maniera innaturale, a suggerire qualche ulteriore costrizione. Si tratta di un’inumazione primaria in piena terra con fossa stretta e appena sufficiente a contenere l’individuo: un giovane di sesso maschile, di corporatura robusta e muscolosa, morto per cause poco chiare, verosimilmente improvvise e non legate a un collasso strutturale. La presenza di tale deposizione, unita all’interesse suscitato dalle particolarità paleo-patologiche riscontrate sui resti, ha fornito lo spunto per uno studio più ampio, teso a inquadrare il ritrovamento in rapporto alle vicende storiche e alle dinamiche di popolamento che segnarono l’agro a sud di Verona tra il III e il IV secolo d.C. Il contributo è il punto di arrivo di questa ricerca, impostata sul dialogo tra fonti archeologiche e dati antropologici, con l’obiettivo di aggiungere un nuovo tassello alla comprensione delle pratiche di seppellimento deviante, partendo dall’individuo, dal suo rango socio-economico e dalle possibili cause di morte. English Abstract This paper is aimed to foster the debate on the meaning of face-down burials in Antiquity, presenting a case-study coming from a mid/late roman context of North-Eastern Italy. Discovered in the ‘70s in the land south of Verona, this non-conventional burial was part of a rural cemetery, consisted of simple inhumations, for the most part without grave-goods. The bio-archaeological analysis highlighted the presence of a humble social group, hard working and malnourished. The deviant burial was placed among the others. It consisted of a narrow pit, containing the skeletal of a young man, set down in procubitus, with hands tied behind the back and legs unusually paired. Several marks of mistreatment were recognized on his bones and this evidence may lead to identify the subject as a slave. Keywords Procubitus, Late Antiquity, Rural context, Northern Italy, Slavery Read at: http://www.calameo.com/read/0042837477fe36ed7fd0d Alessandra Guari, Sepolture anomale nelle tombe del BA I-III di Tell es-Sultan/Gerico (scavi J. Garstang) La letteratura scientifica inerente i contesti funerari del Levante, si è limitata a una descrizione superficiale delle sepolture senza procedere nello specifico a un’analisi dettagliata dei resti osteologici, fondamentale per la comprensione e l’interpretazione dei rituali funerari. In questo contributo si vogliono analizzare in particolar modo le tombe di Gerico scavate dalla prima missione inglese condotta da J. Garstang dal 1930-al 1936. L’importanza di questa necropoli deriva soprattutto, dall’estensione cronologica e dalla continuità delle sequenze stratigrafiche che vanno dall’inizio dell’urbanizzazione in Palestina fino al Bronzo Tardo. Sono state analizzate le fasi del Bronzo Antico, estremamente importanti per comprendere la struttura economica, sociale e ideologica connessa con il fenomeno della sedentarizzazione. L’interesse risiede anche nell’impiego coincidente con la prima esperienza urbana gerichiota che è ben visibile nella necropoli ed è
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
10
testimoniata dal passaggio dalla sepoltura secondaria a quella primaria, questo a conferma della sedentarizzazione, a partire dal Bronzo Antico IB, degli abitanti di Gerico.Le sepolture primarie prese in esame si distinguono per la singolare posizione fatta assumere al defunto, al momento della deposizione e in alcuni casi anche per il corredo funerario ad esso associato. Si tratta di sepolture provenienti dalla grande tomba A e dalla tomba 351; ognuna delle quali è caratterizzata da un’anomalìa che non trova immediati confronti nel territorio palestinese. La metodologia adottata parte dall’analisi dei diari di scavo e di tutta la documentazione edita e inedita e una rielaborazione grafica delle piante originali. L’obiettivo finale è comprendere la simbologia che sta dietro al gesto intenzionale per poter così intuire il pensiero religioso che ha portato al singolare trattamento del defunto. English Abstract The excavations undertaken during the 1930s by J. Garstang in the EBA necropolis of Jericho, revealed three examples of deviant burials. The most famous is represented by Tomb A, by the male deposition 24. Its deviant character is underlined by both the position and the finding: his body was outstretched, with raised arms and flexed legs and a mace head. This association suggest the lineage of chief. Another outstanding revealed deviant burial, the deposition 17, face down, it is strange that this individual was buried in the Tomb A rather than in an isolated view of the negative connotation given to him for burial. Unfortunately neglected by archaeologists until now, is another tomb, 351, characterized by the presence of the cranium of a male individual, surrounded by five female craniums. Keywords Ancient Near East, Deviant Burials, South Levant, Jericho/Tell es-Sultan, Bronze Age
Read at: http://www.calameo.com/read/004283747fc7527bffd63 Ian Gonzalez Alaña, La «défunte aux entraves»: les rites nécrophobiques et l’approche systémique des pratiques funéraires et mortuaires liées aux tombes hors norme La découverte en juin 2004 d’une sépulture exceptionnelle de la fin de l’Âge du Fer dans le site du Vallon du Fou, près de Martigues (Bouches-du-Rhône, France),et comprenant une défunte portant encore des entraves en place, a constitué une découverte d’autant plus inespérée qu’elle était peu conventionnelle. En effet, les cas d’entraves retrouvées in situ constituent des découvertes rares dans la Protohistoire française, et n’ont été retrouvées qu’en quantité infime jusqu’à aujourd’hui. D’autres éléments ont aussi troublé les fouilleurs lors de la découverte de la sépulture. En effet, celle-ci se trouvait très isolée par rapport aux nécropoles environnantes, situées de part et d’autre à des distances non négligeables. Ce fait, mais aussi le fait que la sépulture ne possédait, mis à part les entraves, d’autre mobilier funéraire associé, a fait conclure les chercheurs, une fois la tombe étudiée, qu’ils’agissait d’un très rare exemple de tombe d’esclave. Mais de nombreux éléments montrent que la thèse de la tombe d’esclave, même judicieuse, nepeut pas totalement expliquer la présence d’entraves in situ. D’un côté, le cas est trop rare dans cette sphère chrono culturelle. Si un nombre non négligeable d’entraves ont été trouvées en contexte de fouille, seuls quelques rares exemples ont été trouvés directement sur le cadavre, comme dans le cas qui nous occupe ici, mais aussi dans d’autres cas plus récents comme celui de Saintes (Charente-Maritime, France) où certains individus ont été retrouvés entravés. Un autre élément troublant et non des moindres, c’est l’apparente relégation de la sépulture, et le fait que le cadavre ait été inhumé sans d’autre mobilier.
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
11
Ainsi, dans une réinterprétation de la tombe de Martigues, nous allons observer, au-delà des raisons purement utilitaires des gestes funéraires, une approche systémique des gestes funéraires. En effet, ceux-ci peuvent faire partie d’un système bien plus complexe, à la fois de gestes et de pensées. C’est dans ce sens que nous proposons une approche théorique renouvelée pour interpréter les pratiques funéraires de la sépulture du Vallon du Fou: la thèse du rite nécrophobique. English Abstract The discovery of a deviant burial in the Vallon du Fou (France) was considered a very particular one. The tomb was found in a desolated area in relation to the burial sites in the surroundings. The sepulture had no funerary artifacts inside it, other than an ankle chain that was found in situ. The past studies on this particular case concluded that the tomb showed signs of servitude. Although the general idea can be true, it’s impossible to fully demonstrate the servitude thesis. This case is too rare to be explained as a general example of a particular servile mortuary practice. How can be explained the presence of chains on a dead body? Therefore, we present in this article a hole new approach to the study of this particular burial, that can explain all the missing points that remain on this particular sepulture: the necrophobic rite thesis. Keywords Necrophobia, chains, tomb, slave Read at: http://www.calameo.com/read/0042837471cc3aff9102b Chiara Pilo, Un possibile “iettatore” nella necropoli di Mitza de Siddi ad Ortacesus (CA) in Sardegna La necropoli di Mitza de Siddi si trova nella regione storica della Trexenta, nella Sardegna centro-meridionale. Pertinente a uno degli insediamenti rurali che caratterizzano in età punica e romana quest’area del territorio isolano a vocazione prevalentemente agricola, il sepolcreto presenta una continuità d’uso almeno dal III sec. a.C. fino alla tarda età imperiale. Le tipologie funerarie sono quelle tipiche del contesto sardo in questo ampio arco cronologico: tombe a fossa, incinerazioni, ustrina, tombe “alla cappuccina”. Assolutamente anomala per trattamento del cadavere risulta la sepoltura indicata dagli scavatori come 36 bis. Si tratta di una piccola tomba a fossa scavata nel banco roccioso in cui è stato inumato un individuo di sesso maschile deceduto all’età di 50-60 anni. La parte superiore dello scheletro era adagiata nel fondo della fossa in posizione supina, con la testa fortemente girata di lato, verso sinistra, e le mani posizionate sul collo, come a stringere la gola. La parte inferiore del corpo era stata staccata all’altezza della vita e collocata esattamente sopra la testa e il busto. Al momento della scoperta gli archeologi avevano avanzato la possibilità che la tomba fosse stata intercettata durante la realizzazione di un’altra sepoltura a fossa, collocata a una profondità maggiore e datata sulla base del corredo al periodo tardo-punico. A seguito dello scasso gli arti inferiori sarebbero stati spostati e accatastati sopra il rispettivo busto. A seguito della revisione della documentazione di scavo non è da escludere invece che sia stata la sepoltura “anomala” in questione a intaccare parzialmente il riempimento della tomba punica e che quindi debba essere cronologicamente collocata in un periodo posteriore. Significativa, oltre che per alcuni aspetti inquietante, è soprattutto la singolare posizione delle mani del defunto, poste nell’atto di afferrarsi la gola, un gesto che dalle fonti letterarie e iconografiche sappiamo essere proprio di chi è colpito da malocchio. Lo phthonos– o fascinum in latino – prende innanzitutto alla gola, come ben esplicitato del testo epigrafico a corredo della scena figurata che
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
12
decora il celebre mosaico di Skala a Cefalonia, dove un giovane emaciato si stringe la gola mentre è assalito da belve feroci. La stessa posa ritorna su alcune statuette che riproducono personaggi itifallici, emaciati e ingobbiti. Se la lettura tafonomica coglie nel segno, siamo in presenza di un personaggio ritenuto uno iettatore dalla comunità in cui vive, una persona che soprattutto attraverso il contatto visivo – e non sarebbe casuale la posizione della testa fortemente piegata di lato – trasferisce sul prossimo la sventura e che quindi, anche nei rituali di sepoltura, è necessario separare nettamente dal resto della comunità e trattare con rituali particolari che ne inibiscano i poteri nefasti. English Abstract Focus of this study is a deviant burial found in the Punic-Roman necropolis of Mitza de Siddi at Ortacesus, near Cagliari, in Sardinia. The lower part of the skeletal remains were buried over the upper part, the head was completely turned to the left and the hands were clutched to the throat. Beyond a general fear of the dead, the comparison with iconographic and literary sources seems to connect the abnormal gesture of the deceased to the evil eye. Keywords Sardinia, Punic-Roman necropolis, deviant burial, evil eye. Read at: http://www.calameo.com/read/004283747c575a330e680 Flavio Enei, Sepolture anomale nel cimitero della chiesa paleocristiana di Santa Severa: nuovi dati sui rituali sepolcrali della popolazione medievale del litorale ceretano La comunicazione intende presentare i risultati degli studi archeologici e antropologici effettuati in seguito agli scavi svolti nel Castello di Santa Severa tra il 2007 e il 2010 durante i lavori di ristrutturazione del complesso monumentale, sorto nel medioevo sui resti della città etrusca e romana di Pyrgi. Tali interventi, curati dal Museo Civico di Santa Marinella con i volontari del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite con la supervisione della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, hanno portato all’esplorazione di una complessa stratigrafia comprendente i resti della chiesa paleocristiana di Santa Severa con il suo cimitero, esplorato per circa 1.500 mq di superficie. Lo scavo nel cimitero della chiesa paleocristiana di Santa Severa ha permesso di riconoscere la presenza di diversi livelli di sepolture che dall’alto medioevo arrivano fino al XIV secolo sovrapponendosi le une alle altre, tagliando le più antiche, all’interno di un deposito di terra che in alcuni punti raggiunge oltre 1,50 m di spessore. La parte di cimitero scavata risulta composta da inumazioni in fosse terragne e in sarcofagi costruiti in lastre di tufo, studiate dai ricercatori del Centro di Antropologia molecolare per lo studio del DNA Antico, Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, per un totale di almeno 455 individui di diversa età, maschi e femmine, adulti e bambini. Le tombe presentano individui deposti con le braccia incrociate sull’addome e forse, soprattutto le donne, con una mano appoggiata sul seno e l’altra sul pube. Ad eccezione di tre sepolture infantili,non sono stati trovati oggetti associati con certezza ai defunti che si rivelano sepolti completamente nudi, con ogni probabilità avvolti in un semplice sudario, quasi tutti rivolti a Est, in alcuni casi inumati con la testa protetta da piccole lastre di pietra, tegole o laterizi di recupero. Si segnala un giovane uomo con le mani appoggiate sul viso, la deposizione di crani isolati ai piedi o presso la testa di scheletri completi e l’attestazione di numerosi piccoli mucchi di ossa scomposte, rinvenuti vicino gli scheletri in connessione: potrebbe trattarsi di ossari creati per conservare in qualche modo i resti
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
13
delle sepolture più antiche che vengono disturbate nel momento in cui si effettuano nuove deposizioni. Molte delle tombe intaccano direttamente le strutture romane tagliando parti delle fosse proprio nel cementizio dei muri in opera reticolata e laterizia. Anche un forno altomedievale viene tagliato dalla fossa di deposizione di un giovane e dallo scavo per il posizionamento di un grande sarcofago che ad oggi risulta essere la sepoltura più importante dell’intero cimitero. Il sarcofago in pietra, lungo quasi 2 metri, è formato da quattro lastre laterali e una di fondo e da coperchio monolitico, liscio, a doppio spiovente; all’interno, sul lato corto superiore, presenta una croce scolpita a rilievo e un ampio poggiatesta anch’esso scolpito direttamente nella pietra della lastra. Al momento della scoperta risultava ben chiuso, con il coperchio spostato solo di pochi centimetri rispetto alla posizione originaria. Lo scavo del riempimento presente all’interno ha permesso di riconoscere un deposito formato lentamente nel corso del tempo dall’infiltrazione di acqua, sabbia, limo e piccoli gusci di molluschi terrestri attraverso le strette fessure di connessione esistenti tra le varie lastre. Di grande interesse il risultato delle analisi del terreno nel corso delle quali sono è stata rilevata la presenza di numerose fibre tessili di colore bianco e nero. Nel sarcofago è stato rinvenuto lo scheletro di un individuo adulto di sesso maschile, di circa 60 anni, riverso in una posizione innaturale e scomposta: una deposizione anomala dovuta a una forma di punizione in seguito a condanna, a una morte apparente o a un’antica manomissione della sepoltura per possibili fini di spoglio avvenuta subito dopo la chiusura del feretro. Di notevole interesse lo studio del sarcofago ben inquadrabile in una tipologia di VIII-IX secolo che viene ulteriormente confermata dalla datazione al radiocarbonio dei resti dell’inumato vissuto in un periodo compreso tra il 680 e l’890 d.C. A una prima analisi antropologica gli scheletri, nel complesso ben conservati, rivelano la presenza di neonati, subadulti e adulti con netta prevalenza di individui giovani rispetto agli adulti e agli anziani; la mortalità, molto forte entro i primi sei anni di vita, per le donne adulte si attesta in età giovanile (18-35 anni) senza dubbio dovuta anche alle conseguenze del parto; gli uomini vivono in media più a lungo anche fino ai 50 anni. Solo una ristretta percentuale di uomini e pochissime donne arrivano a vivere per oltre mezzo secolo. Le analisi segnalano un’alimentazione composta da prodotti della terra e dell’allevamento, vegetali e carne, solo in due casi, uno dei quali è l’uomo sepolto nel grande sarcofago, è stata registrata una particolare presenza di pesce. Nel complesso un primo studio degli stress occupazionali e delle patologie rivela una popolazione dedita a lavori di fatica con uso intenso degli arti superiori, caratterizzata da una costituzione fisica e staturale non eccessivamente robusta. Philippe Pergola, Stefano Roascio, Elena Dellù, Esorcizzare la paura in età medievale. Una sepoltura prona da San Calocero di Albenga (SV) Nell’ambito delle ricerche archeologiche condotte nel sito pluristratificato di San Calocero di Albenga (SV), luogo di sepoltura del santo che ha favorito la nascita di una basilica della tarda antichità – il solo esempio ligure di martyrium – sono state riportate alla luce numerose sepolture tra le quali, nella campagna di scavo del 2014, una deviant burial. Essa si colloca nell’area del sepolcreto antistante l’edificio di culto e è appartenuta a un subadulto di 13 anni di età, probabilmente di sesso femminile, deposto insolitamente in decubito prono con cranio a Sud e all’interno di una fossa N/S molto profonda, in aderenza alla facciata. Il volto e il corpo dell’individuo risultavano rivolti contro terra e non con gli occhi al Cielo verso Cristo-Luce, per tale ragione si suppone una prassi del tutto anomala rispetto alle consuete sepolture di ambito cristiano, verosimilmente adottata nei confronti di un
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
14
soggetto che in vita veniva visto come “diverso” e che dopo la morte avrebbe potuto infierire sulla comunità. Il corpo presenta chiari segni di una sviluppata iperostosi porotica (estremamente marcata sul tavolato esterno dell’occipitale, all’interno delle orbite e sulle grandi ali dello sfenoide, ma diffusa anche nel resto del cranio e del corpo) provocata da un forte stato anemico, probabili tracce di scorbuto o Avitaminosi C causati dalla carenza alimentare di vitamina C o acido L-ascorbico e, infine, una precoce parodontopatia con perdita in vita di denti permanenti. Benché lo studio antropologico e paleopatologico dell’individuo consentano solo di osservare gli esiti di particolari patologie sulle ossa, e non comprendano nella globalità le reazioni che interessarono i tessuti molli, non è da escludere che le malattie riscontrate dal soggetto avessero a tal punto indebolito il corpo da provocarne il decesso. Oltretutto, se pensiamo ai sintomi che potevano manifestarsi, sia a causa del presunto scorbuto nonché dell’anemia, la giovane ragazza doveva probabilmente apparire estremamente insana ed emaciata: lo scorbuto potrebbe averle provocato oltre alla mancanza di forze, sanguinamento delle gengive con perdita di denti in vita, emorragie sottoungueali e negli arti inferiori, gonfiore, così come la forte anemia avrebbe potuto causarle svenimenti, allucinazioni, psicosi e, forse, un’associazione con crisi epilettiche. È infatti verosimile che, dati i ridotti sviluppi della medicina dell’epoca, esistesse un confine assai labile tra quanto poteva essere concepito come patologico da quanto, invece, veniva interpretato come manifestazione demoniaca e non è quindi da escludere che la defunta fosse stata stigmatizzata in vita e anche nel momento del suo decesso poiché vista come “soggetto difforme”, colpita da un male che forse, agli occhi dei viventi, poteva sembrare un morbus sacer o una possessione demoniaca, ma in realtà era dipendente dal suo stato di salute generale e dall’apparato neurologico. Nella realizzazione della sepoltura della giovane di Albenga si concretizzò probabilmente un miscuglio di credenze e retaggi arcaici che portarono la comunità a difendersi e verosimilmente, allo stesso tempo, a cercare di far espiare i suoi presunti peccati in una posizione di totale sottomissione a Dio. English Abstract The excavations conducted by the Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana in 2014 at the multistratificated site of San Calocero di Albenga, an ancient basilica of the late Antiquity arisen in connection with the burial of a local martyr, have brought to light a deviant burial. The study, through a multidisciplinary approach (archaeological, taphonomic, bioarchaeological, anthropological), outlines the plausible reconstruction of a severely ill person due to scurvy and anemia that, just for the manifestation of such pathologies, disturbed insomuch his community that probably was mistaken for a evil person or possessed by the Devil. That is why the body was laid prone in an isolated grave, deeper than the other. Keywords San Calocero of Albenga, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, deviant burial, scurvy, witch girl. Read at: http://www.calameo.com/read/004283747a3206c303edb
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
15
Marie De Jonghe, Solenn De Larminat, À propos d’un cas de procubitus du VIIe s. av. n. è. dans la nécropole phénicienne d’Utique (Tunisie) En 1949, P. Cintas réalise la seconde campagne de fouilles dans les zones funéraires phéniciennes d’Utique (Cintas 1951). Dans la nécropole dite «de la Berge»,parmi la cinquantaine de sépultures à inhumation mises au jour, une seule livra un individu en procubitus (tombe XXIII). Cette tombe est une fosse dont les parois sont maçonnées en brique crue comme le sont les autres sépultures de cette période. De même, le mobilier céramique d’accompagnement est représentatif des tombes phéniciennes du VIIe siècle av. n. è. En revanche, la position du défunt, sur le ventre les coudes liés dans le dos, dénote dans ce contexte d’inhumations en décubitus. Actuellement, en Méditerranée occidentale, un seul autre cas de dépôt en procubitus a été identifié à Monte Sirai, en Sardaigne (Guirguis 2012). Le défunt n’a toutefois pas été inhumé mais brûlé puis conservé sur le bûcher. Il faut se tourner vers le Levant, dans la nécropole de Khaldé (Liban) (Saïdah 1966) pour avoir des comparaisons avec d’autres inhumés en procubitus. Il paraît donc difficile, compte tenu du peu d’informations dont nous disposons sur le monde funéraire phénicien et les rares exemples de procubitus, de faire distinctement la part des choses entre mort, défuntet rituel atypiques, et d’identifier ainsi les raisons de ce traitement du corps. Néanmoins, à travers une réactualisation des données de la tombe XXIII d’Utique, nous réfléchirons à la place de ces défunts en procubitus dans les pratiques funéraires phéniciennes: au delà du traitement spécifique du corps, d’autres éléments comme l’architecture ou le mobilier de la tombe permettent-ils de différencier le défunt? La situation de la tombe dans la nécropole présente-t-elle également une particularité? Comment se positionne-t-elle par rapport à la «norme» collective perçue à Utique? English Abstract In 1949, P. Cintas excavated in the necropolis “of the bank” in Utica the grave of an individual in prone position (grave XXIII). This grave is a pit with raw brick walls, as all the other graves of this site for this period, and whose ceramic material is representative of the material found in the VII th century BC Phoenician graves. In the meantime, the position of the deceased, in procubitus with the elbows tied up in the back, denotes in a context of decubitus positions. Through an actualization of the data of this grave XXIII, we will think about the place of those deceased in prone position within the Phoenician funerary practices. Aside from a different treatment of the body, can other elements, such as architecture or material in the grave, induce a distinction of the deceased? How would the grave XXIII be regarded compared to the collective standard seen in Utica Keywords Phoenician ; Utica ; Tunisia ; Prone position ; Funerary practice Read at: http://www.calameo.com/read/004283747877afb94e386 Serena Viva, Un caso di sepoltura anomala dal sito archeologico medievale di San Genesio
La necropoli di San Genesio (San Miniato, PI) è costituita da numerosi periodi e fasi cimiteriali che si susseguono dal VI al XIII secolo d.C. Le 419 sepolture a inumazione rinvenute finora, differenti per tipo di tomba, sebbene la fossa terragna sia la più frequente, per orientamento, spesso peculiarità di una specifica fase cimiteriale, per tipo di decomposizione, in spazio pieno o spazio vuoto, sono però tutte caratterizzate da decubito dorsale e posizione con arti inferiori distesi e arti superiori distesi o variamente flessi sul bacino o sulla parte addominale.
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
16
In un solo caso su 419, quest’ultimo assunto non vale, ossia nella sepoltura SK248. Lo scheletro era in posizione del tutto inconsueta, con arti inferiori iperflessi poggianti sul tronco. Questa sepoltura, datata alla fine del IX, inizi del X secolo d.C., non si trovava isolata, ma all’interno dell’area sepolcrale tra altre sepolture con scheletri in posizione conforme alla tradizione sepolcrale di questo contesto. Secondo l’analisi tafonomica, la tomba sarebbe stata riaperta in un secondo tempo rispetto al seppellimento, a scheletrizzazione parziale o completa, e il calvario asportato, perdendo la connessione anatomica con la prima vertebra cervicale e la mandibola, e riposizionato sulla parte addominale, tra gli arti inferiori. Con l’analisi antropologica è stato determinato il sesso femminile di questo individuo e la sua età, la più avanzata finora individuata, di 60 anni. La donna aveva subito in vita una frattura da parata all’ulna sinistra e la frattura di una costa. La posizione di giacitura atipica, fa già di per sé ipotizzare un rito non consueto; la successiva violazione del sepolcro e la mutilazione, se pur in un momento successivo al seppellimento, fanno pensare all’ipotesi di un rituale messo in atto per infliggere una seconda e irreversibile morte, oppure di attività di tipo offensivo, vendicativo o necromantico. La manomissione del sepolcro e la tardiva asportazione e dislocazione di parti rappresentative del corpo, quale la testa, trovano riscontro in altri casi di sepolture anomale. English Abstract In medieval cemetery of San Genesio, a burial was found, classified as atypical by some unusual features. The individual has been buried in a different way than what is considered the norm for this period and population. The principal difference is the body position, that is the forced flexion of the lower limbs, maybe by ropes. Furthermore, according to the taphonomic analysis, the grave was been reopened, after corpse skeletonization, to remove the skull and replace it facedown, near the legs. The reason for this atypical treatment could be the fear of revenant or just an offensive and vengeful action against the individual. Keywords Tuscany, Middle Age, taphonomy, atypical burial, necrophobia. Read at: http://www.calameo.com/read/004283747f191b5a4310c Corinne Rousse, Solenn De Larminat, Un contexte funéraire atypique de la fin du XIIIe s. dans le complexe artisanal romain de Loron (Croatie): trésor monétaire et étude archéo-anthropologique Le site de Loron, sur la commune de Tar-Vabriga (Istrie, Croatie), correspond à un grand domaine d’époque romaine installée en bord de mer au début du Ier s. de n. è, sur le territoire de la colonie de Parentium (Poreč). Il fait actuellement l’objet d’un programme international franco-croate, associant le musée territorial du Parentin (Zavičajni muzej Poreštine), l’École française de Rome et le centre C. Jullian (université d’Aix-Marseille - CNRS) avec le soutien du ministère de la culture de la République de Croatie et du ministère des Affaires étrangères français. Depuis 1994, les fouilles menées par plusieurs équipes internationales ont mis à jour un vaste atelier d’amphores à huile Dressel 6B destinées à l’exportation. Propriété de sénateurs, puis d’empereurs, l’atelier fonctionne en continu du Ier s. au IVe s. de notre ère, avant d’être progressivement démantelé, puis complètement abandonné à la fin du Ve s. Les recherches réalisées sur le promontoire de Loron, correspondant à l’emprise de la propriété impériale, ont permis de localiser un autre secteur
Diritti riservati per l’edizione nei relativi atti. www.romarche.it
17
résidentiel d’époque romaine (probablement la villa aristocratique), sans révéler d’indices significatifs quant à l’occupation post-antique de cet espace. C’est pourquoi la découverte en 2012 d’une sépulture d’un individu masculin associée à un petit trésor monétaire de la fin du XIIIe s. constitue un contexte funéraire atypique. La sépulture elle-même, une simple fosse creusée à faible profondeur, a été précisément installée à l’angle d’un édifice considéré jusqu’ici comme arasé, dans le quartier d’habitat associé à l’atelier d’amphore. Elle constitue a priori un contexte isolé, à mettre en relation avec une fréquentation sporadique de la côte. Pourtant, la valeur des monnaies associées au défunt contraste fortement avec la simplicité de la sépulture: il s’agit d’un lot de 9 deniers d’argent, émis par les ateliers d’Aquilée et de Trieste entre 1234-1254 et 1260-1282. Ces monnaies étaient probablement rassemblées dans une bourse déposée au niveau du bassin. Elle constituent une somme non négligeable, voire élevée si l’on compare avec des contextes similaires recensés en Italie. La communication présentera l’ensemble des composantes de la sépulture (localisation, architecture, squelette, mobilier) au regard des données connues sur l’occupation du territoire de Poreč au bas Moyen Âge et, en terme de pratique funéraire, par comparaison avec d’autres trouvailles monétaires en contexte d’inhumation isolée d’époque médiévale. English Abstract Loron (Tar-Vabriga, Croatia) is a large Roman estate implanted near the sea in the early first century AD on the territory of the colony of Parentium (Poreč). It’s currently the subject of a French-Croatian international program involving the territorial museum of Poreč (Zavičajni Poreštine muzej), the French School of Rome and the research center C. Jullian (Aix-Marseille University - CNRS) with the support of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the French Foreign Ministry. Since 1994, the excavations led by an international team have unearthed a large workshop complex mainly dedicated to the production of oil amphoras Dressel 6B for export. This workshop was the property of senators and emperors. It was continuously occupied from the first century AD to the fourth century AD, before being gradually dismantled, and then completely abandoned in the late fifth century AD. New research conducted on the Loron promontory corresponding to imperial property, have located another Roman residential area - probably the aristocratic villa- without revealing significant evidences about the post-antique occupancy of this area. This is why the discovery in 2012 of a male individual burial associated with a small monetary treasure of the late thirteenth century is an atypical funerary context. The tomb itself, a no deep simple grave, was specifically installed at the corner of a building associated with the amphora workshop. It constitutes an isolated context to link with sporadic visits to the coast. Yet the value of currencies associated with deceased contrast to the simplicity of the burial: these are 9 silver coins issued by the Aquileia and Trieste money workshops between 1234-1254 and 1260-1282. These coins were probably gathered in a purse discovered near the basin. The poster presents all burial components (location, architecture, skeleton, material) in relation to the known data on the late Middle Ages Poreč territory occupation and the funerary practice, compared to others similar contexts of isolated medieval burials with coins in Italy. Keywords North Adriatic; Istria; Croatia; Italy; Middle Age; isolated burial; treasury; coins. Read at: http://www.calameo.com/read/004283747a734283e586d