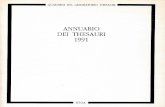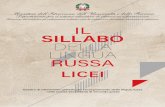Tra Bergamo e Avignone. L'ultima lettera di Ferrante Pallavicino, 2011
«Per teatri non è Bergamo sito». La società bergamasca e l’organizzazione dei teatri pubblici...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of «Per teatri non è Bergamo sito». La società bergamasca e l’organizzazione dei teatri pubblici...
FONDAZIONE PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO
COLLANASTUDI DI STORIA DELLA SOCIETÀ, DELL’ECONOMIA
E DELLE ISTITUZIONI BERGAMASCHE
4
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 1
Soci ordinari3V Sigma SpaACEBA2A SpaABB Power Technologies SpaAssociazione Artigiani di BergamoAssociazione Esercenti e Commercianti della
provincia di BergamoATB Mobilità SpaAugere SrlAzienda vitivinicola La Tordela di Marco BernardiBanca di Bergamo SpaBolis Edizioni SrlBonaldi SpaBrembo SpaCassa Rurale - BCC di Treviglio e GeradaddaCastelli Bolis Poligrafiche SpaCliniche Gavazzeni SpaCo.Pi.Ci. SpaComune di BergamoConfindustria BergamoConsiglio notarile di BergamoDalmine SpaDiocesi di BergamoEcodeco SpaFinedil Servizi Finanziari SpaFondazione A.J. ZaninoniFrattini Spa Costruzioni meccaniche
Gewiss SpaGros Market Lombardini SpaGTS Group Spa (gruppo Di Bi)Impresa Costruzioni Ing. G. Pandini SpaImpresa F.lli Rota Nodari SpaIsmes SpaKpmg SpaLactis SpaLegler Holding SpaL’Innominato SpaMaberfin SpaMontello SpaOrdine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di BergamoPhilco Italia SpaProvincia di BergamoRulli Rulmeca SpaS.E.S.A.A.B. Spa - Società Editrice SS. AlessandroSCAME Mastaf SpaSCAME Parre SpaSIAD Macchine Impianti SpaSIAD SpaTenacta Group SpaTessival SpaTino Sana SpaUBI Insurance Broker SrlZanetti Spa
Collana promossa dallaFondazione per la Storia economica e sociale di BergamoIstituto di studi e ricerche
Soci fondatoriUBI - Banca Popolare di BergamoCamera di Commercio di BergamoCredito BergamascoIntesa - San PaoloItalcementi Spa
Soci di dirittoAteneo di scienze, lettere ed arti di BergamoUniversità degli Studi di Bergamo
Consiglio direttivoPresidente VicepresidenteRoberto Sestini Alberto CastoldiConsiglieriBruno Bossina Renato RavasioGiovanni Giavazzi Franco TentorioItalo Lucchini* Emilio ZanettiAlberto Lupini Cesare ZoncaEttore Pirovano* Consigliere delegato
Il logotipo della Fondazione per la Storia economica e sociale di Bergamo, riprodotto sulla copertina del volume, rappre-senta una moneta di conio bergamasco dell’età di Carlo Magno, attualmente conservata al museo di Coira (Svizzera).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 2
FRANCESCA FANTAPPIÈ
«Per teatri non è Bergamo sito»La società bergamasca
e l’organizzazione dei teatri pubblicitra ’600 e ’700
FONDAZIONE PER LA STORIA ECONOMICA E SOCIALE DI BERGAMO
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 3
“Studi di storia della società, dell’economia,e delle istituzioni bergamasche” -Collana promossa dallaFondazione per la Storia Economicae Sociale di BergamoIstituto di Studi e Ricerche
Volume 4«Per teatri non è Bergamo sito».La società bergamascae l’organizzazione dei teatri pubblicitra ’600 e ’700
Autrice del volumeFrancesca Fantappiè
Ideazione e coordinamento editorialeFondazione per la Storia Economicae Sociale di Bergamo
Fantappiè, Francesca«Per teatri non è Bergamo sito» : la società bergamasca e l’organizzazione dei teatri pubblici tra ‘600 e ‘700 / Francesca Fantappiè.Bergamo : Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, [2010].512 p. : ill. ; 24 cm + 1 CD-ROM(Studi di storia della società, dell’economia e delle istituzioni bergamasche ; 4)ISBN 978-88-86797-24-51. Teatro - Bergamo - Sec. 17.-18.792.0945241
Il volume è stato sottoposto ad un processo dipeer review che ne ha attestato la qualità scientifica.
Copyright © 2010by Fondazione per la Storia Economicae Sociale di Bergamowww.fondazionestoriaeconomicabergamo.it
Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e di adatta-mento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, (com-presi i microfilms e le copie fotostatiche) sono riserva-ti per tutti i paesi.
Con il contributo di
COMUNE DI BERGAMO
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 4
5
Le città raccontano gran parte della propria storia attraverso quel-la dei loro teatri. Le vicende che hanno intrecciato con questi luoghidella finzione rivelano spesso il confronto tra quello che sono state equello che avrebbero potuto essere, tra la loro realtà storica e le solu-zioni a cui non si è arrivati. Oggi Bergamo è senza dubbio il Doni-zetti, un teatro che è un anche un monumento della città, uno deisuoi principali motivi d’orgoglio, meta di visite guidate e prestigiosotestimone della passione artistica dei bergamaschi. Ma c’è stato un tem-po – quello descritto da Francesca Fantappié in questo bellissimo vo-lume – in cui per godere di una rappresentazione si doveva aspettareCarnevale o la fiera d’agosto nei Borghi; un tempo in cui “casotti” dilegno, edificati all’occorrenza nel prato della fiera, fungevano da tea-tro; un periodo in cui le compagnie teatrali erano riluttanti a raggiun-gere Bergamo, considerata lontana e periferica.
A conclusione di un’accurata e massiva ricerca archivistico-do-cumentaria, condotta in modo pionieristico tra ricognizione di ma-teriale librettistico e spoglio di archivi, la giovane studiosa ci resti-tuisce un quadro molto convincente del sistema teatrale bergama-sco di Sei e Settecento, focalizzandosi in particolare sull’interazio-ne tra i modelli produttivi diffusi a livello peninsulare e il contestosocio-culturale e politico cittadino. Oltre alla ricostruzione della cir-colazione degli artisti e dei loro repertori, la ricerca si concentra poiin modo assolutamente originale sul reperimento dei luoghi prepo-sti alla loro esibizione, mettendo in evidenza come il processo diedificazione di un teatro stabile a Bergamo seguì le principali ten-denze delle altre città della Terraferma veneta, senza arrivare mai acompimento.
Presentazione
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 5
6
Assistiamo, così come in altre realtà cittadine, alla nascita di unedificio teatrale privato a conduzione impresariale, a varie iniziativedi edificazione di teatri a conduzione sociale, all’uso di spazi pubbli-ci offerti dai palazzi del potere: molti tentativi ma tutti falliti.
Innanzitutto per cause politiche; da parte dei rettori, esponenti delpotere centrale, non si riscontra un’opera di convinto sostegno in am-bito teatrale, mentre, dal canto loro, le autorità municipali, diretteespressioni della classe dirigente bergamasca, sostennero una posizio-ne fortemente contraria alla stabilizzazione di un sistema teatrale ur-banisticamente riconosciuto. In secondo luogo per cause religioso-cul-turali; il clima ecclesiastico urbano non era per nulla incline ad accet-tare senza riserva l’espansione del teatro operistico a pagamento edera generalmente contrario all’espansione del professionismo attori-co. In terzo luogo per motivi geografici; Bergamo aveva una colloca-zione marginale all’interno dei circuiti teatrali del centro-nord dellaPenisola proprio per la sua ubicazione topografica periferica: uno deitopoi più diffusi, soprattutto tra gli attori professionisti, era proprioquello della difficoltà di raggiungere il «solitario soggiorno». Ma so-prattutto per cause sociali; il problema di fondo appare, infatti, la de-bolezza delle iniziative promosse dalla società bergamasca, che è estre-mamente disorganica e caratterizzata da un forte antagonismo inter-no: i tentativi operati furono, di fatto, episodici e molto disomoge-nei. Le istanze civili che avrebbero potuto determinare il compimen-to del desiderio di dotare la città di un teatro permanente, nel caso incui provarono a trovare un’espressione, furono regolarmente frustra-te dalle forti competizioni interne al ceto nobiliare e, nel corso delSettecento, dalle irrisolte tensioni con quello borghese.
Nulla è mai stato semplice per i bergamaschi; vicende storiche, po-sizione geografica, un carattere a tratti duro e poco incline allo sva-go, non hanno però neutralizzato l’anima artistica di questa terra, che,lentamente, iniziò a superare i propri pregiudizi. Così, il ricco com-merciante Bortolo Riccardi decise di intraprendere, nel 1768, la rea-lizzazione dell’edificio teatrale, che inizialmente gli venne intitolato.Andato distrutto a causa di un incendio, venne ricostruito sotto laguida dell’architetto Giovanni Francesco Lucchini. Il rinato “TeatroNuovo” fu uno tra i primi teatri italiani edificati in muratura, meta-fora di stabilità e tenacia di un popolo, come il nostro.
Il processo di costituzione del sistema teatrale urbano subì poiun’accelerazione del tutto straordinaria nel periodo napoleonico,
PRESENTAZIONE
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 6
7
quando senza le interminabili contrattazioni tra potere centrale e pe-riferico proprie del periodo veneto, venne costruito un teatro stabilein Città Alta utilizzando la sala del Palazzo della Ragione; si trattavadel Teatro Cerri, una sorta di teatro della “transizione”, che rimase at-tivo per dieci anni, nel corso dei quali nuove e più coese istanze por-tarono al compimento del progetto che dette origine, nel 1808, al Tea-tro Sociale, l’altro inestimabile gioiello del nostro panorama scenico.
Per noi, quindi, promuovere la riscoperta dei teatri e delle rappre-sentazioni d’opera a Bergamo tra Sei e Settecento significa educare ariconoscere i valori intrinseci della storia di quest’attività senza maisepararli dalla tradizione specifica del luogo in cui sono collocati, si-gnifica salvaguardarli e soprattutto renderli partecipi dei contingentiinteressi della comunità a cui appartengono.
Questo lavoro fondativo, ospitato a pieno titolo nella collana di‘Studi di storia della società, dell’economia e delle istituzioni berga-masche’, contribuisce ad arricchire ulteriormente il dialogo incessan-te tra passato e presente, aperto a tutti gli attori e a tutti gli aspetti del-l’esperienza umana, che costituisce uno dei tratti fondamentali del-l’azione culturale del nostro Comune e della nostra Camera di com-mercio.
FRANCO TENTORIO GIOVANNI PAOLO MALVESTITISindaco di Bergamo Presidente Camera di commercio di Bergamo
PRESENTAZIONE
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 7
9
Prefazione
La storia del teatro è da sempre storia di un rapporto o di un con-flitto tra la realtà e il sembiante, tra la città storica e il suo immagina-rio. È un racconto che parla di noi e di quello che avremmo volutoo potuto essere.
Le tormentate vicissitudini attraversate dalla storia del teatro a Ber-gamo non sono che una conferma. Quando infatti nel 1720 l’erudi-to abate Giovan Battista Angelini ha ritratto l’immagine di Bergamo,nelle rime di un suo lungo poema, ha tramandato alla memoria sto-rica l’idea di una cultura cittadina priva di una solida istituzione dispettacolo, propensa piuttosto a frenare «il teatral piacere». Ma la cit-tà non fu certamente priva di continue istanze performative.
L’accurata indagine documentaria attraverso la quale Francesca Fan-tappiè ha delineato l’inedito panorama del sistema teatrale sotto il do-minio veneto, restituisce ora alla storia cittadina le complesse vicen-de, ricostruite attraverso un patrimonio documentario fino ad oggi sco-nosciuto e parzialmente valorizzato. La faticosa e contrastata afferma-zione di questa impresa riflette istanze sociali intense e contradditto-rie che a Bergamo, fino dal secolo XVII, hanno contrassegnato un lun-go percorso di aspettative deluse, di contrasti e di rivalità. Ne emergel’intrigante racconto di «un teatro che non si fa» (come a ragione as-serisce l’autrice), sempre auspicato e costantemente ostacolato, a lun-go rinviato e senza lieto esito, ma soprattutto il rapporto tra il pub-blico e la sua ‘rappresentazione’. Una sotterranea radicata ritrosia cit-tadina, pur sotto l’egida propulsiva della Serenissima, sembra talvol-ta non avere trovato adeguate risposte alle proprie istanze, vanifican-do le occasioni per imporre l’innata ‘vocazione’ impresariale berga-masca nei più ampi circuiti teatrali.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 9
10
La novità e la freschezza di questa difficile ricostruzione storica,che esprime quasi simbolicamente l’ostinata passione per la ricerca,rappresentano gli esiti raggiunti da Francesca Fantappiè nella sua tesidi Dottorato in Discipline filosofiche, discipline artistiche e teatralidell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, (titolare la prof.Anna Maria Cascetta). Il progetto di ricerca ha sviluppato le indaginicondotte nell’ambito della cattedra di Storia del Teatro e dello Spet-tacolo della Facoltà di Scienze Umanistiche dell’Università di Berga-mo, sede consorziata del Dottorato, sotto la responsabilità della prof.Anna Maria Testaverde.
ANNA MARIA TESTAVERDEUniversità degli Studi di Bergamo
PREFAZIONE
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 10
11
Indice
Abbreviazioni e sigle pag. 13
Ringraziamenti » 14
Introduzione » 15
PARTE I. Potere e teatro nella Repubblica veneta » 29
1. Il sistema teatrale delle città della Terraferma veneta » 29
2. Bergamo: il teatro senza teatri » 41
PARTE II. Il teatro della Città Alta » 59
1. I palazzi del potere in Piazza Vecchia » 591.1 Le sale del Palazzo della Ragione, Palazzo del Podestà
e Palazzo Nuovo » 591.2 La loggia sotto il Palazzo della Ragione » 68
2. Il teatro e l’oligarchia bergamasca » 782.1 Committenza nobiliare e prime opere in musica » 782.2 Il Teatro Secco Suardo (1686-1695) » 85
2.2.1 Nascita ed ubicazione » 852.2.2 Un tentativo impresariale sul modello veneziano » 98
3. Il potere della Dominante » 1103.1 Il Teatro della Cittadella e gli impresari
costruttori (1757-1797) » 1103.2 Tra opera buffa, compagnie di giro e spettacoli accademici » 1243.3 Il cortile della Cittadella » 137
4. Note conclusive » 139
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 11
12
INDICE
PARTE III. Il teatro dei Borghi pag. 143
1. La fiera e il teatro » 1431.1 I casotti degli attori: dai comici dell’arte
alle compagnie “lombarde” » 1461.2 Le feste di Carnevale in Borgo S. Leonardo
e il teatro circense in fiera » 164
2. I teatri per la musica in fiera » 1782.1 Gli impresari e i teatri provvisionali » 1782.2 Dal portico a piloni al teatro in pietra (1786-1791) » 2002.3 Il Teatro Riccardi alla fine
della Repubblica veneta (1791-1797) » 225
3. Note conclusive » 241
Tavole » 247
Appendice A » 271
Cronologia degli eventi spettacolari » 273
Fonti inedite » 479
Fonti edite » 481
Bibliografia » 483
Indice dei nomi » 499
Indice dei luoghi » 509
Indice del CD
Appendice B pag. 517
Criteri di trascrizione » 519
Regesto documentario » 521
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 12
13
Abbreviazioni e sigle
ACVBg ARCHIVIO DELLA CURIA VESCOVILE DI BERGAMOACRo ACCADEMIA DEI CONCORDI DI ROVIGOAORBg ARCHIVIO OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMOASBg ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO
DS DIPARTIMENTO DEL SERIOASMn ARCHIVO DI STATO DI MANTOVAASP ARCHIVIO DI STATO DI PARMAASV ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA
ASRV ARCHIVIO STORICO DEI RETTORI VENETICDPC CONSIGLIO DEI DIECI. PARTI COMUNIIS INQUISITORI DI STATO
ASSLu ARCHIVIO SECCO SUARDO DI LURANOBAM BIBLIOTECA AMBROSIANA DI MILANOBCABo BIBLIOTECA COMUNALE DELL’ARCHIGINNASIO DI BOLOGNABCBg BIBLIOTECA CIVICA ANGELO MAI DI BERGAMO
ASC ARCHIVIO STORICO DEL COMUNEASRV ARCHIVIO STORICO DEI RETTORI VENETIFMQ FRANCESCO MARIA QUARENGHIVS VIMERC ATI SOZZI
BCPa BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DI PARMABCMM BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI MILANOBCMNa BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI NAPOLIBCMR BIBLIOTECA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI ROMABCPd BIBLIOTECA CIVICA DI PADOVABCV BIBLIOTECA CORRER DI VENEZIABIMDBg BIBLIOTECA DELL’ISTITUTO MUSICALE DONIZETTI DI BERGAMOBMF BIBLIOTECA MARUCELLIANA DI FIRENZEBNBM BIBLIOTECA NAZIONALE BRAIDENSE DI MILANOBRNo BIBLIOTECHE RIUNITE CIVICA E NEGRONI DI NOVARABRTBg BIBLIOTECA GIACOMO MARIA RADINI TEDESCHI DI BERGAMOBSCr BIBLIOTECA STATALE DI CREMONABUBo BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNACMBo CIVICO MUSEO BIBLIOGRAFICO MUSICALE DI BOLOGNACGV CASA GOLDONI DI VENEZIAFGCV FONDAZIONE GIORGIO CINI DI VENEZIAFLPsp FONDAZIONE LEGLER IN PONTE SAN PIETROc./cc. CARTEnn. NON NUMERATEs. l. s. d. SENZO LUOGO SENZA DATAv. VERSOr. RECTOs. SINISTROd. DESTRO
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 13
Intendo qui ringraziare alcune delle persone che hanno contribui-to con il loro aiuto, sia materiale sia morale, a determinare il comple-tamento di questo studio. Per l’estrema disponibilità mostratami nelcorso della ricerca, per la loro competenza e sollecitudine: il dott. San-dro Buzzetti, la dott.ssa Francesca Giupponi, la dott.ssa Maria Elisa-betta Manca, la dott.ssa Marta Gamba, Andrea Pelliccioli della Biblio-teca Angelo Mai di Bergamo. Né da meno sono stati la dott.ssa Mi-chela Dal Borgo dell’Archivio di Stato di Venezia, la dott.ssa MariaPacella dell’Archivio di Stato di Bergamo, la dott.ssa Michela Gattidella Fondazione Legler, il conte Lanfranco Secco Suardo della Fon-dazione Giovanni Secco Suardo di Lurano, al quale va tutta la miapersonale simpatia. Per i numerosi e preziosi consigli il prof. VirgilioBernandoni e la prof.ssa Juanita Schiavini Trezzi. Per l’aiuto e l’inco-raggiamento la prof.ssa Anna Maria Testaverde. Per l’insegnamento diquesti anni il prof. Siro Ferrone e la prof.ssa Sara Mamone. Last butnot least: il prof. Giuseppe De Luca per il suo impegno affinché que-sto volume fosse pubblicato, l’anonimo referee per i suoi preziosi sug-gerimenti la dott.ssa Lavinia Parziale per la pazienza. Gianni Cicali,Maia Gathan, Francesca Simoncini, Simone Testi per il loro aiuto ela loro amicizia. Sergio Tognetti per la sua costante presenza, la suasolerte attenzione, l’esempio.
Ringraziamenti
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 14
La presente ricerca intende offrire un’immagine complessiva e, al-lo stato attuale delle ricerche, quanto più esaustiva possibile delle mo-dalità e dei tempi attraverso cui il tra il Seicento ed il Settecento siaffermò a Bergamo, un sistema teatrale pubblico destinato alla rap-presentazione di spettacoli a pagamento, sia nel settore della prosasia in quello musicale. All’obiettivo iniziale di assegnare alla città unacollocazione nell’ambito del circuito operistico peninsulare e di sta-bilire la frequenza della circolazione di compagnie di attori profes-sionisti si è accompagnato quello, indispensabile, di definire quali luo-ghi fossero preposti ad accogliere artisti e pubblico. Un argomentoche è apparso fin dall’inizio scarsamente esplorato. L’indagine è sta-ta, infatti, possibile solo grazie a un’accurata ricerca archivistico-do-cumentaria, mentre l’esposi zione dei risultati si prefigge di illustrarei percorsi seguiti e quelli tuttora percorribili, nella speranza di forni-re un valido strumento per ulteriori approfondimenti. L’organiz -zazione stessa del materiale reperito persegue la volontà di presenta-re in maniera rigorosa la metodologia adottata. Alla parte critica, cheraccoglie le principali conclusioni e delinea un quadro generale del-l’evoluzione Sei-settecentesca del sistema dei teatri pubblici bergama-schi, è associata una sezione documentaria composta dalla cronolo-gia degli eventi spettacolari cittadini rinvenuti e da un puntuale rege-sto delle fonti, materiale spesso di difficile reperimento e per la mag-gior parte inedito.
Molteplici i quesiti a cui abbiamo provato a dare una risposta. Inche modo e fino a che punto Bergamo fu toccata dal fenomeno delteatro d’opera nel momento della sua massima diffusione, ossia tra lafine del Seicento e l’inizio del Settecento? Che tipo di sistema pro-
Introduzione
15
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 15
16
duttivo si affermò tra quelli attualmente individuati?1 È possibile de-terminare eventuali sfere d’influenza nella circolazione del repertoriooperistico? In che misura e con quale cadenza le compagnie dei co-mici dell’arte si esibivano nella città? Per gli attori professionisti Ber-gamo rappresentava una piazza teatrale primaria o secondaria? Stabi-lita una linea di tendenza nel comportamento delle formazioni degliattori, rimase sempre la stessa o cambiò nel tempo? Queste alcune del-le domande che hanno costituito il punto di partenza dell’indagine.
Una ricerca sulla circolazione degli artisti e sul loro repertorio nonpuò essere mai disgiunta dal reperimento dei luoghi preposti alla loroesibizione. Individuare, quindi, non solo i protagonisti del fenomeno,ma anche gli spazi, stabilire l’arco cronologico della loro esistenza, lemodalità economiche del loro funzionamento. Un’operazione preci-pua della storia dello spettacolo che genera spesso punti di vista e pro-blematiche inedite in relazione alla storia della città stessa. La nascitadi teatri stabili e la loro progressiva articolazione in un sistema urba-nistico coerente è, infatti, strettamente legata alla struttura politica esociale di ogni singola realtà cittadina. Ricostruire un qualsiasi sistemateatrale municipale significa, perciò, lavorare parallelamente su due am-biti. Da una parte quello del potere che regola la città, chiamato a so-vrintendere ed amministrare la sua vita comunitaria, e dall’altra quel-lo della società che la compone, molto spesso il motore principale del-l’istanza spettacolare. Una storia teatrale urbana diventa così un’otti-ma chiave interpretativa della storia cittadina tout court. E viceversa. Sen-za conoscere, o tentare di comprendere, la storia della città oggetto diindagine è impossibile determinare la sua storia teatrale2.
Non si tratta perciò di studiare un fenomeno meramente artistico.Il processo costitutivo di un sistema teatrale urbano si presenta comeil prodotto di vari fattori, tra i quali gioca una parte di primo piano lacondizione istituzionale-amministrativa di ogni singola realtà, oltrel’ambiente culturale e sociale di riferimento. Nel caso di Bergamo èda tenere sempre presente il sistema politico-territoriale all’interno del
FRANCESCA FANTAPPIÈ
1. Sui modelli produttivi del teatro d’opera si vedano F. Piperno, Il sistema pro-duttivo fino al 1780, in Storia dell’opera italiana, vol. IV: Il sistema produttivo e le sue com-petenze, a cura di L. Bianconi, G. Pestelli, Torino, 1987, pp. 3-75; L. Bianconi, T. Wal-ker, Forme di produzione del teatro d’opera italiano nel Seicento, in A. Annibaldi (a curadi), La musica e il mondo, Bologna, 1993, pp. 221-257.
2. L. Zorzi, Il teatro e la città, Torino, 1977.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 16
17
quale la città si collocava: non una città autonoma, una «città capita-le» di uno stato, né tantomeno sede di una corte, ma una «città sud-dita», soggetta ad una dominazione esterna, quella di Venezia3. Ovviaconstatazione cui se ne associa un’altra: la conoscenza dei sistemi tea-trali esistenti negli altri centri urbani della Terraferma veneta si rivelaun termine di paragone fondamentale per determinare le peculiaritàdel caso che stiamo trattando. Tale confronto porta immediatamentea considerare la particolare collocazione geografica di Bergamo comeuna delle sue caratteristiche distintive. Tra le città soggette della Terra-ferma, quella più distante da Venezia, si trovava invece molto vicinaa Milano. Alla prima era politicamente sottoposta, ma ecclesiastica-mente ricadeva sotto il dominio della seconda4. Situata al confine ter-ritoriale estremo della Repubblica veneta, avamposto d’importanza mi-litarmente strategica, ma in realtà città “naturalmente” lombarda, lacompetizione tra i due influenti stati regionali si rifletteva nell’ambi-to dell’educazione e della cultura5. Apparentemente lontana e remo-ta, ai margini dei circuiti teatrali veneti, si trovava invece vicina a quel-li lombardi. Offre quindi un terreno di studio privilegiato per stabili-re le reciproche sfere d’influenza dei due centri teatrali maggiori di areasettentrionale in epoca di antico regime. Né bisogna sottovalutare icontatti di Bergamo con le corti di Mantova, Parma e Modena.
Sul sistema teatrale bergamasco di Sei e Settecento, sulle dinami-che d’interazione del sistema produttivo diffuso a livello peninsularecon il contesto socio-culturale cittadino e le sue istituzioni politiche
INTRODUZIONE
3. Sulla differenza tra «città capitale» e «città suddita», cfr. M. Berengo, L’Euro-pa delle città. Il volto della società urbana europea tra Medioevo ed Età moderna, Torino,1999.
4. La diocesi di Bergamo dipendeva, infatti, dall’arcidiocesi di Milano.5. C. Carlsmith, Schooling and Society in Bergamo 1500-1650, A dissertation pre-
sented to the Graduate Faculty of the University of Virginia in Candidacy for thedegree of Doctor of Philosophy, Department of History, University of Virginia, May1999, p. 128. Tesi di dottorato attualmente in corso di pubblicazione, con il titoloA Renaissance Education: Schooling in Bergamo and the Venetian Republic, 1500-1650, pres-so l’University of Toronto Press. Sulla posizione di Bergamo come baluardo milita-re della Terraferma veneta e sui riflessi architettonici di questa condizione strategicasi vedano G. Scotti, Bergamo nel Seicento, Bergamo, 1897; A. Mazzi, Le mura di Ber-gamo, in «Bollettino della Civica Biblioteca di Bergamo», II (1908), fasc. 3, pp. 197-219; G. Colmuto Zanella, Le fortificazioni di Bergamo nel Medioevo, in Le mura di Ber-gamo, Bergamo, 1977, pp. 281-282, 315-317; Id., La fortezza cinquecentesca di Bergamo,in L’architettura militare veneta del Cinquecento, Milano, 1988, pp. 110-124.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 17
18
non esiste attualmente uno lavoro complessivo. Gli studi esistenti so-no parziali, dovuti spesso a solerti e zelanti eruditi di storia locale,tanto più lodevoli in quanto colmano il vuoto di indagini accademi-che al riguardo, ma purtroppo frammentari e occasionali, non suffi-cienti a restituire una sintesi del processo di affermazione di un siste-ma teatrale pubblico nella città6. Ciò nonostante offrono un indispen-sabile punto di partenza e restituiscono alcune delle convinzioni piùaccreditate sull’argomento. Tra di esse la più notevole appare quellache fino al 1786, anno in cui sarebbe nato il Teatro Riccardi, oggi Do-nizetti, non fosse mai esistito un teatro stabile a Bergamo. Il ritardonei confronti degli altri centri urbani della Terraferma sarebbe stato,quindi, di oltre un secolo, poiché praticamente tutti, grandi o picco-li che fossero, riuscirono a dotarsi di un teatro pubblico prima dellafine del Seicento. Si menziona spesso l’esistenza di un teatro, dettodella Cittadella, attivo a Bergamo nella seconda metà del Settecento,ma non si approfondiscono le conseguenze di questa acquisizione in
FRANCESCA FANTAPPIÈ
6. Principale studioso della storia teatrale bergamasca è sicuramente Luigi Pelan-di con numerosi contributi: Dal prato di Sant’Antonio a piazza Dante. La piazza Baro-ni e i suoi spettacoli, in «Rivista di Bergamo», IV (1925), fasc. 48, pp. 2637-2646; I tea-tri di Bergamo dal provvisionale al Riccardi, in «Rivista di Bergamo», aprile 1928, pp.113-121; Ha centosessant’anni il nostro teatro Donizetti, in «Eco di Bergamo», 19 settem-bre 1950; Vicende storiche del massimo teatro bergamasco nel 1800 nel ricostruito Riccardisi facevan lotterie e si giocava a tombola, in «Eco di Bergamo», 21 settembre 1950, Tea-tri scomparsi. Il teatro della Cittadella ed il Cerri nel palazzo della Ragione, in «Gazzetta diBergamo», luglio 1952, pp. 17-18. Un primo tentativo di riassumere i principali spet-tacoli d’opera tra Sei e Settecento è contenuto in L. Pilon, Il Teatro della Società di Ber-gamo Alta, in «Bergamo Arte», IV (giugno 1973) n. 14, pp. 5-20: 5-8, mentre una par-ziale ricostruzione del sistema teatrale urbano dal punto di vista architettonico sitrova in F. Buonincontri, Il sistema teatrale a Bergamo tra il XVIII e il XIX secolo, in«Storia della città», 22 (1982), pp. 65-90. Una mostra iconografica sui teatri scom-parsi di Bergamo è stata recentemente realizzata grazie all’impagabile contributo diAndreina Moretti, Viaggio alla ricerca dei teatri scomparsi di Bergamo: mostra iconografi-ca, con la collaboraz. di E. Comuzio, Bergamo, 2003. Sulla storia del Teatro Doni-zetti, già Teatro Riccardi, dal periodo veneto ad oggi si vedano i seguenti lavori: E.Comuzio, Il teatro Donizetti. Due secoli di storia, Bergamo, 1990, 2 voll; Id., Il teatroDonizetti, Bergamo, 1995; Id., A. Moretti, Il Teatro Riccardi ora Teatro Donizetti: raccon-to illustrato 1789-1897, Bergamo, 2004. Ognuno di questi studi si è rivelato preziosoper affrontare la ricerca in questione. Utili ad avere un’idea dell’ambiente musicalebergamasco, infine, sono i saggi di G. Donati Petteni, L’arte della musica in Bergamo,Bergamo, 1930; A. Geddo, Bergamo e la musica: sintesi storico biografica e critica, pre-faz. di F. Abbiati, Bergamo, 1958; P. Forcella, Musica e musicisti a Bergamo. Dalle ori-gini ai contemporanei, Bergamo, 1992.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 18
19
quanto, trattandosi soltanto di un teatro provvisorio, costruito perio-dicamente nei saloni del Palazzo del Capitanio, non sembra necessa-rio svolgere alcuna indagine sistematica finalizzata a chiarirne il reper-torio. Per il Seicento non si è a conoscenza di alcun edificio o salateatrale degna di nota7. L’uso del prato della fiera per la costruzionedei cosiddetti «casotti» di legno a scopo teatrale viene ripetutamentericordato, sebbene sia troppo spesso liquidato in maniera sommariasenza tentare di stabilire quali strutture fossero effettivamente usate etantomeno cercare di definire un qualsiasi processo evolutivo.
La mancanza di teatri pubblici permanenti e l’abituale ricorso ateatri provvisori eretti occasionalmente, caratteristica peculiare di Ber-gamo, avrebbe quindi inficiato lo sviluppo di una vita teatrale citta-dina, rendendola alquanto limitata e di scarso interesse. Considera-zione che ha fatto a lungo desistere dall’approfondimento di un’in-dagine apparentemente troppo esigua. A tutto ciò bisogna associareuna generale tendenza della storiografia italiana a trascurare i secolidi antico regime, in particolar modo il Seicento, come campo di ri-cerca8. Meno negletto il Settecento, momento «delle riforme e del di-battito politico-intellettuale»9. Un secolo, quest’ultimo, che per quan-to riguarda la Serenissima coincise, però, con l’inesorabile declino econ il fallimento di ogni timido tentativo di trasformazione in sensomoderno del sistema amministrativo-istituzionale dell’antico e glo-rioso stato10. Una serie di circostanze che ha portato la storia locale
INTRODUZIONE
7. L’unico lodevole saggio che menziona l’esistenza di un teatro seicentesco, de-nominato Secco Suardo, è quello di M. Mencaroni Zoppetti, Sul teatro Sociale, in«Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo», LXIV (a.a. 2000-2001), Ber-gamo, 2002, pp. 479-487. Nonostante questo indiscutibile merito – unito a quellodi essere accompagnato da una valida ricerca documentaria – tale contributo nonporta alla conclusione che l’acquisizione avrebbe potuto recare, ossia l’attestazionedell’esistenza del primo teatro stabile cittadino. Superficiale è, invece, P. Forcella,Musica e musicisti a Bergamo, cit., p. 34, secondo cui la messa in scena del Tullio Osti-lio (1688) nel Teatro Secco Suardo, sarebbe stata una delle tante rappresentazionioperistiche tenute abitualmente nelle «case patrizie» bergamasche.
8. «La Cenerentola della storiografia italiana» secondo D. Sella, L’Italia del Sei-cento, Bari, 2000, prefazione.
9. M. Verga, Appunti per una storia politica del granducato di Cosimo III (1670-1723),in F. Angiolini, V. Becagli, M. Verga (a cura di), La Toscana nell’età di Cosimo III, At-ti del convegno (Pisa-Firenze 1990), Firenze, 1993 pp. 335-354: 336.
10. M. Berengo, Il problema politico-sociale di Venezia e della sua Terraferma, in Laciviltà veneziana del Settecento, Firenze, 1960, pp. 69-96.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 19
20
bergamasca a privilegiare a lungo gli studi sul passato medievale e co-munale, a discapito del periodo veneto, reputato un momento di «sto-ria provinciale»11. Primo a superare tale pregiudizio è Bortolo Belot-ti. Dopo la sua opera, e grazie ad un recente rinnovato interesse cheha prodotto la pubblicazione di numerose fonti documentarie, lacreazione di strumenti idonei per la consultazione dei fondi dell’Ar-chivio Storico del Comune conservati in Biblioteca Angelo Mai, ol-tre che di ricerche mirate su alcune delle principali istituzioni citta-dine, sono stati molti i passi compiuti12. Sembra perciò arrivato il mo-mento anche per una storia unitaria e coerente dei teatri di Bergamoin antico regime.
FRANCESCA FANTAPPIÈ
11. S. Rota, Per una storia dei rapporti fra Bergamo e Venezia durante il periodo delladominazione (secoli XV-XVIII). Rassegna bibliografica, Comune di Bergamo, Assessora-to alla Cultura, 1987, p. 28.
12. Per lo stato della questione negli anni Ottanta del Novecento, dalle carenzedi tipo bibliografico alle difficoltà esistenti nella ricerca documentaria, fino ai pro-getti messi in campo per la ricognizione e l’ordinamento del patrimonio archivisti-co si veda S. Rota, Per una storia dei rapporti fra Bergamo e Venezia, cit., pp. 7-14. Mol-ta strada da allora è stata percorsa. Segnalo qui alcuni dei contributi che, a mio pa-rere, risultano fondamentali per un avanzamento della ricerca relativa al periodo del-la dominazione veneta. Tra le pubblicazioni di fonti vanno ricordate quella del ca-tastico del capitanio Giovanni Da Lezze del 1596 e la descrizione di Bergamo in ter-za rima di Giovan Battista Angelini del 1720: G. Da Lezze, Descrizione di Bergamo esuo territorio 1596, a cura di V. Marchetti e L. Pagani, Bergamo, 1988 e G.B. Angeli-ni, Per darti notizie del paese: descrizione di Bergamo in terza rima 1720, a cura di V. Mar-chetti, con la collaborazione di D. Polini, Bergamo, 2002. Tra le monografie quellasulla fiera di Sant’Alessandro di M. Gelfi, La fiera di Bergamo: il volto di una città at-traverso i rapporti commerciali, presentazione di L. Pagani, postafazione G. Della Va-lentina, Bergamo, 1993 e lo studio sull’Ospedale Maggiore di Bergamo di M. Men-caroni Zoppetti (a cura di), L’ospedale nella città. Vicende storiche e architettoniche dellaCasa Grande di S. Marco, Bergamo, 2002. Altrettanto utili sono i ben quindici volu-mi usciti sotto la serie Storia economica e sociale di Bergamo tra il 1993 e il 2006 a cu-ra della Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo. In Archivio diStato l’accesso ai documenti notarili è reso agile dall’inventario di J. Schiavini Trez-zi, Dal Collegio dei notai all’Archivio notarile: fonti per la storia del notariato a Bergamo,Bergamo, 1997. A questo lavoro va aggiunto, come ulteriore strumento d’indaginesull’ambiente culturale cittadino, l’inventario dell’Ateneo che contiene numerose in-formazioni sull’accademia degli Eccitati e degli Arvali: Id., Ateneo di Scienze, Lettereed Arti di Bergamo. Inventario dell’archivio (secoli XVII-XX), Bergamo, 2005. Per quan-to riguarda gli strumenti di consultazione dei fondi archivistici della Biblioteca Ci-vica Angelo Mai il riordinamento, tuttora in corso, ha portato alla possibilità di ac-cedere agli inventari direttamente in rete.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 20
21
Se i teatri stabili non c’erano, l’attività teatrale era presente. È que-sta la peculiarità della città. Una differenza così netta tra l’esperienzabergamasca e quella degli altri centri urbani soggetti alla Repubblicaveneta che rende l’argomento particolarmente stimolante. In nettocontrasto con la situazione “logicistica” esposta sono, infatti, le testi-monianze librettistiche e gli epistolari dei comici dell’arte. Le primeconfermano l’allestimento di rappresentazioni operistiche almeno dal-la seconda metà del Seicento registrando l’esistenza, seppur breve, diun edificio teatrale stabile detto Secco Suardo; attestano, inoltre, laprogressiva ascesa del teatro musicale per tutto il Settecento, nel cor-so del quale si affermò a Bergamo, come nel resto d’Italia, l’opera buf-fa13. I secondi, ossia i carteggi degli attori, cui vanno aggiunti gli av-visi teatrali, permettono di stabilire il passaggio per la città di compa-gnie rinomate e conosciute nel resto della Penisola14. La mancanza diun riconoscimento urbanistico al fenomeno teatrale non impedì, quin-di, la sua affermazione. Ma quali furono i motivi dell’assenza di unluogo stabile? Dove avvenivano le rappresentazioni? Come si stabi-lizzarono progressivamente due stagioni teatrali, quella del Carneva-le in Città Alta e quella della fiera nei Borghi, in mancanza di edificipermanenti?
Trattandosi di un terreno quasi totalmente vergine, l’avanzamen-to generale della ricerca archivistica non poteva che essere, come è sta-to in molti casi, del tutto pioneristico. Una difficoltà ulteriormenteaccresciuta dalla dispersione di una buona parte del materiale docu-mentario. Diamo sinteticamente conto del procedimento. Il primopasso è stato quella della ricognizione completa del materiale libret-tistico15. Poiché il dato più notevole che ne derivava era l’attestazio-
INTRODUZIONE
13. Per un’idea sommaria delle opere musicali tenute a Bergamo tra Sei e Sette-cento si veda C. Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, Indici, vol. I,Cuneo, 1993, alla voce Bergamo, pp. 7-8.
14. Per la presenza di compagnie di attori professionisti nel secondo Seicento siveda S. Monaldini, L’orto dell’Esperidi. Musici, attori e artisti nel patrocinio della famigliaBentivoglio (1646-1685), Lucca, 2000. Per la seconda metà del secolo successivo: O.Giardi, I comici dell’arte perduta. Le compagnie comiche italiane alla fine del secolo XVII,Roma, 1991.
15. Strumento primario per la ricostruzione della diffusione del genere operisti-co è il catalogo di C. Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, 7 voll., Cu-neo, 1990-1994. Partendo dall’elenco delle rappresentazioni operistiche registrate aBergamo fornito da questo fondamentale lavoro, si è deciso di reperire almeno uno
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 21
22
ne dell’esistenza di un teatro nobiliare nella seconda metà del Seicen-to, la ricerca è stata inizialmente focalizzata sul promotore dell’inizia-tiva, il conte Giuseppe Secco Suardo, al fine di definirne la persona-lità e gli intenti. Tutto ciò è stato possibile grazie ad un’indagine sul-l’archivio familiare, tuttora esistente a Lurano, e sui documenti nota-rili dell’Archivio di Stato di Bergamo16. In parallelo è stato eseguitouno spoglio completo di alcuni fondi dell’Archivio Storico del Co-mune di Bergamo, conservati presso la Biblioteca Civica Angelo Mai,quali le deliberazioni dei Consigli Maggiore e Minore e le supplicheloro presentate; materiale che ha permesso di definire l’atteggiamen-to generale della municipalità bergamasca e la legislazione teatrale daessa prodotta, oltre che la presenza, finora sconosciuta, di alcuni ar-tisti17. Per definire i rapporti con il potere veneziano l’indagine si è
FRANCESCA FANTAPPIÈ
dei libretti ivi segnalati, dal quale sono state successivamente tratte le indicazionifondamentali relative ad ogni spettacolo (si veda in proposito la sezione Cronologiadi questo libro). Lo spoglio effettuato, sebbene tale consultazione non sia semprestata agile, è completo. Il materiale librettistico bergamasco, infatti, con l’eccezionedi alcuni nuclei più consistenti – quali quelli conservati a Bergamo nella BibliotecaCivica Angelo Mai, a Milano nella Biblioteca Braidense e nella Biblioteca Ambro-siana, a Venezia nella Fondazione Giorgio Cini e nella Casa Goldoni – è dispersoin numerose collezioni sia in Italia sia all’estero. Nel reperimento delle riproduzio-ni dei libretti conservati in Canada (Thomas Fisher Rare Book Library dell’Univer-sità di Toronto) e negli Stati Uniti (Library of Congress di Washington D. C.) devoringraziare, per la solerzia e l’indispensabile aiuto, il prof. Gianni Cicali. Per quan-to riguarda quelli conservati nella Music Library di Berkeley dell’University of Ca-lifornia la mia amica Maia Gahtan e sua madre Evelyn. La signora Barbara Walkerper la consultazione della Biblioteca privata di Thomas Walker di Ferrara. Per le co-pie dei libretti conservati a Parma (Biblioteca del Conservatorio), a Padova (Biblio-teca del Museo Civico), a Rovigo (Accademia dei Concordi), negli Stati Uniti (Mu-sic Library di Austin, University of Texas), in Germania (Harburg über Donauwörth,Fürslich Öttingen-Wallerstein’sche Bibliotheck), l’efficiente sollecitudine del dott. An-drea Pelliccioli del prestito interbibliotecario della Biblioteca Angelo Mai.
16. L’archivio familiare della famiglia è conservato nell’antica villa di Lurano, se-de attuale dell’Associazione Giovanni Secco Suardo. La consultazione del materia-le è possibile attraverso due inventari, uno descrittivo e analitico, l’altro più sinteti-co denominato Censimento, messi a disposizione dal conte Lanfranco Secco Suardo,ultimo discendente maschile della dinastia, a cui vanno tutti i miei più sinceri rin-graziamenti per la gentilezza, la simpatia, l’entusiasmo e la curiosità con cui ha se-guito la ricerca da me intrapresa.
17. Lo spoglio sulle Azioni del Comune di Bergamo è stato eseguito attraversol’Indice alfabetico delle azioni. Repertorio dattiloscritto, in Salone Furietti AR 3 (1-3), re-pertorio ottocentesco delle materie di deliberazione dei Consigli. L’uso di questo
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 22
23
poi concentrata sul materiale prodotto dai due rettori veneti: il pode-stà e il capitanio18. La perdita di una parte di questa documentazioneha determinato la decisione di colmare il vuoto di informazioni esi-stente negli archivi cittadini con lo spoglio di alcuni fondi dell’Archi-vio di Stato di Venezia, ottenendo risultati talvolta inattesi19.
Le notizie reperite hanno successivamente permesso di dirigere laricerca su un’ulteriore raccolta archivistica, quella dell’Ospedale Mag-giore di Bergamo, principale ente assistenziale della città, a cui spet-tavano i proventi dell’affitto del fondo su cui veniva costruito annual-mente il teatro di fiera20. Sebbene la perdita di buona parte del mate-
INTRODUZIONE
strumento mi è stato gentilmente suggerito dal dott. Sandro Buzzetti che vorrei rin-graziare non solo per il prezioso aiuto prestatomi in questo caso, ma anche in tuttele innumerevoli altre circostanze, nonché per la sua cortesia e pazienza. Se lo spo-glio delle Azioni è stato eseguito attraverso un indice, quello delle Suppliche è inve-ce stato completo. A questo si sono aggiunti alcuni riscontri ad annum nella serieRelazioni ai Consigli e nel Collegio delle affittanze. Tra i fondi non consultati che riten-go potrebbero portare approfondimenti, vi sono sicuramente le Lettere degli Oratorie del Nunzio in Venezia, raccolte sotto la serie Corrispondenza comunale, e gli atti del-l’Ufficio Pretorio. Le titolazioni in quest’ultimo caso provengono dal nuovo inventa-rio, in corso d’opera, cui ho avuto accesso grazie alla disponibilità della dott.ssa Fran-cesca Giupponi, alla quale vanno ovviamente i miei ringraziamenti per avermenefornito gentilmente una copia. Alla ricerca sui fondi dell’Archivio Storico del Co-mune si sono, infine, aggiunti alcuni controlli in archivi familiari, quali il fondo Vi-mercati Sozzi, e la consultazione della raccolta di Proclami, anche detta Raccolta di du-cali, atti, terminazioni riguardanti la città di Bergamo.
18. Uno spoglio purtroppo deludente. Per quanto riguarda il podestà esistono,infatti, due serie denominate Atti della Cancelleria pretoria e Lettere. Nonostante la ti-tolazione non siamo però di fronte a carteggi, ma ad atti di natura giudiziaria e sen-tenze. Ciò che resta del materiale prodotto dal capitanio è, invece, praticamente nul-lo. I cosiddetti Registri di ducali, così come gli Atti della cancelleria prefettizia sono nu-mericamente troppo esigui e insufficienti ad impostare un qualsiasi tentativo d’in-dagine. Una lacuna estremamente dolorosa, considerando che i saloni del palazzodel capitanio costituivano uno dei luoghi teatrali abituali della Città Alta.
19. La ricerca ha puntato al reperimento dei carteggi dei rettori e degli organiveneziani preposti al controllo della Terraferma con la Dominante. I maggiori risul-tati sono derivati dai Dispacci dei Rettori, dal Senato. Terra, dal Consiglio dei Dieci. Par-ti comuni e infine degli Inquisitori di Stato. Per ovvie ragioni lo spoglio di questi fon-di è stato parziale e mirato, eseguito in base alle acquisizioni raggiunte nel corso diun’indagine preventiva svolta nei fondi documentari conservati a Bergamo.
20. Ciò che resta del materiale documentario prodotto in epoca veneta dall’ar-chivio dell’Ospedale Maggiore di Santa Maria e San Marco è attualmente conserva-to nella biblioteca medica degli Ospedali Riuniti di Bergamo. In questo caso siamoprobabilmente di fronte ad una delle maggiori perdite archivistiche della città, in
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 23
24
riale prodotto da questa istituzione non abbia permesso una ricogni-zione esaustiva delle notizie, lo spoglio di ciò che è rimasto ha chia-rito alcuni meccanismi relativi alla periodica erezione dei teatri prov-visori, oltre ad attestare la presenza di impresari e di compagnie di at-tori21. Le raccolte di avvisi teatrali conservate presso la Biblioteca Ci-vica Angelo Mai, i documenti relativi ai primi anni di esistenza delTeatro Riccardi conservati all’Archivio di Stato di Bergamo, gli Indicidei teatrali spettacoli editi nella seconda metà del Settecento, gli episto-lari degli attori professionisti, hanno infine permesso di completarele notizie relative alla circolazione di repertori ed artisti22.
FRANCESCA FANTAPPIÈ
quanto si tratta una quantità veramente esigua rispetto a quella verosimilmente pro-dotta da un’istituzione la cui influenza nella storia di Bergamo è stata tanto impo-nente e duratura. A tutto ciò si aggiunga che non esiste un inventario per la sua con-sultazione, ma un semplice elenco di consistenza. La difficoltà della ricerca è in par-te mitigata dalla disponibilità dei funzionari addetti alla biblioteca, per cui tengo aringraziare in particolare la dott.ssa Franca Boschini.
21. Fondamentale è stato lo spoglio di ciò che resta del materiale contabile, os-sia dei libri mastri dell’istituzione che, sorprendentemente, non si trovano nella bi-blioteca medica degli Ospedali Riuniti, ma sono conservati alla Fondazione Leglerdi Ponte San Pietro, ente che custodisce i documenti prodotti dall’Ospedale Mag-giore nel periodo ottocentesco e post-unitario. Riuscire a reperirli non è stato quin-di facile, ma il suggerimento mi è stato dato dalla prof.ssa Juanita Schiavini che col-go l’occasione per ringraziare. La serie purtroppo non è completa. Alcuni volumisono mancanti, mentre quelli rimasti sono talvolta mutili. Per la disponibilità nel-l’accesso alla loro consultazione, oltre che per lo scambio d’idee avuto nel corso del-la ricerca, ringrazio l’archivista della Fondazione dott.ssa Michela Gatti.
22. Un fondamentale nucleo di avvisi teatrali è conservato nella raccolta dell’av-vocato Francesco Maria Quarenghi, sotto la serie denominata Ducali et altre cose di-verse, consistente in 45 volumi, cui bisogna aggiungere quella detta Documenti di ca-sa Quarenghi composta, purtroppo, da soli 19 tomi sui 109 un tempo esistenti. In en-trambi i casi lo spoglio è stato completo e ha portato a constatare, per ciascun vo-lume, una cospicua perdita di materiale. Molti sono, infatti, mutili. Non è stato in-vece consultato il resto della collezione: né la serie che va sotto il nome Casi seguiti(223 volumi), né quella denominata Cose attinenti alle mani morte della Repubblica diVenezia (22 volumi). Tutto ciò in considerazione della natura prevalentemente giu-ridica del materiale ivi conservato. Ciononostante, alla luce della passione per il tea-tro dimostrata da Francesco Maria Quarenghi, fratello del famoso architetto Giaco-mo, l’ipotesi che anche in questa parte della collezione sia possibile reperire notiziedi ambito teatrale non è da scartare. Per quanto riguarda gli Indici de’ teatrali spetta-coli la loro consultazione è stata inizialmente effettuata attraverso il saggio di O. Giar-di, I comici dell’arte perduta, cit. In un secondo tempo direttamente sugli indici ripro-dotti, in versione anastatica, in R. Verti (a cura di), Un almanacco drammatico. L’indi-ce de’ teatrali spettacoli 1764-1823, 2 voll., Pesaro, 1996. Relativamente agli ultimi an-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 24
25
I risultati della ricerca portano alla seguente conclusione: il proces-so di edificazione di un teatro stabile a Bergamo seguì le principalitendenze delle altre città della Terraferma veneta, senza arrivare maial loro compimento. Al pari di quanto riscontrabile in altre realtà mu-nicipali assistiamo, infatti, alla nascita di un edificio teatrale privatoa conduzione impresariale, a varie iniziative di edificazione di teatria conduzione sociale, all’uso di spazi pubblici offerti dai palazzi delpotere. I tentativi furono molti e di diverso tipo, ma tutti fallimenta-ri. Nonostante la provvisorietà delle strutture, gli spazi preposti allerappresentazioni erano costanti, mentre la formazione di due stagio-ni, costituite dal Carnevale e dalla fiera d’agosto, fu quasi immedia-ta. Se quella invernale fu la principale nel Seicento, nel corso del se-colo successivo, e in concomitanza con la crescita demografica dei Bor-ghi, quella estiva si attestò come la più prestigiosa. Se quindi il teatroci fu, ma non lasciò tracce architettoniche, in quanto gli venne a lun-go negata una dignità urbanistica, la domanda più interessante diven-ta, non tanto come venivano accolti gli artisti, ma perché questa man-canza, perché un ritardo così protratto nel tempo, tale da assumerel’aspetto di un’interdizione non scritta, ma a tutti ben nota, quasi unasorta di tabù o horror theatri?
Le motivazioni di questa assenza, nel caso di Bergamo, sono mol-teplici. Tutte concorrono a determinare il fenomeno, senza che nes-suna possa essere elevata a causa principale. Vediamo, innanzitutto,quelle politiche. Da parte dei rettori, esponenti del potere centrale, siriscontra solo raramente un’opera di patrocinio in ambito teatrale, néla loro breve durata in carica avrebbe permesso che tale promozioneportasse a risultati duraturi. Per quanto riguarda le autorità munici-pali, esponenti della classe dirigente bergamasca, si osserva che rima-sero tenacemente in una posizione di evidente e strenua marginalità,esprimendo spesso una mentalità fortemente contraria alla stabilizza-zione di un sistema teatrale urbanisticamente riconosciuto. Una par-ziale spiegazione di ciò è da ricercare nella cultura cittadina predo-
INTRODUZIONE
ni della dominazione veneta, infine, la ricerca ha tratto particolare giovamento dal-la consultazione del materiale conservato in Archivio di Stato di Bergamo, Diparti-mento del Serio, Spettacoli pubblici. Ci preme, infine, notare che in merito alle notizierelative al periodo di antico regime contenute nella raccolta privata Ugo Pelandi, giàconosciuta e diffusamente spogliata da Andreina Moretti e da Ermanno Comuzio,si è fatto riferimento ai saggi dei suddetti studiosi, i quali ne hanno da tempo dataun’ampia ed esaustiva ricognizione.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 25
26
minante, fondamentalmente ecclesiastica, poco incline ad accettaresenza riserva l’espansione del teatro operistico a pagamento e gene-ralmente contraria all’espansione del professionismo attorico23. Se lalotta della chiesa contro il teatro pubblico mercenario, visto come mo-ralmente dannoso e socialmente pericoloso, cadde inascoltata in al-tre città della Terraferma, a Bergamo trovò un terreno più fertile24.L’opposizione delle autorità locali al teatro profano mostrò solo ra-ramente timidi segni di apertura. Questo fatto portò la città soggettaa staccarsi nettamente dalla Dominante, centro propulsore dell’espan-sione del fenomeno impresariale musicale, regno dei teatri a pagamen-to a regime concorrenziale, meta delle maggiori formazioni di attoriprofessionisti oltre che sede delle prime compagnie stanziali. L’assen-za di teatri stabili giunse, perciò, ad assumere i tratti di un caratteredistintivo.
Un clima culturale conservatore, la debolezza delle autorità poli-tiche, la probabile incidenza del potere ecclesiastico, la volontà di di-stinguersi da Venezia, non sono però motivazioni sufficienti a spiega-re l’assenza di teatri stabili. Il problema di fondo appare, infatti, la de-bolezza delle iniziative promosse dalla società bergamasca. Una com-pagine cittadina estremamente disorganica, caratterizzata da un forteantagonismo interno alla classe dominante espressa appunto dai con-sigli municipali, non permise alcuna azione concorde nel consegui-mento di uno scopo comune. I tentativi operati furono episodici egeneralmente disomogenei. Le istanze civili che avrebbero potuto de-terminare il compimento del desiderio di dotare la città di un teatro
FRANCESCA FANTAPPIÈ
23. Per una disamina in merito alla polemica antiteatrale seguita al Concilio diTrento, alle motivazioni e alle diverse posizioni interne alla Chiesa cattolica si ve-dano F. Taviani, La commedia dell’arte e la società barocca. La fascinazione del teatro, Ro-ma, 1969; F. Taviani, M. Schino, Il segreto della Commedia dell’Arte. La memoria dellecompagnie italiane del XVI, XVII e XVIII secolo, Firenze, 1982, p. 379 e ss. L’opposi-zione al teatro professionistico non fu una caratteristica tipica della religione catto-lica. In Europa calvinisti, protestanti, anglicani furono altrettanto impegnati in unalotta contro il fenomeno, cfr. R. Zacchi, La scena contestata, Napoli, 2006; D. Pallot-ti, P. Pugliatti, La guerra dei teatri. Le controversie sul teatro in Europa dal secolo XVI allafine dell’Ancien Régime, Pisa, 2008.
24. A Udine il Teatro Mantica (1676-1754) venne fatto distruggere dalla curia,perché troppo vicino al Duomo cittadino. Nel 1739 a Brescia i rifacimenti del Tea-tro degli Erranti scatenarono l’indignazione del cardinale Angelo Maria Querini chepatrocinava la riapertura del cantiere del Duomo. Nel 1768 a Feltre l’incendio delteatro pubblico venne letto come segno della Divina Provvidenza, cfr. Infra, p. 140.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 26
27
permanente, nel caso in cui provarono a trovare un’espressione, fu-rono regolarmente frustrate dalle forti competizioni interne al ceto no-biliare e, nel corso del Settecento, dalle irrisolte tensioni con quelloborghese emergente che solo la rivoluzione bergamasca del 1797 riu-scì a risolvere.
Un’ultima motivazione, non certo secondaria, che concorse a da-re a Bergamo una collocazione marginale all’interno dei circuiti tea-trali del centro-nord della penisola, fu sicuramente la sua posizionegeograficamente e politicamente periferica. Non a caso, uno dei to-poi più diffusi, soprattutto tra gli attori professionisti, è quello delladifficoltà di raggiungere il «solitario soggiorno»25. Le compagnie stan-ziali che partivano da Venezia, in particolare, vi arrivavano solo do-po un lungo tragitto, tenendola come ultima destinazione e riservan-do le tappe principali delle proprie tournée alle città demograficamen-te più grandi e vicine alla Dominante. Avamposto della Terrafermaveneta, nel corso della seconda metà del Settecento iniziò ad acco-gliere con una certa continuità anche artisti e maestranze provenien-ti da Milano. La naturale propensione di Bergamo verso questa cit-tà, potè avere libero sfogo solo nell’Ottocento, quando non vi fu piùalcuna divisione politica tra le due, e coincise non a caso con l’esplo-sione del teatro operistico e in prosa, non ultima con l’esperienza do-nizettiana.
Storia di un teatro che non si fa, quindi. Pur trattandosi di una sto-ria “al negativo”, o forse proprio per questo, tanto più interessante.Ennesima riprova di quanto politica, società e cultura siano legati alfenomeno “teatro”, sintomatico della realtà che lo produce e di essariflesso, specchio del suo pubblico che ne è allo stesso tempo promo-tore e testimone.
INTRODUZIONE
25. Documento 1750: 5, in Regesto. Si veda il caso della compagnia di OdoardoPalazzi nel 1672 e quella di Antonio Sacco nel 1772, cfr. Infra, pp. 129-130, 151-152.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 27
29
1. Il sistema teatrale delle città della Terraferma veneta
Strumento indispensabile per tracciare un quadro generale della for-mazione dei sistemi teatrali urbani della Terraferma veneta è il censi-mento dei teatri storici dell’attuale regione Veneto, che comprende Bas-sano, Belluno, Feltre, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza e Treviso1. Unlavoro che, purtroppo, non tiene conto di Bergamo, Brescia e Crema,città lombarde, ma poste sotto il dominio veneziano in età di anticoregime, così come manca Udine2. Assenze che, tuttavia, non impedi-scono di poter desumere alcune linee di tendenza generali, utili a chia-rire i rapporti tra potere centrale e ceti dirigenti locali nella creazionedi ciascun sistema teatrale: nella fattispecie le relazioni non semprefacili intercorrenti tra le oligarchie patrizie rappresentate nei Consiglicomunali e i rettori veneti esponenti della Dominante.
Una preliminare divisione nella geografia teatrale della Terrafermaveneta può essere attuata tra centri teatrali minori e maggiori3. Tra le
1. F. Mancini, M.T. Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, 5 voll., Venezia, 1985-2000.
2. Sui teatri storici di Udine è disponibile il censimento di C. Burino, C. Gar-bari, A.K. Jelen, P. Patui (a cura di), Alla ricerca dei teatri perduti: appunti per una storiadelle sale teatrali nel Friuli Venezia Giulia, Udine, 1990. Sui teatri di Brescia rimandia-mo almeno a V. Frati, Il Teatro Grande di Brescia. Spazio urbano forme istituzioni nellastoria di una struttura culturale, 2 voll., Brescia, 1985 e R. Robecchi, Il Teatro Sociale diBrescia, Brescia, 2000.
3. La divisione è stata operata sulla base di una valutazione di massima, metten-do insieme i dati demografici, la presenza di uno o due rettori, la complessità di cia-scun sistema teatrale, la differenziazione delle stagioni e la ricchezza del repertorio.Per quanto riguarda la popolazione della Repubblica veneta si vedano D. Beltrami,
FRANCESCA FANTAPPIÈ
PARTE I.Potere e teatro nella Repubblica veneta
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 29
30
FRANCESCA FANTAPPIÈ
città più attive in ambito teatrale vi furono sicuramente Brescia, Pa-dova, Verona e Vicenza, cui seguono per ordine di importanza Trevi-so e Udine, mentre Bassano, Belluno, Crema, Feltre e Rovigo appa-iono piazze teatrali secondarie. In generale, verso ognuna di esse, Ve-nezia riversava la propria produzione operistica, che si rivelò ovun-que egemone e, nel corso del Settecento, le compagnie di attori stan-ziali attive nei propri teatri cittadini4.
Ciò che bisogna innanzitutto sottolineare è che, contrariamentea quanto si potrebbe ingenuamente ritenere sulla scorta della sto-ria della Serenissima, città con la più alta densità di edifici teatraliin epoca di antico regime e la prima in cui si affermò con decisio-ne un sistema produttivo di matrice impresariale altamente compe-titivo, il potere veneziano non fu altrettanto liberale nei confrontidi centri urbani posti sotto il proprio dominio. Viceversa la nasci-ta di nuovi teatri nelle città soggette non venne sempre vista dibuon occhio e, nel corso del Settecento, iniziò ad essere percepitacome una materia non più relegabile alla discrezionalità di ciascunpotere locale, ma tema su cui esprimere una chiara normativa in se-de di potere centrale. È così che, allo scopo di controllare la nasci-ta di nuovi teatri nel territorio della Repubblica e di arginare la lo-ro proliferazione, Venezia impose, con una deliberazione del Con-siglio dei Dieci del 10 novembre 1756, il limite di soli due teatriper ogni città5.
Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica,Padova, 1954, p. 68; G. Beloch, La popolazione d’Italia nei secoli sedicesimo, diciassette-simo e diciottesimo, in Storia dell’economia italiana, a cura di C.M. Cipolla, vol. I, Seco-li settimo – diciassettesimo, Torino, 1959, pp. 449-500: 476-482; M. Ginatempo, L. San-dri, L’Italia delle città. Il popolamento urbano tra Medioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVII),Firenze, 1990, pp. 79, 250-251, mentre fondamentale studio demografico sul terri-torio bergamasco è quello di L. Pagani, Le condizioni demografiche ed economiche di Ber-gamo e del suo territorio secondo l’anagrafe veneta del 1766, in «Atti dell’Ateneo di Scien-ze, Lettere ed Arti di Bergamo», XLII (a.a. 1980-1982), Bergamo, 1983, pp. 77-116.Sulla distribuzione dei rettori veneti nella Terraferma, cfr. L. Pezzolo, Podestà e capi-tani nella Terraferma veneta (secoli XV-XVIII), in Venezia e le Istituzioni di Terraferma, Ber-gamo, 1988, pp. 57-65.
4. P. Bosisio, Goldoni e il teatro comico, in Storia del teatro moderno e contemporaneo.Il grande teatro borghese. Settecento-Ottocento, Torino, 2000, pp. 137-188: 139; P. Fabbri,Il secolo cantante. Per una storia del libretto d’opera nel Seicento, Bologna, 1990.
5. Documento 1756: 1, in Regesto. Una copia del documento, conservata nel Mu-seo Civico di Padova, è riportata in F. Mancini, M.T. Muraro, E. Povoledo, I teatridel veneto, vol. III: Padova Rovigo e il loro territorio, Venezia, 1988, p. 33.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 30
31
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
In secondo luogo vediamo che, nonostante sia possibile delinearealcune linee evolutive, ogni centro urbano costituiva un caso a se stan-te, per motivi geografici (essere o meno sulle principali vie di transi-to degli artisti), culturali (la presenza di accademie o di università), so-ciali e politici (una classe dirigente locale compatta oppure divisa dacontrasti interni). Tuttavia possiamo suddividere i vari episodi in ba-se alle istanze che resero possibile la costruzione dei teatri cittadini ele modalità di attuazione di ciascuna iniziativa, in tre diverse tipolo-gie. La prima è quella degli edifici teatrali, talvolta occasionali, erettinei palazzi del potere, adattando le sale preposte ai Consigli comu-nali o quelle di rappresentanza dei rettori veneti, fenomeno tipico delCinquecento e della prima metà del Seicento. La seconda è quella deiteatri nati per iniziativa privata, spesso per volontà di una famiglia emi-nente della nobiltà locale che, sull’esempio delle principali casate gen-tilizie veneziane, convertì allo scopo teatrale stabili di proprietà colfine esplicito di istituire un’impresa commerciale, fenomeno diffusodalla seconda metà del Seicento. La terza è quella accademica o so-ciale, molto diffusa nella seconda metà del Settecento, momento incui assistiamo alla nascita di numerosi sodalizi nobiliari che, previopagamento di una quota del capitale da parte di ciascun associato, spes-so costituita dall’acquisto di un palchetto, si affermarono come prin-cipali promotori nell’ere zione di nuovi teatri. In tutti e tre i casi i ret-tori veneti, anche quando misero a disposizione una sala dei palazzicittadini da loro occupati, non svolsero alcuna opera esplicita di pro-mozione, limitandosi ad esercitare una funzione di vigilanza e garan-zia dell’ordine pubblico. Nel caso in cui si trovarono a rivestire unruolo di mecenati, la loro durata in carica era troppo breve perché sipotessero creare meccanismi automatici, tali da rendere l’offerta tea-trale meno fragile e non esclusivamente legata alla discrezionalità delloro potere.
Per tutte le città vale, però, una regola generale. La motivazioneprevalente che portò all’erezione dei singoli teatri fu la necessità di al-lestire decorosamente le rappresentazioni musicali, mentre la tipolo-gia di luoghi destinati ad accogliere gli attori professionisti appare mol-to più variegata. Questa funzione, almeno inizialmente, venne deman-data a teatri provvisori costruiti all’aperto, mentre l’uso polivalente(prosa-musica) di alcuni edifici teatrali, nati inizialmente per l’opera,si diffuse solo nel Settecento. Per quanto riguarda i sistemi di produ-zione del teatro musicale, normalmente suddivisi in cortigiano, im-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 31
32
FRANCESCA FANTAPPIÈ
presariale e misto, risulta difficile operare un riscontro puntuale nel-la particolare situazione della Repubblica veneta6. L’assenza di una cor-te determinò, ovviamente, la totale assenza del primo modello. Tragli altri due vediamo come quello impresariale fu il più incisivo nel-la diffusione del teatro professionistico, in particolare dell’opera. Gliimpresari, infatti, si muovevano tra le varie città della Terraferma, por-tando con sé testi e musica, oltre che i cast da loro scritturati, agendoin diverse tipologie di luoghi, dai teatri privati, a quelli ricavati nellesale comunali o dei rettori, ai teatri accademici o sociali. Erano, quin-di, gli spazi che li accoglievano a presentare differenti modi operati-vi, né i teatri privati furono più aperti di quelli sociali nell’accogliereil fenomeno, in quanto le due tipologie si diffusero in misura unifor-me. La nascita di teatri pubblici non dipese tanto dalla maggiore for-za intrinseca di una delle due rispetto all’altra, quanto dalla partico-lare situazione socio-culturale di ogni singola città7. La natura fram-mentaria e disorganica della Repubblica veneta, il ricorso ad una con-tinua contrattazione politico-amministrativa tra poteri locali e Domi-nante nell’ammi nistrazione dello stato, trovò riflesso, quindi, nella va-rietà dei sistemi teatrali cittadini. La differente influenza del poterecentrale sulle diverse aree della Terraferma può essere riscontrata nel-la strutturazione di ciascun sistema teatrale urbano: al pari di quanto
6. Per una suddivisione dei tre modelli produttivi si veda L. Bianconi, T. Wal-ker, Forme di produzione del teatro d’opera italiano nel Seicento, cit., pp. 221-257. Sul ri-lievo delle accademie teatrali nella promozione del fenomeno S. Mazzoni, Lo spet-tacolo delle accademie, in Storia del teatro moderno e contemporaneo. La nascita del teatromoderno, Torino, 2000, pp. 880-894.
7. Solo parzialmente utilizzabile risulta, perciò, lo schema proposto da F. Piper-no, Il sistema produttivo fino al 1780, cit., pp. 3-73: pp. 3-4, che suddivide tra «promo-tori», «realizzatori» e «destinatari». Nel caso dei teatri della Terraferma veneta all’in-terno della casella promotori vanno inseriti i rettori, le famiglie dell’oligarchia citta-dina e le accademie-società teatrali. Gli impresari, invece, devono essere inclusi, in-sieme al personale specializzato itinerante e alle troupes di attori, nella categoria deirealizzatori. Per quanto riguarda i destinatari la divisione tra «pubblico cortigiano»,«aristocrazia cittadina» e «pubblico pagante» è inattuabile. Siamo, infatti, in totaleassenza della prima tipologia di spettatori, mentre risulta impossibile attuare una di-visione netta tra le ultime due, in quanto le classi più elevate di ciascun centro ur-bano costituivano la parte più cospicua del pubblico. Fondamentale notare come ilceto nobiliare locale, oltre a rivestire la funzione di destinatario, si trovava spesso adassumere anche quella di promotore, sia nel caso dei teatri a conduzione privata siain quello dei teatri sociali.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 32
33
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
successo per le istituzioni politiche, ad esempio, le città più vicine al-la laguna, quali Padova, Treviso e Rovigo, che ebbero una netta pre-valenza dei teatri privati rispetto a tutte le altre tipologie, svilupparo-no un sistema molto più simile a quello di Venezia, rispetto ai centriurbani posti in province più lontane8.
Ma vediamo i singoli casi, partendo dai centri urbani medi e pic-coli. L’uso dei palazzi del potere è un fenomeno riconoscibile a Bas-sano, Belluno, Brescia, Crema, Feltre e Treviso. A Bassano, cittadinache constava di un solo rettore con funzioni anche di capitanio, il pri-mo teatro pubblico (1683-1737) venne eretto al secondo piano del Pa-lazzo Pretorio, ad istanza delle famiglie patrizie più importanti e perconcessione del podestà9. A Belluno il Teatro della Caminada (1619-1831), eretto all’interno del Palazzo della Ragione, nacque per volon-tà dell’oligarchia cittadina espressa dal Consiglio comunale10. A Bre-scia e a Treviso, nel corso del Cinquecento, numerose testimonianzeaccertano l’uso delle sale dei palazzi dei rettori e del Comune per rap-presentazioni drammatiche o esibizioni musicali11. Ad Udine il cosid-detto «teatro mobile» venne utilizzato a più riprese, nella seconda me-tà del Cinquecento, «in loggia, in castello ed in abitazioni nobili e pri-vate», così come il Teatro Contarini (1671-1674) venne realizzato nel-la «sala della Loggia»12. A Crema il primo teatro pubblico, nato nelcorso degli anni Ottanta del Seicento, ad istanza della cittadinanza econ l’avallo del podestà, venne eretto in alcuni locali contigui all’ar-chivio municipale, nella piazza dove sorgevano il Palazzo Pretorio e
8. «In province vicine alla laguna come il Trevigiano, il Padovano e il Polesinela presa delle istituzioni centrali è complessivamente più precoce ed intensa, e quel-la delle istituzioni locali in egual misura più debole»: M. Knapton, Le istituzioni cen-trali per l’amministrazione ed il controllo della Terraferma, in Venezia e le Istituzioni di Ter-raferma, Bergamo, 1988, p. 43.
9. F. Mancini, M.T. Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. II: Verona Bellu-no e il loro territorio, Venezia, 1985, pp. 291-292.
10. Ivi, pp. 354-360.11. Ivi, vol. IV: Treviso e la marca trevigiana,, Venezia, 1994, pp. 37-40; N. Messo-
ra, Il teatro lombardo sotto la Repubblica veneta. Commedie bresciane del ’500, Bergamo,1978.
12. Il primo era un teatro provvisorio che poteva essere costruito in più luoghiteatrali, il secondo un teatro a palchetti, il cui progetto venne abbandonato ben pre-sto per ordine del Consiglio cittadino a causa del timore di incendi: C. Burino, C.Garbari, A.K. Jelen, P. Patui (a cura di), Alla ricerca dei teatri perduti, cit., pp. 30, 34,195.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 33
34
FRANCESCA FANTAPPIÈ
quello comunale13. Il Teatro della Senna di Feltre (1684-1797) nacqueper iniziativa degli esponenti del Consiglio municipale, i quali desti-narono una sala del Palazzo della Ragione a tale scopo14.
L’edificazione di teatri per iniziativa di privati si riscontra a Bassa-no, Rovigo, Treviso e Udine. Nel primo centro urbano troviamo ilTeatro Brocchi (1737) fondato in sostituzione del dismesso teatro nelPalazzo Pretorio15. A Rovigo il Teatro della Campagnella (1683-1727)voluto dalla nobile famiglia omonima, destinato all’opera in musica16.Ad Udine il Teatro Mantica (1676-1754) voluto dal conte Carlo Man-tica e costruito a sue spese in uno stabile di sua proprietà17. A Trevi-so tutti i teatri costruiti tra Sei e Settecento nacquero dalla volontà disingoli esponenti delle maggiori casate gentilizie. Vi furono, infatti, ilTeatro Santa Margherita (1678-1697), primo edificio teatrale della cit-tà edificato con la precisa finalità di adibirlo all’opera in musica a pa-gamento; il Teatro Onigo (1692-1714; 1766-1868), nato con lo stessoscopo e voluto dal conte Fiorino Onigo, ricostruito nel 1766 da Gu-glielmo Onigo, che ospitava anche commedie in prosa; il Teatro Dol-fin (1721-1770; 1774-1854), voluto dalla nobile famiglia Dolfin per fi-ni commerciali, specializzato nell’opera buffa dalla seconda metà delSettecento18.
L’iniziativa sociale-accademica caratterizzò soprattutto Brescia, Udi-ne e in parte Rovigo. Nella prima città vediamo che il teatro degli ac-cademici Erranti (1664-ad oggi) venne eretto per volontà dei membridel sodalizio con l’avallo dei deputati del Consiglio comunale, distin-
13. Documenti 1681: 2; 1683: 1-2, in Regesto. Sulle vicende del primo edificioteatrale pubblico cremasco rimandiamo alla Parte II. 1.1 Le sale del Palazzo della Ra-gione e del Palazzo del Podestà.
14. Come stagione principale, la fiera di San Matteo (settembre). Di questo tea-tro usufruì Carlo Goldoni quando nel 1729, in visita a Feltre, provò ad allestire al-cune sue commedie con la collaborazione della nobiltà cittadina: F. Mancini, M.T.Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. II, cit., p. 350.
15. Ivi, pp. 293-294.16. Ivi, vol. III, cit., pp. 336-337.17. Il teatro venne fatto abbattere dalla curia che non approvava la vicinanza del-
l’edificio, posto tra piazza del Duomo e via San Francesco, con la cattedrale cittadi-na. In suo luogo il patriarca Dolfin fece costruire la Cappella della Purità, cfr. C. Bu-rino, C. Garbari, A.K. Jelen, P. Patui (a cura di), Alla ricerca dei teatri perduti, cit., pp.26, 32, 69, 195; A. Battistella, I vecchi teatri udinesi, Udine, 1929, pp. 6 e 36.
18. F. Mancini, M.T. Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. IV, cit., pp. 43-83.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 34
35
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
guendosi immediatamente come principale polo culturale della vitacittadina19. Ad Udine il Teatro Sociale (1770-1964) nacque per volon-tà di diciannove cittadini, in sostituzione dell’inadeguato Teatro del-la Racchetta (1754-1770)20. A Rovigo il Teatro Manfredini (1698-1851),proprietà di alcuni esponenti della nobiltà con a capo il conte Mar-c’Antonio Manfredini, vide la compresenza di opere in musica a ge-stione impresariale e l’episodico intervento finanziario dei soci nel-l’allestimento di alcune rappresentazioni. Dalla seconda metà del Set-tecento ospitò l’opera buffa, ma anche gli attori professionisti21.
Se per i centri più piccoli prevalse la tipologia di edifici teatrali co-struiti nelle sale del potere, nei centri più grandi troviamo in maggiormisura quella dei teatri nati per iniziativa privata e quella dei teatri dimatrice accademico-sociale. Una delle città del Dominio veneto dal-la vita teatrale più ricca fu sicuramente Padova. Facilmente raggiun-gibile dagli artisti attivi a Venezia e centro universitario tra i più fre-quentati dai rampolli della nobiltà veneta e non solo. La multiformepopolazione studentesca garantiva un pubblico numeroso e deside-roso di intrattenimento, costituendo un motore trainante dell’istanzaspettacolare. Non a caso nel Cinquecento fu sede di numerose acca-demie come gli Infiammati, gli Elevati, i Costanti, gli Eterei, i Rina-
19. Si vedano la voce Brescia di R. Zanetti, in Dizionario enciclopedico universaledella musica e dei musicisti, diretto da A. Basso, Il lessico, vol. I, Torino, 1983, pp. 396-397 e quella di C. Perucchetti in The new Grove dictionary of music and musicians, se-cond edition, edited by Stanley Sadie, vol. IV, London, 2001, pp. 321-323. InoltreR. Robecchi, Il Teatro Sociale di Brescia, 2000. Nel corso degli anni il teatro subì nu-merosi rifacimenti. Quelli inaugurati nel 1739 scatenarono l’indignazione del cardi-nale Angelo Maria Querini vescovo di Brescia il quale, volendo invece patrocinarela riapertura del cantiere del Duomo, espresse il suo parere contrario in un sermo-ne pasquale, cfr. V. Frati, Il Teatro Grande di Brescia, cit., vol. II, pp. 21-22.
20. Il Teatro della Racchetta deve il nome alla sala in cui venne costruito, origi-nariamente destinata al «gioco del pallone». Il Teatro della Nobile Società di Udine,costruito su progetto di Tiberio Majeroni, fu dovuto all’iniziativa di diciannove no-bili cittadini associati, i quali si assicurarono gli ordini di palchetti ritenuti migliori,ossia piè piano e primo piano, mentre lasciarono il secondo ordine alle «oneste» fa-miglie, esponenti della nascente classe borghese, cfr. C. Burino, C. Garbari, A.K. Je-len, P. Patui (a cura di), Alla ricerca dei teatri perduti, cit., pp. 33, 72, 195.
21. La prima descrizione del teatro si deve all’attore Francesco Saverio Bartoli,Le pitture, sculture e architetture di Rovigo, con indici ed illustrazioni, operetta di FrancescoBartoli accademico d’onore Clementino, in Venezia, presso Pietro Savioni, 1793, p. 57.Sull’edificio si veda F. Mancini, M.T. Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. III,cit., pp. 338-342.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 35
36
FRANCESCA FANTAPPIÈ
scenti e protagonista di esperienze esemplari come quella degli spet-tacoli allestiti sotto la loggia di Giovanni Maria Falconetto nel corti-le del palazzo di Alvise Cornaro mecenate del Ruzante22.
Sulla scorta di quanto riscontrato nei centri teatrali minori trovia-mo anche a Padova l’uso delle sale pubbliche del potere, fenomenoche si verificò soprattutto nel corso del XVI secolo, quando è attesta-ta la costruzione di alcuni teatri provvisori nel Palazzo del Podestà enel Palazzo del Capitanio (Salone dei Giganti).23 Nel corso del Sei-cento si registra l’uso della Sala Verde del Palazzo del Capitanio e suc-cessivamente anche delle stalle, dando origine al cosiddetto Teatro del-lo Stallone. Le tipologie di spettacolo registrate furono varie, ritrovan-dovi anche i comici dell’arte24.
La costruzione del più importante teatro cittadino fu dovuta, pe-rò, ad un’iniziativa privata. Si trattò, infatti, del Teatro Obizzi (1652-1824) edificato all’interno di uno stabile della nobile famiglia pado-vana, in un’area ricavata dalla demolizione degli alloggi per la servi-tù e delle stalle. Non fu l’adattamento di una sala preesistente, ma unedificio costruito ex novo con un precipuo scopo teatrale. Commit-tente il marchese Pio Enea Obizzi, il quale tra gli anni Trenta e gli an-ni Cinquanta del Seicento figura anche come patrocinatore di una pro-pria compagnia di attori professionisti, tanto da definire se stesso«quello che suol provvedere ogni anno questa città di comici»25. Ani-matore della vita teatrale cittadina, organizzatore di feste e tornei, fuprobabilmente spinto alla decisione di erigere un suo teatro dalla dif-ficoltà di allestire i propri spettacoli nel Teatro dello Stallone. Il Tea-tro Obizzi venne inaugurato nel maggio del 1652 con la compagniadel duca di Parma e dal 1693 destinato anche al teatro in musica26.
Edificato per iniziativa di una società di nobili, al fine di ospitareopere in musica, è il Teatro Nuovo della Nobiltà (1751-1876). Inau-gurato l’11 giugno 1751 con l’Artaserse di Pietro Metastasio, i princi-pali promotori dell’operazione furono alcuni palchettisti del TeatroObizzi irritati dal fatto che parte dei rifacimenti fossero stati messi aloro carico. La nascita del secondo teatro pubblico istituì immediata-
22. L. Zorzi, Il teatro e la città, Torino, 1977, pp. 299-304; Ivi, p. 36 e ss.23. Ivi, p. 57.24. Ivi, pp. 78-84.25. Lettera di Pio Enea Obizzi al duca di Modena del 30 aprile 1651, Ivi, p. 82.26. Ivi, p. 112 e ss.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 36
37
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
mente un regime concorrenziale27. Contesa risolta solo nel 1792 daun decreto del governo veneto che stabilì i rispettivi periodi di aper-tura: il primo doveva aprire nel Carnevale e in Quaresima, il secon-do durante le due fiere annuali. La stagione estiva sarebbe stata aggiu-dicata per sorteggio.
Da segnalare, infine, che Padova è probabilmente l’unica città cheriuscì ad aggirare il divieto, posto dalla Serenissima nel 1756, alla co-struzione di più di due teatri in una sola città. Dal 1778 al 1791 nelPrato della Valle troviamo il Teatrino del Recinto, detto anche TeatroVacca o «casotto grande di legno», edificio costituito da un ordine dipalchi e una o due logge, nato allo scopo di soddisfare le esigenze delpubblico in occasione della fiera di Santa Giustina28. L’operazione fupossibile in quanto si trattò di una struttura provvisionale, ossia amo-vibile. Vi si tenevano rappresentazioni in prosa, opere buffe e spetta-coli acrobatici.
Altra città caratterizzata da un ambiente culturale attivo e dinami-co fu sicuramente Verona. Emblematica in questo senso la figura diScipione Maffei, i cui tentativi di riforma teatrale e il legame con l’at-tore Luigi Riccoboni sono ampiamente noti. Animatore delle princi-pali conversazioni teatrali veronesi, è a lui che si deve la promozionedella costruzione del Teatro Filarmonico per cui venne chiamato l’ar-chitetto Francesco Bibiena29. Le tipologie di committenza nella costru-zione dei teatri veronesi furono molto variegate. La prima fallimen-tare esperienza fu quella del Teatro dell’Isolo (1651) edificato da unasocietà di quattro individui, destinato all’opera in musica e durato so-lo per una stagione, in quanto uno dei promotori, il falegname e co-struttore, fuggì con gli incassi. Segue il Teatro dei Temperati (1665-1687) la cui committenza fu accademica, mentre la gestione delle sta-gioni operistiche venne affidata ad impresari. L’utilizzo di un saloneal secondo piano del Palazzo del Capitanio dette successivamente ori-
27. Ivi, p. 126 e ss. Tra i tentativi di edificare un teatro concorrenziale con il Tea-tro Obizzi vi fu quello del Teatro Tavola (1746-1747), iniziativa del «cerusico» e ap-passionato di musica Pietro Tavola, con l’intenzione di destinarlo all’opera in mu-sica a pagamento. Osteggiato dai rettori, non ottenne il permesso per la messa inscena delle opere e fallì dopo un anno.
28. Ivi, p. 160.29. Scipione Maffei sarebbe stato addirittura «impresario del teatrino in Arena
assieme a Luigi Riccoboni ed Elena Balletti»: F. Mancini, M.T. Muraro, E. Povole-do, I teatri del veneto, vol. II, cit., p. 10.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 37
38
FRANCESCA FANTAPPIÈ
gine al cosiddetto Teatro Prefettizio (1688-1715), nel quale venivaospitata un’opera all’anno, il cui allestimento, come nel caso del Tea-tro dei Temperati, veniva lasciato ad impresari30.
Il Teatro Filarmonico, eretto nel 1715, per iniziativa dell’accade-mia omonima e sotto la guida di Scipione Maffei, nacque in sostitu-zione del Teatro Prefettizio che venne perciò demolito. Le motivazio-ni addotte dagli accademici furono di ordine morale, proclamandositutori di una nuova gestione teatrale riformata. A questo teatro, chesi accreditò come il principale della città, bisogna aggiungere nel 1723il Teatro dell’Accademia Vecchia destinato alle opere in prosa e dallametà del Settecento all’opera buffa.
Se questi furono i teatri dell’opera musicale, il luogo destinato agliattori fu il cosiddetto Teatro dell’Arena, un edificio teatrale in legnoposto al centro dell’anfiteatro romano di Verona e periodicamente ri-costruito31. L’uso di questo spazio è attestato già dalla metà del XVIIsecolo ed è probabilmente qui che si esibì la compagnia ducale di Par-ma nel dicembre del 165232. Del teatrino provvisorio rimangono duefamose riproduzioni settecentesche, un quadro di Marco Marcolla eun’incisione di Pier Antonio Novelli pubblicata nell’antiporta del to-
30. Ivi, p. 13.31. È così che lo definisce F. Bartoli, Notizie istoriche de’ comici italiani che fioriro-
no intorno all’anno MDL fino a’ giorni presenti. Opera ricercata, raccolta ed estesa da Fran-cesco Bartoli bolognese, accademico d’onore clementino, in Padova, per li Conzatti a S. Lo-renzo, 1782, t. 2, p. 150. Il Riccoboni inserisce la descrizione del teatro, in quellapiù generale degli spazi destinati «in molte città delle due Lombardie» alle rappre-sentazioni degli attori nel periodo primaverile ed estivo. «Queste sale, a volte, sonosemplici tettoie costruite in vasti cortili, un po’ come a Verona, dove tutti gli annise ne costruiscono di simili nell’Anfiteatro di Verona»: Luigi Riccoboni, Réflexionshistoriques et critiques sur les différens thèâtres de l’Europe. Avec le Pensées sur la Déclama-tion, Paris, Guerin, 1738, trad. it. in F. Taviani, M. Schino, Il segreto della Commediadell’Arte, cit., p. 307. Secondo Carlo Goldoni, nel centro dell’anfiteatro allo scopo dirappresentare commedie, «on construit, à cet effet, au milieu de cette place sur destrétaux trèes-solides, un théâtre en planche qui se défait en hiver, et se remonte à lanouvelle saison», in Mémoirs de M. Goldoni pour servir à l’histoire de sa vie et a celle deson théâtre, Parigi, 1787, parte I, cap. XXXIV, citato in F. Mancini, M.T. Muraro, E.Povoledo, I teatri del veneto, vol. II, cit., p. 47.
32. Sulla presenza della compagnia ducale di Parma segnalo alcuni documentiinediti conservati in ASV, Senato. Deliberazioni dei Rettori, filza 36 e Senato. Delibera-zioni dei Rettori, registro 26, anno 1652, cc. 180rv. Si tratta di un ordine di cattura,emesso il 14 dicembre del 1652 dal podestà di Verona, nei confronti di non identi-ficati individui, autori di un furto ai danni della compagnia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 38
39
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
mo XII dell’edizione Pasquali di Carlo Goldoni33. Sebbene non si trat-tasse di un teatro stabile, bisogna rilevare come ciò non impedì la re-golare programmazione di rappresentazioni teatrali a pagamento adopera delle principali compagnie di attori attive in Italia, così comedi ospitare uno degli episodi più importanti del teatro italiano del pri-mo Settecento, quale quello della sperimentazione di un teatro rifor-mato da parte di Luigi Riccoboni34.
Tutto ciò per rimarcare che la monumentalità di un teatro, la suastabilità, l’intento costruttivo ab aeterno può in alcuni casi risultare an-titetico alla possibilità di un uso concreto, come dimostra l’esperien-za vicentina del Teatro Olimpico, nato per iniziativa dell’accademiaomonima, e tuttora esistente, che esaurì le proprie possibilità spetta-colari con la rappresentazione inaugurale dell’Edipo Tiranno di Sofo-cle del 3 marzo 1585. Dopo questo famoso episodio lo vediamo uti-lizzato prevalentemente per adunanze accademiche o concerti e solooccasionalmente per rappresentazioni drammatiche o musicali35.
A Vicenza, città caratterizzata da una cultura accademica partico-larmente forte ed espressione di un’oligarchia orgogliosa e in forte an-tagonismo con il potere centrale veneziano, vediamo come tale carat-teristica determinò episodi eccellenti, ma transitori, mentre le espe-rienze più durature, al fine di costituire un sistema teatrale urbano,
33. In questo spazio, a partire dalla seconda metà del Seicento, le compagnie diattori professionisti si susseguirono con regolarità. Vi troviamo gli Accesi di Pier Ma-ria Cecchini, i Fedeli di Giovan Battista Andreini, le compagnie ducali di Parma,Modena e Mantova. Nella prima metà del secolo successivo ebbero luogo gli espe-rimenti di teatro riformato di Luigi Riccoboni ed Elena Balletti, con rappresentazio-ni quali La Sofonisba del Trissino (1711), L’Edipo re di Sofocle (1711), la prima asso-luta dell’Ifigenia in Tauride Pier Jacopo Martelli (1711) o La Merope di Scipione Maf-fei (1713). Nella seconda metà del Settecento vi recitarono le più rinomate forma-zioni comiche stanziali dei teatri veneziani, e non solo, quali la compagnia di Gen-naro Sacco (1713), di Giuseppe Imer (1734), di Girolamo Medebach (1749, 1773), lacompagnia del Teatro San Luca (1754, 1755, 1761), la compagnia di Antonio Sacchi(1771), di Maddalena Battaglia (1782, 1788), di Giuseppe Pellandi (1794), di LuigiPerelli (1795): F. Mancini, M.T. Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. II, cit.,pp. 8-9, 29-52.
34. R. Tessari, Teatro e spettacolo nel Settecento, Bari, 1995, pp. 3-51.35. Sull’uso del teatro nel corso del Sei e Settecento si veda F. Mancini, M.T.
Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. II, cit., p. 196 e ss. Di assoluto rilievo larappresentazione della tragedia il Torrismondo di Torquato Tasso nel 1618, cfr. S. Maz-zoni, L’Olimpico di Vicenza: un teatro la sua «perpetua memoria», Firenze, 1998, pp. 209-223.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 39
40
FRANCESCA FANTAPPIÈ
furono dovute all’iniziativa di privati o di piccole società di nobili.Nel XVI secolo la città fu animata da numerosi sodalizi come i Co-stanti, gli Olimpici, gli accademici della Pusterla, oltre che dall’attivi-tà di letterati illustri, quali Gian Giorgio Trissino. Tutto ciò dette luo-go a varie sperimentazioni e all’edificazione di teatri provvisori d’ispi-razione classicheggiante, come il teatro progettato e realizzato da Se-bastiano Serlio nel Cortile di Ca’ da Porto (1539) o quello del Palla-dio in una sala del Palazzo della Ragione (1561), antesignani della co-struzione del Teatro Olimpico. È però solo nel Seicento che nacque-ro i due principali teatri pubblici36.
Il primo, su committenza privata, fu il Teatro delle Garzerie (1630circa-1683), detto poi Teatro di Piazza (1689-1777). Nacque per inizia-tiva di Filippo Castelli come teatro per gli attori professionisti, in unedificio contiguo al Palazzo della Ragione. Da metà del Seicento ospi-tò le prime stagioni liriche a pagamento. Distrutto da un incendio nel1683 venne ricostruito, prendendo il nome di Teatro di Piazza, perimpulso di alcuni esponenti della nobiltà vicentina, i conti MarzioAngaran, Scipione Repetta, Vincenzo Feramosca, i quali affidarono lagestione delle stagioni operistiche ad impresari. Nei primi decenni delSettecento ospitò alcuni episodi di teatro riformato come la Sofonisbadi Trissino e l’Edipo Tiranno di Sofocle-Giustinian, l’Oreste di Giovan-ni Rucellai (1712) e La Merope di Scipione Maffei37. Da metà del se-colo vide predominarvi l’opera buffa.
Il secondo fu il Teatro Tornieri (1630/1650-1711), poi detto Teatrodelle Grazie (1712-1783). Nato per iniziativa della nobile famiglia Tor-nieri, proprietaria dello stabile, venne inizialmente riservato al sologenere della prosa. Tra il 1672 e il 1686 vi si esibirono le compagniedel duca di Parma, di Mantova e di Modena. Distrutto nel 1711, unasocietà di quattro nobili vicentini ne rilevò la licenza, costruendoneuno nuovo, nominato Teatro delle Grazie38. Il repertorio fu sia musi-
36. Entrambi i teatri avevano cavea semicircolare a gradoni, il primo una scenaprospettica fissa, il secondo una scaena frons. In quest’ultimo vi furono rappresenta-ti l’Amor Costante di Alessandro Piccolomini (1561) e La Sofonisba di Gian GiorgioTrissino (1562) per iniziativa degli accademici Olimpici, cfr. F. Mancini, M.T. Mu-raro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. II, cit., pp. 184-195.
37. Ivi, pp. 234-237, 240-249.38. Ivi, pp. 238-239, 250-256. L’acquisto del vecchio edificio venne motivato co-
me segue: «per recitare opere, commedie et altro (…) a maggior decoro della patriae comodo universale» in Ivi, p. 250.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 40
41
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
cale sia in prosa. Venne abbandonato in seguito alla sua distruzionedovuta ad un incendio.
Il terzo teatro, detto Teatro Eretenio o nuovo teatro di Vicenza(1784-1944), venne costruito ad istanza dell’accademia Eretenia e diun gruppo di nobili vicentini Alvise Trissino, Girolamo Giuseppedi Velo, Francesco Quinto, Girolamo Muttoni, Gualdinello Bissari,i quali ne promossero l’edificazione considerando il Teatro di Piaz-za inservibile e quello delle Grazie inadeguato. Molti degli accade-mici Ereteni erano ex-palchettisti del Teatro di Piazza. La gestionedelle stagioni operistiche venne affidata ad impresari, mentre vi siesibirono alcune delle maggiori compagnie di attori professionistidel secondo Settecento, quali Giuseppe Lapy (1786), Luigi Perelli(1787, 1796, 1798), Carlo Battaglia (1787, 1797), Giuseppe Pellandi(1800)39.
2. Bergamo: il teatro senza teatri
A Bergamo, a differenza delle altre città della Terraferma veneta, lacircolazione delle compagnie di attori professionisti e la diffusione del-l’opera in musica a pagamento non portarono alla stabilizzazione diun sistema teatrale urbano architettonicamente riconosciuto.
«Per teatri non è Bergamo sito» afferma nel 1720 l’abate GiovanBattista Angelini, aggiungendo: «invece qui frequentasi le chiese»40.È con questa frase che il letterato ed erudito bergamasco ricorda,quasi con una punta di soddisfazione, la demolizione del Teatro Sec-co Suardo e il fallimento dei successivi tentativi di dotare la città diun edificio teatrale stabile in sua sostituzione. Più di cinquant’annidopo la situazione non era cambiata. In una descrizione di Berga-mo, pubblicata nel 1774 dall’attore Francesco Bartoli, nella quale siillustrano le opere d’arte conservate nella città e i suoi principali luo-ghi pubblici, non si fa alcuna menzione di un teatro. Non si trattadi una semplice dimenticanza. Lo stesso autore – che per la propria
39. Ivi, pp. 256-272. Da ricordare, infine, il Teatro Berico poi Teatro Garibaldi(1788-1907), nato su committenza sociale, per iniziativa della scrittrice Elisabetta Ca-minèer Turra a capo di un’accademia cittadina di dilettanti. Dedicato alla prosa, vitrovava talvolta luogo anche l’opera buffa, in Ivi, p. 267.
40. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 377.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 41
42
FRANCESCA FANTAPPIÈ
professione avrebbe dovuto essere particolarmente interessato all’ar-gomento, ideatore del primo dizionario biografico sugli attori italia-ni, oltreché membro, nel corso della propria carriera, di alcune del-le compagnie più rinomate del periodo – nel 1794 propose per Ro-vigo un’opera di erudita compilazione esemplificata sulla preceden-te. In questo caso lo spazio dedicato alla storia del teatro cittadino,nella fattispecie il Teatro Manfredini è ampio, ricco di notizie stori-che ed architettoniche41.
Pur in mancanza di un sistema di edifici teatrali pubblici perma-nenti Bergamo non rimase esente dall’espansione del teatro profes-sionistico, né poteva di fatto esserlo. Vi ritroviamo puntualmente al-cuni dei principali fenomeni diffusi del resto della Penisola. È dallafine del Cinquecento che possiamo attestare la circolazione delle pri-me compagnie di comici dell’arte; dalla metà del Seicento la diffusio-ne di un sistema produttivo operistico impresariale; dalla seconda me-tà del Settecento quella dell’opera buffa e dagli anni Settanta dellostesso secolo, per quanto riguarda il repertorio in prosa, la commedialacrimosa e il repertorio gozziano. Faticosamente o meno, tutto ciòsi fece strada anche sul colle bergamasco. La formazione di due sta-gioni teatrali, costituite dal Carnevale (inverno) e dalla fiera (estate),fu relativamente precoce. Bisogna inoltre ricordare che l’uso di edifi-ci teatrali in legno provvisori non fu una precipua caratteristica ber-gamasca. Episodi analoghi ai casotti in legno eretti nel prato di San-t’Alessandro sono riscontrabili nel cosiddetto Teatro del Prato dellaValle a Padova o nel Teatro dell’Arena di Verona destinato ai comicidell’arte. La peculiarità bergamasca fu semmai il ricorso esclusivo aquesta sola tipologia architettonica.
Trovare una ragione assoluta che renda comprensibile questa ap-parente anomalia non è possibile. Le motivazioni sembrano esseremolteplici. Se valutiamo quelle politiche, notiamo che da parte dellaautorità municipali cittadine perdurò a lungo una visione pregiudi-ziale del fenomeno. A Bergamo, come nelle altre città soggette dellaSerenissima, non vi era una nobiltà cortigiana, ma un patriziato or-mai identificato dall’accesso ai pubblici uffici cui si arrivava per co-
41. F.S. Bartoli, Le pitture, sculture ed architetture delle chiese e d’altri luoghi pubblici diBergamo. Descritte da Francesco Bartoli bolognese dedicate al nobile ed eruditissimo signoreconte Giacomo Carrara gentiluomo della stessa città, Vicenza, Carlo Bressan, 1774 e Id.,Le pitture, sculture e architetture di Rovigo, cit., p. 57.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 42
43
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
optazione interna42. Come abbiamo visto è a questa classe sociale chesi deve la promozione della creazione di edifici teatrali nella Terrafer-ma veneta, fossero essi gestiti collettivamente o privatamente. L’oli-garchia cittadina, che nelle altre città soggette si rivelò il principalemotore dell’istanza teatrale, a Bergamo si mostrò invece divisa da for-ti rivalità interne, mentre le agguerrite consorterie nobiliari non per-misero che si affermasse una famiglia egemone. Nel caso in cui suc-cesse, il tentativo venne immediatamente frustrato. La chiusura in sen-so oligarchico, così come la competizione interna, di questa classe so-ciale risalta chiaramente in uno dei momenti topici della progettazio-ne di un teatro pubblico: l’assegnazione dei palchetti. Questi, al paridelle cariche pubbliche, venivano passati per via ereditaria e attraver-so la loro posizione all’interno dell’edificio indicavano il grado socia-le della famiglia cui appartenevano43. La storia dell’evoluzione del si-stema teatrale urbano bergamasco tra XVII e XVIII secolo è, non a
42. La progressiva chiusura in senso oligarchico della nobiltà suddita della Re-pubblica veneta, secondo A. Ventura, Nobiltà e popolo nella società veneta del ’400 e ’500,Bari, 1964, sarebbe avvenuta tra Quattro e Cinquecento. Per alcuni, invece, il pro-cesso di aristocratizzazione del Consiglio comunale bergamasco era già iniziato inepoca viscontea: S. Rota, Politica di Venezia nei confronti del territorio bergamasco nel pri-mo secolo della dominazione, in Venezia e le Istituzioni della Terraferma, Bergamo, 1988,p. 70. In pieno Settecento Ferdinando Caccia (Della cittadinanza di Bergamo. Tratta-to dedicato ad essa Magnifica Città, Bergamo, Lodovico Gavazzoli, 1766), afferma chei titoli nobiliari potevano essere anche conferiti dal Doge, ma il segno distintivo piùimportante rimaneva quello di essere, o essere stati, deputati nei Consigli municipa-li. Avere accesso alle cariche pubbliche significava, quindi, appartenere all’oligarchiacittadina. Per questo motivo, col tempo, si riscontrò un progressivo irrigidimento daparte di questo ceto, sempre più occupato a difendere i propri privilegi e a non ce-derli a coloro che venivano considerati estranei al proprio gruppo sociale. Tuttaviasi trattò solo di un palliativo, in quanto nelle oligarchie cittadine esautorate dal go-verno centrale, rimase sempre un malcelato senso di rivalsa. In alcuni casi la frustra-zione generata dal basso profilo dell’amministrazione pubblica, cui erano incarica-te di sovrintendere, avrebbe portato alla ricerca di un rilievo politico nelle memo-rie: G. Scarabello, La Repubblica di Venezia: Signoria di uno stato o di una città?, in Ve-nezia e le Istituzioni di Terraferma, Bergamo, 1980, p. 30; S. Rota, Per una storia dei rap-porti tra Bergamo e Venezia, cit., p. 29.
43. Il problema dell’assegnazione dei palchetti e le relative contestazioni non fu-rono tipiche di Bergamo ma, al momento della realizzazione di un edificio teatra-le, si riscontrarono costantemente in molte altre città della Terraferma veneta, oltre-ché nella stessa Dominante, come dimostra il caso della «guerra dei palchi» illustra-to in R. Giazotto, La guerra dei palchi, in «Nuova Rivista Musicale Italiana», 2-3(1967), pp. 465-508 e N. Mangini, I teatri di Venezia, Milano, 1974, pp. 30-32.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 43
44
FRANCESCA FANTAPPIÈ
caso, una concatenazione di diatribe insorte per la distribuzione deipalchi. Lotte, talvolta, senza quartiere, attraverso cui ciascun esponen-te del ceto dirigente cercava di sottolineare la propria superiorità ri-spetto agli altri.
Alle numerose e incolmabili divisioni interne della nobiltà suddi-ta bergamasca non fece da contraltare un’azione promotrice da partedel potere centrale veneziano. Rischioso alterare un sistema di forzedall’equilibrio così instabile, ma allo stesso tempo così consolidato.La Serenissima si limitò a guardare ed attuare una politica di conte-nimento dei danni, conservando il ruolo di regolatrice e portatrice diconcordia, funzione con la quale legittimava il proprio potere44. Daparte dei due rettori veneti periodicamente in carica si palesò un ge-nerale disinteresse, salvo qualche raro caso come quello del capitanioPietro Dolfino patrocinatore nel Seicento dell’accademia degli Airo-ni45. Sebbene la nutrita letteratura di natura encomiastica prodotta neiloro confronti da esponenti della nobiltà bergamasca, spesso per sot-tolineare l’arrivo e la partenza delle due autorità veneziane, testimo-ni l’attenzione prestata dalla città alle manifestazioni pubbliche e al-le celebrazioni ufficiali, si trattò di iniziative episodiche che solo mar-ginalmente documentano un interesse per momenti di sociabilità oeventi di natura spettacolare. Questi episodi, in ogni caso, rimaserolegati a funzioni di semplice cerimoniale46. Non produssero, quindi,
44. Sulle continue divisioni del ceto dominante bergamasco e sulle origini di ta-li contrasti si rimanda a G. Gullino, Il ceto dirigente tra Bergamo e la Serenissima, in Sto-ria economica e sociale di Bergamo, vol. III, Il tempo della Serenissima, t. 2: Il lungo Cin-quecento, Bergamo, 1998, mentre sul mito della Dominante come garante di pace etranquillità si vedano G. Cozzi, Cultura, politica e religione nella ‘Pubblica storiografia’veneziana del ’500, in «Bollettino dell’Istituto di Storia della Società e dello Stato Ve-neziano», V-VI (1963-1964), pp. 215-294; G. Benzoni, La storiografia e l’erudizione sto-rico-antiquaria. Gli storici municipali, in Storia della cultura veneta. Il Seicento, vol. IV, t.2, Vicenza, 1984, pp. 67-93; G. Ortalli, Terra di San Marco: tra mito e realtà, in Vene-zia e le Istituzioni della Terraferma, Bergamo, 1988, pp. 9-21.
45. Sulla quale si rimanda alla Parte II. 2. 1 Committenza nobiliare e prime opere inmusica.
46. Esiste un preciso filone di tipo encomiastico nella poesia d’occasione pro-dotta a Bergamo. Per un’idea del cerimoniale tenuto all’arrivo e alla partenza dei ret-tori, così come per i componimenti poetici prodotti dall’accademia degli Eccitatiper quest’occasione si vedano A. Locatelli Milesi, Pubbliche cerimonie cittadine nei se-coli XVII e XVIII, in «Bergomum», XIII (1929), fasc. 1, pp. 58-67; A. Pinetti, Nunzie ambasciatori della Magnifica Città di Bergamo nella Repubblica di Venezia, Ivi, pp. 35-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 44
45
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
una volontà unitaria, né attestano l’esistenza di una compagine socia-le cittadina sufficientemente coesa per agire in autonomia nella pro-mozione del teatro professionistico, né tantomeno nella creazione distrutture architettoniche stabili adibite ad accoglierlo.
Uno degli elementi maggiormente unificanti della città appare, in-vece, la cultura ecclesiastica, normalmente poco incline a favorirel’espansione del teatro profano. La più importante accademia lettera-ria, in realtà la principale accademia tout court del Seicento, quella de-gli Eccitati, vide tra i suoi protagonisti, il padre agostiniano DonatoCalvi, il conte Bonifacio Agliardi chierico teatino, l’avvocato, poi sa-cerdote, Clemente Rivola. Le adunanze accademiche, che prevedeva-no anche interventi musicali, si svolgevano normalmente nel conven-to di Sant’Agostino, ma potevano tenersi anche nel palazzo vescovi-le. Tra i membri del sodalizio troviamo, infatti, il vescovo di Berga-mo Alvise Grimani e, dal 1658, il suo successore Gregorio Barbari-go47. È a quest’ultimo che si deve nel 1662 l’impulso alla rinascita di
57; J. Schiavini Trezzi, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo, cit., pp. XV-XLII.Per quanto riguarda gli eventi spettacolari legati a tali cerimonie le seguenti voci nel-la Cronologia di questo libro: Il trionfo della Gloria nelle mestizie del Brenno (1685), Ac-cademia in lode di Francesco Donado capitanio grande (1709), La gara de’ tre delfini, del Cie-lo, della Terra e del Mare (1712); Cantata nella partenza di Nicolò Barbarigo, Bergamo,[1772]; Cantata nella partenza di Bergamo di Francesco Savorgnana (1773); L’omaggio sin-cero. Cantata nella partenza di Bergamo Giovan Paolo Baglioni capitanio (1775). Comeesempio di componimenti poetici d’occasione si segnalano: A. Lupis, Il simolacro del-la gloria in lode dell’Eccel lenza del sig. Pietro Dolfino capitanio di Bergamo, Bergamo, Fi-gliuoli di Marc’Antonio Rossi; G.B. Angelini, Le glorie del Giglio e della Rosa, Berga-mo, Fratelli Rossi, 1705; Id., Avanzi rifiutati alla glorie di S. E. Pietro Delfin podestà diBergamo, Bergamo, Fratelli Rossi, 1712. Tutti e tre gli opuscoli sono conservati inBAM, S. I. G. B. 24 (3, 7-8). Altri modelli di letteratura encomiastica sono rappre-sentati dal poema di Giacomo Mazzoleni, La Calliope, Venezia, Missirini, 1620 e dal-le seguenti opere: L. Ghirardelli, Gli applausi di Nettuno. Panegirico per la creatione delSerenissimo Doge di Venetia Giovanni Cornaro, Bergamo, Comin Ventura, 1625; D. Cal-vi, Tributo di riverenza al merito dell’Ill.mo et Ecc.mo Sig. Pietro Gradenigo Capitanio et Vi-ce Podestà di Bergamo, Bergamo, Rossi, 1658; A. Ghirardelli, Il Serio trionfante per il fe-lice governo di Marin Nadal, podestà di Clusone, Milano, Francesco Vigone, 1671. Infi-ne, molti sono i componimenti encomiastici conservati nel volume intitolato Reg-gimento di Bergamo, Miscellanea, BCBg, Sala II T 9 – Retro 22 (14), oltre che nelle Du-cali et altre cose diverse, BCBg, FMQ.
47. L’esistenza dell’accademia degli Eccitati in antico regime non è continuati-va. Nel Seicento è circoscrivibile tra il 1642 e il 1677. Dopo questa data il sodaliziosi sfalda per varie ragioni: per le difficoltà di ordine economico nate dall’impossibi-lità di sostenersi solo grazie all’autotassazione degli iscritti, non avendo potuto ot-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 45
46
FRANCESCA FANTAPPIÈ
un’altra accademia cittadina, quella denominata degli Emi, fondata il9 aprile del 1617 dal vescovo Giovanni Emo. Il sodalizio, promossoda Alessandro Terzi rettore del Seminario, era ospitato nell’istituto di-retto da quest’ultimo, sede mantenuta per tutto il secolo successivo.Tra le attività principali vi erano lo studio della teologia, della filoso-fia, nonché della linguistica, agiografia, storia sacra e profana, etc.48.Nel secondo Settecento i seminaristi ed accademici furono parte atti-va nelle feste di beatificazione di Gregorio Barbarigo49.
tenere, al contrario di quanto accaduto agli Erranti di Brescia, alcun tipo di contri-buto pubblico; per l’indifferenza delle più influenti casate gentilizie cittadine, oltre-ché dei Consigli Maggiore e Minore; per la scomparsa di alcuni dei suoi membri piùimportanti. L’accademia rinasce nel 1749 e verrà riunita nel 1810 con quella scien-tifica degli Arvali per dare vita all’Ateneo, cfr. J. Schiavini Trezzi, Ateneo di Scienze,Lettere ed Arti, cit., pp. XV-XLV, cui si rimanda per una bibliografia esaustiva sull’ar-gomento. Tra le accademie, tutte di breve durata, che si registrano nel XVII secolovi furono i Laboriosi (1600), la «nuova accademia di Bergamo» cui fa riferimentoAngelo Ingegneri (1604), gli Aironi patrocinati dal capitanio Pietro Dolfin (1667-1670).
48. D. Calvi, Effemeride sagro-profana, Milano, Francesco Vigone, 1676, vol. I, p.443; M. Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, Bologna, 1929, vol. II, pp. 275-276.Il Seminario, come sede dell’accademia Ema, è ricordato anche da Giovan BattistaAngelini (Per darti notizie del paese, cit., p. 30).
49. Grazie al ritrovamento di una raccolta di componimenti poetici intitolataLe tre panegiriche orazioni ed i componimenti degli accademici Emi pubblicati e recitati nelDuomo di Bergamo per le feste della Beatificazione di Gregorio Barbarigo ed un sonetto delsignor Giuseppe Rigamonti per le medesime feste pubblicato, Bergamo, 1762, dalle stampedi Francesco Locatelli, con autorevole approvazione, in BAM, S. P. G. XII. 122, èpossibile attestare l’esistenza dell’accademia ancora nella seconda metà del Settecen-to e dare un’identità ai membri del sodalizio nell’epoca suddetta. L’opuscolo si aprecon tre orazioni rispettivamente di Francesco Cucchi, Ferrante d’Ambivere, Bene-detto Passi. Seguono i componimenti poetici «degli accademici Emi recitati nel Duo-mo di Bergamo il primo giorno della festa» costituiti da un’orazione in latino, duecantate, un’ode, un’elegia, un’egloga, una canzone, epigrammi e sonetti vari, un poe-metto in ottava rima, un sonetto di Giuseppe Rigamonti dedicato ai cavalieri Vitto-rio Lupo e Giulio Cesare Agosti. Si conclude con il nome degli accademici: «Do-menico Ronzoni stud. di teologia principe. Francesco Carissimi stud. di teologia pri-mo assistente. Giuseppe Recrosio stud. di teologia secondo assistente. Gasparo Maz-zoleni stud. di teologia censore. Carlo Stefanini stud. di filosofia segretario. France-sco Milesi stud. di teologia. Giuseppe Locatelli stud. di filosofia. Giovanni Savoldistud. di filosofia. Gio. Maria Ghedini stud. di filosofia. Antonio Ballio stud. di filo-sofia. Antonio Facchetti stud. di filosofia. Andrea Magili stud. di retorica. Giusep-pe Bottagisi stud. di retorica. Giovanni Bana stud. di retorica. Giacomo Cosetti stud.di retorica. Mario Albani co. arcidiacono della cattedrale di Bergamo protettore del-l’accademia. Marco Negri rettore del seminario promotore. Pietro Ottavio Bolgenimaestro di retorica direttore».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 46
47
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
È l’ambiente ecclesiastico che forma i più importanti eruditi-stori-ci bergamaschi: il Calvi stesso, Celestino Colleoni, Giovan BattistaAngelini50. Se il primo sembra apprezzasse il teatro musicale, tanto daregistrare la rappresentazione dell’Ercole effeminato nel 1654 e quella dialtre opere seicentesche in un suo diario personale, da cui attinse perla stesura dell’Effemeride sagro profana, l’Angelini – pur dimostrandosicultore di musica e poesia, autore di vari componimenti di natura en-comiastica, oltreché dell’unica relazione nota di una mascherata tenu-ta a Bergamo – nella sua descrizione della città in terza rima espressepiuttosto nettamente la propria disapprovazione verso il teatro degliattori professionisti e quello musicale di matrice impresariale51.
Per quanto riguarda la Misericordia Maggiore, una delle più rile-vanti istituzioni culturali cittadine, che produceva cantanti, musicistie compositori di apprezzabile livello, la sua attività non avrebbe po-tuto determinare un’inversione di tendenza ed un’apertura al teatroprofessionistico. Al contrario è stato notato che, se nel primo Seicen-to la cappella di Santa Maria Maggiore, polo di attrazione per artistiprovenienti da tutta l’area lombardo-veneta ed emiliana, formava can-tanti di prim’ordine e «musicisti di indiscutibile talento quali Cavac-cio, Grandi, Merula, Crivelli, Legrenzi, Ziani»52, oltre a produrre mu-sica sacra qualitativamente eccellente, la sua perdita di prestigio av-venne in concomitanza con la diffusione del fenomeno del teatro mu-sicale a pagamento che, rispetto alla committenza delle istituzioni re-ligiose, diventò sempre più competitivo ed attraente53. La presenza diun’illustre scuola di cantanti e musicisti rimase perciò legata all’am-bito sacro e influì solo minimamente sul teatro profano. Non sorpren-
50. C. Carlsmith, Schooling and Society in Bergamo 1500-1600, cit.51. D. Calvi, Effemeride sagro-profana, cit., vol. I, p. 45. Per un commento del-
l’episodio cfr. Infra, p. 60. Per quanto riguarda la vita di Giovan Battista Angelini(1679-1767), ordinato sacerdote nel 1713 e cappellano del podestà, e la sua produ-zione poetica ed erudita, si veda V. Marchetti (a cura di), Giovan Battista Angelini eru-dito bergamasco del Settecento. Antologia di scritti, Bergamo, 1991 e Id., Introduzione aGiovan Battista Angelini, Per darti notizie del paese, cit., pp. XI-LIV. Per il giudizioespresso dall’erudito bergamasco sul fenomeno del teatro mercenario, cfr. Infra, pp.154-155.
52. M. Padoan, La musica in S. Maria Maggiore a Bergamo nel periodo di GiovanniCavaccio (1598-1626), Como, 1983, p. 19.
53. Id., Bergamo e la musica sacra nel primo Seicento: un modello esemplare di media-zione tra Oriente ed Occidente, in Venezia e la Terraferma. La cultura, Bergamo, 1990.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 47
48
FRANCESCA FANTAPPIÈ
de, quindi, notare come molti artisti bergamaschi operassero al di fuo-ri della propria città natale, dove venivano offerte maggiori e più di-versificate possibilità di lavoro54. La collaborazione di alcuni dei mae-stri di cappella di Santa Maria Maggiore, tra cui Maurizio Cazzati,Pietro Andrea Ziani, Giovan Battista Brevi, Francesco Ballarotti, Gio-van Battista Quaglia, Carlo Lenzi, alla stesura della musica di alcunimelodrammi rappresentati in città, sebbene riscontrabile, fu episodi-ca55. Il cosiddetto Collegio Mariano, o Accademia Mariana, fondatoil 3 febbraio 1617, infine ebbe come finalità, oltre che l’insegnamen-to delle lettere e della musica, quella di educare giovani uomini al sa-cerdozio56.
Se l’influenza della cultura ecclesiastica contribuì a contrastarel’espansione del teatro professionistico poiché, diversamente da ciòche avvenne in altre città della Repubblica veneta, non fu bilanciatadall’opposizione di una compagine politico-sociale sufficientementecoesa e determinata in senso contrario, sarebbe adesso utile stabilireil suo peso nella promozione di un’attività spettacolare di matrice re-ligiosa. Ricordiamo, ad esempio, che tra gli episodi che maggiormen-te incisero sulla storia cittadina, vengono unanimemente riconosciu-
54. A Bergamo nacquero i violinisti Pietro Antonio Locatelli e Antonio Lolli iquali, lasciata la propria città, proseguirono la loro carriera nel resto d’Italia e in Eu-ropa. Per quanto riguarda gli scenografi, emblematico il caso di Giacomo Quaren-ghi, emigrato in Russia alla corte di San Pietroburgo.
55. Si vedano le seguenti voci nella Cronologia di questa tesi: Ercole effemminato(1654), Il Giuseppe (1656), Le fortune di Rodope e Damira (1660), L’Annibale in Capua(1668), Hiarba impazzito (1690), Il merito fortunato (1691), Ottaviano in Sicilia (1695),L’eroe cinese (1768).
56. Il 12 febbraio 1618, sotto il governo di Carlo Francesco Ceresolo e GiovanBattista Mazzoleni, vengono stabiliti i capitoli dell’accademia che, dagli iniziali tren-ta iscritti, passa a un centinaio nel secondo Seicento. «Deputati al governo d’essa ac-cademia della Misericordia» furono «Felice Osio per rettore e principal maestro. Ales-sandro Carrara per prefetto de’ studii. Annibal Solza per ministro e economo. Pie-tro Rota per prefetto oltre alcuni destinati alla servitù»: D. Calvi, Effemeride sagro-pro-fana, cit., vol. I, pp. 116, 169; vol. II, pp. 611-612. Sull’organizzazione del CollegioMariano, sulla sua attività, oltre che su quella delle cosiddette «accademie» prece-dentemente sperimentate all’interno della Misericordia Maggiore di Bergamo si ve-dano G. Locatelli, L’istruzione a Bergamo e la Misericordia Maggiore, in «Bergomum»,IV (1910), fasc. 4, pp. 57-169; V (1911), fasc. 1, pp. 21-100; M. Padoan, La musica inS. Maria Maggiore a Bergamo, cit., pp. 112-119, 138-146; P. Forcella, Musica e musici-sti a Bergamo, cit., pp. 37-38; C. Carlsmith, Schooling and Society in Bergamo 1500-1600,cit., pp. 119-124.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 48
49
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
ti la visita del cardinale Carlo Borromeo nella seconda metà del Cin-quecento e l’opera culturale del vescovo Gregorio Barbarigo nel cor-so del Seicento57. Sebbene non esista uno studio complessivo al ri-guardo, quelli attualmente esistenti, pur trattando di singoli eventi,mostrano una realtà assai ricca e composita58. Un’indagine comples-siva in tal senso appare perciò auspicabile. Impossibile in questa se-de, poiché comporterebbe l’apertura di un versante di ricerca nuovo,rispetto a quello percorso in merito al teatro professionistico, ci limi-teremo a proporre alcune indicazioni preliminari sulle possibili lineedi approfondimento percorribili. Tra i primi passi da compiere vi sa-rebbe innanzitutto quello di un censimento delle varie festività reli-giose annuali, di cui andrebbero successivamente stabilite le origini ela durata nel corso del tempo. Una volta determinata la calenderizza-zione dei principali eventi cittadini, andrebbero selezionati quelli piùrilevanti, verificandone la ricorrenza, le modalità, le istituzione reli-giose e/o politiche patrocinatrici, il significato e, nel caso di feste le-gate a santi patroni, la loro tradizione.59 Non è, infatti, raro trovare
57. Sulla visita del cardinale Carlo Borromeo nel 1575 si vedano almeno B. Be-lotti, Venezia e la visita di San Carlo Borromeo a Bergamo nel 1575, in «Bergomum»,XXXIII (1939), fasc. 2, pp. 72-85; A. Roncalli, Gli atti della visita apostolica di San Car-lo Borromeo (1575), Firenze, 5 voll., 1936-1956. Sull’opera del vescovo Gregorio Bar-barigo: D. Montanari, Gregorio Barbarigo a Bergamo (1657-1664). Passi di governo e mis-sione pastorale, Milano, 1997. Al cardinale Carlo Borromeo si deve il fondamentalepatrocinio verso i vescovi Federico Cornaro e Girolamo Ragazzoni per la nascita ecrescita del Seminario di Bergamo, fondato nel 1567 a soli tre anni dalla conclusio-ne del Concilio di Trento: C. Carlsmith, Schooling and Society in Bergamo 1500-1600,cit., p. 149 e ss. Sulla storia religiosa di Bergamo in antico regime si veda inoltre G.Zanchi, Dagli inizi del Cinquecento all’attuazione del Concilio di Trento e Id. L’età post-tri-dentina e il consolidarsi della tradizione bergamasca in A. Caprioli, A. Rimoldi, L. Vac-caro (a cura di), Diocesi di Bergamo, Brescia, 1988, pp. 161-179, 181-200.
58. M. Rabaglio, Drammaturgia popolare e teatro sacro. Riti e rappresentazioni del Ve-nerdì Santo bergamasco, Bergamo, 1989; M. Gatti, Liturgia e architettura. L’antica catte-drale di Bergamo attraverso il libro ordinario del vescovo Giovanni Barozzi (sec. XV), Tesidi laurea in Storia dell’Arte Medioevale, Università Statale di Milano, a. a. 2005-2006;F. Fantappiè, L’immagine di Bergamo nella traslazione dei Santi Fermo, Rustico e Procolodel 1766, in Il paesaggio tra realtà e rappresentazione, Studi in memoria di Lelio Pagani,a cura di J. Schiavini Trezzi, Bergamo, pp. 85-116.
59. Un tema particolarmente ricco di prospettive per il quale auspichiamo futu-re indagini. Per quanto riguarda il teatro religioso musicale proponiamo come pun-to di partenza alcune voci riportate nella Cronologia di questo libro: Oratorio dellaSantissima Croce (1654), Megera delusa (1698), La vittoria di David contro Golia (1680),
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 49
50
FRANCESCA FANTAPPIÈ
che, feste legate al culto dei santi patroni – come nel caso dei santiFermo, Rustico e Procolo – pur praticate in antico regime, avesseroorigini medievali60. Ci preme, infine, ribadire che le modalità e gli stru-menti d’indagine necessari allo studio della spettacolarità di matricereligiosa non potranno che essere profondamente diversi rispetto aquelli utili ad una ricerca sul teatro professionistico, in quanto le fun-zioni e le problematiche dei due ambiti, sebbene non esenti da mo-menti di intersezione, sono fondamentalmente distinti61.
Ma torniamo a quello che per antitesi potrebbe essere definito co-me teatro profano. L’assenza di un sistema teatrale stabile architetto-nicamente riconosciuto, determinata dalla debolezza delle iniziativepromosse dalla società bergamasca, iniziò lentamente ad essere senti-ta come un problema anche nella Bergamo del Settecento. Il risvegliointellettuale che caratterizzò la seconda metà del secolo, portando al-la formazione in città di alcuni salotti letterari e alla diffusione delleidee illuministiche, alla rinascita dell’ac cademia degli Eccitati e allafondazione di quella degli Arvali, il cui interesse principale era rivol-
Componimento drammatico sopra la nascita di San Rocco (1762), La morte di San France-sco Saverio (1764), Componimento drammatico da cantarsi in musica nella cattedrale di Ber-gamo nella solennità del beato Gregorio Barbarigo (1764), Cantata per musica per la cano-nizzazione di San Girolamo Miani (1768), La morte di San Francesco Saverio (1771), Com-ponimento drammatico da cantarsi in musica nella cattedrale di Bergamo nella festa del bea-to Gregorio Barbarigo (1774). Tra le celebrazioni dedicate ai santi patroni erano sicu-ramente rilevanti quelle per Santa Grata e Sant’Alessandro. Degna di uno studio par-ticolare sarebbe sicuramente quella del Corpus Domini. Tra i fondi potenzialmentericchi di documentazione segnaliamo la raccolta di Ducali et altre cose diverse in BCBg,FMQ, mentre al di fuori della città di Bergamo, le collezioni della Biblioteca Am-brosiana di Milano. Per ulteriori indicazioni documentarie si rimanda a F. Fantap-piè, L’immagine di Bergamo nella traslazione dei Santi Fermo, Rustico e Procolo del 1766,cit., pp. 87-88 e note.
60. Ivi, pp. 89-90. Fenomeno riscontrabile in molte altre città italiane, dal nordal sud della Penisola, per il quale ci limitiamo a rimandare ai recenti contribuiti diA. Benvenuti. «Santuario»: un percorso semantico; C. Altavista, Dalla città alla cattedra-le e ritorno: il tesoro del duomo di San Lorenzo a Genova dall’XI al XVI secolo; F. Gallo,Gli occhi di Lucia sulla città. Ridefinizione degli spazi sacri a Siracusa tra XVI e XVII seco-lo, in F. Ricciardelli (a cura di), I luoghi del sacro. Il sacro e la città tra Medioevo ed Etàmoderna, Atti del Convegno (Firenze, 12-13 giugno 2006), Firenze, 2008, pp. 19-42,91-110, 207-218.
61. C. Bernardi, La drammaturgia della settimana santa in Italia, Milano, 1991 eId., Il tempo sacro: «Entierro». Riti drammatici del venerdì santo, in A. Cascetta e Carpa-ni R. (a cura di), La scena e la gloria: drammaturgia e spettacolo a Milano in età spagno-la, Milano, 1995, pp. 585-620.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 50
51
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
to agli studi per la promozione tecnologica e scientifica dell’agricol-tura62, incise però solo parzialmente sulla situazione, così come l’emer-gente classe borghese non riuscì a trovare spazio sufficiente nel siste-ma politico consolidato. La divisione tra una Città Alta, simbolo deiprivilegi nobiliari dell’oligarchia cittadina alleata al potere veneziano,e una Città Bassa, sempre più ricca, popolosa e attiva, progressivamen-te ricettacolo delle istanze più progressiste, si accentuò sul finire delsecolo esplodendo nella cosiddetta rivoluzione bergamasca del 179763.
Sebbene in un contesto tanto difficile e ostile ad accogliere il tea-tro professionistico, è possibile riscontrare una precisa evoluzioneanche del sistema teatrale bergamasco, secondo fasi analoghe a quel-le già verificate nella Terraferma veneta. Un lungo e faticoso succe-dersi di tentativi, generalmente fallimentari, che illustra gli stessi pro-cessi politici, sociali e culturali che, sebbene a Bergamo non riusci-rono a realizzarsi compiutamente, avevano determinato l’erezionedi edifici teatrali stabili in altri luoghi. In Città Alta è, infatti, atte-stato abbastanza precocemente l’uso dei palazzi pubblici per acco-gliere rappresentazioni drammatiche, opzione che permetteva alleautorità cittadine di esercitare un maggiore controllo sugli spettaco-li e sugli interpreti. È questo il caso del luogo teatrale costituito dal-la loggia sottostante il Palazzo della Ragione o dalle sale del Palaz-zo del Capitanio in Cittadella (fig. 1)64. La costruzione del TeatroSecco Suardo negli anni Ottanta del XVII secolo nel palazzo nobi-liare di una delle famiglie più antiche e potenti della città, trova ri-
62. L. Volpi, Tre secoli di cultura bergamasca. Dalle Accademie degli Eccitati e degli Ar-vali all’Ateneo, Bergamo, 1952; J. Schiavini Trezzi, Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti, cit.
63. La crescita demografica che caratterizzò Bergamo nel corso del Settecentomostra lo spopolamento della Città Alta, a fronte di un progressivo e sempre più ac-celerato aumento dei Borghi. Se all’inizio del Seicento la città contava circa 17.500abitanti, a metà del secolo successivo era passata a 25.600 abitanti. Di questi 6.500abitavano in Città Alta, 8.500 in Borgo San Leonardo, 3.000 in Borgo Canale, 5.000in Borgo Sant’Antonio, i rimanenti 2.600 distribuiti nel resto dei borghi: L. Pagani,Le condizioni demografiche ed economiche di Bergamo, cit.; C.M. Belfanti, Dalla stagna-zione alla crescita: la popolazione di Bergamo dal Cinquecento a Napoleone, in Storia eco-nomica e sociale di Bergamo, vol. III, Il tempo della Serenissima, t. 1: L’immagina della ber-gamasca, Bergamo, 1995, pp. 173-214.
64. Sulla differenza concettuale tra luogo teatrale ed edificio teatrale si veda M.Fabbri, E. Garbero Zorzi, A.M. Petrioli Tofani (a cura di), Il luogo teatrale a Firenze.Brunelleschi, Vasari, Buontalenti, Parigi. Spettacolo e musica nella Firenze medicea, introd.di L. Zorzi, Milano, 1975.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 51
52
FRANCESCA FANTAPPIÈ
scontro in quella di altri teatri della Terraferma nati per iniziativa pri-vata, come l’Obizzi di Padova o quelli trevigiani. Eretto ad istanzadel conte Giuseppe Secco Suardo, non solo con intenti autocelebra-tivi o per promuovere il prestigio familiare, si palesò immediatamen-te come un investimento economico, adottando un sistema produt-tivo impresariale e ospitando due personalità, come Antonio Scap-pi e Giacomo Cipriotti, attivamente coinvolte nella circolazione diproduzioni operistiche di successo in area lombardo-veneta, e nonsolo (figg. 5-10).
Se tutto ciò vale per la Città Alta, anche nei Borghi gli impresarinon mancarono. Il primo teatro provvisorio costruito nel prato di San-t’Alessandro da noi conosciuto è del 1714. A questo teatro ne segui-rono molti altri, né la provvisorietà degli edifici impedì che la pro-grammazione melodrammatica fosse decorosa e in qualche modo de-gna d’interesse. Tra gli spettatori illustri dell’opera in musica in fieratroviamo Francesco III d’Este duca di Modena nel 1758 e l’arciducaFerdinando d’Austria nel 1784. Nel prato di Sant’Alessandro, oltre al-l’edificio destinato agli spettacoli musicali, venivano periodicamenteedificati casotti in legno per le rappresentazioni in prosa degli attori.Nonostante che sia quasi del tutto impossibile stabilire la periodicitàdi queste costruzioni, il loro uso da parte delle compagnie professio-niste si configura costante nel tempo, a partire almeno dagli anni Set-tanta del Seicento. Se nel 1720 Giovan Battista Angelini si compiaceche il teatro delle «Diane e le Flaminie» eretto in fiera fosse caduto indisuso, nel 1738 troviamo nuovamente attestato un «casotto dove icomici fanno la commedia»65. Nel corso della seconda metà del seco-lo, grazie agli avvisi conservati in Biblioteca Angelo Mai e agli Indicide’ teatrali spettacoli, possiamo attestare la costante presenza annuale dicompagnie itineranti che usufruivano in modo equivalente dei luo-ghi teatrali della Città Alta, come degli edifici teatrali provvisori nelprato di fiera.
Attribuire con esattezza un luogo per le esibizioni di ogni compa-gnia, che sappiamo passata per Bergamo, è però impossibile. Relati-vamente più semplice è stabilire un arco cronologico entro il qualecollocare l’inserimento della città nei circuiti stagionali delle forma-zioni di attori professionisti. Il fenomeno interessò Bergamo almenodall’ultimo decennio del Cinquecento, quando nel 1583 troviamo i
65. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 376.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 52
53
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
Gelosi di Adriano Valerini e nel 1594, molto probabilmente, IsabellaAndreini che vi pubblicò la sua pastorale Mirtilla. Negli anni Sessan-ta del Seicento alcune formazioni protette dalla famiglia Bentivogliodi Ferrara, tra cui la compagnia di Gioseffo Fiala, e negli anni Ottan-ta una delle due compagnie ducali di Parma. La difficile situazionedocumentaria non permette di esprimere ulteriori conclusioni, nél’estrema frammentarietà delle notizie di stabilire una cronologia uni-forme. Possiamo però trarre alcune conclusioni di ordine generale. Ber-gamo si configura come una piazza teatrale secondaria, frequentatadagli attori prevalentemente nel periodo primaverile o estivo, ossia nel-la prima parte dell’anno comico, fase di riassetto interno delle com-pagnie e meno rilevante dal punto di vista economico, mentre le piaz-ze maggiori, e in particolare Venezia, risultano molto più ambite nelCarnevale, momento in assoluto più redditizio. Rimane, infine, un’ul-tima considerazione. Se confrontiamo la presenza di attori a Berga-mo con quella della vicina Brescia, notiamo una preferenza delle com-pagnie verso quest’ultima, più popolosa e meno difficile da raggiun-gere66. Ciò nonostante la fiera di Sant’Alessandro, garantendo una buo-na affluenza di pubblico e richiamando numerosi forestieri, compen-sò parzialmente tale tendenza. La maggior parte delle compagnie iti-neranti tendeva, infatti, a far coincidere la propria permanenza conquesto periodo.
Tra i tentativi di edificazione di teatri stabili del Settecento si ri-scontrano a Bergamo, come nel resto della Terraferma, quelli a com-mittenza sociale, segno che una parte della società provò a recupera-re il ritardo acquisito nei confronti delle altre città venete. Il primoda noi conosciuto è quello, antecedente al 1720, di un teatro in Bor-go Sant’Antonio, cui seguì nel 1750 quello di un teatro in muraturanel prato di Sant’Alessandro da erigere vicino alle cosiddette “murai-
66. Nelle corrispondenze epistolari degli attori professionisti del primo Seicen-to a noi Bergamo non viene mai menzionata, mentre talvolta troviamo Brescia: C.Burattelli, D. Landolfi, A. Zinanni (a cura di), Comici dell’Arte. Corrispondenze, Firen-ze, Le Lettere, 1993, vol. I, pp. 117-118. Tra le possibili motivazioni di questa assen-za vi potrebbe essere la differenza demografica tra le due città a quest’altezza crono-logica. All’inizio del XVII secolo Brescia contava circa 51.000 abitanti contro i 17.500di Bergamo: L. Pagani, Le condizioni demografiche, cit., p. 103. Non si tratta, però, del-l’unica ragione. Uno dei leit motif delle lettere di attori pervenuti a Bergamo nel cor-so dell’antico regime è proprio quello del disagevole viaggio da effettuare per rag-giungere il luogo.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 53
54
FRANCESCA FANTAPPIÈ
ne” (fig. 1)67. In quest’ultimo caso, per il quale sono a disposizionepiù documenti, è possibile seguire dettagliatamente alcune delle fasitipiche della nascita di teatri a conduzione collettiva e determinare lemotivazioni del fallimento dell’impresa. L’assenza di una cultura as-sociativa radicata e le rivalità mai sopite nel ceto nobiliare portarono,infatti, alla formazione di due fazioni, cui seguirono pericolose discor-die tra alcune delle famiglie più importanti della città. Fu così che, alfine di garantire l’ordine pubblico ed impedire l’aggravarsi delle dia-tribe, il rettore in carica si vide costretto a bloccare il progetto nellasua fase iniziale.
Ma se le rappresentazioni avvenivano in teatri amovibili, quali era-no le regole da rispettare? Il cosiddetto Teatro della Cittadella, attivonella seconda metà del Settecento in Città Alta, era solo un teatro prov-visorio in legno eretto periodicamente in alcune delle sale del Palaz-zo del Capitanio. Pur non trattandosi di un teatro stabile le vertenzenate intorno al suo utilizzo risultano spesso analoghe a quelle riscon-trabili nei teatri in muratura. Esisteva, infatti, una proprietà del tea-tro, ossia della sua struttura lignea, della quale erano responsabili i co-siddetti «fabbricieri» o costruttori. A questo bisogna aggiungere la pro-prietà dei palchetti che, nel caso del Teatro della Cittadella e talvoltaanche di quello dei Borghi, venivano trattati come beni personali, es-sendo numerati, venduti e affittati. Pur riscontrando l’esistenza diquesto sistema, non è stato possibile determinare le modalità di di-stribuzione degli stessi. Se erano numerati, doveva esistere una pian-ta del teatro che, quindi, poteva essere ricostruito sempre nello stes-so modo, anche se in sale diverse. In questo caso quali sarebbero sta-ti gli uffici per l’assegnazione dei palchi? Dove veniva conservato ilteatro smontato? Veniva sempre disfatto o talvolta lasciato in loco? Nona tutte queste domande è stata data una risposta, ma la ricerca ha por-tato alla conoscenza dei nominativi di alcuni dei principali impresa-ri-costruttori del teatrino, quali Domenico Compagnoni, Francesco eNazario Dehe, Giovan Battista Lombardi e fratelli. Così come resta-no del tutto oscuri i processi che portarono ai cambi di «fabriciere»,vanno ancora chiarite le eventuali modalità di affitto dello spazioconcesso dal Rettore per la costruzione del Teatro della Cittadella. So-
67. “Muraine” è il termine normalmente usato per indicare la prima cerchia dimura, attualmente scomparsa, eretta nel Quattrocento, che racchiudeva i Borghi diSan Leonardo e Sant’Antonio.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 54
55
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
no, invece, parzialmente risolte le domande relative alla concessionedel fondo destinato all’erezione del teatro in fiera nel prato di San-t’Alessandro, i cui proventi spettavano all’Ospedale Maggiore. Ciò cheappare chiaro in entrambi i casi è che il sistema teatrale bergamascosi basava su una netta divisione tra costruttori locali, preposti alla cu-ra dei luoghi per la rappresentazione, e impresari itineranti da cui di-pendeva la scelta del repertorio. Il mantenimento della figura del co-struttore, che non diventava mai proprietario di uno teatro stabile, masolo di uno amovibile, si rivelò il mezzo più efficace per impedirel’emergere di una personalità troppo influente nella città.
La legislazione teatrale prodotta dalle autorità municipali nel corsodel XVIII secolo, piuttosto che essere diretta a risolvere la questionedell’assenza di un teatro stabile, circostanza che non veniva sentita inrealtà come un problema, si concentrò, invece, sulla definizione di re-gole utili a contenere l’attività degli impresari. Tra quelli specializzatinel settore musicale e attivi in area lombardo-veneta troviamo SantoBurigotti68, Pietro Denzio69, Francesco Puttini70, Paolo Navaglia71, Gae-tano Belloni72. Era la loro circolazione nella città, alquanto differenzia-ta e in progressivo aumento, che destava i timori maggiori. La questio-ne maggiormente sentita dall’oligarchia cittadina fu limitare l’arrivo in-discriminato di persone forestiere, oltre che stabilire norme che permet-tessero di osservare il decoro e il buon costume. I Capitoli per la Disci-plina dei teatri pubblicati il 14 marzo 1775 stabilirono la creazione dei
68. Impresario attivo a Torino (1721), Bergamo (1723), Verona (1724), Mantova(1725), cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 2909, 13321, 17491, 23319,24462 e Indici, vol. I, p. 473.
69. Impresario attivo a Ferrara (1711, 1712, 1718), Venezia (Teatro San Moisé:1715), Bergamo (1726), Mantova (1726): Ivi, libretti 9909, 9914, 9916, 10269, 10271,14123, 14497, 17678, 19885, 23102, 23384 e Indici, vol. I, p. 475.
70. Impresario attivo a Pavia (1756, 1757), Bergamo (1759), Verona (1760), Bres-sanone (1760), Brescia (1775), Genova (Teatro Sant’Agostino): 1776, 1777, 1778, 1780,1788); Milano (Teatro Interinale: 1776, 1777, 1778): Ivi, libretti 413, 2139, 2170, 3075,3078, 3353, 3521, 4173, 7745, 7819, 8596, 9505, 9539, 9542, 10957, 15133, 15332,15549, 16580, 17019, 19104, 19393, 24597, 35084 e Indici, vol. I, p. 480.
71. Impresario attivo a Bergamo (1729), Brescia (1730): Ivi, libretti 9222, 21956e Indici, vol. I, p. 479.
72. Impresario attivo a Crema (1786, 1788, 1789, 1790, 1792, 1795); Pavia (1791,1792); Bergamo (1791, 1794, 1795); Milano (1791); Varese (1794, 1795, 1796): Ivi, li-bretti 319, 3160, 3329, 3696a, 4471, 5436, 6728, 7586, 7860, 8578, 8970, 15347a,15373, 16015, 16855, 18161, 18806, 21728, 23262 e Indici, vol. I, p. 472.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 55
56
FRANCESCA FANTAPPIÈ
cosiddetti Presidenti teatrali, una carica elettiva ideata dai ConsigliMaggiore e Minore, costituita da tre deputati preposti al controllo del-l’attività teatrale cittadina, ai quali veniva riservato di diritto un palchet-to negli edifici edificati periodicamente. Il contesto si rivelò però trop-po complesso perché i tre Presidenti riuscissero ad adempiere al pro-prio compito, cosicché quando nel 1777 l’im presario-costruttore Gio-van Battista Lombardi chiese al Consiglio municipale l’esclu siva nel-l’erezione dei teatri provvisori cittadini, la supplica venne immediata-mente accettata73. La «privativa» assegnata al Lombardi si trasformò inun monopolio della produzione operistica e consolidò definitivamen-te l’offerta spettacolare annuale: nel teatro di Città Alta la programma-zione invernale (opera buffa), nel teatro di Città Bassa quella estiva perla fiera di Sant’Alessandro (opera seria).
La svolta definitiva fu comunque costituita dall’erezione del TeatroRiccardi nel prato di Sant’Alessandro. La scelta del luogo non è sor-prendente. Come già visto, i falliti tentativi settecenteschi di erezionedi un teatro stabile si concentrarono principalmente su questo spazio.Oltre a quelli già ricordati bisogna aggiungervi la supplica del -l’impresario Francesco Bolognese, il quale nel 1770 chiese al Comunedi Bergamo il permesso di erigere un teatro in muratura in fiera, sul-l’«esempio del nuovo teatro di Padova»74. La domanda venne risoluta-mente respinta. L’esito positivo del processo che portò all’edificazionedel Teatro Riccardi non fu quindi automatico, né si presenta come lapacifica conclusione di un lungo corso evolutivo, ma fu dovuto prin-cipalmente all’abile e ostinata azione di Bortolo Riccardi il quale, ag-girando i numerosi divieti imposti, ruppe definitivamente gli equilibriconsolidati. Dopo aver ottenuto il permesso nel 1786 di costruire unsemplice portico a piloni per circondare e coprire il vecchio teatro prov-visionale in legno, il costruttore passò, senza mai averne ricevuto l’aval-lo ufficiale, alla riedificazione in muratura dell’intero l’edificio, com-pletata solo nel 1791. L’ope razione messa in campo dal Riccardi fu atratti rocambolesca, rischiosa ma decisa, scaltra soprattutto nello sfrut-
73. Accanto a lui, nelle produzioni operistiche bergamasche, troviamo sempreil violinista Giuseppe Lombardi, probabilmente suo fratello, con il ruolo di «primoviolino dei balli». La loro attività si presenta come esclusivamente concentrata a Ber-gamo, escluso per l’anno 1781 in cui Giuseppe Lombardi allestisce l’opera Le nozzein contrasto per l’accademia degli Erranti di Brescia, Ivi, libretto 16781.
74. Documento 1770: 3, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 56
57
POTERE E TEATRO NELLA REPUBBLICA VENETA
tare a proprio vantaggio le divisioni interne degli avversari. I cinque an-ni che intercorsero furono, infatti, segnati da interminabili e intricatevertenze legali. Bortolo Riccardi contro i palchettisti, i palchettisti con-tro la Città, la Città contro l’Ospedale e il Riccardi, i palchettisti e laCittà contro il Riccardi, in una combinazione quasi infinita che si con-cluse solo con il riconoscimento da parte di Venezia al costruttore del-la proprietà del nuovo edificio in muratura e con la capitolazione diuna parte dell’oligarchia cittadina che accettò recalcitrante l’affermazio-ne dell’uomo nuovo. La vicenda biografica del Riccardi, esponente del-la classe borghese emergente, fervido fautore della caduta della domi-nazione veneta e del rinnovamento della classe dirigente bergamasca,diventa quindi emblematica del cambiamento in atto75.
La decisione di prendere il 1797 come termine cronologico dellaricerca nasce, perciò, non solo dall’evidente constatazione di una frat-tura politica, ma anche dalla consapevolezza di un forte cambiamen-to della società bergamasca. Il processo di costituzione di un sistemateatrale urbanisticamente riconosciuto, affermatosi solo nell’ultimo de-cennio della dominazione veneta, subì un’accelerazione del tutto stra-ordinaria nel periodo napoleonico che costituì un’evidente inversio-ne di tendenza rispetto alle vicende anteriori. Vediamo così che do-po lo smantellamento del Teatro della Cittadella, avvenuto per ordi-ne del capitanio Alessandro Ottolini, ultimo rettore veneto di Berga-mo cacciato con l’arrivo delle truppe dei francesi, la costruzione diun teatro stabile in Città Alta fu immediata, né sottoposta alle inter-minabili contrattazioni tra potere centrale e periferico, caratteristichedel periodo veneto, o ad altri tipi di restrizioni. Per l’operazione ven-ne scelta la sala del Palazzo della Ragione, in cui fu eretto il TeatroCerri, una sorta di teatro della “transizione” che rimase attivo per die-ci anni, nel corso dei quali nuove e più coese istanze sociali portaro-no al compimento del progetto che dette origine al Teatro Sociale. Ilbinomio costituito tra Città Alta e Bassa, caratteristico del XVIII se-colo, ma allora possibile solo attraverso l’utilizzo di teatri provvisori,venne così definitivamente ricostituito nell’Ottocento attraverso i dueprincipali teatri stabili della storia cittadina bergamasca.
75. Insieme allo stampatore Francesco Locatelli e al nobile Giovan Battista Vi-tali Rota (impresario nel 1786 della Didone abbandonata) venne imprigionato, nel cor-so del 1796, per le sue idee giacobine e filofrancesi. Si veda in proposito Infra, pp.234-235.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 57
59
1. Documento 1644: 8, in Regesto.2. Le adunanze accademiche tenute nel 1643 a noi note, una dell’8 e l’altra del
13 febbraio, ebbero luogo nel convento di Sant’Agostino. Per quanto riguarda il 1644si conoscono le seguenti date e luoghi: 9 giugno, Sala Grande del Palazzo della Ra-gione; 16 e 30 giugno, Palazzo del vescovo; 16 agosto, «sala del Signor Olmi»: Do-cumento 1644: 8, in Regesto. Tra gli anni Cinquanta e Sessanta le riunioni, che se-condo i capitoli del sodalizio avrebbero dovuto tenersi il giovedì due volte al mese,vennero nuovamente ospitate, a partire dal 9 febbraio del 1647, nel convento di San-t’Agostino: «L’accademia delli Eccitati, alcuni anni avanti principata, sotto l’indiriz-zo e a mossa di Bonifacio Agliardi, fu poi generale de’ teatini e vescovo d’Adria, Cle-mente Rivola, fu poi arciprete di Santa Maria antica in Verona, e Donato Calvi, chequi scrive, senza titolo alcuno in questo giorno, con solenne pompa, e virtuoso con-
1. I palazzi del potere in Piazza Vecchia
1.1. Le sale del Palazzo della Ragione, Palazzo del Podestà1.1. e Palazzo Nuovo
Il primo documento a noi noto, relativo ad un uso degli ambien-ti offerti dagli edifici comunali per attività di pubblico intrattenimen-to, registra la prima adunanza pubblica, tenuta «sopra il PalazzoGrande della Ragione alli 9 giugno 1644»1, della appena costituitasiaccademia degli Eccitati. Non si trattò di uno spettacolo teatrale, madi un semplice incontro letterario, accompagnato da inserti musica-li, nel corso del quale il padre teatino don Bonifacio Agliardi, allapresenza di un pubblico accuratamente selezionato, in cui figurava-no «l’Illustrissimo Signor Pietro Contarini capitano con quasi tuttala nobiltà della città», espose un’erudita disquisizione sul controver-so primato di lettere e musica2. Ancora nel 1669 abbiamo notizia di
FRANCESCA FANTAPPIÈ
PARTE II.Il teatro della Città Alta
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 59
60
FRANCESCA FANTAPPIÈ
un evento organizzato dagli Eccitati «nel palazzo pubblico», per ce-lebrare la partenza del capitanio Pietro Dolfin, consistente in que-sto caso nella declamazione di un panegirico in lode del Rettoreuscente3.
La prima rappresentazione drammatica messa in scena nel Palaz-zo della Ragione, sebbene sia l’unico esempio accertato di un uso diquesto spazio per tale scopo in epoca di antico regime, costituisce unepisodio di portata straordinaria per la storia teatrale cittadina. Si trat-ta, infatti, del primo allestimento conosciuto di un’opera in musica aBergamo. Nel gennaio del 1654 venne messo in scena nella «Sala Gran-de ove si tiene la Ragione» l’Ercole effeminato di Almerico Passarelli conmusica di Maurizio Cazzati, maestro di cappella di Santa Maria Mag-giore4. La particolare rilevanza dell’evento indusse nientemeno che Do-nato Calvi a introdurre un ampio ricordo dell’episodio nella sua Ef-femeride sagro profana, sotto il giorno 11 gennaio 1654:
Già mai in Bergamo erano state opere drammatiche in musica recitate,quand’hoggi per la prima volta nel Palazzo della Ragione fu aperta la por-ta alla nobil impresa, essendosi con ogni maggior pompa di teatro, habi-ti & voci rappresentato l’Ercole effemminato, degna compositione di Mau-ritio Cazzati maestro di cappella in S. Maria Maggiore & ciò con granconcorso di cittadini e forastieri & publico aggradimento della città. Fuquest’opera nel medesimo Carnevale molte volte rappresentata & indi ne-
corso de’ cittadini, s’apriì con la spiegatione dell’impresa per la prima volta in San-t’Agostino. Porta quest’accademia l’impresa d’un alba nascente con il motto Iacen-tes excitat che fu nel congresso d’hoggi valorosamente da varie oppositioni diffesa,dall’accademico Rugginoso Antonio Guerrini canonico, portando di quest’accade-mia il prencipato Theodoro conte Albano», in D. Calvi, Effemeride sagro-profana, cit.,vol. I, p. 188. Le sedute di cui abbiamo notizia grazie ad alcuni verbali rimasti (peri quali si rimanda alle trascrizioni di Erminio Gennaro in J. Schiavini Trezzi, Ateneodi Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo, cit., pp. 587-595) furono le seguenti: 15 genna-io, 9, 13 e 23 febbraio, 20 luglio, 22 agosto, 5 settembre, 14 dicembre 1656, 14 giu-gno, 12 luglio 1657, 2 febbraio, 22 agosto 1658, 1 maggio 1659, 23, 29 e 31 genna-io 1660, 29 agosto 1661, 22 agosto e 9 settembre 1662, 6 settembre 1663. Nel cor-so delle adunanze si svolgevano dispute di argomento letterario e/o declamazionidi componimenti poetici cui venivano associate esibizioni musicali per le quali sifaceva talvolta fatto ricorso a cantanti e musicisti attivi a Bergamo o, in alcuni casi,provenienti da fuori: Milano, Napoli, Verona, Venezia.
3. A. Lupis, ll simolacro della gloria in lode dell’Eccellenza del sig. Pietro Dolfino capi-tanio di Bergamo inalzato da Antonio Lupis nel palazzo pubblico di essa città in nome del-l’Accademia degli Eccitati, Bergamo, Figliuoli di Marc’Antonio Rossi, 1669.
4. Documento 1654: 1.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 60
61
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
gl’anni susseguenti altre opere nella stessa forma recitate che fino all’an-no corrente furno, Il casto Giuseppe, la Rodope, le fortune di Seiano, la Dori,l’Annibale in Capua, il Giasone, il Seleuco, &c. Dal diario mio5.
Poco sappiamo in merito allo svolgimento o all’esito dello spetta-colo, se si eccettuano le parole del frate agostiniano. Ciò che apparesicuro però è che l’utilizzo, fino ad ora considerato incerto, della sa-la principale del «Palagio grande di Bergamo» non può essere ulterior-mente messo in discussione6. Né tantomeno le controversie, tra gli al-lestitori dell’evento e il campanaro del palazzo, che ne derivarono. Èinfatti grazie a queste che ci sono giunte alcune notizie inerenti l’or-ganizzazione dello spettacolo.
Coordinatori e, probabilmente, finanziatori dell’opera furono In-nocenzo Pezzolo e Antonio Adelasio i quali, ottenuta in voce la ne-cessaria licenza da parte dei deputati pro tempore conte David SeccoSuardo, Giovanni Moiolo e Alfonso della Torre, dichiararono di agi-re «con opinione indubitata di recare all’universale delle genti spetta-colo altrettanto gradito, quanto dilettevole e virtuoso»7. Le lodevoliintenzioni espresse si scontrarono però con l’ostilità del «balotino»8
Giovanni Palazzo, al quale Innocenzo Pezzolo chiese di non suona-re le campane la sera prevista per la rappresentazione. Il custode, nonavendo ricevuto alcuna notifica ufficiale dai deputati del Consiglio eper non contravvenire al proprio incarico, rifiutò di acconsentire allarichiesta. Uno scontro dal quale derivarono le violente minacce delPezzolo contro il campanaro, comportamento successivamente stig-
5. In D. Calvi, Effemeride sagro-profana, cit., vol. I, p. 45 e L. Pilon, Il teatro dellasocietà, cit., p. 5. Delle opere che l’erudito indica come rappresentate a Bergamo trail 1654 e il 1676 sono stati recuperati i libretti di almeno cinque per i quali si riman-da alla Cronologia sotto le seguenti voci: Il Giuseppe (1656), Le fortune di Rodope e Da-mira (1660), La Dori (1667), L’Annibale in Capua (1668) e La prosperità di Elio Seiano(1668).
6. L’uso della Sala Grande del Palazzo della Ragione era stata finora ritenuta in-certa da M. Mencaroni Zoppetti, Sul teatro sociale, cit., pp. 479-487: 482 e P. Forcel-la, Musica e musicisti a Bergamo, cit., p. 34. Dubbio apparentemente ingiustificato inquanto il frontespizio del libretto registra puntualmente come luogo della rappre-sentazione il «Palagio grande di Bergamo». Per l’indicazione documentaria si riman-da alla Cronologia, ad annum.
7. Documento 1654: 1 in Regesto. Antonio Adelasio anche figura tra gli iscrittiall’accademia degli Eccitati nel 1644.
8. Documento 1654: 2, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 61
62
FRANCESCA FANTAPPIÈ
matizzato dal Consiglio comunale, ma che, almeno apparentemente,non portò ad una sospensione dello spettacolo.
Per quanto riguarda l’allestimento dell’opera i nostri dati sono esi-gui. Dobbiamo limitarci a quelli contenuti nel libretto, che non ri-porta i nomi dei cantanti (circostanza del tutto normale a quest’altez-za cronologica), né indicazioni sulla scenografia. Questa non sembraprevedesse alcun cambio di scena (non esistono, infatti, didascalie inmerito) ed era probabilmente costituita da una scena fissa, rappresen-tante un paesaggio che ricordava «la Lidia». Ma di che tipo? Unicoelemento di riflessione in tal senso è l’immagine che apre il testo, nel-la quale vediamo raffigurato il personaggio principale: Ercole (fig. 2).Egli indossa i classici calzari e una corta veste di pelle di leone, sor-regge la clava come fosse uno scettro e siede su un carro trainato dadue leoni, sovrastato da un piccolo baldacchino circolare sotto cuistanno due cupidi. Dietro la figura appare un pilastro che rimanda adun’ambientazione anticheggiante. Ciò che maggiormente stupisce, ein qualche modo insospettisce in merito ad un reale riferimento del-l’immagine con la rappresentazione dell’opera in questione, è quan-to troviamo scritto nel vessillo posto dietro le spalle dell’eroe: «Erco-le in Tebe». Si tratta, infatti, del titolo di un altro filone di opere le-gate alla leggenda di Ercole, relativo al suo ritorno alla città natale do-po il compimento delle famose dodici fatiche9. L’Ercole effemminato è,invece, ambientato in Lidia e si presenta come una reinterpretazionedi un’altra vicenda della vita dell’eroe, quella dell’anno passato comeschiavo della regina Onfale, nel corso del quale sarebbe stato costret-to ad indossare abiti femminili e svolgere mansioni muliebri10. La raf-figurazione, utile per suggerire una possibile ambientazione del dram-ma, non può perciò essere utilizzata per attingere elementi descritti-vi della rappresentazione bergamasca del 1654, poiché deriva moltoprobabilmente da altre messe in scena.
Come accennato si tratta dell’unico episodio finora accertato di uti-lizzo della Sala Grande del Palazzo della Ragione per l’allestimento
9. Memorabile Ercole in Tebe fu il melodramma di Giovanni Andrea Moniglia,musica di Jacopo Melani, con cui vennero celebrate le nozze di Cosimo III de’ Me-dici e Margherita Luisa d’Orleans nel Teatro della Pergola di Firenze (1661).
10. Sui diversi episodi della storia di Ercole utilizzati nelle opere in musica nelcorso dei secoli si veda la voce Ercole del Dizionario enciclopedico universale della musi-ca e dei musicisti, diretto da A. Basso, I titoli e i personaggi, 3 voll., Torino, 1999.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 62
63
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
di una rappresentazione teatrale in epoca di antico regime, in quan-to la concessione di beni immobili di proprietà del Comune era sot-toposta ad una legislazione molto restrittiva. Ogni domanda, dopoessere stata vagliata dai Consigli, per poter essere approvata doveva ri-cevere più dei due terzi dei voti dell’assemblea, in base ad una deli-bera ratificata il 21 dicembre 1619 a tutela del patrimonio comunale.Estremamente difficile ottenere il permesso. Scarse le domande. Traesse quella, prontamente respinta, del burattinaio Angelo Vignola ilquale, presente in città nel 1660 «con l’occasione della fiera» ed eser-citando la «professione di far ballare alcune piccole figurine dettebamboci», chiese di poter usufruire di una «stanza di ragione di que-sto pubblico sotto il Palazzo Novo» per i propri spettacoli11. Non sitratta in questo caso del Palazzo della Ragione, ma del cosiddetto Pa-lazzo Nuovo, attuale sede della Biblioteca Angelo Mai12.
Nel corso del Settecento le domande reperite si fanno ancora piùrare. Dobbiamo attendere la seconda metà del secolo perché un’acca-demia «di dilettanti di musica» si accinga a superare l’ostacolo. Il 14marzo 1766 i nobili Flaminio Marchesi e Giovan Battista Brescianichiedono di usufruire di una «sala di questo palazzo che è contiguaalla Cancelleria dell’Officio Illustrissimo della Sanità» per le adunan-ze pubbliche13. Si tratta dal Palazzo Nuovo14. La risposta non fu im-
11. Documenti 1660: 2-3, in Regesto.12. Sulla secolare vicenda costruttiva del palazzo si vedano S. Angelini, Berga-
mo: città alta. Una vicenda urbana, con scritti di L. Angelini, W. Barbero, P. Capelli-ni, V. Landolfi, Bergamo, 1989, pp. 20-21 e M.L. Scalvini, G.P. Calza, P. Finardi, Lecittà nella storia d’Italia. Bergamo, Bari, 1987, pp. 58, 69, 74, 85-87. Progettato nel 1593dall’architetto Andrea Ceresola detto il Vannone, nel 1599 vennero messe le fonda-menta. La costruzione iniziata nel 1604, vide il nuovo progetto di Vincenzo Sca-mozzi nel 1611. È solo nel 1668 che i rappresentanti della Città presero definitiva-mente sede nel Palazzo Nuovo, mentre l’inaugurazione ufficiale sarebbe avvenutanel 1697.
13. Documento 1766: 1, in Regesto.14. Dal 1668 i Deputati iniziarono a riunirsi nel Palazzo Nuovo secondo S. An-
gelini, Bergamo: città alta, cit., p. 21. Nella seconda metà del Settecento il viaggiato-re francese Jérôme de Lalande, descrivendo la Città Alta, affermava che vi si trova-vano «le Palazzo Vecchio où l’on tient les audiences, et où l’on rend la justice; le Pa-lazzo Nuovo où se tiennent les conseils de la ville», Voyage d’un françois en Italie, faitdans les anées 1765 &1766, Venise, 1769, riportato da V. Zanella, Formazione di Ber-gamo moderna riepilogo delle vicende urbanistiche dal 1797 al 1951, in L’Urbanistica a Ber-gamo, Bergamo, 1962, pp. 37-109: 49-50.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 63
64
FRANCESCA FANTAPPIÈ
mediata e, con delibera del 15 marzo 1766, il Consiglio Minore inca-ricò quattro deputati di stilare una relazione per approfondire la te-matica, chiarire l’uso previsto degli ambienti richiesti, redigere le nor-me che gli accademici avrebbero dovuto seguire15. Tra gli articoli delcontratto stilati dai deputati incaricati dal Consiglio troviamo normedi ordine generale, come la limitazione della concessione a soli tre an-ni, oltre ad altre più specifiche quali il permesso di potervi «tenere ilcembalo», l’obbligo di mantenere chiuse le porte che conducevano adaltre stanze, la possibilità per i servitori degli accademici di poter at-tendere nell’atrio sottostante il palazzo, etc. La premessa apposta aicapitoli appariva come favorevole: secondo i compilatori del docu-mento «è stato sempre mai costume di questo Illustrissimo Pubblicodi accondiscendere facilmente alle istanze de’ cittadini qualunquevolta avessero lodevoli oggetti», segno che le intenzioni generali del-l’accademia vennero reputate meritorie16. Nonostante ciò la richiestanon riuscì ad ottenere i due terzi dei voti e venne respinta17. Il 25 apri-le fu quindi necessaria una nuova supplica nella quale l’Accademia diMusica, per rendere la proposta opportunamente più allettante, offri-va ulteriori incentivi ed assicurazioni, come il versamento di un ca-none annuo a beneplacito del Comune, il pagamento dell’illumina-zione della scala che conduceva alla sala e la presenza di guardie percustodire la porta principale del palazzo in caso di adunanze nottur-ne18. Questa volta, dopo aver stabilito un affitto annuale di «lirettequattro di cera», la delibera passò ad ampia maggioranza19.
Una decina di anni più tardi troviamo «un buon numero di nobi-li cittadini», rappresentato dai conti Giovanni Benaglio e Filippo Vi-talba, chiedere l’uso del «Palazzo della Città» per potervi eseguire «unacantata in musica in onore e plauso» del rettore uscente Giovan Pao-lo Baglioni20. Difficile capire, solo sulla base di questa scarna defini-zione, se venga fatto riferimento al Palazzo della Ragione o al Palaz-zo Nuovo. La richiesta è, però, molto dettagliata. In data 22 aprile
15. Documento 1766: 2, in Regesto.16. Documento 1766: 3, in Regesto.17. Documento 1766: 4, in Regesto.18. Documento 1766: 5, in Regesto. Tra i membri del sodalizio che sottoscrivo-
no la richiesta figurano Pompilio Calepio, Paolo Vimercati Sozzi, Lodovico MariaRoncalli, Antonio Franchetti, Luigi Grismondi, Giovanni Pezzoli.
19. Documento 1766: 6, in Regesto.20. Documento 1775: 6, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 64
65
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
1775 i due portavoce chiedono «l’uso della sala grande e delle due la-terali» assicurando che nella sera stabilita per l’evento il luogo sareb-be stato adornato da una «convenevole illuminazione»21. L’importan-za dell’occasione e la volontà di dare risalto alle celebrazioni per lapartenza del capitanio indussero il Consiglio Maggiore ad approvarela supplica senza opporre le consuete resistenze. Ciò che stupisce, se-gno evidente della rilevanza attribuita all’evento, è che, pur di per-mettere l’autorizzazione della domanda, venne stabilito unanime-mente, e senza troppe esitazioni, di scavalcare la legge a tutela dei be-ni comunali, dichiarando che «la presente non sarà soggetta alle stret-tezze della parte 21 dicembre 1619, la quale contempla casi diversi»22.Una decisione evidentemente arbitraria che mostra quanto l’approva-zione delle domande non dipendesse solo da ragioni meramente nor-mative. Per l’occasione venne rappresentata la cantata intitolata L’omag-gio sincero, musica di Carlo Lenzi, con un cast canoro di tutto rispet-to in cui spiccano in particolare Giovanni Tajana e Giacomo David23.
Le occasioni per celebrare i rettori potevano essere molte e nonsempre legate alla partenza e all’arrivo degli stessi24. Nel Carnevale del1733 vediamo che, in onore della podestaressa Adriana Dolfin Bon-fadini, venne organizzata una mascherata in costume con relativo per-corso urbano, alla quale parteciparono le maggiori famiglie della no-biltà bergamasca. La festa, denominata Il trionfo di Cibele, si conclusecon un balletto nella sala del Palazzo del Podestà25.
21. Documento 1775: 6, in Regesto.22. Documento 1775: 7, in Regesto.23. La luminosa carriera operistica del tenore bergamasco Giacomo David è cir-
coscrivibile agli anni tra il 1770 e il 1803, Dizionario enciclopedico universale della mu-sica e dei musicisti, diretto da A. Basso, Le biografie, Torino, 1988, vol. II, p. 410 e C.Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., Indici, vol. II, ad vocem. La vicenda artistica diGiovanni Tajana, molto minore, va dal 1777 al 1792, Ivi, ad vocem. In merito a que-st’ultimo vale la pena ricordare come, nel 1785, figuri tra i membri di una loggiamassonica bergamasca, per cui si veda Infra, pp. 229-230.
24. Sulle cerimonie tributate all’arrivo e alla partenza dei rettori si vedano A. Pi-netti, Nunzi e ambasciatori della Magnifica Città, cit. e A. Locatelli Milesi, Pubbliche ce-rimonie cittadine, cit.
25. Per una dettagliata ed accurata descrizione dell’evento si veda il saggio di M.Mencaroni Zoppetti, …Orobia pendice teatro felice… La festa nella Bergamo del Settecen-to, in «La Rivista di Bergamo», n. s. 6 (luglio-agosto-settembre 1996), pp. 36-41. Se-condo la studiosa la mascherata si sarebbe conclusa nella Sala della Ragione dove,in base al poema in terza rima di Giovan Battista Angelini, Per darti notizie del paese,
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 65
66
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Si tratta, comunque, di occasioni isolate che non denotano unamentalità particolarmente incline ad aperture verso il teatro profes-sionistico. Un confronto con la vicenda della vicina città di Cremapuò far risaltare maggiormente le differenze e dimostrare che se a Ber-gamo non furono trovati spazi pubblici atti ad ospitare stabilmente ilfenomeno, non fu per particolari difficoltà oggettive, ma perché nonne esisteva la volontà. L’atteggiamento espresso dalla classe dirigentebergamasca fu, infatti, opposto a quello riscontrabile nell’oligarchiacremasca. Con alcune migliaia di abitanti in meno rispetto a Berga-mo e governata da un solo Rettore26, la costruzione del primo teatropubblico di Crema, si deve alla volontà del Consiglio comunale. L’edi-ficio venne costruito a spese pubbliche durante il riassetto urbanisti-co della piazza principale, in cui avevano sede i palazzi del Comunee del Rettore veneto, oltre a quello vescovile. Con delibera del 17 set-tembre 1681 il Consiglio cittadino stabilì di destinare all’erezione di«un teatro per commodo de’ recitanti et publico decoro»27 una partedei nuovi locali previsti. I lavori del cantiere, che avrebbero dovutomettere a disposizione ambienti di pubblica utilità, si protrassero fi-no al 1683 e furono finalizzati a ridurre «la fabbrica (…) a maggiorperfezione e renderla capace anco di teatro per recitanti senza esclu-dervi l’accademia»28. Un modo di agire totalmente diverso da quantoavveniva a Bergamo, dove l’arricchimento degli spazi comunali, do-
cit., p. 6, si tenevano abitualmente «feste pubbliche e carole». Lo spoglio delle sup-pliche rivolte ai Consigli non ha però portato al reperimento di alcuna domandaper un utilizzo di questo spazio con riferimento a Il trionfo di Cibele. Per quanto ri-guarda questa festa sembra invece più probabile pensare ad un uso della sala prin-cipale del Palazzo del Podestà descritta, come «sala ducale qual di largo quadrato hala sembianza» da Giovan Battista Angelini, Ivi, p. 6. La mascherata, che celebrava lapodestaressa Adriana Bonfandin nelle vesti di Cibele, prevedeva infatti uno svolgi-mento circolare. L’inizio del corteo, con l’uscita della protagonista dalle sue dimo-re e la sua salita in carrozza, avvenne davanti al Palazzo del Podestà. Dopo aver at-traversato tutta la città il percorso si concluse, tornando al punto di partenza, in Piaz-za Vecchia: G.B. Angelini, Il trionfo di Cibele. Rappresentato nella nobile e pomposa Ma-scherata fatta in Bergomo addì 9 febbraio 1733. Baccanale di Giovambattista Angelini a SuaEccellenza la signora Andriana Dolfin Bonfadini podestaressa, Bergamo, 1733.
26. Se nel 1548 Crema contava circa 10.600 abitanti contro i 17.700 di Berga-mo, nella prima metà del Seicento la distanza è minore essendo pari a 13.000 con-tro 17.500, M. Ginatempo, L. Sandri, L’Italia delle città, cit., pp. 79, 250-251 e L. Pa-gani, Le condizioni demografiche ed economiche, cit.
27. Documento 1681: 2, in Regesto.28. Documento 1683: 1, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 66
67
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
vuto alla costruzione del Palazzo Nuovo, non incluse la prospettivadi un suo parziale utilizzo per finalità spettacolari. Espressione dellavolontà condivisa dell’oligarchia cremasca appaiono le norme istitui-te per l’acquisto dei palchetti, trentotto in tutto distribuiti su due or-dini, trasmissibili solo per via ereditaria e concessi ai soli «soggetti diquesto Consiglio et altri citadini riguardevoli», altrimenti descritti co-me chi «fosse di Consiglio o nobile veneto»29.
La programmazione del teatro cremasco fu fin dall’inizio moltovariegata. Tra il 1682 e il 1683 riscontriamo rappresentazioni dilet-tantesche capeggiate dal nobile Ettore Vimercati, tra cui la rappre-sentazione di «un’opera intitolata La pazzia politica de’ Rodrigo re diCicilia»30. Negli anni successivi il teatro risultava già inserito in uncircuito a pagamento e concesso ad attori o impresari: dalla compa-gnia di Antonio Broglia, all’impresario Antonio Scappi, all’artista Fi-lippo Giuliani «che intende far giuochi»31. Il successo dell’operazio-ne indusse il Consiglio ad approvare nel 1687 l’aggiunta di un ordi-ne di diciotto palchetti al piano inferiore, associando la ristruttura-zione ad un rinnovamento della scenografia32. Per i lavori da effet-tuare nell’impianto della sala vennero chiamati alcuni costruttori lo-cali, mentre per quelli riguardanti il palcoscenico lo scenografo ve-neziano Gaspare Torelli33.
Così come il teatro di Crema nacque per volere del Consiglio mu-nicipale, allo stesso modo venne demolito. Il 7 gennaio 1708 fu deli-berato, infatti, di «rimover il teatro che alias fu construtto e fabricar-ne un altro», per allontanarlo dall’archivio cittadino, giudicandolotroppo pericoloso, alla luce di quanto successo nel «memorabile in-cendio del teatro di Milano seguito pochi giorni sono»34. La città non
29. Documento 1683: 2, in Regesto.30. Documenti 1682: 1-2; 1683: 3, in Regesto.31. Documenti 1684: 3; 1686: 1, 3, in Regesto.32. Nella delibera si decise di «construere al piano sedici palchetti oltre li due con-
tigui alla scena che devono servire per li musici e recitanti»: Documento 1687: 4.33. Documenti 1687: 5, 19. I costruttori, falegnami e muratori, locali furono «ma-
stro Antonio Golcio», «mastro Bernardo Antonietti e Teodoro Tresino», «AntonioScarpino ingegniero», ASV, Inquisitori di Stato 914, quaderno intitolato Teatro, c. 29v.
34. Delibera del Consiglio comunale di Crema, 7 gennaio 1708, ASV, Inquisito-ri di Stato 914, quaderno intitolato Teatro, cc. 30rv, 44r. A questo proposito è utileanche il fascicolo, contenuto nella stessa filza, intitolato Atti del rettore di Crema rela-tivi a quel teatro. 1681, c. 43r. Sull’incendio che nel 1708 distrusse il teatro di Mila-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 67
68
FRANCESCA FANTAPPIÈ
rimase, però, senza un teatro, poiché i nobili proprietari dei palchet-ti dell’edificio smantellato reclamarono i propri diritti. Nel 1716 il Co-mune dichiarò l’intenzione di costruirne uno nuovo al più presto, in-dividuando come luogo destinato allo scopo uno spazio «sopra la rog-gia di Crema»35, lontano dal centro urbano. Il progetto, completatosolo nel 1717, momento in cui seguì la redistribuzione dei palchetti,fu quindi promosso ancora una volta dalla volontà dell’oligarchia cit-tadina espressa nel Consiglio municipale.
1.2. La loggia sotto il Palazzo della Ragione
Le domande di edificazione di teatri provvisori in legno sotto laloggia del Palazzo della Ragione anche se non molto numerose, ri-mangono costanti nel tempo: iniziano dalla metà del Seicento e pro-seguono per tutto il Settecento. Le richieste, però, sebbene formalmen-te simili a quelle redatte per usufruire di ambienti interni ai palazzicomunali, provenivano da una categoria di postulanti molto diversa.Non accademie, né gruppi di nobili cittadini intenzionati a rendereomaggio ai rettori con cerimonie ufficiali, ma artisti o impresari atti-vi in un circuito teatrale a pagamento, interessati ad ottenere lo spa-zio nel periodo di Carnevale. Trattandosi di luoghi pubblici di pro-prietà comunale sottoposti alla legge del 21 dicembre 1619, in basealla quale le domande potevano essere accettate solo con due terzi deivoti, anche in questo caso le concessioni furono rare. Su sette suppli-che a noi note, solamente due ottennero un esito positivo36. Ciono-nostante non possiamo affermare di conoscere tutte quelle effettiva-mente presentate. La prima notizia dell’intenzione di costruire un tea-tro sotto la loggia del Palazzo della Ragione allo scopo di mettere inscena rappresentazioni musicali risale all’ottobre del 1673, quando il
no si vedano almeno A. Paglicci Brozzi, Contributo alla storia del Teatro: il Teatro a Mi-lano nel secolo XVII. Studi e ricerche negli archivi di Stato Lombardi, Milano, 1892 e G.Barblan, Il teatro musicale a Milano nei secoli XVI e XVIII, in Storia di Milano, XII, Mi-lano, 1959, pp. 947-996.
35. ASV, Inquisitori di Stato 914, quaderno intitolato Teatro, c. 31v.36. Lo spoglio delle suppliche, che si trovano nella serie omonima dell’Archivio
Storico del Comune, Antico Regime, è stato completo. Quello delle Azioni è stato,invece, effettuato con l’ausilio dell’Indice alfabetico delle azioni. Repertorio dattiloscritto,in Salone Furietti AR 3 (1-3), reperendo i documenti indicati sotto le voci «Thea-trum», «Theatri», «Theatra», «Theatrorum».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 68
69
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
milanese Pietro Manni, impresario di provata esperienza in area set-tentrionale, risulta debitore nei confronti dell’Ospedale Maggiore «delire ducento sei, soldi dieci otto per assi, usciere e travelli», materialea lui fornito «per servirsene nella constrution del teatro che intendeformare sotto la loggia del palazzo della presente città»37. Sebbene nonsiano state reperite né suppliche attestanti una domanda di edificazio-ne da parte del Manni, né delibere dei Consigli in merito, sappiamoche il debito da lui contratto di «L. 206.18 per il pretio de più legnia-mi al medemo dati per servirsene per la fabrica del teatro» venne sal-dato, come stabilito, il 30 dicembre dello stesso anno38. La permanen-za dell’impresario in città risaliva almeno al 23 settembre, data nellaquale «Pietro Manni quondam Francesco di Milano» venne iscritto co-me debitore verso l’ospedale «per l’affitto di un semestre» di una ca-sa di proprietà della benefica istituzione «posta nella Vicinanza di S.Agata» in Città Alta39. Tra la fine di settembre e l’inizio di dicembrecostruì, quindi, l’edificio40.
La prima opera da lui prodotta nel «Nuovo Teatro di Bergamo» nelCarnevale del 1674 fu l’Argia di Apollonio Apolloni con musica diAntonio Cesti. Probabile protettore dell’impresa il conte Antonio Al-bani, cui venne dedicato il melodramma41. Il Manni puntava ad unsuccesso sicuro. Siamo, infatti, di fronte ad una produzione già da luicollaudata nel Teatro Ducale di Milano durante il Carnevale del 166942.
37. Documento 1673: 1, in Regesto. L’attività professionale dell’impresario mila-nese Pietro Manni è attestata dal 1656 al 1679 nell’aerea settentrionale della peniso-la. Lo troviamo attivo nel Teatro Ducale di Milano, oltre che in alcuni teatri di pro-vincia, tra cui Brescia e Genova. Questa la produzione documentata: Xerse di Nic-colò Minato (Genova, 1656), Eritrea di Giovanni Faustini (Brescia, 1665), L’Anniba-le in Capua di Niccolò Beregani (Milano Teatro Ducale, 1666), L’Erismena di AurelioAureli (Genova, 1666), La regina floridea di Giulio Panceri (Milano Teatro Ducale post1668-ante 1670), Argia di Apollonio Apolloni (Milano Teatro Ducale, 1669), Eritreadi Giovanni Faustini (Milano, 1669), Argia (Bergamo, 1674), Eurimedonte principed’Egitto (Bergamo, 1675), Il Marcello in Siracusa (Bergamo, 1675), Il perfetto Ibraim granvisir di Costantinopoli (Venezia, 1679): C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libret-ti 2034, 2439, 2446, 9120, 9133, 9134, 9407, 14721, 18529, 19701, 25238.
38. Documenti 1673: 4-5, in Regesto.39. Documenti 1673: 1-2, in Regesto.40. Documenti 1673: 4-5, in Regesto.41. Argia (1674) in Cronologia.42. Un’opera di grande successo di cui si segnalano rappresentazioni a Innsbruck
(1655), Roma (1661), Napoli (1667), Viterbo (1668, 1670, 1680), Milano (1669, Tea-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 69
70
FRANCESCA FANTAPPIÈ
La dedica del libretto risale al 10 dicembre del 1673. Anche se si trat-ta dell’unico titolo a noi noto per la stagione in questione, non pos-siamo escludere l’ipotesi che dopo l’Argia fosse prevista una secondaopera. Così accadde il Carnevale successivo, quando ritroviamo l’im-presario milanese a Bergamo, intento a mettere in scena ben due me-lodrammi: L’Eurimedonte principe d’Egitto e Il Marcello in Siracusa. Pro-tettori dell’impresa i conti Girolamo Benaglio e Roberto Martinengo,segno che le due rappresentazioni godettero del favore di una partedella nobiltà bergamasca. Le due produzioni appaiono però estrema-mente diverse. La prima è l’unico allestimento dell’opera attestato inItalia. Nella dedica dell’Eurimedonte il Manni ricorda che l’autore è «unapenna erudita», ma non ne specifica il nome, affermando che si trat-ta di un «drama» scritto molto tempo prima, quando «non molto siaccostumavano varietà di canzonette, ma totalmente si appoggiavanoad un perfetto recitativo» e adattato «all’uso corrente» per l’occasio-ne43. Per quanto riguarda l’autore della musica non viene data alcunaindicazione. Il Marcello in Siracusa è, invece, un’opera di ampia diffu-sione in area centro-settentrionale, scritta da Matteo Noris e compo-sta da Giovanni Antonio Boretti, la cui prima rappresentazione, nelTeatro Grimani di Venezia, risaliva al 167044. Sebbene la condotta ge-nerale di Pietro Manni esprimesse un intento di media o lunga dura-ta, la sua esperienza bergamasca si concluse con il Carnevale del 1675.Per quanto riguarda quest’ultima stagione non sono state reperite pro-ve che attestino una messa in scena dei due melodrammi sotto la log-gia del Palazzo della Ragione. Tuttavia, allo stato attuale delle nostreconoscenze, si tratta dell’ipotesi più probabile45. Difficile, al contra-
tro Regio), Siena (1669, Teatro degli Intronati), Venezia (1669, Teatro Salvadore), Reg-gio Emilia (1671), Udine (1673), Bayreuth (1680): C. Sartori, I libretti italiani a stam-pa, cit., libretti 2434-2448.
43. Euridemonte (1675), in Cronologia.44. Marcello in Siracusa (1675), in Cronologia. La rappresentazione dell’opera è do-
cumentata a Venezia (Teatro Grimani, 1670), Bologna (1672), Napoli (1673), Cremo-na, Genova, Milano (1676), Fano (1680): C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., li-bretti 14717-14724.
45. Oltre ad essere suffragrata dalla rappresentazione dell’Argia nel 1674, vieneconfermata da alcune notizie relative al decennio successivo che ribadiscono un usodello spazio a scopo teatrale. In merito alla demolizione del «teatro ammovibile dilegnami» costruito alla fine del 1685 dall’impresario Antonio Scappi sotto la loggia,i rettori veneti ricordano come tale decisione sarebbe stata necessaria, solo per lamancanza delle «necessarie concessioni», mentre «negl’anni precedenti vi era stato
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 70
71
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
rio, pensare che abbiano avuto luogo in sale private. La presenza del-l’impresario è, infatti, indice della volontà di allestire uno spettacoloa pagamento.
Pur non trattandosi di un edificio stabile, possiamo definire laloggia del Palazzo della Ragione un luogo teatrale, le cui potenzia-lità, immancabilmente riconosciute dagli operatori del settore, ven-nero solo occasionalmente sfruttate46. Anche se l’esperienza del Man-ni mostra un’iniziale apertura da parte dell’oligarchia cittadina, po-chi anni più tardi l’atteggiamento di chiusura nei confronti di colo-ro che fecero richiesta di questo spazio fu netto. Un’opposizione evi-dente fin dal successivo tentativo di un suo utilizzo a noi noto. Lavicenda interessa il cantante e impresario Antonio Scappi, personag-gio protetto da Ferdinando Carlo Gonzaga duca di Mantova, il qua-le a capo di una propria compagnia di virtuosi si rese protagonistadi una pionieristica diffusione del teatro d’opera in varie città dellaPenisola47. La domanda, presentata dallo Scappi in data 18 dicem-bre 1685, venne respinta all’unanimità e immediatamente rimanda-ta al supplicante. Il giorno successivo seguì una delibera che dispo-se l’immediata demolizione «della gran machina de legniami in cuisi presenti voler Antonio Scappi recitar opera o comedia», già par-zialmente eretta, seppure in assenza della necessaria licenza, «nellapubblica loggia inferiore del Palazzo Vecchio Ragione di questa cit-tà»48. Tra le ragioni addotte dal Comune, oltre alla consueta legge atutela dei propri beni immobili e alla necessità di evitare il «grandis-simo pericolo d’incendiar esso palazzo et il pubblico archivio degliistromenti ivi contiguo», ne troviamo esplicitate alcune di tipo mo-rale: il momento non veniva reputato opportuno per un’«operazionecosì scandalosa», laddove «concorrono tutti li motivi contrari a que-ste operazioni per le guerre correnti e per le angustie ben note» alle
fabricato e fatte recite, ma con le dovute concessioni»: Documento 1686: 11, in Re-gesto.
46. Sulla differenza concettuale tra «teatro» e «luogo teatrale» si vedano M. Fab-bri, E. Garbero Zorzi, A.M. Tofani, Il luogo teatrale a Firenze, cit. e L. Zorzi, Il teatro ela città, cit.
47. Antonio Scappi, respinto dal Comune, fu l’impresario di due melodrammimessi in scena nel Teatro Secco Suardo: Il Clearco in Negroponte (1687) e Il Tullo Osti-lio (1688). Riguardo a queste rappresentazioni e alla sua attività di cantante e impre-sario nel corso del Seicento nel centro-nord d’Italia, cfr. Infra, pp. 99-103.
48. Documento 1685: 2, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 71
72
FRANCESCA FANTAPPIÈ
quali sarebbe stato maggiormente appropriato far seguire un atteg-giamento più sobrio e contrito49.
Se ad un cantante al servizio della prestigiosa corte di Mantova nonveniva accordato il permesso di allestire un’opera in musica, non po-teva andare diversamente ad una burattinaia totalmente priva di pro-tezioni. Il 22 dicembre 1700 «Camilla Bissoni detta la Franceschina»chiese di «puoter chiudere parte della Loggia sotto il Palazzo Vecchiodi Raggione» allo scopo di «far ballare li buratini» nel Carnevale im-minente. Contestualmente prometteva di pagare «tutte le spese sì informare la tramezza, come in distruggerla et ad ogni danno potesse aquello inferire»50. Nella delibera posta a votazione venne inoltre pre-vista la stipulazione di una «sicurtà», ossia di un’assicurazione, da par-te della richiedente per gli eventuali danni arrecati e l’obbligo a «sgom-berare la loggia d’ogni impedimento» entro i primi giorni di Quaresi-ma51. La domanda, pur riuscendo ad ottenere la maggioranza dei vo-ti, non raggiunse i due terzi e venne respinta52.
Nel corso della prima metà del Settecento seguirono altre tre sup-pliche, provenienti immancabilmente da impresari locali, costrutto-ri di teatri provvisori, i quali fecero richiesta dello spazio per allesti-re opere in musica a pagamento. Sebbene uno solo dei tre vennesoddisfatto, è possibile notare una progressiva, anche se tenue, aper-tura nelle procedure di valutazione. Il primo nome reperito è quel-lo di un certo Antonio Berzalli il quale, probabilmente analfabeta,non presentò personalmente la domanda, ma usò come intermedia-rio il barbiere Antonio Alessandri53. Nella richiesta, risalente all’ago-sto del 1732, affermava di voler far uso della loggia per «costruerviun picciol teatro per recitarvi nel Carnevale prossimo un’opera adonesto divertimento di quest’Illustrissima Nobiltà»54. Sebbene daideputati venne riconosciuta la possibilità «che tale concessione pos-
49. Ibidem. Con l’accenno ad una difficile situazione politica attraversata dall’Eu-ropa si fa probabilmente riferimento alla minaccia verso i domini asburgici rappre-sentata dai turchi ottomani, i quali nel 1683 arrivarono ad assediare Vienna.
50. Documento 1700: 1, in Regesto.51. Ibidem.52. Documento 1700: 2, in Regesto.53. Antonio Berzalli non è l’unico postulante che faccia firmare la propria do-
manda da un conoscente. Lo stesso si riscontra con Benedetto Agazzi (1742) e coni fratelli Nazario e Antonio Dehe (1761).
54. Documento 1732: 1, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 72
73
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
sa servire a sodisfazione universale», i voti favorevoli non riusciro-no a raggiungere la metà dell’assemblea, tantomeno i due terzi55. Ilsecondo nominativo reperito è quello di Benedetto Agazzi il quale,come il Berzalli, non redasse direttamente la supplica, ma usufruìdell’aiuto di un probabile conoscente56. Il formulario seguito è il me-desimo. La supplica, presentata il 4 settembre del 1742, sollecita laconcessione d’uso di «parte della Loggia sotto del Palazzo VecchioRaggione di quest’Illustrissima Città da construervi un piccol teatroper recitarvi nel Carnovale prossimo un’opera ad onesto divertimen-to di questa Illustrissima Nobiltà»57. La domanda passò e venne pub-blicata come «capta», nonostante ottenesse cinquanta voti su trenta,ossia non raggiungesse per poco i due terzi dei voti58. Siamo moltoprobabilmente all’inizio di un cambiamento di mentalità, anche sesi tratta chiaramente di un’eccezione. Solo tre anni dopo una sup-plica, del tutto simile, presentata l’11 settembre 1745 da Pietro Ra-parini, venne respinta59. Il processo che portò alla sua bocciatura fuperò meno diretto rispetto ai casi precedenti. Prima di arrivare aduna deliberazione si discusse diffusamente se, come nel caso dellerichieste ordinarie, non potesse essere considerata sufficiente la me-tà dei voti favorevoli per accogliere l’istanza o se dovesse valere laregola dei due terzi. Favorevoli al superamento della ristrettezza del-la legge sui beni comunali del 1619 si schierarono i deputati Girola-mo Zanchi, Galeazzo Secco Suardo, Domno Zoppi e Giovan MariaZoppi, i quali chiedevano di ometterne l’osservanza. Contrari furo-no i nobili Guglielmo Alessandri, Girolamo Solza, Giuseppe Casot-ti, Pietro Giacomo Moroni, Pompilio Calepio, Giuseppe Pezzoli eGirolamo Adelasio. Prima della votazione, per ognuna delle parti,venne letta un’arringa dai rispettivi rappresentanti. Giovanni Bena-glio declamò quella dei “progressisti” favorevoli ad un alleggerimen-to della normativa, il dottore Nicola Terzi quella dei “conservatori”.
55. Documento 1732: 2, in Regesto.56. La supplica è presentata da un certo Giovan Battista Testi a nome di Bene-
detto Agazzi. La presentazione di domande di costruzione di un teatro sotto la log-gia del Palazzo della Ragione da parte di Benedetto Agazzi nel 1742 e di FrancescoPuttini nel 1758 è segnalata anche in F. Buonincontri, Il sistema teatrale a Bergamo,cit., p. 68.
57. Documenti 1742: 1-2, in Regesto.58. I due terzi di ottanta votanti sono, infatti, cinquantatrè voti e non cinquanta.59. Documento 1745: 1, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 73
74
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Vinsero questi ultimi. La delibera rimase sottoposta alla legge del1619, la domanda respinta60.
L’unica supplica che sappiamo essere stata sicuramente accettata èquella dell’impresario Francesco Puttini, presentata nell’agosto del1758 per il Carnevale successivo e approvata con un discreto scarto61.Le possibili motivazioni per questa eccezione sono da ricercare nellapersonalità del postulante il quale, sebbene ancora all’inizio di unapromettente carriera (negli anni successivi lo vediamo lavorare concontinuità nei principali teatri di area settentrionale), riuscì ad offriregaranzie sufficientemente valide di una buona produzione62.
In «un picciol teatro sotto la metà verso il Corpo di Guardia del-la Loggia del Palazzo Vecchio», nel gennaio del 1759, venne così rap-presentata l’opera buffa intitolata I due vecchi rivali, altrimenti cono-sciuta sotto il titolo de La facendiera63. Protagonisti i due vecchi Bal-
60. Documento 1745: 2, in Regesto.61. Documenti 1758: 4-5, in Regesto.62. Le precedenti attestazioni dell’impresariato di Francesco Puttini lo vedono
attivo nel Teatro Omodeo di Pavia, dove curò la messa in scena di due melodram-mi del Metastasio: L’Ezio (1756) e L’Antigono (1757). Una carriera che proseguì neglianni Sessanta e Settanta del secolo con numerosi allestimenti di opere, sia serie siacomiche, in alcune delle principali città del Settentrione. Attivo nel Teatro Filarmo-nico di Verona con la Didone abbandonata (1760) e la Merope (1763), nel Teatro degliErranti di Brescia con l’Adriano in Siria (1760) e I matrimoni in maschera (1765), nelteatro di Bressanone con La buona figliuola del Goldoni (1760). Nel 1775 a Novi conL’Antigono, mentre per alcuni anni gestì il Teatro Sant’Agostino di Genova (1776-1780).Nello stesso periodo presente a Milano, dove fu il principale protagonista della pro-grammazione del Teatro Interinale nei tre anni in cui l’edificio, eretto provvisional-mente in attesa della ricostruzione del Teatro Ducale bruciato nel 1776, rimase aper-to. Autore inoltre dell’opera buffa La vera costanza musicata da Pasquale Anfossi, li-bretto di ampia diffusione rappresentato tra il 1776 e il 1792 dalle principali cittàdell’Italia centro-settentrionale, oltre che in Europa: C. Sartori, I libretti italiani a stam-pa, cit., Indici, vol. I, pp. 313, 480; la voce Milano, in Dizionario enciclopedico univer-sale della musica e dei musicisti, cit., Il lessico, vol. III, 1987, pp. 134-143: 139; F. Man-cini, M.T. Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. II, cit., p. 95. Intorno al 1765fu impresario del Teatro San Cassiano di Venezia, ASV, Inquisitori di Stato 914, inser-to Teatro San Cassiano.
63. I personaggi dell’opera buffa I due vecchi rivali, ossia Elisa, Filauro, Flavia, Cec-china/Checchina, Baldone, Don Scialappa, Lelio, sono gli stessi de La facendiera, ope-ra rappresentata al Teatro San Moisè di Venezia e Teatro Obizzi di Padova (1746),Teatro del Cocomero di Firenze (1748), Teatro dell’Arena di Verona (1749), Torino(1751), Vercelli (1752): C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 8596, 9572-9577. Sotto il titolo I vecchi rivali troviamo, invece, una commedia del senese Jaco-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 74
75
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
done e don Scialappa contendenti l’amore della giovane Cecchina.Opera di sicuro successo e facile presa sul pubblico, venne resa ulte-riormente allettante da quanto dichiarato nel libretto in merito alcompositore: il Puttini affermava, infatti, con chiaro intento promo-zionale, che la musica era «del maestro Pergolesi».64 Ciononostante l’at-tribuzione è da considerarsi incerta, in quanto non esiste alcuna atte-stazione di un’opera buffa di Giovan Battista Pergolesi con questo ti-tolo65. Il cast proposto era collaudato. I cantanti chiamati a ricoprirele parti più importanti, oltre ad essere specializzati nell’opera buffa,erano già stati in precedenza interpreti dei personaggi loro assegnati66.Per il fiorentino Carlo Paganini si trattava sicuramente di un cavallodi battaglia. Nelle vesti di don Baldone figura in ben sei delle ottorappresentazioni accertate dell’opera67. Nel repertorio di Pietro Bigio-gero vi era Don Scialappa. Il cantante fu interprete di questo perso-naggio nel 1751 a Torino, edizione in cui troviamo anche, con la par-te di Elisa, la milanese Giuseppa Uzedo Bigiogero, la quale a Berga-mo recitò en travesti come Filauro. Teresa Alberis e Perina Rampazzi,le due cantanti chiamate ad interpretare le giovani innamorate, alla
po Antonio Nelli da cui molto probabilmente deriva l’opera in musica, I vecchi riva-li commedia del signor dottore Jacopo Nelli, in Lucca, 1731, per Salvatore e Giandome-nico Marescand, Con Licenza de’ Superiori. L’intreccio è lo stesso, ossia due vecchiridicoli che si contendono l’amore di una giovane donna. I personaggi sono i se-guenti: Volontario Pieghevoli e Strinato Vecchietti (i due vecchi), Isabella (la giova-ne da loro amata), Clarice (giovane innamorata), Ruggero e Leandro (giovani inna-morati), Serpina, Lauretta, Fracassa, Ciancichino (cameriere e servitori). L’ambienta-zione è Firenze invece di Livorno.
64. I due vecchi rivali (1758), in Cronologia.65. Si vedano le voci Giovan Battista Pergolesi in The new Grove dictionary, cit., vol.
XIX, pp. 389-396 e nel Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, cit.,Le biografie, vol. V, pp 635-641. L’attribuzione delle musiche de I due vecchi rivali al-l’autore di quelle della Serva Padrona appare come un’operazione commerciale crea-ta ad arte dall’impresario Puttini. Nelle precedenti rappresentazioni di questo melo-dramma, seguite sotto il titolo La facendiera, non si fa alcuno accenno al celebre com-positore. Ciò nonostante l’attribuzione della musica de I due vecchi rivali a GiovanBattista Pergolesi non è messa in dubbio da C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit.,Indici, vol. I, p. 429.
66. Per l’elenco completo del cast con le parti assegnate si veda il libretto I duevecchi rivali (1758), in Cronologia.
67. Lo troviamo nelle rappresentazioni de La facendiera di Padova e Venezia(1746), Firenze (1748), Verona (1749), Vercelli (1752), C. Sartori, I libretti italiani astampa, cit., Indici, vol. II, p. 487.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 75
76
FRANCESCA FANTAPPIÈ
prima esperienza attestata nella parte, risultano di media levatura eabitualmente attive nel Centro e nel Nord della Penisola68. Al pari deivirtuosi impegnati, anche il coreografo e il costumista erano artisti nor-malmente attivi in area centro-settentrionale69. Il milanese FrancescoMainino, in particolare, fu per almeno un trentennio il fornitore uf-ficiale di abiti per il Teatro Ducale di Milano, oltre ad intrattenere rap-porti continuativi con il Regio di Torino e con molti altri teatri dellaprovincia piemontese, lombarda, veneta ed emiliana70.
La produzione di Francesco Puttini presenta caratteristiche com-plessivamente simili a quelle di altre opere buffe che, a partire dallostesso periodo, furono allestite con progressiva regolarità – segno evi-dente del crescente desiderio di rappresentazioni teatrali pubblicheespresso da una parte della società bergamasca – nel cosiddetto Tea-tro della Cittadella, edificio provvisorio costruito nei saloni del Palaz-zo del Capitanio. Se l’attività di questo secondo spazio fu più conti-nua e duratura, ciò non significa che la rappresentazione de I due ri-vali sotto la loggia del Palazzo della Ragione sia stato l’unico esem-pio di spettacolo ivi tenuto. Nel 1786 il nobile Giovan Giacomo Ar-rigoni riconosceva come una consuetudine il fatto che i teatri di le-gno in Città Alta fossero costruiti «di soli due ordini» o «nel palazzodell’Eminentissimo Capitanio o sotto il Palazzo Vecchio della città»,ossia il Palazzo della Ragione71. Tra le famiglie di impresari-costrutto-
68. Teresa Alberis attiva almeno tra 1749 e 1765, Perina Rampazzi tra 1756 e 1764,Ivi, pp. 7-8, 546. Del tutto sconosciuti invece Gaetano Monza, la cui unica esibizio-ne precedente accertata è a Pavia nel 1754, e Rosa Banti per cui non si registranoperformance oltre quella bergamasca nel 1759.
69. Il ballerino milanese Giuseppe De Stefani è attivo come coreografo tra glianni Cinquanta e Ottanta a Brescia (1773, 1774), Bologna (1770), Casale Monferra-to (1774, 1783), Lugo (1753), Milano (1762), Pavia (1767), Rovigo (1770) e infine aCadice in Spagna (1764, 1765): C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., Indici, vol.I, p. 505.
70. Nel Teatro Ducale di Milano è attivo con continuità almeno dal 1736 al 1769,nel Teatro Regio di Torino dal 1739 al 1759. Nello stesso periodo risulta presente, inmaniera costante, nei teatri di Alessandria, Bergamo, Bologna, Casal Monferrato,Crema, Lodi, Mantova, Pavia, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Piacenza, Verona, ol-tre che nel Teatro di Salvaterra di Lisbona, Ivi, p. 522.
71. La citazione è tratta da una lettera del 7 novembre 1786 diretta ad ignoto eriportata in F. Buonincontri, Il sistema teatrale a Bergamo, cit., pp. 68, 69-70. Secondola studiosa il documento sarebbe conservato in una filza di carte sciolte segnata ASBg,Dipartimento del Serio 1248. Nonostante una meticolosa disamina è stato, però, im-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 76
77
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
ri attivi negli anni Sessanta del secolo che considerano i due luoghiteatrali come ambivalenti vi furono i fratelli Nazario e Antonio De-he, per alcuni anni attivi nel Teatro della Cittadella, i quali nel gen-naio del 1761 chiesero «la permissione di fabbricare un teatro di le-gno sotto la Loggia del Palazzo Vecchio per farvi l’opera in musica»72.La domanda, per ottenere l’uso di questo spazio nel Carnevale del1762, fu da loro presentata con ben un anno di anticipo. Non seguìil solito formulario, ma venne redatta in maniera molto più circostan-ziata, allegando un nutrito elenco di garanzie a tutela del luogo ri-chiesto. Venne, inoltre, fatto generico riferimento a due precedenticoncessioni, ricordando come la loggia fosse «già stata per due voltebenignamente ad altri accordata»73 nella stagione di Carnevale. Seb-bene la domanda venisse poi respinta, il procedimento seguito per lavotazione riflette un processo di cambiamento in atto. Venne, infat-ti, deciso di fare un’eccezione. Non fu seguita la legge del 1619, per-ché reputata troppo restrittiva e valevole solo per chi facesse doman-da dello spazio per un uso individuale. La rappresentazione di unospettacolo, invece, avrebbe potuto portare utile all’intera comunità:
siccome uno de’ principali ogetti di questa concessione egl’è il commo-do ed onesto divertimento de’ cittadini, onde sembra che cessar debbail rigore prescritto dalla parte 21 dicembre 1619, che solo risguarda le con-cessioni de’ pubblici luoghi ad uso e beneficio di private persone, così lapresente s’intenderà presa senza il suddetto rigore74.
Una precisazione, quella del «commodo ed onesto divertimentode’ cittadini», fino ad allora del tutto inconsueta che rendeva esplici-ta la comparsa di un nuovo punto di vista: la rappresentazione diun’opera non veniva considerata interesse esclusivo dell’impresario odegli artisti coinvolti, ma un momento di pubblico interesse. Le in-tenzioni erano apprezzabili, ma il risultato fu estremamente deluden-te. La supplica venne respinta. Solo venticinque voti favorevoli con-tro cinquantadue contrari!
possibile reperire il documento segnalato. La lettera in questione risulta attualmen-te scomparsa o, come speriamo, semplicemente fuori posto.
72. Documento 1761: 1, in Regesto.73. Ibidem. Una di queste concessioni è probabilmente da identificare con quel-
la del 1759 al Puttini.74. Documento 1761: 2, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 77
78
FRANCESCA FANTAPPIÈ
2. Il teatro e l’oligarchia bergamasca
2.1. Committenza nobiliare e prime opere in musica
Dopo la rappresentazione dell’Ercole effemminato nel Palazzo dellaRagione nel 1654 e prima della costruzione del Teatro Secco Suardonel 1687 le attestazioni di allestimenti di melodrammi a Bergamo so-no varie e ricorrenti, segno di una costante affermazione del teatrod’opera. Sebbene non sia possibile attribuire a ciascuno spettacolo luo-ghi specifici, possono essere tratte alcune conclusioni sulle modalitàdi diffusione del fenomeno, a favore del quale particolarmente evi-dente si configura l’intervento di alcune influenti famiglie della no-biltà cittadina. Le dediche dei libretti, in particolare, si mostrano pre-ziose per individuare alcune linee conduttrici relative ai committen-ti75. Prese nel loro insieme e sul lungo periodo è, infatti, facile notareun’evoluzione: se nel Seicento riportano spesso i nomi di illustrimembri di casate bergamasche, nel Settecento sono i rettori veneti, etalvolta le loro consorti, che vi figurano regolarmente76. Le famigliereperite nei libretti coincidono generalmente con quelle riscontratenei pochi documenti epistolari finora conosciuti. Se una parte dellanobiltà bergamasca garantiva la necessaria protezione nei confrontidegli artisti coinvolti, il modello produttivo fu di tipo commerciale,in quanto molte di queste rappresentazioni videro la presenza di im-
75. Le dediche riportano spesso notizie importanti. Possono essere utilizzate perindividuare il patrocinio dell’evento spettacolare, ma anche per avere qualche indi-zio sui luoghi delle rappresentazioni. Nel caso di Bergamo i libretti della secondametà del Seicento recano indicazioni come «teatro novissimo di Bergamo» (La Do-ri, 1667), «nuovo teatro di Bergamo» (L’Argia, 1674), «nuovo teatro dell’illustrissimosignor conte Giuseppe Secco Suardo» (Il Clearco in Negroponte, 1687). In tutti e tre icasi è possibile intuire che siamo di fronte a edifici teatrali costruiti ex novo, ma so-lo nell’ultimo si fa un chiaro riferimento ad uno permanente. Questa terminologiaè la stessa usata nel Settecento per indicare i teatri provvisionali in legno del pratodella fiera nelle loro progressive riedizioni: «nuovo teatro in fiera di Bergamo» (L’Ata-lanta, 1714), «nuovo teatro di Bergamo» (Il curioso indiscreto, 1778), «nuovo provisio-nal teatro» (L’Osmane, 1785). Con la costruzione di un teatro stabile da parte di Bor-tolo Riccardi la dicitura diventa: «nuovo teatro Riccardi in fiera» (La Didone abban-donata, 1791), «nuovo teatro Riccardi» (La morte di Semiramide, 1792), «nuovo teatroRiccardi» (L’Epponima, 1794). Dopo l’incendio che, nel gennaio del 1797, distrussel’edificio ricompare l’indicazione: «nuovo provvisionale teatro» (L’astuta in amore osia li raggiri scoperti, 1797). Per i riferimenti rimandiamo alla Cronologia.
76. Si veda la voce «Dedicatario» nelle schede della Cronologia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 78
79
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
presari. Per quanto riguarda la provenienza della musica e dei libret-ti l’influenza veneziana si rivela predominante rispetto a qualsiasi al-tra. In questo caso Bergamo non fece eccezione rispetto a tutto il re-sto d’Italia77.
Nel 1654 l’Ercole effeminato è dedicato a Francesco Moroni; Il Giu-seppe del 1656 a Giovan Battista Pelliccioli e Le fortune di Rodope e Da-mira del 1660 a Ludovico Zenni. Difficile capire, nei casi sopraindi-cati, le motivazioni retrostanti. La rappresentazione dell’Egisto nel1659, fortunata opera di Giovanni Faustini, offerta dall’impresario Gio-van Battista Abbatoni al colonnello Bartolomeo Martinengo, permet-te invece maggiori possibilità di riflessione78. Si tratta del primo esem-pio in cui troviamo come dedicatario di un’opera in musica un mem-bro della casata Martinengo79. Circostanza non affatto particolare. Te-stimonianze epistolari accertano l’intervento di Bartolomeo Martinen-go nella messa in scena dell’opera del Giuseppe. Nell’ottobre del 1655è, infatti, il nobile colonnello bergamasco che scrive al mecenate fer-rarese Cornelio Bentivoglio per pregarlo di persuadere lo scrittore Al-merico Passarelli ad aggiungere alcune scene al libretto80. Un altro
77. P. Fabbri, Il secolo cantante. Per una storia del libretto d’opera nel Seicento, Bolo-gna, 1990. La stessa dipendenza dal repertorio veneziano si riscontra anche nella vi-cina Milano, dove l’affermazione del teatro d’opera fu capillare e di grandi propor-zioni. Si veda la voce Milano, in Dizionario enciclopedico universale della musica e deimusicisti, cit., Il lessico, vol. III, 1987, pp. 134-143: 137-138.
78. L’Egisto è una fortunata opera di Giovanni Faustini rappresentata per la pri-ma volta a Venezia nel 1643 con musica di Francesco Cavalli, la cui ultima messain scena nota è del 1667 a Firenze. L’edizione bergamasca si differenzia rispetto adaltri allestimenti per la presenza degli intermezzi ridicoli di Giorgio Jacopo Alcaini.L’impresario fu Giovan Battista Abbatoni, nuovamente presente a Bergamo l’annosuccessivo con Le fortune di Rodope e Damira, opera di grande successo di Aurelio Au-reli, musica di Paolo Andrea Ziani, rappresentata per la prima volta a Venezia (1657).All’Abbatoni si devono le rappresentazioni di Milano (1660) e Torino (1662): C. Sar-tori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 10810, 10811, 10815.
79. Nel 1600 Gaspare Antonio Martinengo, conte di Malpaga e di Cavernago,marchese di Pianezza, è il dedicatario di una rappresentazione allegorica in versi in-titolata Hercole, cioè rappresentatione della virtù et voluttà, a lui offerta dagli «accademi-ci Laboriosi» per la quale si veda la Cronologia.
80. Bartolomeo Martinengo, che considerava il libretto troppo breve, sollecitòla stesura di nuove parti al fine di poterle far musicare: Lettera di Bartolomeo Mar-tinengo a Cornelio Bentivoglio, Bergamo 30 ottobre 1655, in S. Monaldini, L’ortodell’Esperidi, cit., pp. 105-106. La rappresentazione bergamasca del Giuseppe è l’uni-ca accertata del melodramma. Non esistono altre testimonianze nel resto d’Italia: C.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 79
80
FRANCESCA FANTAPPIÈ
membro della famiglia, Francesco Amedeo Martinengo, nel 1655 fi-gura come protettore del virtuoso bergamasco Giovanni Antonio Ca-vagna, segno del patrocinio offerto dalla famiglia ai cantanti prove-nienti dalla propria città81. Ma non solo. Tra gli artisti che sembranogodere della protezione dei Martinengo vi erano anche gli attori chesostavano in città per le loro recite. Nell’agosto del 1664 Giovanni Al-bani (Pantalone), giunto a Bergamo per unirsi alla formazione di Giu-seppe Fiala, chiese la protezione di Gaspare Martinengo nei confron-ti dei propri compagni82. Non stupisce quindi che l’Orontea di Giacin-to Andrea Cicognini, rappresentata a Bergamo nel 1667, fosse dedica-ta proprio a «Gaspare Giacinto Martinengo marchese di Pianezza»83.
Il patrocinio nobiliare, e più in particolare quello della famigliaMartinengo, non è l’unico filone che possiamo trarre dai frontespizidei libretti. È possibile, infatti, rintracciare un’altra costante, caratte-ristica degli ultimi decenni del Seicento, ma che scompare del tuttonel XVIII secolo. Quella delle dediche al castellano. La Dori di Apol-lonio Apolloni musicata da Antonio Cesti, rappresentata nel 1667, èdedicata al castellano Sebastian Giustinian e, in base a quanto dichia-rato nel titolo, rappresentata «nel teatro Novissimo di Bergamo»84. Leindicazioni del libretto rimandano ad attrezzature scenotecniche com-plesse. I personaggi del prologo compaiono nel modo seguente: «Apol-lo in machina. Inganno entro una nube. Invidia sorgendo dall’Infer-
Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretto 12279. In questo caso, quindi, non sia-mo di fronte ad un’opera importata da Venezia, ma ad una produzione “locale”: iltesto è redatto a quattro mani dal ferrarese Almerico Passarelli e dal bergamasco Fran-cesco Michele Carrara; la musica è di Maurizio Cazzati maestro di cappella di San-ta Maria Maggiore.
81. Nel 1655 Francesco Amedeo Martinengo, spesso in contatto con il cuginoCornelio Bentivoglio nello scambio e nella protezione di artisti, figura come patro-cinatore del castrato bergamasco Giovanni Antonio Cavagna. Si veda la lettera diFrancesco Amedeo Martinengo a Cornelio Bentivoglio, Cavernago 21 ottobre 1655,in S. Monaldini, L’orto dell’Esperidi, cit., pp. 102-103.
82. Lettera di Giuseppe Albani a Gasparo Martinengo, Bergamo 20 agosto 1664,Ivi, pp. 201-202.
83. Opera di grande successo di provenienza veneziana, musicata da AntonioCesti. Dopo la prima rappresentazione nel Teatro Grimani di Venezia del 1649 se-guirono numerose repliche sia in Italia sia all’estero fino ad almeno il 1683: C. Sar-tori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 17537-17551.
84. La Dori (1667), in Cronologia. Opera di eccezionale successo e diffusione ne-gli anni Sessanta e Ottanta del secolo: C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., li-bretti 8333-8358.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 80
81
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
no»85. L’uso del palcoscenico era quindi molto articolato, compren-dendo sia lo spazio del sottopalco sia la parte sovrastante la scena.Tutto ciò rende particolarmente auspicabile un chiarimento sulle mo-tivazioni che retrostanno alla dedica. Perché rendere omaggio al ca-stellano? Che ruolo aveva nell’assegnazione dei luoghi destinati allerappresentazioni? Poiché la terminologia è quella abitualmente usataper una costruzione ex novo, si trattava del solito teatro provvisiona-le ad uso di una sola stagione? Se sì, dove sarebbe stato costruito? Im-possibile per adesso dare una risposta a queste domande. La tipolo-gia di dedicatario in questione è, però, presente anche in seguito. Lafortuna tra le disgrazie del 1691 e Il Roderico del 1692 sono offerte allaprotezione del castellano Michele Semenzi86. Non basta. Anche lecompagnie di comici dell’arte consideravano questa carica come unpunto di riferimento. Nel 1672 l’attore Odoardo Palazzi, scrivendo alsuo patrocinatore Ippolito Bentivoglio per ottenere una lettera di rac-comandazione presso il rettore in carica, dichiara: «Dice però il signo-
85. La Dori (1667), in Cronologia.86. Oltre che in questi due melodrammi Michelangelo Semenzi compare, nel
1692, come dedicatario di una raccolta di componimenti poetici encomiastici inti-tolata Riverentissimo tributo d’ossequio al merito impareggiabile dell’illustriss. et eccellentis-si. Sig. Michel Angelo Semenzi composto dal signor dottor Bernardino Manganoni, In Mi-lano, Nella stampa Arcivescovale, 1692, BAM, S. I. G. V. 24 (4). L’opera si apre conun panegirico di Bernardino Manganoni cui seguono diversi sonetti prodotti da al-cuni degli esponenti principali della nobiltà bergamasca, tra cui Girolamo Vimerca-ti Sozzi, Francesco Secco Suardo, Giuseppe Secco Suardo, Camillo Agliardi, FermoGrumello. La fortuna tra le disgrazie è offerta a Michele Semenzi da un certo Tomma-so Mandolino, dedicante anche della Falsirena, altra opera rappresentata lo stessoCarnevale, per cui si rimanda alla Cronologia. Scarse le notizie su quest’ultimo per-sonaggio, in merito al quale non siamo a conoscenza di altri tentativi impresariali.La sua presenza a Bergamo potrebbe essere legata a quella del contralto GiovanniMandolino «del Stato di Milano» e «musico in questa chiesa di Santa Maria Mag-giore» il quale, il 30 marzo del 1678 in una lettera diretta ai Capi del Consiglio deiDieci e scritta da Bergamo, si lamenta di essere stato cacciato dal suo posto in cap-pella dai deputati della Misericordia senza giustificato motivo, ASV, Capi del Consi-glio de’ Dieci, Lettere di Rettori e di altre cariche 7, c. 7rv. L’opera Il Roderico è dedicata aMichele Semenzi da una certa certa «Eleonora Cecarelli». La donna è probabilmen-te da identificare con la cantante Leonora Ceccarelli che nel 1694 recitò a Cremanel Vespasiano e a Milano nell’Arione: C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., Indi-ci, vol. II, p. 172. Il Roderico è un melodramma diffuso tra gli anni Ottanta e Novan-ta del secolo. Diverse le attribuzioni del testo: nel 1684 (Milano e Pavia) a GiovanBattista Bottalino, mentre nel 1687 (Verona) a Pietro Portalupi, Ivi, libretti 20070,20071, 20077.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 81
82
FRANCESCA FANTAPPIÈ
re castellano che sarebbe di mestieri l’avere una lettera per il signoreLorenzo Bragadino capitanio grande qui di Bergamo»87. Stabilire qua-li luoghi fossero sottoposti al suo controllo sarebbe perciò utile ad in-dividuare alcuni degli spazi pubblici cittadini riservati al teatro pro-fessionistico nella seconda metà del Seicento. Sappiamo che i castel-lani erano nobili veneziani posti dalla Dominante a capo di fortifica-zioni sia nelle città sia nei distretti88. Il termine indica perciò un fun-zionario con mansioni di tipo militare sottostante alla carica del ca-pitanio. Tra i complessi architettonici che a Bergamo ricadevano sot-to il suo controllo dovevano sicuramente esservi la Rocca, il Castelloe la Cittadella. Quale di questi quindi?
La frustrazione derivante dalla difficoltà di individuare con certez-za i luoghi destinati alla messa in scena di parte dei melodrammi sei-centeschi, si somma a quella riscontrata nello stabilire quali mezzi sce-notecnici fossero utilizzati per gli allestimenti. Straordinaria e del tut-to sorprendente è perciò una testimonianza iconografica relativa allarappresentazione dell’Annibale in Capua nel 1668 (fig. 3)89. Pur non ri-portando alcuna indicazione in merito al luogo della messa in scena,il libretto si apre con un’incisione che permette di ricavare alcune pre-ziose informazioni relative ai costumi e al tipo di scena su cui veni-vano rappresentate le opere. L’immagine raffigura un palco teatrale,con prospettiva a fuoco unico, al centro del quale troviamo il perso-naggio di Annibale in abiti anticheggianti a dorso di un elefante, at-torniato da due soldati. Nonostante lo scopo di questo tipo di imma-gini non fosse quello di riprodurre con fedeltà la scenografia, sappia-mo che da questa si traeva spesso ispirazione. La scena raffigurata èprospettica e gli edifici sono disposti su più quinte. Se associamo que-
87. Lettera di Odoardo Palazzi a Ippolito Bentivoglio, Bergamo 12 giugno 1672,in S. Monaldini, L’orto dell’Esperidi, cit., p. 274.
88. L. Pezzolo, Podestà e capitani nella Terraferma veneta (secoli XV-XVIII) in Vene-zia e le Istituzioni della Terraferma, cit., p. 58.
89. Probabile impresario dell’edizione bergamasca fu Domenico Angelo di To-bia Manganoni, il quale nel libretto se ne dichiara anche autore. In realtà l’Anniba-le in Capua è di Niccolò Beregani, con musica di Pietro Andrea Ziani. Il nominati-vo di Domenico Manganoni è riscontrabile, nel ruolo sia di impresario sia di auto-re, nella messa in scena di alcune opere in musica a Milano negli anni Ottanta delSeicento. Nel 1667, infine, troviamo un Tobia Manganoni come impresario della Do-ri rappresentata a Bergamo: C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 2030-2041, 8344 e Ivi, Indici, vol. I, pp. 283, 478.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 82
83
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
sti dati a quelli dei cambi di scena registrati dal libretto, in cui vengo-no descritti «archi trionfali», «padiglioni e ordinanza d’elefanti», «grot-te magiche», «logge e fontane», possiamo immaginare che queste am-bientazioni seguissero la stessa distribuzione spaziale. Rimane però unadomanda: con quali mezzi veniva realizzato tutto questo?
Nel corso dello stesso Carnevale venne rappresentata una secondaopera: La prosperità di Elio Seiano di Niccolò Minato, musica di Anto-nio Sartorio90. Anche in questo caso il libretto riporta un’immagine (fig.4). Si tratta di una figura in cui sono presenti dettagli che possono ap-parire meno utili per un’analisi scenotecnica, ma che risultano estrema-mente interessanti per altri motivi. Vediamo, infatti, rappresentato unmomento specifico dell’azione drammaturgica. In essa sono presentidue personaggi, entrambi in movimento: uno si muove verso sinistra,correndo a sorreggere una balconata che sta cadendo, l’altro fugge ver-so destra per evitare il pericolo. La didascalia dell’atto III, scena X dellibretto recita: «Cade un volto di loggia, sotto la quale si trova Tiberio.Seiano si sottopone e lo sostenta fin che Tiberio esce salvo»91. Si trattaquindi di una precisa scena del melodramma, immortalata nel suo svol-gersi, un momento fondamentale dell’opera della quale viene offertaun’efficace sintesi al potenziale lettore-spettatore.
Le notizie ricavabili dalle due immagini non sono però finite. Unloro confronto può essere ulteriormente proficuo al fine d’individua-re i luoghi preposti agli allestimenti. Nella parte superiore di ciascu-na di esse troviamo, sorretti da due putti, gli stemmi dei dedicatari:quello del podestà Lorenzo Loredan nell’Annibale in Capua e quellodel capitanio Pietro Dolfin nella Prosperità di Elio Seiano. Quest’ulti-mo era anche il protettore della nobile accademia degli Aironi per lacui attività concedeva l’uso delle sale del Palazzo Prefettizio92. Se lasua opera di promozione culturale, negli anni in cui restò in carica,
90. Come l’Annibale in Capua anche La prosperità di Elio Seiano fu un’opera diampia diffusione. Testo di Niccolò Minato posta in musica da Antonio Sartorio ven-ne rappresentata per la prima volta a Venezia nel Teatro San Salvatore nel 1667. Se-guirono Bergamo e Genova nel 1668, anno dopo il quale la ritroviamo in tutti iprincipali centri d’Italia fino ad almeno il 1707: C. Sartori, I libretti italiani a stampa,cit., libretti 19236-19248.
91. Libretto de La prosperità di Elio Seiano (1668), in Cronologia.92. D. Calvi, Effemeride sagro-profana, cit., vol. III, 1677, pp. 343, 370; L. Volpi,
Tre secoli di cultura bergamasca, cit., pp. 28-29; J. Schiavini Trezzi, Ateneo di Scienze, Let-tere ed Arti di Bergamo, cit., pp. XV, XXVII, XXVIII.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 83
84
FRANCESCA FANTAPPIÈ
non si fosse limitata solo a questo? Le due opere avrebbero potuto te-nersi negli spazi offerti dalla Cittadella. In mancanza degli opportu-ni riscontri documentari rimane purtroppo impossibile affermarlocon certezza. L’episodio conferma però il fatto che, sebbene i rettoriveneti svolgessero molto spesso una funzione promotrice delle attivi-tà spettacolari, l’offerta teatrale che ne derivava, quando non accoltae perpetuata dalla cittadinanza, rimaneva troppo fragile, legata a sin-gole occasioni e alla discrezionalità del potere.
Ma passiamo gli altri dedicatari. Per l’Argia del 1674 e per l’Euri-medonte principe d’Egitto e Il Marcello in Siracusa, entrambe del 1675, tro-viamo, come già visto, la nobiltà cittadina. Nel primo caso il conteAntonio Albani, nel secondo il conte Girolamo Benaglio, nel terzo ilconte Roberto figlio di Bartolomeo Martinengo. Autore delle dedicheè l’impresario milanese Pietro Manni, negli stessi anni costruttore diteatri provvisori sotto la loggia del Palazzo della Ragione93. Le inten-zioni del dedicante erano molto probabilmente quelle di ottenere laprotezione di alcune importanti famiglie cittadine per garantire il pro-getto da lui iniziato. Difficile stabilire, però, il loro livello di coinvol-gimento nell’operazione. Per le rappresentazioni del Carnevale del1678 è, invece, possibile almeno un’ipotesi. Siamo di fronte a due me-lodrammi molto differenti: l’Elena rapita da Paride, dedicata al nobileVittorio Maria Fugazza, opera di grande diffusione e sicuro successocommerciale, e La Semiramide regina d’Assiria dedicata ai «conti Trus-sardo di Calepio et Grandilia Martinenga iugali», di cui la rappresen-tazione bergamasca è l’unica messa in scena accertata. La presenza diuna coppia di sposi nella dedica del secondo libretto porta ad ipotiz-zare uno spettacolo d’occasione per un matrimonio che avrebbe le-gato le famiglie Calepio e Martinengo94.
93. Cfr. Supra, pp. 68-71.94. Autore dell’Elena rapita da Paride è Aurelio Aureli, musica di Giovan Dome-
nico Freschi, prima rappresentazione a Venezia (Teatro Sant’Angelo, 1677). La mes-sa in scena di un’opera intitolata Semiramide regina d’Assiria è invece attestata solo aBergamo nel 1678. L’opera circolava nel Seicento anche sotto il titolo Semiramide, dicui troviamo messe in scena a Venezia (1671) Vienna (1673), Ferrara (1674), Bologna(1677), Lucca (1682). Sia nel caso dell’Elena rapita da Paride sia in quello della Semi-ramide regina d’Assiria dedicante delle produzioni è un certo Antonio Morone, in me-rito al quale non esiste alcuna notizia di altre esperienze impresariali oltre a quellebergamasche: C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 8715, 21478-21482,21531; Ivi, Indici, vol. I, p. 479.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 84
85
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
La maggior parte delle opere rappresentate tra il 1687 e il 1695 so-no collocabili nel Teatro Secco Suardo. Ciò nonostante non si trattadell’unico luogo possibile per gli allestimenti. Tra i melodrammi cuinon è stato possibile assegnare con sicurezza uno spazio vi sono l’ope-retta morale di Francesco Roncalli Il merito fortunato musicata dal ber-gamasco Francesco Ballarotti, rappresentata nell’agosto del 1691, e IlDionisio di Matteo Noris con musica di Petronio Franceschini e Gio-vanni Domenico Partenio per il Carnevale del 1694. Due episodi to-talmente differenti. Nel secondo caso l’opera è portata a Bergamo dal-l’impresario Carlo Bertini a scopo commerciale95. Nel primo, a giudi-care dall’autore, un nobile bergamasco, e in base alle intenzioni espres-se nella dedica (avere per soggetto «la Moralità» e non «le Istorie fa-voleggiate», presentando come personaggi figure allegoriche quali Me-rito, Fortuna, Inganno, Ignominia, Virtù e Giustizia, Vulcano), si trat-ta di una produzione minore: nonostante la presenza di alcuni can-tanti normalmente attivi nei teatri a pagamento, come Clarice BenniVenturini e Giuseppe Scaccia, essa appare destinata ad un pubblicoscelto. Il periodo della messa in scena, ossia l’estate, porterebbe a col-locarla in uno degli spazi teatrali della fiera in Città Bassa, ma il te-ma allegorico e l’accenno al luogo dello spettacolo come all’«angustascena di questa città», fanno invece pensare ad una piccola sala, situa-ta in Città Alta96.
2.2. Il Teatro Secco Suardo (1686-1695)
2.2.1. Nascita ed ubicazione
All’origine del Teatro Secco Suardo vi fu una scrittura notarile: l’at-to con cui il 6 maggio 1686 il conte Ludovico Secco Suardo affran-cava dalla patria potestà i figli Giuseppe e Marco, ormai in età legit-tima, rendendoli liberi di «contrahere, distrahere, alienar, e vendere et
95. Carlo Bertini è impresario dell’Alcibiade e dell’Oreste in Argo nel Teatro Du-cale di Modena (1685): C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 627, 17376.
96. La dedica del conte Francesco Roncalli al capitanio Agostino Nani recitaquanto segue: «Se la fama non fosse impegnata a pubblicare le di lui degne azionial Mondo tutto, sarei in gran pena rappresentandole nella angusta Scena di questaCittà. Tutti li compositori d’oggidì hanno ne’ loro Teatri per Soggetto le Istorie fa-voleggiate ed io la Moralità». Si veda il libretto de Il merito fortunato (1691), in Cro-nologia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 85
86
FRANCESCA FANTAPPIÈ
comperar», come «padri di famiglia e cittadini romani»97, tutto ciò chesarebbe stato affidato alla loro tutela. L’emancipazione consentì di as-segnare ai due giovani rampolli alcuni beni immobili e proprietà fon-diarie. Nel pacchetto anche il palazzo di via Corsarola, odierna viaColleoni, descritto come «una casa posta in questa città a Sant’Aga-ta, cioè l’appartamento di sopra principiando sopra la fontana sino aSant’Agata con il portone et canepa», all’ultimo piano del quale, pri-ma della fine dello stesso anno, venne costruito l’edificio teatrale (figg.1, 5-6)98.
Tra le famiglie della nobiltà bergamasca che potevano vantare ori-gini più antiche, i Secco Suardo nel Seicento esprimevano la propriainfluenza politica attraverso tre rami distinti: San Salvatore, Leoninie Sant’Agata99. Inevitabile una competizione tra di essi, all’interno del-la quale l’edificazione di un teatro non poteva che spostare l’ago del-la bilancia verso gli ideatori del progetto. Motivi di prestigio furono,quindi, quelli che portarono alla maturazione dell’idea, il cui promo-tore principale fu il non ancora ventottenne Giuseppe, fratello mag-giore di Marco e Carlo100. Come periodo di attuazione: la seconda
97. ASBg, Notarile. Protocolli, 5797, notaio Carlo Ippolito fu Gio. Antonio Bot-tani, filza n. 3, all’atto.
98. Ibidem. La fontana, di proprietà comunale, è tuttora presente, all’incrocio travia Colleoni e il vicolo di Sant’Agata. Il teatro non venne, quindi, costruito dietroil Palazzo del Podestà, sull’area attualmente occupata dal Teatro Sociale, come ipo-tizzato da L. Pilon, Il teatro della Società, cit., p. 6.
99. Tra le più antiche opere genealogiche sui Secco Suardo si segnalano quelladi P. Corbella Bonoreno, De genealogia Illustrissimae Soardorum Familiae, Brevis Epito-me. Ex multis Auctoribus, et Monumentis fide dignis exacte collecta, Bergamo, Comino Ven-tura, 1612 e la settecentesca opera manoscritta di Mario Lupo, Geneaologia della fa-miglia Suardo, BCBg, MMB 520. Il più completo albero della famiglia è reperibilein G. Medolago, Il Castello di Cenate di Sotto e la famiglia Lupi, Cenate di Sotto, 2003.Per quanto riguarda la storia della potente casata tra Cinque e Settecento è possibi-le notare come gli studi abbiano privilegiato il ramo di San Salvatore, per il quale sirimanda al numero della «Rivista di Bergamo», n.s. 17, aprile-giugno 1999, intera-mente dedicato alla quadreria della famiglia, infine ai saggi su Paolina Secco Suar-do di F. Tadini, Lesbia Cidonia: società, moda e cultura nella vita della contessa PaolinaSecco Suardo Grismondi 1746-1801, Bergamo, 1995 e L. Tironi, Paolina Secco SuardoGrismondi: Lesbia Cidonia, la vita e le opere, Trescore Balneario, 2001. Sui palazzi an-ticamente appartenenti alla famiglia si veda G. Secco Suardo, Il Palazzo della Ragio-ne di Bergamo ed edifici ad esso adiacenti, Bergamo, 1901.
100. Giuseppe, figlio di Ludovico Secco Suardo e della contessa Maria Quari-smini, nacque il 23 dicembre 1658 nella vicinia di Sant’Agata. I fratelli Marco e Car-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 86
87
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
metà del 1686. Il 20 novembre di quell’anno, infatti, i due rettori incarica presero ufficialmente atto dell’esistenza dell’edificio teatrale.Chiamati a dare il loro avallo ufficiale e a constatare la sicurezza delsito, il podestà Pietro Pisani e il capitanio Giulio Donado si recaronoal «teatro novo per recitar opere et comedie» che il conte GiuseppeSecco Suardo aveva «fatto construere nella Contrata di Santa Agata»101.L’esito della visita fu positivo ed il rapporto favorevole. Eseguita un’at-tenta ispezione e «coll’assistenza de’ periti fatta in ogni parte de’ pal-chi, scena et altri luoghi, diligente ed accurata osservazione» ritenne-ro il «tutto stabilito con buon ordine et sicurezza, lontano d’ogni pe-ricolo di male»102. Una relazione che, nel corso degli anni successivi,sarebbe stata contestata con ostinata determinazione dai vicini di ca-sa del conte: confinante con il palazzo Secco Suardo di via Corsaro-la si trovava lo stabile del Monte di Pietà.
Se, stando ai rettori, la sala del teatro, con l’opportuna dotazionedi palchetti e la scenografia, era stata conclusa prima della fine di no-vembre, il primo reclamo presentato dai governatori del Monte di Pie-tà al Comune di Bergamo, in data 14 dicembre, insisteva sul fatto chei lavori fossero ancora in corso. Essi affermavano, infatti, di non averpotuto trovare un sostituto nella carica di tesoriero poiché, «andan-dosi costruendo un theatro in vicinanza della casa d’esso Monte», ipossibili candidati avevano opposto un netto rifiuto, preoccupati dal-
lo il 28 novembre 1662 e il 15 novembre 1665. Queste le registrazioni dei battesi-mi per ciascuno di essi: «Adì 30 dicembre 1658. Gioseffo figlio dell’illustrissimo si-gnor conte Lodovico Secco Suardo e dell’illustrissima signora contessa Maria sua le-gitima moglie nacque adì 23 detto e fu batezato adì 30 sudetto da me padre Giro-lamo Carminati curato di Sant’Agata al quale è stato posto nome come sopra essen-do stato padrino il molto illustre et eccellentissimo signor Pietro Salvagno della cu-ra di Santo Cassiano»; «Adì 5 dicembre 1662. Marco Gasparo figlio dell’illustrissi-mo signor conte Lodovico Secco Suardo et dell’illustrissima contessa Maria sua le-gitima moglie nacque adì 28 novembre et fu batezato adì 5 dicembre al quale è sta-to posto nome come sopra essendo stato padrino l’illustrissimo signor Mario Pon-cino della cura di Santo Cassiano»; «Adì 19 febraro 1666. Carlo figlio dell’illustris-simi signori conti Lodovico Secco Suardo et Maria sua legitima moglie nacque adì15 novembre 1665 e fu batezato adì 19 febraro 1666 da me padre Girolamo Carmi-nati curato di S. Agata al quale è stato posto nome come sopra essendo stata padri-na l’eccellentissima signora Chiara Capella capitania grande», AVBg, Sant’Agata. Na-ti e battezzati dal 1643 al 1679, cc. 67, 144, 224 e Nati e battezzati dal 1643 al 1660, let-tera G.
101. Documento 1686: 4, in Regesto.102. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 87
88
FRANCESCA FANTAPPIÈ
le impreviste responsabilità derivanti dalla novità occorsa.103. Concet-to ribadito, seppure con alcune incongruenze, nelle numerose rimo-stranze successive. In una memoria relativa all’accaduto si legge che«solo verso la fine di ottobre 1686 fu datto principio a costruersi in-ternamente in dette case il teatro di legnami nel modo che puoi è sta-to perfettionato», mentre in una diversa versione dello stesso docu-mento si afferma «che fu dato principio a condur li legnami sive tra-velli e assami bisognevoli per formare detto teatro solamente in no-vembre prossimo passato, né è stato compito se non in fine di dicem-bre susseguente»104.
Le discordanti versioni del Monte di Pietà relative ai tempi di co-struzione dell’edificio teatrale sono probabilmente dovute alla neces-sità di dimostrare che i propri reclami erano stati presentati prima del-l’ultimazione dello stesso. Siamo di fronte, perciò, a documenti par-zialmente capziosi. Nonostante ciò la versione più ricorrente, checoincide anche con quella data dalla perizia dei rettori, è «che li si-gnori conti Suardi habbino fabbricato tale teatro nelle loro case nel-li tempi di settembre, ottobre e novembre, destinati in questi paesi al-la permanenza dei cittadini nelle ville», approfittando così del mo-mento più propizio per far passare l’operazione inosservata105. L’uni-co dato sicuro che abbiamo per determinare l’atto di nascita del tea-tro si riferisce allo spettacolo inaugurale, avvenuto nel corso del Car-nevale del 1687 con l’opera in musica Il Clearco in Negroponte. La de-dica del libretto, nella quale l’impresario Antonio Scappi fa omaggiodella rappresentazione al conte Giuseppe Secco Suardo e al podestàPietro Pisani, è datata 24 dicembre106. Quindi, entro la fine del 1686il teatro era concluso.
In una delle descrizioni più circostanziate, redatta dai rettori Pisa-ni e Donado per il Senato veneto, troviamo la versione probabilmen-te più attendibile dell’accaduto, ossia che il teatro, «sussistente e sta-bile» costruito nelle case dei Secco Suardo, fu iniziato
a’ primi di settembre, per quello fu oculatamente da noi stessi notato, es-sendo nel sito più osservabile della città, et per quanto risulta anco da fe-
103. Documento 1686: 5, in Regesto.104. Documento 1687: 2, in Regesto.105. Documento 1687: 3, in Regesto.106. Il Clearco in Negroponte (1687), in Cronologia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 88
89
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
di, fu dato principio a distruggere le stanze di dette case e susseguente-mente a fabricarsi il teatro, che fu poi al fin di decembre susseguente ter-minato107.
La distruzione di alcuni ambienti interni al palazzo sarebbe iniziataa settembre e, una volta creato lo spazio necessario, sarebbe seguitala costruzione dell’edificio teatrale, ultimata nel mese di dicembre. Larelazione continua annotando la stima presunta dei costi sostenuti perultimare il progetto. Per quanto riguarda «alla spesa che possa esseroccorsa nella fabrica di detto teatro questa non si può dire accertata-mente», ma sulla base delle «note» e delle «fedi» esibite dai conti Sec-co Suardo «risultarebbe in lire quattordicimila settecento in circa, ol-tre il discapito per la destruttione d’una casa che s’affittava scudi set-tanta annui, alla reconstruttione della quale vi andarebbe spesa di al-trettanto et in maggior summa per quello consta la fede»108. Alcunestime seguenti risultano, invece, più ridotte. Secondo i rettori MarcoMichiel e Alvise Dolfin, succeduti ai precedenti nel maggio del 1687,la spesa complessiva ammonterebbe a 5.680 lire, mentre per i contiSecco Suardo a 10.174 lire:
Verso la fine d’ottobre prossimamente decorso fu dato principio a con-struere il teatro et nel fine di decembre susseguente perfecionato comeda fede fatta in Milano apparisse con spesa, compresi li materiali fattu-re d’operarii et ogn’altra cosa per stabilirlo, di lire cinquemillaseicentoottanta in circa, così dimostrando una fede di perito intorno ciò pro-dotta, benché detti nobili conti Soardi viene apportato ascendere la spe-sa a lire diecimille cento e settantaquattro in circa, havendo sopra ciòpresentato diverse fedi private e note et con queste una che contienedetta suma lire due mille trentecento e tre, estratta da un libro loro par-ticolare109.
Impossibile stabilire l’affidabilità delle stime presentate. Notiziesicure in merito ai tempi e ai costi di costruzione del teatro potreb-bero derivare solo dal ritrovamento dei libri contabili relativi ai la-
107. Documento 1686: 11, in Regesto.108. Ibidem. La casa era affittata al signor Carlo Ippolito Bottani, ASBg, Notari-
le. Protocolli, 5797, notaio Carlo Ippolito fu Gio. Antonio Bottani, filza n. 3, all’atto.109. Documento 1687: 17, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 89
90
FRANCESCA FANTAPPIÈ
vori110. Una documentazione che permetterebbe di ricavare non so-lo gli estremi cronologici e i dati economici, ma anche notizie sul-l’architettura del teatro e sugli artefici, quali costruttori, ingegneri,scenografi, pittori. Allo stato attuale delle ricerche, purtroppo, la par-te più consistente delle notizie relative alla storia dell’edificio deri-va dalla causa occorsa tra Monte di Pietà e famiglia Secco Suardo,tanto meticolosa nel riportare gli aspetti giuridici della questione,quanto vaga in merito a tutte le altre tematiche111.
Ciò nonostante, nella memoria che riassume i termini della ver-tenza sono reperibili alcune indicazioni sui lavori di costruzione delteatro. Queste confermano le notizie già esposte, tra le quali la neces-sità di abbattere alcune pareti interne al palazzo, situate al piano piùelevato, per ottenere lo spazio sufficiente alla realizzazione dell’edifi-cio. Le mura portanti e il tetto non vennero invece toccate:
per costruere detto teatro in detto luogo superiore sono stati levati sola-mente alcuni tavolati che separavano l’andito, ivi esistente, da alcune stan-ze laterali di detto andito, senza essere stata fatta novità dalle muragliemagistrali di detta casa, essendo rimaste non solo le dette muraglie maanco tutti li tecchiami di detta casa nel suo primiero stato ed essere112.
L’edificio non era visibile dall’esterno, ma «tal costruttione di tea-tro si vede fatta et essere intrinsecamente in detto luogo nel corpo didetta casa et esteriormente non appare esservi il detto teatro, né al difuori si scoprono inditii d’alcuna innovatione di fabrica»113. Una no-
110. Dallo spoglio del materiale contabile conservato nell’archivio familiare a Lu-rano non sono emerse scoperte clamorose, nonostante il prezioso aiuto del conteLanfranco Secco Suardo. Una delle principali difficoltà dello spoglio è stata distin-guere a quale dei tre differenti rami della famiglia, esistenti nel Seicento, appartenes-sero i libri di conto reperiti. La documentazione prodotta dai Secco Suardo di San-t’Agata, primi ad estinguersi nella seconda metà del Settecento, è stata infatti succes-sivamente accorpata a quella del ramo Leonini, cessato nel corso dell’Ottocento. En-trambi i fondi sono stati poi riversati in quello di San Salvatore, tuttora esistente.
111. La causa era già conosciuta grazie a M. Mencaroni Zoppetti, Sul teatro So-ciale, cit., pp. 479-487: 482-483, cui si deve il merito di aver per prima menzionato,e in parte riportato, il documento in questione.
112. Documento 1687: 2, in Regesto.113. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 90
91
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
tizia che non contrasta con la situazione odierna. Attualmente è, in-fatti, impossibile rintracciare sull’antico palazzo Secco Suardo di viaCorsarola evidenze architettoniche esterne che permettano di attribui-re un’ubicazione del teatro all’interno del caseggiato. Circostanza nonaffatto singolare nel Seicento: l’affermazione di una progressiva atten-zione alla facciata degli edifici teatrali è una conquista del secolo suc-cessivo114.
Per collocare il teatro all’interno del palazzo è stato perciò neces-sario ricostruire i confini che separavano la proprietà Secco Suardo da-gli immobili del Monte di Pietà. Una domanda risolvibile incrocian-do i dati catastali con le notizie contenute nella vertenza intercorsatra le due parti. Nel Seicento l’area era molto diversa dalla situazioneattuale. Rilevanti demolizioni, avvenute nel corso dell’Ottocento, han-no determinato la formazione dell’attuale giardinetto posto tra il n.°11 e il n.° 13 di via Colleoni. Il Monte di Pietà occupava anticamen-te proprio questa zona, attualmente vuota, oltre agli stabili tuttora ri-masti sul lato orientale di essa, ossia le particelle catastali numeratecon il 414, 415, 416, 417 e 423 della mappa del 1853 (fig. 5)115. Il ca-
114. Una caratteristica di molti teatri italiani del Seicento fu l’assenza di una fac-ciata. Rimanevano perciò anonimi nel contesto urbano in cui si trovavano e prividi elementi architettonici esterni che li rendessero riconoscibili. Fu solo a partire dalsecondo Settecento, quando la discussione sulla funzione pubblica del teatro diven-tò argomento di riflessione illuminata, che iniziò ad essere sentita l’esigenza di da-re agli edifici teatrali una visibilità. Poterono così avere luogo magnifici esempi ar-chitettonici quali il Teatro della Scala di Milano dell’architetto Giuseppe Piermarinio quella della Fenice di Venezia di Giannantonio Selva, sui quali rimandiamo a G.Ricci, Teatri d’Italia dalla Magna Grecia all’Ottocento, presentaz. di C. Perogalli, Mila-no, 1971, pp. 203-212 e O. Guaita, I teatri storici d’Italia, introduz. di S. Mazzoni,Milano, 1994, pp. 78-79, 81-82.
115. La demolizione avvenne prima del 1876, com’è possibile notare dal con-fronto delle due mappe catastali ottocentesche della città di Bergamo (figg. 5-6). NelXIX secolo buona parte degli immobili che in epoca di antico regime erano appar-tenuti al Monte di Pietà risultano passati alla famiglia Secco Suardo. Nel 1839, in-fatti, non solo la particella 413, che copriva l’area dell’originario palazzo, è descrit-ta come «casa civile con bottega che s’estende sulla fontana pubblica e sulla botte-ga n.° 414» al numero civico 69 appartenente a Bartolomeo e Girolamo Secco Suar-do, in buon stato di conservazione, ma anche le altre particelle 414-417, 423 ai nu-meri civici 68 e 67, in stato di conservazione «mediocre», risultano appartenenti aiconti, ASBg, Castato Lombardo Veneto, Tavola per la stima dei fabbricati 1839. I caseg-giati del Monte di Pietà vennero acquisiti dalla famiglia Secco Suardo, e più preci-samente da Rocco Cedrelli come tutore dei «conti pupilli Secco Suardi quondam si-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 91
92
FRANCESCA FANTAPPIÈ
seggiato del Monte di Pietà, demolito nel corso della seconda metàdell’Ottocento, all’inizio dello stesso secolo viene così descritto:
Un locale detto il Monte de’ Pegni raggione del Pio Luogo della Pietà si-tuato in Corserola al civico n.° 68 consistente in tre piani, cioè pian ter-reno e due superiori, con cortile, pozzo e cantine, al quale confina a mat-tina la restante porzione del locale della Pietà, a mezzo di contrada diCorserola, a sera conti pupilli Suardi ed a monte vicolo di Sant’Agata116.
Era questo l’immobile contiguo al palazzo dei conti Secco Suar-do, del quale adesso rimangono solo alcune porzioni.
Secondo l’istanza presentata dal Monte di Pietà al Senato venetol’edificio teatrale era posto all’ultimo piano del palazzo nobiliare eadiacente al muro divisorio esistente tra le due proprietà, più precisa-mente costruito dai Secco Suardo «in una loro casa, divisa da una de-bole muraglia da una parte che separa le stanze di esso Pio Monte concomunicatione di legnami e tecchiami»117. In base alla dichiarazione
gnor conte cavaliere Girolamo di questa città» con due contratti, rispettivamente del17 e 30 marzo 1818, dopo che l’interno lotto era stato messo all’asta dalla Congre-gazione della Carità, amministratrice del dismesso Monte di Pietà, il 15 febbraio diquell’anno. Vennero pagati «lire novemila quattrocentodieci pel caseggiato n.° 67 elire 7300 settemilatrecento per quello descritto sotto il n.° 68», ASBg, Notarile mo-derno. Protocolli 12962, notaio Antonio Zenucchi, atto 462. Nel Catasto napoleoni-co sono registrati sotto le particelle 2885 (poi 413), 2887 (poi 414), 2888 (poi 415),2889 (poi 416), 2890 (poi 417), 2891 (poi 423), ASBg, Catasto napoleonico. Somma-rione della Mappa 1811. Bergamo. Questa la descrizione delle particelle catastali di viaBartolomeo Colleoni nel 1876: «413. Casa Civile con due botteghe che si estendesopra la fontana pubblica (comprende il n.° 414); 414. Bottega (soppresso e unitoal n.° 413); 415 a. Luogo terreno con stalla (nuova costruzione); 415 b. Area di ca-sa demolita (soppresso ed unito al n.°416); 416. Area di casa demolita (comprendeparte del n.°415 b. e 423 a); 417. Casa con bottega (aumentato di superficie per laporzione dell’accesso al n.°415 c). […] 423 a. Area di casa demolita (soppresso edunito al n.°416). 423 b. Casa (aumentato di superficie per la porzione dell’accessoal n.°415 c)». Se per le particelle 413 e 414 si parla di un «buono» stato di conserva-zione dei fabbricati, quello delle restanti è definito «mediocre». A quest’altezza cro-nologica i numeri 413, 414, 415, 416 e 423a erano posseduti dal conte AlessandroSecco Suardo, il 423b da Carlo Ragazzoni e il 417 da Giacomo Martinoni, ASBg,Catasto Lombardo Veneto, Sommarione di Bergamo Città 1876.
116. Dal verbale d’asta del 17 marzo 1817 con cui i conti Secco Suardo acqui-sirono la proprietà del Monte di Pietà a loro confinante, ASBg, Notarile moderno. Pro-tocolli 12962, notaio Antonio Zenucchi, atto 462.
117. Documento 1687: 10, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 92
93
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
dei rettori Pisani e Donado, invece, il muro divisorio posto tra le dueunità immobiliari sarebbe stato più resistente rispetto a quanto dichia-rato dalla pia istituzione e non avrebbe comportato pericoli di sorta«per le due muraglie grosse di pietra viva che chiudono esso teatro dalluogo del Monte, essistendo fra mezzo esse muraglia uno spazzo divarii brazza e per la distanza di circa quaranta brazza che è tra il tea-tro stesso e le stanze ove sono riposti li pegni»118. Siamo come sem-pre di fronte a due versioni contrastanti. L’unico dato concordante ri-guarda la dislocazione dell’edificio teatrale collocato «nel suolo supe-riore» del palazzo119. L’altro punto di convergenza è il fatto che l’uni-co elemento di comunicazione tra le due proprietà fosse costituito daltetto in comune:
li tecchiami di detta casa sotto li quali è fatto detto teatro, s’unisconocon quelli della casa del Monte de’ Pegni senza divisione né separazionealcuna. Che tanto li tecchiami d’una quanto dell’altra casa delle suddet-te case sono sostenuti da travamenti et materiali di legno, senza esservivolto o celtro d’ogni sorte. Che nella parte superiore della casa del Mon-te vi è una muraglia commune et divisoria con le case nelle quali è con-strutto il detto teatro120.
Sebbene i dati reperiti non permettano di capire se il teatro si tro-vasse nella parte anteriore o posteriore del palazzo, è possibile peròavanzare almeno un’ipotesi. Considerando che la linea di confine trale case dei Secco Suardo e quelle del Monte di Pietà era spezzata daun piccolo cortiletto, tuttora visibile, che determinava una suddivi-sione della residenza nobiliare in due aree, il teatro doveva trovarsi al-l’interno di una di queste. Ma quale? La più credibile, essendo la piùgrande, appare la zona retrostante, adiacente al vicolo di Sant’Agata.In questo modo si spiegherebbe anche l’affermazione di Giovan Bat-tista Angelini in base alla quale il teatro sarebbe stato «de’ Teatini altempio unito»121. Tale soluzione, inoltre, avrebbe permesso un ingres-so separato e lontano dalla strada principale, agevolando l’arrivo dei
118. Documento 1686: 11, in Regesto. I due rettori aggiungono che lo stesso Mon-te di Pietà ha affittato, al piano terreno sottostante, «due botteghe a fabri, che sonoposte sotto li pegni medesimi».
119. Documento 1687: 2, in Regesto.120. Documento 1687: 2, in Regesto.121. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 377.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 93
94
FRANCESCA FANTAPPIÈ
nobili spettatori e delle loro carrozze, infine una maggiore facilità ditrasporto delle attrezzature scenotecniche122. L’ipotesi, necessaria perpoter attribuire preliminarmente un’ubicazione al teatro, potrebbetrovare una conferma solo grazie a rilievi in loco e al loro confrontocon ulteriore documentazione relativa alla struttura architettonica del-l’edificio.
Le domande sulla dislocazione del teatro rimangono, perciò, par-zialmente insolute, mentre i documenti reperiti non aiutano a chiari-re questioni quali la dimensione o la struttura dell’edificio. La sua esi-stenza è, però, fuori dubbio. Il progetto, nonostante le numerose po-lemiche e vertenze, venne compiuto. Un esito della vicenda non af-fatto scontato. I conti Secco Suardo avrebbero potuto perdere la cau-sa contro il Monte di Pietà e vedere il loro teatro immediatamente de-molito. Sebbene di breve durata fu, perciò, un’avventura che ebbe unsuo svolgimento. Vediamo allora i vari passaggi della causa, utili sia adeterminare la mentalità espressa dalle autorità municipali bergama-sche e dal governo veneziano, sia a rivelare le intenzioni della nobilefamiglia Secco Suardo.
Come già parzialmente esposto, il Monte di Pietà dette avvio allavertenza con una supplica al Comune di Bergamo del 14 dicembre1686123. Gli ufficiali del pio luogo giustificarono il ritardo nella pre-sentazione del reclamo, affermando di non essere stati presenti du-rante i lavori di costruzione, poiché «nelli mesi autunnali di settem-
122. All’epoca della costruzione del teatro il vicolo di Sant’Agata era sicura-mente più ampio rispetto alle dimensioni attuali, poiché la sagrestia dei padri tea-tini (attualmente occupata dalle cucine e da alcune stanze del Circolino) era di di-mensioni minori rispetto a quelle odierne, né invadeva parte della strada. È solonel 1705 che Giuseppe Secco Suardo e fratelli concessero ai propri vicini il per-messo di allargare gli ambienti della chiesa ed occupare una parte del vicolo, co-munemente usato dalla nobile famiglia per il passaggio di carrozze: «Adì 25 ago-sto 1705 in Bergamo Indizione XIII. Avendo desiderato li M. RR. PP. Chierici Re-golari di Sant’Agata della presente Città di Bergamo di dilatare alquanto la fabbri-ca della lor chiesa, per il che averebbero dovuto occupar e restringere la strada osia incesso che ha sempre servito e serve alla casa dell’Illustrissimi Signori conteGioseppe et fratelli Secci Soardi per l’ingresso de’ carri et carrozze a detta casa chetiene la porta antica delle rimesse et portico di fieno sopra detta strada, hanno pe-rò risolto di pregar essi signori conti perché fossero contenti che essi padri si dila-tassero recte filando sol tanto quanto si estende il canton della loro sagrestia»,ASSLu, Inventario, Serie I, 718, XVI.
123. Documento 1686: 5, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 94
95
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
bre, ottobre e novembre è solito dalli cittadini di questa città starenelle loro ville come è notorio»124. La prima risposta da parte del Con-siglio Maggiore di Bergamo fu di affidare ai Conservatori del Monteil compito di trovare una soluzione per garantire l’indennità del sito.Il reclamo venne così rimandato al mittente. Una delibera cui si op-pose l’immediato rifiuto degli ufficiali del Monte, i quali presentaro-no nuovamente la questione al Comune. La seconda istanza determi-nò la decisione da parte della autorità municipali di eleggere tre de-putati con l’incarico di approfondire il caso125. Il risultato della peri-zia comunale portò alla seguente conclusione: il Monte di Pietà do-veva essere allontanato dal teatro. La commissione stabilì la necessi-tà «di doversi senza dilazione alontanar li capitali et supellettili pre-ziosi d’esso Pio Luogo in distanza sicura da ogni pericolo di fuocoche puotesse succedere in detto teatro»126. Una soluzione che però ap-parì immediatamente impraticabile. Si riscontrò l’impossibilità di tro-vare un luogo adatto alle funzioni del Monte, con le stesse caratteri-stiche di quello fino ad allora occupato: il sito era ritenuto il più si-curo della Città Alta, poiché godeva della protezione dei corpi di guar-dia dei due rettori, quello del capitanio in Cittadella e quello del po-destà in Piazza Vecchia. Inoltre il trasloco dei beni conservati nei lo-cali del Monte appariva inattuabile senza incorrere in perdite: «cono-scendo l’impossibilità così del trasporto delli mobili di esso Montecome pure un’altra casa con il sito sicuro di questa città»127. Poiché i«masseroli» si rifiutarono di eseguire il trasferimento, avendo firmatoassicurazioni sui beni da loro costuditi, «ogni perdita et discapito de’pegni sarebbe a pregiudizio di detto Monte»128.
Vediamo così che l’azione dei deputati del Comune di Bergamo,almeno inizialmente, non fu affatto incisiva, ma ambigua ed esitan-te. La presenza del podestà Pietro Pisani e del capitanio Giulio Dona-do, dichiaratamente favorevoli alla costruzione del teatro, accrebbe lalentezza nel procedimento della causa inoltrata alla magistrature ve-
124. Documento 1687: 2, in Regesto. La congrega, invece, si era potuta riuniresolo il 30 maggio e il 12 dicembre 1686.
125. Documento 1686: 7, in Regesto.126. Documento 1686: 10, in Regesto.127. Documento 1687: 3, in Regesto.128. Documento 1687: 2, in Regesto. Numerose le attestazioni firmate dai mas-
seroli del Monte: Documenti 1687: 12-13, 15-16, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 95
96
FRANCESCA FANTAPPIÈ
neziane. Fu solo con la loro partenza che la Città presentò una sup-plica ai nuovi rettori, accusando quelli appena decorsi di non aver vo-luto procedere presso il Senato veneto, nonostante le istanze esibiteloro: «come che dette Eccellenze avevano concepito troppa inclina-zione alle allegrie di detto teatro, posposero l’instanze della Città alloro genio, et però partite che sono state dette Eccellenze, sotto li 2maggio fu posta parte nel medesimo Minor Consiglio»129. Vennero co-sì arrecate nuove ragioni contro la costruzione del Teatro Secco Suar-do. Tra esse vi erano il rischio d’incendio, motivo per il quale nel di-cembre del 1685 la Città stessa aveva fatto demolire il teatro provvi-sorio di Antonio Scappi costruito sotto la loggia del Palazzo della Ra-gione, e il pericolo dell’ingresso notturno di malviventi all’interno del-la cinta muraria della Città Alta, le cui porte venivano normalmentechiuse la sera130. L’esistenza del teatro «porta seco l’occasione delle ope-re di tenersi aperto l’ingresso di notte tempo e regresso finite l’operemedeme dalla cinta nuova della città», quando le porte della «cintanuova» dovrebbero rimanere chiuse; inoltre «accresce il pericolo de’bruti, perché gl’huomini malviventi, godendo l’opportunità della not-te et di potere entrare et uscire dalla città più facilmente si dispongo-no a commettere delitti»131. In particolare si temevano furti nel vici-no Monte di Pietà, che custodiva beni di valore.
Il reclamo della Città venne inoltrato al Senato veneto dai rettoriAlessandro Dolfin e Marco Michiel con una lettera del 21 giugno1687132. Parallelamente Giuseppe Secco Suardo e il fratello Marco in-caricarono un loro procuratore presso le magistrature di Venezia133. Laprima risposta da parte del Senato fu la richiesta di un’integrazione
129. Documento 1687: 3, in Regesto.130. Documento 1687: 2, in Regesto.131. Documento 1687: 3, in Regesto.132. Documenti 1687: 8-9, in Regesto.133. Si tratta di Pietro Facchinetti il quale, il 28 maggio 1687, fu latore di un’istan-
za ai Capi del Consiglio dei Dieci da parte di Giuseppe Secco Suardo: Documento1687: 11, in Regesto. Con una procura del 24 aprile 1688 venne inoltre istituito «at-tore e difensore» di Giuseppe e Marco Secco Suardo, loro rappresentante «in tuttele loro cause attive, passive, civili, criminali et miste, vertenti et che vertir puotesse-ro con qualonque persona secolare o ecclesiastica, logo pio come et università avan-ti qualonque illustrissimo et eccellentissimo giudice consiglio collegio officio et ma-gistrato nella inclita città di Venezia», ASBg, Notarile. Protocolli, 5797, notaio CarloIppolito fu Gio. Antonio Bottani, filza n. 3, all’atto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 96
97
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
alla memoria già pervenuta: «prima di venir sopra ciò a deliberazio-ne veruna conoscemo necessaria un’esatta [inform]azione del tempoche sia fabbricato il teatro medemo, della spesa che possa esser occor-sa in costruirlo e del pericolo che può sovvrastare al Monte stesso»134.Ottenuti, per mezzo di una lettera dei rettori dell’8 agosto 1687, gliopportuni chiarimenti, il Senato deliberò che tra le case del Monte equelle dei conti Secco Suardo fosse levato qualsiasi elemento di col-legamento dovuto ad assi di legno: «mentre s’intende attrovarsi alcu-ni legnami» del teatro «che communicano con la Casa del Monte me-desimo», dovrà essere ordinato ai nobili proprietari «di levar a propriespese tutto il legname che vi fosse e che potesse apportar qualche pe-ricolo in accidente di fuoco, facendo ch’il volto delle stanza c’hora ède travi, sia rifformato di pietra e coperte esse stanze di lastre»135. Unadelibera definitiva e inoppugnabile. La decisione del Senato venetopermise così che il teatro continuasse ad esistere, dando di fatto vialibera a Giuseppe Secco Suardo nel suo progetto impresariale. Unasoluzione, quella di rafforzare gli elementi di divisione tra i due ca-seggiati, rendendoli per quanto possibile ignifughi, già suggerita dairettori Pisani e Donado. Essi, infatti, avevano proposto due possibili-tà di rifacimento, tutte a carico della famiglia Secco Suardo. La pri-ma consistente nell’eliminare qualsiasi collegamento esistente tra lecoperture delle due abitazioni, ossia «levar ogni comunicazione d’al-cuni legnami che fosse tra il detto teatro e muraglia del Monte, con-vertendo la fabrica ch’ora è de’ legnami in pietra, cioè reformar il vol-to, hora di travi, in pietra d’alcune stanze che sono tra le due mura-glie del Monte e teatro»136. La seconda nell’alzare il muro di comuni-cazione dalla parte del Monte di Pietà, ossia «render elevata a propriespese la muraglia del Monte nella stessa grossezza per tutto il tratto etener del teatro, così che quella del Monte fosse brazza sei più alta»137.Il Senato si dichiarò a favore della prima soluzione. Non certo peruna questione di «pubblico interesse», così fortemente invocata dairappresentanti del Monte di Pietà, ma per garantire i diritti individua-li di una potente nobile famiglia i cui esponenti principali si eranolanciati in un progetto impresariale del tutto simile a quelli già da tem-
134. Documento 1687: 14, in Regesto.135. Documenti 1687: 17 e 18, in Regesto.136. Documento 1686: 11, in Regesto.137. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 97
98
FRANCESCA FANTAPPIÈ
po affermatisi nella Dominante, oltre che in molte altre città della Ter-raferma veneta.
2.2.2. Un tentativo impresariale sul modello veneziano
La vittoria del conte Giuseppe Secco Suardo non fu decretata daBergamo, bensì da Venezia. Fondamentale, ma di breve durata. Il pro-getto seguì l’esempio di molte altre città della Terraferma veneta, a par-tire da quello più rimarcabile costituito dal Teatro Obizzi, voluto dalmarchese Pio Enea a Padova, per continuare con Bassano (TeatroBrocchi), Rovigo (Teatro della Campagnella), Treviso (Teatro SantaMargherita, Teatro Onigo, Teatro Dolfin), Vicenza (Teatro delle Gar-zerie, Teatro Tornieri)138. Edifici teatrali costruiti per iniziativa privatasul modello di quelli veneziani, nati a loro volta con finalità chiara-mente economiche e al contempo propagandistiche, per volontà dialcune delle più illustri casate cittadine, quali i Tron, i Giustiniani, iGrimani, i Vendramin139.
Se i dati a nostra disposizione in merito alla gestione economicadel Teatro Secco Suardo non sono molti, sono tuttavia sufficienti perescludere l’ostentazione di una magnificenza gratuitamente elargita aipropri concittadini da parte della famiglia che promosse l’iniziativa.Non si trattò di un teatro ideato per funzionare solo nel caso di even-ti eccezionali, ma viceversa di un progetto che aspirava ad imporsi co-me investimento, secondo una precisa logica di mercato. I palchettivenivano, infatti, dati in affitto. L’unica preziosa notizia relativa allariscossione di un pagamento è dovuta ad una nota casualmente ap-puntata in un libro di conti della famiglia Secco Suardo. L’entrata, per-venuta dal conte Gherardo Benaglio e risalente al 5 gennaio 1689, èdi lire 62, ossia 10 ducati, «per l’affitto del palco del teatro del corren-te anno»140. Non conoscendo il numero totale dei palchetti, non pos-siamo stabilire quale fosse il rendimento complessivo costituito daicanoni degli stessi. Sappiamo però che i profitti derivanti dalla loro
138. Si veda la Parte I. 1. Il sistema teatrale delle città della Terraferma veneta.139. N. Mangini, I teatri di Venezia, Milano, 1974; F. Mancini, M.T. Muraro, E.
Povoledo, I teatri del veneto, vol. I, t. 1: Venezia. Teatri effimeri e nobili imprenditori, Ve-nezia, 1995 e vol. I, t. 2: Venezia e il suo territorio. Imprese private e teatri sociali, Vene-zia, 1996.
140. Documento 1689: 1, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 98
99
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
cessione a pagamento costituirono una delle voci prese in considera-zione nella valutazione delle perdite che, nel caso di un’eventuale de-molizione del teatro, avrebbero danneggiato la nobile casata. In que-sto caso non solo sarebbe stato necessario stimare la spesa effettuata«per la construttione di detto teatro, compresi li materiali, fattured’operarii et ogn’altro che puossa essere occorso per stabilirlo», ma«rispetto a’ palchetti» si sarebbe dovuto calcolare «il valore di tutti limateriali in essere et il ricavato dalli palchetti et altri utili provenu-ti»141.
L’intento economico degli allestimenti operistici viene ulterior-mente rimarcato dalla presenza di impresari, come Antonio Scappi,cui vennero affidate le stagioni del Carnevale 1687 e 1688, e Giaco-mo Cipriotti, cui spettarono le due successive. Entrambi nel corso de-gli ultimi decenni del Seicento furono attivamente impegnati nella cir-colazione del repertorio veneziano nei principali centri teatrali dellaprovincia centro-settentrionale. In merito allo Scappi è sicuramenteappropriata la descrizione fornita da Ferdinando Carlo Gonzaga, alcui servizio il cantante militava negli anni Novanta del Seicento. Se-condo il duca di Mantova si sarebbe trattato di una persona che te-neva «un genio particolare d’introdurre divertimenti di recite»142. Co-
141. Documento 1687: 2, in Regesto.142. L. Bianconi, T. Walker, Production, consumption and political function of seven-
teenth-century opera, in «Early Music History», IV, 1984, pp. 209-296: 289. Per la pre-senza di Antonio Scappi tra i cantanti al servizio del duca di Mantova negli anniNovanta del Seicento si veda P. Besutti, La corte musicale di Ferdinando Carlo Gonza-ga ultimo duca di Mantova. Musici, cantanti e teatro d’opra tra il 1665 e il 1707, Manto-va, 1989, p. 81. Contralto della cappella di San Marco di Venezia tra il 1685 e il1689, ne venne espulso per assenze ingiustificate, probabilmente dovute alla sua pa-rallela attività d’impresario. Tra il 1680 e il 1704 firmò le dediche di molte opere rap-presentate, oltre che a Bergamo, nelle città di Fano, Macerata, Mantova, Milano, Ro-ma, Rovigo, Udine, Verona, Vicenza: C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libret-ti 1840, 5748, 8721, 8951, 9614, 9615, 9617, 15088, 20076, 20150, 20156, 24100. Sul-la circolazione del repertorio operistico veneziano nei teatri della provincia, dovutaall’operato di Antonio Scappi si veda F. Piperno, Il sistema produttivo fino al 1780, cit.,p. 28. Per quanto riguarda le rappresentazioni nella Terraferma veneta, particolar-mente documentata è quella de La Venere travestita, tenuta a Murano (Teatro dellaPescaria), a Rovigo (Teatro della Campagnella) e a Conegliano nel corso dell’anno1691, mentre l’anno successivo Antonio Scappi operò a Vicenza e a Verona (Teatrodel Palazzo del Capitanio), F. Mancini, M.T. Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto,vol. II, cit., pp. 58, 244; vol. III, cit., pp. 336-337; vol. I, t. 2, cit., p. 334. Nel set-tembre del 1700 si aggiudicò, insieme alla propria «compagnia» di cantanti (tra cui
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 99
100
FRANCESCA FANTAPPIÈ
me abbiamo visto fu l’impresario che, nel dicembre del 1685, vide de-molito il teatro provvisorio da lui stesso costruito sotto la loggia delPalazzo della Ragione e che, allora respinto da Bergamo, nel Carne-vale del 1686 portò le proprie opere nella vicina Crema143. La costru-zione del Teatro Secco Suardo rappresentò, quindi, l’occasione oppor-tuna per riprovare la strada bergamasca. Fu così che nel Carnevale del1687 «nel Nuovo Teatro dell’illustrissimo signor conte Giuseppe Sec-co Suardo» mise in scena Il Clearco in Negroponte, con musica di Do-menico Gabrielli, dedicandolo al podestà Pietro Pisani e al capitanioGiulio Donado144. Da una nota della vertenza con il Monte di Pietàveniamo a sapere che una parte degli interpreti era presente a Berga-mo già dalla seconda metà del dicembre 1686, ossia quando la com-missione di tre deputati, eletta dai consigli municipali, si recò a su-pervisionare il sito constatando che «era già avanzato tanto il tempoche li recitanti, molto tempo prima capitati, erano pronti per monta-re in scena, come seguì di lì a pochi giorni»145. Tra i virtuosi presenti,oltre al già nominato Antonio Scappi, troviamo un’altra cantante pro-tetta dalla corte di Mantova. Si tratta di Caterina Frangiosi, la qualevenne raccomandata alla protezione del conte Giuseppe Secco Suar-do da Ferdinando Carlo Gonzaga con una lettera del 24 dicembre1686146. Secondo il libretto, per intercalare l’opera erano previsti dueintermezzi danzati, il primo «di pittori» e il secondo «di soldati coro-nati d’ulivo»147. La trama, tratta dalla storia antica, era ambientata aCorinto. La rappresentazione prevedeva svariati cambi di scena raffi-
Agostino e Caterina Azzolini), la stagione autunnale del Teatro San Sebastiano diLivorno, F. Fantappiè, «Un garbato fratello et un garbato zio». Teatri, cantanti, protettori eimpresari nell’epistolario di Francesco Maria Medici (1680-1711), Tesi di Dottorato in Sto-ria del Teatro e dello Spettacolo, 2005, vol. I, pp. 160-162 e vol. II, pp. 22-23, 270-271.
143. Cfr. Supra, p. 66.144. Si veda Il Clearco in Negroponte (1687) in Cronologia. La prima rappresenta-
zione nota dell’opera fu veneziana (Teatro San Moisè, 1685 e 1686). Seguirono Na-poli (1686), Mantova (1688, impresario Antonio Scappi), Modena (1689), Palermo(1691), Udine (1691), Roma (Teatro Capranica, 1695): C. Sartori, I libretti italiani astampa, cit., libretti 5745-5753.
145. Documento 1687: 10, in Regesto. L’incarico ai tre deputati è del 17 dicem-bre, mentre la relazione ai Consigli Maggiore e Minore è del 24.
146. Documento 1686: 8, in Regesto.147. Tavola dei cambi di scena nel libretto Il Clearco in Negroponte (1687), in Cro-
nologia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 100
101
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
guranti ambienti sia esterni sia interni: una «spiaggia solitaria di ma-re», un’«anticamera nobile», il «campo di Clearco attendato di notte»,una «galleria di statue», una «loggia aperta sul mare», alcune «loggiedelitiose in Corinto», un «cortile regio», un «giardino con fontana nelmezo», etc. Infine scene di battaglia, con scontri tra gli «eserciti de’tebani e corinti»148. Anche in questo caso, come nei melodrammi suc-cessivi, le scene marine presentavano barche praticabili. Alla scena se-conda dell’atto primo vediamo «Clearco che sbarca con parte de’suoi». Infine, alcune scene di battaglia: «Si destano li soldati e con unariete abbattono le mura della rocca»; «Cadono atterrate le mura e dop-po breve baruffa»149.
A dimostrazione del buon esito della rappresentazione inauguralel’anno successivo Antonio Scappi fu nuovamente presente a Berga-mo per mettere in scena nel Teatro Secco Suardo una seconda opera,anche in questo caso di provenienza veneziana, ossia il Tullo Ostilio150.Questa volta venne accompagnato da una lettera di raccomandazio-ne del duca Ferdinando Carlo Gonzaga al capitanio Alvise Dolfin151.Quanto agli interpreti conosciamo il nome di una sola delle cantan-ti, la virtuosa Angelica Vitaloni. Anch’essa protetta dalla corte man-tovana, venne raccomandata con una lettera del 30 dicembre 1687 alconte Giuseppe Secco Suardo152. Per quanto riguarda la messa in sce-na, le didascalie poste all’interno del libretto ed una straordinaria im-magine ad esso anteposta rendono possibile ricostruire alcuni passag-gi della rappresentazione e parte degli elementi di scenografia utiliz-zati (fig. 8).
La vicenda rappresentata si ispira alla leggenda di Tullo Ostilio, ter-zo re di Roma, e alla distruzione da lui ordinata della vicina città diAlba Longa, cui seguì la deportazione delle popolazioni dal MonteAlbano al Monte Celio. Nell’immagine, eccezionalmente eloquente,troviamo illustrati sincreticamente buona parte degli episodi della leg-
148. Ibidem.149. Ivi, atto primo, scena VIII.150. La prima rappresentazione nota fu a Venezia (Teatro San Salvatore, 1685),
dopo cui seguirono Milano (1686), Brescia e Livorno (1688), Napoli e Verona (1689),Ferrara (1693), Roma (1694), Bologna (1695), Lucca (1696), Parma e Vicenza (1697),Firenze e Pisa (1701), Siena (1702), Genova (1703), Napoli (1707): C. Sartori, I libret-ti italiani a stampa, cit., libretti 24098-24117.
151. Documento 1688: 2, in Regesto.152. Documento 1687: 20, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 101
102
FRANCESCA FANTAPPIÈ
genda, messi in scena nel corso dell’opera. Analizziamo, quindi, la fi-gura. Si tratta di una scena boschereccia in prospettiva, sul fondo e alcentro della quale è situato un monte cavo, o meglio una grotta, so-pra la quale si stagliano due figure. Una delle due, quella seduta, haun aspetto regale con tanto di corona e di scettro (Tullo Ostilio), l’al-tra indossa un costume da soldato con un elmo e si trova in piedi (Va-lerio). Al di sopra delle loro teste vediamo un sorta di sole e un arco-baleno, infine un’aquila che si muove verso i due personaggi. Ai pie-di del monte si trovano undici figure femminili, vestite con un abitocorto e molto semplice, sulle spalle un mantello e in testa un turban-te. Sono le «prigioniere Albane»153 rapite e portate davanti al trono diTullo Ostilio. Le schiave, sei sulla sinistra e cinque sulla destra, sonodisposte lungo le linee prospettiche disegnate dagli alberi. Il dodice-simo schiavo in primo piano è un nano, o buffone, il quale, in unaposa scomposta e quasi danzante, indica l’intera scena. Si tratta di Mi-lo, unico personaggio ridicolo dell’opera e paggio della schiava Sabi-na. Quest’ultima è identificabile nella prigioniera in primo piano si-tuata dall’altro lato del palcoscenico.
L’immagine riassume buona parte degli episodi contenuti nel pri-mo atto dell’opera. Vi possiamo ravvisare, infatti, la quinta scena, nelcorso della quale Valerio mostra a Tullo Ostilio una schiera di prigio-nieri albani tra cui Sabina e Milo. L’idea generale della raffigurazio-ne, invece, trae ispirazione dalla scena XIII rappresentante una «bo-scaglia vicina a Roma con colline destinata alle caccie reali», al cui in-terno è prevista la presenza di un «colle» su cui Tullo Ostilio sale pervedere la caccia (scena XVI)154. Ciò che manca nel libretto, ma vienerappresentata nell’immagine, è l’aquila, simboleggiante Giove che, se-condo la leggenda, avrebbe ucciso Tullo Ostilio con un fulmine, pu-nizione dovuta al disinteresse del re romano per le pratiche religiosee al suo comportamento irrispettoso nei confronti degli dei155. La tra-ma dell’opera, in questo caso, non sembra prevedesse alcuna scena si-
153. Tullo Ostilio (1688), in Cronologia.154. Descritta anche come «bosco con monte per la caccia». Le didascalie che
indicano i movimenti confermano come la montagna, visibile nell’immagine, fossepraticabile. Nella didascalia della scena XVI si precisa, infatti, che «Tullo Ostilio ve-de Ascanio in disparte nell’uscire per salire il colle ad osservar la caccia». Si veda illibretto Tullo Ostilio (1688) in Cronologia.
155. Secondo la leggenda, riportata nella dedica del libretto da Antonio Scap-pi, Tullo Ostilio fu «incenerito dall’ira di Giove», Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 102
103
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
mile, ma si concluse con una prevedibile promessa di matrimonio trale due coppie di innamorati principali: Silvio-Marzia, Sabina-Ascanio.Una «machina dell’aquila di Giove»156 è, invece, un elemento sceno-tecnico in dotazione al teatro di Crema nel 1687, dopo il passaggiodello Scappi.
L’ultimo argomento di riflessione suggerito dall’immagine riguar-da il numero di donne raffigurato. Poiché i personaggi femminili pre-visti dal melodramma erano solo due, ossia Marzia e Sabina, la pre-senza di ben undici personaggi in costume di schiave induce a pen-sare all’allestimento di balletti, come già avvenuto per Il Clearco inNegroponte del 1687. Altre scene d’insieme del Tullo Ostilio erano quel-le che prevedevano schiere di soldati romani, in alcuni casi accom-pagnate da finte battaglie. Gruppi di comparse per rappresentare eser-citi schierati e contrapposti, oltre che intermezzi danzati (un ballodi paggi e un ballo di Satrapi), fecero sicuramente parte del GiulioCesare in Egitto, opera portata a Bergamo dall’impresario GiacomoCipriotti e rappresentata nel Teatro Secco Suardo durante il Carne-vale del 1689157.
Per quanto riguarda il Cipriotti siamo di fronte a una tipologiadi produzione operistica di vera e propria ispirazione veneziana. Imelodrammi messi in scena nel Carnevale del 1689 furono, infatti,due. Nel mese di gennaio il Maurizio di Adriano Morselli cui seguìa febbraio il Giulio Cesare in Egitto di Giacomo Francesco Bussani.L’allesti mento di due rappresentazioni distinte era un sistema diffu-so cui si ricorreva per ammortizzare le perdite nel caso che una nonriscuotesse sufficiente apprezzamento da parte del pubblico. Del ve-neziano Giacomo Cipriotti sappiamo che tra il 1685 e il 1686 eraoperante come «direttore dell’opera, macchine e scene et altre inven-zione» nel Teatro Ducale di Milano dove, dal 1688, figura come im-
156. Documento 1687: 19, in Regesto. Antonio Scappi è presente come impre-sario nel teatro di Crema durante il Carnevale del 1686. Pur non conoscendo qua-le opera sia stata rappresentata in quell’occasione non è da escludere la possibilitàche «la macchina dell’aquila di Giove» fosse stata lasciata proprio da lui. Per quan-to riguarda il Teatro Secco Suardo, la ritroviamo per la rappresentazione del Mauri-zio nel 1689.
157. In quello che viene definito «coro» fanno parte il seguito di Giulio Cesare,i soldati di Giulio Cesare, il seguito di Tolomeo, i soldati mori di Achilla, le dami-gelle e i paggi di Cleopatra. Si veda il libretto Giulio Cesare in Egitto (1689), in Cro-nologia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 103
104
FRANCESCA FANTAPPIÈ
presario158. Dopo l’esperienza bergamasca continuò la propria attivi-tà nei teatri della provincia lombarda e, in parte, veneta159.
Nella messa in scena del Maurizio troviamo l’uso di alcuni elemen-ti scenotecnici già riscontrati nel Tullo Ostilio (monte/grotta e aqui-la/sole). Per l’allestimento era, infatti, necessaria la presenza di un«Monte de’ Tisei», così come la comparsa di «Giove sopra l’Aquila»160.Il dio, al suo arrivo in scena, fulminava il monte. Questo si apriva fa-cendo uscire i giganti (atto II, scena IX). Effetto di sicura presa sul pub-blico, cui si aggiungevano quelli che prevedevano la rappresentazionedi scene notturne, la più sorprendente delle quali doveva sicuramenteapparire una «notte con luna luminosa» (atto II, scena XXI)161. Sia ilMaurizio, sia il Giulio Cesare in Egitto sono opere di provenienza vene-ziana, già collaudate e di grande successo162. Per quanto riguarda la se-conda vale la pena ricordare la trama, in quanto nel libretto è presen-te un’immagine che possiamo mettere in relazione con essa (fig. 10).Melodramma ispirato alla campagna militare di Giulio Cesare compiu-ta nel 48-47 a. C., l’intricata vicenda, che qui riassumiamo nelle sue li-nee principali, si apre con l’arrivo del protagonista sulle sponde del Ni-lo, dove giunge per inseguire Pompeo fuggito dopo la sconfitta di Far-
158. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 12208, 2223, 13046. A Mi-lano fu scenografo del Giulio Cesare in Egitto (1685) e di Antonino e Pompeiano (1686),impresario dell’Incoronazione di Dario (1688).
159. Lo troviamo a Brescia (1691), Lodi (1694, 1695), Crema (1694, 1695), Bre-scia (1698), Milano (1700, 1703, 1707), Cremona (1703, 1704), Pavia (1704), Manto-va (1707), Ivi, libretti 5855, 6834, 9869, 11261, 13130, 13174, 13297, 14227, 17650,17085, 17785, 19028, 23765, 24731.
160. Il Maurizio (1689), in Cronologia.161. A cui bisogna aggiungere la scena di una «stanza con lumi accesi di notte»
(Atto II, scena XV). Per il libretto si rimanda alla Cronologia.162. Il Maurizio è un’opera di Adriano Morselli rappresentata per la prima vol-
ta nel Teatro San Salvatore di Venezia (1687) cui seguirono messe in scena a Berga-mo, Milano e Modena (1689), Livorno, Padova e Vicenza (1691), Roma (1692), Ri-mini (1693), Palermo (1694), Parma e Udine (1696), Bologna (1697), Ferrara (1699),Firenze (1707), Napoli (1708): C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 15271-15288. Il Giulio Cesare in Egitto, rappresentata per la prima volta a Venezia nel 1677su libretto di Giacomo Francesco Bussani, musica di Antonio Sartorio (Teatro SanSalvatore, 1677), vide successive messe in scena a Napoli (1680), Messina (1681), Mi-lano (impresario Antonio Piantanida, scene del Cipriotti, 1685), Livorno (1697).L’opera, su libretto di Nicola Francesco Haym e musica di Georg Friedrich Händel,venne riproposta al King’s Theatre di Londra (1724, 1725, 1730, 1787), Roma (Tea-tro Argentina, 1796), Ivi, libretti 12205-12215.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 104
105
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
salo. Non appena in terra egiziana trova, però, che il re Tolomeo, perpoter entrare nelle sue grazie, ha già fatto uccidere il condottiero roma-no e, per dimostrare la propria amicizia, ha mandato il proprio coman-dante Achilla a portare in dono la testa del suo nemico. La reazione diCesare è sdegnata e provoca una risposta altrettanto adirata da parte diTolomeo. Da ciò deriva lo scontro tra romani ed egiziani che si con-clude con la sconfitta di questi ultimi. Il regno d’Egitto viene allora af-fidato da Cesare a Cleopatra sorella di Tolomeo.
Come riscontrato nel caso del Tullo Ostilio, l’immagine antepostaal libretto presenta il protagonista dell’opera in una fase iniziale del-la vicenda. La figura principale rappresenta, infatti, Giulio Cesare –con alle spalle i propri soldati – mentre compie un gesto di sdegno difronte al dono della testa di Pompeo, posta su un desco e offertaglida un servo in ginocchio. Sullo sfondo un sole splendente, un collecon alcuni palmizi e un ponte sotto cui scorre un fiume, identifica-bile con il Nilo. Siamo, quindi, all’inizio del dramma e più precisa-mente all’atto primo, scena prima, che rappresenta una «campagna conlucidissimo sole e con ponte di pietra sopra un ramo del Nilo»163. Al-tri elementi di scenografia utilizzati sono ricavabili dall’analisi delledidascalie interne al libretto. Come spesso succede nelle rappresenta-zioni operistiche seicentesche si alternano scene che fingono veduteall’aperto, quali un giardino o la campagna, ad altre che rappresenta-no scene d’interni, come sale reali o prigioni164. Ideata per stupire eimpressionare il pubblico era sicuramente la battaglia navale finale.Essa fu possibile grazie ad imbarcazioni finte, ma praticabili, come di-mostra l’inizio dell’atto terzo, durante il quale vediamo «Tolomeo chesbarca con tutte le sue genti» portando con sé «Cleopatra prigionieracon molti altri suoi confederati»165.
163. Si veda la descrizione delle scene contenuta nel libretto Giulio Cesare in Egit-to (1689), in Cronologia. La testa di Pompeo viene consegnata a Cesare nella scenaXI, atto I.
164. Sulle strategie messe in campo dagli scenografi nei teatri di provincia perrendere più veloce ed economico il procedimento della messa in scena, così comesulla variazione della dotazione scenotecnica in base alla natura degli edifici, si ri-manda a M. Viale Ferrero, Luogo teatrale e spazio scenico, in Storia dell’opera italiana,vol. V: La spettacolarità, a cura di L. Bianconi e G. Pestelli, Torino, 1988, pp. 3-122,mentre sulla ricorrenza della scena di prigione a A. Romagnoli, “Fra catene, fra stili efra veleni...” ossia sulla scena di prigione nell’opera italiana (1690-1724), Lucca, 1995.
165. Atto terzo, scena II del libretto per cui si veda la Cronologia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 105
106
FRANCESCA FANTAPPIÈ
In che modo veniva realizzato tutto questo? In questo caso è fi-nalmente possibile rispondere alla domanda. Grazie al reperimentodi un inventario del materiale scenotecnico appartenuto al Teatro Sec-co Suardo risalente all’11 novembre del 1689166. Lo straordinario do-cumento consiste in un elenco redatto con lo scopo di registrare ladotazione scenografica consegnata a Giacomo Cipriotti dal conte Giu-seppe Secco Suardo. Oltre a svelare i segreti della scenografia, permet-te di stabilire la presenza a Bergamo dell’impresario veneziano versola fine 1689, segno di una rappresentazione prevista per il Carnevaledel 1690, stagione nella quale, purtroppo, non sono tuttora emersi ilibretti relativi alle opere messe in scena.
L’analisi del documento porta alle seguenti conclusioni. Dopotre anni di attività il palcoscenico del Teatro Secco Suardo era do-tato di otto quinte a scorrimento laterale, poste in «prospetto» quat-tro per lato, che permettevano cinque cambi di scena: un bosco, ungiardino, una città, una sala, un cortile167. A ciascuna di esse corri-spondevano nella parte superiore «n. 4 pezze di soffitta ordite conle sue corde et il suo cordone»168, ossia ampie strisce di stoffa dipin-te che attraversavano tutto il palco parallelamente al boccascena, le-gate ad uno stangone e manovrate dall’alto. Alle scene principali sene aggiungevano altre, più piccole, utili per raffigurazioni partico-
166. Documento 1689: 2, in Regesto.167. Nell’inventario definite come «Scene di bosco bone n.° 8 nel prospetto avan-
ti con suoi telari boni. Scene di giardino pezzi n.° otto del prospetto avanti tutti bo-ni. Scene di cortile in telari n.°sedeci tutti boni nel prospetto avanti. Scene di cittàin telari n.° otto nel prospetto avanti tutti boni. Scene di sala di oro in otto telarinel prospetto avanti tutti boni», Ibidem. Le scene o tele dipinte erano inchiodate suicosiddetti «telari» ossia intelaiature lignee formate da quattro regoli commessi in qua-dro. Per una definizione del termine rimandiamo a A.M. Testaverde, L’officina dellenuvole. Il Teatro Mediceo nel 1589 e gli “Intermedi” del Buontalenti nel “Memoriale di Gi-rolamo Seriacopi”, in «Musica e teatro. Quaderni degli amici della Scala», 11-12 (giu-gno-ottobre 1991), p. 172.
168. Documento 1689: 2, in Regesto. Il termine «cordone», il cui significato ge-nerico è quello di grande corda e/o elemento architettonico di forma cilindrica, vie-ne usato nel documento per indicare, insieme alle corde, un elemento di sostegnodelle «pezze di soffitta». Va perciò identificato con la trave di legno, attualmentechiamata stangone, cui vengono legati i fondali e «il soffitto o aria» per la quale siveda B. Mello, Trattato di scenotecnica, Novara, 1999, pp. 178, 210. Per la definizionedi «cordone» può essere utile anche la voce del S. Battaglia, Grande dizionario dellalingua italiana, 21 voll., Torino, 1962-2002, ad vocem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 106
107
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
lari169. Troviamo, ad esempio, registrati «telari di onde di mare n.°nove» e «telarette n.° cinque dipinte a barca» necessarie per rappre-sentare paesaggi marini. In questo caso la dotazione è ulteriormen-te arricchita dalla presenza di «carelli n.° tre per fare le barche» e«barche da sedere n.° vinti una». Veniamo così a sapere che le finteimbarcazioni a disposizione erano ventuno, fatte scorrere attraver-so il palco grazie a carri, detti «carrelli», montati su binari. Le gui-de erano almeno due, descritte nell’inventario come «due strade condue carelli»170.
Per poter effettuare i cambi di scena troviamo «telari sedeci perfar andare le scene con i suoi ferri», indicazione che permette di sta-bilire come dietro ogni quinta ne fossero disposte altre due pronteper le sostituzioni. Le scene venivano mosse da sotto il palco con«uno cordone sotto con li suoi ferri et ordigni et corde per il biso-gno far correre le scene»171. Difficile stabilire come venissero realiz-zati i fondali, in quanto l’unico elemento che sembra farvi riferimen-to è ravvisabile in «una tela sul muro in prospettiva dipinta e aria»172.In merito all’illuminazione erano a disposizione del teatro «le assiper poner le candele con li suoi ferri»173, sufficienti per rappresenta-re, ad esempio, la «riviera del porto d’Alessandria illuminata in tem-po di notte» nel Giulio Cesare in Egitto nel 1689 oppure un «anfitea-tro illuminato in tempo di notte con trono e popolo spettatore» nel-l’Ottaviano in Sicilia del 1695174. Tra gli oggetti scenici troviamo infi-ne «un trono bono» sicuramente utilizzato nel Tullo Ostilio e nellescene regali degli altri melodrammi. Il teatro aveva uno spazio per i
169. Documento 1689: 2, in Regesto. Tra esse vi erano: «Scene piccole pezzi n.°venti uno tutti buoni. Doi prospetti volanti boni. Un prospettino piccolo bono. Unprospettino con una porta in mezzo bono».
170. Ibidem. Per il meccanismo di scorrimento dei carri si veda B. Mello, Tratta-to cit., p. 235, in base a cui il termine «strada», usato per indicare la linea di scorri-mento dei binari, è tuttora in uso. Il «carrello» scorreva quindi tirato da due mac-chinisti, posti ai due lati del palcoscenico, dei quali uno tirava e l’altro spingeva. Perrendere il senso del moto delle onde era possibile costruire strade in legno ondula-te.
171. Documento 1689: 2, in Regesto. Normalmente, infatti, dietro le prime quin-te visibili erano poste almeno tre quinte retrostanti e ad esse molto vicine, prontead essere scoperte al momento dei cambi di scena, cfr. B. Mello, Trattato cit., p. 15.
172. Documento 1689: 2, in Regesto.173. Ibidem.174. Cesare in Egitto (1689) e Ottaviano in Sicilia (1695), in Cronologia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 107
108
FRANCESCA FANTAPPIÈ
musicisti, definito nell’inventario come «l’orchestra in forma buo-na». Non si trattava molto probabilmente di una fossa scenica, an-cora rara a quest’altezza cronologica, ma piuttosto di un semplicetramezzo che separava la platea dagli esecutori della musica. Infineesistevano «de’ palchi» destinati ai rettori veneti in carica, ossia unluogo di rappresentanza per il potere.
Non sappiamo a quale scenografo si debbano le scene. Come ab-biamo visto, per il teatro di Crema nel 1687 venne chiamato il vene-ziano Gaspare Torelli175. Tenuto conto delle ambizioni del conte Giu-seppe Secco Suardo nel progetto da lui intrapreso, l’ipotesi di un ri-corso a collaudati professionisti di scuola veneziana non è improba-bile. Il fugace accenno ad una «fede fatta in Milano»176, vale a dire uncontratto ivi stipulato, riportata nella relazione dei rettori Marco Mi-chiel e Alvise Dolfin al Senato veneto in merito alle spese di costru-zione dell’edificio, non esclude però la presenza di manodopera e/oartefici meneghini. Alle ipotesi suddette dobbiamo aggiungere, però,un dato sicuro: il contributo scenotecnico degli impresari susseguiti-si nel Teatro Secco Suardo. Antonio Scappi doveva avere simili com-petenze se si dimostra capace di montare un teatro in legno provvi-sorio sotto la loggia del Palazzo della Ragione. Per quanto riguarda ilveneziano Giacomo Cipriotti non ci sono dubbi: nasce come sceno-grafo, prima che come impresario.
Le notizie sull’attività del Teatro Secco Suardo posteriori al Carne-vale del 1690 sono purtroppo ridotte. L’unica rappresentazione accer-tata è l’Ottaviano in Sicilia, di autore ignoto con musica del maestrodi cappella di Santa Maria Maggiore Francesco Ballarotti177. Nel libret-to non sono contenute immagini. Le uniche osservazioni possibili in
175. Gaspare Torelli fu scenografo nel Teatro Vendramin di Venezia nel 1685 e 1686:C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., Indici, vol. I, ad vocem. Impossibile per adessostabilire eventuali vincoli di parentela esistenti con il celebre Giacomo Torelli, per lacui vicenda artistica e l’incredibile carriera che lo portò dai teatri veneziani alla cortedi Francia, ci limitiamo a rimandare alla voce di Per Bjuström in Enciclopedia dello Spet-tacolo, ed. diretta da S. D’Amico, vol. IX, Roma, 1962, coll. 973-976 e al volume F. Mi-lesi (a cura di), Giacomo Torelli. L’invenzione scenica dell’Europa barocca, Fano, 2000.
176. Documento 1687: 17, in Regesto.177. L’opera non sembra molto famosa. Le uniche due rappresentazioni docu-
mentate sono a Reggio Emilia (1692, musica di Francesco Ballarotti), Parma (1697,impresario Rinaldo Gherardini): C. Sartori, I libretti italiano a stampa, cit., libretti17612-17613.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 108
109
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
merito alla messa in scena sono, quindi, deducibili dalle ridondantiindicazioni sceniche riportate prima del testo. Due i paesaggi marini:nel primo atto un notturno con «il mare che scorre presso la città» euna «spiaggia di mare» con «le navi di Sesto Pompeo in lontananzaincendiate»178. Seguono le scene boschereccie: nel primo atto «un bo-schetto delizioso con fontane nel palazzo di Romilda» e nel secondoun «bosco ingombrato dalle tende d’Ottaviano». L’allestimento di ap-partamenti signorili è necessario per rappresentare le «stanze nel pa-lazzo di Romilda» e la «sala nel palazzo di Romilda con fuga di ca-mere». Varie le scene di accampamenti di soldati, quando nella «granpianura sotto Messina», quando in un «recinto in cui si era fortifica-to l’esercito di Ottaviano». La presenza degli eserciti rende necessarioportare in scena «su carriaggi le tende e il bagaglio del campo cesa-reo», oppure «approcci e macchine militari». Non manca la scena delgiardino, in questo caso quello «suburbano abitato da Ottaviano». Unanovità rispetto ai precedenti allestimenti è sicuramente rappresentatadalla scena finale che raffigura un «anfiteatro illuminato in tempo dinotte con trono e popolo spettatore»179.
Si tratta dell’ultima notizia sicura relativa ad una rappresentazionenel Teatro Secco Suardo. Tutto ciò che sappiamo in merito alla suademolizione si deve ad un breve accenno del poeta ed erudito Gio-van Battista Angelini, il quale nel 1720, descrivendo in terza rima lacittà di Bergamo, afferma che «per i teatri non è Bergamo sito. De’conti Suardi pur quello è distrutto ch’era de’ Teatini al tempio uni-to»180. Sconosciuto, per adesso, l’esatto momento in cui avvenne lademolizione, né il motivo. Una delle probabili ragioni è ravvisabilein un avvenimento che non interessò direttamente la città di Berga-mo: l’incendio del Teatro Salone Margherita di Milano nel 1708. Undisastro che determinò, tra l’altro, la decisione di chiudere il teatro diCrema per ricostruirlo in luogo più sicuro181. Considerando che la ver-tenza tra Monte di Pietà e famiglia Secco Suardo ruotava principal-mente intorno al pericolo rappresentato da un possibile incendio delteatro, l’avvenimento milanese non avrebbe potuto che rinfocolarevecchi rancori tra i due vicini.
178. Ottaviano in Sicilia (1695), in Cronologia.179. Ibidem.180. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 377.181. Cfr. Supra, p. 66.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 109
110
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Tra le ulteriori motivazioni possibili: la constatazione di un’impre-sa economicamente poco vantaggiosa e, non ultima, l’avversità di al-tre nobili casate bergamasche. La forte competizione tra le varie con-sorterie fu una delle cause principali di fallimento nella costruzionedi teatri a ragione collettiva. Per quanto riguarda Giuseppe Secco Suar-do, principale promotore dell’impresa, le ragioni di prestigio che ave-vano motivato l’iniziativa vennero ampiamente soddisfatte da ben al-tri incarichi. Dal 1707 fu, infatti, nominato «Provveditore ai Confinidel bergamasco», carica che lasciò solo nel 1734, un anno prima dimorire182. Un impegno ragguardevole che la Dominante assegnava so-lo a «sudditi di provata fedeltà», affidando loro la salvaguardia terri-toriale dello stato.183 Una mansione sicuramente strategica a Bergamo,città-avamposto della Repubblica, sia in tempo di guerra sia di pace.Una responsabilità ancor più rilevante se assunta, come nel caso delconte Secco Suardo, in piena guerra di successione spagnola.
3. Il potere della Dominante
3.1. Il Teatro della Cittadella e gli impresari costruttori (1757-1797)
La costruzione di edifici teatrali all’interno dei palazzi del potere,fenomeno che nelle città della Terraferma veneta era maturato tra ilXVI e il XVII secolo, a Bergamo – non avendo trovato ospitalità ne-gli spazi offerti dalle autorità cittadine – ebbe una parziale realizza-zione solo nel corso del Settecento grazie alla disponibilità degli am-bienti del Palazzo Prefettizio. Nonostante ciò, non siamo di fronte al-l’edificazione di teatri stabili, bensì provvisori. È per questo motivoche assegnare al cosiddetto Teatro della Cittadella una collocazione
182. La nomina di Giuseppe Secco Suardo a «Provveditore ai Confini del ber-gamasco» prodotta dal doge Luigi Mocenigo e indirizzata al podestà Paolo AntonioLabbia e al capitanio Michele Magno, risale al 6 dicembre del 1707 ed è conservatain ASSLu, Inventario. Serie I, 233. Del 16 dicembre 1734 è, invece, la domanda uffi-ciale di dimissioni del conte, il quale chiese di essere sostituito dal nipote Ludovicodi Carlo Secco Suardo in ASSLu, Inventario. Serie I, 234. Giuseppe Secco Suardo mo-rì prima del 10 marzo del 1735, data nella quale i rettori veneti dichiararono vacan-te la carica per la sua avvenuta scomparsa, ASBg, Antico Regime, Rettori Veneti, Regi-stri di Ducali, Serie 4, 1, 2, c. 270r.
183. M. Knapton, Le istituzioni centrali per l’amministrazione ed il controllo della Ter-raferma, in Venezia e le Istituzioni di Terraferma, Bergamo, 1988, pp. 35-56: 51.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 110
111
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
precisa all’interno del Palazzo del Capitanio, nel tentativo di ricostrui-re la sua struttura architettonica rimane per molti aspetti impresa ar-dua. Nel periodo in cui la definizione «Teatro di Cittadella» o «Teatrodella Cittadella» iniziò a comparire regolarmente nei libretti d’opera,ossia tra il 1757 e il 1796, non esisteva un luogo a ciò specificatamen-te adibito. L’edificio teatrale provvisorio in legno, detto anche «teatroamovibile», veniva costruito in sale di rappresentanza di volta in vol-ta destinate allo scopo o talvolta al centro del cortile stesso della Cit-tadella. Tra i primi a documentare quest’abitudine troviamo lo scien-ziato francese Jérôme de Lalande il quale, di passaggio a Bergamo nelcorso del suo viaggio in Italia, annotò i luoghi adibiti agli spettacoliteatrali cittadini, scrivendo che, in occasione della fiera, si costruiva-no edifici nel prato di Sant’Alessandro, mentre in inverno si utilizza-va il Palazzo del Capitanio:
Le temps le plus agréable pour Bergame est celui où l’on y tient la foire,dans le huit derniers jours du mois d’août e le commencement de sep-tembre. On costruit alors un théâtre aux environs de la foire. En hiver,quand il y a spectacle, c’est dans le palais du Capitanio Grande184.
Il nobile Giovan Giacomo Arrigoni nel 1786 ricordava come i tea-tri di legno in Città Alta fossero costruiti o «nel palazzo dell’eminen-tissimo capitanio o sotto il Palazzo Vecchio della città»185.
Sebbene non sia possibile attribuire una sala specifica del Palazzodel Capitanio al teatro, l’indagine può essere circoscritta ad alcuni luo-ghi potenziali. Nel complesso architettonico costituito dalla Cittadel-la si trovavano alcuni ampi saloni destinati a diversi usi, la cui primadescrizione si deve al catastico di Giovanni Da Lezze del 1596. Se-condo esso la piazza era
circondata da una parte verso il Colle Aperto dal pallazzo dove habital’ill.mo s.r Capitano, con due sale longe et spaciose et altre numerose etnobilissime stanze che cingono per le due parte di detta Cittadella, con
184. J. de Lalande, Voyage d’un françois en Italie, fait dans les années 1765 &1766,Venise, 1769, riportato in V. Zanella, Formazione di Bergamo moderna riepilogo delle vi-cende urbanistiche dal 1797 al 1951, in L’Urbanistica a Bergamo, Bergamo, 1962, pp. 37-109: 49-50.
185. La citazione è tratta da una lettera di Giovan Giacomo Arrigoni del 7 novem-bre 1786, riportata in F. Buonincontri, Il sistema teatrale a Bergamo, cit., pp. 68, 69-70.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 111
112
FRANCESCA FANTAPPIÈ
la cancellaria al piedi della scala maggiore et nell’altra parte l’officio del-la Cancelleria. Nell’altra parte poi vi abita il clar.mo Camarlengo et altrisuoi ministri del foro Capitanio186.
Una descrizione che coincide in linea di massima con quella repe-ribile in alcune piante della seconda metà del Settecento, sulla basedelle quali vediamo come la Cittadella fosse all’epoca suddivisa in dueparti: una riservata al capitanio e l’altra al camarlingo (fig. 12). En-trambe le aree non avevano sale di rappresentanza al piano terreno,mentre al primo piano della zona destinata al rettore veneto esisteva-no due grandi saloni. Sebbene un loro utilizzo a fini spettacolari siaaccertato con continuità solo dalla seconda metà del Settecento, l’ipo-tesi di un uso anteriore a questa data non è da escludere. Tra il 1667e il 1668, infatti, durante il governo del capitanio Pietro Dolfin, nelPalazzo Prefettizio furono ospitate le adunanze dell’Accademia degliAironi, sodalizio fondato dal rettore in carica e legato al suo patroci-nio. Purtroppo non sappiamo quali sale fossero destinate in questocaso agli incontri settimanali durante i quali, secondo un modello si-mile a quello delle adunanze degli Eccitati, si esercitavano la poesiae la musica187. L’uso del palazzo per l’allestimento dell’Annibale in Ca-
186. G. Da Lezze, Descrizione di Bergamo, cit., p. 129.187. La nascita dell’Accademia degli Aironi è ricordata da Donato Calvi (Effeme-
ride sagro-profana, cit., vol. III, p. 343) alla data 8 novembre 1667 nel modo seguen-te: «Reggeva in grado di capitanio la patria Pietro Dolfino, non meno per belle let-tere, che affabilità e cortesia singolare, quando voglioso convertir il palazzo suo inun atheneo & liceo di virtù, novella accademia vi fondò, e eresse con il titolo delliAironi, che per impresa recava un dolfino natante. Obbligò ciaschuno degl’accade-mici ad un breve discorso in prosa e una composizione poetica, e oggi ultima do-menica di novembre fecesi il primo congresso a cui li seguenti in qualità d’accade-mici intervennero. Andrea Valle, Antonio Lupis, Bartolomeo Facheris, Clemente Are-gazzolo, Filippo Biffi, Nicolò Biffi, Pietro Argo, Pietro Averara. Accademia che quan-to durò il reggimento del detto virtuosissimo capitanio continò e con la sua parten-za spirò». La stessa notizia, con lievi differenze, viene riportata in seguito: «8 dicem-bre 1668. Nel palazzo prefettizio, sotto l’indirizzo & opera dell’Ecc. Capitanio nonmeno delle virtù professore che de’ virtuosi amante Pietro Dolfino si diede ad unagentil’accademia detta delli Arioni nobil principio, ch’ogni settimana s’essercitava.Qui dopo il primo discorso sopra il quesito, già proposto da ciascun accademico al-tro breve discorsetto faveva nello stesso soggetto, e dopo qualche leggiarda poesiarecitava, framischiandosi da musici varie canzoni e ariette, con sommo diletto e so-disfatione di quanti vi concorrevano. Pochi erano gl’accademici, ma per virtù de’primi, e erano dott. Niccolò Biffi, Filippo Biffi suo fratello, dott. Bartolomeo Fache-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 112
113
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
pua e della Prosperità di Seiano nel Carnevale del 1668 è molto proba-bile anche se, allo stato attuale delle ricerche, purtroppo non accerta-bile188.
Ad uno di questi due saloni fa, verosimilmente, riferimento unasupplica presentata il 23 dicembre 1732 ai consigli municipali da unattore presente a Bergamo con la propria compagnia. Nella lettera «Pie-tro Vecchi romano comico» afferma di ritrovarsi «nella città di Berga-mo per esercitare ad uso comico con sua compagnia opere e comme-die» e di aver «per tale effetto presa la sala de’ rappresentadi, ov’in si-mil occasione ànn’altri rappresentato le lor comiche fatiche»189, lamen-tandosi però di aver dovuto interrompere le proprie recite. Erano, in-fatti, incorsi alcuni problemi in merito al contratto di locazione, do-vuti a presunte irregolarità seguite nella sua stipulazione: l’uso dellospazio gli era stato negato «con il giusto motivo che l’affittuario didetta sala non possi sublogare, senza espressa licenza de’ padroni di-retti»190. Ma cosa s’intende per «sala de’ rappresentadi»? A giudicaredal termine utilizzato potrebbe essere identificata con la «sala de’ rap-presentanti», uno spazio interno al palazzo che, nella rara documen-tazione prodotta dal capitanio a noi giunta, veniva considerato spe-cifico delle adunanze ufficiali191. Non esistono, però, prove ulterioriche confermino la supposizione. La risposta del Consiglio Minore diBergamo a Pietro Vecchi, seppur reperita, non chiarisce i numerosi dub-bi relativi alla vicenda. I deputati demandarono l’affare ai loro colle-ghi «ad locanda bona», ossia al Collegio delle affittanze192. La documen-
ris, Antonio Lupis, Dott. Pietro Argo, Pietro Averara, Clemente Aregazzolo, AndreaValle, & […] Benaglio. Durò l’accademia quanto durò nel reggimento il detto capi-tanio e con la sua partenza terminò», Ivi, p. 370.
188. Cfr. Supra, pp. 82-84.189. Documento 1732: 3, in Regesto.190. Ibidem.191. La desinenza «di» invece di «nti» è tipica del dialetto veneziano. La perdi-
ta massiccia dei documenti prodotti dalla carica del capitanio non ha purtroppo per-messo di provare l’ipotesi. Se, infatti, i cosiddetti Atti della Cancelleria pretoria, pro-dotti dal podestà, sono attualmente conservati in un fondo di circa centocinquantatra filze e registri, gli Atti della Cancelleria prefettizia, prodotti dal capitanio, ammon-tano a soli sette pezzi archivistici, dei quali quattro relativi al Quattrocento, uno sei-centesco e i due rimanenti della fine del Settecento. Le Ducali della cancelleria prefet-tizia sono tre, una del Seicento e le altre due del secolo successivo. Si rimanda inproposito all’inventario dei Rettori Veneti, depositato nella Biblioteca Angelo Mai.
192. Documento 1732: 4, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 113
114
FRANCESCA FANTAPPIÈ
tazione disponibile relativa a tale ufficio non contempla alcuna lette-ra in risposta alla supplica dell’attore. Tutto ciò non ha permesso dichiarire le modalità di affitto, né tantomeno le questioni relative allaproprietà della cosiddetta «sala de’ rappresentadi»193.
L’utilizzo degli spazi disponibili nell’area della Cittadella in epocaanteriore alla seconda metà del Settecento rimane in ogni caso mol-to probabile. La presenza del corpo militare del capitanio offriva, in-fatti, un’efficace garanzia per il mantenimento dell’ordine pubblico.La preoccupazione di un ingresso incontrollato in Città Alta di per-sone pericolose o sconosciute, con il pretesto di spettacoli notturni,era sempre presente. La scelta del luogo assicurava, quindi, la tran-quillità dei cittadini e, da parte dei rettori, la possibilità di esercitareuno stretto controllo sugli spettacoli e sul pubblico. La prima notiziasicura relativa ad un uso del cosiddetto «Teatro di Cittadella» risale alCarnevale del 1757, anno della messa in scena dell’opera buffa intito-lata Il filosofo di campagna con musica di Baldassare Galuppi. L’ultimarappresentazione accertata sono Gli artigiani di Giuseppe Maria Fop-pa con musica di Pasquale Anfossi. Tra questi due estremi cronologi-ci le rappresentazioni, sia musicali sia in prosa, furono costanti e re-golari.
Se le informazioni sulla struttura architettonica dei teatri provvi-sori sono scarse, più numerose sono quelle relative alle modalità diaffitto adottate da parte di coloro che si dichiaravano impresari-co-struttori degli edifici. Una documentazione che attesta come, anchese la struttura non rimaneva in essere per tutto l’anno, la proprietà deipalchetti e il correlato impiego erano vissuti in modo simile a quan-to succedeva per i teatri stabili, ossia con un’idea del tutto privatisti-ca del bene in questione. Il primo caso che illustra tale situazione èuna causa intercorsa tra i conti Cristoforo e Marc’Antonio VimercatiSozzi: con una scrittura privata del 24 gennaio 1775 i due nobili fra-telli stabilirono le regole da seguire in ordine al «dominio ed uso delpalco nel teatro tanto di Città che di Borgo posto nel primo ordineal numero 8»194. Per evitare inutili contese familiari venne assegnatoa ciascuno l’uso del palco a giorni alterni. Al conte Cristoforo «tuttele giornate pari in cui il teatro sarà aperto sì in Città che nel Borgo»
193. La ricerca è stata effettuata nel fondo conservato in ASBg, Antico Regime,Archivio Storico del Comune, Deputati e Collegio delle Affittanze.
194. Documento 1775: 3, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 114
115
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
e al conte Marc’Antonio «tutte le giornate dispari». Dal contratto ri-caviamo due dati importanti. Il primo è che i palchetti erano nume-rati. Il secondo, a ciò correlato, è che questo permetteva di conside-rarli come qualcosa di reale, rendendo possibile vietare ai due contra-enti di «affittare» o «alienar» a chiunque «la propria parte di detto pal-co senza l’assenzo del fratello, quale volendo doverà avere la prela-zione ed esclusione di qualunque altro»195. Poiché sappiamo che il tea-tro veniva ricostruito ogni volta, rimane in ogni caso una proprietàvirtuale, trattata come un bene fisico. Bisogna quindi pensare che esi-stesse un sistema di assegnazione dei palchetti di cui, purtroppo, nonconosciamo la procedura. Per poterla effettuare l’edificio doveva es-sere costruito in maniera sempre uguale e non subire variazioni di sor-ta. Ma come poteva accadere in considerazione della diversità di im-presari-costruttori riscontrati?
Una vertenza del Carnevale 1776 intercorsa tra Domenico Com-pagnoni e gli impresari associati del Teatro della Cittadella da una par-te, contro il munizioniere Giorgio Cadonici dall’altra, conferma alcu-ne delle acquisizioni già esposte196. La controversia ruota intorno al-l’assegnazione di un palchetto. Il funzionario militare pretendeva, in-fatti, il diritto «di avere libero l’ingresso dell’opera e di avere ancoraun palco egualmente senza spesa» per sé e per «tutta la di lui fami-glia», mentre gli impresari glielo negarono, ritenendo che dovesse pa-gare197. La causa seguì vicende alterne. Nelle sue fasi iniziali il pode-stà Francesco Correr assegnò la vittoria al Compagnoni, il quale af-fermava «non compettere ragione alcuna al detto signor Cadonici dipretendere il suddetto ingresso e palco gratis, ma abbia ad essere allacondizione di tutte le altre private persone»198. All’ordine del rettoresi sostituì però la sentenza di Girolamo Ascanio Molin avogadore delComun a cui il Cadonici ricorse presso il Tribunale di Venezia199. Inbase ad essa l’esponente militare vide riconosciuti i propri diritti nei
195. Ibidem.196. Domenico Compagnoni era ancora attivo nel primo decennio dell’Otto-
cento, quando lo troviamo direttore del Teatro Riccardi in un documento intitola-to Reclamo del direttore del teatro Riccardi Domenico Compagnoni per il comportamento in-decoroso e oltraggioso tenuto dall’officiale d’ispezione francese. 18 agosto 1809, BCBg, Sala32 C 8 25 4.11.
197. Documento 1776: 5, in Regesto.198. Ibidem e Documento 1776: 6, in Regesto.199. Documento 1776: 7, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 115
116
FRANCESCA FANTAPPIÈ
confronti dell’impresario, ottenendo da parte del tribunale venezia-no l’intimazione al rettore di ritirare la direttiva iniziale. Immediato,quindi, il contrordine del podestà, il quale si espresse a favore del Ca-donici e contro il Compagnoni, comunicando l’esecuzione del man-dato a Venezia200. Nonostante ciò gli impresari non si arresero e, pro-vando a far valere l’ordine originariamente emanato dal podestà in lo-ro favore, contestarono un tentativo di entrare in teatro operato dalCadonici, reo di aver approfittato del fatto che «era alla porta il soloportinaro»201. La causa passò quindi ai Capi del Consiglio dei Dieci.Questi sentenziarono che, nel caso che il «Compagnoni per nome suoet signori soci» avesse voluto ricorrere in giudizio, gli sarebbero staticoncessi quindici giorni. Nel frattempo però avrebbe dovuto attener-si all’autorità espressa dall’avogadore Girolamo Ascanio Molin202.
Non sappiamo come si concluse la vicenda né, alla luce della du-rata spesso estenuante delle cause che da Bergamo passavano a Vene-zia, possiamo giudicare quando terminasse. Esito che, in realtà, nonappare interessante quanto invece si dimostrano le informazioni sulsistema di teatri provvisori di Cittadella, ricavabili dalle dichiarazioniraccolte da Giorgio Cadonici a proprio favore. Secondo i testimonida lui chiamati, infatti, ogni volta che era stato costruito il teatro, lastruttura provvisoria aveva sempre previsto l’erezione di un palchet-to per il munizioniere. Lo «scontro munizioniere» Francesco Araldinella sua deposizione dichiarò che quest’uso si sarebbe attestato fin«dal anno 1759» e che «da tal anno sin oggi, il munizioniere, come iosottoscritto, à sempre goduto il teatro gratis tanto in Salone, come inCitadella, con di più un palco senza spesa veruna»203. Testimonianzaconvalidata da quella dell’ex munizioniere Giacomo Roberti, il qua-le affermò che «ogni volta che è stato fatto il teatro, tanto nel Salonequanto in Cittadella, è sempre stato dalli rispettivi signori impresaridell’opera o comedia dato un palco e porta gratis»204. Praticamenteidentica la dichiarazione di Maria Teresa Zoppa vedova del munizio-niere Giovan Battista205. L’ultima testimonianza a favore del Cadoni-
200. Documento 1776: 8-9, in Regesto.201. Documento 1776: 10, in Regesto.202. Documento 1776: 11, in Regesto.203. Documento 1776: 1, in Regesto.204. Documento 1776: 2, in Regesto.205. Documento 1776: 3, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 116
117
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
ci proviene da un precedente impresario. Si tratta di Antonio Dehe.Non un nome sconosciuto, ma lo stesso che insieme al fratello Naza-rio, nel gennaio del 1761, si era proposto come impresario-costrutto-re di un teatro di legno sotto la loggia del Palazzo della Ragione206.Quella dei due fratelli Dehe non era quindi un’attività occasionale,ma una vera e propria professione. In questo caso Antonio dichiaròche «nelli anni tre che sono stato impresario dell’opera nel teatro diCittadella o nel Salone Prefettizio di questa città ho sempre dato laporta libera» al pubblico munizioniere ed alla sua famiglia207. Tra tut-te le deposizioni è la più circostanziata. Non un salone qualunque,ma quello prefettizio, contrapposto ad un generico Teatro di Citta-della. Ma in cosa consisteva questa distinzione? Come interpretare unafrase che, in mancanza di documenti ulteriori, suona tanto ambigua?
Alcuni chiarimenti provengono dalle annotazioni contenute nel vo-lume che conserva la documentazione della causa. Sono appunti diFrancesco Maria Quarenghi:
Teatro di Cittadella, quando si fa nel salone, il munizionere con la suafamiglia pretende gratis l’ingresso ed il palco n.° 8 secondo ordine pre-vie lire 22 di canone. Atti diversi nati l’anno 1776 tra Giorgio Cadonicimunizioniere e Domenico, e compagni, Compagnoni impresari per li qua-li atti esso Cadonici si conservò in possesso208.
Veniamo così a sapere che il palchetto si trovava al numero ottodel secondo ordine del teatro «quando si fa nel salone». Ciò significache l’edificio poteva essere costruito anche in altri luoghi, oltre al sa-lone prefettizio, anche se questa soluzione appare la più frequente.Ancora nel 1786 troviamo l’avviso di un’accademia musicale «nellaSala del Capitaniato, la quale serve attualmente di teatro».209 L’uso re-
206. Per la richiesta, presentata da Nazario e Antonio Dehe e respinta dal Con-siglio comunale, cfr. Supra, p. 73. Faceva probabilmente parte della famiglia Scipio-ne Dehe, professore di canto e sacerdote, morto nel 1780 e autore dell’opuscolo 12dialoghi intorno al canto, Francesco Traina, Bergamo, 1761, sul quale si vedano G.Donati Petteni, L’arte della musica, cit.; P. Forcella, Musica e musicisti, cit., p. 62; G.S.Mayr, Biografie di scrittori e artisti musicali bergamaschi nativi od oriundi, Bergamo, 1875,p. 77.
207. Documento 1776: 4, in Regesto.208. Documento 1776: 5 e note, in Regesto.209. Documento 1786: 17, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 117
118
FRANCESCA FANTAPPIÈ
golare di uno dei due saloni al primo piano del Palazzo del Capita-nio è quindi confermato. Se tutto ciò chiarisce una parte dell’affer-mazione dell’impresario Antonio Dehe, non aiuta però a compren-dere l’altra. Perché contrapporre «il Teatro della Cittadella» al «Salo-ne Prefettizio»? Una possibile risposta risiede nell’ipotesi che l’edifi-cio provvisorio potesse essere costruito non solo sfruttando gli spaziinterni offerti dal palazzo, ma anche quelli esterni. L’area più proba-bile, in questo caso, è costituita dalla piazza, o cortile, al centro delcomplesso architettonico della Cittadella. Una scelta che non sareb-be comunque stata una soluzione isolata. Simili esempi, sebbene inperiodi molto diversi, sono riscontrabili a Padova e a Verona210.
Il sistema teatrale bergamasco che si veniva così a costituire era,però, costituzionalmente fragile: luoghi teatrali costanti, ma edificiprovvisori affidati ad impresari-costruttori periodicamente diversi.Una parziale normalizzazione si ebbe solo dal 1777. Il 3 settembre diquell’anno, infatti, l’impresario Giovan Battista Lombardi chiese alleautorità municipali un’esclusiva quindicennale per la costruzione deiteatri provvisori nelle due principali stagioni bergamasche. «Due tea-tri annualmente si eriggono in questa città, uno nel Carnovale, l’al-tro per la fiera», motivo per cui domandò «il diritto di detta erezio-ne, quando vi sia opera, a norma del solito prezzo per anni quinde-ci, obligandosi che una tale erezione» sarebbe stata «esequita nelle nor-me più caute e sicure» e con l’avallo dei Presidenti teatrali pro tempo-re211. La supplica fu approvata dal Consiglio Minore il giorno succes-
210. A Padova la «Corte del Capitanio» venne utilizzata per tornei e barriere apiedi (1605), F. Mancini, M.T. Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. III, cit.,pp. 91-93. A Verona il Teatro della Cittadella (1841-1846) e il Nuovo Teatro Diurnoin Cittadella (1861-1892), adibiti ad esercizi acrobatici e circensi, all’operetta e al va-rietà, trovarono luogo nella piazza omonima, Ivi, vol. II, cit. pp. 111-114. Per quan-to riguarda Bergamo alcuni indizi inducono a pensare che nel corso del Carnevaledel 1792 il teatro provvisorio fosse stato costruito nella piazza della Cittadella. Inoccasione delle opere buffe Il fanatico burlato e I due baroni di rocca azzurra, una notadi Francesco Maria Quarenghi registra l’esistenza di un avviso teatrale, purtropposcomparso, per pubblicizzare «una recita gratis li 27 genaro 1792 in sostituzione diuna stata per il tempo cattivo sospesa»: Documento 1791: 50, in Regesto. Riteniamoche fosse previsto l’uso del cortile, poiché l’annullamento di una rappresentazioneper brutto tempo è più probabile quando un teatro viene costruito all’aperto che inuna sala interna ad un palazzo.
211. Documento 1777: 3, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 118
119
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
sivo212. Il provvedimento seguiva di qualche settimana una deliberacomunale da cui emergeva la crescente preoccupazione in merito al-le norme di sicurezza da osservare nella costruzione degli edifici prov-visori. Vi si affermava, infatti, la necessità di «perizie circa la soliditàdella struttura de’ teatri» e si stabiliva che le spese fino ad allora «a ca-rico della Magnifica Città» avrebbero dovuto passare «a peso degli im-presari»213. Affidare ad una sola persona l’incarico della costruzionedi teatri provvisionali avrebbe dato, quindi, maggiori garanzie in talsenso.
Gli anni di attività di Giovan Battista Lombardi, riscontrabili neilibretti d’opera, coincidono in larga misura con quelli concessi dallaprivativa. Tra il 1773 e il 1790 fu il principale impresario di opere buf-fe rappresentate nel Teatro della Cittadella nel periodo di Carneva-le214. Più sporadica risulta la sua presenza fino al 1796, quando mol-to probabilmente gli succedette il figlio Antonio. Per quanto riguar-da la stagione della fiera la sua partecipazione, sebbene meno docu-mentata, appare continua215. Sia nel caso delle rappresentazioni inver-nali, sia di quelle estive siamo in possesso degli avvisi a stampa, coni quali Giovan Battista Lombardi divulgava il costo delle sottoscrizio-ni stagionali e dei singoli biglietti d’entrata. Possiamo così notare chei prezzi venivano stabiliti secondo una logica comune. Gli abbona-menti differenziavano «i signori di Città» dai «signori di Borgo» e dal-le «signore tanto di Città che di Borgo»216. Le gentildonne pagavanoindifferentemente 24 lire per l’intero corso delle recite programmate,ossia una quota minore rispetto a quella richiesta ai gentiluomini iquali, invece, pagavano in base alla loro domiciliazione. Se lo spetta-
212. Documento 1777: 4, in Regesto.213. Documento 1777: 2, in Regesto.214. Giovan Battista Lombardi risulta impresario a partire da Il cavaliere villano
(Carnevale, 1773) fino a Gli artigiani (1796). Si veda in proposito la Cronologia215. Opere buffe nel Teatro della Cittadella: Il cavaliere villano (1773), La buona
figliuola (1774), L’astratto overo il giocatore fortunato (1775), La virtuosa alla moda (1779),La vera costanza (1780), Il matrimonio per inganno (1782), I castellani burlati (1788), Lamodesta raggiratrice (1789), Il marito indiscreto (1789), Una cosa rara ossia bellezza ed one-stà (1790), Gli artigiani (1796), Le gelosie villane (1796). Opere serie ed opere buffe nelteatro di fiera: Il curioso indiscreto (1778), Erifile (1783), La molinara o l’amor contrasta-to (1790). Il Medonte (1783), ebbe come impresario Giuseppe Lombardi, violinista efratello di Giovan Battista. Per i riferimenti rimandiamo alla Cronologia.
216. Documenti 1780: 4; 1789: 44, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 119
120
FRANCESCA FANTAPPIÈ
colo si teneva in Città Alta, il canone maggiore, ossia lire 44, era a ca-rico degli abitanti di quest’area urbana, mentre i residenti della CittàBassa pagavano solo lire 37.10, per invogliarli al necessario spostamen-to, essendo più lontani dal luogo della rappresentazione. Se lo spet-tacolo aveva luogo nei Borghi il procedimento era esattamente oppo-sto. L’affitto dei palchetti era fisso e non faceva distinzioni: 90 lire pertutti i possessori. I biglietti d’entrata e quelli per uno «scagno» in pla-tea variavano leggermente: più economici durante il Carnevale rispet-to al periodo di fiera, quando era possibile fare affidamento su unamaggiore affluenza di spettatori forestieri.
Pur non conoscendo il numero di palchetti a disposizione dell’im-presario e come fossero disposti all’interno dei teatri di volta in vol-ta edificati, sappiamo tuttavia che erano numerati e disposti almenosu due ordini: nel 1775 i fratelli Vimercati Sozzi risultano in posses-so del palco numero otto del primo ordine e nel 1776 il munizionie-re Giorgio Cadonici del palco numero otto del secondo. Tra i posses-sori di palchetti in Cittadella vi era anche l’avvocato Francesco MariaQuarenghi, il quale negli anni Novanta risultava proprietario del nu-mero sedici secondo ordine217.
Per quanto riguarda il palcoscenico sono possibili alcune ipotesi. Cisono, infatti, giunte due preziose immagini relative ad un allestimentodel 1770 voluto dalla contessa Paolina Grismondi Secco Suardo, lette-rata e poetessa, attrice dilettante e accademica, conosciuta tra gli arca-di come Lesbia Cidonia (figg. 13-14). Dietro il disegno che rappresen-ta l’arcoscenico e il palco troviamo la seguente precisazione: «Teatrofatto fare in Cittadella dalla compagnia con cui unitamente recitò las[ignora] c[ontessa] Paolina Grismondi l’anno 1770»218. La figura si ri-ferisce ad un’esibizione patrocinata dalla nobildonna e da un gruppodi attori dilettanti a lei legati. Attesta, quindi, una delle varie versionidell’edificio. Le notizie che si possono ricavare dall’analisi del docu-mento sono molte. Il primo aspetto da mettere in evidenza riguarda la
217. Il palchetto venne definitivamente acquisito nel 1796: Documenti 1790: 1,11; 1793: 7; 1796: 1, in Regesto.
218. La frase si trova dietro il disegno conservato in BCBg, Bergamo Illustrata,Faldone 7, n.° 25. Nel repertorio che apre il faldone le immagini sono registrate sot-to la voce «Teatro fatto costruire da Lesbia Cidonia in Cittadella, 3 disegni sec. XVII».Il volume proviene da una collezione ottocentesca appartenuta al conte Paolo Vi-mercati Sozzi.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 120
121
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
tipologia della fonte: i numerosi appunti, lettere alfabetiche e numeri,indicano un disegno progettuale cui purtroppo non corrisponde piùalcuna legenda. Seguono osservazioni di tipo stilistico: le nicchie late-rali e le statue che ornano l’arcoscenico evidenziano un marcato gustoneoclassico. Uno stile estremamente raffinato e perfettamente al passocon i tempi, sicuramente dovuto alle indicazioni espresse dalla brillan-te committente. Ancora più notevole è, nella parte inferiore del dise-gno, la pianta del palco, dotato di sei quinte, tre per ogni lato, poste suun asse prospettico centrale (figg. 14-15)219. Dietro ogni quinta visibileerano poste due quinte retrostanti per i cambi di scena. Nello spazioestremamente ridotto del retropalco – che non presenta alcuna apertu-ra perimetrale, segno che gli attori dovevano passare attraverso la pla-tea per accedere alla scena – è riconoscibile un camerino segnato conla lettera G. Il palcoscenico e la platea sono collegati tramite scalette si-tuate a destra del proscenio e numerate con la lettera D. Infine, il dise-gno presenta la scala con le misure. Pur trattandosi di una semplice an-notazione posta al centro dell’immagine con l’indicazione «br. 18» enon indicando il sistema di misura usato, permette alcune valutazionisulle dimensioni della struttura. L’apertura del boccascena è la metà delpalco, ossia poco più di 9 braccia. Questo dimostra che il secondo di-segno, molto più semplice e scarno, non è altro che un particolare delprimo, con la funzione di suggerire una variante del frontone, oltre adare indicazioni sul sipario (fig. 13). In base alla scala ivi riportata no-tiamo, infatti, che il boccascena ha le stesse dimensioni di quello raffi-gurato nel primo disegno220.
Se il sistema di misura usato, come appare probabile, è quello del-le braccia bergamasche, il palcoscenico avrebbe avuto un’apertura di9,56 m, mentre il boccascena di circa la metà221. Un possibile stru-
219. La raffigurazione nella parte inferiore dell’immagine si riferisce al palco enon alla platea, come era stato erroneamente interpretato da L. Pelandi, Teatri scom-parsi, cit., p. 17.
220. L’attribuzione di questo disegno al Teatro della Cittadella era stata consi-derata incerta da Francesca Buonincontri (Il sistema teatrale, cit., p. 68), poiché la stu-diosa aveva notato una «notevole diversità di misure» tra le due figure.
221. Un «braccio da fabbrica» bergamasco corrispondeva a 0,531414 m, quellomercantile a 0,659319m. Il braccio milanese a 0,594936m. Quello veneziano a0,683396m (braccio da lana) e a 0,638721m (braccio da seta), A. Martini, Manualedi metrologia, ossia misure, pesi e monte in uso attualmente e anticamente presso tutti i popo-li, Torino, 1883, pp. 70, 350, 817.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 121
122
FRANCESCA FANTAPPIÈ
mento per stabilire le dimensioni del teatrino ligneo deriva dal con-fronto con la pianta del primo piano del Palazzo Prefettizio, nella qua-le sono riportate le misure dei due saloni in «scala di bracci di fabbri-ca bergamaschi» (fig. 12). Entrambe le sale presentano come lunghez-za del lato corto 19 braccia circa, attualmente 10 m, e potevano quin-di contenere l’edificio teatrale provvisorio senza alcuna difficoltà. Tut-tavia, secondo Francesca Buonincontri, le dimensioni del salone piùpiccolo – lungo circa 23 x 9,70 m di larghezza e alto circa 7,30 m –sarebbero quelle ottimali per la struttura rappresentata nei due dise-gni del 1770222.
La fine del Teatro della Cittadella coincise con quella del dominioveneto. Lo smantellamento dell’edificio costruito per il Carnevale del1797 venne messo in atto il 6 gennaio di quell’anno per ordine delcapitanio Alessandro Ottolini223. Da parte del rettore fu una decisio-ne disperata. Bergamo era sotto l’assedio dei francesi, arrivati in cittàdurante la notte di Natale. Spettacoli teatrali all’interno del fortilizioavrebbero permesso un facile accesso ai nemici in un luogo nevralgi-co per il mantenimento del potere militare sulla città. Fu così che, te-mendo l’attacco degli occupanti e le rappresaglie da parte della citta-dinanza favorevole ai francesi, il rettore in carica, prima dell’avvio del-la stagione invernale, chiese pressantemente agli Inquisitori di Statodi Venezia direttive «sollecite per ciò che spetta la sospensione del Tea-tro di Città posto nel mezzo di questo pubblico palazzo»224. La pro-posta alternativa fu l’uso del Teatro Riccardi, situato all’esterno dellemura venete, nel prato di Sant’Alessandro225. Una decisione che nonpassò senza polemiche. I primi a reclamare furono i costruttori-pro-prietari del Teatro della Cittadella di quell’anno, come principali dan-neggiati dalla demolizione dell’edificio. Si trattava dei nobili Vincen-zo Zanchi, Gaetano Pezzoli, Francesco Scotti e Ridolfo Longhi. I pri-mi tre, scaduto il monopolio di Giovan Battista Lombardi, erano en-trati in possesso dell’edificio già dal 23 dicembre del 1795, data di un
222. L’ipotesi è già formulata in F. Buonincontri, Il sistema teatrale, cit., p. 68, cuisi deve anche l’attribuzione delle dimensioni del salone.
223. Documento 1797: 1, in Regesto. Sulla distruzione del Teatro della Cittadel-la si veda anche G.B. Locatelli Zuccala, Memorie storiche di Bergamo dal 1796 alla finedel 1813, Bergamo, 1938, p. 7 e la Parte III. 2. 3 Il Teatro Riccardi alla fine della Repub-blica veneta (1791-1797) di questo libro.
224. Documento 1796: 33, in Regesto.225. Documento 1796: 32, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 122
123
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
atto attestante la restituzione di un «palco posto in detto teatro al nu-mero 16 secondo ordine verso il cortile» da parte di Giorgio Sozzi ai«nobili conte Vicenzo Zanchi, Gaetano Pezzoli, Francesco Scotti at-tuali proprietari del Teatro della Cittadella»226. La contesa tra i pro-prietari del teatro ed il rettore veneto non si limitò alle proteste perla distruzione dell’edificio. I quattro nobili bergamaschi, oltre a subi-re il danno, vennero successivamente indicati dallo stesso capitanioAlessandro Ottolini, in quanto «interessati e proprietari del teatromobile di legno ch’esisteva in un salone di questo Palazzo Prefetti-zio», come i principali mandanti dell’incendio che la notte del 12 gen-naio 1797 distrusse il Teatro Riccardi. Il movente dei presunti colpe-voli sarebbe stato impedire lo svolgimento delle rappresentazioni inuna stagione, quella di Carnevale, abitualmente assegnata al Teatro del-la Cittadella227.
Un caso politico quindi. La demolizione di un teatro e l’incendiodell’altro apparirono immediatamente collegati. Dopo la caduta del-la dominazione veneta il processo attivato dalla municipalità berga-masca individuò nel capitanio Ottolini il vero responsabile ed idea-tore della distruzione del Teatro Riccardi. La chiusura forzata dei dueteatri avrebbe seguito una logica precisa da parte delle autorità vene-ziane, volta ad impedire la temuta rivoluzione228. L’accusa nei con-fronti del rettore, sebbene frutto di un punto di vista parziale, appa-re verosimile. Si trattò solo dell’atto finale di un politica censoria checaratterizzò tutti gli anni Novanta, inaspritasi in particolare a partiredal 1796, con l’inizio della campagna napoleonica in Italia. Non a ca-so, nel mese di maggio, dopo l’entrata trionfante del generale Bona-parte nella vicina Milano, il capitanio Ottolini dette avvio ad un’ul-teriore intensificazione dei controlli su tutte le manifestazioni pub-bliche, spettacoli teatrali e loro interpreti. Tra le decisioni emblema-tiche la condanna ad un esilio forzato del “giacobino” Bortolo Ric-cardi proprietario del teatro stabile in fiera229.
Con la fine della dominazione veneta il teatro ufficiale della Cit-tà Alta non trovò più luogo nell’area della Cittadella. Per dieci anniquesta funzione venne ricoperta dal Teatro Cerri, costruito nella Sala
226. Documento 1795: 15, in Regesto.227. Documento 1797: 3, in Regesto.228. Documento 1797: 10, in Regesto.229. Cfr. Infra, pp. 234-235.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 123
124
FRANCESCA FANTAPPIÈ
del Palazzo della Ragione (1797-1806), dopo il cui smantellamento fuil Teatro Sociale che si impose definitivamente con questo ruolo.
3.2. Tra opera buffa, compagnie di giro e spettacoli accademici
Dal secondo Settecento, momento in cui si delinearono in manie-ra definitiva due stagioni teatrali cittadine, quella del Carnevale equella della fiera d’agosto, il teatro della Città Alta si aggiudicò la pri-ma, mentre il teatro dei Borghi la seconda. Sebbene il periodo inver-nale fosse quello generalmente più rinomato e prestigioso a livello na-zionale, vediamo che a Bergamo accadde il contrario: le rappresenta-zioni estive, soprattutto per quanto riguarda il settore musicale, ave-vano un programmazione più articolata ed impegnativa rispetto aquelle del Carnevale. Il teatro della fiera si specializzò, infatti, nell’ope-ra seria, mentre il Teatro della Cittadella nell’opera buffa, genere diampia diffusione, grazie non solo alla qualità dei personaggi rappre-sentati – ispirati alla vita reale e non più eroi tratti dalla storia grecao romana – ma anche per la maggior facilità di messa in scena deidrammi musicali derivante dal ricorso a mezzi espressivi modesti e adun cast ridotto. Il repertorio offerto dal Teatro della Cittadella non eraperò solo musicale, comprendeva anche rappresentazioni in prosa adopera di compagnie di attori professionisti, molto spesso provenien-ti dai teatri di Venezia, come quelle di Antonio Sacco, di Luigi Perel-li o di Carlo Battaglia. Infine, spettacoli accademici allestiti da grup-pi di attori dilettanti della nobiltà bergamasca, come nel caso di quel-li animati dalla contessa Paolina Grismondi Secco Suardo.
Il teatro musicale è documentato con continuità a partire dal Car-nevale del 1757, con l’opera buffa Il filosofo di campagna di Carlo Gol-doni musicata da Baldassare Galuppi, fino al 1796 con Gli artigiani diGiuseppe Maria Foppa musica di Pasquale Anfossi. All’interno di que-sto arco cronologico il teatrino della Cittadella ospitò alcune delle pro-duzioni più famose e ampiamente diffuse del periodo230. Tra gli anni
230. Per una bibliografia sull’opera buffa rimandiamo almeno a L. Bianconi, Ilteatro d’opera in Italia, Bologna, 1993, mentre per quanto riguarda l’organizzazionedel lavoro e l’interpretazione dei cantanti specializzati in questo genere teatrale a F.Piperno, Buffe e buffi (considerazioni sulla professionalità degli interpreti di scene buffe ed in-termezzi), in «Rivista italiana di musicologia», XVII (1982), pp. 240-284 e G. Cicali,Attori e ruoli nell’opera buffa italiana del Settecento, Firenze, 2005.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 124
125
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
Cinquanta e Settanta del Settecento, quando come librettista domi-nava incontrastato il Goldoni, spicca tra tutte la Buona figliuola (1774)musicata dal napoletano Niccolò Piccinni, adattamento della Pameladi Richardson ed opera di straordinario successo sia in Italia sia in Eu-ropa231. In questo stesso periodo è accertata l’attività di due scenogra-fi locali: Giovanni Maria Giussani e Giacomo Rodegario “d’Albino”232.
Grazie al Teatro della Cittadella arrivò a Bergamo la scuola napo-letana al completo e non solo233. Oltre ai già citati Galuppi, Piccinnie Anfossi, troviamo compositori come Domenico Fischietti, GiovanBattista Lampugnani, Luigi Caruso, Domenico Cimarosa, VincenzoFabrizi, Giovanni Paisiello, Giuseppe Gazzaniga, Pietro Guglielmi,Vincenzo Martini, Giuseppe Sarti. La maggior parte delle opere buf-fe messe in scena erano produzioni sperimentate, i cui primi allesti-menti erano stati tenuti generalmente a Venezia, o talvolta a Bolognae a Milano, pochi anni prima. Anche in questo caso, come osservatonel secondo Seicento, assistiamo ad un vero e proprio fenomenod’importazione.
In merito alle modalità di programmazione si può notare che nelcorso del tempo l’offerta annuale degli spettacoli musicali aumentòin maniera progressiva. Se in principio veniva rappresentata una solaopera per ogni Carnevale, dagli anni Ottanta del secolo iniziarono adessere due a stagione. Il primo esempio si riferisce al 1782, quandovennero messi in scena Gli amanti canuti di Carlo Lanfranchi Rossi,musica di Pasquale Anfossi, e L’Italiana in Londra di Giuseppe Petro-sellini, musica di Domenico Cimarosa. Nel 1788 il numero delle rap-presentazioni registrato in un anno sale addirittura a quattro. Le dueopere di Carnevale furono I Castellani burlati e Le Gelosie fortunate diFilippo Livigni, cui seguirono in primavera Le trame deluse di Giusep-
231. L. Bianconi, Il teatro d’opera, cit., p. 60. Le opere buffe rappresentate in que-sto periodo nel Teatro della Cittadella, oltre a quelle già citate, furono La ritornatadi Londra (1758), Il mercato di Malmantile (1758), Il conte Chicchera (1763), La scaltra let-terata (1764), L’astratto ovvero il giocatore fortunato (1775), La virtuosa alla moda (1779),per le quali si rimanda alla Cronologia.
232. Giovanni Maria Giussani fu lo scenografo del Filosofo di campagna (1757) edel Conte Chicchera (1763), sicuramente tenute nel Teatro della Cittadella, oltre chedell’Artaserse (1755) e L’Amante di tutte (1762). Giacomo Rodegario fu lo scenografodella Ritornata di Londra (1758) e del Mercato di Malmantile (1761), rappresentati nelTeatro della Cittadella, oltre che dell’Antigono (1754). Si veda la Cronologia.
233. L. Pilon, Il teatro della Società, cit., p. 7 e ss.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 125
126
FRANCESCA FANTAPPIÈ
pe Maria Diodati ed uno spettacolo composto da due farse intitolateIl Capriccio drammatico ed il Convitato di Pietra ossia il don Giovanni234.Oltre ai già citati Rossi, Petrosellini, Diodati e Livigni gli autori docu-mentati tra gli anni Ottanta e Novanta sono Giovanni Bertati, Loren-zo Da Ponte, Giuseppe Palomba, Giambattista Lorenzi235.
L’elemento di richiamo per il pubblico non era rappresentato sol-tanto da un repertorio costantemente rinnovato, costituito da tramedi sicuro successo e opere di autori e compositori di fama, ma anche,e soprattutto, dalla composizione del cast proposto. L’opportuna di-vulgazione degli interpreti era una delle principali operazioni messein campo dagli impresari per attirare il maggior numero di spettatori.Come in altri teatri della provincia veneta, anche nel Teatro della Cit-tadella venivano organizzate serate a favore dei singoli artisti, in par-ticolare delle cantanti e delle ballerine. Il 5 aprile del 1788, ad esem-pio, l’incasso della rappresentazione delle Trame deluse, fu devoluto al-la ballerina Rosa Masan la quale, oltre ad esibirsi nel corso degli in-termezzi danzati, annunciava l’esecuzione di «un nuovo ballo rappre-sentante la morte di Pulcinella, con nuovo Padedù eseguito alla pro-venzale dalla signora Geltrude Gallazi e Masan sudetta in abito da uo-mo» da tenersi alla fine dello spettacolo236. Il 26 aprile a Camillo eVittoria Bastianelli, primo buffo e seconda donna, che cantaronoun’aria intitolata Il maestro di musica tedesco che dà lezione ai gatti237. Perquanto riguarda il Carnevale del 1789, in occasione delle due operebuffe Il marito disperato e La modista raggiratrice, sono molti gli avvisia noi giunti, nei quali si promuovono serate musicali in favore deisingoli interpreti: il 24 gennaio l’incasso venne devoluto alle balleri-ne Teresa Sedini e Margherita Albertini, il 3 febbraio al primo grotte-
234. Si veda la Cronologia.235. Tra le rappresentazioni documentate negli anni Ottanta e Novanta trovia-
mo L’Italiana in Londra (1782), Gli amanti Canuti (1782), Il matrimonio per inganno(1783), Il pittor parigino (1785), Le gelosie villane (1786), I castellani burlati (1788), Le ge-losie fortunate (1788), Il capriccio drammatico ed il Convitato di Pietra ossia il don Giovan-ni (1788), Le trame deluse (1788), Il marito disperato (1789), La modista raggiratrice (1789),Una cosa rara ossia bellezza ed onestà (1790), I viaggiatori felici (1790), I zingari in fiera(1791), Tra i due litiganti il terzo gode (1791), Il fanatico burlato (1792), Nina o la pazzaper amore (1794), La virtuosa bizzarra (1794), Il matrimonio segreto (1795), Gli artigiani(1796), Le gelosie villane (1796). Per i libretti si rimanda alla Cronologia.
236. Documento 1788: 8, in Regesto.237. Documento 1788: 14, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 126
127
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
sco Salvatore La Ros, il 12 al primo ballerino Pietro Giudice, il 18 aicantanti Domenico Madrigali primo buffo e Rosa Madrigali primadonna, il 20 alla cantante Teresa Giurini seconda donna238. In segui-to alle esibizioni venivano spesso redatti componimenti poetici da par-te degli spettatori che li offrivano agli artisti da loro favoriti. Nel 1789si registrano sonetti in lode di Domenico e Rosa Madrigali (18 feb-braio) o di Teresa Giurini (20 febbraio)239. Un’altra forma di omaggiopoteva essere un contributo finanziario all’allestimento delle rappre-sentazioni, come avvenne il 20 febbraio, quando il nobile FrancescoMaria Quarenghi risarcì l’impresario Antonio Lombardi per le spesed’illuminazione del teatro in occasione della serata dedicata a RosaMadrigali240. Ulteriori serate in onore di singoli artisti si registrano nelCarnevale del 1790 con la rappresentazione delle opere buffe Una co-sa rara ossia bellezza ed onestà e I viaggiatori felici. Tra coloro che si ag-giudicarono le attenzioni particolari del pubblico troviamo le cantan-ti Antonia Viscardini e Teresa Oltrabelli, i ballerini Assunta Sassoni,Livia Maffei e Giovacchino Mari241.
Se i documenti relativi a serate in onore di singoli interpreti riguar-dano solo gli anni tra il 1788 e il 1790, ciò non significa che questiepisodi fossero isolati. Si trattava di una formula consolidata che co-stituiva la norma non solo nel caso di opere buffe, ma anche di spet-tacoli in prosa e in genere di tutti quelli tenuti nei teatri di fiera. Il fe-nomeno del divismo non fu una peculiarità della città di Bergamo,ma riguardava anche gli altri teatri della provincia veneta, tanto da pro-vocare la condanna morale dei benpensanti nel caso di una sua dege-nerazione. È quanto successe nel Teatro Dolfin di Treviso, secondouna relazione riportata dal conte Sebastiano Benincasa agli Inquisito-ri di Venezia il 14 luglio 1792. Secondo il nobile delatore «nei teatribuffi della provincia» era ormai abituale assistere ad un atteggiamen-to indecoroso delle «donne di scena» che avrebbe provocato le sgua-iate reazioni del pubblico maschile:
Oso unicamente indicar con rispetto un disordine che generalmente, piùo meno tollerato nei teatri dello stato, nel piccolo teatro Dolfin adessooltrepassa i termini della facile indulgenza. (…) La poca o nessuna cura
238. Documenti 1789: 1, 3, 6, 8, 10, in Regesto.239. Documenti 1789: 9, 12-13, in Regesto.240. Documento 1789: 11, in Regesto.241. Documenti 1790: 2, 3, 8-10, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 127
128
FRANCESCA FANTAPPIÈ
che usa tra noi massimamente sui piccoli teatri dell’opera buffa in gene-re, di esterna e pubblica decenza e polizia, è addirittura scandalosa (…).Succedono spesso delle sguaiataggini rumorose ed indecenti tra le don-ne di scena e certa gioventù sbordellata dei palchi e della platea (…). Ilpermettere l’accesso generale alle scene ed il trascurare le picciole disso-lute irregolarità delle attrici che dimenticano il proprio dovere ed il ri-spetto dovuto al pubblico sono le ragione del vergognoso parapiglia chevediam nei teatri buffi della provincia242.
Il Teatro della Cittadella, provvisorio o meno, consentì quindi cheanche a Bergamo avessero luogo fenomeni sociali ampiamente dif-fusi, caratteristici della fruizione dello spettacolo da parte del pub-blico italiano settecentesco. La principale attrazione per gli spettato-ri bergamaschi, come nel resto d’Italia, non sembra fosse costituitadall’opera proposta, ma dalla presenza dei singoli interpreti, per iquali si scrivevano sonetti, lanciati poi dai palchetti, e nascevano par-titi contrastanti all’interno dell’uditorio che acclamavano l’artistaamato o protestavano rumorosamente contro quello odiato. Una pe-culiarità rimarcata, in maniera concorde, dai viaggiatori stranieri se-condo i quali «gli spettatori italiani (…) non si curavano affatto del-l’illusione teatrale e invece di applaudire l’opera, acclamavano que-sto o quel cantante, o questo o quell’attore»243. Tutto ciò non impe-dì al teatrino situato nel Palazzo del Capitanio di offrire una pro-grammazione di tutto rispetto, al passo con quella offerta dalle altrecittà della Terraferma. Tra le opere di grande successo allestitevi ne-gli anni Novanta troviamo Tra i due litiganti il terzo gode musicata daGiuseppe Sarti, una versione dell’opera buffa goldoniana La buonafigliuola approntata per il Teatro della Scala nel 1782 e arrivata a Ber-gamo nel Carnevale del 1791244. Seguì nel 1794 la Nina o la Pazzaper amore, opera dalla trama sentimentale tratta dal francese con mu-sica di Giovanni Paisiello, e nel 1795 Il Matrimonio segreto opera di
242. Referta fatta agli Inquisitori della Repubblica di Venezia dal loro confiden-te Sebastiano Benincasa intorno alle condizioni del Teatro Dolfin, ASV, Inquisitoridi Stato, b. 551, Treviso 14 luglio 1792, documento riportato da F. Mancini, M.T.Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. IV, cit., p. 81.
243. G. Guccini (a cura di), Il teatro italiano nel Settecento, Bologna, 1988, pp.22-29.
244. Sulla derivazione dei Fra i due litiganti il terzo gode dalla La Buona figliuolagoldoniana si veda L. Bianconi, Il teatro d’opera, cit., p. 61.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 128
129
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
estremo successo con musica di Domenico Cimarosa rappresentataper la prima volta a Vienna nel 1792245.
Grazie al Teatro della Cittadella si diffuse infine anche un’altra tipo-logia di spettacolo: quello in prosa. L’arrivo delle compagnie di girorappresentava, infatti, un momento socialmente importante, al pari diquanto succedeva nel caso degli interpreti del teatro musicale, quali can-tanti e ballerini. Le formazioni di attori professionisti registrate a Ber-gamo nel secondo Settecento sono molte, anche se solo in rari casi èstato possibile stabilire con certezza il luogo delle rappresentazioni. Cio-nonostante sono delineabili alcune consuetudini: gli attori erano nor-malmente presenti nei mesi primaverili e/o estivi, mentre solo dagli an-ni Novanta si aggiunse una stagione autunnale. Da quel momento glispettacoli in prosa diventarono una sorta di intervallo rispetto alle benpiù prestigiose stagioni musicali, costituite da opera buffa (Carnevale,Teatro della Cittadella) e opera seria (fiera d’agosto, teatro dei Borghi).Le compagnie potevano essere di vario tipo e provenienza, sebbene siaevidente una prevalenza delle formazioni attive nei teatri veneziani.Queste avevano l’abitudine di spingersi nella Terraferma veneta nei pe-riodi meno redditizi dell’anno comico, riservandosi la stagione inver-nale e quella del Carnevale a Venezia246. Anche se le notizie in meritoai luoghi usati per le rappresentazioni in prosa sono frammentarie, pos-siamo formulare la seguente ipotesi: poiché a Bergamo i teatri veniva-no costruiti e disfatti periodicamente, è più probabile che nei mesi suc-cessivi al Carnevale, ossia la primavera e i primi mesi d’estate, gli atto-ri usassero il Teatro della Cittadella; in estate inoltrata e in autunno ave-vano invece a disposizione il teatro dei Borghi.
Nel Teatro della Cittadella si esibirono sicuramente la compagnia diAntonio Sacco (aprile-giugno 1772), quella di Luigi Perelli (1, 9 e 10agosto 1788) e quella di Carlo Battaglia (aprile-maggio 1789) ossia al-cune delle formazioni più rinomate dell’epoca247. In merito alle rappre-
245. Per una sintesi delle numerose traduzioni e riedizioni della Nina pazza peramore si veda F. Bascialli, Opera comica e opéra comique al teatro Arciducale di Monza(1778-1795), Lucca, 2002, p. 14 e ss., cui rimandiamo anche per la bibliografia.
246. P. Bosisio, Goldoni e il teatro comico, in Storia del teatro moderno e contempora-neo. Il grande teatro borghese. Settecento-Ottocento, Torino, 2000, pp. 137-188: 139.
247. Su Carlo Battaglia e la compagnia da lui diretta rimandiamo alla voce diChiara Bettinelli dedicata all’attore in A.M. Testaverde, Prime attrici e primi attori. Sto-rie di attori lombardi fra Settecento e Ottocento, ricerca storica di C. Bettinelli e M. Gor-la, Bergamo, 2007, pp. 23-26.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 129
130
FRANCESCA FANTAPPIÈ
sentazioni della prima, le notizie a nostra disposizione sono di caratte-re epistolare. Sulla base di queste sappiamo che gli attori furono pre-senti a Bergamo dal mese di aprile fino a giugno e che da lì erano di-retti a Milano248. Oltre al capocomico Antonio Sacco, in arte Arlecchi-no, facevano parte della troupe Angela Vitalba, Francesco Bartoli e, co-me prima attrice, la moglie di quest’ultimo Teodora Ricci249. Nel reper-torio erano previsti alcuni “cavalli di battaglia” della compagnia, trattidall’opera drammaturgica di Carlo Gozzi, tra cui spiccano il prologoteatrale La caduta di donna Elvira e la tragicommedia La punizione nelprecipizio250. Interprete principale Teodora Ricci, la quale da metà giu-gno venne sostituita da Angela Vitalba, non potendo continuare le rap-presentazioni a causa di uno stato avanzato di gravidanza. A Bergamonacque, infatti, una delle figlie dei coniugi Bartoli, tenuta a battesimoper procura dallo scrittore Carlo Gozzi amante di Teodora Ricci251. Tra
248. La lettera scritta da Teodora Ricci a Carlo Gozzi, il 18 aprile 1772 da Ber-gamo è riportata in M. Gorla, Cinque lettere di Teodora Ricci a Carlo Gozzi, in M.G.Cambiaghi (a cura di) Studi gozziani, Milano, 2006, pp. 107-132, saggio in cui è pub-blicato integralmente il carteggio tra l’attrice e lo scrittore, conservato nella Raccol-ta Gamba della Biblioteca del Museo Civico di Bassano del Grappa. La lettera diFrancesco Bartoli a Carlo Gozzi, scritta da Bergamo il 13 giugno 1772, è invece edi-ta da P. Molmenti, Carlo Gozzi inedito, in «Giornale Storico della Letteratura Italia-na», LXXXVII (1926), pp. 36-73: 63-64.
249. Sono gli anni in cui i coniugi Bartoli fecero parte della rinomata compa-gnia per la quale si rimanda a O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., pp. 256-259,alle Memorie inutili di Carlo Gozzi e alle voci biografiche dedicate agli attori dellaformazione da F. Bartoli, Notizie istoriche de’ comici italiani, cit.
250. Sia il prologo che la tragicommedia sono pubblicate in C. Gozzi, Opere,vol. IV, Venezia, per il Colombani, 1772, p. 175 e ss. L’autore definisce La caduta didonna Elvira come un «prologo tragico» tratto da un’opera spagnola, incentrato sullavicenda di una «regina incinta oppressa» (autore don Giovanni di Matos Fragoso),da lui ridotto ad una forma drammatica, inserendo vari personaggi: Donna Elvira,Don Sancio, Don Raimondo, Don Ramiro, Beltramo. Il prologo introduce la tragi-commedia La punizione nel precipizio, con i seguenti personaggi: Don Sancio, Don-na Elvira, Alfonso, Don Roderigo, Don Raimondo, Don Ramiro, Donna Bianca,Giovanni, Smeraldina, Pantalone, Tartaglia, Truffaldino. Entrambe le opere sarebbe-ro state rappresentate per la prima volta dalla compagnia di Antonio Sacco al Tea-tro Sant’Angelo il 30 gennaio 1768.
251. Nel corso della permanenza a Bergamo l’attrice dette alla luce una bambi-na che venne tenuta a battesimo per procura dal Gozzi tramite Antonio Sacco. Fi-nite le rappresentazioni gli attori passarono a Milano, dove figurano almeno dal me-se di agosto, F. Bartoli, Notizie istoriche de’ comici italiani, cit., vol. II, p. 81; C. Goz-zi, Memorie inutili, cit., vol. II, p. 101; M. Gorla, Cinque lettere, cit., p. 125.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 130
131
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
le altre opere in repertorio troviamo La principessa filosofa di Carlo Goz-zi e La Virginia di autore ignoto252.
La documentazione relativa alla permanenza bergamasca dellatroupe mette in evidenza almeno due caratteristiche peculiari della si-tuazione cittadina: la difficoltà di raggiungere il sito e la mancanzadi un teatro stabile. Il primo dato si ricava da una lettera scritta daTeodora Ricci a Carlo Gozzi il 18 aprile. Nella missiva l’attrice, co-me altri prima e dopo di lei, si lamenta delle difficoltà superate perraggiungere Bergamo, dichiarando di esservi arrivata «dopo venti tregiorni di inquietissimo viagio» e dopo aver passato «cinque giornifermi a Pontevico, non potendo partire per non ritrovare comodo»;una situazione così malagevole che suo marito aveva dovuto «fareventi miglia a piedi» fino a Brescia per «fermare il legno» con cui ri-partire e giungere a destinazione253. Il secondo è riscontrabile in unadelle opere erudite di Francesco Bartoli: la famosa descrizione di Ber-gamo del 1774 dedicata al nobile Giacomo Carrara, nella quale l’at-tore dà conto delle maggiori opere artistiche cittadine.254 Un’operache costituirà un modello per altre redatte dallo stesso Bartoli a pro-
252. Si veda la lettera di Francesco Bartoli riportata da P. Molmenti, Carlo Goz-zi inedito, cit., pp. 63-64.
253. M. Gorla, Cinque lettere, cit., pp. 123-124. Sulle difficoltà logistiche da su-perare per raggiungere Bergamo da Pontevico si veda anche la lettera dell’attore Odar-do Palazzi a Ippolito Bentivoglio, 12 giugno 1672, in S. Monaldini, L’orto dell’Espe-ridi, cit., p. 274.
254. F. Bartoli, Le pitture, sculture ed architetture delle chiese e d’altri luoghi di Berga-mo, cit. L’autore afferma che l’idea del lavoro era nata in occasione della tournée: «di-ligente ricercatore qual io mi sono delle cose più d’Italia, anche in Bergamo pur giun-si coll’occasione di esercitarvi la comica mia professione». Le sue lettere a GiacomoCarrara, patrocinatore dell’opuscolo, confermano che il periodo in cui prese corpoil progetto fu quello della primavera del 1772, cfr. A. Pinetti, Francesco Bartoli comi-co ed erudito bolognese e la prima guida artistica di Bergamo, in «Bollettino della CivicaBiblioteca di Bergamo», X (1916), fasc. 4, pp. 157-186: 165. La guida turistica di Ber-gamo del Bartoli si apre con un’immagine che ricorda molto da vicino una sceno-grafia teatrale. Secondo Angelo Pinetti la figura, che sarebbe stata realizzata utiliz-zando un’antica incisione del 1618, rappresenta in maniera idealizzata la città di Ur-bino. Secondo P. Serra (a cura di), Antiche stampe di Bergamo, Bergamo, 1982, vol. I,fig. 85, che riproduce l’immagine, si tratterebbe invece di una veduta prospettica divia Corsarola, con la torre d’ingresso della Cittadella sullo sfondo. In primo pianosi notano due personaggi in abito cinquecentesco che conversano amabilmente esotto di essi la seguente didascalia: «Per Colleon questa notturna festa, grata al di luivalor, Bergamo appresta».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 131
132
FRANCESCA FANTAPPIÈ
posito di altre città dell’Italia settentrionale, tra le quali figura anchequella su Rovigo, in cui è contenuta un’accurata descrizione del Tea-tro Manfredini255. Nel caso di Bergamo le opere artistiche ricordatesono quadri, palazzi e chiese. Manca, però, qualsiasi riferimento adun edificio teatrale.
Se la permanenza della compagnia Sacco è iscritta in un periododell’anno, normalmente destinato all’esibizione degli attori profes-sionisti, ossia la primavera, quella della compagnia Perelli è invecemolto breve e appare come un evento del tutto straordinario. La no-tizia delle loro esibizioni è contenuta nell’Indice de’ teatrali spettacolidi tutto l’anno dalla primavera 1788 a tutto il Carnevale 1789 nel quale,dopo aver dato conto delle opere buffe programmate nel Teatro del-la Cittadella, si registra che «nel suddetto teatro fece tre rappresen-tazioni la compagnia comica italiana diretta dal sig. Luigi Perelli perconto ed ordine di S. Eccellenza il sig. conte Valmarana capitaniodi Bergamo, cioè nel giorno 1, 9, 10 agosto 1788»256. Un breve ciclodi esibizioni, quindi, voluto espressamente da uno dei rettori in ca-rica. Non si trattò dell’unica compagnia presente a Bergamo nel 1788.Tra i mesi di giugno e luglio aveva recitato in città la formazioneMarchesini-Cicuzzi, meno rinomata, ma ciononostante munita diun repertorio degno di attenzione, al quale non siamo in grado diassegnare con sicurezza un luogo per gli allestimenti257. L’alta con-centrazione di spettacoli tenuti, sia nel teatro sia nel cortile della Cit-tadella, tra il periodo di Carnevale e il mese di agosto del 1788, por-ta però a pensare che anche questa compagnia avesse usufruito de-gli spazi concessi dal Palazzo del Capitanio258. In questo caso il car-tellone offerto al pubblico dalla compagnia Marchesini-Cicuzzi pre-vedeva una «commedia lagrimosa» di grande successo come L’amo-re irritato dalla difficoltà o sia Teresa e Claudio di Giovani Greppi, cosìcome commedie dell’«erudita penna di don Francesco Sangro deiprincipi di San Severo», tra le quali Il fanatismo alla berlina, definitanella locandina come «una commedia di carattere», e La donna ar-
255. F.S. Bartoli, Le pitture, sculture ed architetture di Rovigo, cit.256. Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1788 a tutto il Carne-
vale 1789, in R. Verti (a cura di), Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 722.257. Si veda la Cronologia.258. Per un’idea degli spettacoli patrocinati dal rettore Leonardo Valmarana nel
1788 rimandiamo alla Cronologia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 132
133
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
chibugier francese (figg. 16-17)259. Né mancarono «le maschere», previ-ste ne La favola del Corvo di Carlo Gozzi. L’intento dichiarato negliavvisi era quello di risvegliar «commozione e stupore negli animi sen-sibili e delicati», ma allo stesso tempo offrire intrecci e testi graditiad «un pubblico scientifico»260.
Se l’interesse del capitanio Leonardo Valmarana verso la compa-gnia Perelli non fu stimolato dal desiderio di assistere a spettacoli inprosa, già ampiamente elargiti dalla formazione Marchesini-Cicuzzi,fu verosimilmente dettato da altre motivazioni, e più in particolareda una precisa predilezione: nella compagnia Perelli dell’anno comi-co 1788-1789 era presente la giovane attrice Luigia Belloni. Non è quin-di un caso se la compagnia che si esibì nel Teatro della Cittadella tral’aprile e il maggio del 1789 fu quella di Carlo Battaglia. Dall’annocomico 1789-1790, infatti, Luigia Belloni era entrata a far parte di que-sta formazione, detenendo il ruolo di «prima attrice» e costituendo ilprincipale elemento di richiamo per tutto il corso delle rappresenta-zioni tenute a Bergamo261. Il nucleo principale di documenti relativialla permanenza bergamasca della compagnia è contenuto nella col-lezione di bandi intitolata Ducali ed altre cose diverse di Francesco Ma-ria Quarenghi che, purtroppo, risulta in molte parti mutila. La noti-zia dell’arrivo degli attori si ricava da una semplice nota di repertorioche apre uno dei volumi della raccolta: alla lettera B troviamo «Bat-
259. L’amore irritato dalla difficoltà o sia Teresa e Claudio fa parte, insieme a Teresavedova e Teresa e Wilk, della cosiddetta trilogia di Teresa, opera di Giovanni Greppi,arcade, accademico, autore drammatico e poeta di compagnia. Ispirata ad un argo-mento tratto dai romanzi di Richardson è uno degli esempi più famosi di produzio-ne italiana sul filone della «commedia lagrimosa». Fu rappresentata per la prima vol-ta a Venezia nel Teatro San Luca dalla compagnia Perelli. Si vedano G. Pastina, Gio-vanni Greppi, in Enciclopedia dello Spettacolo, cit., vol. V, coll. 1728-1729 e L. Rodler,Giovanni Greppi, in Dizionario biografico degli italiani, vol. 59, pp. 326-328. Sotto ilnominativo Francesco di Sangro si nasconde, invece, l’autore drammatico France-sco Avelloni, uno dei principali protagonisti della diffusione del genere teatrale del-la comèdie larmoyante in Italia, cfr. C.M. Tanfani, Francesco Avelloni, in Enciclopedia del-lo Spettacolo, cit., vol. I, coll. 1175-1176.
260. Documenti 1788: 24, 26-27.261. Per il ruolo di «prima attrice» si rimanda al Documento 1789: 26, in Rege-
sto. La Belloni entrò a far parte della compagnia nell’anno comico 1789-1790. Primadi lei, nel ruolo di «innamorata a vicenda» con Maddalena Battaglia, troviamo Teo-dora Ricci (dall’anno comico 1782-1783 all’anno 1787-1788), O. Giardi, I comici del-l’arte perduta, cit., pp. 102-104.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 133
134
FRANCESCA FANTAPPIÈ
taglia compagnia comica del Teatro di San Giovanni Grisostomo diVenezia, invito a trenta recite nel Teatro di Cittadella 13 aprile 1789con la distinta della spesa dei palchi, accordi e biglietto serale a carte193»; alla lettera T il rimando alla stessa notizia: «Teatro di Cittadel-la incomincia la comedia dì 13 aprile 1789 la compagnia comica Bat-taglia con il prezzo dei abbonamenti e dell’ingresso serale a carte193»262. L’avviso contenuto alla carta 193 del volume è mancante. Nonconosciamo, quindi, il prezzo dei biglietti o degli abbonamenti al cor-so di recite programmate. Sappiamo però che le rappresentazioni ini-zialmente previste erano trenta e che venne dato inizio alle esibizio-ni il 13 aprile del 1789.
La frustrazione derivata dalla mancanza di questo specifico docu-mento si accresce maggiormente constatando l’eccezionale quantitàdi materiale, purtroppo oggi scomparso, un tempo contenuto nellaraccolta Quarenghi e relativo agli spettacoli bergamaschi della com-pagnia Battaglia. L’unico elemento di consolazione di fronte ad unvero e proprio saccheggio è dato dall’accuratezza del repertorio alfa-betico anteposto al volume che conteneva gli avvisi, grazie a cui è pos-sibile seguire i passaggi principali della vicenda (fig. 19). Sappiamoquindi che il 27 aprile si rappresentò l’«Agrippina tragedia del Pinde-monti patrizio veneto», con soddisfazione del pubblico e «con con-corso»263. Il 4 maggio La figlia dell’aria «ossia L’inalzamento di Semira-mide favola del co. Carlo Gozzi» che «fu bella, venne replicata»264. L’11maggio una commedia dal titolo «Guerino meschino agl’alberi del sole edad altri luoghi» opera di autore sconosciuto probabilmente ispirata alpersonaggio antieroico e ridicolo di Guerino e alle sue avventure con-tro i turchi create nel Seicento da Andrea da Barberino265. L’11 mag-gio la favola intitolata Il Meleagro. Il 13 maggio La principessa filosofadi Carlo Gozzi per la cui interpretazione Luigia Belloni venne omag-giata «con due sonetti»266. Il 18 maggio, in occasione di una serata in-
262. Documento 1789: 15, in Regesto.263. Documento 1789: 16, in Regesto.264. Documento 1789: 19, in Regesto.265. Documento 1789: 21, in Regesto. La prima edizione italiana dell’opera di
Andrea da Barberino sul personaggio di Guerino il meschino è del 1635, Venezia,presso Ghirardo Imberti, con il titolo Guerino detto il Meschino, nel quale si tratta cometrovò suo padre e sua madre, in la cttà di Durazzo in prigione. Et diverse vittorie havute con-tra Turchi. L’ultima è del 1668.
266. Documenti 1789: 22-23, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 134
135
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
teramente devoluta alla prima attrice, Il pittore naturalista di Otto Hen-rich Gemmingen267. Per quanto riguarda quest’ultima esibizione è for-tunatamente rimasto l’avviso. Da esso ricaviamo che la rappresenta-zione non era compresa in quelle inizialmente programmate dalla trou-pe: la «recita non appartiene all’impresa e succede dopo l’impegno del-le 30 recite» stabilite con gli abbonati. Il prezzo del biglietto era unpaolo e, per invogliare il pubblico, si notificava che «la suddetta Lui-gia Beloni sarà alla porta» a riscuoterne il pagamento268. Nell’annun-cio, come di dovere, veniva proclamata l’assoluta originalità del sog-getto: «la commedia scielta per tale sera è una delle più interessantidi carattere novissima esperimentata con fortuna in altri teatri d’Ita-lia», affermazione probabilmente veritiera in quanto la prima edizio-ne italiana a stampa nota è del 1789269.
Nel complesso notiamo che il repertorio della compagnia era mol-to vario e differenziato, passando dalle tragedie di Ippolito Pindemon-te alle favole di Carlo Gozzi, dalle farse alle commedie, secondo unaprecisa strategia commerciale che permetteva di accontentare un’am-pia varietà di spettatori270. Il vero asso nella manica però, lo strumentomigliore per richiamare il pubblico, rimaneva l’attrice di punta. Attor-no a Luigia Belloni «bella e brava commediante» ruotavano la maggiorparte delle rappresentazioni della compagnia, così come i commenti ele lodi del pubblico. La scelta della Figlia dell’aria di Carlo Gozzi tra isoggetti da mettere in scena è sicuramente emblematica in tal senso.Non si trattava soltanto di un’opera di straordinario successo, per laquale l’autore affermava di aver ricevuto lettere di apprezzamento «daTorino, da Bergamo, da Trieste, da Udine» e da tutte le altre città nellequali era stata rappresentata, ma anche di uno dei cavalli di battagliadell’attrice. La prima assoluta di questo «dramma favoloso, poetico, al-legorico» tenuta il 14 febbraio del 1786 nel Teatro San Salvatore di Ve-nezia aveva visto come protagonista proprio la Belloni nella parte di
267. Documento 1789: 24, in Regesto.268. Documento 1789: 26, in Regesto.269. O.H. Gemmingen, Il pittore naturalista ossia lo specchio delle umane passioni,
commedia del barone Ottone Ghminghen tradotta dal tedesco, In Venezia, presso Gio. An-tonio Curti q. Vitto, 1789.
270. Sulla estrema varietà del cartellone proposto dalla compagnia di Carlo Bat-taglia e la necessità di incontrare il gusto del pubblico rimandiamo a F. Mancini,M.T. Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. I, t. 2, cit., p. 95 e A.M. Testaverde(a cura di), Prime attrici e primi attori, cit., p. 24.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 135
136
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Semiramide da lei sostenuta «con della energia e della bravura la partesua»271. Nel corso delle rappresentazioni bergamasche gli estimatori deltalento mostrato dalla «prima commediante» furono molti. Tra essi tro-viamo in primis il capitanio Leonardo Valmarana e l’avvocato France-sco Maria Quarenghi, cui vanno aggiunti il «pastore arcade» LorenzoBrini, l’abate Cristoforo Negri, il signor Giacomo Muletti272.
Nel Teatro della Cittadella infine, oltre all’opera buffa e alle rappre-sentazioni di attori professionisti, erano possibili molte altre tipologiedi spettacolo. Nel periodo di Quaresima del 1786 fu la volta di «unaragguardevole accademia musicale» costituita da esibizioni canore in-tervallate da musica strumentale e da intermezzi orchestrali; nel luglio1789 di un’«accademia di canto»273. In qualche caso, come nel genna-io del 1790, ebbero luogo «diversi giuochi», probabilmente spettacoliillusionistici, da parte di curiosi personaggi come Otnip D’Irrab Ot-ting274. Infine, con un certa costanza, dovevano tenersi anche spettaco-li di attori dilettanti. È sicuramente il caso di quelli patrocinati da Pao-lina Grismondi Secco Suardo, ad uno dei quali si riferisce l’unica im-magine dell’arco scenico e del palco del teatro a noi giunta, relativa al1770 (fig. 14). Riguardo al tipo di offerta drammaturgica promossa dal-la contessa in quell’occasione non ci sono notizie. Rinomata per i suoimolteplici interessi culturali e in contatto epistolare con alcuni dei mag-giori intellettuali del suo tempo, possiamo avere un’idea degli spetta-coli da lei favoriti, e normalmente anche interpretati, in base a notizierelative ad anni successivi, per i quali conosciamo il genere di spetta-colo offerto, ma non i luoghi degli allestimenti. Nel 1777, ad esempio,sappiamo che Lesbia Cidonia venne omaggiata per una sua performan-ce teatrale con «sonetti tre del signor dottor Giovan Battista Salvagnide’ Roteri allorché recitava il Fajel», tragedia di François Thomas Maried’Arnauld de Baculard tradotta in versi sciolti dal conte Carlo Gozzi275.
271. Prefazione di Carlo Gozzi a La figlia dell’aria o sia l’innalzamento di Semira-mide. Dramma favoloso allegorico in tre atti e in verso sciolto del conte Carlo Gozzi, Secon-da edizione emendata e corretta, In Venezia, Appresso Gio. Antonio Curti q. Vitto,1791, cc. XVIII, XXII, XXVI.
272. Documenti 1789: 17-18, 20, 24, 27-29, in Regesto.273. Documenti 1786: 17; 1789: 33, in Regesto.274. Documento 1790: 4, in Regesto.275. Documento 1777: 1, in Regesto. F.T. Marie d’Arnauld de Baculard, Il Fajel
tragedia del signor d’Arnaud tradotta in versi sciolti dal conte Carlo Gozzi, In Venezia, Peril Colombani, 1772.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 136
137
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
Qualche anno dopo la contessa Paolina Grismondi «nata Secco Suar-di in settembre 1780 rappresenta co’ suoi amici una tragedia»276. Il tito-lo dell’opera è sconosciuto, ma il genere è significativamente lo stesso.Un repertorio impegnativo, quindi, che tradisce un’idea molto elevatadella funzione teatrale, in accordo con i progetti di riforma caratteristi-ci del periodo settecentesco.
3.3. Il cortile della Cittadella
Lo spazio del cortile, costituito dall’attuale piazza della Cittadella,poteva essere usato per l’edificazione di un teatro provvisorio, comeper tipologie molto differenziate di spettacolo. Secondo FerdinandoCaccia vi erano tenuti abitualmente «esercizi militari», ma poteva es-sere usato anche «per popolari spettacoli, piantate di maggi, forzed’Ercole, caccie di tori e giuochi in altri tempi di pallone»277. Attesta-zioni puntuali su singoli eventi sono però tarde e si riferiscono al pe-riodo compreso tra il 1778 e il 1788278.
In considerazione della funzione della Cittadella e dell’autorità sot-to cui era preposto il complesso architettonico, non sorprende affat-to che le manifestazioni pubbliche più comuni fossero di tipo mar-ziale e che spesso servissero al rettore veneto per esibire la propria po-tenza. Un primo «divertimento pubblico di essercizio militare, fattodall’officiale Lellio in Cittadella» si registra il 28 giugno del 1788, cuiseguirono, nell’agosto dello stesso anno, «forze de’ nicolotti veneti fat-te in Cittadella»279. Quest’ultime vennero replicate nel Carnevale del1780280. Infine il cortile fu lo spazio probabilmente usato nell’apriledel 1782 per alcuni «equilibri diversi di tre inglesi fatti a cavallo» e perun «divertimento del officiale Antelmi di essercizio di fuoco»281.
276. Documento 1780: 5, in Regesto.277. F. Caccia, Trattato scientifico di fortificazione sopra la storia particolare di Berga-
mo, edito da F.M. Tassi, Vite de’ pittori, scultori e architetti bergamaschi, Bergamo, 1793,vol. II, p. 175 e citato in F. Buonincontri, Il sistema teatrale, cit., p. 68.
278. Tali attestazioni derivano unicamente dalla raccolta di stampe di FrancescoMaria Quarenghi.
279. Documenti 1778: 3 e 5, in Regesto.280. Documento 1780: 2, in Regesto.281. Documenti 1782: 1-2, in Regesto. Attribuiamo lo spazio della Cittadella al-
le esecuzioni di questi due spettacoli, in considerazione della loro tipologia e del pe-riodo dell’anno in cui furono eseguiti, normalmente destinato alla Città Alta.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 137
138
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Non si trattava dell’unica forma di intrattenimento possibile. Al-cuni spettacoli realizzati nel cortile della Cittadella ricordano quellinormalmente tenuti nel prato di Sant’Alessandro per la fiera. Il 22 set-tembre e il 12 ottobre abbiamo notizia di un «globo areostatico man-dato in aria in Cittadella da certo Casanova» macchinista veneziano282.Per il mese di luglio del 1785, infine, un avviso descrive molto detta-gliatamente uno spettacolo equestre di natura acrobatica eseguito «incorte Cittadella» dal «signor Price colla sua compagnia»283. Un pro-gramma estremamente complesso costituito da ben quattordici diver-si passaggi tra «salti» e «giuochi di forza», comprensivi di figure quali«la posizione del Mercurio volante», «piramidi d’Egitto», «forze d’Er-cole» e concluso da «la rappresentazione della buffoneria d’un sartoandando di Londra a Brandfort per dare la sua voce al signor Wil-kes»284. Un vero e proprio spettacolo circense, cui seguì nel maggiodel 1788 un intrattenimento sicuramente più prosaico, voluto dai «so-ci impresari del teatro della Cittadella» per «procurarsi numeroso con-corso al teatro» e consistente in «una corsa di 12 uomini legati nelsacco fino alla gola»285. Anche in questo caso lo spettacolo è accura-tamente descritto nell’avviso che lo pubblicizza. Si tenne di domeni-ca, iniziò «alle ore 21 e mezza» e consistette in tre corse di quattro gi-ri ad eliminazione cui partecipavano quattro uomini per ciascuna. Itre vincitori furono i protagonisti della gara finale composta di tre gi-ri. Ciò che appare più importante rilevare è che siamo in grado di sta-bilire i luoghi a disposizione per la visione dello spettacolo tenuto nel-la «corte della Cittadella». Le opportunità date agli spettatori eranodue: la prima era costituita dalla semplice entrata nel cortile – dovesi suppone che il pubblico fosse separato con una recinzione da co-loro che correvano – al costo di cinque soldi; la seconda, previo pa-gamento di un ulteriore biglietto di dieci soldi, consisteva nel trova-re «luogo o nelle finestre del Salone o nella Loggia di fronte»286. Ven-nero usate quindi le finestre della Sala del Capitanio e le logge del ca-marlingo sfruttando, come succedeva normalmente nel caso dei cor-tili, lo spazio a disposizione nella sua altezza. L’episodio, dal punto
282. Documento 1784: 4, in Regesto.283. Documento 1785: 5, in Regesto.284. Ibidem.285. Documento 1788: 19, in Regesto.286. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 138
139
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
di vista artistico poco rilevante, faceva da cornice alla programmazio-ne musicale del Teatro della Cittadella. Serviva per attirare gli spetta-tori i quali, al termine della corsa, furono invitati a recarsi al teatroper assistere ad «un’opera nuova ed un ballo nuovo», dopo cui eraprevista una «festa da ballo colle solite discipline»287.
4. Note conclusive
Che tipo di sistema teatrale fu quello che si costituì in Città Altae quali elementi di continuità possiamo riscontrare rispetto alle cittàdella Terraferma veneta? Come nella maggior parte degli altri centriurbani la motivazione prevalente che portò all’edificazione di teatrifu la necessità di allestire decorosamente le rappresentazioni musica-li. I filoni seguiti furono quello di edifici teatrali provvisori costruitinei palazzi del potere (sotto la loggia del Palazzo della Ragione o neisaloni del Palazzo del Capitanio) e quello dei teatri privati, rappresen-tato dal tentativo di un teatro stabile da parte del conte Giuseppe Sec-co Suardo. Il terzo modello, costituito dai teatri accademici o socia-li, non ebbe luogo. Il sistema di produzione adottato fu di tipo im-presariale.
Se tutti questi costituiscono elementi di somiglianza, molti di piùsono quelli di discontinuità. L’estrema difficoltà nel dotare la CittàAlta di un teatro stabile e la tenace ostilità nell’accogliere gli artisti intransito furono costanti nel tempo. A Bergamo, più che in ogni altracittà della Terraferma veneta, si palesò lo scontro tra teatro profano ecultura ecclesiastica che segnò i secoli di antico regime288. Se nel 1685l’impresario Antonio Scappi fu respinto, in quanto la costruzione diun teatro provvisorio venne giudicata un’«operazione così scandalo-sa», laddove concorrevano «tutti li motivi contrari» a tali iniziative «perle guerre correnti e per le angustie ben note»289, ancora nel 1720 l’aba-
287. Ibidem.288. Esemplare in questo senso il pensiero espresso dal gesuita Giovan Dome-
nico Ottonelli, Della Christiana Moderatione del Theatro, per cui si rimanda a F. Tavia-ni, La commedia dell’arte e la società barocca, cit., pp. 313-526. Per la vertenza del car-dinale Carlo Borromeo vs compagnia dei Gelosi del 1583 si veda F. Taviani, M. Schi-no, Il segreto della Commedia dell’Arte, cit., pp. 376-399.
289. Documento 1685: 2, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 139
140
FRANCESCA FANTAPPIÈ
te Giovan Battista Angelini scriveva che «la commedia (…) del pec-car fomenta la licenza»290. Bergamo non era sicuramente un caso iso-lato. Quanto il pregiudizio morale nei confronti del teatro professio-nale fosse ancora forte nella seconda metà del Settecento, lo dimostrauna descrizione a stampa del 1768, nella quale si dà conto dell’incen-dio che il 26 luglio distrusse il teatro pubblico di Feltre. Nel corso dialcune rappresentazioni serali un fulmine cadde sull’edificio, causan-do morti e feriti. Il tragico evento venne letto come un castigo di Dio,segno della «Divina Misericordia che, con modi reconditi e imperscru-tabili dalla condizione de’ mortali» aveva così salvato «quelle anime»le quali, «vicine a perdersi per un vile transitorio mondano piacere»,erano state finalmente indirizzate su una strada salvifica291. Cionono-stante a Feltre un teatro stabile esisteva già dal 1684292. A Bergamol’assenza di edifici teatrali architettonicamente riconosciuti si protras-se per quasi tutto il Settecento, acquisendo il valore di un tratto di-stintivo che la allontanava da Venezia, città dei teatri a pagamento aregime concorrenziale, e la avvicinava a Milano, dalla cui arcidiocesidipendeva la diocesi bergamasca, sulla quale rimasero a lungo vivi gliinsegnamenti del cardinale Borromeo293.
Non si trattò però solo di un fatto culturale, ma anche sociale. Trale ragioni di questa anomalia troviamo l’intrinseca debolezza dei po-tenziali promotori del fenomeno teatrale: i rettori, le autorità muni-cipali e le famiglie dell’oligarchia cittadina294. A Bergamo la classe so-ciale più alta, rappresentata nei consigli municipali, costituiva la par-te più cospicua del pubblico ma, diversamente da quanto successo inaltre città, il ceto nobiliare locale non assunse mai un ruolo promo-tore. È sufficiente un confronto con la vicina Crema per capire la di-versità di atteggiamento dell’oligarchia cittadina. Qui i deputati co-munali, fermamente decisi ad avere un teatro, ne promossero la co-struzione all’interno degli spazi appartenenti alla comunità già dal1683. A Bergamo, nello stesso periodo, iniziarono ad essere negate le
290. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 376.291. Documento 1768: 1, in Regesto.292. F. Mancini, M.T. Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. II, cit., p. 350.293. B. Belotti, Venezia e la visita di San Carlo Borromeo, cit.; A. Roncalli, Gli atti
della visita apostolica di San Carlo Borromeo (1575), cit.; C. Carlsmith, Schooling and So-ciety in Bergamo 1500-1600, cit., p. 149 e ss.
294. Per la divisione tra «promotori», «realizzatori» e «destinatari» si rimanda aF. Piperno, Il sistema produttivo, cit., pp. 3-4.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 140
141
IL TEATRO DELLA CITTÀ ALTA
licenze per l’uso della loggia sottostante il Palazzo della Ragione, dif-ficoltà che si riscontrarono abitualmente per tutto il Settecento. Lamaggior parte delle domande, dopo essere state vagliate con estremapuntigliosità, venivano respinte. Le prime avvisaglie di un cambiamen-to di mentalità si ebbero solo nel corso della seconda metà del seco-lo. Si veda il caso delle discussioni scaturite nel 1745 in seguito allarichiesta dell’impresario Pietro Raparini, per la quale venne ipotizza-ta la possibilità di rendere legislativamente più agevole la concessio-ne dello spazio, oppure quello della delibera relativa all’impresario Na-zario Dehe nel 1761, in base alla quale si faceva strada l’idea che laprincipale finalità della rappresentazione di un’opera fosse il «com-modo ed onesto divertimento de’ cittadini»295. Emergeva per la primavolta un nuovo punto di vista: il teatro come pubblico interesse e nonesclusivo tornaconto dell’impresario o degli artisti coinvolti.
Il parziale disgelo da parte delle autorità municipali non si rilevò,però, sufficiente. Nel secondo Settecento tra i due luoghi teatrali, log-gia in Piazza Vecchia e salone della Cittadella, veniva largamente pre-ferito il secondo, posto sotto la tutela del capitanio. La diffusione del-l’opera buffa, permettendo di usare anche spazi ridotti, rese abitualela costruzione del cosiddetto Teatro della Cittadella, che assunse co-sì un uso polivalente, ospitando sia prosa sia opera. In Città Alta quin-di, nonostante la loro breve durata in carica, furono i rettori coloroche riuscirono a dare maggiore impulso all’espansione del teatro pro-fessionistico296.
L’azione individuale fu rappresentata da alcune influenti famigliedell’oligarchia, quali i Martinengo e i Secco Suardo. Se la prima ca-sata si limitò a promuovere singoli allestimenti operistici, la secondasi spinse fino a progettare la costruzione di un edificio privato, secon-do il modello della Dominante o di altre città soggette quali Padova,Treviso e Rovigo. Tuttavia non senza qualche diatriba o noioso stra-scico legale. Grazie all’appoggio dei rettori in carica, nonostante la po-lemica con il Monte di Pietà, il teatro andò avanti. L’oligarchia mu-nicipale, sempre così rigida, in questo caso non espresse apertamentealcun giudizio, verosimilmente per il timore di porsi contro i poten-
295. Documenti 1745:2; 1761: 2, in Regesto.296. Né bisogna dimenticare l’esperienza del capitanio Pietro Dolfin tra il 1667
e il 1668, dall’Accademia degli Aironi alla rappresentazione della Prosperità di ElioSeiano e dell’Annibale in Capua.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 141
142
FRANCESCA FANTAPPIÈ
ti Secco Suardo. L’iniziativa ebbe purtroppo vita breve, probabilmen-te per difficoltà economiche, ma anche per l’avversità di altre nobilicasate. Bisogna, infatti, ricordare che la forte competizione tra varieconsorterie fu la causa principale del fallimento nella costruzione diteatri a ragione collettiva.
L’iniziativa spettacolare rimase così in mano alle compagnie di at-tori girovaghi e agli impresari itineranti, che portavano con sé testi emusica, oltre ai cast da loro scritturati. Elementi estranei, visitatori maltollerati. Ad affiancare gli artisti errabondi nell’allestimento degli spet-tacoli si costituirono in loco alcune famiglie di impresari-costruttori,realizzatori degli edifici provvisori: Compagnoni, Dehe, Lombardi. Lacomparsa di una personalità troppo emergente all’interno della com-pagine sociale cittadina, quale poteva essere il proprietario di un tea-tro stabile, venne in questo modo impedita. Dopo il conte GiuseppeSecco Suardo tale impresa sarebbe riuscita solo a Bortolo Riccardi.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 142
143
1. La fiera nel Medioevo rappresentò uno dei momenti e degli spazi privilegia-ti per l’esibizione dei giullari. In epoca moderna, oltre agli spettacoli dei saltimban-chi, degli acrobati, degli imbonitori di vario genere, iniziò ad ospitare in manieraprogressiva forme di teatro regolare, dall’opera musicale alle rappresentazioni comi-che delle troupes di attori professionisti. Si veda la voce fiera in Enciclopedia dello Spet-tacolo, cit., vol. V, 1958, coll. 284-286.
2. A. Serena, Storia del circo, prefazione di P. Bosisio, Milano, 2008, pp. 10-152.
1. La fiera e il teatro
La fiera e il teatro, sia in Italia sia in Europa, furono indissolubil-mente legati dal Medioevo fino a tutta l’età moderna1. Lo spazioaperto del mercato richiamava non solo potenziali clienti, ma anchepossibili spettatori. Costituiva, quindi, un polo d’attrazione per ar-tisti e performer di genere molto variegato. Era il luogo in cui si espri-meva una spettacolarità diffusa, un teatro non convenzionale, inte-so nel senso più ampio del termine, quello che avrebbe dato origi-ne al circo moderno2. Nella fiera si esibivano acrobati ed equilibri-sti, così come imbonitori i quali, attirando il pubblico con brevi sce-ne comiche o giochi di prestigio, vendevano le proprie mercanzie,ritrovati miracolosi o invenzioni. Era possibile trovare esposti ani-mali esotici e selvaggi, vivi o imbalsamati, chiusi in gabbie oppureammaestrati. Rimanere meravigliati per l’esistenza di creature uma-ne incredibili, uomini o donne deformi, “mostri della natura” dalleabilità fuori dal comune. Nel corso del Settecento, infine, assisterea spettacoli proto-cinematografici, dalle scatole ottiche al teatro d’om-bre fino alla lanterna magica. Il cosiddetto teatro professionale rego-
PARTE III.Il teatro dei Borghi
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 143
144
FRANCESCA FANTAPPIÈ
lare, musicale o in prosa, con i suoi attori, cantanti o ballerini, co-stituiva perciò solo una delle tante possibilità.
Se lo stretto legame tra teatro e fiera in ambito europeo ha godu-to di una robusta tradizione bibliografica, ciò non è altrettanto veroper l’Italia, per la quale non esiste uno studio complessivo3. Ciono-nostante sappiamo che la fiera di Bergamo non era l’unica nella Pe-nisola ad ospitare rappresentazioni operistiche. Oltre a Venezia, conla sua famosa fiera primaverile dell’Ascensione, vi erano molte dellecittà della Terraferma veneta tra cui Padova (con ben due fiere annua-li), Belluno, Crema, Rovigo, Verona, Vicenza e Treviso. Nell’area emi-liano-romagnola spicca tra tutte la fiera di Reggio, ma non erano dameno Bologna, Ferrara, Piacenza e Ravenna. Nel Sud la fiera di Mes-sina attirava gli attori delle compagnie stanziali di Napoli fin dalla fi-ne del Cinquecento. Difficile, allo stato attuale delle ricerche, redige-re una mappa o un censimento delle fiere annuali italiane. Queste,però, non coincidendo quasi mai con il Carnevale, ma essendo tenu-te in occasione delle feste patronali di ciascun centro urbano, rappre-sentavano un appuntamento importante per i professionisti del tea-tro che potevano così coprire tutti i periodi dell’anno nel corso delleproprie tourneés.
La rilevanza dell’annuale fiera di Sant’Alessandro per la storia diBergamo è ampiamente riconosciuta, tanto che l’esistenza di un mer-cato intitolato al santo patrono sembra documentata fin dal decimosecolo4. La più importante dell’area lombardo-veneta in epoca di an-tico regime, momento fondamentale per la vita cittadina e non solo,trovava luogo nel prato di Sant’Alessandro, durava nove giorni, dal
3. Sul teatro di fiera londinese e sul teatro forain in Francia si vedano almeno S.Rosenfeld, The Theatre of the London Fairs in the Eighteenth-Century, London, 1960; R.Guardenti, Le fiere del teatro. Percorsi del teatro forain del primo Settecento, Roma, 1995;P. Martinuzzi, Le “pièces par écriteaux” nel teatro della Foire (1710-1715). Modi di unateatralità, Milano, 2007, cui si rimanda anche per la bibliografia. Numerosi documen-ti sulla fiera di Reggio Emilia sono pubblicati in U. Bellocchi, La fiera di Reggio com-pie 400 anni, Reggio Emilia, 1998.
4. Secondo Vincenzo Marchetti, Per un censimento dei luoghi destinati a Sant’Ales-sandro, in Bergamo e Sant’Alessandro. Storia, culto, luoghi, a cura di L. Pagani, Bergamo,1999, pp. 97-114: 106, l’intitolazione della fiera a Sant’Alessandro è da far risalire al-meno al 16 aprile 909, data in cui è attestata l’esistenza di un «mercatum […] quodbeati Alexandri dicitur». In proposito si veda anche A. Mazzi, Corogrofia Bergomen-se nei sec. VIII-IX-X, Bergamo 1880, p. 84.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 144
145
IL TEATRO DEI BORGHI
22 al 30 agosto, ma era prolungabile per altri quattro. Finiva quindiil 3 settembre5. Dal 1475 l’affitto dei fondi su cui venivano costruitebotteghe e casotti provvisori spettava all’Ospedale Maggiore6. Esalta-ta da Donato Calvi nel 1676 viene così ricordata:
fiera celebre all’Italia tutta, copiosa d’ogni qualità di mercantie, per sitoopportuna, per posto sicura, per dispositione ben regolata, e dal concor-so non solo de’ confinanti popoli, ma di tutta l’Italia, Francia, Rhetia, El-vetia & Germania resa conspicua7.
Frequentata da mercanti provenienti da tutta Italia ed Europa, Gio-van Battista Angelini nel 1720 dedica alla fiera una buona parte del-la sua descrizione di Bergamo in terza rima. Secondo l’abate le mer-ci vendute sarebbero state di ogni tipo: «Lini e stoppe e fili e biade»da Crema, «refe, pelli archibugi, e ferri e spade» da Brescia, «calce, ca-nape» da Verona, «bambagino e baracan»8 da Cremona, etc. Un mer-cato di respiro internazionale. Tra le città italiane presenti in fiera conle proprie mercanzie vi sarebbero state Genova, Venezia, Lodi, Savo-na, Biella, Reggio Emilia, Vigevano, Milano, Parma, Lucca, Torino,Bologna, Piacenza. Per quanto riguarda l’Oltralpe: «Ginevra, Francia,Frianda, Inghilterra», «Linza, Sangallo e Carintia e l’Alemagna» e«Mompellier»9.
Non stupisce che l’evento fieristico, così centrale per la vita citta-dina attirasse anche gli artisti del teatro professionale. Data la sua ri-levanza, nel 1732, le autorità municipali, di concerto con l’Ospedale,decisero un’importante opera di riassetto dell’area, ossia la conversio-ne in muratura di una parte della zona destinata al mercato10. L’ope-ra di riorganizzazione architettonica, conclusasi nel 1740, portò alla
5. Per un confronto tra la varie fiere della Terraferma veneta e per il primato diquella di Bergamo su tutte le altre si rimanda a P. Lanaro, Periferie senza centro. Retifieristiche nello spazio geografico della terraferma veneta in età moderna, in Sistemi di fiere,mercanti e città in Europa (1400-1700), Venezia, 2003, pp. 21-51.
6. M. Gelfi, La fiera di Bergamo: il volto di una città attraverso i rapporti commercia-li, presentazione di L. Pagani, postfazione di G. Della Valentina, Bergamo, 1993, p.20.
7. D. Calvi, Effemeride sagro-profana, cit., vol. II, p. 613.8. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 3719. Ibidem.10. M. Gelfi, La fiera di Bergamo, cit., p. 20 e ss.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 145
146
FRANCESCA FANTAPPIÈ
costruzione di un quadrato di edifici di pietra costituito da ben cin-quecentoquaranta botteghe. Un intervento urbanistico di rilievo, tan-to che «le bâtiment de la foire» viene ricordato da Jérôme de Lalandecome «la chose la plus remarquable de Bergame»11. Nonostante ciò,nelle zone circostanti la fiera permanente continuavano ad essere co-struite strutture provvisorie di legno, facendo uso di materiale forni-to dallo stesso Ospedale. Tra questi edifici effimeri vi erano sia i ca-sotti per gli attori sia il teatro provvisionale per l’opera abitualmenteedificato «aux environs de la foire»12. Prima che anche quest’ultimovenisse convertito in muratura bisogna aspettare il 1791.
1.1. I casotti degli attori: dai comici dell’arte alle compagnie “lombarde”
Le prime attestazioni del passaggio di compagnie di attori profes-sionisti a Bergamo risalgono alla fine del Cinquecento, periodo per ilquale non conosciamo, purtroppo, i luoghi usati per le rappresenta-zioni. È solo nel secondo Seicento che siamo in possesso di alcunidati sicuri, sulla base dei quali possiamo affermare che gli attori era-no prevalentemente presenti nella stagione estiva e si esibivano neiteatri provvisionali di fiera. Un’abitudine che si consolidò nel corsodel Settecento, secolo che vide l’aggiunta di una seconda stagione de-dicata alla prosa, quella della primavera. Sebbene la frammentarietàdelle notizie disponibili non permetta di attribuire un luogo specifi-co agli spettacoli di ciascuna compagnia, notiamo la progressiva co-stituzione, nel corso del Settecento, di un’alternanza tra la Città Altae i Borghi, simile a quanto verificabile nell’ambito del teatro musica-le. Nel caso della prosa si affermò la regola seguente: primavera nelTeatro della Cittadella ed estate-autunno nei teatri della fiera. È solola definitiva apertura del Teatro Riccardi, nel 1791, che determinò uncambiamento nell’uso consolidato, attirando a sé la maggioranza del-le formazioni comiche che si registrarono a Bergamo da quel momen-to fino al 1796.
La prima compagnia di cui abbiamo notizia è niente meno chequella dei Gelosi, la cui presenza è attestata nell’estate del 1583. Nonsi trattava in realtà di una tournée programmata. Gli attori ripiegaronosu Bergamo poiché non avevano potuto tenere i propri spettacoli a
11. J. de Lalande, Voyage d’un françois en Italie, cit., pp. 49-50.12. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 146
147
IL TEATRO DEI BORGHI
Milano, in attesa della necessaria licenza sugli scenari da parte del car-dinale Carlo Borromeo. Dovendo comunque esibirsi al fine di garan-tire la propria sopravvivenza economica, scelsero la città più vicina.Nel corso dell’anno comico 1583-1584 facevano sicuramente parte del-la rinomata formazione artisti di grido quali Isabella e Francesco An-dreini, Giacomo Braga, Giovanni Pellesini, Ludovico de’ Bianchi,Adriano Valerini13. Purtroppo non sappiamo quale spazio venne de-stinato alle rappresentazioni, né tantomeno quale area della città.Un’attribuzione che si rivela ancora più difficile per la Mirtilla, pasto-rale dell’attrice Isabella Andreini, pubblicata a Bergamo nel 1594. Inquesto caso è la rappresentazione stessa dell’opera in città che appa-re incerta. Nella dedica, infatti, non viene fatto alcun accenno ad unamessa in scena bergamasca. Tuttavia sappiamo che gli attori promuo-vevano spesso la ristampa delle proprie produzioni drammaturgicheper divulgarne un nuovo allestimento14. Per quanto riguarda questotipo di pubblicazione, però, la scelta di Bergamo potrebbe essere sta-ta dettata da motivazioni di carattere letterario e rientrare in un pro-getto autopromozionale messo in atto dall’attrice stessa. I pochi datidisponibili sull’attività accademica teatrale bergamasca, a cavallo traCinque e Seicento, indicano un orientamento erudito e letterario del-l’offerta drammaturgica, sia nel caso che venisse concretamente mes-
13. G.B. Castiglione, Sentimenti di S. Carlo Borromeo intorno agli spettacoli, Berga-mo, Pietro Lancelotti, 1759, pp. 140, 141 e n, 143; R.G. Arcaini, I comici dell’arte aMilano: accoglienza, sospetti, riconoscimenti, in La scena e la gloria, a cura di A. Cascet-ta e R. Carpani, Milano, 1995, pp. 265-326: 272; F. Taviani, M. Schino, Il segreto del-la Commedia dell’Arte, cit., pp. 209-210, 379-389.
14. Nella prima edizione della Mirtilla (Verona, 1588) la dedica è dell’attrice Isa-bella Andreini, cui seguono nel 1590 due edizioni, una a Ferrara, l’altra a Venezia.L’ultima ristampa è quella bergamasca, con dedica dell’editore, per la quale riman-diamo alla scheda Mirtilla (1594), in Cronologia.
15. Oltre a Il re Torrismondo Torquato Tasso pubblicò presso Comin Ventura al-tre opere, prevalentemente componimenti poetici e lettere: Delle lettere familiari delsig. Torquato Tasso (1588), Stanze del sig. Torquato Tasso per le lacrime di Maria Vergine san-tissima e di Giesù Christo Nostro Signore (1593), Rime spirituali (1597, 1605). Per quan-to riguarda Muzio Manfredi si veda la schede Semiramis (1593) in Cronologia. Il gu-sto per il genere tragico e per il teatro erudito di parte della società bergamasca puòprobabilmente chiarire il motivo per cui nella Biblioteca Civica Angelo Mai è con-servata una copia manoscritta della tragedia Reina di Scotia di Federico della Valle:A. Cascetta, La spiritual tragedia e l’azione devota. Gli ambienti e le forme, in La scena ela gloria, cit., pp. 115-218: 198.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 147
148
FRANCESCA FANTAPPIÈ
sa in scena, sia che fosse solo stampata. Presso l’editore bergamascoComin Ventura, Torquato Tasso pubblicò la tragedia Il re Torrismondonel 1587 e Muzio Manfredi La Semiramis pastorale nel 159315. Seguìnel 1604 Angelo Ingegneri con la seconda edizione del suo famosotrattato sull’arte drammatica Della poesia rappresentativa et del modo dirappresentare le favole sceniche16. Un’opera nella quale, per elogiare il nuo-vo genere pastorale, vengono citati vari esempi prodotti dal genio divalenti scrittori. Tra tutti i titoli ricordati spicca La Mirtilla di Isabel-la Andreini, unica donna e attrice menzionata, in quanto autrice diuna favola boschereccia in prosa e non in versi17. La ristampa berga-masca dell’Ingegneri è dedicata a Marin Garzoni come camarlingo del-la «nuova accademia di Bergamo», sodalizio di breve durata, registra-to anche da Donato Calvi18. Non si trattò dell’unico esempio di cir-colo intellettuale erudito del periodo. Nel 1600 gli accademici Labo-riosi pubblicarono la rappresentazione allegorica in versi dedicata aGaspare Martinengo intitolata Hercole, cioè rappresentatione della virtù etvoluttà19. Anche in questo caso però fu un’esperienza effimera.
Una tradizione che si protrasse nel corso del primo Seicento, quan-do sono documentati alcuni esempi di teatro erudito e letterario, cuinon appare associata la presenza di attori professionisti. Animatore dibuona parte degli episodi fu Alessandro Terzi, rettore del Seminariodi Bergamo autore, nel 1629, del dramma allegorico in versi intitola-to Il trionfo dell’amicizia dedicato al podestà Giulio Valier20. Nel 1662
16. A. Ingegneri, Della poesia rappresentativa et del modo di rappresentare le favole sce-niche. Discorso del sig. Angelo Ingegneri all’Illustrissimo sig. Marin Garzoni camerlingo e pri-mo prencipe della nuova accademia di Bergamo, Bergamo, Comin Ventura, 1604. La de-dica, del primo settembre, è dell’editore.
17. A. Ingegneri, Della poesia rappresentativa e del modo di rappresentare le favole sce-niche, a cura di M.L. Doglio, Modena, 1989, pp. 4, 35n.
18. Questa notizia è riportata anche da Donato Calvi che molto probabilmen-te la trae dall’Ingegneri: «12 agosto. 1604. Fu hoggi in Bergamo aperta per la primavolta celebre e glorioso accademia, eleggendo in primo prencipe Marino Garzonicamarlengo di Bergamo. Principio da gran calore accompagnato, ma che con l’en-trata del verno si raffreddì, e dileguò», Effemeride sagro-profana, cit., vol. II, p. 653.
19. Hercole (1600) in Cronologia.20. Il trionfo dell’amicitia di Nicolò Barbarigo e Marco Trivisiano patrici vinitiani
(1629) in Cronologia. Un repertorio delle opere a stampa e manoscritte di Alessan-dro Terzi è contenuto in D. Calvi, Scena letteraria degli scrittori Bergamaschi, Figliuolidi Marc’Antonio Rossi, Bergamo, 1664, pp. 28-31, il quale ricorda le numerose «ora-tioni, i panegirici, le rappresentazioni drammatiche, le poetiche e le latine e tosca-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 148
149
IL TEATRO DEI BORGHI
venne pubblicata postuma dal nipote Francesco la tragicommedial’Eraclito consolato, scritta per celebrare il cardinale Barbarigo. Operadrammatica di particolare interesse nella quale il Terzi, «accademicofra gli Eccitati il Furace e fra gli Erranti l’Invigorito» mescola, segnodi una parziale influenza del teatro professionistico, personaggi di re-gistri molto diversi, sia seri sia ridicoli, tratti dal genere bucolico, co-sì come derivati dalla commedia degli zanni. Vi troviamo i filosofiEraclito e Democrito (che dialogano in italiano), la pastorella Ama-rilli e il pastore Mirtillo (i quali cantano), il Pedante (che parla italia-no e latino), personaggi grotteschi come Paolaz o Pavolaz (caratteriz-zato da un lingua ibrida tra dialetto bergamasco e latino maccheroni-co) ed infine Ruffino, Toni, Tognaz, Ghilorem e Lorenzo che si espri-mono in dialetto bergamasco21. Alessandro Terzi «canonico di S. Vin-cenzo, teologo della cattedrale, consultore e fiscale del Sant’Officio»morì il 6 gennaio 1662 e fu sepolto nel Duomo22.
Per quanto riguarda gli attori professionisti non è stata reperita al-cuna documentazione attestante una loro presenza a Bergamo nellaprima metà del XVII secolo. Un silenzio assoluto rotto solo nel 1657.Nel maggio di quell’anno sappiamo della difficoltà riscontrata da unacompagnia protetta da Cornelio Bentivoglio nel trovare ospitalità incittà23. Tra i patrocinatori dell’arrivo della troupe, nella quale militavala ricercatissima Brigida Fedeli Bianchi Romagnesi in arte Aurelia, fi-
ne» composte dal Terzi che furono «fatte alle occasioni recitare». Tra di esse segna-liamo la tragedia manoscritta dal titolo La maestà Cornelia romana transportata in Ve-nezia rappresentatione tragicomica a monsig. Cornaro vescovo di Bergamo e l’orazione astampa Riverente dimostrazione dell’osservanza dovuta a’ meriti dell’Illustrissimo Sig. Gior-gio Emo podestà di Vicenza da Alessandro Terzi rettore del seminario di Bergamo. Abbozza-ta di un’orazione, Bergamo, s. d. Tra gli autori di drammi eruditi di argomento teolo-gico bisogna, inoltre, aggiungere Giovan Battista Terzi con La Androphisia racconso-lata rappresentazione misteriosa, Bergamo, Comin Ventura, 1604, opera in cui compa-iono numerosi personaggi allegorici: Androphisia, rappresentante la natura umana,«le virtù theologiche, le sette età dell’uomo, il Demonio, gli Angeli, Christo mede-simo», D. Calvi, Effemeride sagro-profana, cit., p. 238.
21. Si veda la scheda Eraclito sconsolato (1662), in Cronologia.22. D. Calvi, Effemeride sagro-profana, cit., vol. I, p. 23, secondo cui il Terzi mo-
rì «dopo il corso d’anni ottanta tutti di gloria ripieni, per le continue letture, assi-due fatiche, indefessi studij, innumerabili compositioni stampate & honorevoli ca-riche sostenute».
23. In questo caso, come nel corso dei decenni successivi, riscontriamo l’esisten-za di uno stretto legame tra Bergamo e Ferrara, dovuto ai legami della famiglia Ben-tivoglio con quella Martinengo. Dal punto di vista musicale un rapporto privilegia-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 149
150
FRANCESCA FANTAPPIÈ
gurava il nobile bergamasco Francesco Amedeo Martinengo, mentretra gli oppositori il capitanio veneto «parzialissimo della parte avver-sa»24. Impossibile attualmente determinare se la tournée sia stata poieffettivamente realizzata. Tre anni dopo, ossia nell’agosto del 1660,abbiamo la certezza di spettacoli tenuti dalla compagnia di FedericoGabrielli, in arte Mario25. Ad essa seguì, tra i mesi di agosto e settem-bre del 1664, la compagnia di Giuseppe Fiala sulla cui permanenza,grazie alle numerose lettere dirette dagli attori al protettore della for-mazione Ippolito Bentivoglio, sono a nostra disposizione svariate no-tizie. Il carteggio che – come nel più frequente dei casi, documentaampiamente le difficoltà interne alla formazione, le defezioni e le so-stituzioni dovute a disaccordi nell’assegnamento delle parti – non of-fre alcuna indicazione sul luogo delle rappresentazioni.
La compagnia Fiala, che nel mese di luglio recitava a Cremona, fupresente a Bergamo dal 5 agosto fino alla metà di settembre del 1664,periodo in parte coincidente con quello annualmente destinato allafiera, una circostanza che rende molto probabile l’uso degli spazi mes-si a disposizione nel prato di Sant’Alessandro26. Tra gli attori che lacomponevano: Marzia Narici Fiala (Flaminia), Ippolita Gabrielli (Ip-polita), Agostino Grisanti (Mario), Francesco Calderoni (Silvio), Giu-seppe Fiala (Capitan Sbranaleoni), Giovan Battista Paghetti (Dotto-re), Giovan Battista Verzelli (Bagolino) e i non identificati interpretidi Pantalone, Tabarrino e Colombina27. Anche la loro permanenza fu
to tra le due città è confermato dall’esperienza dei musicisti Maurizio Cazzati e Gio-vanni Legrenzi, e del poeta Almerico Passarelli, per cui si vedano M. Padoan, La mu-sica in S. Maria Maggiore, cit.; Id., Bergamo e la musica sacra, cit.; A. Morelli, Legrenzie i suoi rapporti con Ippolito Bentivoglio e l’ambiente ferrarese. Nuovi documenti, in Giovan-ni Legrenzi e la cappella ducale di San Marco, Atti dei convegni internazionali di studi(Venezia-Clusone, 1990), a cura di F. Passadore e F. Rosi, Firenze, 1994, pp. 47-86.
24. Lettere di Francesco Amedeo Martinengo a Cornelio Bentivoglio, Bergamo17 e 27 maggio 1657, in S. Monaldini, L’orto dell’Esperidi, cit., pp. 119-120. Il meseseguente la compagnia di Aurelia cercava protezione per recitare a Brescia. Si vedala lettera di Girolamo Bucchia a Girolamo Contarini, Brescia 14 giugno 1657 e quel-la di Giacomo Negroni a Girolamo Contarini, Brescia 14 giugno 1657, Ivi, p. 121.
25. Documento 1660: 1, in Regesto.26. Lettere di Giovan Battista Paghetti ad Ippolito Bentivoglio, Cremona 24 lu-
glio 1664 e Bergamo 5 agosto 1664, in S. Monaldini, L’orto dell’Esperidi, cit., pp. 194-195, 197.
27. Oltre ad essi, tra gli attori non identificati vi erano un sostituto di Tabarrinocome secondo zanni, «la signora Maddalena», la sorella di Francesco Calderoni, «laGuercina», Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 150
151
IL TEATRO DEI BORGHI
segnata da continui litigi. Il principale motivo di disarmonia del grup-po derivò dallo scontro tra Giuseppe Fiala e Giovan Battista Paghet-ti. Il dottore della compagnia contestava al capocomico la scelta deltrovarobe, accusandolo di privilegiare la famiglia Calderoni, con laquale avrebbe spartito la maggior parte dei proventi degli spettacoli,a danno del resto dei compagni. Il Fiala sosteneva, invece, l’inutilitàdell’aggiunta, voluta dalla compagnia, di un nuovo secondo zanni inluogo di quello originariamente scritturato: i mancati guadagni sareb-bero derivati dall’inutile spesa causata da quest’assunzione non pre-ventivata28. Un’annessione che, per Francesco Calderoni schierato dal-la parte del capocomico, sarebbe stata addirittura dannosa, in quan-to il nuovo attore non sarebbe stato all’altezza della situazione, comedimostrato dalla rappresentazione dei Tre finti turchi, dove «recitò il se-condo zanni novo, che andò così bene che tutti si partirono inanzifornita»29. Secondo i conti Giovanni Albani e Gaspare Martinengo,chiamati da Ippolito Bentivoglio a sorvegliare la compagnia e ad espri-mere il proprio parere sul comportamento degli attori, fu il capoco-mico ad uscire vincente dalla disputa, mentre sarebbe stato il «Dot-tore sfera motrice di tutte queste discordie»30. Il risultato finale, in ognicaso, fu un ciclo di spettacoli non molto brillante e la scissione dellatroupe al termine della stagione bergamasca31.
La prima formazione di cui abbiamo notizia dopo quella di Giu-seppe Fiala è la compagnia di Odoardo Palazzi, presente a Bergamodalla seconda metà di giugno del 1672. Meno rinomata della prece-dente non ne conosciamo la composizione. Di essa faceva parte unnon identificato attore con il ruolo di «Dottore», mentre il capoco-mico appare in trattative per aggregarvi la famosa Antonia Isola Tor-ri, in arte Lavinia. La documentazione sul soggiorno bergamasco del-la compagnia è estremamente limitata, ma rivelatrice della particola-
28. Lettera di Giuseppe Fiala a Ippolito Bentivoglio, Bergamo 6 agosto 1664, inS. Monaldini, L’orto dell’Esperidi, cit., pp. 199-200.
29. Lettera di Francesco Calderoni a Ippolito Bentivoglio, Bergamo 13 agosto1664, Ivi, p. 201.
30. Lettera di Gaspare Martinengo a Ippolito Bentivoglio, s. l. e s. d.; lettera diGiovanni Albani a Gaspare Martinengo, Bergamo 20 agosto 1664; lettera di Gaspa-re Martinengo a Ippolito Bentivoglio, Bergamo 21 agosto 1664, Ivi, pp. 198, 201-203.
31. Lettera di Orazio Canossa a Ippolito Bentivoglio in Ferrara, Mantova 14 set-tembre 1664, Ivi, p. 208.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 151
152
FRANCESCA FANTAPPIÈ
re situazione cittadina. Inaugura un leit motif comune ad altre testimo-nianze epistolari prodotte da attori: il viaggio per arrivare a Bergamoera scomodo e lungo, l’accoglienza lasciava alquanto a desiderare, tro-vare un luogo per le rappresentazioni era arduo e sottoposto ad unacontinua trattativa con le autorità locali. Il capocomico si lamenta diaver impiegato più tempo a percorrere «quaranta miglia» per arrivareda Pontevico a Bergamo, che «cento e passa» per arrivare da Ferrara aPontevico32. Alle difficoltà riscontrare «per condurre la robba», ossiacostumi ed attrezzature di scena, si sarebbero aggiunte quelle per ot-tenere la licenza di recitare. Quella parte di nobili dimostratasi favo-revole alla venuta degli attori non aveva «volsuto l’assunto di proteg-gere alla scoperta la compagnia per le picche» che avrebbero potutonascere tra i rettori veneti. Ciò nonostante aveva contribuito finan-ziariamente «per far il palco» e aveva «anche trovato case per tutti»33.Per risolvere velocemente la questione, e su suggerimento del «signo-re castellano», il capocomico riteneva necessaria una lettera di racco-mandazione per il capitanio Lorenzo Bragadino, meglio se prove-niente dal «procuratore da Ca’ Mosto» o dai «signori Grimani»34. Ip-polito Bentivoglio, come patrocinatore della compagnia, ottenne lalettera da Vincenzo Grimani Calergi35. Sappiamo che le rappresenta-zioni iniziarono il 13 giugno, ma non quando terminarono.
Non sappiamo quali spazi furono concessi alla compagnia di Odo-ardo Palazzi per le proprie esibizioni, sebbene la necessità di ricorre-re ad una lettera per il capitanio e l’intervento del castellano in favo-re degli attori faccia pensare ad un luogo sottosposto all’autorità ve-neta, come poteva essere la Cittadella. Per quanto riguarda gli ultimidue decenni del Seicento siamo a conoscenza di ben quattro compa-gnie presenti a Bergamo, di cui almeno tre recitarono nei casotti delprato di Sant’Alessandro. La prima è registrata nel mese di settembredel 1677 come debitrice verso l’Ospedale Maggiore di Bergamo perl’affitto del «teatro dei comici» in fiera36. La seconda formazione di
32. Lettera di Odoardo Palazzi a Ippolito Bentivoglio, Bergamo 12 giugno 1672,Ivi, p. 274.
33. Ibidem.34. Ibidem.35. Lettera di Vincenzo Grimani Calergi a Ippolito Bentivoglio, Bergamo 25 giu-
gno 1672, in S. Monaldini, L’orto dell’Esperidi, cit., p. 274.36. Documento 1677: 1, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 152
153
IL TEATRO DEI BORGHI
«comici» versò il «residuo dell’affitto di casotto» il 2 ottobre 168337.La data del saldo presuppone, in questo caso, che gli attori fosseropresenti nei mesi antecedenti e quindi, ancora una volta, durante lafiera annuale. È sicuramente così per la quarta compagnia che versòl’«affitto del casotto di fiera» il 20 settembre del 168538. In tutti e trei casi siamo di fronte a compagnie non identificate. È, invece, possi-bile individuare la terza troupe: presente a Bergamo dopo la secondametà di luglio del 1684, si tratta di una delle formazioni protette dal-la famiglia Farnese, quella del principe Alessandro. Se il luogo dellerappresentazioni non è conosciuto, ritroviamo il leit motif della diffi-coltà di ottenerne la concessione. Secondo il nobile bergamasco Bo-nifacio Agliardi, referente per la corte di Parma nell’impresa di pro-curare l’opportuna licenza agli attori, «non è stato poco suplicar il loc-co dalla città per ricittare, poiché l’anno passato fu negata tal licen-za»39. Un’ostinazione che venne premiata: superate le difficoltà ini-ziali e dato principio alle «recite», esse vennero accolte «con aggradi-mento»40.
Prese nel loro insieme, le poche testimonianze relative alla presen-za di attori professionisti a Bergamo nel secondo Seicento, sia che ri-guardino il periodo della fiera o quello dei mesi di giugno e di luglio,fanno riferimento alla stagione estiva, momento che permetteva di po-ter rappresentare all’aperto, secondo un modello accertato in altre cit-tà della Terraferma veneta, quali Verona e Brescia, dove le tournées ve-nivano programmate per i periodi in cui il clima era più favorevole.Eloquente in proposito quanto espresso dall’attore Giovan AntonioZanotti:
non sono mai frequentate dalle compagnie de’ comici per qualche pocodi tempo doppo Pasqua quelle città, che dano il luogo scoperto per rap-presentar comedie, come Brescia o Verona, perché sarebbe un volonta-riamente perdersi col esporsi alle stravaganze de’ tempi che per lo più rie-scono in simile stagione piovosi41.
37. Documento 1683: 4, in Regesto.38. Documento 1685: 1, in Regesto.39. Documento 1684: 1, in Regesto.40. Documento 1684: 2, in Regesto.41. Lettera di Giovan Antonio Zanotti a Girolamo Graziani, 3 maggio 1651, in
L. Rasi, I comici italiani. Biografia, bibliografia, iconografia, Firenze, 1905, vol. II, p. 743.Per la presenza di compagnie di comici dell’arte a Brescia nel primo Seicento e l’abi-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 153
154
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Sebbene per Bergamo non esistano immagini dei cosidetti «casotti»di fiera possiamo usare come modello di riferimento quelle dei teatridi legno costruiti nella piazzetta di San Marco a Venezia durante il Car-nevale, oppure quelle settecentesche raffiguranti il teatrino esistente nel-l’arena di Verona42. Nel primo caso vediamo strutture provvisorie costi-tuite da edifici molto semplici con il tetto a capanna. Poiché sono raf-figurate solo dall’esterno, non è possibile sapere né come si dispones-sero gli spettatori, né tantomeno quali spettacoli vi fossero tenuti. L’op-zione teatrale era solo una tra le tante, in quanto potevano ospitare esi-bizioni di genere molto variegato, tipiche del teatro forense. Più descrit-tive le due immagini raffiguranti il Teatro dell’Arena che mostrano unastruttura posta al centro dell’anfiteatro romano, costituita da un palco-scenico rialzato e coperto, dotato di un fondale e di quinte a scorrimen-to. Il pubblico si disponeva frontalmente e assisteva allo scoperto, inpiedi o su panche, con l’eccezione di alcuni spettatori privilegiati chetrovavano luogo in due palchetti situati ai lati dell’arco scenico.
L’esistenza di un «posticcio teatro» nel prato di Sant’Alessandro,adibito periodicamente alle rappresentazioni «comiche», è conferma-ta da Giovan Battista Angelini nella sua descrizione di Bergamo interza rima del 1720. A quell’altezza cronologica, però, secondo l’aba-te, «le Diane e le Flaminie» avrebbero disertato la città da almeno seianni, per aver riscontrato nelle loro passate permanenze «poco rac-colto di monete» e il danno «più volte della poca udienza»43. Un’as-
tudine di recitare in teatri provvisori all’aperto si veda C. Burattelli, D. Landolfi, A.Zinanni (a cura di), Comici dell’arte, cit., vol. I, p. 118.
42. Per un’immagine dei casotti provvisori edificati durante il Carnevale nellapiazzetta di San Marco a Venezia si rimanda ad una veduta di Gabriel Bella della se-conda metà del Settecento, nella quale troviamo raffigurati attori, con indosso le ti-piche maschere della commedia dell’arte, imbonitori, ciarlatani vari. Le esibizioniavvengono su strutture provvisorie di vario genere, quali assi poste orizzontalmen-te su capre, metodo molto semplice e abituale per i venditori, o all’interno di veri epropri edifici, sorta di baracche, al cui ingresso è situato un podio da cui un perso-naggio, accanto al quale campeggia un cartellone con funzioni pubblicitarie, invitail pubblico ad entrare. La figura è pubblicata in G. Busetto (a cura di), Pietro Longhi,Gabriel Bella. Scene di vita veneziana, Milano, 1995, p. 186, fig. 71. Se la forma dei co-siddetti casotti è raramente documentata dall’iconografia, il teatrino di legno del-l’Arena di Verona gode, invece, di maggiore fortuna. Due sono le immagini che loricordano, un quadro di Marco Marcolla e un’incisione di Pier Antonio Novelli, pub-blicata nell’antiporta del tomo XII dell’edizione Pasquali di Carlo Goldoni, F. Man-cini, M.T. Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. II, cit., pp. 7, 38.
43. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 376.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 154
155
IL TEATRO DEI BORGHI
senza, quella degli attori professionisti, che l’erudito bergamasco pro-clama come una fortunata circostanza, stigmatizzando il fenomenodel teatro mercenario con un duro giudizio moralistico: «Tenga lon-tana Iddio la pestilenza. Altro v’è che pensar che udir comedia, chedel peccar fomenta la licenza»44. Le peripezie economiche degli atto-ri vengono lette dall’Angelini come una segno positivo, avendo im-pedito alle «donne vecchie», ossia le attrici già in carriera, di dare ali-mento «al giovanile errore» e alle giovani emergenti di proseguire «permancanza di soldo» nella loro professione. Un commento moraleg-giante che conferma come tra i principali motivi di disapprovazionenei confronti del teatro dei comici dell’arte permanesse ancora quel-lo della presenza delle donne sul palco. Si condannava e si temeva inparticolare il potere di fascinazione da loro esercitato sul pubblico ma-schile di ogni età, dai «vecchi» ai «giovinastri». Questi ultimi soprat-tutto, secondo l’abate, avrebbero tratto particolarmente giovamentodalla lunga assenza delle compagnie di giro, avendo finalmente im-parato «a far cervello (…) né corron dietro allo spirto farfarello»45. Ol-tre alle attrici interpreti del ruolo di giovani innamorate, come perso-naggio più rappresentativo del decadimento morale del teatro merce-nario, l’Angelini individua Pantalone, avaro mercante veneziano evecchio libidinoso, colpevole di mettere in scena passioni e desideriindecenti. È quindi con estremo sollievo che l’erudito constata come«né per le donne di scena alcun delira. Pantalon paroncin or col bat-tello, lungi dal lido avaro altrove gira»46. Il veemente attacco si con-clude con l’apologia dell’assenza degli attori professionisti da Berga-mo, interpretata come trionfo dell’«onestà» e sconfitta «del piacermendace e finto», che avrebbe restituito Bergamo alla sua consuetacondizione di città onesta, laboriosa e virtuosa47.
44. Ivi, p. 377.45. Ibidem.46. Ibidem.47. Ibidem. È questa l’immagine che della città l’abate vuole dare. Contro di es-
sa non poteva che contrastare la presenza del teatro mercenario, sia nella forma del-l’opera musicale impresariale sia in quella delle compagnie girovaghe di attori pro-fessionisti. La condotta morale dei bergamaschi, al contrario, viene descritta comeirreprensibile: «in ogni conto è Bergamo cristiano, in ogni sesso e stato di persone»,Ivi, p. 206. Lo spirito religioso, presente a tutti i livelli della società, dai nobili agliartigiani, dai contadini ai commercianti, sarebbe stato particolarmente presente nel-le donne che si sarebbero distinte per pietà, onestà e riservatezza, Ivi, pp. XLIII-XLIV.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 155
156
FRANCESCA FANTAPPIÈ
La diffusa mentalità di condanna verso il fenomeno del teatro pro-fessionistico e la sua relegazione a luoghi provvisori non impedì allecompagnie di continuare a inserire Bergamo nei loro circuiti. Per ilprimo Settecento le notizie sono rare, ma costanti. Nel settembre del1725 troviamo alcuni «comici» saldare l’affitto dovuto all’OspedaleMaggiore di Bergamo per uno spazio loro concesso nel prato di San-t’Alessandro, mentre nel 1738 si registrano spettacoli tenuti «nella fie-ra nel casotto dove i comici fanno la commedia»48. Più difficile dareun significato al pagamento dell’affitto da parte di un certo Carlo Fran-cesco Quadri per «il casotto della Franceschina della fiera 1718»49. Ilnome d’arte di Franceschina era uno dei più diffusi, non solo tra leattrici, ma anche tra altre tipologie di professioniste attive nel mon-do dello spettacolo, quali cantanti e ballerine50. Tra gli attori sicura-mente presenti negli anni Trenta vi fu il romano Pietro Vecchi51. Nel1756, infine, sappiamo che morì a Bergamo, durante una tournée conla sua compagnia, l’attore e capocomico vicentino Francesco Berti, inarte Brighella52.
Se per il primo Settecento le notizie sono scarse, la seconda metàdel secolo gode fortunatamente di una maggior documentazione, gra-zie agli Indici dei teatrali spettacoli, pubblicati a Milano a partire dal Car-nevale del 1764, e alla raccolta di stampe e avvisi teatrali di FrancescoMaria Quarenghi conservata nella Biblioteca Civica di Bergamo, unacollezione che, sebbene mutila in molte parti, conserva ancora docu-
Non a caso la forma letteraria che l’Angelini sceglie per la sua opera è quella anticadelle Laudes civitatum, tipica dell’Italia settentrionale, nella quale gli aspetti sacri edevozionali delle città descritte trovavano un particolare risalto, E. Occhipinti, Im-magini di città. Le «laudes civitatum» e le rappresentazioni dei centri urbani nell’Italia setten-trionale, in «Società e Storia», XIV (1991), fasc. 51, pp. 23-52.
48. Documenti 1725: 1; 1738: 1, in Regesto.49. Documento 1728: 1, in Regesto.50. L’ipotesi che l’artista in questione sia da identificare con Camilla Bissoni,
detta Franceschina, che nel 1700 chiede alle autorità municipali la possibilità di co-struire un teatro provvisorio sotto la loggia del Palazzo della Ragione per uno spet-tacolo con i burattini, appare particolarmente intrigante ma, sulla base dei pochi da-ti a nostra disposizione, difficile da dimostrare. Su di essa si veda Supra, p. 68.
51. Cfr. Supra, p. 113-114.52. Francesco Berti fu interprete del ruolo di innamorato all’inizio della propria
carriera, per passare successivamente, con qualche successo, a quella di Brighella. Egli«fu a capo d’una compagnia che guidò con reputazione e decoro per molti anni»cui, dopo la sua morte «che accadde in Bergamo l’anno 1756», subentrò il cognatoPietro Rossi, cfr. F. Bartoli, Notizie istoriche de’ comici italiani, cit., vol. I, p. 121.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 156
157
IL TEATRO DEI BORGHI
menti preziosi, oltre a minuziosi repertori alfabetici posti all’inizio diciascun volume53. Tramite gli Indici dei teatrali spettacoli è possibile ri-costruire la composizione delle formazioni, mentre gli avvisi della rac-colta Quarenghi permettono spesso di determinare il loro repertorio.Si riscontrano così cartelloni teatrali estremamente variegati: dallecommedie all’improvviso, legate alla tradizione dell’Arte, alle fiabe goz-ziane, dalla farse ai drammi d’ispirazione storica, esotica o romanze-schi, dalle tragedie di Vincenzo Monti o di Vittorio Alfieri alla «com-media lagrimosa» di Francesco Avelloni o di Giovanni Greppi. Fattaeccezione, quindi, per il repertorio tragico, assistiamo ad un generaletrionfo del meraviglioso che soppiantò la cosiddetta «commedia di ca-rattere» o una qualsiasi ricerca della verosimiglianza54. Nella varietà digeneri proposti, quello privilegiato dalle compagnie, fu sicuramentela comèdie larmoyante, in cui il tema del conflitto tra sentimenti e va-lori morali, il contenuto patetico e il frequente ricorso a colpi di sce-na garantivano un successo immediato sugli spettatori55. Stupisce so-lo in parte quindi che, tra i titoli documentati, dove figurano testi diautori italiani come traduzioni di autori stranieri, nella continua ri-cerca di novità drammaturgiche tali da accontentare un pubblico sem-pre più differenziato, non sia mai presente il riformatore settecente-sco per eccellenza, ossia Carlo Goldoni.
53. Sulla tipologia di documento rappresentata dagli Indici de’ teatrali spettacoli sivedano O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., p. 7 e ss.; R. Verti (a cura di), Un al-manacco drammatico, cit., pp. XI-XV. All’interno della raccolta di Ducali et altre cose di-verse conservata nel fondo di Francesco Maria Quarenghi, consistente in 45 volumisono reperibili preziosi avvisi delle compagnie in transito a Bergamo (figg. 15-17).
54. Valori per i quali si era battuto nel corso di tutta la vita Carlo Goldoni conla sua riforma teatrale, sulla quale esiste una nutrita bibliografia. In questa sede ci li-mitiamo a rimandare a G. Nicastro, Goldoni e il teatro del secondo Settecento, Bari, 1974;P. Bosisio, Carlo Gozzi e Goldoni, Firenze, 1979; Id., Goldoni e il teatro comico, cit.; S.Ferrone, Carlo Goldoni. Vita, opere, critica, messinscena, Firenze, 1991.
55. La pièce o comèdie larmoyante, conosciuta in Italia, come «commedia lagrimo-sa» e in Inghilterra come sentimental comedy, nacque in Francia nel primo Settecentoe vide come suo esponente principale Nivelle de la Chausée. La diffusione italianadel nuovo genere fu più tarda. Inaugurata in parte da Goldoni, Chiari e Gozzi, spes-so attraverso una riduzione di opere d’Oltralpe, vide una definitiva affermazione nel-la seconda metà del secolo attraverso le opere di Giovanni Greppi, Giovanni De Ga-merra, Andrea Willi, Camillo Federici, Francesco Avelloni, Alberto Nota. Si veda inproposito la voce Lacrimoso teatro di A.M. Ripellino in Enciclopedia dello Spettacolo,cit., vol. VI, coll. 1130-1136.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 157
158
FRANCESCA FANTAPPIÈ
I documenti relativi agli anni Settanta sono frammentari, ma con-fermano la presenza di attori nel periodo primaverile-estivo e l’inse-rimento di Bergamo nei circuiti delle compagnie attive in area cen-trosettentrionale56. Le formazioni documentate sono normalmente dilivello medio alto e, in qualche caso, compagnie stanziali veneziane.Nel giugno del 1773 troviamo Nicola Menichelli, in arte Arlecchino57.Nella primavera del 1777 la compagnia del milanese Francesco Paga-nini58. L’anno successivo sappiamo che erano presenti gli attori LuigiDelicati e Margherita Grismondi, insieme all’attore milanese Giaco-mo Torri59. Seguirono nella primavera del 1780 e del 1785 la compa-gnia di Antonio Camerani, nell’estate del 1781 quella di Girolamo Me-debach, nella primavera del 1783 quella di Nicola Menichelli, nellaprimavera del 1785 quella di Daniele del Puppo60. Incerti i luoghi usa-ti per le rappresentazioni, in quanto non vengono mai specificati. Gliattori potrebbero aver recitato nel Teatro della Cittadella come nei ca-sotti di fiera. A differenza del secolo precedente vediamo che le com-pagnie non passavano più solo attraverso l’autorizzazione delle auto-rità locali, ma dipendevano anche dai loro contatti con gli impresari-
56. Nel corso del Settecento si determinò una divisione del territorio italiano inquattro diverse regioni teatrali: Lombardia, Toscana, Roma, Napoletano. All’inter-no di ognuna agivano differenti gruppi di attori. Nella cosiddetta «Lombardia», os-sia l’area degli stati emiliani e del lombardo-veneto, troviamo attive almeno tre ti-pologie di compagnie: «castelleggianti», di giro, stanziali veneziane. Le prime eranopiccole formazioni di mediocre livello che percorrevano i centri urbani minori. Leseconde, di livello medio-alto, percorrevano le città più importanti. Le terze, le piùrinomate, agivano nei teatri veneziani per metà dell’anno comico (autunno-invernoe Carnevale), per spostarsi in Terraferma durante i mesi estivi. Per tali definizioni sivedano G. Guccini (a cura di), Il teatro italiano, cit., 54-60 e P. Bosisio, Goldoni e ilteatro comico, cit., pp. 139-141.
57. Si veda la Cronologia.58. Si veda la Cronologia.59. Per quanto riguarda Giacomo Torri, in arte Dottore, dobbiamo la notizia ad
un commento poco lusinghiero di Francesco Bartoli, il quale lo descrive inizialmen-te attivo nelle compagnie di Girolamo Medebach e di Pietro Rossi, mentre nella fa-se finale della sua carriera «impiegossi in deboli vaganti compagnie e finalmente mo-rì in Bergamo la primavera del 1778», Notizie istoriche de’ comici italiani, cit., vol. II,p. 253.
60. Si veda la Cronologia. Se la compagnie del Camerani, del Medebach e delMenichelli godevano di ottima fama, quella di Daniele Del Puppo, che aveva inizia-to la propria carriera da imbonitore vendendo «un balsamo in banco», era meno sti-mata secondo F. Bartoli, Notizie istoriche de’ comici italiani, cit., vol. II, p. 101.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 158
159
IL TEATRO DEI BORGHI
costruttori dei teatri provvisori. Il 27 marzo 1781 sappiamo infatti che«il comico Perelli», da identificare con Luigi Perelli, firmò «una scrit-tura» con Giovan Battista Lombardi, detentore del diritto esclusivo dicostruire gli edifici teatrali provvisori sia in Cittadella sia in fiera61.
Le notizie più interessanti riguardano le formazioni presenti a Ber-gamo tra il 1786 e il 1792, delle quali conosciamo parte del reperto-rio. La rinomata troupe di Giuseppe Pellandi, attore formatosi nellacompagnia Medebach e interprete della parte di Arlecchino, presentea Bergamo nell’estate del 1786, passa con facilità dalla messa in sce-na di uno spettacolo come Gli oracoli funesti di Diana superati dalla for-za dell’amore con Trufaldino trionfatore del Minotauro all’isola de’ mostri,titolo che potrebbe ricordare un canovaccio della commedia dell’ar-te, alla Virginia tragedia di Vittorio Alfieri, fino a drammi di contenu-to fortemente patetico come la Gabriella di Vergi62. L’offerta teatrale vi-de quindi l’alternanza strategica di generi drammaturgici molto diver-si. Una logica che ritroviamo nella compagnia di Francesco Menichel-li nel settembre del 1787. La rappresentazione della saga favolosa diKouli-Kan, opera di Pietro Chiari, debitrice della moda delle turque-ries o chinoiseries, con le sue scene di battaglia e meravigliose scenogra-fie, venne suddivisa in due parti: la prima, ossia Le glorie di Kouli-Ka-no innalzato al trono di Persia, fu rappresentata la domenica, mentre laseconda, La morte di Kouli-Kano a cavallo alla testa del suo esercito alle-stita il martedì63. Il ciclo venne interrotto il lunedì dalla messa in sce-na, «a richiesta di rispettabili persone», di due «farse comiche»: Le con-vulsioni delle donne e suo rimedio per guarirle e Il pazzo ragionevole, la se-conda delle quali si presenta come la traduzione de L’Anglais ou le Fou
61. Documento 1781: 5, in Regesto.62. Si veda la Cronologia. La Virginia di Vittorio Alfieri, opera conclusa nel 1778
e pubblicata, insieme ad altre dieci tragedie, nell’edizione di Siena (Vincenzo Pazzi-ni Carli e figli, 3 voll., 1783-1784), entrò ben presto a far parte del repertorio dellecosiddette compagnie «lombarde». Lo stesso autore potè assistere ad una sua messain scena nel Teatro Carignano di Torino nel 1784, riportando un pessimo giudiziosulle qualità dell’allestimento. Si veda in proposito la voce Vittorio Alfieri, in Enciclo-pedia dello Spettacolo, cit., vol. I, coll. 298-315.
63. Nel Kouli-Kan re di Persia (1758) e Morte di Kouli-Kan (1759) il protagonista,un ex-pastore, costretto a decidere tra il trono e la donna amata, una pastorella, sce-glie il primo. Il potere lo trasforma in tiranno e viene punito con la morte, C. Vare-se, Per un’imparziale rilettura, in Pietro Chiari e il teatro europeo del Settecento, a cura diC. Alberti, Vicenza, 1986, pp. 47-75: 63-64.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 159
160
FRANCESCA FANTAPPIÈ
raisonnable di Joseph Patrat, commedia in prosa di una atto e opera digrande successo europeo64. Non mancano allestimenti propagandaticome grandi produzioni e perciò soggetti a «gravose spese» da partedegli attori. È il caso del Ludovico Sforza detto il moro, marito di Beatri-ce d’Este e zio d’Isabella d’Aragona, vedova di Gian Galeazzo Duca di Mi-lano. Nella locandina che divulga l’evento si dà particolare risalto nonsolo all’originalità del genere teatrale offerto, un soggetto storico trat-to «dalle croniche di Milano» e frutto di «quella celebre penna chenell’anno 1773 diede alla luce in Roma un dramma bizzarro intitola-to il Conclave»65, ma anche al successo delle precedenti messe in sce-na e all’attenzione prestata nell’allestimento preparato dalla compa-gnia. L’opera «rappresentata per la prima volta dalla compagnia Bat-taglia nel Regio Teatro di Torino»66 sarebbe stata replicata ben cinquevolte al suo esordio. Particolarmente allettante per il pubblico dove-va apparire il protagonista dell’intreccio, del quale si sottolinea diffu-samente il «carattere doppio», la sua «avvedutezza ed ipocrisia», «lesue violenze», le sue «più barbare carneficine», «i suoi tradimenti na-scosti»67, tracciando i contorni di un vero e proprio genio del male,degno antesignano dei grandi anti-eroi romantici. Né l’allestimentodella scenografia sembra venisse lasciato al caso. Prevedeva ben cin-que «mutazioni di scena», un «pomposo ingresso di Pavia di Carlo ot-tavo re di Francia preceduto dagli strumenti militari e circondato da’suoi uffiziali con numeroso seguito» nel secondo atto, mentre nel ter-zo atto «si vedrà una magnifica sala da ballo illuminata di cera a gior-no in cui si darà una festa da ballo». Grandiose scene corali e senza
64. Documento 1787: 25, in Regesto. Le prime traduzioni italiane de L’Anglais oule Fou raisonnable, che debuttò a Parigi nel 1780, furono pubblicate a Firenze nel 1789con il titolo di Il pazzo ragionevole, ossia il generoso inglese, farsa in un atto in prosa tra-dotta dal francese e a Napoli di L’inglese o sia il pazzo ragionevole. Comedia in un atto dimonsieur Patrat tradotta dal francese. Seguì la traduzione di Placido Bordoni edita a Ve-nezia nel 1796. L’incredibile successo dell’opera in Oltralpe è confermato anche inItalia. A Bergamo la ritroviamo nel 1792 nel repertorio della compagnia Polinà. Perquanto riguarda l’attore ed eclettico autore drammatico Joseph Patrat si rimanda al-la voce relativa dell’Enciclopedia dello spettacolo, cit., vol. VII, coll. 1774-1776.
65. Documento 1787: 27, in Regesto. Il Conclave del 1774. Dramma per musica darecitarsi nel teatro delle Dame nel Carnevale del 1775, Roma, Kracas [1775], è opera d’in-certo autore, attribuita a Gaetano Sertor.
66. Documento 1787: 27, in Regesto.67. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 160
161
IL TEATRO DEI BORGHI
avarizia di «colpi di scena», che «saranno interessanti ed eseguiti contutta la maestria»68.
Nella primavera del 1791 recitò a Bergamo la «compagnia Segali-ni», detta anche «la compagnia comica italiana diretta da’ signori Mar-zocchi e Rosa»69. Secondo gli Indici deì teatrali spettacoli gli attori si esi-birono «nel teatro di quella città»70. Un luogo di difficile identifica-zione: la stagione scelta, ossia la primavera, induce ad ipotizzare l’usodel Teatro della Cittadella, mentre la definitiva conversione in mura-tura del Teatro Riccardi, porterebbe a collocare le rappresentazioni nelnuovo edificio, polo d’attrazione molto forte per tutte le compagniedi passaggio a Bergamo negli anni successivi alla sua ultimazione. Ilprimo avviso della compagnia Segalini in nostro possesso è del 7 mag-gio. In esso gli attori affermavano di avere in programma quaranta re-cite. Come nei casi precedenti possiamo notare l’alternanza program-matica di generi molto diversi. La permanenza si aprì con «una nuo-vissima commedia» intitolata Un salutare avviso ai maritati di CamilloFederici, definita «bizzarra nella tessitura, immagine e condotta»71. Trale opere che seguirono nel mese di giugno erano invece previste bendue tragedie, la prima intitolata Penelope, la seconda Nitocri «a benefi-cio della prima donna che è la Marzocchi nella compagnia Segalini»72.
68. Ibidem.69. «Bergamo. Primavera 1791. Nel Teatro di quella Città rappresentò comme-
die e tragedie la compagnia comica italiana diretta da’ signori Marzocchi e Rosa»,Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1791 a tutto il Carnevale 1792,in R. Verti (a cura di), Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 945.
70. Ibidem.71. Documento 1791: 9, in Regesto. Opera di grande successo, pubblicata per la
prima volta a Venezia con il titolo Avviso ai maritati (1792), cui seguirono numero-se ristampe fino al secondo decennio dell’Ottocento. Rappresentata per la prima vol-ta nel Teatro Sant’Angelo di Venezia dalla compagnia Pellandi nel 1788. Autore del-la commedia è Camillo Federici, pseudonimo di Giovan Battista Viassolo, seguacedella riforma goldoniana, ma anche protagonista della diffusione in Italia del nuo-vo genere del teatro «lagrimoso», sul quale si veda la voce Camillo Federici di M.A.Aimo in Enciclopedia dello spettacolo, cit., vol. V, coll. 113-114 e quella del Dizionariobiografico degli scrittori italiani, a cura di N. Cannata, Bologna, 1997, pp. 98-99.
72. Documento 1791: 14, in Regesto. Non facile attribuire un autore alle due ope-re. Penelope è il titolo di una tragedia del 1724 di Giuseppe Salio, poeta e letteratospecializzato in questo genere teatrale, cfr. Dizionario della letteratura italiana: gli au-tori, i movimenti, le opere a cura di Ettore Bonora, Milano, 1977, 2 voll., ad vocem. DiGiacinto Magnocavallo, conte di Varengo, è invece la Nitocri pubblicata a Torinopresso Gianmichele Briolo nel 1784.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 161
162
FRANCESCA FANTAPPIÈ
L’anno successivo si esibì, sicuramente nel Teatro Riccardi, la «com-pagnia comica di Pietro Polinà»73. Gli attori arrivarono a Bergamoalla fine di aprile proclamando, come di routine, di avere in program-ma quaranta recite. La loro permanenza fu molto più lunga di quan-to annunciato o di quanto abitualmente registrato per altre forma-zioni, che normalmente arrivavano a poco più di un mese di rappre-sentazioni, ma si protrasse fino alla metà di luglio, ossia per ben qua-si tre mesi. Un dato che va sicuramente messo in relazione con ladefinitiva apertura del teatro e la necessità da parte dell’impresarioBortolo Riccardi di trarre quanto più possibile profitto dall’affittodello stabile. Necessaria quindi per gli attori un’estrema varietà nelcartellone proposto che si concretizzò in un ciclo di spettacoli mol-to articolato. Tra le opere messe in scena troviamo successi consoli-dati come La figlia dell’aria di Carlo Gozzi o le due farse il Pazzo ra-gionevole di Joseph Patrat e Le convulsioni delle donne74. Molti, infine,i titoli reperiti di difficile identificazione, quali la tragedia Geltrude eRoberto, i drammi intitolati La presa di Belgrado di Francesco Avello-ni e Clementina e Desombres di autore non identificato. Infine un dram-ma dal soggetto storico come Il re Federico di Prussia e una tragediadi Vincenzo Monti ossia l’Aristodemo75. Gli avvisi della compagnia anoi giunti propagandano, per quanto possibile, gli aspetti innovati-vi della drammaturgia proposta. Una strategia particolarmente evi-dente per Il calderaio di San Germano o sia la contessa di Varan, defini-to un «dramma novissimo in cinque atti» encomiabile per la «sceltaprosa» e «per la nuovità dell’argomento»76, o per il Rutzanzcat il gio-vine, «arcisopratragichissima tragedia» di Zaccaria Vallaresso, presen-tata, dopo una serie di argomentazioni erudite sull’inutilità di una«pedantesca esecuzione delle regole ed una ligia imitazione» dei clas-
73. Documento 1791: 24, in Regesto.74. Le convulsioni delle donne e Il pazzo ragionevole sono due farse già messe in sce-
na a Bergamo dalla compagnia di Francesco Menichelli nel 1787. L’immancabile Goz-zi è presente con La figlia dell’aria nel repertorio della compagnia Battaglia nel mag-gio del 1789.
75. La tragedia Aristodemo, in cinque atti ed endecasillabi sciolti, dopo aver vin-to il premio di Parma nel 1786 ed essere stata recitata in forma privata dallo stessoMonti, venne offerta per la prima volta al pubblico pagante al Teatro della Valle diRoma il 16 gennaio 1787 riscuotendo grande successo. Si veda la voce Vincenzo Mon-ti di F. Doglio in Enciclopedia dello Spettacolo, cit., vol. VII, coll. 795-796.
76. Documento 1792: 18, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 162
163
IL TEATRO DEI BORGHI
sici, come una valida alternativa al modello rappresentato dalla tra-gedia antica (fig. 18)77.
Recitarono sicuramente nel Teatro Riccardi la compagnia di Fran-cesco Menichelli nell’estate del 1793 e quella di Nicola Aratta nel set-tembre dello stesso anno78. Seguirono nel 1794, molto probabilmen-te ancora in Città Bassa, quella di Antonio Goldoni in estate e di Bar-tolomeo Zuccato in autunno79. Il repertorio di queste troupes è scono-sciuto. Per quanto riguarda la formazione Goldoni sappiamo che eraaccompagnata da Francesco Avelloni, scritturato come «poeta di com-pagnia» e autore specializzato nella «commedia lagrimosa»80. Nel 1795tutti i gruppi di attori registrati a Bergamo si esibirono nel Teatro Ric-cardi: quella di Pietro Pianca nella primavera, di Luigi Mazzotti Ma-lipiero in giugno e di Antonio Mariani in autunno81. L’alta concen-trazione di spettacoli teatrali attesta lo strenuo impegno del proprie-tario del teatro nel promuoverne l’attività. Particolarmente significa-tiva in tal senso la presenza, nella primavera del 1796, di una forma-zione estranea al circuito teatrale lombardo-veneto, ossia la «compa-gnia comica toscana diretta da Luigi Del Buono»82, in arte Stenterel-lo. Una novità assoluta per Bergamo, così come per Modena, Lodi e
77. Documento 1792: 20, in Regesto.78. Si veda la Cronologia.79. Si veda la Cronologia.80. Il poeta di compagnia Francesco Avelloni, autore di quasi seicento drammi
tra pubblicati, manoscritti o irreperibili (drammi lacrimosi, azioni allegoriche, com-medie di imitazione goldoniana, etc.) deve la sua fortuna al genere della commedialagrimosa. Nella sua vita si legò a molte compagnie. Introdotto al teatro da Alessan-dro Zanchi, iniziò la sua collaborazione con le formazioni di attori professionisti aVenezia, prima con la compagnia Medebach e poi con quella Battaglia. Abbando-nata la Serenissima, lavorò a Roma e successivamente a Napoli, città nella quale mol-ti dei suoi drammi furono presentati al pubblico come opera di Francesco di San-gro dei principi di San Severino impresario del Teatro del Fondo. Si vedano la vo-ce Francesco Avelloni di C.E. Tanfani, in Enciclopedia dello Spettacolo, cit., vol. I, coll.1175-1176 e quella di M.L. Scauso in Dizionario biografico degli italiani, cit., vol. IV,pp. 655-656.
81. Si veda la Cronologia.82. Per la definizione si rimanda all’Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla
primavera 1796 a tutto il Carnevale 1797, in R. Verti (a cura di), Un almanacco dramma-tico, cit., vol. II, p. 1221. Gli attori diretti da Luigi del Buono recitarono a Modenain Quaresima, a Bergamo in primavera, a Lodi in estate e in autunno a Bologna, O.Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., p. 145.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 163
164
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Bologna, uniche altre città centro-settentrionali toccate dalla tournéedella formazione nell’anno comico 1796-1797. Si tratta dell’ultimapresenza accertata di una compagnia di attori professionisti nel Tea-tro Riccardi prima della cosiddetta rivoluzione bergamasca del 1797.La «compagnia comica italiana diretta di Francesco Buratti» infatti,presente a Bergamo nell’autunno del 1796, tenne le proprie rappre-sentazioni nel «Teatro in Città», identificabile con il Teatro della Cit-tadella83. Il repertorio è sconosciuto. In merito alle rappresentazionisappiamo che la serata del 10 dicembre 1796 fu interamente dedica-ta a «Gnudi Paolina prima comica nella compagnia Buratti»84.
1.2. Le feste di Carnevale in Borgo San Leonardo e il teatro circense1.2. in fiera
Le notizie a noi pervenute su spettacoli di tipo circense tenuti nel-l’area destinata alla fiera di Sant’Alessandro sono tutte settecentesche.Le più antiche si devono alla descrizione di Bergamo in terza rima diGiovan Battista Angelini del 1720. La maggior parte sono, tuttavia,del secondo Settecento e, con l’eccezione di alcuni dati reperiti neisuperstiti e preziosi libri contabili dell’Ospedale Maggiore, si trovanoprincipalmente nella raccolta di stampe e avvisi di Francesco MariaQuarenghi. In generale si evince che non era solo la fiera ad ospitaremanifestazioni difficilmente iscrivibili sotto la categoria del teatro re-golare, ma era la Città Bassa in generale, nella quale confluivano lamaggioranza dei cosiddetti «forestieri», a distinguersi come luogo pri-vilegiato di spettacoli molto diversificati.
Borgo San Leonardo, in particolare, si attesta come l’area favori-ta per i festeggiamenti del Carnevale, durante il quale lungo l’attua-le Sentierone e attorno a piazza Pontida, un tempo detta piazza del-le Legne, si riversavano le persone vestite in maschera (fig. 1)85. Se-condo Giovan Battista Angelini il motivo per cui il quartiere attira-
83. Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1796 a tutto il Carneva-le 1797, cit.
84. Documento 1796: 30, in Regesto.85. Un’abitudine che risaliva almeno all’inizio del Seicento, se come riportato
da P. Mosca, Arte e costume a Bergamo. Seicento, presentazione di A. Possenti, Berga-mo, 2003, p. 55, in Borgo San Leonardo il 29 gennaio 1615, in occasione del Car-nevale, avvenne un duello tra due gruppi di persone mascherate.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 164
165
IL TEATRO DEI BORGHI
va tutte «le maschere a sé», mentre «negl’altri borghi ed in cittade»ne poteva essere ammirata «solo qualcheduna», andava ricercato nel-la storia antica della città: «perché qui corra il mascherato stuolo, èla ragione che antico tempio, era innalzato a Bacco in questo suo-lo»86. Sarebbe stata, quindi, l’area anticamente riservata ai «baccana-li» i quali, in epoca romana si sarebbero tenuti in marzo e che, nelSettecento, sarebbero passati all’inverno. La condanna dell’abate neiconfronti dell’abitudine di travestirsi per Carnevale, e più in parti-colare l’allargamento di questa concessione alle donne nel 1662, èinflessibile. Con l’occasione, infatti, sarebbe svanita «la modestia» ti-pica della città e si sarebbe dato largo spazio al lusso87. Con l’inten-zione di ribadire il proprio giudizio moralistico l’erudito descrive am-piamente il fenomeno, permettendoci di constatare quanto fosse dif-fuso e condiviso dalla società bergamasca. Vediamo così che dopoNatale, nonostante il freddo, i giovani si mascheravano. Le donne,invece di coprirsi, coglievano l’occasione per indossare vestiti suc-cinti, percorrendo volentieri a piedi «dai borghi alla città le salit’er-te», senza lamentarsi per la fatica pur di esibire il proprio travesti-mento. Quali i costumi possibili? La maggior parte di quelli registra-ti dall’abate proviene dal teatro. Si va dalle principali maschere del-la commedia dell’arte, a personaggi ispirati alla tradizione del gene-re bucolico-pastorale, fino a tipi “comuni” caratterizzati semplice-mente dal mestiere o dalla nazionalità. Ecco quindi «chi messer Bel-trame si finge, in guisa di persona milanese, e col linguaggio cian-cione, e grossolan move le risa», «chi di dottor Graziano fa ‘l perso-naggio bolognese», «chi di Coviello e Capitan Paura napoletano inandamento altero sbuffa l’orror, milanta la bravura», «chi fa da cala-brese cavaliero Giangorgolo vo’ dir, ch’ha lungo il naso, alto il cap-pello, al dorso col forziero», «chi da Pulcinella in capo raso una cup-pola innalza e va gobbuto» portando un vaso «pieno de macchero-ni», «chi si fa zane bergamasco astuto», «chi si traveste, al nostro dir,da Tone con la salsiccia e con un’otre in mano, parla milenso e gi-ra dondolone»88. Otto maschere di varia provenienza che mostranochiaramente come la cultura teatrale degli attori professionisti, no-
86. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 410.87. «Non da gran tempo è l’introdotto abuso, se van le donne mascherate, ch’ora
s’è stabilito e ognor va più diffuso», Ivi, p. 407.88. Ivi, p. 409.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 165
166
FRANCESCA FANTAPPIÈ
nostante gli ostacoli, fosse penetrata largamente nella vita cittadina.Tutti personaggi ridicoli tra cui è possibile distinguere almeno duefiloni. Uno “locale”, in cui vanno inseriti Beltrame, parte inventatadall’attore Nicolò Barbieri, lo «zane bergamasco» e infine Toni, i cuisegni distintivi, le salsicce e il fiasco di vino in mano, ricordano mol-to da vicino quelli della maschera di Gioppino. L’altro filone è “fo-restiero” e vede, con l’eccezion del dottore bolognese Graziano, unaprevalenza di maschere di area meridionale: i servi Coviello e Pulci-nella, il Capitan Paura napoletano e il calabrese Giangurgolo che dalruolo di vecchio, abitualmente riservatogli, slitta a quello di «cava-liero». Seguono costumi derivati da vari generi teatrali quali «l’inna-morato villanello», la «cingara indovina», il personaggio esotico «conil turbante in capo alla moresca»; le nazionalità e i mestieri: «il mu-gnaio», «chi svizzero si finge», «chi da pastor va con la piva a lato, efa salti sgarbati e giravolte»; infine una classica inversione di gene-re: «chi d’una dama in abito apparisce»89. Tutte «maniere stolte» perl’Angelini, che mostrano quanto «fu sempre il mondo cieco», poi-ché il Carnevale, con i suoi travestimenti, avrebbe tolto alla ragione«tutti i rispetti», vanificando le differenze sociali: «in maschera parlecito che sia, fuor di maschera il che non si concede»90.
Gli avvisi di tardo Settecento confermano la forza di attrazionedi Borgo San Leonardo e in particolare dell’attuale piazza Pontida,area dove si concentravano molte osterie e sale aperte al pubblico,per spettacoli di vario genere. Ritroviamo il filone dei travestimentiin maschera nel gennaio del 1781, quando il quartiere fu sede di unasorta di festa di rovesciamento carnevalesco, descritta come un «in-coronamento da Policinelli fatto in genaro 1781 al podestà AlviseContarini in Borgo Santo Leonardo»91. Non si tratta dell’unica tipo-logia d’evento spettacolare ivi registrata. Il 9 aprile del 1790 tenne leproprie esibizioni «nella sala di Emanuele Chiapella in Borgo SanLeonardo» un certo Ignazio Vignola «poeta improvvisatore»92. Il 17aprile dell’anno seguente un certo Francesco Vicario «novarese or-bo, grande sonatore» dette saggio delle proprie abilità musicali «al-
89. Ibidem.90. Ibidem.91. Documento 1781: 4, in Regesto.92. Documento 1790: 15, in Regesto. Quattro giorni prima il poeta improvvisa-
tore si era esibito in teatro.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 166
167
IL TEATRO DEI BORGHI
l’Osteria del Fondaco in Borgo San Leonardo»93. Il 18 aprile del 1792fu la volta di «un’accademia di canto» tenuta «in piazza della legnanella sala dell’illustrissimo Bortolo Facheris»94. Infine, nella vicina«contrada di Broseta» venne lanciato nel 1785 «un ballone areosti-co», spettacolo che ebbe «una bellissima riuscita, concorso e rinfre-sco» in casa del nobile Vincenzo Vitalba95.
Il corso delle carrozze, che sembra percorresse l’attuale Sentiero-ne, rappresentava il culmine delle feste del Carnevale e uno degli even-ti spettacolari preferiti dalla nobiltà bergamasca per tutto il Settecen-to. Anche in questo caso l’Angelini, prima di offrirne una descrizio-ne, propone un’ipotesi di derivazione antica. Nel primo Settecento,secondo l’erudito bergamasco, «nel prato della fiera» si sarebbe tenu-to «l’uso per anco ad ora de’ giochi eguiri u’ provansi i cavali al cor-so bene», esercizi cui un tempo era «destinato ‘l giorno 29 di genna-io e febraio il ventisei»96. Le corse con i carri, invece, che in epoca ro-mana avrebbero avuto luogo «sul Monte San Giovanni» in Città Al-ta, sarebbero passate ai Borghi: «or que’ giochi circensi che facea concarrette, con cocchi e con destrieri» sono eseguiti «da dame e cavalie-ri nel Borgo San Leonardo in corso e fanno questi le veci de’ cocchie-ri»97. L’Angelini descrive una sfilata tenuta nel Carnevale del 1720: «incomparsa si videro quest’anno con pennacchi e con nastri in varie gui-se, le redini trattar sedenti in scanno»98. Un evento particolarmentearticolato a cui la nobiltà bergamasca partecipò suddivisa in due squa-dre, distinte da colori diversi, così come il pubblico che indossava quel-li dei propri beniamini. Bianchi contro rossi: i primi a simboleggiarel’inverno e la vecchiaia, i secondi l’estate e la gioventù.
Un «corso straordinario di carozze nel Borgo Santo Leonardo ladomenica ultima di Carnovale» è registrato il 2 marzo 178399. Poichési trattava di una manifestazione che godeva di una forte partecipa-zione di pubblico, le autorità cittadine imposero progressivamente unaregolamentazione sempre più rigorosa alla sfilata. Il 17 febbraio 1789
93. Documento 1791: 8, in Regesto.94. Documento 1792: 7, in Regesto.95. Documento 1785: 1, in Regesto.96. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 411.97. Ibidem.98. Ibidem.99. Documento 1783: 4, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 167
168
FRANCESCA FANTAPPIÈ
si stabilì, ad esempio, che le carrozze avrebbero «dovuto fermarsi inBorgo S. Leonardo nel corso dalla parte opposta alla chiesa di S. Leo-nardo onde» potessero «le altre correre»100. Il 12 gennaio del 1796 siproibì il porto d’armi durante «il solito divertimento delle maschereed il corso delle carrozze in Borgo San Leonardo», vietando «di pra-ticare spari d’armi da fuoco a rocchette, rocchettoni e simili»101. Unaltro tipo di corsa, documentata negli ultimi due decenni del Sette-cento, era quella dei lacché. Abbiamo testimonianza di simili gare te-nute negli anni 1781, 1785, 1786, 1788 e 1796, anche se la perdita del-le descrizioni relative a tali eventi, non permette di capire né dove sitenessero, né in che modo102. Semplici corse podistiche, oppure a ca-vallo?
Se questo era il Carnevale, anche l’estate offriva numerosi diverti-menti. Quello principale era la fiera. La vasta gamma di tipologie spet-tacolari e l’estrema varietà di passatempi da essa offerti sono descrit-ti dall’Angelini e confermati dai documenti tardosettecenteschi. In que-sto caso il giudizio dell’abate è meno rigoroso rispetto a quanto espres-so sul teatro professionistico o sull’abitudine di travestirsi per Carne-vale, ma non per questo unilateralmente positivo. Il biasimo, mani-festato in maniera più o meno palese, viene in parte attenuato da unamalcelata fascinazione nei confronti di alcuni tipi di divertimento. Ingenerale, però, il punto di vista rimane quello di una compiaciuta su-periorità rispetto alle reazioni del pubblico, descritto come troppo in-genuo e facilmente influenzabile. Né viene giudicato un bene che mol-te persone venissero a visitare la fiera solo per vedere gli spettacoli ele distrazioni offerte, disertando le botteghe del mercato, dove avreb-bero dovuto tenere i propri affari: «Pur la folla maggior, ch’ogn’altraeccede, dove stanno indovini e cerretani, cantambanchi e funambolisi vede»103. Tra gli imbonitori troviamo «l’astrologo» che «parla al vil-lano» e legge la mano a «quest’e quella contadina», lusingandola conpromesse fittizie di amori corrisposti e felicità coniugali104. Segue «ilcerretan» che vende «un vaso d’antidoto e di balsamo, schiamazza, ea chi mal ha di capo il porge al naso. Giura che de’ fanciulli i vermi
100. Documento 1789: 7, in Regesto.101. Documento 1796: 6, in Regesto.102. Documenti 1781: 1; 1785: 6; 1788: 11, in Regesto.103. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 373.104. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 168
169
IL TEATRO DEI BORGHI
ammazza, che per foco, velen, ferite è raro; contro ogni che fe’ le pro-ve in piazza»105. Rimedi che raramente si rivelano benefici, ma più fre-quentemente dannosi, soprattutto per le tasche di chi, credendo allaloro efficacia, li acquista. Unica consolazione per costoro è quella diascoltare «una sonata, una canzon geniale» offerta poco lontano e, tro-vando un «sito bono» facendosi «largo dalla gente folta», godere del-lo spettacolo musicale «in piè»106. È possibile assistere ai «balli dellebambole» tenute «in certo oscuro loco», probabile antenato del tea-tro d’ombre, così come all’esposizione di fenomeni della natura, ani-mali selvaggi e feroci al pari di esseri umani deformi107. Nella folla c’èchi «o là, grida, un gran mostro», nato «nella parti africane» dai «mem-bri doppi e con due teste», seguito subito dopo da altri che strepita-no: «o là qui avvien si mostri una simia, una tigre, una pantera»108. Al-l’entusiasmo degli spettatori creduloni l’Angelini contrappone il sar-castico commento di una persona ormai assuefatta a simili manifesta-zioni: «a me non cale, perché non è cosa nova il veder tali bestie infiera»109.
Almeno due tipi di spettacolo scalfiscono parzialmente l’integritàdi giudizio espresso dall’abate: i balletti acrobatici sulla corda e i co-siddetti mondi niovi, ossia le raffigurazioni di luoghi sconosciuti e lon-tani fatti vedere attraverso una scatola ottica, opportunamente chio-sati da colui che li esponeva110. Attraverso un «cristal» è, infatti, pos-
105. Ivi, p. 375.106. Ibidem.107. Ivi, p. 376. L’esibizione di esseri viventi mostruosi, uomini, donne o anima-
li, in fiera, secondo P. Mosca, Arte e costume a Bergamo, cit., p. 166, è documentatagià da metà del Seicento da Donato Calvi.
108. Ivi, p. 375.109. Ibidem.110. Vari gli esemplari settecenteschi di scatole ottiche o mondi niovi, con le re-
lative vedute ottiche, a noi pervenuti. Attraverso una lente posta in uno o più forioperati su una cassa di legno, dentro cui si trovava una lastra di vetro dipinta, lospettatore poteva vedere raffigurazioni di ogni genere, paesaggi fantastici o realmen-te esistenti, viaggiando con la propria immaginazione in luoghi altrimenti inacces-sibili. Molte le testimonianze iconografiche di ambulanti, i quali portavano le loroapparecchiature pseudo-scientifiche nelle piazze o nelle fiere delle città europee, cfr.P. Bertetto, D. Pesenti Campagnoni (a cura di), La magia dell’immagine. Macchine espettacoli prima dei Lumière nelle collezioni del Museo Nazionale del Cinema, Milano, 1996,pp. 10, 12, 14, 27-30, 37, 44-45. Per un’idea della diffusione e dell’evoluzione del fe-nomeno, dalle scatole ottiche al teatro d’ombre, fino alla lanterna magica, della mo-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 169
170
FRANCESCA FANTAPPIÈ
sibile vedere «il mondo novo» e ammirare scene di vario genere: unasala di Parigi con «cavalier e dame assisi al gioco», «la cittade di Mar-siglia e ‘l suo porto di mar con navi altere», «la boema selva con alte,ombrose piante», «l’assediato Corfù» circondato dalla «piena di tur-chesca nazion»111. Uno spettacolo che si conclude con la fine del com-mento sulle immagini da parte del presentatore: «Chiusa tal scena, al-lor che qui si tace con trombe e con tamburi a suon d’invito con in-tenso clamor turba si sface»112. Gli equilibristi si esibiscono con ac-compagnamento musicale in uno spazio apposito, una sorta di recin-to: «il loco egl’è dei ballator in corda, ch’ampio teatro forma in qua-dratura, e dove a vario ballo il suon s’accorda»113. Nella descrizionedelle loro perfomances acrobatiche traspare ammirazione e meraviglia:«su corda il saltator ben tesa, e dura, con lungo legno equilibrato inmano, scorre saltando e i salti suoi misura»114. L’acrobata «spicca inaria a vol sovrano» e poi ricade sulla corda, ripetendo lo stesso eser-cizio fino alla fine del percorso. Numerose le figure eseguite: «cocco-lon piomba e come al balzo palla con risalto maggior sorge tantosto»,oppure «le gambe inarca ardito in aria» per scendere nuovamente conun piede. Se la corda è meno tesa «supin si stende» per poi risalirnea cavallo «con quattro giravolte», oppure vi rimane legato solo con ilcorpo «penzolone e le man batter non cessa»115. Vari gli esercizi diffi-cilmente interpretabili come «la figura di sirena finge, ove boccon lemani e il piè attorciglia», oppure «coll’una ed altra man la corda strin-ge e fra quella e sue braccia il corpo in giro tutto, che si contorce en-tro e fuor spinge» ed infine «carpone» cammina sulla corda «in guisadi scoiattolo o di ghiro». Spesso i numeri acrobatici sono inframmez-zati da colpi di scena, come una «finta caduta con bell’arte», per man-tenere alta la tensione degli spettatori «fra speranza e timor mille so-spensi». Una descrizione entusiasta, cui segue un giudizio moralisti-
dalità di fruizione da parte del pubblico, popolare come aristocratico, della fascina-zione esercitata da questa forma di spettacolo, si vedano almeno D. Pesenti Cam-pagnoni, Verso il cinema. Macchine spettacoli e mirabili visioni, appendice di D. Robin-sono, Torino, 1995; G.P. Brunetta, Il viaggio dell’iconauta dalla camera oscura di Leona-ro alla luce dei Lumière, Venezia, 1997; V. Tosi, Il cinema prima del cinema, Milano, 2007.
111. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 374.112. Ivi, p. 375.113. Ibidem.114. Ibidem.115. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 170
171
IL TEATRO DEI BORGHI
co. Questa volta però non contro gli esecutori, ma verso coloro che,invece di ammirare l’abilità degli acrobati, guardavano solo la loro fi-sicità, e in particolar modo il corpo delle ballerine «penetrando il pen-sier dove non lice, per quella parte ch’apparisce fuora»116.
Le tipologie di spettacolo “censite” dall’Angelini nel primo Sette-cento trovano conferma nelle notizie riguardanti la seconda metà delsecolo. I documenti relativi a questo periodo mostrano come la fieraoffrisse ogni sorta di divertimento circense. Per quanto riguarda l’even-tualità di vedere animali feroci o esotici le modalità di fruizione era-no molteplici. Le più frequenti: la loro semplice esposizione o l’alle-stimento di spettacoli venatori. Nell’estate del 1773 troviamo «un ve-neziano che» conduceva «dalla Barbaria e dalla Siberia undeci anima-li tutti vivi», tra cui un leone, una leonessa «giovane e molto forte»,«un leopardo di smisurata grandezza», «una pantera», «un occifanod’Egitto», «un camello di Barbaria tutto bianco», «un avoltoio», «unsatiro giovane dell’Indie», oltre «tre altri animali piccioli e rari». Glianimali vennero mostrati in un casotto di fiera (figg. 21-22)117. Nel-l’agosto del 1791 fu la volta di «una tigre reale», di una «gran hienamaschio e femmina nominata nella Sacra Scrittura» e di un «grandeavvoltoio», tutti «animali ferocissimi» portati in fiera da Antonio Cap-pellino118. Meno paurosa, ma altrettanto interessante, doveva esserel’esposizione di Carlo Somaschi «milanese professore d’imbalsamareanimali al naturale»119. L’altra possibilità, ossia l’utilizzo di animali fe-roci per spettacoli venatori, è documentata almeno dal 5 settembre1759, quando Giuseppe Cortesi «oste al salnitro» organizzò una «cac-cia dell’orso nella Dogana»120. Nel Carnevale del 1787 «nello steccatodel fabbricato nuovo dirimpetto alla fiera», ossia nel Teatro Riccardinon ancora ultimato, venne allestita da «Francesco Cagnola verone-se peritissimo capocaccia», una «magnifica e strepitosa caccia de’ toricon scielti e bravissimi cani forestieri». Lo spettacolo fu seguito da «stu-pendissimi fuochi artifiziati»121. Due anni dopo, «per li otto giorni di
116. Ivi, p. 376.117. Documento 1773: 3, in Regesto.118. Documento 1791: 45, in Regesto.119. Documento 1791: 44, in Regesto.120. Un altro episodio di caccia al toro fu tenuto nel luglio 1778 nelle «case del
Todeschini», Documento 1778: 4, in Regesto.121. Documento 1787: 2, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 171
172
FRANCESCA FANTAPPIÈ
fiera», abbiamo l’avviso di una caccia di tori seguita da una «cucca-gna»122. Non mancano gli animali ammaestrati, unica tipologia dispettacolo che l’Angelini loda, apparentemente senza riserve: «Si ve-de in fiera pur danzare in giro e far più giochi un erudito cane, e que-sto più dell’altre cose ammiro»123. Il solo avviso a noi giunto, relativoa questa forma d’intrattenimento, descrive una performance particolar-mente strabiliante. Nel marzo del 1790 il veneziano Agostino Bernar-di annunciò l’esibizione di «un cane tedesco» da lui ammaestrato «asapere leggere e conoscere tutte le lettere del alfabetto in maniera checompone e mette insieme tante lettere quante sono necessarie a for-mare qualsivoglia nome» che agli spettatori fosse piaciuto richiedere.Il cane avrebbe mostrato di saper «sommare, contare, moltiplicare edimostrare le quattro regole dell’aritmetica». Inoltre indicare l’ora, ri-conoscere i colori, distinguere «il valore delle monete» e infine inten-dere «l’italiano, il francese ed il tedesco» e fare «giuochi con carte nonmai veduti li simili». Unico al mondo nel suo genere le sue abilità sa-rebbero state già mostrate nelle più rinomate corti d’Europa. A Ber-gamo venne eposto «nel casotto di fiera»124.
La fiera rappresentava, quindi, un mondo di meraviglia e fantasiain cui, allo scopo di sorprendere e sbalordire un pubblico increduloe facilmente suggestionabile, veniva mostrato tutto ciò che non rien-trava nella quotidianità. Non importava che si trattasse di uomini odi animali. Bastava che fossero straordinari e che non appartenesseroall’ordine “naturale” delle cose. Un filone estremamente importanteera quello dell’esibizione di esseri umani fisicamente deformi. Nel-l’agosto del 1738 venne mostrato in «fiera nel casotto dove i comicifanno la commedia» un uomo che, nonostante la sua condizione fi-sica, essendo «aborto di natura che ingiuriosa lo fece nascere senzagambe e senza coscie» e senza l’uso di una mano «della quale non hache due sole dita» riusciva ad eseguire «giochi meravigliosissimi»125.Nell’agosto del 1787 è la volta di «una delle più rare meraviglie del
122. Documento 1789: 47, in Regesto.123. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 378. Il motivo per cui l’aba-
te afferma di ammirare l’«erudito cane» è che, al contrario di quanto avviene nor-malmente, «non il padron al can, che ‘l serve ognora, ma ‘l cane al suo padron man-tiene il pane», Ibidem.
124. Documento 1790: 13, in Regesto.125. Documento 1738: 1, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 172
173
IL TEATRO DEI BORGHI
mondo», ossia di «una donna italiana d’età d’anni 30, d’altezza 3 pal-mi e mezzo», «nata dalla madre naturale senza mani, con due braccianon più lunghe d’oncie tre, senza gambe, co’ piedi attaccati alle gi-nocchia proporzionati alla sua natura»126. Anche in questo caso, no-nostante la deformità, essa poteva eseguire molte azioni sorprenden-ti, come filare e cucire, oltre ad aver partorito un figlio del tutto nor-male127. Nel corso della fiera del 1790, in «una sala in faccia all’Alber-go Imperiale nella contrada di Prato, Borgo San Leonardo» venne mo-strato «il piccolo uomo di Selva Nera, chiamato Akenheil»128. Un crea-tura eccezionale già esibita in numerose città e nelle maggiori cortid’Europa. Un ragazzo di quattordici anni «alto solamente tre palmi emezzo» ma, secondo l’avviso, «benché questa sorta di fenomeni rarisiano generalmente nella loro figura ributtanti, pure questo ben di-verso da tutti gli altri è ben proporzionato». Si diceva che conoscessevarie lingue, suonasse diversi strumenti, cantasse e facesse «alcunigiuochi di mano»129.
Stupore e meraviglia quindi. Non solo di fronte ad esseri viventi stra-ordinari, ma anche per invenzioni meccaniche o pseudoscientifiche, og-getti strabilianti creati dall’uomo. Gli esempi in questo caso sono nu-merosi e non sempre di facile decifrazione. Potevano essere semplici fi-gure di cera, esposte quando nel «casotto del salnitro», quando «all’Al-bergo Imperiale in Borgo S. Leonardo», oppure genericamente «in fie-ra». Ritratti delle maggiori autorità politiche o personalità del momen-to, da Luigi XV a papa Pio VI, fino al «Gran Sultano colla Sultana suafavorita», oppure famosi malviventi come «la crudele Babet, appiccataa Montargì per aver barbaramente trucidato un tenero suo figlio»130, fi-no ad una statua di Venere. Non mancavano le ricostruzioni di partianatomiche di esseri viventi, quali «una testa di cera» in cui era visibilel’interno con il «cerebro», i «nervi» e le «vene», «un braccio umano», «unagamba e piedi cavallo», etc.131. Particolarmente apprezzate erano le figu-
126. Documento 1787: 19, in Regesto.127. Ibidem.128. Documento 1790: 30, in Regesto.129. Ibidem. Durante il suo ultimo giorno di permanenza Akenheil o «piccolo
uomo della Selva Nera» venne mostrato al pubblico nel tezzone del salnitro: Docu-mento 1790: 33, in Regesto.
130. Documento 1789: 30, in Regesto.131. Documenti 1786: 36; 1788: 36, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 173
174
FRANCESCA FANTAPPIÈ
re meccaniche, in alcuni casi animate. Nel giugno del 1786 «il macchi-nista Giuseppe Tanzi milanese» in una «rimessa dell’Albergo Reale»espose la sua ultima invenzione: un «cavallo formato al naturale» con«tutti li movimenti propri» di un animale vero132. Il 29 aprile del 1787«nell’Albergo dell’Aquila Imperiale d’Oro nel Borgo San Lionardo» fu-rono mostrate al pubblico «due figure di legno» rappresentanti un pa-dre e una figlia; ingegno del «signor Fridolin Flury machinista del can-tone Glarus degli Svizzeri» erano costruite per eseguire vari esercizi, tracui contare, giocare a dadi, riconoscere i colori, etc.133. Tra le invenzio-ni esposte in fiera nel 1789 troviamo «una macchina, che costruita permezzo d’un interno meccanismo, suona diversi istromenti colla varia-zione di differenti sonate»134. Ma soprattutto dispositivi proto-cinema-tografici, quali «le ombre francesi fisiche-mecaniche» dei fratelli Man-geani già esposte nel «teatro di Sua Maestà a Parigi» o nel teatro Realedi Londra, visibili a Bergamo durante la fiera del 1787 «nel luogo delsalnitro», probabilmente un casotto vicino al tezzone presso le mona-che di Santa Marta (fig. 23). Grazie alle «suddette ombre» era possibilerappresentare «piccole commedie con pantomime dilettevoli» davantia «decorazioni boschereccie, montagne, pianure, anfiteatri, palagi, fon-tane, scherzi e giuochi d’acque, cadute, giardini, templi e disegni di fab-briche tra le più belle d’Europa»135. Tra le storie animate previste quellapiù grandiosa è intitolata Malbrouk in campo «mai più rappresentato inalcun teatro. Si vedrà l’armata, provvisione di guerra, infanteria, caval-leria, cannoni, bombe, carri, vivandieri e vivandiere, ed altro seguito del-l’armata»136. Questa sarebbe stata seguita da «un temporale sul mare, unnaufragio di molti vascelli, colla perfetta imitazion della pioggia, tem-pesta, tuoni e fulmini, il tutto naturale. Di più comparirà un ballerinoinglese»137. Se tutto ciò è da ricondurre al théâtre des ombres chinoises spe-rimentato in Francia dalla seconda metà del Settecento, meno facile com-prendere lo svolgimento di altri esempi di teatro meccanico138. Tra di es-
132. Documento 1786: 21, in Regesto.133. Documento 1787: 15, in Regesto.134. Documento 1789: 42, in Regesto.135. Documento 1787: 23, in Regesto.136. Ibidem.137. Ibidem.138. Sul teatro delle ombre cinesi di Audinot introdotto alla fiera di Saint Ger-
main in Francia (1760) si veda P. Bertetto, D. Pesenti Campagnoni (a cura di), Lamagia dell’immagine, cit., p. 121.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 174
175
IL TEATRO DEI BORGHI
si troviamo le «egregie macchine» di Lorenzo Ferzi «di nazione tirolese»esposte durante la fiera del 1788 «in un casotto dirimpetto all’OspitalMaggiore»139. Automi straordinariamente articolati, uno dei quali rap-presentava «il Trionfo dell’Imperatore del Mogol» ed era «in quattro faccia-te», su ognuna delle quali si trovavano raffigurate varie scene animate.Sulla prima si vedevano «alcune serpi che, pel loro meccanismo, fannode’ movimenti che sembrano naturali», seguivano «due faccie d’Archi-mede» e in alto «un elefante che sembra vivo»140. Nel secondo lato siscorgeva «un fiore detto Passion formato di diamanti che fa tre movi-menti contrari» contornato da altri fiori del giardino dell’Imperatore conle guardie «che fanno la ronda, armati all’indiana». Alla terza facciata sivedeva «una stella composta di cinque punte spirali, attorniata d’un’in-finità d’altre più piccole il di cui meccanismo sorprende». Sulla quarta«il palazzo ed il giardino dell’imperatore del Mogol guernito di brillan-ti» con «la famiglia reale che vi passeggia» e in alto «un giglio il cui mo-vimento è maraviglioso, così pure un girasole di gemme a tre diversi mo-vimenti»141. Se questo spettacolo viene accuratamente descritto dall’av-viso a noi giunto, più problematico è capire in cosa consistesse l’esibi-zione di Bortolo Martinelli e «compagnia veneziani», avvenuta duran-te la fiera del 1791, i quali mostravano «un edificio matematico il Bu-cintoro»142.
Associati agli spettacoli ottici e pseudo-scientifici vi erano gli im-bonitori, venditori e ciarlatani, in un miscuglio così articolato che nonrende sempre facile attuare una distinzione. Arduo comprendere lareale natura dell’esibizione del «macchinista» Francesco Rupano ilquale, nel corso della fiera del 1789, vendeva «diversi secreti» e «nel-la sala del sarto Giuseppe Antonioli» faceva «giochi di mecanica e dimatematica»143. Molto semplice è invece la lettura dell’avviso di unvenditore veronese, il quale pubblicizzava «tre segreti di tre acque, unadifferente dall’altra» tra cui la prima avrebbe curato «il dolor di testa,flussioni d’occhi, umidità, catarri» e infine «il dolor di denti»144. Si espo-nevano assortimenti di tessuti, o «telerie», così come apparecchi per
139. Documento 1788: 37, in Regesto140. Ibidem.141. Ibidem.142. Documento 1791: 46, in Regesto.143. Documenti 1789: 45, 56, in Regesto.144. Documento 1788: 32, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 175
176
FRANCESCA FANTAPPIÈ
la loro tessitura. Nel 1786 in «un casotto di fiera dirimpetto al salni-tro» Giorgio Aman mostrò «le sue macchine, tra le quali» vi era «unamacchinetta che consiste in un telarino tutto organizzato di suste, do-ve da una figurina matematica al naturale come se fosse persona vivasi fabbricano sei pezze di cordella di seta all’uso di Francia»145. Si ven-devano oggetti di antiquariato, come «quadri, carte e cose antiche»,al pari di «mirabili secreti» esposti da un sedicente «chimico»146. Co-stituivano un motivo di attrazione anche opere di scultura, in cui siraffiguravano articolate scene di genere, esposte per essere vendute.Per la fiera del 1787 «in una sala verso strada presso la fiera di vicinoa Santa Marta» venne mostrato «un camino di marmo bianco di Car-rara», opera dello scultore di Milano Stefano Bottinelli e rappresen-tante per mezzo di un «fino minutissimo travaglio» alcune storie trat-te dalle Metamorfosi di Ovidio147.
Gli spettacoli più graditi rimanevano però quelli acrobatici, dagliequilibrismi sulla corda agli esercizi equestri148. Per il primo Settecen-to, oltre alla già menzionata descrizione dell’Angelini, l’unico dato chepossediamo è la registrazione di un pagamento, effettuato nel 1722da un certo «Cornelio Varò fiamengo» all’Ospedale Maggiore di Ber-gamo, «per affitto del casotto della corda»149. Per la fine del secolo gliavvisi sono, invece, numerosi. «Ballerini di corda e saltatori» eranopresenti nel corso della fiera del 1789150. Nel 1791 eccoli provenire dalTeatro di San Cassiano di Venezia, mentre nel 1795 si esibirono conle «scimmie»151. Più articolata la descrizione degli spettacoli acrobati-ci tenuti nel Teatro Riccardi, definito il «nuovo fabbricato ora ad usodi gran casotto», nel corso della fiera del 1787 da una «compagnia de’ballerini, saltatori, equilibristi di piramidi cinesi e pantomimisti com-posta in varie nazioni»152. La performance appare molto elaborata. Ini-ziò con gli equilibristi, descritti con i loro nomi d’arte: la Piccola Ve-neziana, la Maltese, il Parigino, la Spagnuola, il Famoso Tedesco e il
145. Documenti 1786: 35; 1789: 40, in Regesto.146. Documenti 1791: 42-43, in Regesto.147. Documento 1787: 24, in Regesto.148. A. Serena, Storia del circo, cit., pp. 38-92.149. Documento 1722: 1, in Regesto.150. Documento 1789: 43, in Regesto.151. Documenti 1791: 41; 1795: 11, in Regesto.152. Documento 1787: 21, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 176
177
IL TEATRO DEI BORGHI
loro servo Pagliaccio. Seguirono le «piramidi cinesi» eseguite dall’Ir-landese e i salti mortali di una compagnia di saltatori di provenienzainternazionale. Lo show si concluse con una scenetta ridicola consi-stente in «una pantomima inglese» la quale aveva per «titolo Arlecchi-no can da toro d’Inghilterra»153. Un cast eterogeneo, così come quello chesi riscontra nell’ambito dei giochi equestri. Durante la fiera del 1785erano presenti un certo Gillet «cavalarizzo francese e sua sposa», i qua-li «con vari giochi di cavalli ed a cavallo», secondo Francesco MariaQuarenghi, «in fatto superorono forse l’avviso stampato»154. Nel 1787«Mr. Praignoni italiano col suo piccolo cavallo inglese», il quale si esi-bì «in fiera di contro a Santa Marta» annunciando esercizi dell’anima-le ammaestrato, giochi con «spade e piatti» eseguiti da una bambinadi nove anni ed infine «il divertimento delle ombre chinesi, con ungabinetto obtico trasparente» in cui si rappresentavano i ritratti di ree regine di Europa155. Nel marzo del 1790 fu la volta dei «giochi di ca-valli» e del «salto delle tre botti» da parte di un certo «Balp monsieurcavallerizo»156. Né potevano mancare il lanciatore di coltelli, né il pre-stigiatore. Nel 1787 l’arrotino Giacomo Nella annunciò che avrebbemostrato la sua abilità nel «tirare a segno qualunque ferro sottile»157.Nel luglio del 1786, infine, «nella sala della solita accademia nella Con-trada dell’Aquila Nera» si tennero giochi di prestigio eseguiti da «Gio-vanni Piglietti veneziano che fu scolare del celebre giocolatore Jonas»,il quale faceva «giuochi di bussolotti, carte, monete ed altri più anco-ra sorprendenti e di nuova maniera»158.
Dulcis in fundo: i «fuochi». L’Angelini li ricorda come semplici pireaccese in ogni quartiere della città, atto conclusivo del Carnevale e fi-ne di ogni festeggiamento, descrivendo questo momento con un’evi-dente partecipazione e quasi con una punta di malinconia:
lascio che de le piazze in ogni loco s’accenda un gran falò con gran fra-casso, d’ululati e padelle a lieto sfogo. Lascio all’intorno che dall’alto al
153. Documenti 1787: 22, 26, in Regesto.154. Documento 1785: 8, in Regesto.155. Documento 1787: 20, in Regesto.156. Documento 1790: 12, in Regesto.157. Documento 1787: 1, in Regesto. Il luogo dello spettacolo è incerto in quan-
to l’arrotino, che dice di alloggiare in piazza Mercato delle Scarpe, non specifica do-ve si sarebbe tenuta la performance.
158. Documento 1786: 29, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 177
178
FRANCESCA FANTAPPIÈ
basso cadan scoppiando mille saltarelle. Lascio che intorno vadino facel-le all’avvampante pira e le faville col fumo faccian oscurar le stelle159.
Durante la fiera potevano assumere la forma di veri e propri spet-tacoli pirotecnici. Nel 1787, come visto, vennero effettuati da France-sco Cagnola, al termine della caccia con i tori da lui organizzata160,mentre nell’agosto del 1789 costituirono uno spettacolo a se stante.«I fuochi d’artificio», in questo caso, furono effettuati da un certo «Gu-jot francese fochista» in fiera «nel recinto» e si svolsero per l’interomese di agosto, riscuotendo un discreto successo161.
2. I teatri per la musica in fiera
2.1. Gli impresari e i teatri provvisionali
La severità del sistema politico bergamasco nel concedere spazi dadestinare al teatro venne superata dalla Città Bassa. Demograficamen-te in continua crescita rappresentava l’area urbana economicamentepiù vitale, come dimostra in maniera esemplare l’annuale fiera di San-t’Alessandro, e la prima ad accogliere eventuali visitatori162. Secondoil capitanio Niccolò Corner, incaricato nel 1793 di incentivare i con-trolli sull’ingresso di persone sconosciute in città, si trattava di unazona estremamente difficile da vigilare, poiché «particolare la fisicacostituzione di Bergamo», solo «pochi forestieri» salivano «in Città»,mentre la maggior parte di loro si fermava «nei Borghi dove, per es-sere apperti e per conseguenza non custoditi» era «a tutti libero l’in-trodurvisi»163. Concetto ribadito nel 1797 dal capitanio Alessandro Ot-tolini per il quale vi si trovava «senza confrontro maggiore la popo-lazione e colà» soleva «alloggiare la massima parte de’ forestieri»; qua-si impossibile contenere il loro accesso, in quanto mancavano «guar-die militari» alle «porte de’ Borghi» simili a «quelle della Città»164. Non
159. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 415.160. Documento 1787: 2, in Regesto.161. Documento 1789: 36, in Regesto.162. L. Pagani, Le condizioni demografiche ed economiche di Bergamo, cit. e C.M. Bel-
fanti, Dalla stagnazione alla crescita, cit.163. Documento 1793: 5, in Regesto.164. Documento 1796: 14, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 178
179
IL TEATRO DEI BORGHI
sorprende, quindi, se Borgo San Leonardo, quartiere con un’alta con-centrazione di osterie e polo di aggregazione in occasioni di eventiquali le feste di Carnevale o l’annuale corsa delle carrozze, costituìuno dei principali focolai di rivolta negli anni che precedettero la ri-voluzione bergamasca del 1797.
L’esistenza della fiera annuale cittadina fu la ragione principale chedeterminò la precoce costituzione di due stagioni teatrali, quella delCarnevale e quella estiva. Tra di esse la prima si attestò come la piùimportante nel Seicento, mentre nel corso del secolo successivo fu laseconda ad affermarsi progressivamente come la principale. Se inizial-mente i «casotti» costruiti nel prato di Sant’Alessandro accoglievanocompagnie itineranti di attori professionisti e solo in rari casi produ-zioni operistiche, dalla seconda metà del Settecento la programma-zione musicale dei teatri di fiera divenne sempre più complessa ed ar-ticolata rispetto a quella offerta dalla Città Alta, dove il Teatro dellaCittadella fu destinato quasi unicamente all’opera buffa. È sufficien-te una semplice lettura dei libretti per notare come le rappresentazio-ni estive godessero di un cast più numeroso rispetto a quelle inverna-li, sia per quanto riguarda i cantanti sia per i ballerini, oltre che di al-lestimenti scenografici generalmente più elaborati. Tutto ciò spiega per-ché le poche testimonianze relative alla presenza di ospiti illustri neiteatri bergamaschi fanno sempre riferimento a quelli situati nel pratodella fiera. La provvisorietà degli edifici non impedì, infatti, che per-sonalità quali Francesco III d’Este duca di Modena nel 1758, l’arci-duca Ferdinando d’Austria nel 1784 o un ambasciatore di Sassonia nel1781, fossero indotti a far visita a Bergamo per assistere agli spettaco-li operistici offerti tra i mesi d’agosto e di settembre165. Non è quindiun caso se, con l’eccezione del seicentesco Teatro Secco Suardo, i va-ri tentativi settecenteschi di dotare la città di un teatro stabile interes-sarono invariabilmente l’area dei Borghi, e più in particolare le zoneadiacenti al prato della fiera. I progetti che giunsero alle autorità ber-gamasche, sia che fossero essi proposti da singoli impresari sia che pro-venissero da società di cittadini, indicavano invariabilmente questo
165. Sia Francesco III d’Este che Ferdinando d’Asburgo-Lorena colsero l’occa-sione di assistere alla stagione operistica della fiera di Bergamo, in concomitanza conla loro carica di governatori dello Stato di Milano. Il primo amministrò la Lombar-dia austriaca dal 1754 al 1771. Il secondo da questa data fino al 1797, quando fu co-stretto a fuggire prima della caduta di Milano sotto Napoleone Bonaparte.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 179
180
FRANCESCA FANTAPPIÈ
spazio come luogo più naturale per la costruzione di un teatro stabi-le. Com’è noto, il primo a spuntarla fu Bartolomeo Riccardi nel 1786.La sua fu, però, solo l’ultima di una lunga serie di domande.
La prima notizia di uno spettacolo operistico tenuto in occasionedella fiera risale all’agosto del 1690, quando venne allestito lo Hiar-ba impazzito di autore ignoto e musica di Giovan Battista Brevi (fig.11)166. L’uso di casotti da parte di compagnie di attori professionistipuò, invece, essere fatto risalire almeno al 1677167. Per quanto riguar-da il primo Settecento sappiamo, grazie alla testimonianza di GiovanBattista Angelini, che l’edificio provvisorio destinato all’opera e quel-lo per la prosa erano differenti. Egli distingue molto chiaramente traun «teatro in fiera» per la musica e un «posticcio teatro» per i comicidell’arte168. Se in merito al secondo non fornisce alcuna indicazionedi tipo strutturale, si dilunga molto nella descrizione del primo. Trale rime dell’erudito bergamasco sono rintracciabili molte notizie sul-l’edificio teatrale, dalla data della sua costruzione al luogo scelto peressa, dalla sua architettura all’esito dell’opera rappresentatavi. Secon-do l’abate, che scrive nel 1720, «l’anno scaduto passò l’anno quintoche d’un teatro in fiera la struttura co’ legnami s’alzò ben grande epinto»169. L’edificio sarebbe, quindi, stato costruito nel 1714. Moltoprecisa l’indicazione del sito: «un fianco li faceano le vecchie mura»,ossia la cerchia più antica che cingeva la Città Bassa. Il teatro era quin-di a ridosso delle cosiddette muraine. Sebbene «posticcio», si presen-tava ben fatto e «di vaga idea», dotato di «quattro giri de’ palchetti»170,ossia quattro ordini di palchi. Un’informazione preziosa che permet-te di individuare una fondamentale differenza tra gli edifici costruitiper l’opera – che prevedevano normalmente stanzini per il pubblicoo, al limite, delle logge – e quelli per la prosa, i cosiddetti casotti, chegarantivano un palcoscenico agli interpreti, ma non necessariamente
166. Unica opera accertata con questo titolo. Come dedicataria della rappresen-tazione troviamo una certa Margherita Pasqual, la quale affermava di essere stata as-sistita nell’allestimento da Giacomo Cipriotti. Con un titolo diverso, ossia L’aman-te nemica, lo spettacolo venne riproposto dalla Pasqual, probabilmente una buratti-naia, a Crema (1693) ma con «personaggi di legno»: C. Sartori, I libretti italiani a stam-pa, cit., libretti 1056, 12616.
167. Documento 1677: 1, in Regesto.168. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., pp. 376-377.169. Ivi, p. 377.170. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 180
181
IL TEATRO DEI BORGHI
la sistemazione dello spazio destinato agli spettatori, i quali poteva-no assistere in piedi e allo scoperto. L’Angelini, infine, precisa il ge-nere teatrale tenuto per l’occasione: «si recitò di pastorali affetti l’opracomposta in boscareccie scene, e fur di gusto i musici soggetti»171.Un’opera musicale dal tema pastorale sul cui svolgimento esprime ino-pinatamente un giudizio critico positivo, opportunamente bilanciatodalla relazione sul fallimento economico dello spettacolo. È con unapunta di soddisfazione che riferisce come, sebbene il pubblico aves-se riempito il teatro, l’impresario dovette darsi alla fuga: «furo le cel-le teatrali piene de spettatori, ma l’autor fallito fugì perché non fecei conti bene»172. La notizia dell’Angelini è pienamente confermata dallibretto dell’opera, fortunatamente a noi giunto, secondo cui nel 1714«nel nuovo teatro di fiera di Bergamo» venne rappresentato un «dram-ma pastorale» dal titolo L’Atalanta o sia la costanza d’Amore negli ingan-ni 173. L’opera musicale era intercalata da intermezzi ridicoli, intitolatiIntermezzi di Pimpinone, interpretati dai cantanti Rosa Ungarelli e Igna-zio Ferrari174.
L’edificazione di un teatro «posticcio» nel prato di Sant’Alessandroper allestire opere musicali sarebbe stata, secondo l’Angelini, del tut-to inusuale per la città: «Bergamo più qui visto non l’avea, né forse ilvedrà l’età futura»175. La previsione dell’abate venne, però, contrad-detta almeno in parte. Per la fiera del 1723 si rappresentò L’innocenzagiustificata di Francesco Silvani prodotta da Santo Burigotti, con uncast si di buon livello, mentre l’allestimento scenografico, al pari del-l’Atalanta, fu molto semplice e poco dispendioso. È l’impresario stes-so a dichiarare che l’edizione bergamasca era più dimessa rispetto aprecedenti allestimenti, dovendo «comparire su d’un posticcio teatrodopo ch’ha onorate le scene de’ principi»176. Si trattava, infatti, di «undrammatico componimento» già «ammesso alle scene d’una delleprincipali corti d’Italia in occasione di nozze principesche»177. Il 6 lu-glio del 1741 sappiamo, infine, che dall’Ospedale Maggiore di Berga-
171. Ibidem.172. Ibidem.173. L’Atalanta (1714), in Cronologia.174. Gli Intermezzi di Pimpinone (1714) in Cronologia.175. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 377.176. L’innocenza giustificata (1723), in Cronologia.177. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 181
182
FRANCESCA FANTAPPIÈ
mo venne riscosso l’«affitto del Toresino de’ Signori Conservatori intempo dell’opera in fiera», segno che nell’agosto di quell’anno vennemessa in scena una rappresentazione musicale della quale purtropponon è rimasto il libretto178.
Se le notizie relative ad un uso del prato di Sant’Alessandro nelprimo Settecento sono rare, la situazione doveva essere sicuramentepiù animata di quanto è stato possibile stabilire sulla base dei docu-menti reperiti179. È proprio in questo periodo che si riscontrano i pri-mi progetti di edificazione di teatri stabili in Città Bassa. I tentatividi cui abbiamo notizia sono almeno due, uno del 1717 circa e l’altrodel 1750. Il primo è ricordato sinteticamente dall’Angelini il quale,dopo aver dato conto dell’avvenuta distruzione del Teatro Secco Suar-do, afferma: «sono anni tre che sen volea costrutto un altro in BorgoSant’Antonio, impresa tentata con disgusto e senza frutto»180. Sebbe-ne la notizia non permetta di individuare i promotori dell’iniziativa,né di capire i motivi del fallimento dell’impresa, viene indicato conchiarezza il luogo: Borgo Sant’Antonio. L’area urbana, pertanto, èquella della Città Bassa. Il quartiere copriva la zona limitrofa ad orien-te del prato della fiera ed era l’unico, insieme a quello di San Leonar-do, racchiuso dalla prima cerchia di mura. La ricca documentazionereperita in merito all’episodio del 1750 permette, invece, di seguireagevolmente le varie fasi del progetto, dalla sua ideazione all’esito fal-limentare, un’esperienza che si impone come assolutamente paradig-matica. Anche se gli elementi di riflessione che da essa emergono so-no molti, la principale causa dell’insuccesso dell’impresa fu il conte-sto sociale: una classe nobiliare estremamente disgregata, dagli oriz-zonti irrimediabilmente particolaristici, con un’attitudine alquanto li-mitata ad una visione collettiva del problema.
178. Documento 1741: 1, in Regesto.179. Sono, infatti, molti i melodrammi tenuti a Bergamo nel primo Settecento
cui non è stato possibile attribuire un luogo specifico per l’allestimento, sebbene lastagione riportata dai libretti, vale a dire l’inverno, induca ad ipotizzare una loromessa in scena in Città Alta piuttosto che nei Borghi: La pace per amore (Carnevale,1726), La fede tradita e vendicata (Carnevale, 1726) Amore di sangue (Carnevale, 1729),L’error punito (Carnevale, 1729), Orlando furioso (Carnevale, 1738), La caduta di Baja-zetto (Carnevale, 1740), Armida abbandonata (Carnevale, 1740), La fortunata sventura(Carnevale, 1740), Arrenione (Carnevale, 1741), La clemenza di Tito (Carnevale, 1742),La vedova ingegnosa (Carnevale, 1742), Il Siroe (Carnevale, 1743), in Cronologia.
180. G.B. Angelini, Per darti notizie del paese, cit., p. 377.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 182
183
IL TEATRO DEI BORGHI
L’intera vicenda si svolse durante la prima metà dell’anno 1750. Nelcorso del mese di gennaio, a poco più di dieci giorni di distanza l’unadall’altra, vennero presentate al Comune di Bergamo ben due doman-de di costruzione di un teatro stabile nel prato di Sant’Alessandro. Laprima era di un privato: Giovan Battista Macazzoli chiese di «con-struere un teatro per recitarvi l’opera in musica in tempo di fiera, on-de ritrarne qualche profitto»181 per sé e per la sua famiglia. Progettavadi erigere l’edificio «in vicinanza del quartiero de’ soldati a cavallo edella muraglia vecchia verso il portello, così che» potesse «anche so-pra questa poggiare». Riteneva che la sua realizzazione sarebbe torna-ta «di vantaggio di tutta la provincia, stante l’affluenza de’ forastieriche certamente sarà più grande del solito et in ornamento della fie-ra»182. La seconda domanda proveniva, invece, da tre stimati esponen-ti della nobiltà bergamasca: Coriolano Brembati, Francesco VailettiSalvagno e Girolamo Rivola. Essi dichiaravano di agire «a nome an-cora d’un considerabile numero d’altri cittadini» e proclamavano chela realizzazione dell’edificio sarebbe stata «a pubblico ornamento evantaggio del commercio»183. Come sito per la sua costruzione indi-cavano lo stesso proposto dal Macazzoli e già utilizzato nel 1714. In-tendevano, infatti, costruire il «teatro con appoggiarne la fabbrica aquelle mura vecchie». Aggiungevano che avrebbero previsto «un pal-co per l’Eccellentissima Rappresentanza» e «uno per l’IllustrissimaCittà», quindi sia per i rettori sia per i deputati del Comune184. Nes-suna delle due domande venne accettata immediatamente ma, allo sco-po di vagliare l’ammissibilità delle richieste, le autorità municipali de-cisero di nominare una commissione, composta da tre deputati deiconsigli e da tre «deputati alle muraglie vecchie», per approfondire lamateria in questione185.
Non è dato sapere quale sarebbe stato il responso. Prima che ve-nisse promulgata una qualsiasi delibera scoppiò una furiosa contro-versia all’interno della nobiltà cittadina che portò, nel giro di pochimesi, al fallimento di entrambi i progetti. Dietro ognuno di essi si ce-lavano, infatti, due gruppi contrapposti. Sebbene la domanda dei con-
181. Documento 1750: 1, in Regesto182. Ibidem.183. Documento 1750: 3, in Regesto.184. Ibidem.185. Documenti 1750: 2 e 4, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 183
184
FRANCESCA FANTAPPIÈ
ti Brembati, Vailetti Salvagno e Rivola, fosse stata la seconda in ordi-ne di tempo ad essere presentata, la società di nobili che li supporta-va, indicata come la «compagnia delli trentatré cittadini»186 o talvoltadei trentadue, era stata la prima ad aver maturato l’idea di costruireun teatro pubblico. Un progetto, ricalcato su un modello produttivoa conduzione collettiva che, stando al capitanio Giovanni AntonioBaglioni, relatore della vicenda al Consiglio dei Dieci a Venezia, sa-rebbe stato elaborato nel corso dell’anno precedente:
appena giunto a questa reggenza, e sono già otto mesi che servo in essaVostre Eccellenze, mi si rilevorono alcuni discorsi che pareano indiferen-ti fra cittadini vogliosi di avere nel solitario sogiorno un teatro che maivi fu, e questa lor brama non nasce in adesso, ma da più anni fu ella finqui inutilmente coltivata187.
Il rettore riferiva perciò che il desiderio di un teatro stabile da par-te della società bergamasca era fortemente radicato e largamente dif-fuso, ma inutilmente perseguito da tempo. In merito alla possibilitàche il progetto, nato durante la sua permanenza in carica, andasse inporto, il capitanio esprimeva però un giudizio estremamente sarcasti-sco. Riteneva infatti «ridicolo e vano l’assunto», un tentativo manca-to prima di nascere, per ragioni molto disparate: la volontà di nonesporsi finanziariamente da parte dei promotori, la loro inesperienzain simili iniziative, la pigrizia e, più indecifrabile di tutte, un «costu-me della nazione non facile a determinarsi»188. Tramite il rapporto delcapitanio alle autorità veneziane veniamo, infatti, a sapere che l’ac-cordo stipulato dal primo gruppo, formato da «trentadue persone no-bili, ma ornate ancora di fortune», era stato fatto «fra loro il più taci-turno» possibile, «formando scrittura e capitoli per intraprenderla» al-l’insaputa del resto del corpo nobiliare, allo scopo di aggiudicarsi undiritto di prelazione nella distribuzione dei palchetti al momento del-la loro estrazione a sorte. La strategia della segretezza però non riu-scì. «Sebbene nel profondo silenzio in cui è la compagnia» i nobili la-sciati fuori «seppero traspirare di essere stati esclusi e negletti»189.
186. Documento 1750: 9, in Regesto. Per la definizione si vedano inoltre i Do-cumenti 1750: 8, 10, 19.
187. Documento 1750: 5, in Regesto.188. Ibidem.189. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 184
185
IL TEATRO DEI BORGHI
La reazione della parte emarginata fu quella di costituire una so-cietà contrapposta alla prima la quale, giocando d’anticipo sui rivali,assegnò a Giovan Battista Macazzoli il compito di presentare la do-manda al Comune e successivamente, con un incarico sottoscritto daventidue membri del sodalizio, nominò un proprio «difensore e pro-curatore» a Venezia190. Il risultato della vicenda fu dunque, come ac-cennato, la quasi contemporanea presentazione al Comune di due do-mande, praticamente identiche, da parte di due società teatrali con-trapposte per poter usufruire dello stesso spazio. Per quanto riguardalo stato d’animo generale e il clima venutosi a creare in città, appareparticolarmente eloquente la sintesi offerta dal capitanio: «un movi-mento non ordinario ed una divisione d’animi che può farsi un semi-nario di discordie e d’impegni»191. Nonostante la forte preoccupazio-ne del rettore per la difficile situazione venutasi a creare e l’impegnoda lui profuso per porre immediato termine alle contese, evitando unaloro pericolosa degenerazione, si trattava solo del primo atto di unaquestione che si protrasse per alcuni mesi.
Poiché i termini iniziali della contesa tra i due gruppi riguardava-no prevalentemente il problema della distribuzione dei palchetti, laprima direttiva giunta da Venezia fu quella di evitare la formazionedi ulteriori «conventicole», vietando alla società di nobili rappresen-tata da Brembati, Vailetti e Rivola di «escludere altro corpo di nobilieguali della compreda ed acquisto de’ palchi in detto teatro»192. Cio-nonostante, ancora nel mese di marzo, il secondo gruppo, nel qualefiguravano Carlo Benaglio, Giovan Battista Mozzi e Giovan BattistaBenveuti, ribadiva l’accusa. Essi imputavano ai «trentatrè cittadini» divoler «formare nella construzione d’un teatro un ordine distinto, oc-cupare i primi palchetti e preferirsi sopra tutto il resto della nobiltà»193.Secondo il primo gruppo, che persisteva nella volontà di attribuirsi il
190. Documento 1750: 6, in Regesto. Il sodalizio era composto da Giovan Bat-tista Adelasio, Francesco Agosti, Teodoro Albani, Girolamo Albani, Antonio Alber-ghetti, Francesco Arrigoni, Carlo Benaglio, Ottavio Benaglio, Gio. Battista Benve-nuti, Girolamo Bonduri, Giovanni Dall’Olmo, Giovan Paolo Franchetti, Giovan Bat-tista Mozzi, Giuseppe Pezzoli, Giovanni Prezzati, Benedetto Pietrobelli, Carlo San-ti, Giovanni Maria Scotti, Marc’Antonio Spini, Tommaso Tasca, Cristoforo Zanchi,Girolamo Zanchi.
191. Documento 1750: 5, in Regesto.192. Documento 1750: 7, in Regesto.193. Documento 1750: 8, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 185
186
FRANCESCA FANTAPPIÈ
diritto «di sciegliere un palchetto per cadauno da estraersi a sorte»194,si trattava di una prerogativa irrinunciabile. Essa sarebbe spettata lo-ro per il fatto di essere stati «li primi uniti per la costruzione e soliesposti a tutti li eventi della sudetta fabrica»195, ossia dall’aver già in-vestito denaro nell’impresa e dall’averla progettata anteriormente aglialtri. Era per questo motivo che inficiavano la validità della propostapresentata da Giovan Battista Macazzoli al Comune, né importava sequella proposta era arrivata per prima; essa non poteva essere consi-derata come espressione del gruppo rivale, ma solo una domanda acarattere prettamente individualistico, con la quale un impresariochiedeva di «construere il teatro per lui solo a sostentamento di suapersona»196. Un rilievo che gli eventi successivi mostrarono in partecorretto. Gli intenti del secondo gruppo si rivelarono infatti fragili evelleitari, così come la domanda fatta presentare dal Macazzoli un me-todo per sabotare l’impresa della società iniziale197.
Né le ragioni del primo gruppo, né quelle del secondo interessa-vano in ogni caso Venezia o il rettore che la rappresentava. Se i «tren-tatré cittadini» volevano costruire un teatro avrebbe dovuto essere «sen-za risserve di preferenza»198, altrimenti nessuna costruzione sarebbe sta-ta autorizzata. Altrettanto valeva per gli altri. Il discorso venne chiu-so dal capitanio Giovan Antonio Baglioni, il quale suggerì come uni-ca soluzione per porre termine alle contese, la sospensione della rea-lizzazione del progetto: «l’unico riparo a nuovi sconserti sarebbe chenulla più per ora si trattasse di questa erezione e che, già priva da se-coli la città solitaria, potesse continuar nella privazione di cosa nonnecessaria»199. Proposta pienamente approvata da parte delle autoritàveneziane da cui venne stabilito che, senza «una intiera uguaglianzanel complesso dei supplicanti», i Capi del Consiglio dei Dieci nonavrebbero dato il permesso all’edificazione di alcun teatro200.
Una direttiva, quella della Dominante, che congelava qualsiasi ini-ziativa di costruzione di teatro sociale in assenza di un accordo del-
194. Ibidem.195. Ibidem.196. Documento 1750: 9, in Regesto.197. Ibidem.198. Ibidem.199. Documento 1750: 10, in Regesto.200. Documento 1750: 11, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 186
187
IL TEATRO DEI BORGHI
l’intero corpo nobiliare. Problema concluso? Solo apparentemente.Con suo enorme disappunto e sincera sorpresa, ancora a metà di mag-gio, il capitanio fu costretto a comunicare a Venezia una pericolosadegenerazione della vicenda. Il rettore era incredulo. Nonostante l’av-venuta disgregazione della «prima unione delli trentatré cittadini» che,in mancanza dell’indispensabile licenza da parte del Consiglio dei Die-ci per il progetto da loro ideato, si era sciolta, i membri del secondogruppo avevano disatteso completamente alle direttive promulgate.Non solo avevano mantenuto la loro unione, ma si prefigurava il ri-schio di un duello all’ultimo sangue tra due dei suoi maggiori espo-nenti: il conte Carlo Benaglio contro il conte Cristoforo Zanchi. Lagravità della situazione era tale che Giovanni Antonio Baglioni, persventare ogni pericolosa conseguenza aveva ordinato «il reciproco lo-ro sequestro»201. Una fase della querelle che assunse tratti a dir pocogrotteschi, nel corso della quale i protagonisti mostrarono un’assolu-ta mancanza di progettualità comune od una minima logica di com-portamento compatibile con la realtà politica e sociale in cui si tro-vavano ad agire. Si trattò, non a caso, dell’ultimo capitolo della sto-ria. Uno strascico che si protrasse per altri due mesi.
Al contrario di quanto proclamato, il secondo gruppo, guidato daCarlo Benaglio, Giovan Battista Mozzi e Giovan Battista Benvenuti,non si comportò diversamente dal primo, ma cercò di mettere in at-to lo stesso principio di «esclusione» nei confronti dei rivali. Sembrainfatti che avessero «la mira di accomunar quei soli cittadini che» era-no «del corpo di questo Consiglio», ossia i Deputati del Comune202.Il motivo che aveva scatenato la promessa di duello tra i due nobilibergamaschi, messi agli arresti domiciliari dal rettore, era però un al-tro. Cristoforo Zanchi, dopo essere stato inizialmente ammesso nellasocietà, ne fu estromesso. Per quanto pronto a saldare la propria quo-ta, i suoi ripetuti tentativi di pagamento erano stati immancabilmen-te respinti. Lo Zanchi si rivalse quindi contro Carlo Benaglio, il qua-le rifiutò. Da ciò la promessa di duello203.
201. Documento 1750: 12, in Regesto.202. Ibidem. Si veda anche l’istanza di Girolamo Albani presso l’Ufficio Preto-
rio di Bergamo, nella quale il conte bergamasco afferma di essere stato invitato a farparte della società con la clausola «che si facesse firmar la carta di compagnia da’ so-li di Consiglio»: Documento 1750: 22, in Regesto.
203. Documenti 1750: 13-14, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 187
188
FRANCESCA FANTAPPIÈ
In merito alla diatriba venutasi a creare ciò che sorprende maggior-mente è il fatto che i due contendenti, così come il resto dei membridel gruppo, si rivolsero a tribunali locali per risolvere le proprie que-stioni interne, cercando di evitare ad ogni costo quelli veneziani. Alcontrario della società dei «trentatré cittadini», che avevano riconosciu-to l’impossibilità di condurre a termine il proprio progetto senza l’aval-lo del rettore, il secondo gruppo percorse invano, ma pervicacemente,una strada che si mostrò fin dall’inizio senza via di uscita. I numerosiricorsi e controricorsi presentati dai vari componenti all’Ufficio Preto-rio di Bergamo assumono perciò un aspetto del tutto paradossale. I pas-saggi furono diversi. Inizialmente vediamo che dieci membri dellacompagnia si unirono per firmare una scrittura privata contro Cristo-foro Zanchi204. Da parte di Venezia, che non comprendeva come le con-tese non riguardassero più due «fazioni» di nobili per la «distributtio-ne de’ palchetti di teatro», ma fossero passate all’interno di uno stessogruppo, si ribadiva la sospensione dell’erezione dell’edificio205. A Ber-gamo intanto, per ordine del rettore, i due difensori di Benaglio e Zan-chi cercarono inutilmente di comporre la contesa206. Il capitanio Gio-vanni Antonio Baglioni estese quindi l’ordine degli arresti domiciliaria tutti i componenti maschi delle rispettive casate in duello. Ciò nonimpedì però che continuassero ad essere prodotte «carte infruttuose»presso i tribunali locali da parte della società teatrale capeggiata da Be-naglio, Mozzi e Benvenuti207. Il culmine dell’autoreferenzialità venneraggiunto quando ben sette, tra i dieci firmatari della scrittura privatacontro Cristoforo Zanchi, affermarono di reclamare la separazione da-gli altri «volendo diffendersi» da soli208. Fu lo stesso capitanio a giudi-care la situazione ormai insensata, in quanto questa compagnia, dopoaver presentato «tali carte», si era resa «affatto ridicola a tutta la città,tanto più che per le correnti vertenze, e posso dire anco per la respet-tive qualità delle ultime persone associate, va a cadere per se stessa»209.
204. Documento 1750: 15, in Regesto. I firmatari furono Girolamo Albani, Teo-doro Albani, Antonio Alberghetti, Giovan Giacomo Arrigoni (succeduto a France-sco Arrigoni), Giovan Battista Benvenuti, Paolo Franchetti, Giuseppe Pezzoli, Gio-vanni Prezzati, Giovan Maria Scotti, Marc’Antonio Spini.
205. Documento 1750: 16, in Regesto.206. Documenti 1750: 17-18, in Regesto.207. Documento 1750: 19, in Regesto.208. Documenti 1750: 20-25, in Regesto.209. Documento 1750: 26, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 188
189
IL TEATRO DEI BORGHI
Non era però ancora finita. A suggello finale di tutta la vicendatroviamo la falsificazione di un atto da parte di cinque componentidel sodalizio; questi pur di non accettare il versamento della propriaquota da parte di Cristoforo Zanchi, da lui finalmente effettuato nel-le mani di Giovan Battista Benvenuti, redassero una «nuova apocrifacarta»210, tramite cui documentare che nella società iniziale erano com-presi diciannove componenti e non ventidue come in realtà. I nomi-nativi omessi ad hoc furono quelli di Carlo Santi, Cristoforo Zanchi eGirolamo Zanchi211. Il giudizio delle autorità veneziane verso i cin-que «giovanastri oziosi» fu severo ed irremovibile, tanto più che il sal-do del pagamento aveva portato alla definitiva riconciliazione delle«due egualmente nobili famiglie» Benaglio e Zanchi212. Dopo aver or-dinato al capitanio di chiamare a sé i cinque colpevoli e «impudentiautori» del documento falso, allo scopo di minacciarli di provvedi-menti più seri nel caso di un’ulteriore trasgressione dei «pubblici pre-cetti», Venezia intimò che venisse requisita tutta la documentazione,scritture private e/o istanze all’Ufficio Pretorio da essi, o dal loro grup-po, prodotte, così da evitare qualsiasi possibilità di ulteriori ricorsi213.Non si trattò di un semplice atto formale. Il sequestro dagli uffici pub-blici cittadini e dalle carte notarili di tutti gli incartamenti relativi al-la vicenda era una reale dimostrazione di forza da parte della Domi-nante che reclamava la propria superiorità su qualsiasi altro tribuna-le. Alla fine di giugno, con l’esecuzione dell’ordine da parte del ret-tore, tutte le contestazioni ebbero termine214.
Sebbene fin dall’inizio l’estrema litigiosità dimostrata dai due grup-pi, sia tra di essi sia al loro interno, avesse inficiato la possibilità di as-sicurare alla città un teatro stabile, quella del 1750 fu una preziosa oc-casione sprecata. L’episodio si presenta comunque emblematico. Al-cuni meccanismi interni alla società bergamasca registrati in questocaso sono riscontrabili anche in seguito. In particolar modo vediamocome la classe più abbiente, il cosiddetto «corpo nobiliare», fosseestremamente disunita, così come ogni famiglia era continuamentetesa a dimostrare la propria supremazia rispetto alle altre. Nel 1750 la
210. Documento 1750: 28, in Regesto.211. Documento 1750: 27, in Regesto.212. Documento 1750: 28, in Regesto.213. Documenti 1750: 29-30, in Regesto.214. Documenti 1750, 32-33, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 189
190
FRANCESCA FANTAPPIÈ
netta volontà di distinzione tra i due sodalizi, il primo in una posi-zione di forza dovuta alla propria influenza economica e il secondoalla ricerca di un principio di distinzione nell’appartenenza o menoal Consiglio comunale, determinò di fatto l’inutile dispersione delleenergie presenti nella classe dominante normalmente portavoce del-le istanze spettacolari di una città, pregiudicando la realizzazione diun teatro stabile. Ciò non impedì che, nel secondo Settecento, la pro-grammazione teatrale bergamasca subisse un netto incremento, sia perquanto riguarda la stagione invernale sia quella estiva. L’uso dello spa-zio della fiera per opere musicali è attestato con continuità. Tutto ciòportò alla presentazione di ulteriori progetti per la costruzione di edi-fici teatrali permanenti nel prato di Sant’Alessandro, oltre che alla pro-mulgazione di un legislazione teatrale allo scopo di arginare il pro-gressivo aumento di impresari e controllare le modalità di costruzio-ne dei teatri provvisori.
Tra le controversie nate dall’incertezza logistico-normativa emer-ge, nel 1761, quella tra un palchettista del «teatro di fiera» contro l’im-presario di quell’anno. Giuseppe Chiappati, in qualità di abituale pos-sessore di un palco «in secondo ordine senario numero venti otto en-trando a man destra verso al monte» chiese che il «direttore dell’ope-ra» Giovan Battista Ghislanzoni non facesse «alterazione alcuna so-pra le appostazioni e registri del teatro fatti in passato coll’occasionedell’opera in fiera»215. La soluzione della contesa è purtroppo scono-sciuta. Notiamo, però, che nonostante l’aspirazione del richiedente avedersi riconosciuto lo stesso palchetto dell’anno precedente, la suaassegnazione era a discrezione del Ghislanzoni, come produttore del-lo spettacolo, il quale – al pari di Domenico Compagnoni o della fa-miglia Dehe per il Teatro di Cittadella – possiamo far rientrare nellacategoria degli impresari-costruttori locali.
Soddisfacente, anche se non cospicua, la documentazione relativaalla programmazione musicale estiva tra gli anni Cinquanta e Sessan-ta del secolo. Per la fiera d’agosto del 1751 venne rappresentato il De-metrio di Pietro Metastasio cui seguì, dello stesso autore, L’eroe cinesenel 1756. Nell’agosto del 1758 l’Armida maga abbandonata di autoreincerto, nel 1762 L’amante di tutte opera buffa di Antonio Galuppi, pertornare al Metastasio nel 1766 con la Semiramide216. Sebbene la docu-
215. Documento 1761: 3, in Regesto.216. Si veda la Cronologia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 190
191
IL TEATRO DEI BORGHI
mentazione librettistica attesti solo queste opere, alcune note conta-bili permettono di ipotizzare un’attività molto più continuativa. Nel1759 e nel 1766 viene, infatti, registrata la riscossione dell’affitto peril «fondo di teatro» da parte dell’Ospedale Maggiore di Bergamo217.Tra il 1764 e il 1765 quella di un accordo stipulato dal conte Leoni-no Secco Suardo per l’abbonamento alle rappresentazioni dell’operae il pagamento per l’uso di un «camerino» e di un «palco in fiera»218.
Non sorprende che l’ennesimo tentativo di costruzione di un teatrostabile nel prato di Sant’Alessandro risalga al 1770, ossia in concomitan-za con il progressivo aumento delle opere rappresentate durante la fie-ra, ma in una situazione logistica sostanzialmente invariata rispetto aventi anni prima. In questo caso il latore della supplica presso il Comu-ne di Bergamo, non fu un gruppo di cittadini, ma un singolo individuo:il musicista Francesco Bolognese219. La domanda da lui presentata è mol-to circostanziata, così come la motivazione con cui viene aperta:
Per mancanza di teatro stabile in questa Città e suoi Borghi, è invetera-to costume erigersene ogni anno al tempo di fiera uno provvisionale ditavole, poco agiato per la sua angustia, mal connesso e sicuro per la in-felice costruzione sua, che lo rende incapace per garantire le persone chevi concorrono dalla pioggie e da’ venti, con pericolo bene spesso di fu-nesti successi ed indecoroso per la città stessa ch’è forse l’unica nello sta-to la quale manchi di una fabbrica, considerata presso che necessaria perun dilettevole onesto trattenimento de’ suoi cittadini220.
Oltre a sottolineare la concreta inadeguatezza del sistema teatralecittadino, il supplicante metteva in particolare risalto la peculiarità del-la città di Bergamo, «unica nello stato» veneto a non disporre di unedificio stabile. Come luogo per la sua costruzione proponeva il «fon-do in cui è solito di erigersi il detto provvisionale teatro di cui n’è pro-prietaria questa Magnifica Città, che ne concesse però il reddito al Ve-nerando Ospitale»221. Francesco Bolognese si offriva come unico so-
217. Documenti 1759: 2; 1766: 7, in Regesto.218. Documenti 1764: 1; 1765: 1, in Regesto.219. Un Francesco Bolognesi «primo contrabbasso» è attestato nel cast del Me-
donte (fiera, 1784) e in quello degli Artigiani (Teatro della Cittadella, 1796), spettaco-li per i quali si rimanda alla Cronologia.
220. Documento 1770: 2, in Regesto.221. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 191
192
FRANCESCA FANTAPPIÈ
stenitore delle spese di edificazione dell’immobile. La proposta pre-vedeva «uno stabile teatro, circondato di muro», dotato di palchetti,a «norma d’un regolato moderno disegno», tale da «preservare il pub-blico stesso dalla intemperie delle stagioni», garantire un’entrata fissaper l’Ospedale Maggiore – che avrebbe così continuato a riscuoterel’affitto del terreno usato per la sua fondazione – e infine dare «nuo-vo lustro ed adornamento»222 alla città stessa. Affermava, inoltre, diessere in grado di portarlo a termine in breve tempo, segno che le in-tenzioni dell’aspirante costruttore erano quelle di poter usare l’edifi-cio nel corso della fiera imminente.
Per dare maggiore attendibilità alla supplica, quattro giorni dopola sua presentazione, Francesco Bolognese consegnò il progetto delteatro. Per quanto riguarda l’area su cui edificarlo rinnovò la propo-sta di utilizzare il «solito luogo ove ora esiste il teatro di tavole», sen-za però opporsi all’eventuale scelta di «altro sito di detto prato chefosse considerato più conveniente al comune vantaggio»223. Il model-lo a cui affermava di ispirarsi era quello «del nuovo teatro di Padovafabbricatosi ultimamente sopra le demolizione del vecchio», ossia delTeatro Nuovo della Nobiltà224. Estremamente dettagliata la descrizio-ne del numero dei palchetti previsti, così come quella della loro di-stribuzione. L’impresario intendeva costruire un teatro di «tre ordininobili, cioè piè piano, primo ordine e secondo ordine», oltre «un al-tro ordine ancora» da assegnare a suo piacimento. Il progetto preve-deva quindi un aumento del numero complessivo di palchetti esisten-te nel «teatro di tavole» che, stando alla descrizione da lui fornita, do-veva essere di due ordini di ventotto palchetti ciascuno. Francesco Bo-lognese prometteva la costruzione, per ogni ordine, di «palchi sediciper ogni lato», ossia trentadue in totale. Ciò significa che «ogni ordi-ne» avrebbe avuto «quatro palchi di più del solito per ogni intiero or-dine»225. I primi tre sarebbero stati attribuiti alla «nobiltà» secondo ilseguente criterio: piè piano e primo ordine a «tutti quelli che attual-mente hanno palco nel teatro di tavole»; i quattro nuovi palchetti nel
222. Ibidem223. Documento 1770: 3, in Regesto.224. Ibidem. In merito al Teatro Nuovo della Nobiltà di Padova si veda F. Man-
cini, M.T. Muraro, E. Povoledo, I teatri del veneto, vol. III, cit., p. 127 e ss.225. Capitolo primo del progetto di Francesco Bolognese: Documento 1770: 3,
in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 192
193
IL TEATRO DEI BORGHI
piè piano e nel primo ordine, oltre a tutti quelli del secondo ordine,sarebbero stati «imbussolati per estrarsi a sorte fra le case del Conci-lio della Magnifica Città»226. Nel caso di eventuali obiezioni alla mo-dalità di distribuzione proposta, Francesco Bolognese prevedeva unaseconda possibilità:
quando poi non potesse aver luogo la distinzione tra quelli che hannopalco nel teatro di tavole e li altri che abbiano ad essere imbussolati co-me sopra, si potrebbe fare una imbussolazione indistinta di tutti quelliche hanno palco e di tutti quelli del Consiglio che si dassero in nota227.
In quest’ultimo caso l’estrazione di tutti i palchetti dei primi treordini sarebbe avvenuta senza alcun criterio di preferenza tra i vecchie i nuovi possessori.
Tra le richieste di Francesco Bolognese vi era quella della redazio-ne di un elenco, da depositare presso un notaio, con i nomi di tutticoloro che avessero voluto comprare i palchetti, allo scopo di preve-dere il numero dei possibili acquirenti, verificare il gradimento del-l’impresa ed avere «preventivamente una idea della cauzione» a dispo-sizione. Per dare modo ai potenziali spettatori di conoscere i prezziprevisti, l’impresario inserì una tabella alla fine del progetto, standoalla quale il prestigio di ciascun palchetto era stimato in maniera pro-porzionale rispetto alla sua posizione all’interno del teatro. I due or-dini più cari: il piè piano e il primo ordine. Seguiva a poca distanzail secondo, mentre il terzo ordine era il più negletto. I palchetti rite-nuti migliori all’interno di ciascun ordine erano quelli centrali, oltreall’ultimo, il numero sedici, a ridosso del palcoscenico228. Altra im-portante richiesta di Francesco Bolognese era quella che, nel caso diun’approvazione del progetto, venisse vietato all’Ospedale Maggioredi «farsi altro teatro di tavole, né di fabbrica» che programmasse «ope-ra» o «commedia» nel periodo di fiera, tale da poter essere concorren-ziale al suo229.
La risposta del Consiglio di Bergamo non fu però immediata. Co-me già accaduto nel 1750 venne istituita una commissione, in questo
226. Ivi, capitolo terzo.227. Ivi, capitolo ottavo.228. Ivi, tabella.229. Ivi, capitolo nono.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 193
194
FRANCESCA FANTAPPIÈ
caso costituita da quattro deputati, per vagliare l’ammissibilità dellaproposta230. Una perizia che si fece attendere a lungo e che arrivò benun anno dopo l’assunzione dell’incarico. Ciò nonostante la relazio-ne prodotta non appare circostanziata quanto il tempo messo a di-sposizione avrebbe permesso. Il progetto di Francesco Bolognese fuanalizzato sotto vari aspetti. Quello che, però, destò maggiore preoc-cupazione nei commissari, come prevedibile, fu il problema della di-stribuzione dei palchetti. L’impressione è che l’anno intercorso tra ladata di presentazione della domanda da parte dell’impresario e quel-la della stesura del rapporto, fosse in realtà servito a tastare il terrenoin città e a vagliare gli umori, regolando i fragili rapporti tra le variecasate. L’unico vero rilievo opposto alla domanda presentata da Fran-cesco Bolognese fu che, a fronte della tabella dei prezzi presentata perl’acquisto dei palchi, non era stato «esibito alcun modello, né presoalcun impegno rispetto alli comodi, solidità o ornati del teatro»231 cheegli intendeva erigere. Per questo motivo i quattro commissari dichia-rarono di non avere elementi sufficienti per stabilire se il valore attri-buito a ciascun palchetto fosse proporzionato all’effettiva «spesa del-la fabrica»232. Il resto del rapporto, ossia la parte più cospicua, si con-centra su obiezioni relative alla modalità di assegnazione dei palchet-ti. In primo luogo si contestava il fatto che il secondo ordine fosse daconsiderare «egualmente nobile» rispetto al piè piano ed al primo, néche fosse possibile lasciare libertà assoluta all’impresario di assegnar-ne i palchetti vacanti «ad ogni genere di persone come liberamente sirisserva tutti li palchi»233. In secondo luogo l’«esempio di Padova» nonveniva ritenuto conforme alla situazione bergamasca. In quel caso, in-fatti, era stata riproposta la distribuzione dei palchetti di un vecchioteatro nel nuovo edificio da erigere, mentre a Bergamo ciò non sareb-be stato possibile in quanto «quello di tavole si mette insieme ora inun luogo, ora nell’altro senza costanza nelli occupatori di ritenere inogni luogo il palco medesimo»234. Per questo motivo il modo miglio-re per l’assegnazione dei palchetti sarebbe stato quello dell’estrazionea sorte, senza alcun principio di discriminazione tra i possessori di
230. Documento 1770: 42, in Regesto.231. Documento 1771: 1, in Regesto.232. Ibidem.233. Ibidem.234. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 194
195
IL TEATRO DEI BORGHI
palchi nel teatro «di tavole di Città o in fiera» e membri delle «fami-glie che attualmente sono o sono state di Consiglio di questa Magni-fica Città». Infine, per ragioni di rappresentanza, doveva essere lascia-to al Comune un palchetto libero da qualsiasi spesa. Solo l’ultimo or-dine avrebbe potuto essere a discrezione dell’impresario, il quale sa-rebbe stato libero di assegnarlo «ad ogni genere di persone». Per i pal-chetti vacanti dei primi tre ordini, invece, doveva essere prestato «ildebito riguardo alla qualità e condizione» di chi ne avrebbe fatto ri-chiesta235.
Nel rapporto manca, dunque, una qualsiasi osservazione in meri-to alla adeguatezza del luogo scelto per l’erezione, così come si sor-vola sulla necessità di anticipare il denaro per l’acquisto dei palchet-ti. Totalmente ignorata poi la questione della peculiarità del sistemateatrale bergamasco. Il problema dell’assenza di un teatro stabile, let-to da Francesco Bolognese come un elemento di arretratezza della cit-tà rispetto alle altre della Terraferma veneta, viene eluso completamen-te, né costituisce un elemento di riflessione o di preoccupazione daparte della classe dirigente municipale. La delibera del Consiglio, cheseguì il rapporto della commissione, rispecchiò la mentalità ivi espres-sa. Dopo la lettura della perizia si giunse, a larghissima maggioranza,alla bocciatura della proposta di Francesco Bolognese, così come del-la modalità di distribuzione dei palchetti da lui esposta236. Nessun al-tro aspetto della domanda venne preso in minima considerazione.
Ciò nonostante un problema esisteva. Appena tre anni dopo, an-che l’oligarchia cittadina sembrò in qualche modo farsene carico. Il12 marzo 1774 il Consiglio Minore deliberò in merito alla necessitàdi creare una legislazione in ambito teatrale. Tutto ciò per garantire«il buon ordine», oltre che «la conveniente decenza e l’intiera sicurez-za»237 degli spettatori. Tuttavia non era la mancanza di un teatro sta-bile ad essere sentita come problema, ma piuttosto la crescita ormaiinarrestabile della programmazione teatrale cittadina e la correlatapresenza d’impresari. «Essendosi da alcuni introdotto in questa cittàl’uso della fabbrica ordinariamente di due ed alcune volte ancora ditre teatri all’anno, fatta da persone le quali non ànno altro oggettoche quello d’un ingordo guadagno» si decise di eleggere una commis-
235. Ibidem236. Documento 1771: 2, in Regesto.237. Documento 1774: 2, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 195
196
FRANCESCA FANTAPPIÈ
sione di «tre zelanti e prudenti cittadini» che redigessero una norma-tiva in merito alla problematica esposta238. Segno della premura concui venne affrontato l’argomento, dopo poco più di un mese i tre de-putati incaricati proposero la propria relazione.
Il rapporto, stilato il 23 aprile del 1774, aveva come traguardo prin-cipale quello di passare «dalla totale anarchia a qualche principio disistema e disciplina»239. Per arrivare ad una soluzione della questione,secondo la commissione, era necessario «prendere di mira precipua-mente la persona dell’impresario»240. Allo scopo di tenere sotto con-trollo questa figura professionale e garantire il rispetto delle regole im-poste dalla città, venne proposta la creazione di una carica elettiva de-nominata dei «Presidenti al Teatro». Essi sarebbero stati tre, sarebbe-ro rimasti in carica due anni, mentre uno di loro avrebbe potuto «es-sere confermato per il terzo»241. A loro sarebbero state affidate variefunzioni di vigilanza. Tra le principali troviamo la periodica verificadella solidità strutturale degli edifici teatrali provvisori. Poiché le pro-porzioni di questi ultimi erano variabili, i tre presidenti avrebbero do-vuto porre particolare attenzione affinché venissero mantenute inal-terate nel tempo «le consuete dimensioni de’ palchi in altezza, lun-ghezza e larghezza»242. Associate al problema della sicurezza del fab-bricato vi erano le misure antincendio. Dovevano, perciò, impedireche nei teatri venissero introdotte «torcie a vento accese, scaldapiedi,bragiere di fuoco, pipe e cose simili» facendo in modo che nei luoghiopportuni fossero «collocati alcuni mastelli d’acqua a pronto riparod’ogni evenienza»243.
Non basta. Ad essi veniva affidata la tutela dell’ordine morale, ef-fettuata tramite la selezione delle opere musicali rappresentate, dellequali avrebbero dovuto vagliare la qualità artistica. Per farlo era lorocompito accordarsi con l’impresario affinché egli si applicasse «seria-mente alla plausibilità e decorazione della rappresentazione colla scel-ta d’ottimi ed onesti drammi o componimenti, colla condotta di va-
238. Ibidem.239. Documento 1774: 3, in Regesto.240. Ibidem.241. Ibidem.242. Capitolo terzo della relazione per una normativa teatrale: Documento 1774:
3, in Regesto.243. Ivi, capitolo quarto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 196
197
IL TEATRO DEI BORGHI
lenti e ben costumati attori, sia in classe di musica, sia in quella diballo»244. Per quanto riguarda le compagnie in prosa, dovevano con-trollare che non si allontanassero «dalla cristiana modestia», oltre a di-rimere «le loro ordinarie frequenti contese»245. Infine i problemi di or-dine pubblico. I tre presidenti avrebbero dovuto risolvere i frequentie spiacevoli casi di spettatori molesti arrecanti disturbo durante gli spet-tacoli, isolando «qualunque insolente schiamazzoso o contraventorealle leggi a prammatica del teatro» e facendone successivamente rap-porto ai rettori246. «Regolare le feste del teatro» evitando l’introduzio-ne di «maschere sospette» o di persone «inverecondamente abbiglia-te»247. Controllare l’ingresso di «servitori e biricchini di piazza», cuiveniva precluso «l’ingresso alla platea», in quanto ne nasceva spesso«confusione, tumulto e pericolo d’ulteriori disordini», ma ai quali era-no «riservate le corsie inferiori»248. La selezione del pubblico riguarda-va anche gli «sbirri e loro mogli», i quali non avrebbero potuto averepalchetti in affitto dall’impresario, ma solo «un palco sotto la loggiaa sinistra»249. Affinché l’aspetto generale del teatro fosse decoroso, do-veva essere posta particolare attenzione al posizionamento «dei lumiper gli anditi o controloggie» e a quello dei «barili d’orina», stabilen-do luoghi appositi al fine di evitare spiacevoli incidenti250.
I compiti dei tre presidenti del Teatro erano, dunque, molto diver-sificati, così come estremamente ampia era la varietà di competenzeloro richiesta. Per poter adempiere al proprio dovere, sarebbe statomesso a loro disposizione un palchetto, senza alcuna spesa, scelto dal-l’impresario. La commissione incaricata lasciò però che fosse il Con-siglio municipale a decidere se la spesa doveva «andare a carico dellaMagnifica Città, ovvero dell’impresario»251. La delibera dei deputaticomunali, come prevedibile, optò per la seconda soluzione. Il costodel palco sarebbe ricaduto su colui che produceva lo spettacolo. Pertutto il resto il progetto redatto dai tre incaricati venne approvato, a
244. Ivi, capitolo quinto.245. Ivi, capitolo sesto.246. Ivi, capitolo settimo.247. Ivi, capitolo nono.248. Ivi, capitolo decimo.249. Ivi, capitolo tredicesimo.250. Ivi, capitolo undicesimo e dodicesimo.251. Ivi, capitolo quattordicesimo.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 197
198
FRANCESCA FANTAPPIÈ
piena maggioranza252. Prima di poter entrare in vigore dovette peròpassare attraverso la convalida definitiva di Venezia, che arrivò il 14marzo del 1775253. La relazione poté essere così stampata e resa pub-blica, dando origine ai noti Capitoli per la buona e retta direzione e disci-plina delli teatri254. L’unico articolo del regolamento che differiva dallaversione approvata nel 1774 era il numero tredici, ossia quello relati-vo al divieto di affittare palchi agli «sbirri e loro mogli», abitudine cheaveva creato tanto «scandalo» e «indignazione» nella nobiltà bergama-sca. Nella versione a stampa il veto venne cassato, mentre il capitolotredici fu sostituito con quello che nel 1774 era posto al numero ot-to, ossia con l’obbligo della presenza in teatro di un «offizial d’ispe-zione col distaccamento militare» a disposizione dei tre presidenti nelcaso di incidenti o problemi di ordine pubblico255.
Se la creazione ex novo di una normativa in ambito teatrale da par-te delle autorità municipali costituiva un importante passo in avanti,in quanto mostrava per la prima volta la presa di coscienza dell’esi-stenza del fenomeno, le misure previste in merito si rivelarono imme-diatamente deficitarie. Per quanto riguarda l’obbligo di verificare lasicurezza degli edifici provvisori vediamo che, già dall’agosto del 1777,emerse il problema del costo delle perizie. Chi le doveva pagare? Co-lui che pose la questione fu Lanfranco Furietti, uno dei presidenti delTeatro in carica per quell’anno, il quale propose che, «non essendo insin ad ora gl’impresari delle opere rappresentate in questa città staticaricati delle spese occorse per le perizie circa la solidità della struttu-ra de’ teatri», quelle passate avrebbero dovuto rimanere «carico dellaMagnifica Città», ma «da qui innanzi le spese medesime» sarebberopassate «a peso degli impresari»256. Come prevedibile i deputati comu-nali approvarono la proposta. Nonostante ciò si trattava di un prov-vedimento difficilmente applicabile, in considerazione soprattuttodell’estrema variabilità degli impresari presenti in città durante le dueprincipali stagioni. In pratica a coloro che producevano gli spettaco-li sarebbero state addebitate sia le spese di costruzione degli edifici siale perizie! Una regola difficile da far rispettare e che non avrebbe of-
252. Documento 1774: 4, in Regesto.253. Documento 1775: 4, in Regesto.254. Documento 1775: 5, in Regesto.255. Documenti 1774: 3; 1775: 5, in Regesto.256. Documento 1777: 2, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 198
199
IL TEATRO DEI BORGHI
ferto nessuna garanzia, mentre più semplice sarebbe stato se i presi-denti al Teatro avessero dovuto tenere rapporti con una sola persona,invece che con individui continuamente diversi. Fu così che quando,il 4 settembre del 1777, Giovan Battista Lombardi chiese l’assegnazio-ne per quindici anni del diritto esclusivo di edificazione dei teatri prov-visori in Città Alta ed in fiera, sfondò una porta aperta257. L’approva-zione della richiesta fu immediata258.
Se Giovan Battista Lombardi fu il principale impresario delle ope-re buffe tenute dalla fine degli anni Settanta fino ai primi anni No-vanta nel Teatro della Cittadella, per quanto riguarda il teatro di fie-ra la sua attività s’interruppe con l’approvazione della domanda di ri-strutturazione dell’edificio provvisorio esistente presentata nel 1786da Bortolo Riccardi. Non conosciamo l’esatta struttura dei cosiddet-ti «teatri di tavole», ma un’idea ci può essere data dalla testimonian-za del nobile Giovan Giacomo Arrigoni: prima della costruzione delTeatro Riccardi, i casotti di fiera «si facevano di soli due ordini. Il pri-mo ordine aveva il suolo della altezza dello scenario, ed il secondoprincipiava dove terminavano li palchi del primo e sotto il primo or-dine eravi si può dire una loggia che serviva per li servitori»259. Tra il1775 e il 1786 vennero rappresentate opere musicali con cadenza an-nuale, prevalentemente di genere buffo. Nel 1775 Il geloso in cimento enel 1776 L’avaro di Giovanni Bertati da parte di impresari imprecisa-ti260. Nel «nuovo teatro di fiera» costruito da Giovan Battista Lombar-di venne rappresentata nel 1778 l’opera buffa, da lui stesso prodotta,intitolata Il curioso indiscreto con musica di Pasquale Anfossi261. Seguìnel 1779 La forza delle donne del Bertati e nel 1780 La contessina di Mar-co Coltellini e Carlo Goldoni262. Di quest’ultima rimane l’avviso astampa nel quale, all’inizio del mese di agosto, vennero pubblicizza-
257. Documento 1777: 3, in Regesto.258. Su Giovan Battista Lombardi ricadeva anche il pagamento dell’affitto del
«fondo del teatro in tempo di fiera» all’Ospedale Maggiore di Bergamo, di cui l’uni-ca registrazione che possediamo risale al settembre del 1785: Documenti 1785: 10-11, in Regesto.
259. La citazione è tratta da una lettera di Giovan Giacomo Arrigoni diretta adignoto del 7 novembre 1786, riportata in F. Buonincontri, Il sistema teatrale, cit., pp.68, 69-70.
260. Il geloso in cimento (1775) e L’avaro (1776), in Cronologia.261. Il curioso indiscreto (1778), in Cronologia.262. La forza delle donne (1779) e La contessina (1780), in Cronologia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 199
200
FRANCESCA FANTAPPIÈ
ti i prezzi degli abbonamenti e dei biglietti, con le relative modalitàdi pagamento, da parte di Giovan Battista Lombardi263. Nel 1781 ab-biamo la rappresentazione «nel teatro di fiera» dell’opera buffa di Fi-lippo Livigni: I viaggiatori felici con musica di Pasquale Anfossi, cui se-guì nell’autunno del 1782 quella de Il convito con musica di Domeni-co Cimarosa264. Nel 1783, invece, il Lombardi cambiò genere. Si rap-presentò l’Erifile di Giovanni De Gamerra, musica di Giuseppe Gior-dani, scenografi i rinomati fratelli Galliari. Una produzione impegna-tiva, offerta alle «dame e cavalieri» della città, ossia alla società nobi-liare bergamasca, cui l’impresario dedicò il libretto al fine di accatti-varsene la benevolenza265. Segno del successo dell’iniziativa fu la ri-conferma del genere nei due anni direttamente successivi. Nel 1784Giuseppe Lombardi, fratello di Giovan Battista e violinista, proposenel «nobile provvisionale teatro di fiera» la rappresentazione del Me-donte di Giovanni De Gamerra musica di Giuseppe Sarti. L’opera fuintervallata da un ballo eroico-pantomimo dal titolo Atridate Farnacedi Giovanni Favier266. Nel 1785, infine, venne messa in scena, in quel-lo che fu definitivo il «nuovo provvisionale teatro di fiera», per ini-ziativa di alcuni impresari «associati», il dramma serio di Gaetano Ser-tor L’Osmane con musica di Giuseppe Giordani267. Una scelta, quelladel repertorio operistico musicale serio, che sarebbe stata confermatain seguito dalla programmazione del Teatro Riccardi, rendendo defi-nitivamente la stagione operistica estiva artisticamente superiore aquella invernale del Teatro della Cittadella.
2.2. Dal portico a piloni al teatro in pietra (1786-1791)
Il 1786, anno in cui ebbe inizio l’edificazione del Teatro Riccardi,è la data a partire dalla quale viene normalmente attribuito un teatrostabile a Bergamo268. Considerazione che appare parzialmente inesat-
263. Documento 1780: 4, in Regesto.264. I viaggiatori felici (1781) e Il convito (1782), in Cronologia.265. L’Erifile (1783), in Cronologia.266. Il Medonte (1784), in Cronolgia.267. L’Osmane (1785) in Cronolgia.268. L. Pelandi, I teatri di Bergamo, cit., p. 116; F. Buonincontri, Il sistema teatra-
le, cit., p. 70; E. Comuzio, Il teatro Donizetti, cit., vol. I, p. 22; E. Comuzio, A. Mo-retti, Il Teatro Riccardi, cit., pp. 9-10, secondo i quali la costruzione del portico a pi-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 200
201
IL TEATRO DEI BORGHI
ta: prima che l’edificio teatrale fosse concluso e potesse tenere con re-golarità la propria programmazione bisognava attendere il 1791. Latrasformazione del teatro di fiera da una struttura provvisoria in le-gno ad una permanente in pietra non si rivelò affatto un processo scon-tato. Viceversa si mostrò, fin dal suo inizio, un’avventura piena di in-cognite, a tratti rocambolesca, costellata di innumerevoli ostacoli chesolo una personalità risoluta, scaltra e insieme dotata di grandi slan-ci, come quella di Bortolo Riccardi poteva superare. Fu grazie alla de-terminazione del suo costruttore che il processo avviatosi nel 1786 siconcluse con l’erezione di un teatro progettato per durare. Com’è no-to infatti, l’edificio – nell’Ottocento rinominato Teatro Donizetti – èattualmente esistente, seppure non nella sua forma originale.
È sufficiente leggere la domanda presentata dal Riccardi alla Cittàdi Bergamo nel 1786 per comprendere come il progetto inizialmenteapprovato non prevedesse alcun edificio stabile. Ciononostante l’im-presario, alla fine di un meccanismo apparentemente inarrestabile, pas-sò alla realizzazione di un teatro permanente. Tutto ciò senza mai aver-ne ottenuto il permesso e riuscendo perfino a vedersene legittimamen-te riconosciuta la proprietà. Una vicenda che può essere suddivisa inalmeno due fasi. Quella iniziale si svolse nella prima metà del 1786, os-sia dal conseguimento della licenza per la messa in sicurezza del vec-chio teatro di legno fino all’inaugurazione della nuova struttura con larappresentazione di un’opera tenuta nell’agosto dello stesso anno. Laseconda fase è quella che seguì la fine della fiera del 1786 e si conclu-se con la definitiva conversione in pietra dell’edificio nel 1791. È nelcorso di questo quinquennio che ebbero luogo le “battaglie” determi-nanti. Si trattò di un lungo periodo segnato da controversie di ogni ti-po. Nel corso del primo anno lo scontro principale avvenne tra alcunipalchettisti del primo ordine del vecchio teatro provvisorio in fiera – i
loni avrebbe coinciso con l’atto di nascita del Teatro Riccardi. Un punto di vista opi-nabile, ma che trova parziale giustificazione nei documenti. Errato è, invece, attri-buire il 1784 quale data di nascita del teatro come fanno Elia Dolci, Spettacoli liricinei teatri di Bergamo, Riccardi, Cerri, Società, Rossi, Politeama Givoli 1784-1894. Testo.Dedica. Dichiarazione. Illustrazioni artistiche bergamasche. Teatro Riccardi. Teatro Cerri.Teatro della Società. Teatro Rossi. Politeama Rivoli. Notabilità artistiche che vi agirono, Edi-zione fuori commercio, Copie 10 a spese dell’autore, [1894], BCBg, Sala 32 B 8 1/2e G.B. Pinetti, Teatro Donizetti, cit., p. 8. Inverosimile, infine, la tesi di Pierluigi For-cella, Musica e musicisti, cit., pp. 63-64, secondo cui l’edificio non solo sarebbe statoinaugurato nel 1784, ma avrebbe subito un incendio lo stesso anno.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 201
202
FRANCESCA FANTAPPIÈ
quali contestavano la realizzazione del progetto che, invece, era gradi-to ai palchettisti del piè piano – contro i Deputati della Città, i presi-denti del Teatro e i presidenti dell’Ospedale Maggiore. Verso la fine del1788 la lite si capovolse totalmente. Tutti i palchettisti si trovarono adagire uniti, compresi quelli del secondo ordine. Coadiuvati dalla Cittàdi Bergamo, dai presidenti del Teatro e da quelli dell’Ospedale, si schie-rarono contro il Riccardi, colpevole di non aver ancora terminato il tea-tro. La causa, arenata a Venezia, vide fasi alterne. Il punto di svolta funel 1790, quando i Deputati della Città e i ministri dell’Ospedale usci-rono dalla vertenza legale. Rimasta a carico dei soli presidenti del Tea-tro, a loro volta dimissionari e divenuti semplici procuratori dei pal-chettisti, la vicenda si concluse con il riconoscimento da parte dei tri-bunali veneziani di Bortolo Riccardi come unico proprietario dell’edi-ficio. Una catena di atti giudiziari, petizioni e contro petizioni che rim-balzarono a lungo da Bergamo a Venezia e viceversa, durante la qualeaffiorarono, tutti in una volta, i comportamenti e gli automatismi giàriscontrati in un secolo e mezzo di storia teatrale della città. Ritrovia-mo puntualmente la forte volontà di distinzione di buona parte dellaclasse nobiliare, una mentalità conservatrice largamente diffusa, il pre-valere degli interessi individuali sugli obiettivi comuni e, infine, la vo-lontà, in questo caso largamente condivisa, di non lasciare emergereuna personalità che potesse minare i rapporti di potere esistenti, tantopiù un homo novus, non appartenente ad alcuna delle casate di anticafondazione della città.
Il brillante avvio di tutta la vicenda va comunque ricercato nel 1786,momento della presentazione della domanda. Come abbiamo visto,le richieste di costruzione di edifici teatrali stabili in fiera esibite inprecedenza erano state puntualmente rifiutate. Un atteggiamento dichiusura riscontrato normalmente anche nella concessione dello spa-zio sotto la loggia del Palazzo della Ragione a scopo teatrale. Se con-frontiamo la domanda di Francesco Bolognese del 1770 con quella diBortolo Riccardi possiamo individuare due strategie molto differenti.Il primo presentò un progetto molto dettagliato e circostanziato incui chiedeva esplicitamente di edificare un teatro permanente. Venneperò bocciato, perché non si raggiunse un accordo sull’assegnazionedei palchetti.269 Il secondo fu più scaltro. Non chiese di costruire un
269. Cfr. Supra, pp. 191-195.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 202
203
IL TEATRO DEI BORGHI
teatro stabile ex novo, ma il permesso di tirare su, alquanto generica-mente, alcuni piloni di rinforzo per coprire e proteggere un nuovoteatro in legno che sarebbe stato in questo modo messo in sicurezza.In merito all’edificio provvisorio sottostante si impegnò ad apporta-re alcune modifiche che avrebbero determinato l’aumento comples-sivo del numero dei palchetti, con la promessa di non alterare la di-sposizione dei vecchi e mantenendo invariati i posti già assegnati aipalchettisti del vecchio teatro di fiera. Promise quindi il miglioramen-to della situazione, escludendo che venissero apportati cambiamentidi sorta. A favore di Bortolo Riccardi giocava inoltre un altro fattore:la scelta del momento. L’approvazione dei Capitoli per la buona e rettadirezione e disciplina delli teatri nel 1775 e la concessione di una priva-tiva quindicennale a Giovan Battista Lombardi nel 1777 avevano am-piamente evidenziato l’esigenza espressa dalla classe dirigente berga-masca di garantire la sicurezza strutturale degli edifici teatrali. Infine,affinché il progetto fosse approvato, il Riccardi lasciò che fossero i pre-sidenti del Teatro e i presidenti dell’Ospedale Maggiore a redigere ilcontratto.
Ma vediamo in dettaglio la domanda. Il primo dato in nostro pos-sesso è relativo al 26 gennaio del 1786, quando Giovan Battista Vita-li Rota e Bortolo Riccardi presentarono contemporaneamente al-l’Ospedale Maggiore di Bergamo i rispettivi progetti per costruire «unportico sostenuto da vari piloni de mattoni, a fine ed effetto di sottofabbricarvi il solito teatro di fiera a maggior sicurezza del pubblico»270.Poiché il pio istituto, pur riscuotendo la pigione del fondo, non neera proprietario, i suoi funzionari inoltrarono la supplica alla Città diBergamo che ne aveva il diretto possesso. La scelta tra i due postulan-ti spettò quindi ai deputati comunali i quali, riuniti nel Consiglio Mag-giore, scartarono il progetto del Vitali Rota e approvarono quello delRiccardi, affidando il compito di concordare il relativo contratto aipresidenti del Teatro e ai presidenti dell’Ospedale. Nonostante ciò siriservavano il diritto di abbattere la struttura a loro piacimento, ossiache «tanto il detto portico, quanto il detto provisional teatro di legnodebba demolirsi in ogni tempo a beneplacito di questo Maggior Con-cilio»271. Il 31 dicembre 1786 l’Ospedale Maggiore incaricò, quindi, il
270. Documento 1786: 7, in Regesto.271. Documento 1786: 8, in Regesto. L’approvazione del progetto di Bortolo Ric-
cardi non fu l’unico ordine del giorno messo a votazione. Emblematica di una men-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 203
204
FRANCESCA FANTAPPIÈ
proprio ministro Girolamo Secco Suardo e due deputati di stendere,insieme ai presidenti del Teatro in carica, l’accordo da far firmare aBortolo Riccardi272.
Il contratto, sottoscritto il 13 febbraio dello stesso anno, venne sud-diviso in ventotto capitoli che disciplinavano più aspetti. Per quantoriguarda le problematiche di ordine strutturale il principale cambia-mento rispetto al cosiddetto «teatro di tavole» sarebbe stato la con-versione delle logge sottostanti il primo ordine di palchetti, destinatenormalmente ai servitori, in un «nuovo ordine de’ palchi» da «deno-minarsi piè piano, conforme si vede ne’ teatri di altre colte città»273.Ai servitori veniva così destinato il loggione, mentre per ogni lato diciascun ordine era prevista l’aggiunta di due palchetti274. In vista delloro aumento complessivo si stabilì il metodo di attribuzione. Colo-ro che fossero stati in possesso di palchetti nel vecchio teatro di fierasi vedevano riconosciuto un diritto di prelazione nell’acquisto dei nuo-vi. La tabella con il preventivo dei costi mostra come nel nuovo tea-tro gli ordini più prestigiosi diventassero il piè piano e il primo. Perquesto motivo chi fosse stato in possesso di un palchetto nel primoo secondo ordine del vecchio teatro poteva esercitare il diritto, dichia-randolo anticipatamente, di scendere in maniera automatica al livel-lo a lui direttamente inferiore275. Per quanto riguarda l’accesso a nuo-vi palchettisti si ribadiva un criterio di stretta selezione sociale. Essisarebbero stati scelti solo tra gli appartenenti alle «famiglie del Con-cilio di questa Magnifica Città e quelle de’ titolati assentiti dall’eccel-lentissimo Magistrato sopra feudi»276. Per essere estratti a sorte dove-vano iscriversi in una lista esposta «nella Cancelleria della Città», manessuno avrebbe potuto «imbussolarsi per avere più di un palco»277.Stabilite le regole relative allo spinoso argomento della distribuzione
talità fortemente conservatrice, anche se respinta, fu la proposta di Ferdinando Pez-zoli, il quale chiedeva che «questa Magnifica Città non presti verun assenso, né sipossa fabbricare teatri, né in tutto, né in minima parte figuranti solidità, cioè né me-no con piloni di pietra o mattoni, quando libero non sia il concorso de’ nostri cit-tadini alla proprietà dei palchi de’ teatri medesimi», Ibidem.
272. Documento 1786: 9, in Regesto.273. Primo articolo del contratto per la costruzione di un portico a piloni: Do-
cumento 1786: 10, in Regesto.274. Ivi, secondo e terzo articolo del contratto.275. Ivi, quarto e quinto articolo.276. Ivi, ottavo articolo.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 204
205
IL TEATRO DEI BORGHI
dei palchi, si passava a definire i prezzi per gli abbonamenti alla sta-gione di fiera, distinguendo tra «opera seria», «opera buffa» e «com-media», stimate in ordine di valore decrescente; ed infine il prezzodel biglietto serale che, uniformandosi ad un’abitudine consolidata,distingueva tra «signori di Città» e «signori dei Borghi»278. Dietro cia-scun palchetto era prevista la costruzione di «un camerino» che sareb-be stato affittato «per il tempo che vi sarà opera lire ventidue e per iltempo della commedia lire undici per cadauno»279. Ai presidenti delTeatro sarebbe stato assegnato «in luogo decente un palco» senza ilpagamento di nessun compenso280.
Per quanto riguarda le regole cui si doveva attenere il «fabbricato-re», ossia Bortolo Riccardi, troviamo norme di ordine economico, maanche di tipo più generale. Il punto fondamentale rimaneva però unosolo: non gli sarebbe stata riconosciuta la proprietà ufficiale dell’edi-ficio. Il suo utilizzo rimaneva sottoposto ad uno stretto controllo, inquanto «le chiavi del teatro medesimo» dovevano rimanere «in custo-dia del Venerando Ospital Maggiore», per essere consegnate al Riccar-di soltanto nel periodo stabilito per l’apertura281. Tale periodo eracompreso dall’«ottava di Pasqua sino alla prima domenica d’Avventoall’effetto che l’opera o commedia del Carnevale si faccia sempre en-tro la cinta nuova di questa città»282. La stagione estiva era destinataai Borghi, mentre quella invernale spettava di diritto alla Città Alta.In merito ai teatri provvisori costruiti in quest’area urbana anche ilRiccardi, in qualità di costruttore, avrebbe avuto i suoi obblighi. Pergarantire spettacoli tutto l’anno, nel caso che non si fossero trovati«altri fabbricatori del suddetto teatro di legno in Città», sarebbe spet-tato a lui edificarlo, sia che venisse stabilito come luogo la «sala gran-de del Palazzo Prefettizio», sia che si ripiegasse su «altro sito sempredentro il fortilizio nuovo della città stessa»283. Si legiferava poi sul ca-
277. Ivi, decimo articolo.278. Ivi, ventiquattresimo e ventisettesimo articolo. Sulla distinzione dei prezzi
tra spettatori di Città Alta e quelli dei Borghi in relazione alla zona in cui si tenevalo spettacolo si veda anche il Documento 1780: 4, 1788: 44, in Regesto.
279. Quattordicesimo articolo: Documento 1786: 10.280. Ivi, ventesimo articolo.281. Ivi, sedicesimo articolo.282. Ivi, diciassettesimo articolo.283. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 205
206
FRANCESCA FANTAPPIÈ
none d’affitto del «teatro nel prato di fiera»: da parte del «progettan-te fabbricatore» sarebbero state riscosse «lire cinquemila correnti» enon oltre da chi avesse fatto richiesta dell’edificio. L’impresario affit-tuario, infine, avrebbe potuto subaffittarlo «per commedie o altri spet-tacoli ne’ tempi permessi per l’apertura del teatro medesimo»284. Il Ric-cardi avrebbe dovuto corrispondere all’Ospedale Maggiore «l’annuocanone di lire cinquecento correnti per il fondo» su cui veniva co-struito l’edificio285. Il termine finale previsto per la sua ultimazionevenne fissato ai «primi di agosto» del 1786, mentre l’area destinata fuquella «in prospetto al rastello di mezzo di là dallo stradone verso ilportello delle Grazie»286.
Se quindi il contratto definiva nei minimi particolari gli aspetti eco-nomici, oltre al metodo di assegnazione dei palchetti, ciò che stupi-sce maggiormente è che, al momento della sua redazione, mancasseancora un disegno che definisse il progetto dal punto di vista archi-tettonico e strutturale. All’articolo dodicesimo venne, infatti, ordina-to a Bortolo Riccardi di fornire
un disegno, il quale dimostri la costruzione e circonferenza di detto tea-tro da essere il disegno medesimo prima di mettersi in esecuzione appro-vato da detti Magnifici Signori Presidenti del Teatro e presidenti dell’Ospi-tale, nel qual dissegno doveranno comprendersi le particolari scale chediano ingresso alli palchi, scenarii di tutti gl’ordini, distinte da quelle del-lo scenario287.
La pianta dell’edificio progettato, fonte di numerose polemiche suc-cessive, venne fornita dal Riccardi e approvata dai ministri dell’Ospe-dale, nonché dai presidenti del Teatro in carica, solo il 20 maggio 1786,mentre non abbiamo alcuna testimonianza della realizzazione di unalzato (figg. 24-25)288. Si tratta di una palese superficialità che contra-sta fortemente con la pignoleria con cui vennero definiti tutti gli al-
284. Ivi, diciottesimo articolo.285. Ivi, diciannovesimo articolo.286. Ivi, tredicesimo articolo.287. Ivi, dodicesimo articolo.288. Si tratta della pianta sottoscritta dall’architetto Giovan Francesco Lucchi-
ni. Del teatro non esiste però un alzato, né è stata reperita la richiesta di un similedisegno progettuale. Per un’analisi del progetto si veda anche F. Buonincontri, Il si-stema teatrale, cit., p. 72.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 206
207
IL TEATRO DEI BORGHI
tri termini contrattuali. È evidente che, almeno inizialmente, Borto-lo Riccardi fu considerato alla stregua della categoria professionale rap-presentata da Domenico Compagnoni, Giovan Battista Lombardi o ifratelli Dehe, costruttori di teatri provvisori in legno a loro volta ce-duti ad impresari itineranti. Figure attive nel settore teatrale, ma chenon destavano sospetti, in quanto destinati a perdere ogni loro fun-zione con la demolizione dell’edificio da loro stessi creato.
Il contratto, così stipulato, fu approvato dal Consiglio Maggioresenza l’apposizione di modifiche sostanziali. Venne aggiunta una so-la precisazione ossia che, nel caso di inadempienze da parte di Bor-tolo Riccardi, fosse data facoltà ai presidenti del Teatro e ai presiden-ti dell’Ospedale «di far eseguire da qualunque altra persona che da lo-ro fosse scielta la sudetta costruzione di detto portico e teatro»289. Ta-le clausola, che relegava l’edificatore della struttura ad un elementofacilmente sostituibile, ribadiva ulteriormente la volontà della classedirigente bergamasca di non lasciare spazio a pericolose iniziative in-dividuali. L’Ospedale, a sua volta, dette il via libera290. Per quanto ri-guarda i rettori, in considerazione dell’«universale consenso» e «con-formità d’opinioni» da loro riscontrata nella compagine sociale citta-dina, non ci furono obiezioni di sorta. Il progetto passò senza diffi-coltà al Consiglio dei Dieci di Venezia allo scopo di ottenere l’indi-spensabile licenza, che arrivò il 21 marzo del 1786291. La proposta ap-provata dai Capi del Consiglio si presentava nel modo seguente: «ri-costruire sotto un portico a pilloni il solito provvisionale teatro chetrovasi formato di legno, il quale reso dal tempo fracido minaccia im-minente rovina»292. Anche in questo caso, pertanto, non vediamo an-cora espressa l’idea di un teatro stabile in pietra.
Ottenuto il via libera di Venezia seguì, senza problemi, il processodi assegnazione dei palchetti, cui venne dato avvio con la pubblicazio-ne, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, di appositi proclami daparte dei rettori293. Nello stesso periodo venne completata la lista deinominativi da estrarre a sorte per la distribuzione di quelli nuovi294. È
289. Documento 1786: 12, in Regesto.290. Documento 1786: 11, in Regesto.291. Documenti 1786: 13-14, in Regesto.292. Documento 1786: 16, in Regesto.293. Documenti 1786: 20, 22, in Regesto.294. Documento 1786: 23, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 207
208
FRANCESCA FANTAPPIÈ
così che il 16 giugno poterono essere resi noti ufficialmente gli elenchidefinitivi295. Il giorno seguente fu intimato agli assegnatari un terminedi quindici giorni per versare alla cassa dell’Ospedale Maggiore la quo-ta d’acquisto per il palchetto ricevuto, pena la rinuncia a qualsiasi di-ritto296. Tutto secondo i programmi, tanto da rendere possibile il rego-lare svolgimento della rappresentazione inaugurale. In occasione dellafiera del 1786 venne, infatti, messa in scena, con la scenografia dei fra-telli Galliari, La Didone abbandonata di Pietro Metastasio intervallata dadue balletti: il primo, un «un ballo favoloso pantomimo», intitolato Er-cole negli Orti Esperidi, il secondo, un «ballo comico», Le reclute del villag-gio297. Produzione impegnativa sostenuta dall’impresario Giovan Batti-sta Vitali Rota il quale, all’inizio del mese di luglio, aveva stipulato uncontratto di affitto stagionale con Bortolo Riccardi per il prezzo di cin-quemila lire.
Nonostante ciò il reale stato della situazione era molto differente daquanto appariva in superficie. L’atto sottoscritto tra Vitali Rota e Ric-cardi mostra le prime avvisaglie di una dilazione da parte del costrutto-re rispetto ai termini stabiliti per la consegna dell’edificio. La sua realiz-zazione, inoltre, iniziava a rilevarsi parzialmente differente da quantodichiarato originariamente. Giovan Battista Vitali Rota definisce lo sta-bile da lui preso in affitto come «il teatro novo sopra piloni presente-mente in fabrica»298. Una variante descrittiva in cui i cosiddetti «piloni»non vengono più indicati come semplice elemento di sostegno di unportico posto a protezione di un edificio ligneo sottostante, ma sonoconsiderati struttura portante dello stesso. Parallelamente veniamo a sa-pere che i lavori non erano ancora terminati. Vitali Rota chiese, infatti,particolari assicurazioni che «detto teatro con li quattro ordini de’ pal-chi, cioè piè piano, primo, secondo e terzo ordine» fosse «in stato ser-vibile per il 15 d’agosto prossimo venturo, tempo in cui deve andare inscena l’opera, coperto di assi sì il senario che li palchi e la platea»299. Co-
295. Documenti 1786: 24-26, in Regesto.296. Documento 1786: 27, in Regesto. La quota raccolta dai ministri dell’Ospe-
dale Maggiore di Bergamo ammontava, in data 20 marzo 1787, a «lire quarantamilacontanti»: Documenti 1787: 11, 14, in Regesto.
297. La Didone abbandonata (1786), in Cronologia.298. Documento 1786: 28, in Regesto.299. Ibidem. Il conto contratto dal Rota con il Riccardi venne saldato il 3 mar-
zo dell’anno seguente: Documento 1787: 12. Lo stato incompleto dell’edificio vie-ne confermato da attestazioni successive, secondo cui «nell’anno 1786 fu fatta l’ope-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 208
209
IL TEATRO DEI BORGHI
me ulteriore segno delle difficoltà incontrate dal suo costruttore, l’8 ago-sto cadde «parte del Teatro Riccardi»300. Nonostante il teatro fosse in-completo, l’opera andò in scena ugualmente. La dedica del libretto daparte dell’impresario è del 22 agosto 1786301. L’avviso a stampa relati-vo agli spettacoli è del 31 agosto302. Lo spettacolo non ottenne proba-bilmente il successo sperato, tanto che per coprire le spese il 7 settem-bre venne indetta una serata a beneficio dell’«impresa dell’opera»303. Lerappresentazioni continuarono almeno fino al 17 dello stesso mese,quando abbiamo notizia di una una serata in onore di alcuni interpre-ti del cast304.
L’inaugurazione dell’edificio incompiuto non rappresentò l’attoconclusivo della vicenda, ma fu soltanto l’inizio di una lunga peripe-zia costruttiva e legale. Al termine della fiera, tutti i nodi vennero alpettine. Le numerose recriminazioni per le anomalie rilevate nell’edi-ficio e per le inadempienze del costruttore, le lamentele più diversifi-cate, tenute a freno nel corso della stagione operistica per dare modoallo spettacolo di avere il suo corso, emersero una dopo l’altra e si le-varono in un’immancabile protesta che si placò solo dopo ben cin-que anni di battaglie giudiziarie, segnando un lungo periodo di sta-gnazione per l’attività del teatro. Tuttavia il meccanismo era stato in-nescato. Impossibile ricostruire l’estenuante vicenda legale in tutti isuoi particolari, nonostante l’ampia documentazione reperita. L’im-magine complessiva che ne deriva è quella di una città che per un quin-quennio visse un clima generalizzato di delazioni, di polemiche e disospetti, assistendo a continui capovolgimenti di fronte nei gruppi chedi volta in volta si contrastavano: pur di vedersi riconosciuta una qual-siasi vittoria, i contendenti erano disposti ad aggirare le regole, elu-dendo parte dei fatti o talvolta contraffacendoli. Difficile perciò di-stinguere la veridicità delle testimonianze in una situazione progres-sivamente sempre più intricata. Ciò che emerge chiaramente è che,
ra in questa città nel tempo di fiera in un teatro incompleto a piloni, senza tetti ecoperto di tele»: Documento 1788: 39.
300. Documento 1786: 30, in Regesto. La notizia è confermata da una lettera diGiovan Giacomo Arrigoni secondo il quale «cascò parte del tetto di legno, ma nel-l’atto della costruzione per caso fortuito»: Documento 1786: 63, in Regesto.
301. Si veda La Didone abbandonata (1786), in Cronologia.302. Documento 1786: 32, in Regesto.303. Documenti 1786: 41-42, in Regesto.304. Documento 1786: 43, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 209
210
FRANCESCA FANTAPPIÈ
approfittando dei non infrequenti momenti di divisione dei propriavversari e proseguendo pervicacemente nella propria ambiziosa lineadi condotta, Bortolo Riccardi riuscì a portare a compimento la costru-zione di un teatro permanente. Un progetto che lo svolgimento de-gli eventi mostrò essere stato quello da lui realmente concepito findal principio.
Ma analizziamo gli avvenimenti principali che caratterizzarono glianni tra il 1787 e il 1791. Primi ad insorgere contro la realizzazionedel progetto furono alcuni palchettisti del primo ordine, i quali nonsi schierarono direttamente contro il Riccardi, ma fecero causa ai De-putati del Consiglio, ai presidenti del Teatro e ai presidenti dell’Ospe-dale che avevano approvato il progetto305. L’insoddisfazione nascevadal fatto che il piè piano era troppo alto ed appariva più prestigiosodel primo ordine, fino ad allora considerato il livello più importante.I cosiddetti «piepianisti», al contrario soddisfatti del risultato, feceroistanza contro i palchettisti del primo306. Essi a loro volta risposero ag-giungendoli ai contendenti del loro ricorso iniziale307. Lo scontro co-sì descritto, ancorché grottesco, appare semplice. In realtà dietro tut-to ciò si celavano una molteplicità di ulteriori rimostranze che nonemergono dalle carte legali. Rivelatore dello stato della questione è ilcarteggio di Giovan Giacomo Arrigoni, capofila dei palchettisti del pri-mo ordine, con il proprio procuratore legale a Venezia. Grazie al no-bile bergamasco sappiamo che l’intenzione iniziale del gruppo da luirappresentato non era tanto quella di «una demolizione di teatro, mache quello» fosse «ridotto in quel stato che il Principe» aveva accor-dato e che non venissero «pregiudicati li aventi palco in quel teatrodi fiera»308. Il problema principale riguardava l’ordine piepiano «alte-rato notabilmente in pregiudizio di tutti li altri ordini de’ palchi, daquello che era nel teatro di legno demolito». Di ciò poteva darne pro-va «con testimoni ed anche col disegno che tengo del vecchio demo-lito teatro»309. Un’anomalia rilevata nel corso dell’opera in fiera, mache non sarebbe stato possibile comprendere prima del suo svolgimen-to. Secondo l’Arrigoni il nuovo edificio, situato «in qualche distanza
305. Documenti 1786: 65-66, in Regesto.306. Documenti 1787: 3, 5, in Regesto.307. Documenti 1787: 9, 13, in Regesto.308. Documento 1786: 47, in Regesto.309. Documenti 1786: 48, 51, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 210
211
IL TEATRO DEI BORGHI
dal vecchio», avrebbe dovuto essere di legno e «conformarsi a quelloera in pericolo di cadere»310. Quest’ultimo, però, era stato abbattuto:«principiata la fabbrica del portico per il nuovo teatro, fu demolito ilvecchio»311. È per questo che i palchettisti del primo ordine, che ades-so si dichiaravano insoddisfatti, avevano scelto di non cedere il pro-prio palco e, quando era stata data loro la possibilità, «non mutaro-no sito». Perché non avevano avuto alcun modo di prevedere l’entitàdelle modifiche. L’altezza complessiva degli ordini era cresciuta ecces-sivamente, mentre lo spazio occupato dal portico era «maggiore diquello fosse tutto il vecchio teatro di legno». Il risultato: «un teatropiù grande di quello di San Benedetto» a Venezia312. Il ricorso caddenel vuoto. Contro i palchettisti del primo ordine si obiettava che ave-vano comunque assistito all’opera del 1786.
A tutto ciò bisogna aggiungere che, come accennato, la conversio-ne della loggia sottostante il primo ordine in un nuovo livello di pal-chetti, detto piè piano, era stata prevista dalla commissione incarica-ta di redigere il contratto con il Riccardi. Secondo Giovanni AntonioAdami, funzionario dell’Arrigoni, «non è da stupirsi» se «li Presiden-ti del Teatro e quelli dell’Ospitale non si siano mossi», in quanto «es-si in certo modo sono li rei in quanto che hanno mancato ai loro do-veri»313. Essi sarebbero stati i principali “conniventi” di Bortolo Ric-cardi. L’accusa si spingeva oltre. Descritti come autori di un vero eproprio complotto, avrebbero consapevolmente lasciato che il co-struttore convertisse il progetto di un teatro provvisorio in quello diuno permanente. «Doppo avere il tutto combinato col Riccardi, sen-za meno chiamare li proprietari dei palchi» e ricevuta «la ducale ap-provativa del teatro» iniziarono a dare corso al loro piano: «fecero cor-rere voce che erano approvati anche li capitoli» e «ordinavano al Ric-cardi ciò che credevano senza parlarne con altri», né più «si curavanodi esporre alla Città»314. Il costruttore, agendo senza alcuna autorizza-zione da parte del Consiglio municipale, ma incitato dai suoi com-plici, «principiò a far scavare per li fondamenti dei piloni e del murocon cui venivano legati. E fin qui non si poteva dire se non che erig-
310. Documento 1786: 49, in Regesto.311. Ibidem.312. Ibidem.313. Documento 1786: 54, in Regesto.314. Documento 1786: 55, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 211
212
FRANCESCA FANTAPPIÈ
geva il portico per costruervi poscia il teatro di legno internamente»315.La costruzione sarebbe poi andata avanti sulla base di «una termina-zione de’ Presidenti con certo disegno da essi voluto», chiaro riferi-mento alla pianta sottoscritta dai ministri dell’Ospedale e presidentidel Teatro il 20 maggio 1786 (fig. 25). Nessuno in quel momento ave-va obiettato, perché «non si poteva comprendere da un sol dissegnoche, posto in città e poi portato via» ciò che «si ebbe a vedere col en-trare nei palchi», ossia la reale volontà del costruttore: «la idea che que-sto sia teatro suo»316. Solo dopo lo spettacolo si sarebbero accorti cheil Riccardi voleva «fare anche li palchi con mattoni» e che, sebbenefossero ancora separati da «soli assi», erano «le buche artefatte per far-vi tanti muri che dividessero li palchi»317.
Di fronte all’esplicita conversione del progetto da quello di un tea-tro provvisorio in legno ad uno permanente in muratura non seguìalcuna azione da parte della Città. Secondo l’Arrigoni, che accusavail Consiglio municipale di inerzia, «ànno li deputati, dopo il nato, evi-tato di portare alcuna parte»318. Una scelta obbligata da parte del Co-mune: tra i palchettisti del Teatro Riccardi vi era una buona parte deideputati o, se non essi direttamente, vi erano rappresentate le loro fa-miglie. Deliberare sull’argomento avrebbe inevitabilmente trasferitola diatriba all’interno della principale assemblea cittadina, provocan-do pericolosi contrasti al suo interno e intralciando le attività ordina-rie. Ciononostante, secondo l’Arrigoni, a Bergamo sarebbero stati «ilmaggior numero quelli delli malcontenti del teatro»319. Un’afferma-zione probabilmente non del tutto veritiera. Da parte della Città tut-to taceva e la denuncia dei palchettisti del primo ordine contro i de-putati municipali fu inascoltata. Le accuse contro di loro divenneroquindi sempre più pesanti: essi avrebbero addirittura contravvenutoalle loro proprie stesse regole, in quanto «passarono propriamente adordinare al Reccardi un nuovo teatro di pietra solido e non di legno,né solo appoggiato a’ piloni permessi, ma con totale alterazione delvecchio demolito»320. Insinuazione che l’Arrigoni non riuscì a prova-
315. Ibidem.316. Ibidem.317. Ibidem.318. Documento 1786: 58, in Regesto.319. Documento 1786: 67, in Regesto.320. Documento 1787: 6, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 212
213
IL TEATRO DEI BORGHI
re con nessun documento, né esiste alcuna delibera comunale in talsenso. Per potersi difendere la Città mise, inizialmente, in campo ilNunzio, il quale in un secondo tempo venne ritirato dalla contesa: laCittà non poteva essere coinvolta in battaglie legali senza l’approva-zione del Collegio alle Liti321. Le polemiche di una parte dei palchet-tisti, espresse dall’Arrigoni, non ebbero perciò alcun esito. La conclu-sione finale di fronte all’iniziale sconfitta fu un giudizio di tipo carat-teriale nei confronti del costruttore: «il Reccardi è noto a tutti per per-sona violenta» e «non se ne poteva aspettare che dei disordini e di-spiaceri»322.
Il tacito consenso di una parte del ceto dirigente cittadino fu, al-meno inizialmente, un dato reale, così come quello dei ministri del-l’Ospedale, per i quali il passaggio da un teatro provvisorio ad unostabile avrebbe reso definitivamente sicuro l’affitto e garantito, comenel 1732 la conversione della fiera in muratura, un miglioramento del-l’assetto complessivo dell’area323. I palchettisti del primo ordine si tro-varono ad agire totalmente isolati. Approfittando dell’inefficacia deiloro ricorsi Bortolo Riccardi poté quindi proseguire i propri lavori,apparentemente indisturbato, sulla base di un programma che con-templava, senza ombra di dubbio, un teatro in muratura. L’incaricovenne affidato ai due costruttori edili Gaetano Rocca e Carlo Argani-ni, mentre il progetto fu commissionato all’architetto Marcellino Se-gre: questi prevedeva che il teatro venisse edificato elevando «tutti limuri e pilastri circondari e muri interni dell’altezza prefissa»324, por-tando a termine la struttura incompiuta. Bisognava inoltre «riffare tut-ti li palchi ornati esteriormente», «le scale co’ gradini di pietra», infi-ne il «tetto colle sue capriate con tutti i legnami principali di laricebene fermati». Per quanto riguarda lo scenario: «24 molini per li tel-loni e le arie ed in giro al palcoscenico si farà la ringhiera per como-do del movimento delle scene»325. Il pavimento sarebbe stato di «as-se». Il preventivo totale del lavoro era «di lire cento diciotto mila di-
321. Documento 1787: 7, in Regesto.322. Documento 1786: 58, in Regesto.323. L’affitto del fondo da parte dell’Ospedale passò dalle 221 lire pagate an-
nualmente da Giovan Battista Lombardi alle 500 lire di Bortolo Riccardi: Documen-ti 1785: 10-11, in Regesto.
324. Documento 1787: 16, in Regesto.325. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 213
214
FRANCESCA FANTAPPIÈ
consi £. 118.000 milanesi»326. L’architetto venne chiamato anche a va-lutare il teatro ancora incompleto, permettendo di determinarne lostato. La stima, che ammontava a lire 42695. 8. 3 «di moneta milane-se», riguardava tutto ciò che era permanente ossia
non com[preso] però nel detto prezzo il legname che ha servito per [fa-re] tetto e palco e quant’altro vi esiste d’interinale, e per[ciò s’]intendononel detto prezzo compresi soltanto li muri […], li soffitti tanto dei pal-chi come del corridore, le colon[ne] del vestibolo e sue volte, le pianta-ne con li serramenti [e] tutto ciò che resta fisso in detto fabbricato327.
Veniamo così a sapere che gli elementi fissi erano già molti: mura,soffitti dei palchi, il corridore, le colonne dell’entrata, etc.
La corsa per la conclusione dei lavori però non riuscì. Fu così che,in concomitanza con l’abituale inizio della stagione operistica in fie-ra, ossia il 21 agosto 1787, venne recapitata la prima istanza diretta aBortolo Riccardi. I palchettisti che sporgevano il reclamo in questocaso appartenevano in maggioranza al secondo ordine. Essi chiedeva-no ragione delle «novità» che si andavano «praticando dall’illustrissi-mo signor Bortolo Riccardi progettante e fabriciere del teatro di fie-ra, in delazione degli obblighi da esso assunti»328. Il teatro non era an-cora completo e veniva usato per altri fini. Si chiedeva il motivo diquesta grave inadempienza, oltre che della mancanza della messa inscena di un’opera per quell’anno la quale, molto probabilmente, fusostituita da alcuni spettacoli acrobatici di tipo equestre329. Nel corsodel Carnevale dello stesso anno, «il fabbricato nuovo dirimpetto allafiera» era stato invece usato per allestirvi una caccia di tori con fuo-chi artificiali330.
Siamo di fronte ad un vero e proprio capovolgimento di fronte.Se prima della fiera del 1787 la vertenza era stata limitata ad una con-tesa tra palchettisti di ordini diversi, dopo di essa e nel corso del 1788,a causa della dilazione nella consegna dell’edificio, assistiamo all’unio-ne di tutte le parti interessate contro il Riccardi. Segno del cambia-mento in atto fu l’elezione di Giovan Giacomo Arrigoni alla carica di
326. Ibidem.327. Documento 1787: 17, in Regesto.328. Documento 1787: 18, in Regesto.329. Documento 1787: 21-22, 26 in Regesto.330. Documento 1787: 2, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 214
215
IL TEATRO DEI BORGHI
Presidente del Teatro, dopo la quale il nobile bergamasco inauguròuna nuova fase nel carteggio con il proprio procuratore legale, invi-tandolo a «caminare una via tutta contraria» rispetto a quella fino adallora percorsa331. Tra i tentativi iniziali vi fu quello di raccogliere unasottoscrizione tra tutti i palchettisti finalizzata alla «erezione di un nuo-vo teatro», attraverso la quale «potere, a nostre spese, far la fabbricadi un teatro stabile come si vede praticato in tutte le colte città»332.Per qualche tempo riaffiorò l’idea di un edificio a conduzione socia-le, simile a quanto inutilmente tentato nel 1750. In questo caso, pe-rò, si trattava di una mossa finalizzata all’eliminazione della figura diun proprietario unico333. Come accaduto in precedenza, l’iniziativafallì miseramente. Nonostante che l’idea di un teatro permanente siconfigurasse come un desiderio condiviso, appena un mese dopo laproposta, l’unione era già dissolta. La procura dei palchettisti verso itre presidenti del Teatro, tra i quali oltre all’Arrigoni figuravano Gio-van Battista Vertova e Luigi Grismondi, si ridusse a quella di rappre-sentanza nella vertenza legale «contro l’abuso che ha fatto il Reccar-di del contratto o più tosto la burla che dà al di lui progetto, alle par-ti della Città, alle Ducali dell’Eccelso ed a tutti li proprietari de’ pal-chi»334. Ciò che veniva dichiarato come maggiormente intollerabile erache il Riccardi lasciasse «la città senza teatro massime in tempo di fie-ra»335. Arrigoni suggerì di usare, come capo d’impu tazione, il ritardonella consegna e il fatto di avere «contravenuto all’assonto impegnodi dar compito il teatro nel primo anno quando tuttora è soltanto prin-cipiato»336. Invitava però a non usare più, come in precedenza, il cam-biamento in corso d’opera del progetto, per non coinvolgere anche ipresidenti del Teatro allora in carica, i quali furono «quelli che ad es-so ordinarono la fabrica nel sito e modo che è costrutta»337. La procu-ra dei ministri dell’Ospedale Maggiore verso Arrigoni, Vertova e Gri-smondi nella causa contro «Bortolo Riccardi fabbricatore del nuovodetto teatro» arrivò nel giugno del 1788338.
331. Documento 1788: 5, in Regesto.332. Ibidem.333. Ibidem334. Documento 1788: 7, in Regesto.335. Ibidem.336. Ibidem.337. Ibidem.338. Documento 1788: 25, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 215
216
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Incalzato dai suoi avversari e costretto a far fronte a continue spe-se legali, i lavori del teatro rallentarono ulteriormente. Si affacciaro-no i primi problemi di ordine economico tanto che il Riccardi «on-de terminar li piloni e far il techiame del teatro stesso per renderloesercitabile nella prossima fiera d’agosto», si vide costretto a chiedereun prestito di «lire ventiquattromila» al conte Paolo Colleoni, offren-do in garanzia «non solo li proventi tutti derivanti dal teatro medesi-mo, ma inoltre anche il teatro stesso»339. Per il costruttore divenne as-solutamente necessario vincere la causa. Per perorarla, nel maggio del1788, si recò personalmente a Venezia. Bortolo Riccardi stava giocan-do d’azzardo. Nella supplica da lui presentata al Consiglio dei Diecitroviamo una verità distorta, ma estremamente efficace per ottenereciò che voleva. L’affermazione d’esordio è emblematica. Essendo
universale desiderio in Bergamo, per oggetti di decoro e di commercio,di costruire in forma stabile e luminosa il solito provvisionale teatro cheprima era formato di legno, si accolse da quella Magnifica Città il pro-getto di me Bortolo Riccardi suo cittadino340.
Si trattava di una dichiarazione che dava una lettura contraffattadella realtà. Il Riccardi esibiva un permesso che, almeno sulla carta,non aveva mai ricevuto. Più realistica invece l’affermazione seguente,ossia che la dilazione nella consegna sarebbe stata determinata dal fat-to che «insorsero discordie poi tra pretendenti azioni nei palchi delvecchio teatro di legno, sicché non è ancora intieramente perfeziona-to»341. Rivelatrice la conclusione. Il Riccardi chiedeva che gli fosse da-ta la possibilità di «proseguire il total compimento del mio teatro sud-detto»342. Una frase con cui si assegnava la vittoria, ancor prima di aver-la ottenuta, in quanto riconosceva se stesso come legale proprietariodell’edificio. Per assicurare il finanziatore del proprio investimentoscrisse, appena tornato da Bergamo, a Paolo Colleoni affermando vit-toriosamente che, «essendo già dichiarato di mia raggione» il teatro, i«presidenti Vertova e Grismondi, che nulla poterono ottenere» a Ve-nezia, «partirono mortificati». Inoltre: «vengo assicurato da quei pri-
339. Documento 1788: 9, in Regesto.340. Documento 1788: 17, in Regesto.341. Ibidem.342. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 216
217
IL TEATRO DEI BORGHI
mi avvocati che saranno miei anche li palchi e chi li vorrà dovrà dame provederli». Infine era stato deciso dal Serenissimo Principe che,a Bergamo, non vi dovevano «essere altri teatri»343. Non facile capirequanto vi fosse di verità o di arroganza nelle parole del Riccardi. Unottimismo ostentato fino al punto di affermare di aver già ricevutoproposte per l’utilizzo dell’edificio incompleto nel corso dell’immi-nente stagione di fiera: «avrò facilmente nel prossimo agosto lire 5.000per affitto del teatro, tal quale sta, che mi viene ricercato da Milano»344.La verità era invece che gli affari sembravano mettersi male. Il 26 lu-glio venne condannato per una lettera di cambio protestata del valo-re di 30.000 lire345. Né bisogna dimenticare che continuava a pagareregolarmente l’affitto del fondo all’Ospedale Maggiore, pur dovendotenere il teatro inattivo346.
Tra il 1788 e il 1790 nel Teatro Riccardi non fu tenuta alcuna ope-ra, privando il suo costruttore di un’entrata sicura. Nonostante quan-to finora ritenuto, gli spettacoli musicali vennero allestiti in teatriprovvisori347. Nel corso della fiera del 1788 l’opera buffa I due suppo-sti conti ossia lo sposo senza moglie di Angelo Anelli, musica di Domeni-co Cimarosa, si svolse in «un casotto di legno con tratte di logge nelcircondario» edificato dai due costruttori Giuseppe Gattai e France-sco Cipriani348. Una struttura provvisoria e senza palchetti. Al fine dievitare future rivalse il capitanio Leonardo Valmarana obbligò i log-gisti a rinunciare a qualsiasi diritto di proprietà futura sui posti loroassegnati, ossia «che niuno con tale assegno acquistar possa verun ti-tolo in avvenire»349. All’interno dei cosiddetti due ordini di logge nondoveva essere apportata «alcuna separazione di un tratto all’altro, nécon assi, né con tende», in modo da evitare una qualsiasi somiglian-za con un palchetto350. I nomi degli affittuari corrispondono in mas-
343. Documento 1788: 23, in Regesto.344. Ibidem345. Documento 1788: 29, in Regesto.346. Documenti 1786: 39-40; 1788: 31; 1791: 17, in Regesto.347. Secondo E. Comuzio, Il teatro Donizetti, cit., vol. I, p. 22 e ss., tutte le ope-
re musicali in fiera seguite al 1786 sarebbero state tenute nel Teatro Riccardi.348. Documento 1788: 39, in Regesto. Secondo E. Comuzio, Il teatro Donizetti,
cit., vol. I, pp. 22-23, nel 1788 si sarebbe tenuta anche l’opera Giannina e Bernardo-ne.
349. Documento 1788: 28, in Regesto.350. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 217
218
FRANCESCA FANTAPPIÈ
sima parte a quelli dei palchettisti del Teatro Riccardi. Lo spettacolovenne prodotto da più persone in società. Gli abbonamenti furono,infatti, pagati a «Carlo Vertova, cassiere eletto dai soci impresari»351.
Per quanto riguarda le due stagioni successive la certezza che le ope-re furono allestiste in edifici provvisori deriva da una dichiarazione diGiovan Battista Vitali Rota dell’8 luglio 1791, in cui egli affermavache l’anno 1786 «fu il primo e finora l’unico anno in cui» nel TeatroRiccardi «fu fatta opera»352. Non conosciamo, però, la tipologia di edi-fici teatrali usati nel corso della fiera del 1789 e del 1790, ma solo ititoli delle rappresentazioni. Nel 1789 venne messo in scena il melo-dramma Alessandro nell’Indie di Pietro Metastasio con musica di Fran-cesco Bianchi353. Nel 1790 l’opera buffa La Molinara o l’Amor contra-stato di Giuseppe Palomba, musica di Giovanni Paisiello, intercalatadal ballo eroicomico L’Adelasia in Italia di Luigi Dupen354. La presen-za dell’impresario Giovan Battista Lombardi nella produzione di que-sto secondo spettacolo fa pensare ad una sua partecipazione alla co-struzione del teatro provvisorio per l’allestimento. Nella dedica del li-bretto esso scrive: «Il drama giocoso intitolato La Molinara sarà lo spet-tacolo che si riprodurrà su le provisionali scene in Prato per la fieradi quest’anno 1790»355.
Dopo la fiera del 1788 la causa legale che impediva la conclusio-ne dei lavori del Teatro Riccardi rimaneva ancora aperta. Fu un perio-do di stallo nel corso del quale assistiamo a frequenti richieste vene-ziane di apportare integrazioni alla documentazione, mentre gli av-versari del Riccardi elessero un unico rappresentante legale nella figu-ra dell’«avvocato veneto» Girolamo Antonio Costantini356. Nel nuo-vo materiale emerge una dichiarazione giurata dell’architetto GiovanFrancesco Lucchini: egli affermava di aver ricevuto l’incarico da par-te di Bortolo Riccardi nel corso del 1786 e di averlo concluso con lafiera di quell’anno. Il progetto sarebbe stato concordato sulla base di
351. Documento 1788: 33, in Regesto.352. Documento 1791: 22, in Regesto.353. Alessandro nell’Indie (1789), in Cronologia.354. La Molinara o l’Amor contrastato (1790) e L’Adelasia in Italia (1790), in Crono-
logia. Le due opere buffe Bertoldo e Bertoldino e La pastorella nobile, attribuite da E.Comuzio, Il teatro Donizetti, cit., vol. I, p. 23, al Teatro Riccardi per la fiera del 1790,furono invece tenute nel Teatro di Cittadella.
355. Si veda La Molinara (1790), in Cronologia.356. Documento 1789: 48, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 218
219
IL TEATRO DEI BORGHI
un disegno «presentato nella Cancelleria di detta Magnifica Città», per-ciò da essa conosciuto357. Il punto principale della questione ruotava,infatti, sulla necessità di stabilire le ragioni del ritardo nell’ultimazio-ne dell’edificio. Secondo Bortolo Riccardi,
avendo fabbricato un teatro diverso da quello convenuto colli capitolidel contratto 13 febbraio 1786, avendolo fatto di pietra e non di legno,con tanto maggior dispendio e con sacrifizio del suo stato, secondandoanche il nuovo disegno 20 maggio 1786 fatto firmare dalli Presidenti
non sarebbe stato possibile «spogliarlo del suo teatro eretto a suespese»358. La dilazione sarebbe dunque derivata da una modifica so-stanziale del progetto iniziale: invece di un teatro provvisorio gli sa-rebbe stato ordinato un teatro permanente. I suoi avversari, questa vol-ta uniti, dichiararono invece che tale cambiamento non era dovutoad alcuna direttiva comunale, ma ad un’arbitraria iniziativa del co-struttore:
Doveva il Riccardi fabbricare sotto il portico il teatro di legno. Invecepretese che, con nuove intelligenze con li Presidenti del Teatro ed Ospi-tale, sia stato indotto a fabbricare il teatro di pietra stabile e non provi-sionale. Non vi è parte alcuna della Città che abbia autorizzato li Presi-denti a cambiar la natura del contratto primo, non vi è carta alcuna onuovo contratto scritto neppur colli Presidenti. Pur tuttavia il Riccardifabbrica il teatro di pietra359.
Le contestazioni presentate dai procuratori legali dei suoi avversa-ri non vennero reputate sufficienti e Bortolo Riccardi vinse la causaa Venezia360. «Qual è l’effetto di questo giudizio?», recita con sconfor-to una relazione del Consiglio municipale: «Il Riccardi fabbricatore eproprietario del teatro non è più soggetto al contratto 13 febbraio1786»361.
Siamo agli episodi conclusivi. L’anno 1790 fu quello della resa deiconti. Il 30 aprile Giovan Battista Vertova, Luigi Grismondi e Giovan
357. Documento 1789: 37-38, in Regesto.358. Documento 1791: 20, in Regesto.359. Ibidem.360. Documento 1789: 58, in Regesto.361. Documento 1791: 20, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 219
220
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Giacomo Arrigoni, dettero le dimissioni dalla carica di presidenti delTeatro per accogliere una nuova procura da parte di tutti i palchetti-sti. Questa volta allo scopo di «poter amichevolmente convenire colpredetto Riccardi»362. Nel frattempo rinunciavano a proseguire le cau-se ancora pendenti contro di lui363. Bortolo Riccardi a sua volta di-chiarò che avrebbe cessato ogni procedimento nei confronti di colo-ro che il 4 giugno 1790, data fissata per l’udienza finale, avrebbero fat-to seguire «giudizio assente», ossia non si fossero presentati364. E cosìavvenne. Si trattava dell’atto finale che decretò, anche da parte dellaCittà di Bergamo, il riconoscimento al costruttore della proprietà del-l’edificio da lui realizzato365. Divenne perciò necessario stipulare unnuovo contratto che, il 30 giugno 1790, fu sottoscritto con i procura-tori dei palchettisti. Nella convenzione si ribadiva «esser di sola ragio-ne del nobile signor Bortolo Riccardi il teatro di pietra in parte eret-to e che intende di condurre a fine con le sue adiacenze, situato di-rimpetto alla fontana di fiera nel prato di Sant’Alessandro»366. Conte-stualmente il proprietario «dà, cede e vende» ai tre procuratori «gli ri-spettivi palchi giusta il registro de’ nomi esistente in tabella della Can-celleria di questa Città»367. Per quanto riguarda i termini dell’accordosi stabiliva in primo luogo «per la fiera di agosto del prossimo anno1791 di rendere compito e perfezionato detto teatro»368. In merito al-la struttura architettonica si decretava che ne dovesse essere garantitala sicurezza facendo «legare li piloni di pietra con cinta di mura e pa-rimente li palchi e camerini delli palchi con porte ben ferrate, collesue chiavi e suoli di pianelle in tutte le corsie, palchi e camerini»369.Seguivano indicazioni sulle modalità da rispettare nella esecuzione del«tecchiame» e dello «scenario»370. Erano previste anche indicazioni ditipo estetico. I palchettisti chiedevano un «soffitto alla veneziana nel-l’interno del teatro», così come una decorazione uniforme dei «para-
362. Documenti 1790: 16-17, in Regesto.363. Documento 1790: 18, in Regesto.364. Documenti 1790: 21-22, in Regesto.365. Documento 1790: 23, in Regesto.366. Documento 1790: 25, in Regesto.367. Ibidem.368. Primo capitolo della convenzione del Riccardi per la conclusione del tea-
tro: Documento 1790: 25.369. Ivi, secondo capitolo.370. Ivi, terzo e quarto capitolo.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 220
221
IL TEATRO DEI BORGHI
petti», «non che li soffitti ed i lati interni de’ palchi»371. Questo per-ché l’edificio fosse «a somiglianza del nobile teatro di Verona», ossiail Filarmonico, obbligando il proprietario a vigilare affinché venissesempre mantenuto «tale patto di perfetta uguaglianza»372. Il prezzo deipalchi venne fissato nel modo seguente: lire 920 per il piè piano e pri-mo ordine, lire 690 per il secondo e lire 360 per il terzo. Le sommesarebbero state depositate «in cassa di questo venerando OspitaleMaggiore» in rate successive e saldate al Riccardi solo a lavoro con-cluso373. «Ad uso de’ servitori» venne destinata, «senza verun pagamen-to, tutta la loggia o piggionara fuori di braccia quatordeci dirinpettoal scenario»374.
Le motivazioni che indussero i procuratori Vertova, Grismondi eArrigoni ad accettare un contratto che di fatto attribuiva a BortoloRiccardi tutti i diritti fin lì contestati sono riassunte in una relazioneda loro stilata qualche settimana più tardi375. Essi spiegavano di averdovuto desistere dalla vertenza, dopo la rinuncia da parte della Cittàe dell’Ospedale Maggiore a proseguire nella causa. Tale ritiro, in par-te provocato da problemi di ordine economico, li avrebbe lasciati to-talmente soli. La Magnifica Bina avrebbe, infatti, chiesto garanzie di«non involverla nelle spese fatte e da farsi in liti», pena il proprio ab-bandono. Una circostanza che, secondo gli avvocati veneti, sarebbestata assolutamente disastrosa: «senza il concorso della Città et Ospi-tale non era possibile proseguire la causa al laudo»376. Con l’assenzadi due delle parti principali, e conclusasi questa prima fase giudizia-ria, sarebbe stato perciò necessario «far nuova stampa, replica di con-sulta, ed incontrar le spese come fossero da capo e che ci volevano al-tri mille ducati»377. La previsione di un eccessivo costo delle vertenzelegali, in questo caso ad esclusivo carico dei palchettisti, oltre alle spe-se già sopportate, aveva indotto i procuratori ad organizzare un col-loquio con Bortolo Riccardi, nel corso del quale il costruttore avevarivendicato la proprietà del teatro e dei palchi. Arrigoni, Vertova e Gri-
371. Ivi, quinto capitolo.372. Ibidem.373. Ivi, settimo e nono capitolo.374. Ivi, dodicesimo capitolo.375. Documento 1790: 26, in Regesto.376. Ibidem.377. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 221
222
FRANCESCA FANTAPPIÈ
smondi, sebbene recalcitranti, avevano accettato l’acquisto dei palchet-ti, tramite il contributo alla «fabbrica de’ medesimi con muro di pie-tra e suolo di pianelle, con li camerini», affinché non fossero messi alpubblico incanto, garantendone il possesso ai propri rappresentati. Pri-ma di giungere a questo accordo avevano provato però un’ulteriorerivendicazione, ribattendo al Riccardi che, «volendo finire la questio-ne, bisognava che si spogliasse della proprietà del teatro e de’ palchied il tutto cedere alli proprietari de’ palchi»378. Una pretesa del tuttovelleitaria, considerato il momento in cui veniva espressa, e alla qua-le il Riccardi aveva risposto prontamente che «quando dalli signoripalchettisti si volia la proprietà del teatro» avrebbero dovuto «inden-nizzarlo d’ogni spesa da esso incontrata nella fabbrica e nelle liti». Ver-tova, Grismondi e Arrigoni valutarono: «strabocchevole sarebbe la spe-sa». Il male minore rimaneva quello di concordare il prezzo d’acqui-sto dei palchi e «lasciare a di lui peso la fabbrica intera», stabilendo lemodifiche strutturali desiderate: «cinta di muro, scenario, vuolto allaveneziana e pittura di tutto l’interno del teatro»379.
Vicenda conclusa? Non ancora del tutto. L’ultimo colpo di codasi verificò prima dell’opera inaugurale, tenutasi regolarmente nell’ago-sto del 1791, nonostante che a metà del mese di maggio i lavori risul-tassero ancora in corso380. Bortolo Riccardi era ormai inattaccabile, tan-to che l’incarico di presidenti del Teatro, lasciato da Vertova, Gri-smondi e Arrigoni, un tempo impegno gradito, iniziò ad essere accet-tato con generale titubanza381. La sconfitta non era del tutto smaltita.Il 14 giugno 1791 Venezia fu costretta a ribadire il giudizio espressonella ducale del 4 giugno 1790 che assegnava definitivamente al Ric-cardi la proprietà del teatro e dei palchetti. Questa nuova ducale funecessaria, in quanto da parte di Bergamo venne avviata una nuovadisputa. In questo caso si cercò di ottenere il riconoscimento dell’ob-
378. Ibidem.379. Ibidem.380. Il 14 maggio del 1791 i ministri dell’Ospedale affermano di non potere «con-
struere il solito casotto de’ sbirri necessari alla custodia della fiera» in quanto il pra-to della fiera risulta ingombrato da vari impedimenti consistenti «in gran pile qua-drate di sassi, buche per calcina, casotti legno, il tutto preparato per la costruzionedella pubblica Dogana come vien figurato, non che in poca parte anche per il fini-mento del nuovo teatro»: Documento 1791: 10, in Regesto.
381. Documenti 1790: 27-29, 35-36, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 222
223
IL TEATRO DEI BORGHI
bligo da parte del proprietario di assegnare ai presidenti del Teatro unpalchetto, come stabilito nei Capitoli per la buona e retta direzione e di-sciplina dei teatri del 1775382. Al fine di ribadire questo diritto venneroraccolte le dichiarazioni di precedenti costruttori di teatri provvisoriin fiera, tra cui Giovan Battista Vitali Rota383. Si trattò, in realtà, del-l’ultimo tentativo di mantenere un controllo sul teatro, come appareda una lettura del compendio allegato alla richiesta, in cui l’intera vi-cenda è riassunta secondo il punto di vista della Magnifica Bina. Nonpotendo più considerare il Riccardi un semplice «fabbricatore», madovendolo riconoscere come «proprietario», l’unica rivalsa possibilerimaneva il palchetto da assegnare ai presidenti del Teatro, una caricadi cui veniva ribadito l’estremo rilievo e che avrebbe dovuto conti-nuare ad essere ricoperta da «persone di condizione scelte da un cor-po nobile e pubblico, e di probata condotta»384. Al contrario, la pre-senza di «un proprietario qualunque di un teatro, massime il signorRiccardi uno di nessuna fama, e massime se, come potrebbe succede-re, passasse in persone di nessuna condizione e carattere la proprietàdel Teatro Riccardi»385, non avrebbe potuto garantire la necessaria fun-zione di vigilanza sugli spettacoli cittadini. Evidente è il rimpianto peril periodo in cui il teatro si «erigeva provvisionalmente di anno in an-no», quando il suo controllo era totalmente delegato ai presidenti386.Venezia rispose asserendo di non voler togliere a Bergamo la facoltàdi vigilare sul «buon andamento delli pubblici spettacoli», ma ribadìcategoricamente la proprietà del Riccardi nei confronti del «di lui tea-tro, con immensa spesa e decoro e benefitio anco di detta MagnificaCittà e con profusione di tutto il suo stato, fabbricato», giudicando«non mai ammissibile» il memoriale «del dì 4 luglio»387. L’esercizio deldiritto di un palchetto da parte dei presidenti venne ritenuto una «malgiudicata intrusione», oltretutto «non mai verificabile, né adattabilein un teatro giudicato di assoluta sua proprietà»388. La Città, tuttavia,non cedette e incaricò il nunzio Girolamo Fogaccia di intervenire in
382. Documento 1791: 19, in Regesto.383. Documenti 1791: 21-22, in Regesto.384. Documento 1791: 20, in Regesto.385. Ibidem.386. Ibidem.387. Documento 1791: 23, in Regesto.388. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 223
224
FRANCESCA FANTAPPIÈ
proprio favore presso i tribunali veneziani389. Parallelamente BortoloRiccardi ricorse contro di essa, poiché riteneva che venisse «abusatoin giudizio il nome della Città stessa»390. Siamo di fronte ad un’enne-sima vittoria del Riccardi391. Non potendo rivalersi sul proprietario delteatro, i deputati si concentrarono allora, in occasione della stagioneoperistica in corso, verso l’impresario. Se il proprietario non volevacedere un palchetto ai presidenti, ritenevano che comunque dovesseoccuparsi di far rispettare questa regola alla persona cui avrebbe datoin affitto l’edificio. Sostenevano che, in questo caso, il palchetto avreb-be dovuto essere «a peso dell’impresario dello spettacolo, non del fab-bricatore o proprietario del teatro, distinzione importantissima a com-prendersi»392. La patata bollente passò quindi a Gaetano Belloni, im-presario dell’opera in fiera nel 1791. È però probabile che anch’egli sisia rifiutato di ottemperare l’obbligo presunto393.
Per quanto riguarda i palchettisti, infine, le ultime schermaglie daparte dei recalcitranti riguardarono l’arredo dei palchetti. Non fu suf-ficiente un proclama del rettore del 4 agosto 1791 per intimare aiproprietari il rispetto della regola di una perfetta uguaglianza nellaloro decorazione, «con la proibizione perciò di non alterar le pittu-re e molto meno di pararli»394. Pochi giorni dopo fu lo stesso Borto-lo Riccardi che si vide costretto alla pubblicazione di un avviso incui accusava alcuni di essi per aver contravvenuto agli accordi e diaver dichiarato «pubblicamente di non voler eseguire il patto conve-nuto di non parare li palchi»395. Il proprietario li minacciò perciò pergli eventuali danni arrecati da tale condotta, quali la mancata ven-dita degli altri palchetti e le spese per probabili cause con i restantipalchettisti396.
389. Documento 1791: 30, in Regesto.390. Documenti 1791: 31, 34-35, in Regesto.391. Nonostante ciò la causa rimase a lungo aperta e, ancora nel 1793, Venezia
dovette emanare una nuova Ducale in cui ribadiva la proprietà del teatro da partedi Bortolo Riccardi: Documenti 1792: 11, 13; 1793: 3, in Regesto.
392. Documento 1791: 20, in Regesto.393. In questo caso sarebbero più facilmente comprensibili le non meglio spe-
cificate rimostranze, espresse da un certo Pietro Soffietti, contro «l’azione turpe delBelloni» perpetrata ai danni della Città: Documenti 1791: 39-40, in Regesto.
394. Documento 1791: 27, in Regesto.395. Documento 1791: 29, in Regesto.396. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 224
225
IL TEATRO DEI BORGHI
Erano però gli ultimi goffi battibecchi. L’inaugurazione fu tenutanormalmente. Negli anni successivi la programmazione si svolse sen-za ulteriori intralci. Bortolo Riccardi poté quindi concentrare la pro-pria attenzione sull’attività del proprio teatro.
2.3. Il Teatro Riccardi alla fine della Repubblica veneta (1791-1797)
«Persona violenta» e «uno di nessuna fama»397. A dispetto della pes-sima reputazione a lui attribuita, Bortolo Riccardi divenne il primoproprietario di un teatro stabile a Bergamo dopo il conte GiuseppeSecco Suardo, la cui esperienza, troppo lontana nel tempo, era ormaidimenticata alla fine del Settecento. Un confronto che mette imme-diatamente in risalto una fondamentale differenza. L’iniziativa fu si-mile, ma il ceto sociale di riferimento era cambiato. Nel caso dei Sec-co Suardo siamo di fronte ad una delle principali e più antiche fami-glie del patriziato cittadino. Per quanto riguarda il Riccardi, invece,sebbene nella documentazione prodotta dai tribunali veneziani ven-ga ripetutamente definito «nobile signore», a Bergamo fu a lungo ri-badito il suo status di semplice «fabriciere»398. Per l’aspirante costrut-tore ottenere il riconoscimento di una presunta provenienza nobilia-re, recente o remota non importa, fu quindi necessario a conseguireil proprio intento, ma non sembra fosse parte integrante del propriosistema di valori. Egli si dimostra invece un rappresentante esempla-re dell’emergente classe imprenditoriale cittadina399.
Dopo l’apertura definitiva del teatro e nel corso della sua storia suc-cessiva, ossia fino all’incendio che nel 1797 distrusse lo stabile, ebbemodo di palesarsi in tutta la sua evidenza il grado di appartenenza delRiccardi a questo milieu borghese. In quest’arco di tempo l’edificiopoté lavorare a pieno regime, senza destare particolari preoccupazio-ni nelle autorità. Tuttavia venne sottoposto ad una vigilanza continua.Siamo infatti nel periodo seguente lo scoppio della rivoluzione fran-cese, evento che indusse il potere veneziano a tenere un atteggiamen-to sempre più guardingo nei confronti di tutti i luoghi pubblici de-
397. Documenti 1786: 58; 1791: 20, in Regesto.398. Documenti 1790: 21; 1791: 15; 1792: 13, in Regesto.399. La famiglia Riccardi avrebbe fatto parte di quella «piccola nobiltà» le cui
fortune erano dovute al commercio della seta. Si veda E. Comuzio, Il teatro Donizet-ti, cit., vol. I, p. 14.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 225
226
FRANCESCA FANTAPPIÈ
putati al tempo libero e all’intrattenimento: dai teatri alle osterie, dal-le accademie alle pubbliche piazze400. A Bergamo, come nella altre cit-tà del Dominio, si intensificarono progressivamente i controlli por-tando alla luce gruppi potenzialmente sovversivi: prima i «franchimuratori», poi i cosiddetti «giacobini»401. Non sorprende quindi se nel1796, anno che precede la rivoluzione bergamasca, il proprietario del-l’unico teatro stabile cittadino, insieme a parte dei personaggi che ruo-tavano attorno all’attività del medesimo, figurassero tra i principali fau-tori della ribellione contro Venezia e propugnatori dei diritti di ugua-glianza, libertà e fraternità diffusi dai francesi. Nel corso degli eventiche prepararono la rivolta Bortolo Riccardi assunse i tratti di una fi-gura carismatica, così come il suo teatro sembrò diventare un puntodi riferimento per un nuovo ceto cittadino.
Ma vediamo innanzitutto come il neoproprietario predispose laprogrammazione del proprio teatro al fine di recuperare le spese perla sua costruzione e le perdite subite nei cinque anni trascorsi in cau-se legali. Prima ancora dell’apertura ufficiale, durante il Carnevale del1791, «nel teatro di fiera in pietra» venne organizzato il lancio di unpallone areostatico402. Conclusi i lavori e completata la copertura, co-me opera inaugurale fu scelta la Didone abbandonata di Pietro Meta-stasio, già messa in scena nell’agosto del 1786 per l’apertura del tea-tro ancora incompiuto. Nella dedica del melodramma l’impresarioGaetano Bellone rimarca il fatto di «agire su questo nuovo teatro in
400. Sull’immediata e generale diffusione nella Repubblica veneta delle mas-sime rivoluzionare, sul rapido orientamento dell’opinione pubblica verso le «no-vità della Francia», sulla loro stretta relazione con una crescente insofferenza ver-so il dominizio veneziano da parte della nobiltà suddita così come della nascenteclasse borghese, si veda M. Berengo, La società veneta alla fine del ’700, Firenze, 1956,p. 252 e ss.
401. Sulla diffusione delle logge massoniche nella Repubblica veneta, cfr. R. Tar-ghetta, La massoneria veneta dalle origini alla chiusura delle logge (1729-1785), Udine, 1988.Sul valore di fronda intellettuale delle società segrete, sebbene spesso frazionate eterritorialmente disomogenee, si vedano M. Berengo, Il problema politico-sociale di Ve-nezia e della sua Terraferma, in La civiltà veneziana del Settecento, Firenze, 1960, pp. 69-96: 90 e ss. e G. Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, La Repubblica di Venezia nell’etàmoderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, in Storia d’Italia, diretta da G. Galasso,vol. XII, t. 2, Torino, 1992, pp. 647-650. Da ricordare che tra i massoni veneziani fi-guravano Girolamo Casanova e Carlo Goldoni: C. Francovich, Storia della massone-ria in Italia. Dalle origini alla rivoluzione francese, Firenze, 1989, pp. 133-147.
402. Documento 1791: 4, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 226
227
IL TEATRO DEI BORGHI
occasione del suo primo aprimento»403. Non fu quindi, di uno dei tan-ti spettacoli della storia dell’edificio ma, in considerazione soprattut-to del quinquennio lasciato alle spalle, di un evento totalmente stra-ordinario. Tale aspirava ad essere la produzione, come si evince da unrapido sguardo al nutrito cast radunato per i balli che intercalavanol’opera o alla varietà dei cambi di scena proposta404. Come scenogra-fo venne chiamato, non a caso, uno dei più rinomati del momento:Pietro Gonzaga «pittore delle scene tutte nuove»405. Il comparto can-tanti non fu da meno. Spicca tra tutti la prima donna Luigi Todi cui,nel corso della tournée, furono tributate numerose lodi406. È tramite icomponimenti poetici in suo onore che sappiamo come la virtuosa,nonostante l’opposizione del «signor Ottavio Viganò impresario delteatro di San Samuele», fosse stata strappata a precedenti impegni dalei contratti a Venezia407. La conclusione degli spettacoli, avvenuta il25 settembre, fu resa magnificente dalla completa illuminazione delteatro408.
La scelta del genere operistico serio e di produzioni economica-mente impegnative in occasione della stagione della fiera è confer-
403. Si veda il libretto della Didone abbandonata (1791), in Cronologia. Il dato vie-ne ulteriormente avvalorato dagli indici teatrali dell’anno comico 1791-1792, in ba-se ai quali la rappresentazione fu tenuta in occasione dell’«apertura del nuovo Tea-tro Ricardi in Fiera»: R. Verti (a cura di), Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p.945.
404. Per il quale si veda il libretto della Didone abbandonata (1791), in Cronolo-gia.
405. Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1791 a tutto il Carne-vale 1792, c. 14, in R. Verti (a cura di), Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 945.Pietro Gonzaga, pittore e scenografo, nato a Belluno nel 1751, fu attivo nella secon-da metà del Settecento. Formatosi alla scuola dei fratelli Galliari al Teatro della Sca-la di Milano, nel 1792 venne chiamato a San Pietroburgo per ricoprire il ruolo dipeintre en chef al Teatro Reale. Morì in Russia nel 1831. Su di lui si vedano la vocePietro Gonzaga di E. Povoledo, in Enciclopedia dello Spettacolo, cit., vol. V, coll. 1470-1473 e quella contenuta nel Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musi-cisti, cit., Le biografie, vol. III, p. 269. Inoltre M.T. Muraro (a cura di), Scenografie diPietro Gonzaga, presentaz. di G. Folena, Vicenza, 1967. Sui contatti di «Gonzaga Pie-tro celebre pittore di scene e di prospettiva» con Francesco Quarenghi interessanteè anche il Documento 1792: 10, in Regesto
406. Sulla fama della cantante Luigia Todi e sul suo successo a Bergamo si vedaanche E. Comuzio, Il teatro Donizetti, cit., vol. I, p. 27.
407. Documento 1791: 38, in Regesto.408. Documento 1791: 48, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 227
228
FRANCESCA FANTAPPIÈ
mata negli anni successivi. Nel 1792 si rappresentò «nel nuovo Tea-tro Riccardi» La morte di Semiramide di Antonio Sografi, musica diGiovan Battista Borghi409. Come intermezzi furono previsti due bal-letti del coreografo Giuseppe Bartolomei, eseguiti da un copioso cor-po di ballo. Durante la fiera del 1793 il teatro ospitò il Pirro di Gio-vanni De Gamerra, musica di Nicola Zingarelli, con balletti di Ono-rato Viganò410. Nei due anni seguenti ritroviamo l’impresario Gaeta-no Belloni come produttore de L’Epponina nel 1794 e La morte diCleopatra nel 1795411. All’opera seria, momento chiave della program-mazione coincidente con la fiera, si affiancavano altri generi nei re-stanti periodi dell’anno: teatro in prosa, opera buffa e, in alcuni ca-si, spettacoli circensi. Nel 1792 vediamo che l’opera venne precedu-ta dalla compagnia di attori professionisti Polinà e da un’accademiamusicale tenuta da un certo «Cristoforo Weis professore di piano-forte», mentre fu seguita dalle esibizioni acrobatiche di una troupe di«saltatori e funamboli diretti da Placido Bologna»412. Prima della sta-gione fieristica del 1793 si tenne, in primavera, l’opera buffa Il fana-tico in berlina con musica di Giovanni Paisiello, mentre in estate siesibirono gli attori della compagnia Menichelli413. Dopo l’opera se-ria seguirono i «saltatori e funamboli diretti da Giovanni Coppinimilanese», cui successe in autunno la compagnia diretta da NicolaAratta e Antonio Romagnoli414. Nel 1794 non siamo a conoscenzadi spettacoli tenuti prima della fiera, ma sappiamo che, appena fini-ta, si esibì nel Teatro Riccardi «una compagnia de’ giovani cantantinapolitani diretta dal sig. Giovanni Bassi» che rappresentava ben cin-que opere: La sposa contrastata, Nina pazza per amore, La virtuosa biz-zarra, Debora e Sifara, Le due gemelle415. Nel 1795, infine, l’opera seriafu preceduta dalle esibizioni della compagnia Paganini in primave-
409. La morte di Semiramide (1792), in Cronologia.410. Pirro (1793), in Cronologia. La rappresentazione di una seconda opera, os-
sia L’Alessandro nelle Indie (1793), è documentata solo dagli indici teatrali, ma non con-fermata da un libretto. Si veda in proposito la scheda relativa in Cronologia.
411. Si vedano i libretti L’Epponina (1794) e La morte di Cleopatra (1795), in Cro-nologia.
412. Si veda la Cronologia e il Documento 1792: 16, in Regesto.413. Si veda la Cronologia.414. Si veda la Cronologia.415. Si veda la Cronologia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 228
229
IL TEATRO DEI BORGHI
ra e di Luigi Mazzotti Malipiero in giugno, mentre fu seguita in au-tunno dalla compagnia di Antonio Mariani416.
Un calendario pieno, nel corso del quale il teatro rimaneva inatti-vo solo durante la stagione di Carnevale, destinata in maniera esclu-siva al Teatro di Cittadella. Per rendere più agevole l’accesso agli spet-tatori Bortolo Riccardi chiese, prima della fine del 1792, il permessoall’Ospedale Maggiore «di poter a sue spese construere un sentiero indetto prato»417. Non sappiamo se riuscì, incrementando i propri gua-dagni, a recuperare le spese. Alcuni problemi di natura economica si-curamente rimasero se, nel settembre del 1794, quando venne stilatauna nuova lista di palchettisti, l’istanza di pagamento verso di essi nonproveniva dal proprietario del teatro, ma dal conte Paolo Colleoni suoprincipale creditore418.
Nella gestione dello stabile si fece però strada un secondo questio-ne, progressivamente sempre più rilevante. Nel corso degli anni No-vanta del Settecento si intensificarono i controlli sui luoghi pubblicida parte delle autorità veneziane. Ai consueti richiami relativi al giocod’azzardo si aggiunsero, quelli sulle regole di comportamento da tene-re in teatro e sui temi da evitare durante gli spettacoli419. I primi segna-li dell’esistenza a Bergamo di «società ed adunanze» considerate sospet-te, in questo caso di società segrete, risalgono al maggio del 1785, quan-do Venezia scoprì una cellula di «franchi muratori». Della loggia mas-sonica facevano parte alcuni membri della nobiltà cittadina, oltre a fi-gure appartenenti al mondo del teatro e del commercio di libri, qualii cantanti «Ignazio Ladin buffo di teatro», «Giovani Tajana quondam Pas-sano virtuoso di musica» e Giuseppe Rondis «faceva il libraio»420. I con-
416. Si veda la Cronologia.417. Documento 1792: 31, in Regesto.418. Documenti 1794: 4-5, in Regesto.419. Contro il gioco d’azzardo si registrarono provvedimenti e richiami da par-
te della Dominante nel corso di tutto il Settecento: Documenti 1704: 1-2; 1750: 34;1757: 1-3; 1789: 57, in Regesto.
420. Documenti 1785: 2-3, in Regesto. Tra i «franchi muratori» troviamo DoraPaula Grismondi, Zavario Volpe, Benedetto Bassoni, oltre ai conti Giuseppe Beltra-melli, Antonio Moroni, Girolamo Secco Suardo, Lorenzo Brini: Documento 1785:4. A Bergamo, secondo A. Ottolini, Alessandro Ottolini e la Rivoluzione di Bergamo nel1797, in Atti e Memorie del secondo Congresso Storico Lombardo (Bergamo 1937), Mila-no, 1938, pp. 195-210: 202, sarebbero state presenti due logge massoniche delle qua-li una si trovava «in contrada S. Lorenzino, l’altra in quella del Mattume».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 229
230
FRANCESCA FANTAPPIÈ
trolli si intensificarono dopo lo scoppio della rivoluzione francese421.Nel luglio del 1791 ai rettori in carica venne affidato il compito di ri-portare «quali discorsi» venissero tenuti a Bergamo «sulle novità dellaFrancia, da quali persone e quale» fosse «la preponderanza delle incli-nazioni e dei partiti»422. I luoghi su cui venne concentrata l’indagine fu-rono «le botteghe di caffè» e tra i testimoni interrogati un «certo Ema-nuel Chiappella, uno dei principali caffettieri in questo Borgo San Leo-nardo», il quale affermava che solo pochi sarebbero stati gli inclini alpartito «dell’Assemblea Nazionale»; le fonti d’informazione su cui i ber-gamaschi potevano impostare le loro discussioni sarebbero state «cer-te gazzette, dette Giornali di Francia, che colà giungono con le letteredell’Elvezia per la parte di Como»423. Per il potere veneziano diventòindispensabile la censura. Fu così che nell’ottobre dello stesso anno se-guirono direttive in merito agli spettacoli pubblici. I rettori comunica-rono che sarebbe stata loro «cura di non permettere in verun tempo suiteatri di questa città (…) rappresentazioni comiche e tragiche, se primanon» fossero state fatte da loro «con la più scrupolosa attenzione esa-minare e correggere da questo Ecc[ellent]e Vicario Pretorio», non soloper assicurare il rispetto della «religione e buon costume», ma ancheper impedire la diffusione «di perniciose moderne massime che conte-nessero»424. L’anno seguente toccò al nuovo capitanio Ottavio Trentoassicurare Venezia del proprio impegno nella vigilanza sulle «rappre-sentanze che si potessero esseguire in questa Città e Borghi, tanto tra-giche, comedie, dramatiche e pantomime azzioni, perché queste sianoin prevenzione da chi speta scrupolosamente esaminate»425. Sebbenenel 1792 e nel 1793 i proclami diventassero più generici ed incitasserosemplicemente alla «dovuta moderazione» e al mantenimento di uncomportamento decoroso, stigmatizzando le cattive abitudini del pub-blico, come quella di «pretendere la ripetizione delle arie o d’alcuna
421. I controlli interessarono tutto lo stato veneto ma nel caso di Bergamo lepreoccupazioni delle autorità veneziane furono maggiori in quanto, per la posizio-ne geografica di confine, vi si riscontrava una più ampia diffusione di stampe proi-bite. Si veda M. Berengo, La società veneta, cit., pp. 262, 306.
422. Documento 1791: 25, in Regesto.423. Ibidem. Tra i simpatizzanti per la rivoluzione troviamo i dottori Antonio
Bonzi e Paolo Mazzoleni, oltre a Giuseppe Rondis, già indicato come franco mura-tore nel 1785.
424. Documento 1791: 49, in Regesto.425. Documento 1792: 30, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 230
231
IL TEATRO DEI BORGHI
parte del dramma o dei balli», dietro tali direttive è palpabile il timoredi ben altri problemi426. Almeno dal giugno del 1795 cominciarono adessere redatte settimanalmente dal capitanio in carica le note dei fore-stieri presenti in città427. Il massimo allarme si registrò durante il Car-nevale del 1796. Diventò necessario ribadire nel modo più assoluto laproibizione «di praticare spari d’armi da fuoco a rocchette, rocchetto-ni e simili» nel corso dell’abituale mascherata e corsa di carrozze in Bor-go San Leonardo428. Per quanto riguarda il Teatro della Cittadella si sta-bilì «nel corrente Carnevale un limitato numero di cavalchine» e chenessuno potesse «entrare nel teatro se non sarà munito anche del bi-glietto della festa»429.
Nel marzo 1796, con l’inizio della campagna d’Italia guidata dalgenerale Napoleone Bonaparte in Piemonte e in Lombardia, la situa-zione precipitò irrimediabilmente. Le manifestazioni di dissenso ver-so la Dominante da segrete diventarono palesi. Non si limitavano piùsolo ad anonimi pamphlet, quale l’«audace e sedizioso libello» rivo-luzionario, ritrovato nel gennaio del 1793 sotto la loggia del Palazzodella Ragione, in cui si esprimeva rancore e disprezzo verso i funzio-nari veneziani, come il «camerlingo e sior fiscal», concludendo con ilmonito: «gh’è i francesi; recordeve»430. Queste prime avvisaglie si era-no stemperate immediatamente con la conclusione, nel corso dellostesso anno, della prima campagna militare voluta in Italia dal Diret-torio431. Nel 1796, invece, dopo la resa di Vittorio Amedeo III di Sa-voia e la firma dell’armistizio di Cherasco, avvenuta il 28 aprile, i ti-mori di Venezia diventarono una realtà. Gli aspiranti rivoluzionari ber-gamaschi uscirono alla scoperto e cominciarono ad esprimere pubbli-camente le loro idee, tanto che il dispaccio del capitanio Alessandro
426. Documenti 1792: 27; 1793: 4, in Regesto. Sui provvedimenti adottati da Ve-nezia tra il 1792 e il 1795 contro i sospetti giacobini bergamaschi, cfr. M. Berengo,La società veneta, cit., pp. 306-309.
427. Documenti 1795: 2-9, 13, in Regesto.428. Documento 1796: 6, in Regesto.429. Documento 1796: 3, in Regesto.430. Documento 1793: 1, in Regesto. Il sonetto contenuto nella lettera del capi-
tanio Ottavio Trento è riportato anche da B. Belotti, Storia di Bergamo, cit., vol. V,p. 321 e M. Berengo, La società veneta, cit., p. 316.
431. Sulla differenza tra la campagna militare del 1793 e quella del 1796, cfr. C.Zaghi, L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, in Storia d’Italia, diretta da G. Ga-lasso, vol. XVIII, t. 2, Torino, 1986, p. 30 e ss.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 231
232
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Ottolini relativo al 30 aprile è, dal suo punto di vista, sconfortante432.Incaricato di vigilare «onde scoprire se ci fosse chi professasse e sen-za riguardo difendesse nei caffè e nei ridotti le false opinioni che han-no rovinata la Francia», testimonia come anche a Bergamo e nel di-stretto fosse «predominante ed osservabilmente diffuso un certo ge-nio d’indipendenza e di propensione alla novità»433. Tutte le vicendebelliche erano state seguite con estrema attenzione in città e non ap-pena conosciuti «i fortunati progressi delle armi francesi in Italia», era-no ripresi i «discorsi nei principali caffè e spezierie»434. Le discussioni«si fanno ogni dì generalmente più calde ed impegnate ma, general-mente parlando, sono assai più senza confronto gli aderenti alla feli-cità ed alle massime francesi che li contrari»; non erano più solo pa-role, ma era cresciuto «uno spiegato genio di libertà»435. Ottolini tre-mava al pensiero di ciò che sarebbe seguito ad un’eventuale vittoriadei francesi a Milano: «se la sola fama di una lontana vittoria ha po-tuto tanto», le sue previsioni nel caso di «un più decisivo vicino suc-cesso» erano drammatiche. Il pronostico tragico: «una scintilla potreb-be bastare a suscitare un incendio totale»436. Allo scopo di impedirlo,il rettore avviò un’azione capillare di spionaggio nei principali centridi aggregazione cittadini. Molti furono i discorsi rivoluzionari regi-strati, così come il materiale proibito requisito.
Cominciò, così, la caccia ai «giacobini» bergamaschi. Punto d’in-contro per «molti del genio francese» erano i «due caffè detti del Co-sta e de’ Nobili di Borgo San Leonardo», dove i simpatizzanti palesa-vano «impudentemente la loro compiacenza nelle vittorie e nelle di-
432. In merito all’operato del capitanio Alessandro Ottolini di fronte agli even-ti rivoluzionari sono stati espressi giudizi contrastanti. Per alcuni il suo modo di agi-re sarebbe stato adeguato agli avvenimenti, mentre le maggiori responsabilità del tra-collo sarebbero da attribuire a Venezia che non avrebbe ascoltato le sue numeroseed allarmate segnalazioni, cfr. A. Ottolini, Alessandro Ottolini e la Rivoluzione, cit. Peraltri, invece, le scarse doti politiche del capitanio in carica sarebbero evidenti. Ad es-se andrebbero aggiunte la particolare «grettezza e l’angustia mentale», la sua totaleincomprensione del fenomeno rivoluzionario, l’illusione che «debellare la penetra-zione delle idee rivoluzionarie fosse una semplice incombenza di tipo amministra-tivo»: M. Berengo, La società veneta, cit., pp. 310-311.
433. Documento 1796: 12, in Regesto.434. Ibidem.435. Ibidem.436. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 232
233
IL TEATRO DEI BORGHI
rezioni che» venivano «prese da’ francesi contro le Potenze coalizza-te»437. Vari i nominativi reperiti dalle autorità veneziane. Coloro cheperò si mostravano più infervorati, emergendo senza confronto su tut-ti gli altri, erano il frate Carlo Pezzoli, i due fratelli Bortolo e Girola-mo Riccardi, Giovan Battista Vitali Rota. Il primo, inveendo controla Dominante, avrebbe esclamato: «e chi sa che non venghi levata l’in-tollerabile sovranità delli nostri tre Pantaloni?»438. Il Riccardi avrebbeproclamato i principi espressi dalla dichiarazione dei diritti dell’uo-mo, ossia «ch’era ormai tempo che cessasse l’ingiustizia che un sol uo-mo potesse disporre della vita di un altro uomo e che l’Autorità riscie-de negl’uomini tutti in generale e che siamo tutti uguali»439. GiovanBattista Vitali Rota, auspicando una nuova redistribuzione del pote-re, si sarebbe augurato che «li francesi venissero anco qui, mentre al-lora si comanderebbe un poco per uno»440. Lo stampatore FrancescoLocatelli infine, in conversazione con Gaetano Pezzoli (uno dei pro-prietari del teatro di legno in Cittadella), si sarebbe espresso contro il«nuovo piano daziale», affermando che le tasse per i sudditi sarebbe-ro state eccessive e che soltanto «l’esempio delle rivoluzioni dellaFrancia tengono in freno questa Puttana Vecchia di Repubblica dal-l’istituire nuovi aggravi»441. Tutti erano unanimemente convinti che,
437. Documento 1796: 13, in Regesto.438. Ibidem.439. Ibidem.440. Ibidem.441. Ibidem. Francesco Locatelli fu uno stampatore, attivo tra gli anni Sessanta
e Novanta del Seicento, di opere di genere molto vario: opuscoli encomiastici e poe-sie d’occasione, trattati di carattere scientifico e letterario, opere storiche e pubbli-cazioni di statuti cittadini, cantate e libretti d’opera. Il suo catalogo andava dallepoesie di Paolina Secco Suardo Grismondi, a La vita di Torquato Tasso di Pier Anto-nio Serassi (1790), dagli statuti di Martinengo, fino ad una Raccolta degli avvisi, edit-ti ed ordini ec. pubblicati in nome della Repubblica Bergamasca (1797). Per quanto riguar-da il nucleo di libretti relativi a spettacoli tenuti a Bergamo, si vedano le seguentivoci della Cronologia all’interno di questo volume: La morte di S. Francesco Saverio(1764; 1771), Cantata per musica per la canonizzazione di San Girolamo Miani (1768),La cameriera astuta (1770), Cantata per la partenza di Francesco Savorgnan (1773), Com-ponimento drammatico nella festa di Gregorio Barbarigo (1774), L’astratto ovvero il giocatorfortunato (1775), L’omaggio sincero (1775), Il curioso indiscreto (1778), Il Medonte (1784),Atridate e Farnace (1784). In qualità di «stampatore camerale» pubblicò molti editti,oltre ad avvisi di vario genere e stampe di poesie di occasione: Documenti 1786: 20,22, 27, 32, 41; 1789: 13, in Regesto. Nel 1778 compare come attore dilettante nellaDidone di Metastasio: Documento 1778: 1, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 233
234
FRANCESCA FANTAPPIÈ
ad un arrivo delle truppe francesi, la città sarebbe immediatamentecaduta, poiché «è affatto sproveduta di forze e che, invece di far giar-dini a spese de’ suditi, avrebbe fatto meglio la Repubblica di rimetterli cannoni da qui levati»442. Dietro i principi rivoluzionari molte era-no le rivendicazioni economiche. Emblematico il pronostico del Pez-zoli e dei due Riccardi, secondo i quali, giunti i francesi, «ritroveran-no il dinaro dov’è ammucchiato e che allora ne avranno anch’essi unpoco per cadauno»443. La loro attività per la rivoluzione non dovettelimitarsi alle sole parole. Nel dicembre del 1796 venne scoperto cheun certo «Luigi Eugenio Lhermite», sobillatore francese arrivato da Mi-lano a Bergamo per diffondere segretamente le massime rivoluziona-rie, aveva avuto stretti rapporti di vicinanza proprio con Carlo Pez-zoli e Bortolo Riccardi444.
Sempre più consapevole dell’imminente pericolo Alessandro Ot-tolini chiese inutilmente rinforzi e «guardie militari alle porte de’ Bor-ghi come lo sono quelle della Città»445. Parallelamente fece scattare iprimi arresti, cui seguirono immediate le condanne. I principali sedi-ziosi vennero condotti a Venezia. Tra coloro cui fu intimato di recar-si presso il Tribunale dell’Inquisizione troviamo Bortolo Riccardi,Francesco Locatelli e Giovan Battista Vitali Rota, tutti e tre condan-nati a due anni di reclusione, ma in luoghi separati: il primo nel ca-
442. Documento 1796: 13, in Regesto.443. Ibidem.444. Documenti 1796: 28-29, in Regesto. Per alcuni Louis L’Hermite sarebbe sta-
to «un brigante della più bassa lega» e conoscitore del «basso popolo di Bergamo»:A. Ottolini, Alessandro Ottolini e la Rivoluzione, cit., p. 203; G. Locatelli Milesi, L’an-no 1797 a Bergamo, in Atti e Memorie del secondo Congresso Storico Lombardo, cit., pp.173-194: 174. Si trattava in realtà di un infiltrato, portatosi a Bergamo per entrare incontatto con la parte della cittadinanza favorevole alla venuta dei francesi. Con laloro presa di potere «Lhermit detto anche Smit o Hermit» – il quale «col pretesto diveder dei quadri si era introdotto in varie case di signori» – assunse il ruolo di com-missario e «si mise alla testa della Municipalità»: G.B. Locatelli Zuccala, Memorie sto-riche di Bergamo dal 1796 alla fine del 1813, Bergamo, 1938, p. 9. Non conosciamo lareale natura dei suoi contatti con il Riccardi. Il mero accostamento delle due figu-re, operato dal capitanio Ottolini, rende evidente quale fosse divenuto, agli occhidelle autorità veneziane, il grado di pericolosità del proprietario del teatro stabile infiera.
445. Documento: 1796: 14, Regesto. Secondo A. Ottolini, Alessandro Ottolini e laRivoluzione, cit., p. 199, le proposte militari del capitanio rimasero inascoltate da Ve-nezia, arroccata in una politica di forzata neutralità.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 234
235
IL TEATRO DEI BORGHI
stello di Chioggia, il secondo in quello di Sant’Andrea del Lido, il ter-zo nel Forte di Zara446. Ciò servì a placare momentaneamente le ma-nifestazioni pubbliche di dissenso. Tuttavia la fine appariva inevitabi-le. Dopo aver vinto contro gli austriaci a ponte Lodi, un trionfanteNapoleone Bonaparte, accolto come liberatore, entrò a Milano il 14maggio, provocando l’arrivo a Bergamo di numerosi fuggiaschi447.
L’ultimo contributo del Riccardi alla programmazione del proprioteatro prima della sua incarcerazione risale quindi alla primavera del1796, periodo in cui si esibì la «compagnia comica toscana direttada Luigi Del Buono», ossia Stenterello, primo episodio settecente-sco che attesti la presenza a Bergamo di formazioni di attori profes-sionisti non provenienti dall’area lombardo-veneta448. Si tennero, in-vece, in sua assenza le opere buffe L’amore immaginario, Nina pazzaper amore, Le astuzie femminili, Lisetta e Giannina, La Bonghi della «com-pagnia di cantanti napoletani diretta da Giovanni Bassi»449. La pro-duzione dell’opera seria per la fiera fu affidata ad un fedele suddito
446. Documenti 1796: 15, 18, in Regesto. Don Carlo Pezzoli venne, invece, la-sciato al giudizio del padre provinciale dei somaschi, suo ordine religioso. L’oste Pie-tro Magni, colpevole di aver tenuto una costante corrispondenza rivoluzionaria conGenova e Milano, fu condannato a due anni di prigionia. Si vedano in proposito lelettere degli Inquisitori di Stato ad Alessandro Ottolini, Venezia 18, 23 maggio 1796,ASV, Inquisitori di Stato, 17, cc. 1170, 1178, 1179 e le risposte di Alessandro Ottoliniagli Inquisitori di Stato, Bergamo 11, 14, 15, 21 maggio, ASV, Inquisitori di Stato 228,cc. 1705, 1708, 1709, 1712. Infine M. Berengo, La società veneta, cit., p. 309.
447. Numerose le segnalazioni da parte del capitanio Ottolini a Venezia in me-rito all’esodo dei milanesi nel bergamasco, alla loro ricerca di abitazioni nel territo-rio dove cercavano di mettere al sicuro i propri beni, «rilevandosi che alcuni abbia-no anche qui inoltrato per sicurezza delle casse con effetti preziosi e carte»: Letteradel 27 aprile 1796, ASV, Inquisitori di Stato 228, c. 1694. Il 9 maggio fu la volta diFerdinando d’Asburgo-Lorena e Maria Beatrice d’Este «arciduca e l’arciduchessa diMilano», i quali alloggiarono all’albergo Imperiale in Borgo San Leonardo, Ivi, c.1703. Sul loro arrivo, accompagnato da quello di altri fuorisciti milanesi si vedanoB. Belotti, Storia di Bergamo, cit., vol. V, p. 349; A. Ottolini, Alessandro Ottolini e laRivoluzione, cit., p. 198; G.B. Locatelli Zuccala, Memorie storiche, cit., p. 5. Lo stessomovimento di fuggiaschi dal milanese si registrò anche nella vicina Crema, cfr. G.Cozzi, M. Knapton, G. Scarabello, La Repubblica di Venezia, cit., p. 664.
448. Si veda la Cronologia. Tra le formazioni toscane in tournée in area veneta siregistra, nel 1791 al Teatro Obizi di Padova, la compagnia fiorentina del Teatro delCocomero diretta da Pietro Andolfati, cfr. M. Gorla, Pietro Andolfati, in A.M. Testa-verde, Prime attrici e primi attori, cit., pp. 16-19: 17.
449. Si veda la Cronologia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 235
236
FRANCESCA FANTAPPIÈ
veneziano, il ballerino ed impresario Onorato Viganò, il quale alle-stì ben due opere: la Merope di Mattia Botturini e l’Ines de Castro diLuigi De Santis, occupandosi per entrambe della coreografia dei bal-letti450. Impossibile tuttavia trattenere i facinorosi e «geniali giacobi-ni» che in alcuni casi si manifestavano anche nelle file dei funziona-ri veneziani. Ottolini riferì con incredulità che un certo «Sanfermosegretario dell’Eccellentissimo Provveditore Straordinario», in con-comitanza con l’opera, «al caffè, per le strade, nel teatro, tenne qua-si una cattedra di dispute sulle cose correnti, ostentando quasi il suogenio francese»451. Furono ravvivati i controlli nell’ambiente dellospettacolo e tra gli stampatori. Nel primo caso fu osservata la piùstretta vigilanza sulla circolazione di persone reputate sospette, nelsecondo su quella di libri, riviste, opuscoli, etc. Innumerevoli quel-li requisiti il cui arrivo, grazie alla posizione della città, centro dismistamento per il materiale di contrabbando proveniente d’Oltral-
450. Ines De Castro (1796) e Merope (1796), in Cronologia. Nel corso dello stessoanno le stesse opere furono rappresentate con il medesimo cast a Bologna (entram-be), a Venezia (solo la Merope): C. Sartori, I libretti italiani, cit., libretti 13084, 15561-15562. Su Onorato Viganò, rinomato ballerino, nonché coreografo, impresario e sce-nografo, attivo nella seconda metà del Settecento a Venezia nei teatri della Fenice,San Samuele e San Benedetto, oltreché nella Terraferma (Padova-Teatro Nuovo, Tre-viso, Mestre-Teatro Balbi), si rimanda alla voce relativa del Dizionario enciclopedicouniversale, cit., Le biografie, vol. VIII, p. 240 e a F. Mancini, M.T. Muraro, E. Povole-do, I teatri del veneto, vol. II, cit., pp. 332, 334; vol. III: Padova, Rovigo e il loro territo-rio, cit., pp. 148, 151; vol. IV: Treviso e la marca trevigiana, cit., pp. 62, 73; vol. I, t. 2:Venezia. Teatri effimeri, cit. p. 401; vol. I, t. 2: Venezia e il suo territorio, cit., pp. 190,191, 193, 194, 261, 285; C. Sartori, Il libretti italiani, cit., Indici, vol. I, p. 514.
451. Documento 1796: 20, in Regesto.452. Sulla posizione strategica del territorio bergamasco, crocevia tra l’Alta Ita-
lia, la Svizzera e l’Austria, sul passaggio di «stampe massoniche, eterodosse ed an-tiautoritarie» che attraverso le valli «s’insinuavano nello Stato Veneto», si veda M.Berengo, La società veneta, cit., pp. 302, 305. Tra i documenti requisiti da AlessandroOttolini troviamo il materiale più disparato: La dichiarazione dei diritti e de’ doveri del-l’uomo e del cittadino del 1789, molte gazzette provenienti dalla Francia (tra cui il Mo-niteur), vario materiale proibito dall’Olanda (transitato attraverso la Svizzera), un In-no patriottico francese stampato a Milano e cantato al Teatro della Scala dopo l’arrivodi Napoleone, e così via. Grazie alle ispezioni del capitanio negli appartamenti diCarlo Pezzoli furono rintracciati «articoli ed opuscoli sospetti», lettere, proclami, ol-tre ad un compendio manoscritto sulla rivoluzione francese. La requisizione dell’in-tero inventario del librario Giuseppe Ambrosioni e del figlio Bernardo portò alla lu-ce un vastissimo campionario di stampe proibite che non si limitava ad opuscoli ditipo rivoluzionario, ma comprendeva anche romanzi libertini. Tutto ciò sarebbe cir-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 236
237
IL TEATRO DEI BORGHI
pe, appariva impossibile arginare452. Per quanto riguarda l’opera del1796 fu impedito ad alcuni artisti di recitare. È il caso di «certa Ma-rianna Beccaccini ballerina», invitata ad «allontanarsi da’ pubblici sta-ti»453. Stesso ordine per «la ballerina Luigia Zerbi»454. Provvedimentiche però risultarono semplici palliativi, se il 4 settembre 1796 «al tea-tro di fiera in Bergamo» sembra che assistesse Giuseppina Beauhar-nais, moglie del generale Napoleone Bonaparte455.
In ottobre le città di Modena, Reggio, Bologna e Ferrara, alcunedelle quali erano insorte volontariamente, vennero unite nella Repub-blica Cispadana. A Bergamo, l’arrivo delle truppe francesi avvenne pri-ma della fine dell’anno456. Il 25 dicembre occuparono e disarmaronoil castello di San Vigilio, punto militarmente strategico, in attesa delvia libera da parte dei comandi generali per prendere ufficialmentepossesso della città457. All’assedio dei nemici Alessandro Ottolini nonpoté opporre alcun reale provvedimento bellico. I mesi che seguiro-no si contraddistinsero come un periodo di estenuante attesa da en-trambe le parti. Le scelte del capitanio furono perciò disperate. Dopo
colato in e da Bergamo, molto prima dell’inizio della campagna napoleonica. L’ar-rivo dei francesi in Italia, però, aveva fatto definitivamente precipitare la situazione,rendendola incontrollabile. Bergamo diventò il principale centro di smistamento perla Terraferma veneta. Nel mese di settembre vennero sequestrate stampe dirette aBrescia, Verona, Vicenza, Padova, Venezia. Una delle cause di ciò, secondo il capi-tanio, era che a causa della «vicinanza di Milano, le ragioni di commercio» avevano«fatto transitare continuamente de’ forestieri ed in mille modi» erano state introdot-te «carte e fogli d’ogni sorte». Ma non c’erano solo gli opuscoli. Fu, infatti, clamo-roso scoprire che don Cammillo Pezzoli, all’insaputa delle autorità, era riuscito a fa-re dipingere in casa sua un albero della libertà colla «berretta rossa sulla cima». Peri riferimenti documentari relativi alle notizie qui riportate si rimanda alla lettera de-gli Inquisitori di Stato ad Alessandro Ottolini, Venezia 28 maggio 1796, ASV, Inqui-sitori di Stato 17, p. 1182 e alle risposte di Alessandro Ottolini agli Inquisitori di Sta-to, Bergamo 4, 14, 25, maggio, 7 settembre 1796, 7 gennaio 1797, ASV, Inquisitori diStato 228, cc. 1699, 1704, 1708, 1718, 1765, 1774, 1799.
453. Documenti 1796: 21, 23, in Regesto.454. Documenti 1796: 26; 1797: 8, in Regesto.455. Documento 1796: 25, in Regesto.456. Sugli avvenimenti del 1797 rimandiamo anche a G.B. Locatelli Zuccala, Me-
morie storiche, cit., pp. 173-194.457. Documento 1797: 9, in Regesto. Sull’arrivo dei francesi in Bergamo, sul lo-
ro rifiuto di acquartierarsi nel Lazzaretto, come proposto dal capitanio, e sulla loropresa di possesso del castello di San Vigilio, cfr. A. Ottolini, Alessandro Ottolini e laRivoluzione, cit., p. 200.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 237
238
FRANCESCA FANTAPPIÈ
aver ottenuto il permesso da Venezia, il 6 gennaio fece disfare il Tea-tro della Cittadella, allo scopo di impedire l’ingresso nel proprio pa-lazzo dei soldati francesi in veste di spettatori. Nel frattempo ordinòche la stagione invernale proseguisse nel Teatro Riccardi458. Cinquegiorni dopo, un incendio distrusse irrimediabilmente anche questo edi-ficio. Ecco la descrizione dell’accaduto secondo Giovan Battista Lo-catelli Zuccala:
Il rappresentante Ottolini fece demolire in una notte il teatro che era diasse fabbricato in Cittadella nella sua gran sala, di cui era fissata l’aper-tura nei primi di gennaio. Era stato però autorizzato prima dagli Inqui-sitori di Stato di servirsi di ogni mezzo per impedire in quello le stabili-te rappresentazioni. Per non restar senza teatrale spettacolo nel Carneva-le si combinò di aprire nel giorno tredici di gennaio il Teatro Riccardiposto in Prato, ora Campo di Marte; ma nel giorno tredici del Teatro Ric-cardi non vi erano che le nude muraglie. Poiché un terribile incendio qual-che giorno prima (la notte dell’undici venendo il dodici) lo aveva già ar-so e consunto. Si scoprì il fuoco alla ore tredici del mattino, si suonòcampana a martello, accorse gran gente e lo stesso rappresentante con lesue guardie e sgherri; ma invano, perché il fuoco erasi già inoltrato di ma-niera che ne cadde il tetto e rovinò e scenario e palchi. Si suppose chenon a caso, ma ad arte sia stato incendiato. Di chi poi? Vedremo in ap-presso come finì il processo instituito per scoprir il reo459.
Incendio doloso quindi. Responsabile dell’accaduto fu immedia-tamente considerato il capitanio460. Ciononostante, per allontanareogni sospetto, Alessandro Ottolini aprì immediatamente un’indaginecon la quale si stabiliva che l’incendio non era stato «accidentale, maprocurato e doloso»: Giuseppe Riccardi, uno dei fratelli proprietaridello stabile, avrebbe accusato gli «interessati e proprietari del teatromobile ch’esisteva in un salone di questo Palazzo Prefettizio»461, os-sia del Teatro di Cittadella. Il rettore cercò quindi di far ricadere ogniresponsabilità su Ridolfo Longhi, Gaetano Pezzoli, Francesco Scotti
458. Documenti 1796: 32-33; 1797: 1, in Regesto. Sulle proteste dei fratelli Lom-bardi e dei proprietari Longhi, Pezzoli, Scotti e Zanchi, per la demolizione del tea-tro si veda anche. A. Ottolini, Alessandro Ottolini, cit., p. 210 e ss.
459. G.B. Locatelli Zuccala, Memorie storiche, cit., p. 7.460. Documento 1797: 2, in Regesto.461. Documento 1797: 3, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 238
239
IL TEATRO DEI BORGHI
e Vincenzo Zanchi, i quali per gelosia avrebbero distrutto l’edificioteatrale rivale462. Sulla base di tali indicazioni i tribunali veneziani ini-ziarono un procedimento legale463. Il processo non ebbe mai luogoin quanto, dopo la caduta della dominazione veneziana, la nuova mu-nicipalità bergamasca riaprì il caso con un nuovo imputato: principa-le ideatore e mandante dell’incendio del Teatro Riccardi sarebbe sta-to l’ex rettore. Secondo gli atti prodotti in questo caso «fin dal suonascer fu l’incendio del teatro di Borgo San Leonardo giudicato datutti che fosse stato ordinato da Alessandro Ottolini, fu capitano e vi-cepodestà di Bergamo»464. Egli fu inchiodato dalla deposizione di due«capi di sbirri», allora sottoposti al suo comando, i quali affermaronodi essere stati obbligati ad agire seguendo le sue precise direttive. Ot-tolini aveva ordinato loro di appiccare l’incendio, temendo che «que-sti cittadini si potessero in teatro famigliarizzare troppo con li france-si». Le due guardie, per eseguire l’incarico avrebbero affidato il com-pito a tre forestieri di passaggio, procurando loro il materiale «assali-no, polvere, zolfo ed altro occorente»465. Dopo il compimento del mi-sfatto, gli esecutori materiali sarebbero stati pagati dal cancelliere pre-fettizio.
Il 2 febbraio del 1797 anche Mantova cadde in mano ai francesi.Le città periferiche della Repubblica veneta cominciarono a trema-re. La presa di possesso ufficiale di Bergamo ebbe luogo tra il 12 eil 13 marzo del 1797. Nel corso della vicenda vediamo a confrontodue diversi atteggiamenti e modi di agire, sintomatici di due oppo-ste mentalità. Da un lato la retorica del capitanio e dall’altro la con-
462. Documenti 1797: 3 e 4, in Regesto.463. Documenti 1797: 5-7, in Regesto. Il processo contro il capitano Alessandro
Ottolini iniziò il 17 marzo del 1797. I due testimoni principali contro il rettore, os-sia Bernardino Acchiappati e Nicola Chiappati, ritrattarono la loro deposizione ingiugno. Tra coloro che accusavano l’Ottolini vi erano anche Girolamo Riccardi, fra-tello di Bortolo, e gli impresari della Cittadella fratelli Lombardi: A. Ottolini, Ales-sandro Ottolini e la Rivoluzione, cit., p. 207. Il 9 aprile vennero messi all’incanto i be-ni dell’ex rettore e «il sopravanzo» fu confiscato «forse a risarcimento dei danni deiproprietari del teatro che si voleva da lui fatto incendiare»: G.B. Locatelli Zuccala,Memorie storiche, cit., p. 19. Difficile fare chiarezza sul caso, in quanto assunse im-mediatamente il rilievo di un processo politico. Le alterne vicende che subì nel cor-so degli anni seguenti furono strettamente legate al destino del dominio francese aBergamo, cfr. E. Comuzio, Il teatro Donizetti, cit., p. 42 e ss.
464. Documento 1797: 10, in Regesto.465. Ibidem.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 239
240
FRANCESCA FANTAPPIÈ
creta azione dei francesi occupanti. Il 12 marzo 1797 una parte del-le truppe nemiche scese dal castello di San Vigilio, mentre quattrocannoni furono trascinati in città per essere puntati sugli edifici pub-blici principali: il Palazzo della Ragione, il Palazzo del Podestà e ilPalazzo del Capitanio. I deputati della Città, interpellati dal coman-dante francese Faivre per sottoscrivere «l’unione del Bergamasco al-la Repubblica Cisalpina»466, si recarono immediatamente dal capita-nio a darne relazione e chiedere protezione. Tutto ciò che poté fareil capitanio fu rispondere proclamando gli ideali di «fedeltà» e «sud-ditanza», facendo leva sul mito della Repubblica e su concetti ap-partenenti ad un mondo ormai al tramonto. Ottolini, «uomo di mio-pe mediocrità»467, adottò quindi i metodi di una vecchia e tradizio-nale diplomazia, cui i deputati bergamaschi opponevano timori con-creti. Essi affermavano che «qualora non li garantissi, il che già ve-devano non poter fare» sarebbero stati costretti a «cedere nella ne-cessità del momento, colla solenne protesta però che essi» erano «fe-deli sudditi di Vostra Serenità»468. Invano il capitanio cercò di met-tersi in contatto con Brescia alla ricerca di rinforzi. Il suo corrierevenne intercettato dai francesi e, in ogni caso, anche Brescia si tro-vava in condizioni molto simili, segno di un’azione francese prece-dentemente orchestrata ed attentamente pianificata. Il 13 marzo gli«uffiziali francesi Hermit e Boussion» con il «nuovo eletto capo delpopolo conte Pietro Pesenti e conte Alborghetti nuovo municipali-sta in divisa e coccarda francese»469 intimarono al capitanio di an-darsene, pena la vita. Vennero chieste però alcune condizioni: la con-segna della cassa, il rilascio dei bergamaschi filofrancesi incarcerati,«il licenziamento della veneta truppa»470. All’Ottolini non rimase chela fuga. Perfino il vescovo di Bergamo benedisse la nuova repubbli-ca bergamasca471.
466. Documento 1797: 9, in Regesto.467. M. Berengo, La società veneta, cit. p. 310.468. Documento 1797: 9, in Regesto469. Ibidem.470. Ibidem.471. Sulle probabili ragioni di opportunismo politico del vescovo Dolfin si ve-
da M. Berengo, La società veneta, cit., p. 312, mentre sulle reazioni della comunitàreligiosa bergamasca si rimanda a G. Bonicelli, Rivoluzione e restaurazione a Bergamo.Aspetti sociali e religiosi della vita bergamasca alle soglie dell’età contemporanea (1775-1825),Bergamo, 1961.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 240
241
IL TEATRO DEI BORGHI
Per la città fu l’inizio di una nuova era ma, per quanto riguardail sistema teatrale, con molti aspetti di continuità. L’abbattimentodei due teatri principali non impedì che venisse immediatamente ri-stabilito il binomio Città Alta vs Borghi. Nell’agosto del 1797, seb-bene in un edificio provvisorio, descritto come «nuovo Provisionalteatro di Fiera» si tenne l’opera buffa L’Astuta in amore o li Raggiri sco-perti, con un cast quasi del tutto milanese472. La necessità di un tea-tro stabile, conquista ormai consolidata, venne ribadita dalla rico-struzione del Teatro Riccardi nel giro di pochi anni473. Per quanto ri-guarda la Città Alta, per sostituire il Teatro di Cittadella, venne da-to prontamente il permesso all’impresario Francesco Cerri di costrui-re un teatro nella Sala Maggiore del Palazzo della Ragione, con lariserva che restasse attivo per soli dieci anni 1797-1807474. Dopo lademolizione di questo teatrino la Città Alta non rimase senza unedificio consono agli spettacoli del Carnevale. Nel 1808 i tempi era-no finalmente maturi per l’attesa inaugurazione del primo Teatro So-ciale di Bergamo.
3. Note conclusive
Il sistema teatrale costituitosi nei Borghi fu, al pari di quello dellaCittà Alta, un sistema basato sulla periodica costruzione di edifici prov-visori. Il ricorso a tali strutture non fu una caratteristica peculiare diBergamo, ma è riscontrabile anche in altre città del Dominio qualiVerona e Padova, dove il Teatro dell’Arena e il Teatro del Prato veni-vano costruiti in spazi all’aperto. Né l’uso di teatri provvisori si rive-lò antitetico alla qualità del repertorio proposto. L’eccezione berga-masca fu semmai l’esclusivo ricorso a questa tipologia architettonica.Sia che fossero costruiti all’aperto, sia che fossero al chiuso, gli edifi-ci teatrali dovevano rimanere provvisori. Si venne così a configurareun tipo di gestione del fenomeno teatrale del tutto singolare, basatosu una netta divisione tra impresari-costruttori locali, preposti alla cu-
472. Documenti 1797: 11-46, in Regesto.473. Finalmente portato a termine, nonostante numerosi problemi finanziari, il
nuovo Teatro Riccardi venne inaugurato nel 1800: F. Buonincontri, Il sistema teatra-le, cit., p. 73.
474. Ivi, p. 74; L. Pelandi, Teatri scomparsi, cit., pp. 17-18.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 241
242
FRANCESCA FANTAPPIÈ
ra dei luoghi adibiti agli spettacoli, e impresari itineranti da cui dipen-deva la scelta del repertorio.
Dal punto di vista delle autorità municipali la figura professiona-le del costruttore, o proprietario di un teatro amovibile, garantì a lun-go una serie di apparenti vantaggi. Poiché esso era destinato ad eser-citare una funzione imprenditoriale temporanea, con la demolizionedell’edificio costruito si allontanava la temuta eventualità di un’alte-razione della compagine sociale cittadina. Un pericolo che l’afferma-zione di un proprietario di teatro stabile avrebbe sicuramente alimen-tato. Si dava, inoltre, l’illusione di poter controllare il fenomeno e,quando ritenuto necessario dalle autorità, di poterlo “espellere”. Tut-to ciò non teneva conto, però, di quanto succedeva al di fuori delleristrette mura cittadine. A livello peninsulare, e particolarmente in areacentro-settentrionale, la diffusione del teatro professionistico musica-le e in prosa, avviata nella seconda metà del Seicento, esplose defini-tivamente in quello successivo. Bergamo non ne rimase esclusa. Difronte all’inarrestabile aumento del numero di impresari attivi in cit-tà e per passare «dalla totale anarchia a qualche principio di sistema edisciplina»475, anche l’oligarchia bergamasca fu costretta a promulga-re le prime norme in ambito teatrale. Nel 1775 nacque così la caricadei cosiddetti tre presidenti del Teatro, cui fu affidato il controllo sul-la costruzione dei teatri provvisori, sul repertorio proposto nel corsodegli spettacoli e soprattutto sugli impresari, «persone le quali non àn-no altro oggetto che quello d’un ingordo guadagno»476. Verso di essiil giudizio, diffuso anche tra i moralizzatori e i riformatori del teatrosettecenteschi, rimarrà fortemente negativo.
L’alternativa ad un teatro posseduto e gestito da un singolo impre-sario rimaneva quella di un teatro sociale a conduzione collettiva, sulmodello del Filarmonico di Verona o degli Erranti di Brescia. Sebbe-ne tale desiderio fosse stato a lungo nutrito da una parte della nobil-tà bergamasca, non riuscì mai a trovare un’effettiva realizzazione. Vi-ceversa numerosi furono i fallimenti collezionati. Nel 1750 il capita-nio Baglioni riscontrava che, nei «cittadini vogliosi di avere nel soli-tario soggiorno un teatro che mai vi fu», tale aspirazione «non nascein adesso, ma da più anni fu ella fin qui inutilmente coltivata»477. La
475. Documento 1774: 3, in Regesto.476. Documento 1774: 2, in Regesto.477. Documento 1750: 5, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 242
243
IL TEATRO DEI BORGHI
ragione principale dell’impossibilità di portare a compimento il pro-getto di un teatro sociale, va ricercata nelle ricorrenti contese interneal cosiddetto «corpo nobiliare». Tali discordie, nel caso in cui venivaproposta la realizzazione di un teatro stabile si palesavano regolarmen-te al momento della distribuzione dei palchetti. Nel 1750 si ridusse-ro a piccinerie grottesche, ma non furono da meno le rivalità emersenel 1770 in occasione della proposta di Francesco Bolognese. Il pos-sesso di un palchetto era sinonimo di uno status sociale e le contesta-zioni relative alla sua assegnazione erano comuni, come dimostra ilcaso veneziano meglio noto come «guerra dei palchi»478. Ciò che di-stinse il caso bergamasco non fu il fenomeno in se stesso, quanto ilfatto che non venne mai superato.
Se le mura cittadine tardavano ad aprirsi, quelle della Città Alta sidimostravano sicuramente più anguste di quelle dei Borghi. Arrocca-ta su un colle e protetta dalla cinquecentesca cinta muraria venezia-na, costituiva un sistema chiuso, apparentemente impermeabile. I Bor-ghi, al contrario, più aperti alle novità, divennero ben presto metafo-ra di una nuova città in continua espansione, sempre più ricca e di-namica, pronta ad accogliere i cosiddetti «forestieri» i quali, guardacaso, vi confluivano in maggioranza479. Contrapposta all’immobilismodella Città Alta, simbolo dei privilegi nobiliari dell’oligarchia urbana,la Città Bassa cresceva, così come la sua popolazione, portando Ber-gamo ad essere nel corso del Settecento, insieme a Vicenza, l’unicacittà della Terraferma con un trend demografico positivo480. La fieraannuale, volàno principale dell’economia urbana, attirò come preve-dibile il teatro, costituendo un punto di riferimento per gli operatoridel settore. Al teatro regolare, rappresentato dalle stagioni operisticheestive e dagli spettacoli delle compagnie di attori professionisti, si af-fiancava il composito e diversificato teatro “circense” degli acrobati,dei burattini, dei ciarlatani, degli ammaestratori di animali, degli am-bulanti con i loro apparecchi proto-cinematografici, etc. I festeggia-
478. R. Giazotto, La guerra dei palchi, cit., pp. 465-508; N. Mangini, I teatri di Ve-nezia, cit., pp. 30-32.
479. La crescita demografica che caratterizzò Bergamo nel corso del Settecento,illustra un progressivo spopolamento della Città Alta, contro un sempre più accele-rato aumento dei Borghi: L. Pagani, Le condizioni demografiche, cit.; C.M. Belfanti,Dalla stagnazione alla crescita, cit.
480. Tutte le altre città della Terraferma presentano una stasi demografica, se nonadirittura un decremento: D. Beltrami, Storia della popolazione, cit., p. 68.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 243
244
FRANCESCA FANTAPPIÈ
menti per il Carnevale, infine, si tenevano in Borgo San Leonardo cherichiamava le sfilate delle persone in maschera, così come ospitava lecorse con le carrozze.
La mentalità bigotta e provinciale che voleva una Bergamo labo-riosa, onesta e virtuosa, ma poco incline ai divertimenti del teatro pro-fano, fu piegata dalla vitalità dei Borghi, fino ad essere definitivamen-te sconfitta dall’azione individuale di una persona che non apparte-neva all’oligarchia cittadina, ma al ceto imprenditoriale emergente. Fucosì possibile uscire da meccanismi reiterati, quali l’immancabile ri-valità interna alla classe sociale dominante ed una politica teatrale di-sorganica, sottoposta alla continua contrattazione politico-amministra-tiva tra potere locale e Dominante. A Bergamo, in ogni caso, l’azio-ne collettiva si dimostrò immancabilmente perdente, mentre quellaindividuale-privata fu l’unica vincente. Nel Seicento era stato il con-te Giuseppe Secco Suardo, nel Settecento fu Bortolo Riccardi. In en-trambe le occasioni Venezia aveva protetto l’iniziativa del singolo, de-cretandone la vittoria.
La ben poco lungimirante politica cittadina, ironia della sorte, por-tò alla realizzazione di ciò che era stato a lungo combattuto: la costru-zione di un teatro stabile da parte di un privato. Non fu certo un pro-cesso indolore, né tantomeno lineare. La domanda iniziale del Riccar-di venne approvata solo perché sembrava non prevedere alcuna novi-tà. Egli sarebbe rimasto un semplice costruttore, scongiurando il peri-colo che «persone di nessuna condizione e carattere»481 potessero di-ventare proprietarie di un edificio teatrale. Sottobanco, però, vi furo-no ordini contrari. Il disegno originariamente firmato e approvato daitre presidenti del Teatro e dai funzionari dell’Ospedale Maggiore fa chia-ramente riferimento ad un teatro stabile (figg. 24-25)482. Con questo con-cordano le dichiarazioni del suo costruttore, secondo il quale essendo
universale desiderio in Bergamo, per oggetti di decoro e di commercio,di costruire in forma stabile e luminosa il solito provvisionale teatro cheprima era formato di legno, si accolse da quella Magnifica Città il pro-getto di me Bortolo Riccardi suo cittadino483.
481. Documento 1791: 20, in Regesto.482. Secondo l’Arrigoni furono i tre presidenti del Teatro in carica nel 1786 «quel-
li che ad esso ordinarono la fabrica nel sito e modo che è costrutta»: Documento1788: 7, in Regesto.
483. Documento 1788: 17, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 244
245
IL TEATRO DEI BORGHI
Nel momento in cui emersero le prime contestazioni contro il Ric-cardi, Venezia non le accolse, né avrebbe potuto capire, dall’alto del-la sua secolare tradizione di teatro professionistico e imprenditoriale,una distinzione come quella tra un proprietario di un teatro stabile eun costruttore di uno provvisorio, che tanto premeva ai bergamaschi.Approvando il suo operato, acconsentiva implicitamente all’idea diun edificio teatrale permanente. Ciò non significò difendere l’idealedi una funzione sociale del teatro. Nel 1750, quando il progetto di unteatro stabile a conduzione sociale aveva messo a rischio la pace trale varie casate, Venezia si era opposta drasticamente e il capitanio Ba-glioni aveva ritenuto che «già priva da secoli la città solitaria, potessecontinuar nella privazione di cosa non necessaria»484. Né vinse il con-cetto espresso da Francesco Bolognese nel 1770, secondo cui un tea-tro stabile avrebbe potuto dare «nuovo lustro ed adornamento» allacittà stessa485. La preferenza accordata da Venezia al Riccardi fu dovu-ta a ragioni pragmatiche. Vinse l’interesse di un privato cittadino.
La lentezza e l’incertezza delle autorità municipali nel prendere unadecisione in merito alle diatribe innescate dalla costruzione del Tea-tro Riccardi, così come le divisioni interne ai palchettisti, che per tan-to tempo aveva impedito la conduzione di un teatro collettivo, de-cretarono la vittoria del Riccardi. Nessuno chiese esplicitamente la di-struzione del teatro, ma tutti dichiararono di volerne l’ultimazione,secondo un progetto difficilmente verificabile. Unico trait d’union nel-la varietà e nella confusione delle recriminazioni furono gli interessidi tipo individualistico: garantirsi un palchetto adeguato al proprio li-vello sociale, reale o presunto, all’interno del nuovo edificio. Le po-lemiche erano imprecise, gli ordini frammentari. L’unico determina-to si rivelò il costruttore Riccardi che continuò seguendo «la idea chequesto sia teatro suo»486.
«Il signor Riccardi, uno di nessuna fama», per di più «noto a tuttiper persona violenta», dal quale «non se ne poteva aspettare che deidisordini e dispiaceri»487 riuscì così a far prevalere il proprio interesse.A dispetto della scarsa reputazione da lui goduta all’interno di unaparte della nobiltà cittadina, l’homo novus non era semplicemente un
484. Documento 1750: 10, in Regesto.485. Documento 1770: 2, in Regesto.486. Documento 1786: 55, in Regesto.487. Documenti 1786: 58; 1791: 20, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 245
246
FRANCESCA FANTAPPIÈ
imprenditore scaltro e tenace nella realizzazione dei propri progetti,ma un “illuminato”. Allo scoppio della rivoluzione lo troviamo pro-clamare i principi della dichiarazione dei diritti dell’uomo: «ch’era or-mai tempo che cessasse l’ingiustizia che un sol uomo potesse dispor-re della vita di un altro uomo e che l’Autorità risiede negl’uomini tut-ti in generale e che siamo tutti uguali»488. Con la sua vittoria si apri-va una nuova era. Non a caso, nel corso del periodo napoleonico, ilprocesso di costituzione di un sistema teatrale urbanisticamente rico-nosciuto subì un’ accelerazione del tutto straordinaria. Dopo lo sman-tellamento del Teatro della Cittadella, venne immediatamente costrui-to il Teatro Cerri nella sala grande del Palazzo della Ragione. Nel cor-so dei dieci anni in cui questo rimase attivo, nuove e più coese istan-ze sociali portarono al compimento del Teatro Sociale, un teatro a con-duzione collettiva, il primo nella storia della città, per la quale taleprogetto era rimasto per quasi un secolo una semplice chimera.
488. Documento 1796: 13, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 246
249
Fig. 1. Cittadella (1), Teatro Secco Suardo (2), Piazza Vecchia (3),Borgo San Leonardo (4), Prato della Fiera (5), Borgo Sant’Antonio (6)
Elaborazione della pianta della città di Bergamo di Stefano Scolari, Venezia, 1680.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 249
250
Fig. 2. Ercole effemminato (1654)
Immagine contenuta nel libretto d’opera, BNBM, Raccolta Drammatica 280.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 250
251
Fig. 3. Annibale in Capua (1668)
Immagine contenuta nel libretto d’opera, BCBg, Sala 32 D 2 5/1.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 251
252
Fig. 4. Elio Seiano (1668)
Immagine contenuta nel libretto d’opera, BRNo, 782 MIN.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:28 Pagina 252
253
Fig. 6. Palazzo Secco Suardo (413, 415) nella mappa castastale di Bergamo (1876)
ASBg, Catasto lombardo veneto, mappe.
Fig. 5. Palazzo Secco Suardo (413) ed ex Monte di Pietà (414-417, 423)nella mappa catastale di Bergamo (1853)
ASBg, Catasto lombardo veneto, mappe.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 253
254
Fig. 7. Frontespizio del libretto del Tullo Ostilio (1688)
BNBM, Raccolta Drammatica 2570.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 254
255
Fig. 8. Tullo Ostilio (1688)
Immagine contenuta nel libretto d’opera, BNBM, Raccolta Drammatica 2570.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 255
256
Fig. 9. Frontespizio del libretto Giulio Cesare in Egitto (1689)
BNBM, Raccolta Drammatica 2354.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 256
257
Fig. 10. Giulio Cesare in Egitto (1689)
Immagine contenuta nel libretto d’opera, BNBM, Raccolta Drammatica 2354.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 257
258
Fig. 11. Hiarba impazzito (1690)
Immagine contenuta nel libretto d’opera, BNBM, Raccolta Drammatica 2456.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 258
259
Fig. 12. Pianta del primo piano della Cittadella (seconda metà XVIII sec.)
ASV, Provveditori alle fortezze, 42 bis II.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 259
260
Fig. 13. Teatro della Cittadella, boccascena (1770)
BCBg, Bergamo illustrata, Faldone 7, c. 23
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 260
261
Fig. 14. Teatro della Cittadella, prospetto dell’arcoscenico e pianta del palco (1770)
BCBg, Bergamo illustrata, Faldone 7, c. 25.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 261
262
Fig. 15. Teatro della Cittadella, pianta del palco (1770)
BCBg, Bergamo illustrata, Faldone 7, c. 25 (particolare).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 262
263
Fig. 17. Avviso di rappresentazione teatrale, La donna archibugier francese,La favola del corvo, Il fanatismo alla berlina
(compagnia Marchesini – Cicuzzi, 28-30 giugno 1788)
BCBg, Francesco Maria Quarenghi, Ducali ed altre cose diverse, tomo XIV, c. 204.
Fig. 16. Avviso di rappresentazione teatrale, Amore irritato dalla difficoltà ossiaTeresa e Claudio (compagnia Marchesini – Cicuzzi, 14 giugno 1788)
BCBg, Francesco Maria Quarenghi, Ducali ed altre cose diverse, tomo XIV, c. 140.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 263
264
Fig. 18. Avviso di rappresentazione teatrale, Il Rutzvanzcat il giovane(compagnia di Pietro Polinà, 23 giugno 1792)
BCBg, Francesco Maria Quarenghi, Ducali ed altre cose diverse,tomo XLI, cc. 153-154.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 264
265
Fig. 19. Note di repertorio alfabetico relative alla stagione operistica del Teatrodi Cittadella (Bergamo 8 gennaio, 2, 4, 8 marzo 1791)
BCBg, Francesco Maria Quarenghi, Ducali ed altre cose diverse, tomo XXXVIII, indice.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 265
266
Fig. 20. Avviso di accademia musicale nel Teatro Riccardi (8 giugno 1792)
BCBg, Francesco Maria Quarenghi, Ducali ed altre cose diverse,tomo XLI, c. 14.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 266
267
Fig. 22 Immagine di leonessa da un avviso di esposizione di animali in fiera(estate 1773)
BCBg, Francesco Maria Quarenghi, Ducali ed altre cose diverse, tomo XIX, c. 146.
Fig. 21. Immagine di avvoltoio da un avviso di esposizione di animali in fiera(estate 1773)
BCBg, Francesco Maria Quarenghi, Ducali ed altre cose diverse, tomo XIX, c. 145.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 267
268
Fig. 23 Pianta del tezzone del salnitro di Bergamo presso il recintodelle monache di Santa Marta (sec. XVIII)
ASV, Patroni Provveditori Arsenale 562/5.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 268
269
Fig. 24 Pianta del Teatro Riccardi, particolare con sottoscrizioni (1786)
BCBg, Sala 32 C 8 25 3 (3).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 269
270
Fig. 25 Pianta del Teatro Riccardi (1786)
BCBg, Sala 32 C 8 25 3 (3).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 270
273
Cronologia degli eventi spettacolari
In questa appendice si dà conto degli eventi spettacolari tenuti aBergamo finora reperiti. L’organizzazione delle schede varia in baseall’ambito dello spettacolo: Teatro in musica o Teatro in prosa. All’in-terno di ciascun ambito la registrazione è invece uniforme.
DATA:AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA:LUOGO:TITOLO:AUTORE:COMPOSITORE:GENERE:PERSONAGGI:SCENA:CAMBI DI SCENA PER L’OPERA:SCENOGRAFO:DEDICATARIO:DEDICANTE/IMPRESARIO:CANTANTI:MUSICISTI:COSTUMISTA:TITOLO DEI BALLI:PERSONAGGI DEI BALLI:COREOGRAFO:BALLERINI:FONTI:
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 273
274
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Per quanto riguarda il Teatro in musica le notizie si ricavano prin-cipalmente dai libretti. Sono stati reperiti tutti quelli registrati in C.Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, Cuneo, 1990-1994,7 voll, per ognuno dei quali è stata indicata la provenienza e il luogoin cui è conservato1. Ulteriori notizie documentarie sono state segna-late sotto la voce Fonti. Nel caso di una sovrapposizione con gli Indi-ci dei teatrali spettacoli si è dato maggior rilevanza a questi ultimi2. Traparentesi quadre [ ] sono state messe le notizie che non derivano dal-le fonti primarie consultate, le attribuzioni incerte e le definizioni del-la curatrice, es: [Libretto], [Giovan Battista Pergolesi], ecc… Tra «» so-no state inserite le trascrizioni del testo originale. I dati che seguonole voci Personaggi, Scena, Cambi di scena per l’opera, pur non essendo sta-ti riportati tra virgolette basse, sono trascrizioni del testo orginale. Al-cune definizioni dei libretti, come «direttore e compositore dei bal-li», «pittore delle scene», ecc… sono state automaticamente converti-te nelle voci corrispondenti come Coreografo o Scenografo. In merito airuoli attribuiti a ciascun interprete, come «parte seria», «grottesco»,«mezzo carattere», ecc… si sono trascritte le definizioni dei libretti.
DATA:AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]TIPOLOGIA:LUOGO:COMPAGNIA:TITOLO DELLE OPERE RAPPRESENTATE:ATTORI:FONTI:
Le notizie che riguardano la prosa derivano da documenti di ge-nere più vario, in quanto non esiste una fonte primaria simile al li-bretto. Possono essere epistolari, avvisi, indici teatrali ecc… In alcunicasi, in particolar modo nel Seicento, non conosciamo i nomi degliattori, ma solo i nomi d’arte. Spesso, anche nel Settecento, conoscia-mo solo il nome della compagnia. I titoli delle opere rappresentateemergono solo in rari casi. Nel caso che siano state reperite notizie in
1. Quando possibile è stata data anche la collocazione.2. Gli indici venivano pubblicati alla fine dell’anno comico. I libretti, invece,
erano spesso stampati prima della rappresentazione, cfr. R. Verti, Un almanacco dram-matico. L’indice de’ teatrali spettacoli 1764-1823, Pesaro, 1996, vol. I, p. XI e sgg.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 274
275
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
tal senso è stata data notizia della data di rappresentazione tra paran-tesi ( ), es: La Virginia di Vittorio Alfieri (13 maggio). I nomi d’arte so-no stati messi in corsivo, mentre i ruoli in tondo, es: Isabella Andrei-ni (Isabella, prima innamorata).
DATA: 1583, estateAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]TIPOLOGIA: [Commedia dell’arte]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA DI ATTORI: [Compagnia dei Gelosi]ATTORI: Isabella Andreini, Francesco Andreini, Giacomo Braga, Gio-
vanni Pellesini, Ludovico de’ Bianchi, Adriano Valerini.FONTI: Giovan Battista Castiglione, Sentimenti di S. Carlo Borromeo in-
torno agli spettacoli, Bergamo, Pietro Lancellotti, 1759, pp. 1 40, 141(nota 3) e 143; R. G. Arcaini, I comici dell’Arte a Milano: accoglienza,sospetti, riconoscimenti, in La scena e la gloria, a cura di A. Cascetta eR. Carpani, Milano, 1995, p. 272.
DATA: 1593 (rappresentazione solo presunta)3
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]TIPOLOGIA: [Teatro letterario]LUOGO: Bergamo, sala non identificata.TITOLO: La SemiramisAUTORE: Muzio ManfrediGENERE: Tragedia in versiPERSONAGGI: Ombra di Nino; Ombra di Mennone; Semiramis; Hi-
metra; Coro; Nino; Simandio; Dirce; Atirtia; Beleso; Nunzio.DEDICATARIO: Cardinale Odoardo FarneseDEDICANTE: [Muzio Manfredi]. Data: Nancy primo giugno 1593.FONTI: [Libretto], La Semiramis. Tragedia di Mutio Manfredi il Fermo aca-
demico Innominato, Invaghito e Olimpico. All’illustrissimo cardinale Far-nese dedicata, Con licenza de’ Superiori, in Bergamo, Per CominVentura, 15934.
3. Non vi è alcun documento che attesti la rappresentazione dell’opera in Ber-gamo, né il testo a stampa dà conto di alcuna sua messa in scena. Il titolo viene in-serito nella cronologia sull’esempio di C. Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origi-ni al 1800, Cuneo, 1990-1994, libretto numero 21591.
4. I libretti consultati si trovano in BCABo, 8 - L. ITAL. COMP. TEATR. D. 2.2 e in BUBo, Aula V Tab. 1 L. 2 168/2.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 275
276
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DATA: 1594 (rappresentazione solo presunta)5
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]TIPOLOGIA: [Commedia dell’arte]LUOGO: Bergamo, sala non identificata.TITOLO: La MirtillaAUTORE: Isabella AndreiniGENERE: PastoraleCOMPAGNIA DI ATTORI: Compagnia dei GelosiATTORI: Isabella AndreiniFONTI: [Opera a stampa], La Mirtilla. Pastorale della signora Isabella An-
dreini comica Gelosa. Di nuovo dall’istessa riveduta et in molti luoghi ab-bellita, Bergamo, Comin Ventura, 15946.
DATA: 1600AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]TIPOLOGIA: [Teatro di attori dilettanti]LUOGO: Bergamo, luogo non identificato.TITOLO: Hercole, cioè rappresentatione della virtù et voluttàAUTORE: Accademici LaboriosiGENERE: Dramma allegorico in versiPERSONAGGI: Fama, Hercole, Coro, Venere, Pallade, Sardanapallo, Te-
seo, Giove, Giunone, Genio d’Ercole, Fatica, Issione, Polluce, Ca-store, Bacco, Re d’Arcadia, consegliero del Re d’Arcadia, ambascia-tore del Re d’Arcadia, Olindo capitano della corte del Re di Gre-cia, Re di Grecia, Consegliero del Re di Grecia, Anteo capitano ge-nerale del Re d’Arcadia, Terra, Virtù.
DEDICATARIO: Gaspare Antonio MartinengoDEDICANTE: Accademici Laboriosi. Dedica: 18 novembre 16007.
5. Come nel caso della Semiramis di Mutio Manfredi non possediamo alcun do-cumento che attesti la rappresentazione a Bergamo della Mirtilla di Isabella Andrei-ni nel 1594, né il testo a stampa dà conto di ciò. In questo caso, però, l’allestimen-to appare più probabile per varie ragioni. Sappiamo, infatti, che nel 1583 i Gelosiavevano tenuto rappresentazioni in città. Inoltre, la pubblicazione dei propri lavo-ri da parte degli attori professionisti aveva spesso la funzione di promuoverne la mes-sa in scena.
6. Il libretto consultato si trova in BNBM, Raccolta Drammatica 6081/6.7. Il dramma è preceduto da alcuni componimenti poetici in onore di Gaspare
Martinengo, ad opera degli accademici: Francesco Manara, Claudio Marchetto, Gio.Antonio Gargano, Agostino Alzano, Francesco Bosone, Francesco Cassotto, Ales-sandro Zanchi, Alessandro Manara.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 276
277
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
ATTORI: Gli accademici Laboriosi8.FONTI: [Testo a stampa], Hercole, cioè rappresentatione della virtù et vo-
luttà. Dagli academici Laboriosi rappresentata e da loro dedicata all’Illu-strissimo Signor Gaspar’Antonio Martinengo conte di Malpaga e di Ca-vernago e marchese di Pianezza, Con licenza de’ Superiori, In Berga-mo, Per Comin Ventura, 16009.
DATA: post 1627–ante 2 novembre 1629AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]TIPOLOGIA: [Teatro dei dilettanti]LUOGO: Bergamo, luogo non identificatoTITOLO: Il trionfo dell’amiciziaAUTORE: Alessandro TerziGENERE: Dramma allegorico con inserti musicali10.PERSONAGGI DEL PROLOGO: Genio dell’autore, Comandamento del
Podestà.PERSONAGGI: Giudizio, Amore, Amicizia, Homero, Eromaco, Filo-
maco, Libertà, Servitù, Religione, Nobiltà, Virtù, Cuore di MarcoTrevisano, Interesse di Marco Trevisano, Dignità veneziana, Cuo-re di Nicolò Bargarigo, Interesse di Nicolò Barbarigo, Historia,Stampa, Amicizia di Nicolò Barbarigo e Marco Trevisano, Poesia,Favola, Dialoghi d’amicizia di Marco Tullio, Dialoghi d’amiciziadi Catone, Foriero della maestà, Diadema reale, Applausi tre, Ap-plauso di Parnaso11.
8. Nella dedica esordiscono nel modo seguente: «Se deve uscir alla vista del mon-do il presente poema recitato da noi, favorito da lei, richiesto da tanti, non deve inmodo alcuno consecrarsi ad altri che all’Illustrissimo nome suo».
9. Il libretto non è segnalato in C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit. Si trovaconservato nella Biblioteca Giacomo Maria Radini Tedeschi di Bergamo e presentail seguente ex libris: «Biblioteca del Clero. S. Alessandro in Colonna. Bergamo». L’im-primatur è posto dopo il frontespizio: «Librum hunc pro mandato mihi munere ad noviindici regulas examinavi. Nihil habet, quin tuto praelo comissus emitti in lucem possit. Lu-dovicus brigientius theologus. Idem F. Iulius Tertius Theol. Ord. S. Francisci Min. Convent.Io. Baptista Episcopus Bergomi. Fr. Pius Lug. Inquisitor. Imprimatur».
10. Il personaggio di Omero canta alcuni versi. Nel corso della rappresentazio-ne è prevista «un’armonia di suono». Alla fine «s’ode una musica d’organi, arpicor-di, tiorbe, cornetti e flauti».
11. Non esiste una tavola dei personaggi, ma si ricavano dalla lettura del testo.Li riportiamo in ordine di apparizione.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 277
278
FRANCESCA FANTAPPIÈ
SCENA: Ambientazione non specificata12.DEDICATARIO: Giulio Valier podestàDEDICANTE: Angelo Trono. Dedica: 2 novembre 162913.FONTI: [Testo a stampa], Alessandro Terzi, Il trionfo dell’amicitia di Ni-
colò Barbarigo e Marco Trivisiano patrici vinitiani. Opera drammaticadel Molto Reverendo Sig. Alessandro Terzi rettore del Seminario di Berga-mo, In Bergamo, Appresso Pietro Ventura, Con Licenza de’ Supe-riori, 162914.
DATA: 1654, gennaioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Sala grande del Palazzo della RagioneTITOLO: Ercole effeminatoAUTORE: Almerico PassarelliCOMPOSITORE: Maurizio CazzatiGENERE: Opera seriaPERSONAGGI DEL PROLOGO: Amore; Bellezza; Valore.PERSONAGGI: Oraldo cortigiano; Laida vecchia; Onfale regina di Li-
dia; Ercole; Mercurio; Alceste pastore; Niso pastore; Celinda da-ma di corte; Sillo paggio della Regina; Eurippe sacerdote.
SCENA: LidiaDEDICATARIO: Francesco MoroniDEDICANTE: Maurizio Cazzati. Data: 2 gennaio 165415.IMPRESARIO: Innocenzo PezzoloFONTI: [Libretto], Ercole effemminato dramma del sig. Almerico Passarel-
li, da rappresentarsi nel Palagio grande di Bergamo, posto in musica dal
12. La rappresentazione si conclude nel modo seguente: «Comparisce allo scen-dere d’una cortina il Monte Parnaso».
13. Il dedicante ricorda al podestà Giulio Valier: «Vostra Signoria Illustrissimaper sollievo dell’animo, mentre esercitava la carica di questo laboriosissimo reggi-mento vide recitata in forma di poema drammatico» il dramma. Sappiamo che il ret-tore rimase in carica tra il 1627 e il 1629. La rappresentazione deve, perciò, essereavvenuta all’interno di questo arco cronologico.
14. Il libretto non è segnalato in C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit. Unacopia è reperibile nella Biblioteca Angelo Mai di Bergamo.
15. È presente l’abituale avvertimento al lettore: «Se t’incontri nelle parole Ado-rare, Fato, Idolo, Paradiso, Deità & in altre simili, ricevile con sentimento da poetae non da Christiano. Vivi felice».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 278
279
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
sign. D. Mauritio Cazzati, dedicato dal medesimo all’illustriss. sig. Fran-cesco Moroni, In Bergamo, Per Marc’Antonio Rossi, Con Licenzade’ Superiori, [1654]16; [Suppliche e delibere] Documenti 1654: 1-2, in Regesto; [Cronaca] Donato Calvi, Effemeride sagro-profana diquanto di memorabile sia successo in Bergamo, sua diocese et territorio da’suoi principii fin’ al corrente anno, Milano, Francesco Vigone, 1676,vol. I, p. 45.
NOTE: Prima del titolo un’immagine (fig. 2).
DATA: 1654, febbraioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Teatro religioso]LUOGO: Bergamo, chiese varie.TITOLO: Oratorio della Santissima CroceAUTORE: Almerico PassarelliCOMPOSITORE: Maurizio CazzatiGENERE: Oratorio in tre parti17.PERSONAGGI: Sant’Elena, angelo, ebreo, sacerdote, morto resuscita-
to, coro di angeli.DEDICATARIO: Annibale AlessandriDEDICANTE: Maurizio Cazzati. Dedica: 26 febbraio 1654.FONTI: [Libretto], Oratorio della Santissima Croce del sig. dot. Almerico
Passarelli, posto in musica dal signor D. Mauritio Cazzati, e rappresen-tato in diuerse chiese nella citta di Bergamo; dedicato al M. Ill. & Rev.moSig. Annibale Alessandri dottor dell’una, & l’altra legge, Canonico dellaCathedrale, & Vicario Generale Episcopale, In Bergamo, per M. An-tonio Rossi, 1654, Con licenza de’ superiori18.
DATA: 1656, gennaioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]
16. Il libretto consultato si trova in BNBM, Raccolta Drammatica 280.17. Tutte e tre le parti sono aperte da una sezione strumentale: la prima da «una
sinfonia grave», la seconda e la terza da «una sinfonia allegra». La prima parte si con-clude con un coro di tre angeli, la seconda con un madrigale a otto voci e la terzacon un madrigale cantato da Sant’Elena e il morto. Tra la seconda e la terza parteviene tenuto un «discorso sopra le grandezze della Santissima Croce» da don Anto-nio Guerini dottore di teologia.
18. Il libretto non è segnalato in C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., ma sitrova conservato nella Biblioteca Ariostea di Ferrara alla segnatura M F 86 15.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 279
280
FRANCESCA FANTAPPIÈ
TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Il GiuseppeAUTORE: Francesco Michel Carrara, Almerico Passarelli.COMPOSITORE: Maurizio CazzatiGENERE:Opera seriaPERSONAGGI DEL PROLOGO: Amore, Fortuna, Destino.PERSONAGGI: Beronica moglie di Putifar capitano generale dell’eser-
cito del re Faraone; Putifar; Giuseppe suo servo; Serilla donzelladi Beronica; Linda vecchia; Lesbino paggio di Beronica; Faraonere d’Egitto; Arante capitano della guardia di Faraone; Filosofo; Bo-tigliero; Pistore; Florindo paggio di Faraone; Guardiano delle car-ceri; Pastorello in habito da cacciatore; Soldato solo; Guardia diFaraone; Soldati di Atante; Corteggio del re Faraone; Volontà.
SCENA: EgittoCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Giardino; Reggia con prospetto serra-
to; Prospetto aperto; Palaggio serrato; Prigione19.DEDICATARIO: Giovan Battista PelliccioliDEDICANTE: Maurizio Cazzati. Dedica: Bergamo 15 gennaio 1656.DESCRIZIONE DEGLI INTERMEZZI: «Ballo de’ ninfe con Satiro. Per in-
termedio nel Bosco» (primo intermezzo); «Tartaglia in habito di cac-ciatore loda il bosco e biasima la corte» (secondo intermezzo)20.
FONTI: [Libretto], Il Giuseppe. Dramma musicale degli Eccellentissimi Si-gnori Dottori Francesco Michel Carara di Bergamo e Almerico Passarelliferrarese. Posto in musica dal signor don Mauritio Cazzati e dedicato al-l’Illustrissimo Signor Giovan Battista Pelliccioli. Rappresentato in Berga-mo l’anno 1656, In Bergamo, Per Marc’Antonio Rossi, 1656, ConLicenza de’ Superiori21; [Cronaca] Donato Calvi, Effemeride sagro-profana, cit., vol. I, p. 45.
DATA: 1659, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]
19. Non esiste una tavola iniziale delle scene che si ricavano dalle didascalie in-terne al testo.
20. Tartaglia parla in lingua italiana e in rima. Come personaggio compare solonel testo, ma non è compreso nell’elenco iniziale.
21. Libretto conservato in BCMR, Carvallais 7675.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 280
281
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’EgistoAUTORE: Giovanni FaustiniCOMPOSITORE: [Francesco Cavalli]GENERE: Opera seria con intermezzi ridicoli22.PERSONAGGI PER IL PROLOGO: La Notte; L’Aurora.PERSONAGGI PER L’OPERA: Lidio amante di Clori; Clori innamorata
di Lidio; Egisto acceso di Clori; Climene infiammata di Lidio; Ip-parco fratello di Climene; Volupia, Bellezza; Amore; Venere; Se-mele; Fedra; Didone; Hero; Cinea servo d’Ipparco; Apollo; Ore 4ministre d’Apollo; Dema vecchia; Le Grazie e coro di Amorini (ta-citi seguaci di Venere); Coro di Heroide morte infelicemente perAmore; Coro di servi armati d’Ipparco; Coro di serve di Climene.
SCENA: Contado di Zacinto, isola del mare Ionio, nella stagione diprimavera.
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Scena boscareccia; Palaz-zo di Venere. Atto secondo: Scena boschereccia; Selva di mirti del-l’Erebo. Atto terzo: Scena boschereccia; Scena marittima.
DEDICATARIO: Bartolomeo MartinengoDEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista Abbatoni. Data: Bergamo,
14 gennaio 1659.FONTI: [Libretto], L’Egisto favola dramatica musicale di Giovanni Fausti-
ni rappresentato dal signor Gio. Battista Abbatoni, dedicato all’Illustriss.Sig. Colonello Bartolomeo Martinengo, In Bergamo, 1659, Per gl’He-redi di Marc’Antonio Rossi, Con licenza de’ Superiori23.
DATA: 1659, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’IrbenoAUTORE: Giorgio Jacopo AlcainiCOMPOSITORE: Autore non specificatoGENERE: Intermezzo musicale ridicoloPERSONAGGI: Irbeno ortolano amante di Lisetta; Dema vecchia aman-
te d’Irbeno, Lisetta.
22. Intermezzi intitolati L’Irbeno cfr. voce successiva.23. Il libretto consultato si trova in BCBg, Salone Loggia M 6 57 (1).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 281
282
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DEDICATARIO: Pietro Duodo podestàDEDICANTE: Giorgio Jacopo Alcaini. Dedica: Bergamo, 14 gennaio
1657.FONTI: [Libretto], L’Irbeno, piacevole & redicolo Intermedio di Giorgio Gia-
copo Alcaini rappresentato nell’Egisto dal signor Gio. Battista Abbatoniet consacrato all’Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Pietro Duodo po-destà di Bergamo, In Bergamo, 1659, Per gli Heredi di Marc’Anto-nio Rossi, Con licenza de’ superiori24.
DATA: [1660]25
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Le fortune di Rodope e DamiraAUTORE: Aurelio AureliCOMPOSITORE: Pietro Andrea ZianiGENERE: Opera con balliPERSONAGGI DEL PROLOGO: Il Diletto; La Lascivia; Giunone; Hime-
neo.PERSONAGGI: Rodope innamorata di Nigrane; Creonte re d’Egitto in-
namorato di Rodope; Damira moglie di Creonte creduta affogatanel Nilo, sotto nome di Fidalba; Nigrane cavaliero privato di cor-te amante di Rodope; Brenno generale dell’armi d’Egitto acceso diRodope; Lerino paggio di Rodope; Sicandro cortegiano favoritodel Re; Bato villano; Nerina vecchia moglie di Bato; Erpago pittordi corte; Coro di Egitto con Rodope; Coro di mori; Coro di ar-mati con Brenno.
SCENA: MenfiCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Campagna di vendem-
mia; Galeria che introduce ai gabinetti di Rodope; Atto secondo:Cortile del Palagio Reale su la di cui prospettiva dipinto si vedel’accidente occorso a Damira nel Nilo; Tumulo eretto in memoria
24. Il libretto consultato si trova in BCBg, Salone Loggia M 6 57 (2).25. La data si ricava dalla constatazione che i nomi degli interpreti sono identi-
ci a quelli di un altro allestimento della medesima opera avvenuto a Milano nel 1660cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretto 10810. L’impresario Giovan Bat-tista Abbatoni è, invece, lo stesso dell’Egisto e dell’Irbeno, rappresentati a Bergamonel Carnevale del 1659, per i quali si rimanda alle relative voci.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 282
283
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
di Damira creduta affogata nel Nilo; Atto terzo: Cortile di Erpa-go pittor di corte; Prigione orrida26.
DEDICATARIO: Ludovico ZenniDEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista AbbatoniCANTANTI: Anna Felicita Chiusi (Rodope), Pellegrino Canneri (Creon-
te), Virginia Camuffi (Damira), Francesco Maria Rascarini (Nigra-ne), Giacomo Filippo Biella (Brenno), Antonio Rossi (Lerino), An-tonio Secondo (Sicandro), Giovan Battista Ferrari (Bato), GiovanniBotti (Nerina), Antonio Franceschini (Erpago).
TITOLO DEI BALLI: «Ballo della mascherata» (primo ballo); «Ballo de’pazzi» (secondo ballo).
FONTI: [Libretto], Le fortune di Rodope a Damira. Drama per musica diAurelio Aureli. Favola terza. Fatta rappresentare dal signore Gio. Batti-sta Abbatoni in Bergamo. Dedicata all’Illustriss. Signor Ludovico Zen-ni, In Milano nella R. D. C., per Giulio Cesare Malatesta stampa-tore R. C., Con licenza de’ Superiori27; [Cronaca] Donato Calvi,Effemeride sagro-profana, cit., vol. I, p. 45.
DATA: 1660, agostoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]TIPOLOGIA: [Commedia dell’arte]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA DI ATTORI: Compagnia di Federico GabrielliATTORI: Federico Gabrielli (Mario, innamorato); Girolamo Gabrielli
(Pantalone, secondo vecchio).FONTI: [Documento epistolare], Documento 1660: 1, in Regesto.
DATA: 1662, luglio (rappresentazione presunta)28
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]TIPOLOGIA: [Teatro di dilettanti]LUOGO: Bergamo, luogo non identificato.TITOLO: Eraclito consolato
26. I cambi di scena si traggono dalle didascalie del testo, in quanto non esisteuna tavola iniziale.
27. Il libretto consultato è conservato in BUBo, Aula V, Tab. I, E. III, 18 A (4).28. Nel testo, infatti, non si fa riferimento esplicito ad alcuna rappresentazione
dell’opera.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 283
284
FRANCESCA FANTAPPIÈ
AUTORE: Alessandro Terzi29
GENERE: Tragicommedia in due atti con interventi musicali.PERSONAGGI: Heraclito; Democrito; Ruffino; Toni; Tognaz; Ghilo-
rem; Pavolaz/Paolaz; Lorenzo; Il pedante; Mirtillo; Amarilli30.DEDICANTE: Francesco Terzi. Dedica: 12 luglio 166231.FONTI: [Testo a stampa], Heraclito consolato. Dramma del signor Alessan-
dro Terzi canonico teologo, In Bergamo, Per li figliuoli di Marc’Anto-nio Rossi, Con licenza de’ Superiori [1662]32.
DATA: 1664, 5 agosto-14 settembre 1664 circaAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]TIPOLOGIA: [Commedia dell’arte]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA DI ATTORI: Compagnia di Giuseppe FialaTITOLO DELLE OPERE RAPPRESENTATE: Li tre finti turchi (12 agosto).ATTORI: Marzia Narici Fiala (Flaminia, innamorata); Ippolita Gabriel-
li (Ippolita, innamorata); Agostino Grisanti (Mario, innamorato);Francesco Calderoni (Silvio, innamorato); Giuseppe Fiala (CapitanSbranaleoni, capitano); Giovan Battista Paghetti (Dottore, primo vec-chio); Pantalone, secondo vecchio; Tabarrino, zanni; Giovan Batti-sta Verzelli (Bagolino, zanni); Colombina, serva.
SCENOGRAFO: Verigola (apparatore), Carlazzo Calderoni (trovarobe).FONTI: [Documenti epistolari], Documento 1664: 1, in Regesto; Let-
29. A c. 9 si legge: «Alessandro Terzi canonico accademico, fra gli Eccitati il Fu-race e fra gli Erranti l’Invigorito».
30. Non esiste una tavola di personaggi, i quali si ricavano dalla lettura del te-sto. Solo Eraclito e Democrito parlano in italiano. Il Pedante in italiano e latino.Paolaz in dialetto bergamasco e latino maccheronico. Mirtillo e Amarilli cantano ac-compagnati da un «chitarone» due componimenti poetici (c. 23). Tutti gli altri si espri-mono in dialetto bergamasco. Tra questi ultimi, però, Ruffino si presenta nel fina-le, elogiando in perfetto italiano la figura di Gregorio Barbarigo e annunciando lacostruzione di una statua in suo onore (c. 25). Al termine del suo discorso «si odo-no trombe e musici suoni» (c. 26). Il testo è concluso da alcuni componimenti poe-tici in lode del cardinale (cc. 28-32).
31. Secondo Francesco Terzi, nipote dell’autore, l’opera ha come fine quello di«celebrare le lodi del cardinale Barbarigo». La pubblicazione è postuma in quantoAlessandro Terzi muore il 6 gennaio 1662. Il dedicante decide di mandarla alle stam-pe, affinché «ad un fondo di cassa» non «resti condannata».
32. Il libretto si trova conservato in BAM, S. I. G. I. 16 (4). In interlinea, tra iltitolo e lo stampatore, si legge manoscritto: «Cappuccini di Bergamo».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 284
285
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
tera di Giovan Battista Paghetti a Ippolito Bentivoglio, Cremona24 luglio 1664; Lettera di Giovan Battista Paghetti a Ippolito Ben-tivoglio, Bergamo 5 agosto 1664; Lettera di Francesco Calderoni aIppolito Bentivoglio, Bergamo 6 agosto 1664; Lettera di GiuseppeFiala a Ippolito Bentivoglio, Bergamo 6 agosto 1664; Lettera diFrancesco Calderoni a Ippolito Bentivoglio, Bergamo 13 agosto1664; Lettera di Giovanni Albani a Gaspare Martinengo, Bergamo20 agosto 1664; Lettera di Marzia Fiala a Ippolito Bentivoglio, Ber-gamo 20 agosto 1664; Lettera di Giovan Battista Paghetti a Ippo-lito Bentivoglio, Bergamo 3 settembre 1664; Lettera di Orazio Ca-nossa a Ippolito Bentivoglio in Ferrara, Mantova 14 settembre1664 in S. Monaldini, L’orto dell’Esperidi. Musici, attori e artisti nelpatrocinio della famiglia Bentivoglio (1646-1685), Lucca, 2000, pp.196-205.
DATA: 1667AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «Teatro novissimo».TITOLO: La DoriAUTORE: [Apollonio Apolloni]COMPOSITORE: [Marc’Antonio Cesti]GENERE: Opera seriaPERSONAGGI DEL PROLOGO: Apollo; Inganno; Invidia; Amore33.PERSONAGGI: Dori figlia d’Archelao re de’ Niceni creduta figlia di Ter-
modoonte re d’Egitto, finta schiavo sotto nome d’Ali, sposad’Oronte; Oronte re de’ persi marito di Dori; Artaserse satrape delgovernoe tutore d’Oronte; Arsinoe prencipessa figlia d’Archelao rede’ Niceni stabilita moglie ad Oronte; Tolomeo prencipe figlio diTermodonte re d’Egitto creduto fratello a Dori, sotto habito di fe-mina, con il nome di Celinda; Arsete aio di Dori; Erasto capita-nio, amante di Tolomeo creduto Celinda e seguace di Dori; Dircevecchia nutrice d’Arsinoe; Golo servo sciocco d’Oronte e custodedel serraglio; Ombra di Parisatide fu madre d’Oronte.
SCENA: Babilonia.
33. I personaggi allegorici compaiono nel modo seguente: «Apollo in machina.Inganno entro una nube. Invidia sorgendo dall’Inferno. Amore che sopraggiunge».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 285
286
FRANCESCA FANTAPPIÈ
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Riva dell’Eufrate; Serra-glio di Babilonia; Atto secondo: Giardino sotto il serraglio; Attoterzo: Piazza di Babilonia; Cortile34.
DEDICATARIO: Sebastiano Giustiniani castellano.DEDICANTE/IMPRESARIO: Tobia ManganoniTITOLO DEI BALLI: «Ballo d’eunuchi» (primo ballo); «Ballo de’ tode-
schi e una todesca» (secondo ballo)35.FONTI: [Libretto], La Dori. Drama per musica da rappresentarsi nel teatro
novissimo di Bergamo. Dedicata all’illustrissimo signor Patron Colendis-simo il signor Sebastiano Giustiani castellano, In Bergamo MDCLXVII,Per li Figliuoli di Marc’Antonio Rossi, Con licenza de’ Superiori36;[Cronaca] Donato Calvi, Effemeride sagro-profana, cit., vol. I, p. 45.
DATA: 1667, post 9 aprile.AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’OronteaAUTORE: Giacinto Andrea CicogniniCOMPOSITORE: [Marc’Antonio Cesti]GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Orontea regina d’Egitto; Creonte filosofo aio di Oron-
tea; Silandra dama di corte; Corindo cavaliero di corte; Gelone buf-fone; Tibrino valletto; Aristea vecchia; Alidoro creduto figlio d’Ari-stea che si scopre esser Floridano figlio di Sidonio re de’ Fenici;Giacinta schiava in abito di maschio sotto nome d’Ismero.
SCENA: PafoCAMBI DI SCENA: 1. Giardino delizioso; 2. Cortile; 3. Sala; 4. Galle-
ria; 5. Giardino; 6. Sala Regia37.DEDICATARIO: Gasparo Giacinto MartinengoDEDICANTE/IMPRESARIO: Domenico di Tobia Manganoni. Dedica:
Bergamo 9 aprile 1667.
34. Non esiste una tavola delle scene. Le notizie si ricavano dalle didascalie dellibretto.
35. Non esiste una tavola dei balletti. Le notizie si ricavano dalle didascalie dellibretto.
36. Il libretto si trova conservato in BRNo, 782 DOR DIR.37. I numeri sono nell’originale.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 286
287
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
FONTI: [Libretto], L’Orontea. Drama musicale del Sig. D. Hiacinto An-drea Cicognini academico Instancabile di nuovo ristampata e rappresen-tata in Bergomo l’anno 1667. Dedicata all’Illustriss. et Eccell. Gasparo Gia-cinto Martinen[go] marchese di Pianezza, conte di Cavenago signore diOriano &c., In Milano, Appresso Lodovico Monza, [1667]38.
DATA: 1668, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’Annibale in CapuaAUTORE: [Nicolò Beregani]39
COMPOSITORE: [Pietro Andrea Ziani]GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Annibale, capitano dei Cartaginesi; Artanisba, figlia di
Siface re de’ Numidi; Emilia, donzella romana figlia di Paolo Emi-lio consolo amante di Floro; Floro figlio di Pacunio, amante d’ Emi-lia; Pacunio, principe del senato capuano padre di Floro; Dalisa,vecchia scudiera d’Artanisba; Glibo, servo faceto di Floro; Maher-bale, generale della cavalleria; Bomilcare, capitano delle squadreNumide; Arbaste, conduttore degl’elefanti; Alcea, maga; Cadave-re, incantato che parla; Ombra d’Amilcare padre d’Asdrubale.
CORI: Di soldati; Di arcieri; Di mori; Di Damigelle; Di Cavalieri ar-mati con lancia.
CAMBI DI SCENA: Atto primo: Piazza Reale con archi trionfali fregia-ta di trofei e militari insegne, ove si guida il trionfo; Campo di bat-taglia, ove sta squadronato l’esercito africano con padiglioni e or-dinanza d’elefanti; Stanze, ove riposta Annibale; Selva con grottemagiche e cielo notturno con luna piena. Atto secondo: Giardinodelizioso con logge e fontane sopra le sponde del fiume Volturno
38. Libretto si trova conservato in BNBM, Raccolta Drammatica 1526 (esem-plare mutilo) e in BCMM, Libretti Q. 97. Dopo il frontespizio segue «Imprimatur.Commissarius Sancti Officij Mediolani. Carolus Ghioldus Canonicus Theologus S. Nazarijpro Eminentissimo & Reverendissimo D. D. Cardinali Litta Archiepisc. Franciscus Arbonapro Excellentiss. Senatu».
39. Nicolò Beregani è autore del testo nelle edizioni di Venezia (1661), Ferrara(1665), Milano (1666), Bergamo (1668), Bologna (1668), mentre Ippolito Bentivo-glio di quelle di Ferrara (1665), Viterbo (1671) e Francesco Sbarra di quelle di Luc-ca (1675, 1676), cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 2030 – 2040.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 287
288
FRANCESCA FANTAPPIÈ
da cui spunta il sole nascente. Campagna di canne piena di cada-veri e di straggi irrigata dal fiume aufido. Boschetto d’allori con pe-schiere e cadute d’acque. Scogli dirupati che spuntano sovra il ma-re. Atto terzo: Appartamenti regii d’Emilia. Cortile reale. Sala illu-minata con torce e lumiere pendenti.
DEDICATARIO: Leonardo Loredan podestàDEDICANTE/IMPRESARIO: [Domenico di Tobia Manganoni]FONTI: [Libretto], L’Annibale in Capua. Melodramma rappresentato a Ber-
gamo l’anno 1668. Consegrato all’Eccellenza del signor Leonardo Lore-dano podestà di essa città, Bergamo, MDCLXVIII, Per gl’heredi diMarc’Antonio Rossi, Con licenza de’ Superiori40; [Cronaca] Do-nato Calvi, Effemeride sagro-profana, cit., vol. I, p. 45.
NOTE: Prima del titolo un’immagine (fig. 3).
DATA: 1668, Carnevale41
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La prosperità di Elio SeianoAUTORE:[Niccolò Minato]COMPOSITORE: Antonio Sartorio «maestro di cappella del serenissi-
mo di Bransuich».GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Tiberio Imperatore; Elio Seiano suo favorito; Livia;
Germanico suo fratello; Agrippina; Gaio Cesare; Ligdo confiden-te di Seiano42; Plancina vecchia con Agrippina; Eudemo paggio con
40. Il libretto consultato si trova in BCBg, Sala 32 D 2 5 (1).41. Secondo quanto registrato nel prefazione del libretto, intitolata «a chi legge
in Bergamo» (c. 11), la rappresentazione della Prosperità di Seiano è successiva a quel-la dell’Annibale in Capua: «Havendo goduta Seiano la Prosperità della sua fortuna,non men nell’inclita città di Venezia l’anno 1667, che nel tempo di Tiberio in Ro-ma, chi le vive affettuoso, vuol procurargliela anco in questa nobilissima città di Ber-gamo. Nella presente congiuntura, però che tanti virtuosi musici per recitare la fa-mosissima opera dell’Annibale in Capua in questa città si ritrovano, negli ultimi gior-ni di Carnevale viene stimata opportuna occasione, o lettore, farti il medesimo dra-ma sopra queste scene vedere».
42. Secondo quanto registrato nel prefazione del libretto, intitolata «a chi leggein Bergamo» (c. 11), per rendere il melodramma «più grato» al pubblico, venne «tra-mutata la parte di Ligdo confidente, in servo faceto di Seiano».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 288
289
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
Agrippina; Ombra di Druso che fu marito di Livia e fu fatto ave-lenar da Seiano; Coro di soldati pretoriani; Coro di servi; Coro didamigelle; Coro di cavalieri; Coro di popolo; Coro di paggi.
SCENA: Roma e «luochi suburbani di essa»43.CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Sala reale; Villa delitiosa confina col
Monte Celio44; Cortile; Campagna45; Giardino; Stanze46; Luogo de-litioso con Logge; Sala regia.
DEDICATARIO: Pietro Dolfin capitanioDEDICANTE/IMPRESARIO: Domenico di Tobia Manganoni. Dedica:
18 gennaio 166847.TITOLO DEI BALLI: «Di genti che hanno ammorzato l’incendio del
Monte Celio» (primo ballo)48; «Di soldati pretoriani per allegrezzadelle prosperità di Seiano» (secondo ballo)49.
FONTI: [Libretto], La prosperità di Elio Seiano dramma per musica rap-presentata in Bergamo l’anno 1668. Consegrata all’eccellenza del signorPietro Dolfino capitanio di essa città, In Bergamo, Per li figliuoli di Mar-c’Antonio Rossi, 1668, Con licenza de’ Superiori50; [Cronaca] Do-nato Calvi, Effemeride sagro-profana, cit., vol. I, p. 45.
NOTE: Prima del titolo un’immagine (fig. 4).
DATA: 1672, post 13 giugnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]
43. Il libretto è aperto da un’immagine che si riferisce all’atto III, scena X: «Ca-de un volto di loggia, sotto la quale si trova Tiberio. Seiano si sottopone e lo sosten-ta fin che Tibero esce salvo».
44. Atto I, scena XI si legge: «Villa delitiosa fuori di Roma con siti d’acque aca-denti, confina col Monte Celio».
45. Atto II, scena VIII si legge: «Campagna delitiosa fuori di Roma».46. Atto III, scena I si legge: «Stanze reali».47. Domenico di Tobia Mangaoni è molto probabilmente anche l’impresario.
L’opera è sicuramente a pagamento. Nella prefazione del libretto gli spettatori ven-gono invitati alla rappresentazione nel modo seguente: «Se più d’uno però s’è affa-ticato a dilettarti, fa tu ancora la parte tua col frequentemente portarti all’opera, ac-ciò il titolo della medesima, che in Venetia fu rappresentata per prima, a total pre-giuditio di chi con tanto rischio spende, in quello della seconda, sfortunatamentenon si muti. E vivi felice».
48. Nel libretto si legge: «Otto persone con tizzoni di fuoco in mano fanno unballo».
49. Nel libretto si legge: «Vengono otto servi facendo un ballo».50. Il libretto si trova conservato in BRNo, 782 MIN.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 289
290
FRANCESCA FANTAPPIÈ
LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA: Capocomico Odoardo PalazziATTORI: Odoardo Palazzi, Antonia Isola Torri (Lavinia), Dottore.FONTI: [Documenti epistolari], Lettera di Odoardo Palazzi a Ippoli-
to Bentivoglio, Bergamo 12 giugno 1672; Lettera di Vicenzo Gri-mani Calergi a Ippolito Bentivoglio, Venezia 25 giugno 1672, in S.Monaldini, L’orto dell’Esperidi, cit., p. 274.
DATA: 1674, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «Nuovo Teatro» in legno sotto la loggia del Palaz-
zo della Ragione.TITOLO: L’ArgiaAUTORE: Giovanni Apollonio ApolloniCOMPOSITORE: Marc’Antonio CestiGENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Atamante re di Cipro; Doriste sua figliola; Feraspe prin-
cipe di Negroponte; Argia principessa di Negroponte sorella di Fe-raspe sotto nome di Laurindo in abito da paggio; Lucimoro figliod’Atamante creduto Selino figlio del re dei Traci; Solimano servodi Selino; Aceste servo di Feraspe; Filaura cantatrice di corte; Osma-no vecchio pastore; un bambino; Venere.
COMPARSE: Di soldati con Atamante; Di scocchi con Doriste.CORI: MarinaiSCENA: Salamina, città di Cipro.MUTAZIONI DI SCENE: [Atto primo]: Porto di mare con la fortezza
di Salamina; Stanze regie; Cortile con stanze di Filaura; Atto se-condo: Machine di Venere nel cortile ad uso di tempio; GiardinoReale; Corte regia; Atto terzo: Città con prigione; Anfiteatro; Sa-la Regia.
DEDICATARIO: Conte Antonio AlbaniDEDICANTE/IMPRESARIO: Pietro Manni. Dedicante: 10 dicembre
1673.BALLI: Di Covielli; Di Schiavi.FONTI: [Libretto], Argia. Drama musicale da rappresentarsi nel Nuovo Tea-
tro di Bergamo. Dedicata al merito degnissimo dell’Illustrissimo SignorConte Antonio Albano, Milano, per Gioseppe Gariboldi, Con licen-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 290
291
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
za de’ superiori, [1673]51; [Registrazioni contabili], Documenti1673: 1 e 5, in Regesto.
DATA: 1675, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, [teatro provvisorio in legno sotto la loggia del Pa-
lazzo della Ragione].TITOLO: Eurimedonte principe d’Egitto52
AUTORE: «Una penna erudita»COMPOSITORE: Compositore non specificato.GENERE: Opera con intermezzi.PERSONAGGI: Eurimedonte prencipe d’Egitto amante di Laodicea;
Eritrea creduta morta sotto nome di Periandro suo fratello gemel-lo re dell’Assiria; Therramene principe assiro successore del regnoe sposo ad Eritrea creduta morta; Laodicea regina della Fenicia pro-messa in sposa ad Eritrea creduta Periandro; Dione generale del-l’armi di Pierandro; Niconida satrapo del regno Assiro e aio d’Eri-trea; Misenna nudrice di Laodicea; Aurilla damigella di Laodicea;Lesbo paggio di Therramene; Trinano servo d’Eurimedonte; File-no pescatore Fenicio.
COMPARSE: Soldati Arcieri con Periando; Soldati Assiri con Dione;Soldati Fenici con Laodicea.
SCENA: Sidone metropoli della Fenicia.CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Bosco con spiaggia di ma-
re tempestoso; Sala regia; Stanze d’Eritrea; Atto secondo: Atrio rea-le; Boschetti ameni; Giardino reale; Atto terzo: Città di Sidone;Gabinetti di Missena; Campo d’armi egizie.
DEDICATARIO: Conte Girolamo Benaglio
51. Il libretto consultato si trova conservato in BCBg, Sala 32 D 2 5 (2).52. La rappresentazione bergamasca del Carnevale 1675 è l’unica rappresenta-
zione attestata per quest’opera. In merito all’autore qualche indizio viene fornitodalla dedica, nella quale Pietro Manni fa riferimento all’uso di un testo «antico» cuisono stati apportati numerosi aggiustamenti per adattarlo al gusto dei contempora-nei: «Questo Drama ha avuto origine da una penna erudita, in tempo che non mol-to si accostumavano varietà di canzonette, ma totalmente si appoggiavano ad unperfetto recitativo; onde per adattarla all’uso corrente è convenuto farvi molte agion-te di diverse ariette».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 291
292
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DEDICANTE/IMPRESARIO: Pietro Manni. Dedica: Bergamo, 23 gen-naio 1675.
FONTI: [Libretto], Eurimedonte prencipe d’Egitto. Drama musicale nel tea-tro di Bergamo l’anno 1675. Dedicato all’Illustrissimo Signor Conte Gi-rolamo Benaglio feudatario di Sanguineto e cavaliere di S. Stefano, In Ber-gamo, 1675. Per li Figliuoli di Marc’Antonio Rossi, Con licenza de’Superiori53.
NOTE: Prima del titolo è presente un’immagine54.
DATA: 1675, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, [teatro provvisorio in legno sotto la loggia del Pa-
lazzo della Ragione].TITOLO: Marcello in SiracusaAUTORE: Matteo NorisCOMPOSITORE: [Giovanni Antonio Boretti]GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Marcello capitano de’ romani; Celia sua moglie fatta
schiava in Siracusa; Fabio e Lentulo capitani romani; Fulvio infan-te figlio di Marcello e prigioniero con Celia; Varrone duce dellacavallaria; Un soldato romano; Ierone re tiranno di Siracusa; Vir-ginia sua figlia; Archimede geometra sirucusano; Nicia capitano del-le squadre siracusane; Birena nutrice di Verginia. Sillo servo di cor-te.
SCENA: [Siracusa]CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Riviera del porto di Sira-
cusa con tre rocche55; Reggia di Siruacusa; Campo d’armi romane;Giardino reale. Atto secondo: Solitudine deliziosa; Sala Reale; Lo-co disabitato con antro cavarnoso. Atto terzo: Stanze nel palagiodi Ierone; Campo de’ romani con padiglioni; Appartamenti d’Ar-chimede.
53. Il libretto consultato si trova in BAM, S. I. G. I. 16 (1).54. L’immagine raffigura Eurimedonte e si trova riprodotta in L. Pilon, Il teatro
della Società, cit., p. 7.55. La descrizione completa è: «Riviera del porto di Siracusa con tre rocche. Ar-
mata navale di Marcello. Su la cima d’altissima rocca Archimede con il concavo ve-tro. Nel cielo il Sole, su la riviera Ierone re spettatore alla machina».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 292
293
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DEDICATARIO: Conte Roberto figlio di Bartolomeo MartinengoDEDICANTE/IMPRESARIO: Paolo Manni. Dedica: Bergamo, 15 feb-
braio 1675.FONTI: [Libretto], Marcello in Siracusa. Dramma per musica nel Teatro di
Bergamo di Matteo Noris. Consecrato all’Illustrissimo Signor Co. Ruber-to figliuolo dell’illustrissimo signor conte Bartolomeo Martinengo, In Ber-gamo, per li Fratelli Rossi, 1675, Con licenza de’ Superiori56.
DATA: 1677, settembreAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, teatro di fiera.COMPAGNIA: Compagnia non identificataFONTI: [Registrazione contabile], Documento 1677: 1, in Regesto.
DATA: 1678, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Semiramide regina d’AssiriaAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Compositore non specificato.GENERE: Opera seria con intermezzi ballati.PERSONAGGI: Nino re dell’Assiria; Semiramide sua madre; Creonte
re di Babilonia ribelle; Elvida sua figlia schiava e amante di Ninosotto nome Ifide; Ireo generale di Semiramide; Eliso aio di Nino;Eurillo paggio di corte; Clitarco servo d’Ireo; Bellona su carro vo-lante; Marte in machina; Coro di soldati57.
CAMBI DI SCENA: Atto primo: Giardino con statue, fontane e gabi-netti reali; Cortile regio con statue; Sala regia con lontanza di ca-mere; Campo di battaglia con machine da guerra &c.; Atto secon-do: Bosco; Città; Padiglioni con città assediata; Prigioni; Loco de-serto col fiume Tigri; Atto terzo: Sala regia con sfondo di camere;Cortile regio; Piazza e fontane.
56. Il libretto consultato si trova in BAM, S. I. G. I. 11 (2).57. I personaggi sono gli stessi di un’altra Semiramide di autore e compositore in-
certi, nella quale mancano solo Clitarco e Marte, opera rappresentata a Lucca nel1682, cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretto 21480.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 293
294
FRANCESCA FANTAPPIÈ
TITOLO DEI BALLI/INTERMEZZI: «Ballo di soldati» (primo); «Ballo diNaiadi ch’escono dal Tigri» (secondo).
DEDICATARIO: Conti Trussardo Calepio e Grandilia MartinengoDEDICANTE: Antonio Morone58. Dedica: 30 dicembre 1677.FONTI: [Libretto], Semiramide regina d’Assiria. Drama per musica da rap-
presentarsi nel teatro di Bergamo l’anno 1678 consegrato agli Ill.mi Sig.rico. Trussardo di Calepio et Grandilia Martinenga iugali, In Milano,Nella Stampa de’ fratelli Camag. vicino alla chiesa della Rosa, ConLicenza de’ Superiori59.
DATA: 1678, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identficatoTITOLO: Elena rapitaAUTORE: [Aurelio Aureli]COMPOSITORE: [Gian Domenico Freschi]GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Helena moglie di Menelao re di Sparta amante rapita
di Paride; Paride principe troiano; Enone ninfa troiana amante tra-dita da Paride; Euristene pastore innamorato di Enone; Arminoecavaliero troiano amico di Paride; Elisa vecchia nutrice d’Enoneamica d’Euristene; Desbo servo d’Arminoe; Ersilo fianciullo figliod’Enone (personaggio muto); Amore (personaggio muto).
SCENA: Isola Fenice hoggidì detta Tenedo poco lontana da Troia.CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Palagio d’Enone che cor-
risponde sul mare con Troia lontano; Boschetto delitioso di plata-ni; Salone d’antico palagio reale disabitato; Atto secondo: Grotte-sca deliziosa con fontane nel palagio d’Enone; Stanze d’Enone; At-to terzo: Giardino; Appartamenti terreni d’Enone; Sala contiguaalle stanze d’Enone.
58. Il quale si firma sotto l’anagramma di Eronio Montano, dedicatario dell’Ele-na rapita rappresentata lo stesso Carnevale.
59. I libretti consultati si trovano in BCBg, Salone Loggia M 6 57 (4) e BNBM,Raccolta Drammatica 1348. Presente il seguente imprimatur: «Fr. Antonius Maria Cru-ceius sac. th. magister & commissarius S. Offitijs Mediolani. Iacobus Saita canoni-cus S. Ambrosij pro Eminentiss. D. card. archiep. Franciscus Arbona pro Excellen-tiss. Senatu».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 294
295
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DEDICATARIO: Vittorio Maria FugazzaDEDICANTE: Antonio Morone. Dedica: Bergamo, 30 gennaio 1678.FONTI: [Libretto], Helena rapita da Paride. Drama per musica nel theatro
di Bergamo l’anno 1678. Consacrato all’Illustrissimo Signor Vittorio Ma-ria Fugazza, In Bergamo, Per li Rossi, 1678, Con licenza de’ Supe-riori60.
DATA: 1680, post 16 luglioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Teatro religioso]LUOGO: Bergamo, oratorio del Duomo.TITOLO: La vittoria di David contro GoliaAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Giovan Battista QuagliaGENERE: OratorioPERSONAGGI: Testo, Golia, Saul, David, Coro, Coro di donzelle.DEDICATARIO: Giacomo Pezzoli canonicoDEDICATANTE: Giovan Battista Quaglia. Data: Bergamo, 16 luglio
1680.FONTI: [Libretto], La vittoria di David contro Golia. Oratorio in musica
di Gio. Battista Quaglia mastro di capella di S. Maria Maggiore dedica-to al merito dell’Illustrissimo Signor Canonico Giacomo Pezzoli. Da can-tarsi la domenica susseguente a S. Maria Madalena nell’Oratorio del Duo-mo, In Bergamo, Per li fratelli Rossi, 1680, Con licenza de’ supe-riori61.
DATA: 1683, 2 ottobreAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, casotto in fiera.COMPAGNIA: Compagnia non identificata.FONTI: [Registrazione contabile], Documento 1683: 4, in Regesto.
DATA: 1684, post 12 luglioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]
60. Il libretto consultato si trova in BAM, S. I. G. I. 5 (4).61. Consultati i libretti in BCBg, 20 R 16 (13) e in BAM, S. I. F. V. 29 (4). Que-
st’ultimo riporta manoscritto, sotto il frontespizio, il seguente ex libris: «Ad usum D.Jo. Jacobi Guerrini».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 295
296
FRANCESCA FANTAPPIÈ
LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA: Compagnia protetta dal principe Alessandro Farnese.FONTI: [Documenti epistolari], Documenti 1684: 1-2, in Regesto.
DATA: 1685AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Spettacolo encomiastico]LUOGO: Bergamo, luogo non identificato.TITOLO: Il trionfo della gloria nelle mestizie del BrennoAUTORE: Antonio GrumelloCOMPOSITORE: Giovan Battista BreviGENERE: Accademia letteraria con inserti musicali.PERSONAGGI: Fama, Gloria, Brenno.DEDICATARIO: Giorgio Cocco capitanio di BergamoFONTI: [Libretto], Il trionfo della Gloria nelle mestitie del Brenno. Pubbli-
cato con armonici applausi dalla fama in occasione dell’accademia fattadal sig. conte Antonio Grumello per la prossima partenza da questo reggi-mento dell’Illustriss. & Eccell. Sig. Giorgio Cocco capitanio di Bergamo.Posto in musica dal signor Gio. Battista Brevi mastro di capella del Duo-mo di Bergamo, In Bergamo, MDCLXXXV, Per li fratelli Rossi, ConLicenza de’ Superiori62.
DATA: 1685, settembreAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, casotto in fiera.COMPAGNIA: Compagnia non identificata.FONTI: [Registrazione contabile], Documento 1685: 1, in Regesto.
DATA: 1687, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Secco Suardo.TITOLO: Il Clearco in NegroponteAUTORE: [Antonio Arcoleo]COMPOSITORE: Domenico GabrielliGENERE: Dramma musicale con balli.
62. Il libretto consultato si trova in BNBM, Raccolta Drammatica 1373.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 296
297
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
PERSONAGGI: Clerco re di Tebe, Eurimede re di Corinto, Asteria e Al-cidamia figlie d’Eurimede, Adrasto amico di Clearco che poi si sco-pre Idraspe prencipe di Mileto, Olinda sorella d’Idraspe non cono-sciuta, Aceste fratello d’Idraspe e d’Olinda finto musico, Ismenoaio d’Olinda.
SCENA: [Corinto]CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Spiaggia solitaria di ma-
re vicino a Corinto. In lontano armata navale combattuta dalla tem-pesta63; Anticamera nobile nel luogo dorte dove è costudito Adra-sto; Campo di Clearco attendato di notte, con veduta d’un fiancodel luogo dove è costudito Adrasto; Galeria di statue e pitture inCorinto64; Atto secondo: Loggia aperta sul mare con altare dedica-to a Nettuno65; Logge deliziose in Corinto contigue alle stanze d’Al-cidamia66; Eserciti tebani e corinti schierati l’uno contro l’altro67;Atto terzo: Cortil regio; Giardino con fontana nel mezo; Gabinet-ti d’Asteria68; Reggia.
DEDICATARIO: Pietro Pisani podestà e Giulio Donado capitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: Antonio Scappi. Dedica: 24 dicembre 1686.CANTANTI: Antonio Scappi, Catterina Frangiosi.TITOLO DEI BALLI: «Di pittori» (primo ballo); «Di soldati coronati d’uli-
vo» (secondo ballo)69.FONTI: [Libretto], Il Clearco in Negroponte. Drama per musica da rappre-
sentarsi nel nuovo teatro dell’illustrissimo signor conte Giuseppe Secco Suar-do e dedicato a Sue Eccellenze Pietro Pisani podestà e Giulio Donado ca-pitanio di Bergamo l’anno 1687 da Antonio Scappi, In Bergamo, Per
63. Nelle didascalie interne al libretto descritta come: «Spiaggia del mare egeovicino a Corinto. In lontano armata navale combattuta da venti in tempo di notte».
64. Didascalie interne al libretto: «Galeria di statue e pitture con apprestamentiper dipingere Alcidamia».
65. Didascalie interne: «Loggia aperta sul mare in villaggio suburbano con aradedicata a Nettuno».
66. Didascalie interne: «Loggia aperta deliciosa che corrisponde alle stanze d’Al-cidamia».
67. Didascalie interne: «Esercito de’ corintii schierato da una parte a fronte quel-lo de’ tebani».
68. Didascalie interne: «Gabinetti d’Asteria con tavoliero sopra il quale vi saràun ferro e un vaso di veleno».
69. Didascalie interne: «Ballo di pittori in forma d’academia» e «Ballo di guer-rieri festanti per la pace».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 297
298
FRANCESCA FANTAPPIÈ
li Rossi, Con Licenza de’ Superiori, 168770; [Documento epistola-re], Documento 1686: 8, in Regesto.
DATA: 1688, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Secco Suardo.TITOLO: Tullo OstilioAUTORE: [Adriano Morselli]COMPOSITORE: [Marc’Antonio Ziani]GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Tullo Ostilio re de’ Romani; Silvio finto Orazio figlio
del Re Alba morto; Ascanio prencipe degli Albani; Valerio capita-no de’ Romani; Sabina figlia di Metio dittator d’Alba; Martia fi-glia di Tullo; Araspe prencipe confidente di Tullo e Martia; Milopaggio di Sabina; Celio picciolo infante figlio di Martia e di Sil-vio; Ambasciatore.
SCENA: Roma e luoghi circonvicini.CAMBI DI SCENA: Atto primo: Stanza; Luoco spazioso fuori di Roma
con quartieri de’ soldati e trono; Appartamenti di Marzia; Boscocon monte per la caccia71; Atto secondo: Appartamenti di Sabina;Ramo vastissimo del Tevere con navi72; Galleria; Atto terzo: Stec-cato fuori di Roma73; Cortile; Prigione74; Salon regio.
DEDICATARIO: Antonio Gaetano Trivulzio principe del Sacro Roma-no Impero
DEDICANTE/IMPRESARIO: Antonio Scappi
70. Il libretto consultato si trova conservato in BCMNa, Rari 10. 4 1/3.71. Nelle didascalie interne al libretto descritta come: «Boscaglia vicina a Roma
con colline destinata alle caccie reali» (Atto I, scena XIII). Successivamente una di-dascalia aggiunge: «Tullo Ostilio vede Ascanio in disparte nell’uscire per salire il col-le ad osservar la caccia» (Atto I, scena XVI).
72. Discalie interne: «Ramo vastissimo del Tevere ingombro da navi romane ealbane. Padiglione sopra la sponda con soglio» (Attoi II, scena VI). Nella scena se-guente si legge: «Valerio sopra la prora dìuna nave. Tullo Ostilio sedente».
73. Didascalie interne: «Steccato fuori di Roma, ingombrato da folto numero diromani e di Albani». Cui segue: «Qui compariscono nello steccato i tre Curiati ar-mati e i due Oratii e cominciano la battaglia, stanco ancor Silvio irresoluto in di-sparte» (Atto III, scena I).
74. Didascalie interne: «Prigione con picciol lume» (Atto III, scena VIII).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 298
299
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
CANTANTI: Angelica Vitaloni, Antonio Scappi.FONTI: [Libretto], Tullo Ostilio. Drama per musica da rappresentarsi nel
Teatro dell’Illustriss. Sig. Conte Cavagliero Giuseppe Secco Suardo l’anno1688 in Bergamo, dedicato all’Ill.mo ed Ecc.mo Sig.r don Antonio Gae-tano Trivultio prencipe del Sacro Romano Imperio, libero Barone di Rete-gno Imperiale, Cavagliere della Chiave d’Oro, & Commissario Generaledella Cavalleria Straniera per sua C. M. nel Stato di Milano, In Mila-no, Nella stampa di Federico Francesco Maietta in piazza de’ Mer-canti, Con Licenza de’ Superiori75; [Documenti epistolari], Docu-menti 1687: 20; 1688: 2, in Regesto.
NOTE: Prima del titolo un’immagine (fig. 8).
DATA: 1688AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Spettacolo encomiastico]LUOGO: Bergamo, luogo non identificato.TITOLO: Dialogo musicale tra Nettuno e Bergamo76
AUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Francesco BallarottiGENERE: Cantata (all’interno di un’accademia letteraria con inserti
musicali).PERSONAGGI: Nettuno; Bergamo.DEDICANTE DELLE RACCOLTA DI COMPONIMENTI: Flavio dalla Val-
le. Dedica: Bergamo, aprile 1688.FONTI: [Libretto], Applausi accademici alla glorie dell’Illustrissimo & Ec-
cellentissimo Signor Domenico Minelli nella di lui partenza dal castello diBergamo, dedicati all’Eccellenza Illustrissima del Signor Kavalier PietroMorosini, dalli signori Canonico Antonio Scotti, Andrea Locatelli, donBenedetto di Caleppio, Carlo e Flavio dalla Valle e conte Gio. Maria diCaleppio, Bergamo, MDCLXXXVIII, Per li fratelli Rossi, Con Li-cenza de’ Superiori77.
75. Il libretto si trova conservato in BNBM, Raccolta Drammatica 2570.76. Il dialogo apre la raccolta di componimenti poetici accademici ed è imme-
diatamente seguito da una poesia o «arietta» di Pietro Antonio Carrara intitolata IlBrenno.
77. Il libretto, conservato in BAM, S. I. G. V. 24 (2), non è segnalato in C. Sar-tori, I libretti italiani a stampa, cit.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 299
300
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DATA: 1689, gennaioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Teatro Secco SuardoTITOLO: Il MaurizioAUTORE: [Adriano Morselli]COMPOSITORE: Domenico GabrielliGENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Maurizio favorito di Tiberio, poi imperatore; Tiberio
II imperatore; Cosdroe re di Persia; Ergilda sua moglie; Placilla fi-glia di Tiberio; Ircano prencipe d’Egitto finto Prisco; Cirene Prin-cipessa d’Egitto amante d’Ircano; Leno servo faceto di Cosdroe;Giove sopra l’aquila; Apollo; Monte de’ Tisei.
SCENA: BisanzioCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Anfiteatro e trono; Bo-
schetto delizioso negli appartamenti di Placilla; Sala con foro ne-gli appartamenti d’Ergilda78; Parte di mare con palagio in eminen-za di Placilla e scala che conduce sul lido79; Atto secondo: Sala distatue, monte e giganti80; Luogo delizioso con scena81; Camera dinotte con lumi accesi82; Giardin di notte83; Atto terzo: Sala di sta-tue; Cortile con seraglio di fiere; Anfiteatro84.
DEDICATARIO: Giovan Battista Corner podestà; Nicolò Maria Magnocapitanio.
DEDICANTE/IMPRESARIO: Giacomo Cipriotti. Dedica: 12 gennaio1689.
TITOLO DEI BALLI: «ballo de’ turchi» (primo); «ballo de’ baccanti» (se-condo).
78. Nelle didascalie interne al libretto descritta come: «Sala con lungo foro percui si vede in distante».
79. Didascalie interne: «Parte di mare che s’interna nella città e bagna da unaparte il piede ad un colle, sovra di cui v’è un palagio con gli appartamenti di Placil-la, con scala che porta sul lido».
80. Didascalie interne: «Sala negl’appartamenti d’Ergilda».81. Didascalie interne: «Giove fulmina, quale s’apre nel mezo e precipitano i Gi-
ganti, restando la scena luminosa con Apollo che spunta dal fondo della medesi-ma».
82. Didascalie interne: «Stanza con lumi accesi di notte».83. Didascalie interne: «Giardin alle mura con quercia eminente e strada che con-
duce agli appartamenti d’Ergilda. Notte con luna luminosa».84. Didascalie interne: «Anfiteatro con trono».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 300
301
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
FONTI: [Libretto], Il Maurizio. Drama da rappresentarsi in musica nel tea-tro dell’Illustrissimo Signor Conte e Cavaliere Giuseppe Secco Suardo.Consacrato al merito impareggiabile degl’Illustrissimi & Eccellentissimi Si-gnori Giovan Battista Corner podestà, Nicolò Maria Magno CapitanioGrande di Bergamo, In Bergamo, MDCLXXXIX, Per li Fratelli Ros-si, Con Licenza de’ Superiori85.
DATA: 1689, febbraioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Secco Suardo.TITOLO: Giulio Cesare in EgittoAUTORE: [Giacomo Francesco Bussani]COMPOSITORE: [Antonio Sartorio]GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Romani: Giulio Cesare primo imperator de’ romani;
Curio tribuno del popolo di Roma; Cornelia moglie di PompeoMagno; Sesto Pompeo figlio di Pompeo e di Cornelia; Egizi: Cleo-patra regina dell’Egitto; Tolomeo re giovine dell’Egitto fratello diCleopatra; Achilla duce generale dell’armi e consigliero confiden-te di Tolomeo; Rodisbe nutrice di Cleopatra; Nireno servo di cor-te e confidente di Cleopatra; Coro: cavalieri, paggi e soldati conCesare; soldati con Curio; damigelle e paggi con Cleopatra; Sa-trapi; cavalieri e paggi con Tolomeo; eunuchi; soldati; mori conAchilla.
SCENA: Alessandria d’Egitto.CAMBI DI SCENA: Atto primo: Campagna con lucidissimo sole e con
ponte di pietra sopra un ramo del Nilo86; Sala reale87; Quartieri mi-litari di Giulio Cesare88; Atrio della reggia de’ Tolomei89; Atto se-condo: Deliciosa di cedri che si tramuta nella Regia della Virtù;
85. Il libretto consultato si trova conservato nella nella Library of Congress diWashington D. C. (USA).
86. Nelle didascalie interne al libretto descritta come: «Campagna d’Egitto fla-gellatta dai reaggi del sole con antico ponte di pietra sopra un ramo del Nilo».
87. Didascalie interne: «Sala di Cleopatra».88. Didascalie interne: «Quartieri del campo cesareo con l’urna in mezzo che
racchiude il capo di Pompeo Magno sopra eminente cumulo di trofei guerrieri».89. Didascalie interne: «Atrio del palagio reale de’ Tolomei con concorso di po-
polo. Al suon delle trombe precedono cavalieri egizi e romani».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 301
302
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Giardino corrispondente al serraglio delle fiere90; Stanze di Cleo-patra; Bagni di Tolomeo; Atto terzo: Riviera illuminata in tempodi notte dove segue battaglia navale91; Stanze reali; Salone.
SCENOGRAFO: [Giacomo Cipriotti]DEDICATARIO: Conte Antonio Barziza e Marietta Tofetti.DEDICANTE/IMPRESARIO: Giacomo Cipriotti. Dedica: 8 febbraio
168992.TITOLO DEGLI INTERMEZZI/BALLI: «ballo di paggi» (primo); «ballo di
Satrapi» (secondo)FONTI: [Libretto], Giulio Cesare in Egitto. Drama per musica da rappre-
sentarsi nel teatro di Bergamo dell’Illustriss. Sig. Conte e Cav. GiuseppeSecco Soardo consacrato all’Illustriss. Signori, li signori Antonio conteBarziza e Marietta Tofetti patrizia veneta, In Milano, MDCLXXXIX,Nella Stampa di Francesco Vigone, Con licenza de’ Superiori93.
NOTE: Il libretto è aperto da un’immagine (fig. 10). Inoltre è presen-te l’imprimatur94.
DATA: 1690, agostoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro in fiera.TITOLO: Hiarba impazzitoAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Giovan Battista Brevi «maestro di cappella del Duo-
mo di Bergamo».GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Hiarba re de’ Gettuli amante di Didone; Didone regi-
90. Didascalie interne: «Giardino del serraglio dove corrisponde quello delle fie-re».
91. Didascalie interne: «Riviera del porto d’Alessandria illuminata in tempo dinotte, dove segue battaglia navale e terrestre».
92. Giacomo Cipriotti nella dedica precisa che l’opera si tiene anche «per festeg-giare i gloriosi himenei» o «fastosi sponsali» del conte Antonio Barziza e MariettaTofetti.
93. Il libretto consultato si trova conservato in BNBM, Raccolta Drammatica2354.
94. Imprimatur: «F. Seraphinus Angelerius S. T. Magister Commissarius S. Offitijs Me-diolani. Iacobus Saita canon. basilica S. Ambrosij pro Eminentiss. D. D. Card. ViceomiteArchiep. Franciscus Arbona pro Excellentiss. Senatu».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 302
303
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
na di Cartagine amante riamata d’Enea; Enea principe troiano; Aca-te cavalier troiano amico d’Enea; Nice vecchia nodrice di Didone.
SCENA: CartagineCAMBI DI SCENA: Appartamenti di Didone; Selva con antro; Cortile
regio; Sala regia.DEDICATARIO: Colonnello Giacomo LavezzarioDEDICANTE: Margarita Pasqual: Dedica: 17 agosto 169095.SCENOGRAFO: [Giacomo Cipriotti]96
CANTANTI: Giuseppe Belucchi da Pavia (Hiarba); Rosa Farina milane-se (Didone); Teresa Carera di Torino (Enea); Carlo Lesma (Acate);Antonio Corna (Nice).
MUSICISTI: Giovan Battista Brevi maestro di cappella del Duomo diBergamo (direttore dell’opera).
FONTI: [Libretto], Hiarba impazzito. Drama musicale recitato nella cittàdi Bergamo nell’occasione della fiera dedicato all’Illustrissimo Sig. colon-nello Giacomo Lavezzario, In Bergamo, MDCXC, Per li fratelli Ros-si, Con Licenza de’ Superiori97.
NOTE: Prima del titolo un’immagine (fig. 11). Segue nella seconda car-ta l’imprimatur98.
DATA: 1691, Carnevale.AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La falsirenaAUTORE: Rinaldo CialliCOMPOSITORE: Marc’Antonio Ziani
95. La dedica inizia nel modo seguente: «Solevano gli antichi romani celebrarecerte festività dell’anno con famosi spettacoli & io mi servo dell’istesso costume, consolennizzare la fiera di Bergamo, insigne a tutta la Lombardia, con la recita d’un dra-ma musicale». Margherita Pasqual, nel 1693 a Crema con l’opera L’amante nemica(personaggi: Didone, Hiarba, Enea, Acate, Pippo), dichiarava: «questo picciol dram-ma che sebene rappresentato da personaggi di legno» in C. Sartori, I libretti italiania stampa, cit., libretto 1056.
96. Margarita Pasqual nella dedica dichiara: «mentre io assistita dal valore et in-defessa applicatione del sig. Giacomo Cipriotti».
97. Il libretto consultato si trova conservato in BNBM, Raccolta Drammatica2456.
98. Imprimatur: «Reimprimatur Inquisit. Gener. Berg.».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 303
304
FRANCESCA FANTAPPIÈ
GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Adone, Venere, Falsirena, Marte, Mercurio, Amore, Bre-
no.CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Luogo sotterraneo che ser-
ve a sepolture nobili de cadaveri e lumi eterni e sepolcro nel mez-zo; Cielo sereno con mare99; Delitiosa di cedri e platani con collecangiandosi di novo in cielo sereno con mare100. Atto secondo: Cor-tile delle prigioni di Falsirena che si cangia in nobilissima stanzacon letto adornato101; Giardini di Venere con fontane; Atrio cheintroduce a luohi delitiosi. Atto terzo: Castello con porta secretache poi si cangi in vasta campagna; Antro orrido; Reggia di Vene-re102.
SCENOGRAFO: Tommaso Bezzi103
DEDICATARIO: Zaccaria Sagredo podestà, Agostin da Riva capitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: Tommaso MandolinoFONTI: [Libretto], La Falsirena. Drama per musica da rappresentarsi nel
Teatro di Bergamo l’anno 1691 di don Rinaldo Cialli. Consacrata all’Ec-cellenze Illustrissime Zaccaria Sagredo podestà et Agostin da Riva capi-tan grande, In Milano, Per Federico Francesco Maietta, Stamp. inPiazza de’ Mercanti, Con licenza de’ superiori, [1691]104.
DATA: 1691AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La fortuna tra le disgrazieAUTORE: [Rinaldo Cialli]
99. Didascalie interne: «Cielo sereno con mare. Marte e Venere sopra dorata con-chiglia tirata da due cavalli marini» (Atto I, scena II).
100. Il cambio avviene nel corso della scena XII che si apre con la seguente di-dascalia: «Tra il denso delle nuvole comparisse in aria Falsirena. Detti: lampi e tuo-ni che scorrono per l’aria». Si chiude: «Qui viene portato via per l’aria Adone da undemone, s’apre il colle, sparisce la scena ritornando la marittima».
101. Didascalie interne: «Atrio delle prigioni di Falsirena con sasso nel mezo Ado-ne» (Atto II, scena I).
102. L’ultima didascalia è: «Comparisce Saturno tra nuvole».103. Autore delle «sceniche rappresentenze» il quale, secondo l’avvertimento al
lettore, «ancorché confinato tra l’angustie d’un letto, ha operato quello era impos-sibile e nell’angustia del tempo e del luogo».
104. Il libretto consultato si trova in BCMR, Carvallais 6048.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 304
305
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
COMPOSITORE: Paolo BiegoGENERE: Opera seria con balli.PERSONAGGI: Satrape re di Persia; Gilde sorella di Satrape; Clearte fi-
glio del re di Damasco; Irene sua sorella; Alindo principe armeno;Dario favorito di Satrape; Delfo paggio di Alindo.
COMPARSE: Cacciatori; Arcieri; Alabardieri; Paggi.CAMBI DI SCENA: Atto primo: Spiaggia marittima con bosco e sco-
gli; Sala con trono; Giardino con fontane; Atto secondo: Loggenegli appartamenti reali; Stanza nella reggia con letto; Gran piaz-za nella città; Atto terzo: Atrio scoperto negli appartementi di Gil-de; Luogo spazioso di delizie con monticelli dentro la città; Salareale illuminata.
EFFETTI SCENICI: Atto primo: Gigante che alza la tenda; Fortuna dimare con tuoni, lampi e tempesta con legno che si rompe; Irideche comparisce; Capriolo che fugge da’ cacciatori; Cigni che pas-seggiano; Lumache dalle quali usciranno gobbi che formano il bal-lo; Atto secondo: Sacrificio nella piazza; Sole; Vittima accesa da’raggi del sole; Ara che si tramuta in spiriti che formano il ballo;Atto terzo: notte con luna e stelle.
TITOLO DEGLI INTERMEZZI/BALLI: «ballo di gobbi» (primo), «ballo dispiriti» (secondo).
DEDICANTE/IMPRESARIO: Tommaso Mandolino105.DEDICATARIO: Michele Semenzi castellanoFONTI: [Libretto], La fortuna tra le disgratie. Drama per musica da rap-
presentarsi nel teatro di Bergamo l’anno 1691 di D. Rinaldo Cialli. Con-sacrato all’Eccellenza Illustrissima Michele Semenzi castellano di Bergo-mo, In Milano, Per Federico Francesco Maietta Stamp. in piazzade’ Mercanti, Con Licenza de’ Superiori106.
DATA: 1691, agostoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.
105. Nell’avvertimento al lettore: «Le operazioni sceniche sono inventioni di chinon pretende lode per l’opera (…). Poco vedrai in luogo dove il molto non si puòfar vedere, ma si dichiara, chi operò il poco, che sempre vi sarà poco da lodarsi an-che nel suo molto».
106. Il libretto consultato si trova in BNBM, Raccolta Drammatica 1726.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 305
306
FRANCESCA FANTAPPIÈ
TITOLO: Il merito fortunatoAUTORE: Francesco RoncalliCOMPOSITORE: Francesco BallarottiGENERE: Operetta moralePERSONAGGI: Merito amante della Fortuna; Fortuna; Inganno in ha-
bito di Merito Amante della Fortuna; Ignominia amante del Me-rito; Virtù madre del Merito; Giustizia; Vulcano
CAMBI DI SCENA: Scene dell’atto primo: Mare in tempesta con naveinfranta gettata alla spiaggia; Reggia della fortuna; Grottesca habi-tazione dell’Ignominia; Sala Regia. Scene dell’atto secondo: Piaz-za; Tempio con l’Oracolo della Giustizia; Giardino con Statue &Fontane; Fucina di Vulcano con Ciclopi; Scene dell’Atto Terzo:Cortile Regio; Steccato per la Battaglia; Machina della Giustizia.
DEDICATARIO: Battista Nani fratello del capitanio Agostin Nani.DEDICATANTE: Francesco Roncalli107. Data: Bergamo 16 agosto 1691.CANTANTI: Giovan Battista Speroni (Merito), Clarice Benni Venturi-
ni virtuosa di S.A.S. di Parma (Fortuna), Gioseppe Scaccia musicodi S.A.S. di Parma (Inganno), Giovanna Atti Gabrieli bolognese(Ignominia), signora N. N. bolognese (Virtù e Giustizia), don Gio-van Battista Baracca (Vulcano).
FONTI: [Libretto], Il merito fortunato. Operetta morale per musica da rap-presentarsi nel teatro di Bergamo alla glorie di S. E. il signor Agostin Na-ni capitanio grande di detta città et dedicata a S. E. il Sig. Battista Nanifratello del rappresentante. Dal conte Francesco Roncalli, in Bergamo,MDCXCI, Per li fratelli Rossi, Con licenza de’ Superiori108.
DATA: 1692, febbraioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Il RodericoAUTORE: [Giovan Battista Bottalino]
107. Nella dedica Francesco Roncalli scrive: «Se la fama non fosse impegnata dipubblicare le di lui [di Agostino Nani] degne azioni al Mondo tutto, sarei in granpena rappresentandole nella angusta Scena di questa Città. Tutti li compositori d’og-gidì hanno ne loro Teatri per Soggetto le Istorie favoleggiate & io la Moralità».
108. Consultati i libretti in BCBg, Salone loggia P 9 47 (2) e in BNBM, 25.1. E.33/1.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 306
307
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
COMPOSITORE: Compositore non specificato109
GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Sancio infante del Regno delle Spagne; Roderico suo
zio usurpatore del Regno; Anagilda regina vedova madre di San-cio; Don Giuliano110 prencipe di Alghizirra; Florinda sua figliola;Ulit re de’ mori; Zilauro infante di Tunesi; Lesbia giardiniera; Bu-bo servo faceto; Paggi e guardie con Sancio; Paggi e guardie conRoderico; Paggi e damigelle con Anagilda; Paggi e arcieri con Ulit;Soldatesche europee & africane; Dame e cavaglieri con popolo al-lo steccato.
SCENA: ToledoCAMBI DI SCENA: Atto primo: Salon regio con trono; Cortile con in-
gresso de’ giardini; Campo con padiglioni & ordinanze di soldatiafricani, elefanti, cameli e cavalli in riva al Tago; Atto secondo: Cor-tile regio; Campo seminato di stragi con battaglia sotto le mura diToledo; Boscareccia; Stanze con letto negli appartamenti di DonGiuliano; Sala Regia; Atto terzo: Galaria; Giardino con statue e fon-tana; Sala; Piazza con steccato & popolo al torneo.
DEDICATARIO: Michelangelo Semenzi castellano.DEDICANTE: Eleonora Cecarelli. Data: febbraio 1692.FONTI: [Libretto], Il Roderico drama per musica da rappresentarsi nel tea-
tro di Bergamo l’anno 1692. Consacrato all’Illustrissimo & Eccellentissi-mo Signor Michelangelo Semenzi castellano di Bergamo, In Milano, Al-la Stampa di Carlo Giuseppe Quinto, Con Licenza de’ Superio-ri111.
DATA: [1693]AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Spettacolo encomiastico]LUOGO: BergamoTITOLO: Il cuor del leone o sia la stella di prima grandezza
109. La musica è sicuramente di Carlo Francesco Pollaroli nelle edizioni di Pa-via (1684), Verona (1687), mentre è di Francesco Gasparini in quelle di Livorno (1686),Roma (1694), cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 20070, 20073, 200077,200080.
110. Nel libretto: «D. Giugiliano».111. Il libretto consultato si trova nella Thomas Fisher Book Library dell’Uni-
versità di Toronto in Canada. L’esemplare è l’unico conservato, ma purtroppo è mu-tilo.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 307
308
FRANCESCA FANTAPPIÈ
AUTORE: Fermo GrumelloCOMPOSITORE: Francesco Ballarotti maestro di cappella di Santa Ma-
ria Maggiore di Bergamo.GENERE: SerenataPERSONAGGI: Nettuno, Acheloo, Amore.SCENA: Nel mezzo dell’Adriatico di notte.DEDICATARIO: Marina da LezeDEDICANTE: Fermo GrumelloFONTI: [Libretto], Il cuor del leone o sia la stella di prima grandezza sere-
nata consacrata alli meriti degl’illustrissimi et eccellentissimi signori Locre-tia Badoera et signor Alvise Priuli in occasione della loro insigne prefeti-cia regenza in Bergamo, dedicata all’illustrissima signora Marina da Le-ze dal conte Fermo Grumello, In Milano, Nella Reg. Duc. Corte, perMarc’Antonio Pandolfo Malatesta stampator Reg. Cam., Con li-cenza de’ Superiori, [1693]112.
DATA: 1694AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Dionisio overo la virtù trionfante del vizioAUTORE: [Matteo Noris]COMPOSITORE: Compositore non specificato113.GENERE: Opera seria con balli.PERSONAGGI: Dionisio re di Siracusa; Atalo primo consigliero; Dori-
de figlia d’Atalo; Fausta favorita del re; Periandro, Platone filoso-fi; Gisambe fratello del Re; Breno servo d’Atalo.
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Stanze di Dionisio; De’cedri nella casa d’Atalo; Bibliotecaria regia nel real palazzo; Stan-za in forma di prigione nella casa d’Atalo; Atto secondo: Sala controno; Loggia corrispondente agli appartamenti di Doride; Colli-
112. Il libretto consultato si trova in BNBM, Raccolta Drammatica 5961/1. Perl’attribuzione della data cfr. S. Rota, Per una storia dei rapporti tra Bergamo e Veneziadurante il periodo della denominazione (secoli XV-XVIII). Rassegna bibliografica, Bergamo,1987, p. 59.
113. Nella prima edizione dell’opera (Venezia, Teatro Grimani, 1681) come au-tori della musica risultano Petronio Franceschini (primo atto) e Giovanni Domeni-co Partenio (secondo e terzo atto), cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., li-bretto 7923.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 308
309
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
ne con fontana114; Camera di Fausta con letto da riposo; Atto ter-zo: Atrio regio; Gabinetto di Fausta115; Sala regia.
DEDICATARIO: Francesco Pasqualigo Basadonna e Francesco Soranzorettori.
DEDICANTE: Carlo BertiniFONTI: [Libretto], Dionisio overo la virtù trionfante del vizio. Drama per
musica da reccitarsi nel teatro di Bergamo dedicato agl’Illustriss. & Ec-cell. Signori Francesco Pasqualigo Basadonna e Francesco Soranzo degnis-simi rettori di detta città l’anno 1694, In Venezia, MDCXCIV, Per ilNicolini, Con Licenza de’ Superiori e Privilegio116.
DATA: 1695, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Secco SuardoTITOLO: Ottaviano in SiciliaAUTORE: [Ercole Pesci]COMPOSITORE: [Francesco Ballarotti]GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Ottaviano Cesare Augusto; Sesto Pompeo figlio del
gran Pompeo usurpatore della Sicilia; Giunia moglie di Sesto Pom-peo; Lepido re dell’Africa amante corrisposto da Romilda; Romil-da dama principale di Messina; Idrena principessa di Corinto tra-dita da Lepido; Valerio capitano e favorito di Sesto Pompeo, aman-te non corrisposto da Romilda; Gildo servo di Lepido.
SCENA: La scena si finge in Messina e luoghi circonvicini.CAMBI DI SCENA: Atto primo: Notte col tramontar della luna; Par-
te di mare che scorre presso la città. Si vedono al fianco alcunipalazzi tra’ quali quello di Romilda. Dall’altra parte sulla spiag-gia si vedono le tende di Sesto Pompeo con l’esercito che dorme;Boschetto delizioso con fontane nel palazzo di Romilda; Spiag-gia di mare. Si vedono le navi di Sesto Pompeo in lontananza in-
114. La didascalia interna al libretto aggiunge: «Qui si cangiano le colline in ca-mera con il letto sopra il quale vi è Fausta coperta da un velo che finge di dormire»(Atto II, scena 15).
115. In luogo del «Gabinetto di Fausta» la didascalia interna registra un «Locoda delizia» (Atto III, scena V).
116. Il libretto consultato si trova in BCPa, SC 113/138.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 309
310
FRANCESCA FANTAPPIÈ
cendiate; Atto secondo: Linee con approcci e macchine militarisotto le mura di Messina; Bosco ingombrato dalle tende d’Otta-viano; Stanze nel palazzo di Romilda; Recinto in cui si era forti-ficato l’esercito d’Ottaviano, ove si caricano su carriaggi le tendee il bagaglio del campo cesareo; Loggie nel palazzo di Romilda;Atto terzo: Gran pianura sotto Messina. Si vede una porta dellacittà col ponte calato; Sala nel palazzo di Romilda con fuga dicamere; Giardino di palazzo suburbano abitato da Ottaviano; An-fiteatro illuminato in tempo di notte con trono e popolo spetta-tore.
DEDICATARIO: Dolfin Tiepolo Cornaro podestaressa; Canzian Giu-stiniani Soranzo capitania.
DEDICANTE/IMPRESARIO: «Il direttore dell’opera»117.FONTI: [Libretto], Ottaviano in Sicilia. Drama per musica da rappresen-
tarsi nel teatro Secco Soardo di Bergamo consacrato all’Ill.me & Ecc.meSig.re Dolfina Tiepola Cornaro podestaressa e Cantiana Giustiania So-ranzo capitania, In Milano, 1695, Nella Stampa di Francesco Vigo-ne, Con Licenza de’ Superiori118.
DATA: 1698, 7 marzoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Teatro religioso]LUOGO: Bergamo, convento di San BartolomeoTITOLO: Megera delusaAUTORE: [Giovan Battista Pichi]119
COMPOSITORE: Paris Francesco AlghisiGENERE: OratorioPERSONAGGI: San Tommaso, Teodora sua madre, Rinaldo suo fratel-
lo, Coro d’angeli, Testo, Cintia meretrice, Lucifero, Megera, Corodelle Furie.
117. Alla fine del libretto il seguente avvertimento al lettore, per mano degli stam-patori Rossi di Bergamo: «Per mancanza d’una delle parti si ha dovuto trasportareda luogo a luogo qualche aria». Segue l’elenco, scena per scena, delle arie tagliate esostituite.
118. Il libretto consultato si trova conservato in BNBM, Raccolta Drammatica1020.
119. Nel libretto stampato a Faenza (1701) definito «inquisitore generale del S.Offizio di Parma», cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretto 15384.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 310
311
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DEDICATARIO: Girolamo Pesaro podestà.DEDICATANTI: «Gli studenti teologi del Convento di San Bartolomeo
di Bergamo»FONTI: [Libretto], Megera delusa. Oratorio consacrato al merito sopragran-
de di Sua Eccellenza il signor Girolamo Pesaro podestà di Bergomo dallisignori studenti teologi del convento di San Bartolomeo di detta città. Nelcelebrarsi dalli medemi la festa del glorioso S. Tomaso d’Aquino dottore del-la chiesa e loro maestro li 7 marzo 1698. Posto in musica dal signor Pa-ris Francesco Alghisi maestro di cappella, in Brescia, MDCXCVIII, PerGio. Maria Rizzardi, Con Licenza de’ superiori120.
DATA: 1709AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’Alciade overo l’eroico amore (altro titolo: L’Alciade overo la vio-
lenza d’amore).AUTORE: [Marcantonio Gasparini]COMPOSITORE: Francesco Gasparini (atto primo), Carlo Francesco
Pollaroli (atto secondo), Francesco Ballarotti (atto terzo).GENERE: Opera tragicomicaPERSONAGGI: Alciade; Clodomira; Egisto; Cirene; Eritone vecchio pa-
store.DEDICATARIO: Francesco Donado capitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: «La più obbligata & ossequiosa Nobiltà di
Bergamo»121.CANTANTI: Giovan Battista Carboni di Mantova (Alciade); Alessan-
dra Scaccia di Parma (Clodomira); Giacomo Carmeli di Verona (Egi-sto); Anna Maria Giusti romana (Cirene); Giuseppe Scaccia di Par-ma (Eritone).
FONTI: [Libretto], L’Alciade overo l’eroico amore. Opera tragicomica da rap-presentarsi in Bergamo nella partenza del glorioso reggimento della mede-sima città dell’Illustriss. & Eccellentiss. Sig.r Francesco Donado capitanio
120. Il libretto consultato si trova in BCBg, Sala Seconda Loggia P. Fila I. 8 (5).121. Prima del testo è inserito l’imprimatur: «Fr. Ioseph Maria Reina ord. pred. sa-
cra thelo. mag. ac commissarius S. Officij Mediolani. Michael De Constantinis canonicus theo-logus S. Nazarij proeminentiss. D.D. cardinali Archinto archiepiscopo. Angelus Maria Mad-dius pro Excellentiss. Senatu».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 311
312
FRANCESCA FANTAPPIÈ
grande e dedicata a Sua Eccellenza medesima, In Milano, MDCCIX,Per Giuseppe Pandolfo Malatesta, Con Licenza de’ Superiori122.
DATA: 1709AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Spettacolo encomiastico]LUOGO: Bergamo, luogo non identificato.TITOLO: Accademia in lode di Francesco Donado capitanio grande123
AUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Carlo Marini «virtuoso di violino».GENERE:Cantata all’interno di un’accademia letteraria.PERSONAGGI: Amore, Fantasia, Clio, Merito, Gratitudine.DEDICATARIO: Leonardo Dolfin podestà.DEDICANTE: «Gli accademici».CANTANTI: Giovan Battista Carboni di Mantova, detto il Carbonci-
no (Amore), Alessandra Scaccia di Parma (Fantasia), Anna MariaGiusti detta la Romanina (Clio), Giuseppe Scaccia (Merito), Giaco-mo Carmeli di Verona (Gratitudine).
FONTI: [Libretto], Accademia detta in lode dell’Ill.mo et Ecc.mo SignorFrancesco Donado capitanio grande nella sua partenza dalla città di Ber-gamo e dedicata all’illustrissimo & eccellentissimo Signor Leonardo Dol-fin podestà, In Milano, Per Giuseppe Pandolfo Malatesta, 1709, Conlicenza de’ Superiori124.
DATA: 1712AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]
122. Consultati i libretti conservati in BNBM, Raccolta Drammatica 1229 e inCMBo, LO 1984. L’opera è stata catalogata in C. Sartori, I libretti italiani a stampa,cit., sotto due voci diverse (libretti numero 617 e 618), poiché esistono due diversetitolazioni: L’Alciade overo l’eroico amore e L’Alciade overo la Violenza d’Amore. Per tut-to il resto, dal frontespizio al testo, dalla dedica all’imprimatur, dai cantanti all’av-vertimento al lettore, siamo di fronte ad una medesima emissione di stampa. Gra-zie all’esemplare conservato in CMBo, sotto la collocazione LO 1984, è possibilecapire com’è stato effettuato il cambiamento del titolo: la parte «Violenza d’Amo-re» è stata sostituita a «l’eroico amore» per mezzo di un foglietto di carta incollatosull’intestazione originale.
123. Il volume raccoglie numerosi componimenti poetici ed encomiastici inter-calanti la cantata, tra i quali segnaliamo un sonetto di Giuseppe Secco Suardo e unpanegirico di Coriolano Brembati.
124. Il libretto consultato si trova in BAM, S. I. F. IV. 7 (17).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 312
313
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
TIPOLOGIA: [Spettacolo encomiastico]LUOGO: Bergamo, luogo non identificato.TITOLO: La gara de tre’ delfiniAUTORE: Carlo Benaglio125
GENERE: SerenataPERSONAGGI: Giove, Nettuno, Cibele, Gloria.DEDICATARIO: Pietro Delfino podestà.FONTI: [Libretto], La gara de’ tre delfini del Cielo, della Terra e del Mare,
introduzione in musica all’Accademia da farsi con l’occasione della par-tenza dal Glorioso regimento di Bergamo di Sua Eccellenza il signor Pie-tro Delfino Podestà, In Bergamo, Per li fratelli Rossi, Con Licenzade’ Superiori, 1712126.
DATA: 1713AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Spettacolo encomiastico]LUOGO: Bergamo, luogo non identificato.TITOLO: Didone et EneaAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Compositore non specificato.GENERE: SerenataPERSONAGGI: Venere, Didone, Enea, Ergasto.FONTI: [Libretto], Didone et Enea. Serenata per musica, In Bergamo, Per
li fratelli Rossi, Con Licenza de’ Superiori, 1713127.
DATA: 1714AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro provvisorio in fiera o «nuovo teatro in fiera».TITOLO: Atalanta o sia la costanza d’Amore negl’inganniAUTORE: Autore non specificato128.
125. L’autore, il quale si nasconde sotto l’anagramma Claro Nobilega, inserisce ilsolito avvertimento: «Li soli nomi che si introducono a bastanza provano quanto sia-no differenti dalli qui espressi, que’ veri e cattolici sentimenti che professa l’autore».
126. Il libretto consultato si trova in BCBg, 32 R 7 (1).127. Il libretto consultato si trova in BCBg, 32 3 7 (3).128. Autore di un Atalanta dramma pastorale per musica (Parma, 1697), replicato
a Modena nel 1710, è Ercole Pesci, cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., li-bretti 3384-3385.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 313
314
FRANCESCA FANTAPPIÈ
COMPOSITORE: Compositore non specificato.GENERE: Dramma pastoralePERSONAGGI: Atalanta principessa d’Arcadia sotto nome di Clori;
Meleagro principe della Grecia sotto nome di Tirsi; Silvia e Amin-ta pastori; Alindo servo di Tirsi.
SCENA: BoscoDEDICATARIO: Elisabetta Grimani Gambara podestaressa; Maria Ven-
dramin Zenobio capitania.DEDICANTE: Dedicante non specificato129.FONTI: [Libretto], L’Atalanta o sia la costanza d’Amore negl’inganni. Dra-
ma pastorale da rappresentarsi nel nuovo teatro in fiera di Bergamo con-segrato a S.S. E.E. contessa Elisabetta Grimani Gambara podestaresssa econtessa Maria Vendramin Zenobio capitania di detta città, In Milano,MDCCXIV, Nella stampa di Giuseppe Pandolfo Malatesta, ConLicenza de’ Superiori;130 [Descrizione in rima], Giovan BattistaAngelini, Per darti notizie del paese: descrizione di Bergamo in terza ri-ma 1720, a cura di V. Marchetti, con la collaborazione di D. Poli-ni, Bergamo, 2002, p. 377.
DATA: 1714AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro provvisorio in fiera.TITOLO: Intermezzi del PimpinoneAUTORE: Autore non specificato131.COMPOSITORE: Compositore non specificato132.
129. Nell’avvertimento al lettore si avvisa: «Non vi sia però chi s’inganni nelleespressive di termini e delle parole che hanno formola ed aria pagana, perché sonotutti aredi poetici e l’autore si protesta di sincero cuore cattolico &c. Idibus AugustiMDCCXIV». Segue: «Imprimatur. Fr. Ioseph Maria Ferrarini Sac. Theol. Prof. Ord. Pra-ed. ac Commiss. S. Officij Mediolani. Carolus Franciscus Curionus pro Eminentiss. & Re-verendiss. D.D. Card. Odeschalco Archiepiscopo. Angelus Maria Maddius pro Excell. Sena-tu».
130. Il libretto consultato si trova conservato in BNBM, Raccolta Drammatica2239.
131. Autore degli Intermezzi di Vespetta e Pimpinone (Parma 1714), Pimpinone (Ve-nezia 1708, Milano, 1709, Venezia 1725) è Pietro Pariati, cfr. C. Sartori, I libretti ita-liani a stampa, cit., libretti 13421, 18721, 18722, 18726.
132. Compositore degli Intermezzi di Vespetta e Pimpinone (Parma 1714), Pimpino-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 314
315
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
GENERE: Intermezzi ridicoli in musica.PERSONAGGI: Vespetta, Pimpinione.CANTANTI: Rosa Ungarelli, Ignazio Ferrari.FONTI: [Libretto], Intermezzi del Pimpinone recitati nell’Atalanta pastora-
le rappresentata in Bergamo nella fiera d’agosto 1714, dalli qui sotto no-tati virtuosi, signora Rosa Ungarelli virtuosa della duchessa di Modena,signore Giuseppe Ignazio Ferrari virtuoso di Sua Maestà, In Bergamo,Per li Fratelli Rossi, 1714, Con Licenza de’ Superiori;133 [Descrizio-ne in rima], Giovan Battista Angelini, Per darti notizie del paese, cit.,p. 377.
DATA: 1723, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro provvisionale in fiera.TITOLO: L’innocenza giustificataAUTORE: [Francesco Silvani]COMPOSITORE: Compositore non specificato134.GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Carlo re Infante sotto la tutela di Giuditta sua madre;
Giuditta madre di Carlo vedova di Ludovico Pio; Gildippe figliadi Giuditta e d’un re di Svezia destinata sposa di Adalgiso; Lota-rio imperatore figliolo di Lodovico Pio e Irmengarde; Adalgisio fi-gliolo di Lotario; Asprando cavaliere della corte di Giuditta e se-greto dipendente di Lotario; Berardo principe spagnolo duca di Sep-timania.
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Atrio imperiale corrispon-dente alla piazza d’Aquisgrana; Stanze di Giuditta; Atto secondo:Camera; Atrio corrispondente al palazzo di Lotario; Atto terzo: Ga-binetto con due porte.
DEDICATARIO: Francesco Martinelli podestà; Zuane Tron capitanio.
ne (Venezia 1708, Milano, 1709) è Tommaso Albinoni, cfr. C. Sartori, I libretti italia-ni a stampa, cit., libretti 13421, 18721, 18722.
133. Il libretto consultato si trova conservato in BCBg, Salone Piccola 21. 1. 8(10).
134. Compositore dell’opera per l’edizioni di Palermo (1714), Praga (1725) è An-drea Stefano Fiorè, per quella di Mantova (1700) è Benedetto Vinacese, per quelladi Milano (1711) Fortunato Chelleri, cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., li-bretti 13317, 13319, 13320, 13323.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 315
316
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DEDICANTE/IMPRESARIO: Santo Burigotti. Data: Bergamo, 20 agosto1723135.
CANTANTI: Anna Maria Giusti detta la Romanina «virtuosa della Ca-sa Reale di Polonia» (Giuditta); Teresa Peruzzi detta Denzio (Gil-dippe); Antonio Denzio (Lotario); Giulia Paronetto (Adalgisio); Fe-lice Novello (Asprando); Paolo Vida (Berardo)136.
FONTI: [Libretto], L’innocenza giustificata drama per musica da rappesen-tarsi in Bergamo in occasione della fiera dedicato all’alto merito delle SS.EE. Francesco Martinelli podestà e Zuane Tron capitano grande di Ber-gamo, In Bergamo, Per li Fratelli Rossi Stamp. Pub. Pr. 1723, Conlicenza de’ superiori137.
DATA: 1725, settembreAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA: Compagnia non identificata.FONTI: [Documento contabile], Documento 1725: 1, in Regesto.
DATA: 1726, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La pace per amoreAUTORE: [Angiolo Schietti]COMPOSITORE: [Giuseppe Maria Buini]
135. Nella dedica l’impresario ricorda i precedenti fastosi allestimenti dell’ope-ra per rimarcare che la versione bergamasca è più dimessa a causa delle limitate po-tenzialità del teatro provvisionale: «Espongo al pubblico piacere l’autorevole e ve-nerato patrocinio dell’EE. VV. questo dramatico componimento, che altre volte me-ritò con buona sorte la gloria d’essere ammesso alle scene d’una delle principali cor-ti d’Italia in occasione di nozze principesche e fo ad esempio di que’ pittori che met-tono in buon lume di prospettive l’opere loro, affinché ricrescano con maggiore ri-salto. Da tale elezione risulterà questo vantaggio al presente drama, che tutti mi com-mendranno di averlo saputo ben dedicare, se non avrò io la presunzione di credereche possano lodarmi di averlo fatto ben comparire su d’un posticcio teatro dopoch’ha onorate le scene de’ principi».
136. L’opera viene replicata, appena un mese dopo e con lo stesso cast, a Cre-ma in occasione della fiera, cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretto 13322.
137. Il libretto consultato si trova in BNBM, Raccolta Drammatica 3582.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 316
317
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Casira regina de’ Barcei fu moglie del re Arsace; Bere-
nice principessa figlia di Casira; Idalma principessa d’Epiro pro-messa sposa d’Adrasto, ma da lui abbandonata per Berenice; Cli-mene principe reale amante di Berenice sotto nome di Floro; Adra-sto principe di Calcide sposo di Idalma amante di Berenice, manon gradito; Lucrino giardiniere regio.
CAMBI DI SCENA: Atto primo: Tempio dedicato alla dea Osiride tu-telare d’Egitto138; Giardino reale; Atto secondo: Bosco ameno conrivoli d’acque; Camere delizione della reggia; Atto terzo: Lochi an-tichi nel recinto della reggia; Torre profonda e orrida; Anfiteatromagnifico139.
DEDICATARIO: Alvise Foscarini podestà; Bortolo P[aol]o Gradenigocapitanio.
DEDICANTE/IMPRESARIO: Pietro Denzio140.CANTANTI: Margarita Biondi veneziana (Casira); Maria Maddalena
Carrara veneziana (Berenice); Giulia Giessi bolognese (Idalma); Do-menico Borghi cantante del «principe d’Armestat» (Climene); Feli-ce Novelli veneziano cantante del duca di Massa e Carrara (Adra-sto); Giovanni Perella Bresciano (Lucrino).
FONTI: [Libretto], La pace per amore. Drama per musica da rappresentar-si in Bergamo nel Carnevale dell’anno 1726 dedicato a S.S. E.E. li signo-ri Alvise Foscarini podestà e Bortolo P.o Gradenigo capitano grande, InBergamo, MDCCXXV, Per li fratelli Rossi Stamp. Publ. Privil.,Con Licenza de’ Superiori141.
DATA: 1726, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]
138. Nelle didascalie interne al libretto: «Tempio dedicato alla Deità tutelared’Egitto Osiride, con ara solenne di magnifica struttura. Urna di nero marmo. Ve-ste candida macchiata di sangue. Saranno la regina vestita a bruno e così la princi-pessa reale. Nel mezzo del tempio foco ardente entro una gran conca elevata soprauna tripode» (Atto I, scena I).
139. Didascalie interne: «Anfiteatro maestoso. Qui la Reina va in trono e Bere-nice siede un poco più abbasso» (Atto III, scena IX).
140. Nell’avviso al lettore si legge: «Le parole Fato, Destino, Nume &c. ricevilecome scherzi di poesia e non sentimenti da Cattolico, che tale si professa l’autore evivi felice».
141. Il libretto consultato si trova in BNBM, Raccolta Drammatica 2776.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 317
318
FRANCESCA FANTAPPIÈ
TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La fede tradita e vendicataAUTORE: [Francesco Silvani]COMPOSITORE: Compositore non specificato142.GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Ricimero re de’ Ghoti destinato sposo d’Evige poi aman-
te d’Ermelinda; Rodoaldo re di Norvegia; Ernelinda figlia di Ro-doaldo e amante di Vitige; Edvige figlia di Grimoaldo già re di Nor-vegia; Vitige principe reale di Dania, cugino di Edvige amante diErnelinda; Edelberto principe reale di Boemia amante d’Edvige.
CAMBI DI SCENA: Atto primo: Cortile regio; Campagna con padiglio-ni dell’esercito di Ricimero in veduta della città; Stanze; Atto se-condo: Deliziosa; Appartamenti; Atto terzo: Prigione; Strada checonfina al lago; Sala regia.
DEDICATARIO: Alvise Foscarini podestà e Bortolo Paolo Gradenigocapitanio grande.
DEDICANTE/IMPRESARIO: Pietro Denzio143.CANTANTI: Felice Novelli veneziano cantante del duca di Massa e Car-
rara (Ricimero); Giovanni Perella Bresciano (Rodoaldo); MargaritaBiondi veneziana (Ernelinda); Maria Maddalena Carrara veneziana(Edvige); Domenico Borghi cantante del «principe d’Armestat» (Vi-tige); Giulia Giessi bolognese (Edelberto).
FONTI: [Libretto], La fede tradita e vendicata. Dramma per musica da rap-presentarsi in Bergomo nel Carnovale dell’anno 1726 dedicato a S.S. E.E.li signori Alvise Foscarini podestà e Bortolo P.o Gradenigo capitano gran-de, In Bergomo, MDCCXXVI, Per li Fratelli Rossi Stamp. Publ. Pri-vil., Con Licenza de’ Superiori144.
142. Compositore per le messe in scena di Venezia (1704), Firenze (1705), Livor-no (1707), Napoli (1707), Ferrara (1711), Bologna (1712), Roma (1712), Venezia(1715), Torino (1719), Praga (1727) è Francesco Gasparini, mentre per quella di Ve-nezia (1726) è Antonio Vivaldi, cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti9902-9903, 9905-9906, 9909-9911, 9914-9915, 9917-9918.
143. Oltre alla dedica è presente l’abituale avviso al lettore: «Le parole Fato, De-stino, Nume &c. ricevile come scherzi di poesia e non sentimenti da cattolico, chetale si professa l’autore e vivi felice».
144. I libretti consultati si trovano in BCBg, Sala 32 D 2 5 (3) e BNBM, Rac-colta Drammatica 311.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 318
319
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DATA: 1729, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Amore di sangue145
AUTORE: Francesco PasseriniCOMPOSITORE: Giovanni PortaGENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Arnea regina de’ Fenizi; Ormonda principessa d’Egit-
to amante d’Ismeno; Ismeno pittor regio; Aristeo principe di Ci-rene amante d’Ormonda non corrisposto; Creonte principe d’Egit-to tutore d’Ormonda amante d’Arnea.
CAMBI DI SCENA: Atto primo: Galleria di pitture; Appartamenti; At-to secondo: Giardino reale; Atrio regio; Atto terzo: Parco reale; Reg-gia Maestra.
DEDICATARIO: Aurelio Rezzonico podestà; Angelo Contarini capita-nio.
DEDICANTE/IMPRESARIO: Paolo Navaglia146.CANTANTI: Giacinta Spinola cantante del Duca di Parma (Arnea);
Margarita Patriarchi (Ormonda); Paolo Vida (Ismeno); Stefano Pasi(Cirene); Pietro Paolo Monza (Creonte).
FONTI: [Libretto], Amore di sangue. Drama per musica da rappresentarsiin Bergamo il Carnevale dell’anno 1729. Dedicato a Sue Eccellenze li si-gnori Aurelio Rezzonico podestà e Angelo Contarini capitano grande, InVenezia, Nella stamperia nuova di Andrea Pippari e compagno die-tro la chiesa di S. Moisé in Calle Larga, Con licenza de’ Superio-ri147.
DATA: 1729, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.
145. Altro titolo: Amore e fortuna.146. La dedica non è datata. Nell’avviso al lettore l’impresario chiede allo spet-
tatore di essere indulgente nei confronti dell’allestimento: «Compatirai le necessitàdel teatro a cui è convenuto addattarlo».
147. Il libretto consultato si trova conservato nella nella Library of Congress diWashington D. C. (USA).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 319
320
FRANCESCA FANTAPPIÈ
TITOLO: L’Error punito148
AUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Compositore non specificato.GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Alidea regina; Asteria sorella d’Afranio amante di Ro-
lando corrisposta; Rolando principe del Regno amante d’Asteria;Afranio principe del sangue reale amante d’Alidea; Ildoro princi-pe confidente d’Alidea amante d’Asteria.
SCENA: Messana149
CAMBI DI SCENA: Atto primo: Deliciosa nella reggia150; Atto secon-do: Logge; Camera d’Asteria; Atto terzo: Ingresso agli appartamen-ti di Rolando; Tempio di Cerere addobbato per gli sponsali151.
DEDICATARIO: Angelo Contarini capitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: Paolo Navaglia. Dedica: Bergamo gennaio
1729.CANTANTI: Giacinta Spinola cantante del Duca di Parma (Alidea); Mar-
garita Patriarchi (Asteria); Paolo Vida (Rolando); Stefano Pasi (Afra-nio); Pietro Paolo Monza (Ildoro).
FONTI: [Libretto], L’Eror punito. Drama per musica da rappresentarsi inBergomo il Carnevale dell’anno 1729 dedicato a Sua Ecc[ellen]za ilSig[nor] Angelo Contarini da Mula capitano grande, In Bergomo,MDCCXXIX, Per li fratelli Rossi stamp. publ. priv., Con licenzade’ sup152.
DATA: 1729AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]
148. Si tratta dell’unica rappresentazione accertata dell’opera, almeno sotto que-sto titolo.
149. Nella «Delucidazione al Lettore» Pietro Navaglia, impresario dell’opera,giustifica l’insufficienza della messa in scena e del teatro nel modo seguente: «Sor-passerai con benignità li difetti che incontrerai discordi o dall’arte drammatica o daltuo genio: e quelli ancora che devono lasciarsi correre per le convenienze del tem-po e del teatro».
150. Nelle didascalie interne al libretto si precisa: «Deliziosa nella reggia conti-gua al mare».
151. Didascalie interne: «Tempio di Cerere addobbato per gli sponsali d’Alideacon gran cortinaggio» (Atto III, scena VII).
152. Il libretto consultato si trova in BNBM, Raccolta Drammatica 2580.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 320
321
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Ircano innamoratoAUTORE: [Belisario Valeriani]COMPOSITORE: [Fortunato Chelleri]GENERE: IntermezziPERSONAGGI: Lidia; Ircano.CANTANTI: Rosa Venturini cantante del Duca di Parma (Lidia); Gio-
vanni Michelli (Ircano).FONTI: [Libretto], Ircano innamorato. Da rappresentarsi in Bergamo l’an-
no 1729. Dalla signora Rosa Venturini virtuosa di camera di S.A.S. diParma e dal signor Giovanni Michelli, In Venezia, Nella Stamperianuova di Andrea Pippari e compagno, dietro la chiesa di San Moi-sé in Calle larga, Con lincenza de’ Sup153.
DATA: 1733, 9 febbraioAMBITO DELL’EVENTO: [Festa pubblica. Percorso urbano]TIPOLOGIA: [Mascherata]LUOGO: Bergamo: Piazza Vecchia, Porta Sant’Agostino, Borgo San-
t’Antonio, Borgo San Leonardo, piazza Pontida, Porta San Giaco-mo, Mercato delle Scarpe, Palazzo del Podestà.
TITOLO: Il trionfo di CibeleAUTORE: [Giovan Battista Angelini]GENERE: BaccanaleDEDICATARIO: Adriana Dolfin Bonfadini podestaressa.PERSONAGGI: Cibele, due schiavi, Saturno, Cielo, due agricoltori, Pri-
mavera, due giardinieri, Estate, due mietitori, Autunno, satiro, ven-demmiatore, Gennaio, Dicembre, Febbraio, America, Africa, Asia,Europa.
PARTECIPANTI: Podestaressa Andriana Bonfandini (Cibele), Cesare Lu-pi (schiavo), Francesco Agosti (schiavo), conte Febo Alessandri (Sa-turno o Tempo), conte e cavaliere di San Luigi Scipione Boselli (Cie-lo), conte Giulio Cesare Agosti (agricoltore), Pierantonio Furietti(agricoltore), contessa Barbara Roncalli Angelini (Primavera), conteBartolomeo Secco Suardo (giardiniere), conte Francesco GiuseppeTassi (giardiniere), contessa Maria Suardi Roncalli (Estate), AlbertoMoroni (mietitore), Giovanni Medolago (mietitore), contessa Ma-
153. Il libretto consultato si trova in BNBM, Raccolta Drammatica 2772/2.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 321
322
FRANCESCA FANTAPPIÈ
rianna Roncalli Lupi (Autunno), conte Antonio Alessandri (satiro),conte Marchese Girolamo Terzi (vendemmiatore), dottor Giambat-tista Grismondi (Inverno o Gennaio), conte Francesco Colleoni (In-verno o Dicembre), Giuseppe Pezzoli (Inverno o Febbraio), conte e ca-valiere di Malta Giulio Martinoni (America), Antonio Vecchi (Afri-ca), conte Fermo Grumelli (Asia), conte Cristoforo Vimercati Soz-zi (Europa).
MUSICISTI: Conte Ludovico Secco Suardo (flauto o traversiera), aba-te Alessandro Gualdi (flauto o traversiera), conte Pompilio di Ca-leppio (violino), dottor Giovanni Benaglio (violoncello), conte An-tonio Roncalli (violino), conte Giovanni Santi (liuto alla francese),conte Giuseppe Vecchi (violoncello), Prospero Alessandri (violon-cello), Fabio Biffi (violone), Paolo Bresciani (violino), AntonioGritti (violino), Giambattista Carera (violino), Nicola Noris (violi-no).
FONTI: [Descrizione a stampa], Giovan Battista Angelini, Il trionfo diCibele. Rappresentato nella nobile e pomposa Mascherata fatta in Bergo-mo addì 9 febbraio 1733. Baccanale di Giovambattista Angelini a SuaEccellenza la signora Andriana Dolfin Bonfadini podestadessa, in Ber-gomo, MDCCXXXIII, Per li Fratelli Rossi Stampat. Publ. Privil.,Con Licenza de’ Superiori154.
DATA: 1738, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: ArtaserseAUTORE: Pietro MetastasioCOMPOSITORE: Johann Adolf HasseGENERE: Opera seria con intermezzi.PERSONAGGI: Artaserse, figlio del tradito Xerse, erede della Corona
di Persia & amante di Semira; Mandane, sorella d’Artaserse & aman-te d’Arbace; Artabano, prefetto delle guardie reali, uccisore di Xer-
154. Il libretto consultato si trova in CGV, 59 A 245/1. Una copia, non registra-ta da C. Sartori, I libretti italiani a stampa cit. e alla base dello studio di M. Mencaro-ni Zoppetti, …Orobia pendice teatro felice… La festa nella Bergamo del Settecento, in «LaRivista di Bergamo», nuova serie n. 6 (luglio-agosto-settembre 1996), pp. 36-41, èconservata in Biblioteca Angelo Mai.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 322
323
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
se e padre d’Arbace e Semira; Arbace figlio d’Artabano, amante diMandane e fratello di Semira; Semira, figlia d’Artabano & amanted’Artaserse.
CAMBI DI SCENA: Atto primo: Giardino interno della Reggia di Susala quale si vede nel fondo di detto Giardino pensile al lume dellaLuna; Atto secondo: Deliziosa nella Reggia; Atto terzo: Parte in-terna d’una rocca, nella quale è ritenuto priggioniero Arbace conporta che communica con la Reggia.
DEDICATARIO: Maria Querini Corraro moglie del capitanio Vincen-zo Corraro.
DEDICANTE/IMPRESARIO: «L’impresario».CANTANTI: Elisabetta Berti di Venezia (Artaserse); Anna Cosini «vir-
tuosa di S.A.S. il duca di Modona, romana, abitante in Bologna»(Mandane), Antonio Denzi di Venezia (Artabano), Giacinta Spino-la Costantini di Venezia (Arbace), Elisabetta Ricci di Venezia (Se-mira).
CANTANTI DEGLI INTERMEZZI RIDICOLI: «Gl’intermezzi saranno rap-presentati dalli signora Maria Penna di Bologna e dal signor Mat-teo Bevilacqua pur di Bologna».
FONTI: [Libretto], Artaserse. Drama per musica da rappresentarsi in Ber-gamo il Carnevale dell’anno 1738. Dedicato a Sua Eccellenza la signoraMaria Querini Corraro, degnissima cognata di S. E. signor VincenzoCorraro capitano grande, In Bergamo, MDCCXXXVII, Per li FF.Rossi Stamp. Publ. Privil. Con Lic. De’ Sup155.
DATA: 1738, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Intermezzi in musica]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La contadinaAUTORE: [Andrea Belmuro]COMPOSITORE: [Johann Adolf Hasse]GENERE: Intermezzi in musica.PERSONAGGI: Scintilla; Don Tabarano; Corbo servo di Tabarano (per-
sonaggio non parlante); Lucindo amante di Scintilla (personaggionon parlante).
155. Il libretto consultato si trova in BNBM, Raccolta Drammatica 3709.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 323
324
FRANCESCA FANTAPPIÈ
CAMBI DI SCENA: Giardino (primo intermezzo); Bosco (secondo in-termezzo).
CANTANTI: Maria Penna (Scintilla); Matteo Bevilacqua (don Tabarra-no).
FONTI: [Libretto], La contadina. Intermezzi da rappresentarsi in musicanel teatro di Bergamo nel Carnevale dell’anno 1738, in Bergamo,MDCCXXXVII, Per li Fratelli Rossi Stamp. Publ. Privil. Con Li-cenza de’ Superiori156.
DATA: 1738, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identficato.TITOLO: Al sospetto l’effetto per dispettoAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Compositore non specificato.GENERE: Intermezzi ridicoli.PERSONAGGI: Gelsomina, Pedronco, Fabrizio.FONTI: [Libretto], Al sospetto l’effetto per dispetto intermezzi da rappresen-
tarsi in musica nel teatro in Bergamo, nel Carnovale dell’anno 1738, InBergomo, MDCCXXXVIII, Per li Fratelli Rossi Stamp. Publ. Pri-vil., Con licenza de’ superiori157.
DATA: 1738, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Orlando furiosoAUTORE: Autore non specificato158.COMPOSITORE: Compositore non specificato159.GENERE: Opera seria
156. Il libretto consultato si trova in BNBM, Raccolta Drammatica 3721.157. Il libretto consultato si trova in BCBg, Salone Piccola 21 1 8 (7).158. Autore negli allestimenti di Venezia (1713, 1714), Braunschweig (1722), Pra-
ga (1724), Mantova (1725), Brno (1735) è Grazio Braccioli, cfr. C. Sartori, I librettiitaliani a stampa, cit., libretti 17487-17491, 17493.
159. Compositore negli allestimenti di Venezia (1714), Praga (1724), Brno (1735)è Antonio Vivaldi, cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 17488, 17490,17493.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 324
325
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
PERSONAGGI: Orlando innamorato d’Angelica; Angelica, amante e poisposa di Medoro; Alcina maga lasciva e crudele; Medoro, amatoamante d’Angelica; Astolfo amante geloso d’Alcina; Aronte custo-de invulnerabile delle ceneri di Merlino, personaggio che non par-la; Paggi, guardie e cacciatori in seguito dei personaggi; Uno spiri-to in ombra che parla.
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Giardino pensile bagnatoda picciol lago ad uso di bagno da cui si vedono maestose fabbri-che nel recinto di Alcina; Viali di verdura corrispondenti al mareche metterassi improvvisamente in borasca sommergendo una na-ve160; Atto secondo: Atrio confinante con varie stanze d’Alcina; Mon-tuosa alpestre con alta e scocesa rupe su cui si vede un arbore conrami d’oro; Profondata la rupe resta un’orribil caverna nelle visceredella terra161; Atto terzo: Parco delle caccie adorno di fiori con lau-ta mensa attendata e ricche credenze apprestate per gli sponsali d’An-gelica e di Medoro162; Parte esterna del tempio d’Ecate e spezzatasila ferrea porta; Tempio interno con l’urna delle ceneri di Merlinosotto maestosa tribuna levata la qual urna resta; Campagna desertacon un sol arbore a cui stanno appese l’armi d’Orlando163.
DEDICATARIO: «Illustrissime signore dame».DEDICANTE/IMPRESARIO: «L’impresario».CANTANTI: Antonio Denzi di Venezia (Orlando), «Anna Cosimi vir-
tuosa di S. A. S. il Duca di Modena» (Angelica); Giacinta Spinola,or Costantini di Firenze (Alcina); Elisabetta Ricci di Bologna (Me-doro); Elisabetta Berti di Venezia (Astolfo).
160. Nel libretto descritto come: «Viali di verdura corrispondenti al mare, il qua-le si vede in placida calma con nave che va veleggiando prosperamente e in dettiviali le due fonti d’Amore e d’Oblio» (Atto I, scena V). Nel corso della scena una di-dascalia descrive il seguente cambiamento: «Sorge improvvisa procella con tuoni,grandine e venti che sommerge la veleggiante nave». La tempesta è provocata da Al-cina, poiché sulla nave si trova Medoro che viene trascinato sulla spiaggia dell’isolaai piedi di Angelica: «Medoro nuotante nel mare» (Atto I, scena VI).
161. Didascalie interne: «Si profonda la rupe e resta Orlando racchiuso in unaorribil caverna che non ha in parte alcuna l’uscita» (Atto II, scena X).
162. Didascalie interne: «Qui si vedono a comparire per l’aria alcuni amoriniportando il seguente distico in lettere d’oro: Vivan sempre amorosi Angelica e Me-doro amanti sposi» (Atto III, scena II).
163. La tavola delle «Mutazioni di scene» continua con un elenco intitolato: «Tra-sformazioni». Esse sono descritte come segue: «Astolfo in mirto. Alcina in serpen-te. La rupe in antro. Il tempio in deserto».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 325
326
FRANCESCA FANTAPPIÈ
FONTI: [Libretto], Orlando furioso. Drama per musica da rappresentarsi inBergomo il Carnevale dell’anno 1738 consagrato al merito distinto dell’il-lustrissime signore dame della suddetta città, In Bergomo,MDCCXXXVIII, Per li fratelli Rossi Stamp. Publ. Privil., Con Li-cenza de’ Superiori164.
DATA: 1738, agostoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro circense]LUOGO: Bergamo, «casotto dove i comici fanno la commedia».PERFORMER: Uomo deforme.FONTI: [Avviso a stampa], Documento 1738: 1, in Regesto.
DATA: 1740, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La caduta di BajazettoAUTORE: Autore non specificato165.COMPOSITORE: Compositore non specificato166.GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Tamerlano gran Kam de’ Tartari padre di Medraspe e
amante di Roselana; Roselana figlia di Bajazetto, amante di Me-draspe e amata da Tamerlano; Bajazetto imperatore de’ Turchi pa-dre di Roselana e Zeanghire e marito di Atalida; Atalida moglie diBajazetto e madre di Roselana e Zeanghire; Medraspe figlio di Ta-merlano e amante di Roselana; Zeanghire figlio di Bajazetto; Ru-steno eunuco favorito di Bajazetto e poscia di Tamerlano per mez-zo de’ tradimenti a’ suoi stessi sovrani.
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Regio padiglione; Accam-pamento Ottomano; Bosco; Gran piazza167. Atto secondo: Corti-
164. Il libretto consultato si trova in BCPd, H 49502.165. Autore della Caduta di Bajazetto imperatore dei turchi (Praga, 1728) è Antonio
Denzi, cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretto 4355.166. Autore della Caduta di Bajazetto imperatore dei turchi (Praga, 1728) è Giovan-
ni Matteo Lucchini, cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretto 4355.167. La descrizione completa delle scene nelle didascalie del libretto è: «Nell’at-
to primo: Regio padiglione nel campo di Bajazetto a fronte dell’esercito di Tamer-lano che tine assediata Bursa città capitale della Bitinia; Alzate l’ali del padiglione sivede tutto l’accampamento ottomano che termina sopra varie colline a vista della
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 326
327
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
le rustico; Arsenale nautico168; Atto terzo: Stanze nella Reggia; Ba-gni reali; Salone Magnifico169.
CANTANTI: Lorenzo Moretti di Venezia (Tamerlano); Teresa Peruzzi diVenezia (Roselana); Antonio Denzi di Venezia (Bajazetto); GioseffaTedeschini di Milano (Atalida); Nicolino Grimaldi di Sinigaglia(Medraspe); Caterina Zane di Venezia (Zeanghire), Giovan BattistaAcchiappati di Brescia (Rusteno).
FONTI: [Libretto], La caduta di Bajazetto. Drama per musica da rappre-sentarsi in Bergamo nel Carnovale dell’anno MDCCXXXX, In Berga-mo, MDCCXXXX, Per li Fratelli Rossi Stamp. Publ. Privil., ConLicenza de’ Superiori170.
DATA: 1740, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Armida abbandonata171
AUTORE: Francesco Silvani
città in grande distanza. Truppe nel campo in ordinanza di battaglia marcianti pre-cedute da molti elefanti e carri falciati, cammelli e cavalieri dell’equipaggio che van-no sfilando per parte opposta ad assicurarsi su l’erto del monte vicino; Folto boscopoco dal campo di battaglia distante; Gran piazza di Bursa adorna per il trionfo diTamerlano che celebra sopra grande elefante proceduto da insegne tartare e da tro-fei d’attrezzi militari ottomani e da molti schiavi fra’ quali Bajazetto ed Atalida incatene d’oro».
168. Didascalie interne: «Nell’atto secondo: Cortile rustico dell’orrido quartie-re de’ schiavi che vedransi in grande numero e di nationi diverse, aperta che ne sa-rà al cenno di Tamerlano la grande porta d’ingresso; Arsenale nautico in Bursa eret-to. Quantità d’attrezzi nautici e militari cosparsi qua e là ad uso degli artefici impie-gati».
169. Didascalie interne: «Nell’atto terzo. Stanze nella reggia di Bursa adorne al-l’uso de’ Turchi e con origlieri da sedervi sopra; Bagni reali con gran fonte nel mez-zo illuminati di notte; Salone magnifico illuminato di notte con sontuoso appara-to di mensa reale i cui ministri si vedano tutti da maestosa scala a discendere por-tanti vivande e liquori».
170. Il libretto consultato si trova in BNBM, Raccolta Drammatica 4138.171. Nella dedica in merito al soggetto scelto si precisa che il «fondamento fu
tolto dal già famoso abate Silvani dalla Gierusalemme liberata, immortale poema delgrande Torquato Tasso». Opera già rappresentata a Praga (1725) per iniziativa del-l’impresario Antonio Denzi, cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretto2729.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 327
328
FRANCESCA FANTAPPIÈ
COMPOSITORE: Compositore non specificato172.GENERE: Opera in musica con intermezzi.PERSONAGGI: Armida principessa di Damasco amata amante di Ri-
naldo; Rinaldo principe d’Este, uno dei capitani dell’esercito diGoffredo amante amato d’Armida; Rambaldo, nobile di Guasco-gna, pur uno de’ capitani dell’esercito sopradetto, mal graditoamante d’Armida ed apostata per amore di lei; Erminia amante noncorrisposta di Tancredi creduta da principio la guerriera Clorinda;Tancredi principe un altro capitano dell’assediante esercito trattoprigionier con inganno nel castello d’Armida; Ubaldo altro capi-tano del detto esercito spedito da Gottifredo nelle delizie d’Armi-da a recupare Rinaldo; Filomaco filosofo professore della magia na-turale.
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: I. Grotta nelle viscere della terra fattadalla natura e abbellita dall’arte di Filomaco; II. Castello incanta-to d’Armida vicino al mare e circondato d’ameni boschetti; III.Giardino dentro al detto castello, sopra d’un lago di delizia, cir-condato di fabbriche maestose e vaga conchiglia tirata da cavallimarini a diporto d’Armida; IV. Ameno ritiro nelle delizie d’Armi-da; V. Bosco foltissimo con gran cipresso nel mezzo, da cui esco-no vari mostri tra fiamme in difesa dell’armi di Rinaldo a quellosospese; VI. Stanze d’Armida; VII. Cortile nel palazzo d’Armida;VIII. Spiagga del mare con navicella approdata, scoglio in lonta-no sopra di cui il castello d’Armida che si profonda tra fiamme epoi carro tirato da due draghi infernali che porta Armida in aria.
SCENOGRAFO: Francesco ZanoiCANTANTI NELL’OPERA: Teresa Peruzzi di Venezia (Armida); Caterina
Zane di Venezia (Rinaldo); Antonio Denzi di Venezia (Rambaldo);Gioseffa Tedeschini di Milano (Erminia); Lorenzo Moretti di Ve-nezia (Tancredi); Nicolino Grimaldi di Sinigaglia (Ubaldo); GiovanBattista Acchiappati (Filomaco).
CANTANTI NEGLI INTERMEZZI: Nicolino Grimaldi; Giovan Battista Ac-chiappati.
172. Autore della musica nelle edizioni di Bologna (1716), Venezia (1723, 1746)è Giuseppe Maria Buini, mentre per quelle di Venezia (1707), Udine (1710), Verona(1710), Ferrara (1711), Mantova (1711), Pesaro (1715), Padova (1716) è Giovanni Ma-ria Ruggieri, cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 2718, 2720, 2722-2726, 2728, 2732.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 328
329
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
FONTI: [Libretto], Armida abbandonata. Dramma per musica da rappre-sentarsi in Bergamo nel Carnovale dell’anno MDCCXXXX, In Berga-mo, MDCCXXXX, Per li fratelli Rossi Stamp. Publ. Privil., Con li-cenza de’ Superiori173.
DATA: 1740, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La fortunata sventuraAUTORE: Autore non specificato174.COMPOSITORE: Giovan Battista Serini «violinista di Venezia» (per i
recitativi ed alcune parti del dramma) e «celebri autori diversi».GENERE: Opera seria con intermezzi musicali.PERSONAGGI: Aladino re d’Algeri, amante di Fatime e poi di Clime-
ne; Fatime favorita d’Aladino e amante non corrisposta d’Aldimi-ro; Climene sposa promessa ad Aldimiro e amata da Aladino; Al-dimiro sposo promesso a Climene e che poi si scuopre essere Ru-steno, figlio di Aladino re d’Algeri; Acomate, giovine eunuco cor-saro d’Algeri; Comparse: Corsari con Acomate; Schiave con Fati-me; guardie e paggi con Aladino.
DEDICATARIO: Dedicatario non specificato175.CAMBI DI SCENA: Atto primo: I. Scoscesi dirupi di scoglio su le co-
ste del mare africano. Turbine gonfio di tuoni e folgori. Mar bor-rascoso. Nave agitata che poi si sommerge e picciolo palischermoche approda al lido; II. Stanze di Fatime nel Serraglio del Re d’Al-geri; III. Cortile della Reggia sudetta; IV. Atrio maestoso di dettaReggia, corrispondente ad altro cortile; Atto secondo: V. Parte este-riore del Serraglio sudetto, con giardini pensili bagnati dal mare.Luna in Cielo attorniata da nubi e breve schifo, che viene dal ser-raglio medesimo. VI. Stanze di Fatime nel Serraglio con porta degabinetti contigui; Atto terzo: VII. Atrio delle carceri nel serraglio
173. Il libretto consultato si trova in BAM, S. I. G. II. 1.174. Opera già rappresentata a Praga (1725) dall’impresario Antonio Denzi, cfr.
C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretto 10801.175. Dopo l’esposizione dell’argomento segue una dichiarazione dell’autore al
lettore: «Le parole Fato, Destino, Numi, e simili sono semplicemente espressioni poe-tiche, non sentimenti dell’autore, che si professa vero cattolico. Vivi felice».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 329
330
FRANCESCA FANTAPPIÈ
d’Algeri, su cui corrispondono molte prigioni e cortile delle mede-sime; veduta d’interna parte della prigion d’Aldimiro per muragliache resta abbattuta da scossa improvvisa di terremoto, e secreta viasottoranea per l’uscita dette prigioni; VIII. Atrio nella Reggia d’Al-geri; IX. Giardini reali nel serraglio; X. Salone di marmorei colos-si confinante con loggi della reggia d’Algeri e trono alla turca daun lato.
SCENOGRAFO: Federico Zanoi da VeneziaCOSTUMI: Natale Canzian di VeneziaCANTANTI: Lorenzo Moretti di Venezia (Aladino); Teresa Peruzzi di
Venezia (Fatime); Gioseffa Tedeschini di Milano (Climene), NicolaGrimaldi di Sinigaglia (Aldimiro); Caterina Zane di Venezia (Aco-mate), Giovan Battista Acchiappati di Brescia (per gli intermezzi), Ma-ria Penna di Bologna (per gli intermezzi).
FONTI: [Libretto], La fortunata sventura drama per musica da rappresen-tarsi in Bergamo nel Carnovale M.D.CC.XXXX., in Bergamo,M.D.CC.XXXIX, Per li Fratelli Rossi Stamp. Publ. Privil., Con Li-cenza de’ Superiori176.
DATA: post 1740–ante 1767177
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Teatro religioso]LUOGO: Bergamo, Chiesa di San Defendente.TITOLO: Cinque sacre cantate in onore della Passione di Nostro Signore.AUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Carlo OriniGENERE: CantatePERSONAGGI: San Pietro, San Giovanni e Gesù (cantata prima per il
primo venerdì: Cristo che s’incammina all’orto); Testo, Gesù e Maria(cantata seconda: Cristo condotto al calvario); Gesù, Maria e Giovan-ni (cantata terza: Cristo in croce consegna Giovanni alla madre e la ma-dre a Giovanni); Testo, Gesù e Maria (cantata quarta: Gesù in croceche esclama Sitio); Angeli (cantata quinta: Il pianto degli angioli dellapace sopra la Passione di Nostro Signor Gesù Cristo).
DEDICATARIO: Ludovico Macassoli canonico
176. Consultati i libretti conservati in BNBM, Raccolta Drammatica 4185. 2 ein CGV, 57 F 68/1.
177. Pietro Lancellotti è in attività almeno dal 1740 al 1767.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 330
331
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DEDICANTE: «Associati alle funzioni del SS. Redentore».FONTI: [Libretto], Cinque cantate in onore della passione di Nostro Signo-
re da recitarsi nella chiesa di S. Difendente ne’ cinque venerdì precedentialla festa del SS. Redentore operetta dedicata all’illustrissimo signor contecanonico Lodovico Macassoli protettore eletto alla suddette funzioni. Mu-sica del signor Carlo Orini organista nella suddetta chiesa, In Bergamo,Appresso Pietro Lancellotti, Con Licenza de’ Superiori178.
DATA: 1741, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: ArrenioneAUTORE: Francesco SilvaniCOMPOSITORE: Compositore non specificato179
GENERE: Opera seria con intermezzi ridicoliPERSONAGGI: Arrenione, prima bifolco e poi tiranno in Siracusa;
Aquilio, pretore per la Romana Repubblica in Siracusa in abito dibifolgo e sotto nome d’Errenio amante di Merope e fratello di Emi-lia; Emilia sorella d’Aquilio e amante di Amilcare; Linceste figliad’Arrenione, destinata sposa d’Amilcare e amante d’Aquilio credu-to Errenio; Amilcare principe cartaginese adulator del tiranno,amante d’Emilia e fratello di Merope; Merope amata amanted’Aquilio e sorella d’Amilcare.
SCENA: [Siracusa]CAMBIAMENTI DI SCENA PER L’OPERA: 1. Spiaggia di mar borascoso
con veduta di Siracusa e salda di monte ch’occupa parte del Lido;2. Stanze di Linceste con giuochi d’acque e tavoletta; 3. Vasto giar-dino in detta reggia; 4. Parte esterna di Siracusa con subborgo chevanno attualmente edificando cosparso di vari attrezzi ad uso difabricieri; 5. Atrio nella reggia medesima; 6. Stanze terrene con gio-chi d’acque; 7. Luogo magnifico pomposamente adornato per lacoronazion d’Arrenione.
178. Il libretto consultato si trova in BAM, S. N. P. VIII. 7 (15). Sul dorso delvolume: «Cantate ed oratori per musica. Miscell».
179. Autore della musica negli allestimenti di Venezia (1708), Mantova (1711),Brescia (1718), Praga (1726) è Giovanni Maria Ruggieri, cfr. C. Sartori, I libretti ita-liani a stampa, cit., libretti 2832-2834, 2836.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 331
332
FRANCESCA FANTAPPIÈ
CANTANTI: Antonio Denzi (Arrenione); Sebastiano Naldi (Aquilio);Anna Cosimi, cantante del duca di Modena (Emilia); Giulia Frasi(Linceste); Paolo Vida (Amilcare); Teresa Castelli (Merope).
FONTI: [Libretto], Arrenione. Dramma per musica da rappresentarsi in Ber-gomo nel Carnovale dell’anno MDCCXLI, In Bergomo, MDCCXLI,Per li Fratelli Rossi Stamp. Publ. Privil., Con Licenza de’ Superiori,[1741]180.
DATA: 1741, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’impresario d’opere nell’Isola CanarieAUTORE: Pietro MetastasioCOMPOSITORE: Compositore non specificato181.GENERE: Intermezzi per musica.PERSONAGGI: Dorina, Nibio.FONTI: [Libretto], L’impresario d’opere nell’Isole Canarie. Intermezzi per mu-
sica da rappresentarsi nel teatro in Bergomo nel Carnevale dell’annoMDCCXLI, In Bergamo MDCCXLI, Per li Fratelli Rossi Stamp.Publ. Privil., Con Licenza de’ Superiori182.
DATA: 1742, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La clemenza di TitoAUTORE: Pietro MetastasioCOMPOSITORE: Compositore non specificato183.
180. I libretti consultati si trovano in BCBg, Sala 32 D 2 5 (4) e BNBM, Rac-colta Drammatica 4489.
181. Compositore per gli allestimenti di Parigi (1739), Venezia (1741, 1742), Pi-sa (1746), Vienna (1747), Postdam (1748), Parma (1749), Venezia (1749) è LeonardoLeo, per quelli di Copenaghen (s. a.), Gorizia (1742) è Giuseppe Orlandini, per quel-lo di Venezia (1725) è Tommaso Albinoni cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa,cit., libretti 12898, 12905, 12907, 12909, 12911-12914.
182. Il libretto consultato si trova in BNBM, Raccolta Drammatica 4178.183. Compositore per gli allestimenti di Vienna (1733, 1734) e Roma (1734, 1743)
è Antonio Caldara, per quelli di Dresda (1738, 1746), Verona (1738), Berlino (1743),
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 332
333
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
GENERE: Oepera seriaPERSONAGGI: Tito Vespasiano imperatore di Roma; Vitellia figlia del-
l’Imperatore Vitellio; Servilia sorella di Sesto amante d’Annio; Se-sto amico di Tito amante di Vitellia; Annio amico di Sesto aman-te di Servilia; Publio prefetto del pretorio.
SCENA: Quella parte del colle palatino che confina col foro romano.CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Sala Regia; Atrio; Giardi-
no. Atto secondo: Piazza vicina al Campidoglio; Camera. Atto ter-zo: Gabinetto; Luogo magnifico all’anfiteatro.
CANTANTI: Pasqual Negri di Venezia (Tito Vespasiano), Francesca Buf-fel Leoni di Venezia (Vitellia), Caterina Galli di Cremona (Servilia),Carlo Dardocci di Faenza (Sesto), Fortunata Giacinta Cestari di Ve-nezia (Annio), Lucia Fabani (Publio).
FONTI: [Libretto], La clemenza di Tito. Dramma per musica da rappresen-tarsi in Bergamo il Carnovale dell’anno MDCCXLII, Per li Fratelli Ros-si Stamp. Publ. 1742, Con licenza de’ Superiori184.
DATA: 1743, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identficato.TITOLO: La vedova ingegnosaAUTORE: [Tommaso Mariani]COMPOSITORE: Leonardo Leo, Tommaso Prota, Giuseppe Sellitti.GENERE: Intermezzi per musica.PERSONAGGI: Drusilla vedova; Strambone medico; Servo pratico del
Medico, Volpina serva di Drusilla che non parlano.SCENA: Camera con sedie.CANTANTI: Genevra Magagnoli bolognese (Drusilla), Alessandro Cat-
tani da Cesena (Strambone).FONTI: [Libretto], La vedova ingegnosa. Intermezzi per musica da rappre-
Bologna (1743), Amburgo (1745, 1748), è Johann Adolf Hasse, per quello di Mila-no (1738) è Giovanni Maria Marchi, per quello di Torino (1739) è Giuseppe Arena,per quello di Madrid (1747) sono Francesco Corselli, Francesco Corradini e GiovanBattista Mele, per quello di Mannheim (1748) è Carlo Grua, cfr. C. Sartori, I libret-ti italiani a stampa, cit., libretti 5761, 5763-5764, 5770, 5772, 5775, 5777-5779, 5781-5782, 5784, 5786.
184. Il libretto consultato si trova conservato in BNBM, Raccolta Drammatica4129.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 333
334
FRANCESCA FANTAPPIÈ
sentarsi in Bergomo nel carnovale dell’anno MDCCLXIII185, In Bergo-mo, MDCCXLII, Per li fratelli Rossi Stamp. Publ., Con licenza de’superiori186.
DATA: 1743, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Il SiroeAUTORE: Pietro MetastasioCOMPOSITORE: Compositore non specificato187.GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Cosroe re di Persia, amante di Laodice; Siroe primoge-
nito del medesimo e amante d’Emira; Medarse secondogenito diCosroe; Emira principessa di Cambaja in abito da uomo sotto no-me d’Idaspe, amante di Siroe; Laodice amante di Siroe sorella diArasse; Arasse generale d’armi persiane ed amico di Siroe.
SCENA: Città di Seleucia.CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Gran tempio dedicato al
sole con simulacro del medesimo; Camera di Cosroe con cameri-no e sedia; Atto secondo: Parco reale; Appartamenti terreni corri-spondenti a giardini con sedie; Atto terzo: Cortile; Luogo angustorinchiuso nel castello destinato per carcere a Siroe; Gran piazza diSeleuzia.
DEDICATARIO: Giambatttista Albrici capitanio vicepodestà.DEDICANTE/IMPRESARIO: «Li nobili direttori dell’opera». Dedica: Ber-
gamo dicembre 1742FONTI: [Libretto], Il Siroe. Dramma per musica da rappresentarsi in Ber-
185. La data riportata nel titolo è evidentemente sbagliata, né avrebbe alcun sen-so, tenendo conto della data di pubblicazione del libretto. Si tratta, quindi, di unerrore di stampa. Quello più probabile è un’inversione della L e della X. Bisognaquindi leggere «carnovale dell’anno MDCCXLIII», ossia 1743, invece che «carno-vale dell’anno MDCCLXIII».
186. Il libretto consultato si trova nel fondo Carvallais della BCMR.187. Compositore della musica per gli allestimenti di Roma (1740) è Gaetano
Latilla, per quelli di Firenze (1742) e di Livorno (1747) è Giuseppe Scarlatti, di Bo-logna (1743) e Lucca (1748) è Johann Aldolf Hasse, di Venezia (1743) è GennaroManna, cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 22065, 22067, 22069,22072, 22074.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 334
335
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
gomo nel Carnevale dell’anno MDCCXLIII dedicato all’Eccellenza delSignor Giambattista Albrici p.o di S. E. Giambatista proc.r di S. Marcocapitano v. podestà della città medesima, In Bergamo, Per li fratelli Ros-si stamp. pubbl., 1741 [sic], Con licenza de’ superiori188.
DATA: 1751, agostoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro provvisionale in fiera.TITOLO: Demetrio189
AUTORE: Pietro MetastasioCOMPOSITORE: «Di vari autori».GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Cleonice, Alceste, Barsene, Olinto, Fenicio, Mitrane.SCENA: Seleucia190.DEDICATARIO: Dorolice Bolani Maffetti moglie del podestà e viceca-
pitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: Prospero Olivieri «impresario»191.CANTANTI: Rosa Costa «virtuosa di camera di S. A. S. I. Elettore di
Polonia» (Cleonice), Giuseppe Ricciarelli «romano detto il Romani-no» (Alceste), Pasqua Caterina Spina «veneta» (Barsene), Agata Cal-vani «detta la Ricci» (Olinto), Francesco Boschi, Rosanna Perger (Mi-trane).
COSTUMISTA: «Sig. Bianchi milanese».COREOGRAFO: Giacomo Brigenti «di Bologna».BALLERINI: Anna Giringhella, Margherita Fusi, Teresa Moreli, Elena
Zerbini, Giacomo Brigenti, Gaudenzio Berri, Gasparo Pieri, Gio.Battista Ferrei.
188. Il libretto consultato si trova conservato in BNBM, Raccolta Drammatica4266.
189. Nell’avvertimento al lettore si precisa che la versione del dramma è più bre-ve rispetto alla versione originale: «Non mai, per creder soperfluo, ciò che il famo-sissimo autore ha posto nel suo dramma, ma per solo adattarlo alla stagione ed alpiacere del moderno teatro, si è dovuto abbreviarlo».
190. Non esiste una tavola dei cambi di scena. L’unica indicazione presente neltesto è: «Atrio magnifico destinato per le pubbliche udienze» (Atto I, scena I):
191. Nella dedica Prospero Olivieri afferma di essere alla sua prima esperienzacome impresario: «essendo questa la prima volta che, per servire al pubblico, ad unatale impresa m’azzardo».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 335
336
FRANCESCA FANTAPPIÈ
FONTI: [Libretto], Demetrio. Dramma per musica del Sig. Abate Pietro Me-tastasio da rappresentarsi in Bergomo per la prossima fiera di agosto del-l’anno 1751. Dedicato all’imparegiabil merito di S. E. la N. D. DoroliceBolani Maffetti moglie di S. E. Agostino Maffetti Podestà e Vice Capita-nio, In Venezia, MDCCLI, Appresso Modesto Fenzo, Con Licen-za de’ Superiori192.
DATA: 1753, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: TigraneAUTORE: Autore non specificato193.COMPOSITORE: Giuseppe CarcaniGENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Mitridate; Tigrane; Cleopatra; Apamia; Oronte;
Clearte.CAMBI DI SCENA: Atto primo: Campagna nelle vicinanze di Sinope.
Da una parte mura e magnifica porta della città194; Stanza di Cleo-patra nella Reggia195; Atto secondo: Giardino di fiori, fontane, grot-tesche e sedili di verdura; Rotonda tutta adornata con statue dibronzo nel palazzo reale dov’è custodito Tigrane; Borghi della Cit-tà: in prospetto e da un lato facciata delle mura del regio castello
192. Dati ricavati dall’unico libretto esistente, conservato in USA, Austin, Uni-versity of Texas, Music Library and Humanities Research Center.
193. Autore delle rappresentazioni di Napoli (1729) è Francesco Silvani, quelladi Venezia (1747) sono Francesco Silvani e Carlo Goldoni, quelle di Venezia (1741,1747), Cremona (1751), Pistoia (1755), Torino (1761), Venezia (1762) è Carlo Goldo-ni, cfr. C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit., libretti 23126, 23130, 23134, 23137,23142, 23145, 23146.
194. Non esiste una tavola delle scene che pertanto si ricavano dalle didascalieinterne al libretto: «Campagna nelle vicinanze di Sinope. Da una parte mura e ma-gnifica porta della città. Vicina alle mura tenda militare ad uso di trono con due se-dili. Dall’altra parte archi, statue e trofei. In prospetto fiume e sopra del fiume pon-te di barche praticabile. In lontano collinette sopra le quali schierato si vede nume-roso esercito, dal quale preceduto da strepitosa militare sinfonia viene sopra carrotrionfale Tigrane sotto nome d’Argene, accomapgnato dalla sua guardia, parte a ca-vallo e parte a piedi, con prigionieri e spoglie nemiche, ec.» (Atto I, scena I).
195. Didascalie interne: «Stanza di Cleopatra nella Reggia e in disparte due cu-scini per sedere» (Atto I, scena V).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 336
337
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
con fortificazione all’antica, torri e palazzo reale. Arieti, macchinemilitari196; Atto terzo: Gran padiglione nell’accampamento de’Massageti che poi si apre; altre tende all’incontro; S’apre il padi-glione e si vede Cleopatra che riviene in sé dallo svenimento; Tri-buna nella reggia ove Mitridate suole dare udienza; Grande atrioche introduce al tempio di Giove, il di cui interno si vede alzato avarie tribune, con scalinate praticabili e diversi trasparenti197.
SCENOGRAFO: «Signori Brignoli e Federici»DEDICATARIO: Galeazzo Dondi Orologio podestà; Niccolò Erizzo ca-
pitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: «L’impresario»CANTANTI: Ercole Ciprandi (Mitridate); Angelo Rottigni (Tigrane); An-
na Chiara Deb (Cleopatra); Elena Tagliabò (Apamia); Regina Ron-chetti (Oronte); Antonio Priorino (Clearte).
COREOGRAFO: Giovan Domenico Giusani.BALLERINI: Giuseppa Bernachi; Angiola Vimercati; Caterina Sacchi;
Gio. Domenico Giusani; Carlo Negri; Pietro Boerio.FONTI: [Libretto], Il Tigrane drama per musica da rappresentarsi in Berga-
mo nel Carnevale dell’anno 1753. Dedicato agl’Illustriss. ed Eccellentiss.Signori Galeazzo Dondi Orloggio podestà, Nicolò Erizzo P. Capitanio,In Bergamo, Per Giovanni Santini, Con Licenza de’ Superiori198.
DATA: 1754, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]
196. Atto II, scena XII. Alla fine della scena la seguente descrizione: «Allo stre-pito de’ militari stromenti segue l’assalto delle mura, le quali dopo ostinato contra-sto cadono a terra all’urto degli arieti e si apre la vista all’interiore fortezza, da unaparte della quale si scorge magnifica scalinata praticabile che dà l’ingresso alla Reg-gia di Mitridate. Segue sanguinoso conflitto fra’ soldati di Clearte e d’Oronte che sistendono parte dinanti alle mura, parte entro la gran piazza del castello e parte perla mura del medesimo. Restano sconfitte e fugate le truppe d’Oronte ed intanto Ti-grane per la breccia parte s’incammina alla reggia e s’incontra in Cleopatra che fret-tolosa scende la scalinata, ec.».
197. La didascalia continua: «Grande atrio che introduce al tempio di Giove, ildi cui interno si vede alzato a varie tribune, con scalinate praticabili e diversi traspa-renti che rappresentano le diverse azioni e fatti della detta deità. Nel mezzo altaresacro ad Imeneo e da una parte dell’atrio ara funebre. Vasi vittimatj [sic] e strumen-ti di sacrifici ec. Trono da una parte» (Atto III, scena XII).
198. Il libretto consultato si trova in FGCV.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 337
338
FRANCESCA FANTAPPIÈ
LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: AntigonoAUTORE: Pietro MetastasioCOMPOSITORE: Gioacchino CocchiGENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Antigono re di Macedonia; Berenice principessa
d’Egitto promessa in sposa ad Antigono; Ismene figliuola di An-tigono amante di Alessandro; Alessandro re d’Epiro amante diBerenice; Demetrio figliuolo d’Antigono amante di Berenice;Clearco capitano delle guardie d’Alessandro e amico di Deme-trio.
SCENA: Tessalonica città marittima della Macedonia.CAMBI DI SCENA: Atto primo: Giardino Reale; Strada di fabbriche an-
tiche che corrisponde al porto di Tessalonica dal quale viene Ales-sandro; Atto secondo: Camere adorne di statue e pitture; Loggereali, con veduta d’una parte del campo distrutto, e di parte delsuddetto porto; Atto terzo: Luogo di prigioni; Gabinetto con por-ta praticabile; Reggia.
SCENOGRAFO: Giacomo Antonio Rodegario bergamasco199.DEDICATARIO: Niccolò Erizzo capitanio e vicepodestà.DEDICANTE: «Gl’impresari».CANTANTI: Antonio Cataneo (Antigono), Anna Chiari Dehe (Bereni-
ce), Ippolita Mondini (Ismene), Rosa Curioni (Alessandro), Carlo Ni-colini (Demetrio), Regina Beloni (Clearco).
COSTUMISTA: Francesco MaininoCOREOGRAFO: Gaudenzio BerriBALLERINI: Maddalena Offarelli, Chiara Montagnani, Giuseppa Mar-
chetta, Gaudenzio Berri, Filippo Porzio, Giovan Battista Bossi, Ge-rolama Monti200.
FONTI: [Libretto], Antigono dramma per musica da rappresentarsi nel tea-tro di Bergamo il carnevale dell’anno 1754. Dedicato al merito impareg-giabile di S. E. Nicolò Erizzo capitano e vicepodestà, In Bergamo, PerGiovanni Santini, Con Licenza de’ Superiori, 1754201.
199. «Le scene sono tutte di nova e vaga invenzione del sig. Giacom AntonioRodigario bergamasco».
200. «Ballerà a sola fuori de’ concerti».201. Il libretto è conservato nella Music Library dell’Università di Berkeley in
California.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 338
339
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DATA: 1754, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Le pescatriciAUTORE: Carlo GoldoniCOMPOSITORE: Baldassare Galuppi detto BuranelloGENERE: Opera buffa202.PERSONAGGI: Eurilda creduta figlia di Mastricco; Lindoro principe di
Soriento; Nerina pescatrice sorella di Frisellino e amante di Bur-lotto; Lesbina pescatrice sorella di Burlotto e mante di Frisellino;Frisolino203 pescatore amante di Lesbina; Burlotto pescatore aman-te di Nerina; Mastricco vecchio pescatore; Coro di pescatori e pe-scatrici; Seguito di Lindoro.
SCENA: «Le spiaggie di Taranto»CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Spiaggia di mare, poi bar-
ca deliziosa per l’arrivo di Lindoro; Recinto d’alberi folti che di-fendono da’ raggi del sole, con sedili erbosi d’intorno; Atto secon-do: Cortile che introduce al giardino delizioso; Collina praticabi-le con fontana al piano; Recinto di capanne che formano una piaz-zetta nel mezzo, con sedili erbosi d’intorno; Atto terzo: Tempiodedicato a Nettuno204; Spiaggia di mare illuminata in tempo di not-te, con barche adornate di fanò per l’imbarco di Eurilda.
SCENOGRAFO: Giacomo Rodigario d’AlbinoDEDICATARIO: Niccolò Erizzo capitanio e vicepodestàDEDICANTE/IMPRESARIO: «Gli impresari».CANTANTI: Vittoria Quercioli (Eurilda), Enrico Cataneo (Lindoro), Se-
rafina Penni (Nerina), Anna Quercioli Laschi virtuosa di camera diS. A. R. il principe Carlo duca di Lorena e di Baviera (Lesbina), Fi-lippo Laschi virtuoso di camera di S. A. R. il principe Carlo ducadi Lorena e di Baviera (Frisolino), Gaspero Barozzi (Burlotto), An-tonio Nesti (Mastricco).
COSTUMISTA: Francesco Mainino di MilanoBALLERINI: «Otto ballerini»
202. Nella dedica gli impresari definiscono l’opera un «dramma bernesco».203. Il personaggio viene indicato indifferentemente Friselino o Frisolino.204. Descritto anche come: «Picciolo Antico Tempio dedicato a Nettuno».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 339
340
FRANCESCA FANTAPPIÈ
FONTI: [Libretto], Le pescatrici. Dramma giocoso per musica da rappresen-tarsi nel teatro di Bergamo. Nella primavera dell’anno 1754. Dedicato al-l’Illustrissimo ed Eccellentissimo Signor Nicolò Erizzo P[rim]o CapitanioVicepodestà, In Bergamo, MDCCLIV, Appresso Pietro Lancellotti,Con Licenza de’ Superiori205.
DATA: 1755, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: ArtaserseAUTORE: Pietro MetastasioCOMPOSITORE: Giovan Battista PescettiGENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Artaserse principe e poi re di Persia amico d’Arbace ed
amante di Semira; Mandane sorella di Artaserse ed amante di Ar-bace; Artabano prefetto delle guardie reali, padre di Arbace e diSemira; Arbace amico d’Artaserse ed amante di Mandane; Semirasorella d’Arbace ed amante d’Artaserse; Megabise generale dell’ar-mi e confidente d’Artabano.
SCENA: Città di Susa reggia de’ monarchi persiani.CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Portico terreno nella reg-
gia del re di Persia corrispondente a’ reali giardini; Atrio nella reg-gia. Atto secondo: Galleria nella reggia; Gran sala del real consigliocon trono da un lato, sedili dall’altro per i grandi del regno, tavoli-no e sedie vicino al suddetto trono. Atto terzo: Interno del castel-lo, nel quale è ritenuto prigione Arbace. Cancelli in prospetto. Pic-ciola porta a mano destra per la quale si ascende alla reggia; Gabi-netto negli appartamenti di Mandane; Luogo magnifico destinatoper la coronazione di Artaserse. Trono da un lato con sopra scettroe corona. Ara nel mezzo accesa con simulacro del sole.
SCENOGRAFO: Giovanni Maria GiussaniDEDICATARIO: Lucchese Loredan PriuliDEDICANTE/IMPRESARIO: «Gli associati nell’opera».CANTANTI: Antonio Fratta (Artaserse), Chiara Marini (Mandane), Au-
relio Arigoni Rossi (Artabano), Margarita Giacomazzi «virtuosa di
205. Il libretto consultato si trova in ACRo, Biblioteca Silvestriana, Op. 877.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 340
341
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
camera all’attual servizio di S.A.S. Elettrice di Baviera» (Arbace), An-na Fabris (Semira), Paolo Baregi (Megabise).
COSTUMISTA: Francesco MaianinoCOREOGRAFO: Giovan Battista MarcandiniFONTI: [Libretto], Artaserse dramma per musica nel teatro di Bergamo nel
Carnevale dell’anno 1755 dedicato a Sua Eccellenza la sig. Luchese Lore-dana Priuli dignissima consorte dell’Illustrissimo ed Eccellentissimo sig. Pie-tro Priuli proveditor estraordinario, In Bergamo, Per Giovanni Santi-ni, Con Licenza de’ Superiori206.
DATA: 1756AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA: Capocomico Francesco BertiATTORI: Francesco Berti (Brighella)FONTI: [Repertorio biografico], Francesco Saverio Bartoli, Notizie isto-
riche de’ comici italiani che fiorirono intorno all’anno MDL fino a’ gior-ni presenti, In Padova, Per li Conzatti, 1781, vol. I, p. 121.
DATA: 1756, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: [Bergamo, teatro di fiera]TITOLO: L’eroe cineseAUTORE: Pietro MetastasioCOMPOSITORE: «Diversi celebri autori»GENERE: Opera seria con intermezzi danzati.PERSONAGGI: Leango reggente dell’Impero Cinese; Siveno creduto fi-
gliuolo di Leango, amante di Lisinga; Lisinga principessa tartaraprigioniera de’ cinesi, amante di Siveno; Minteo mandarino d’ar-mi, amante di Ulania, amico di Siveno; Ulania sorella di Lisingaamante di Minteo; Comparse: paggi cinesi; Mandarini d’armi e dilettere; Soldati tartari e cinesi.
SCENA: Recinto imperiale «nella città di Singana».CAMBI DI SCENA: Atto primo: Appartamenti nel Palazzo Imperiale,
destinati alle tartare prigioniere, distinti di strane pitture, di vari tra-
206. Il libretto consultato si trova conservato in BNBM, Raccolta Drammatica3495.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 341
342
FRANCESCA FANTAPPIÈ
sperenti, di ricchi panni, di vivavi tapeti, e di tutto ciò che serve allusso ed alla delizia cinese. Tavolino e sedia da un lato; Atto se-condo: Loggie terrene, dalle quali si scuopre gran parte della realCittà di Singana, e del fiume che la bagna. Le torri, i tetti, le Pago-di, le navi, gli alberi istessi, e tutto ciò che si vede ostenta la diver-sità con la quale producono in clima così diverso non men la na-tura che l’arte; Atto terzo: Luogo solitario ed ombroso ne’ giardi-ni imperiali. Parte interna ed illuminata delle maggiore ImperialePagode. Così la struttura, come gli ornamenti del magnifico edifi-cio esprimono il genio ed il culto della nazione.
DEDICATARIO: Luchese Loredan Priuli moglie di Pietro Priuli provve-ditore straordinario.
DEDICANTE/IMPRESARIO: «L’impresario»CANTANTI: Mauro Malvasi di Mantova (Leango), Giuseppe Cimino
di Napoli (Siveno), Angiola Cattarina Riboldi da Milano (Lisinga),Gaetana Arifi di Piacenza (Minteo), Teresa d’Uccedo da Milano(Ulania).
BALLERINI: Anna Massese virtuosa di Sua Altezza Reale don Filippoduca di Parma [prima ballerina]; Baldassare Albuzio [primo balle-rino]; Giacinta Radaeli; Nonciadina Cassati; Francesco Bertarini;Anibale Petrazani; Antonia Cappellina; Valentino Riva.
COSTUMISTA: Francesco Mainino di MilanoFONTI: [Libretto], L’Eroe cinese. Dramma per musica del signor abate Pie-
tro Metestasio romano da rappresentarsi nel teatro di Bergamo nella fieradel corrente anno 1756. Dedicato al merito impareggiabile di Sua Eccel-lenza la Sig. Luchese Loredan Priuli degnissima consorte dell’Illustrissimoet Eccellentissimo Signor Pietro Priuli proveditore estraordinario, in Ber-gamo, Per Francesco Traina, MDCCLVI, Con Licenza de’ Supe-riori, [1756]207.
DATA: 1757, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro di Cittadella.TITOLO: Il filosofo di campagnaAUTORE: Carlo Goldoni
207. Libretti consultati in BNBM, Raccolta Drammatica 4193. 2 e in CGV, 59A 245/4.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 342
343
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
COMPOSITORE: Baldassarre Galuppi detto BuranelloGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Eugenia figlia nubile di don Tritemio; Rinaldo genti-
luomo amante d’Eugenia; Nardo ricco contadino detto il filosofo;Lesbina cameriera in casa di don Tritemio; Don Tritemio cittadi-no abitante in villa; Lena nipote di Nardo; Capocchio nodaro del-la villa.
DEDICATARIO: Sebastian Venier capitanio e vicepodestà.DEDICANTE/IMPRESARIO: «Il Direttore».CANTANTI: «Parti serie»: Anna Dechè (Eugenia), Angela Leonardi det-
ta la Taccarini (Rinaldo); «Parti buffe»: Giovanni Leonardi (Nardo);Lavinia Guadagni (Lesbina); Giuseppe Guadagni (don Tritemio); Ma-rianna Brivio (Lena); Francesco Moro (Capocchio).
SCENOGRAFI: Giovanni Maria Giussani208.CAMBI DI SCENA: Atto primo: Giardino; Bosco con casa rustica; Ca-
mera con porte; Atto secondo: Camera; Bosco con casa rustica;Camera sudetta; Atto terzo: Bosco con casa rustica sudetta.
COSTUMISTI: Giovan Battista Fornacini bresciano.COREOGRAFO: Giulio SalamoniBALLERINI: Margherita Morelli, Giovan Battista Nichili, Marianna Ni-
colini, Giulio Salamoni, Annamaria Salamoni, Luigi Luchisino,Domenico Morelli.
FONTI: [Libretto], Il filosofo di campagna. Dramma giocoso per musica darappresentarsi nel teatro di Cittadella di Bergamo nel Carnevale 1757. De-dicato a Sua Eccellenza il signor Sebastian Venier Capitanio e V. Podestà,in Bergamo, MDCCLVI, Per Francesco Traina, Con Licenza de’Superiori209.
DATA: 1758, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: La ritornata di LondraAUTORE: Carlo GoldoniCOMPOSITORE: Domenico FischiettiGENERE: Opera buffa
208. Nel libretto citato come «signor Giuzzani».209. Il libretto consultato si trova in CGV, 59 A 245/3.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 343
344
FRANCESCA FANTAPPIÈ
PERSONAGGI: Il conte Ridolfino; La contessa sorella del conte; Ma-dama Petronilla virtuosa di musica; Giacinta cameriera di Mada-ma; Carpofero amante di Madama che si finge fratello; Il marche-se del Topo; Il barone di Montefresco.
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Piazza con casa da un la-to210; Camera211. Atto secondo: Camera. Atto terzo: Camera; Piaz-za con casa come sopra nella scena prima dell’atto primo212.
SCENOGRAFO: Giacomo Rodegario d’Albino.DEDICATARIO: Sebastiano Venier capitanio e vicepodestà.DEDICANTE/IMPRESARIO: «L’impresario».CANTANTI: Angela Leonardi detta la Tacarini (Il conte Ridolfino, parte
seria); Francesca Mucci (La contessa, parte seria); Agata Ricci (Ma-dama Petronilla, parte buffa); Anna Zanini (Giacinta, parte buffa);Gio[v]anni Leonardi (Carpofero, partre buffa), Ambrogio Ghezzi (Ilmarchese del Topo, pare buffa), Giacomo Caldinelli (Il barone di Mon-tefresco, parte buffa).
COSTUMISTA: Francesco MaininoCOREOGRAFO: Francesco BonnucciBALLERINI: Francesco Benucci detto dell’Aquila (serio); Gerolama
Monti (seria); Michele Costa (grottesco), Brigida Coronati (grotte-sca), Francesco Curioni (grottesco), Teresa Vismara (grottesca).
FONTI: [Libretto], La Ritornata di Londra. Dramma serio e giocoso permusica di Polisseno Fegejo P. A. da rappresentarsi nel teatro della Cit-tadella di Bergamo nell’anno 1758. Dedicato a Sua Eccellenza il signorSebastian Venier, capitanio e v. podestà, Bergamo, per il Traina,1757213.
210. La didascalia interna descrive la scena come segue: «Piazza colla casa delconte da un lato. Vedesi arrivato il carrozzino di Madama Petronilla ed un calessedi seguito per la cameriera, ed un cameriere, e vari servitori di dietro di ciascun le-gno. Smontano dal calesse Giacinta ed il cameriere ed i servitori tutti e s’accostanoal carrozzino di cui apresi l’uscita. Escono Madama Petronilla, il marchese del To-po il barone tedesco e carpofero. Dal palazzo del conte vengono altri servitori a ri-cever Madama invitandola ad entrare per ordine del padrone» (Atto I, scena I).
211. Didascalia interna: «Camera in casa del conte» (Atto I, scena V).212. Didascalia interna: «Piazza come nella scena dell’atto primo col carrozzi-
no di Madama ec.» (Atto III, scena VI).213. I dati si ricavano dal libretto conservato nella collezione privata Thomas
Walker di Ferrara. Un ulteriore esemplare dell’opera è conservato in Belgio, Bruxel-les, Bibliothèque Royale Albert 1er.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 344
345
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DATA: 1758, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro di fiera.TITOLO: Armida maga abbandonataAUTORE: [Francesco Silvani]214
COMPOSITORE: Compositore non specificato.GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Armida215; Rinaldo216; Rambaldo217; Tancredi218; Ermi-
nia219; Ubaldo220.CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Castello d’Armida221; Va-
sta deliziosa peschiera222; Ameno ritiro de’ Carpani223; Bosco in-
214. Nel presentare l’argomento dell’opera al lettore si dichiara che «la lettura erappresentazione del dramma ti renderà più intelleggibil l’intreccio, così dal celebrefu signor abate Silvani ridotto sui fondamenti dell’immortale poema del grande Tor-quato Tasso, combinando più azioni in un sol luogo, la quale licenza à in oggi ser-vito d’esempio a qualche variazione dalle edizioni passate, non già con presunzio-ni di correggere, ma sol per accomodarsi alle circostanze che incontrasi nel reitera-re le produzioni».
215. La descrizione continua: «principessa real di Damasco, amata amante diRinaldo ed amata dal rinegato Rambaldo».
216. Continua: «principe estense, guerriero del campo fedele, amato amante d’Ar-mida».
217. Continua: «rinegato guerriero guascone amante abbandonato d’Armida».218. Continua: «guerriero nel campo de’ fedeli amante non corrisposto della
guerriera Clorinda».219. Continua: «principessa reale d’Antiochia che sotto le spoglie di Clorinda
segue l’amato Tancredi».220. Continua: «guerriero tra’ Franchi in traccia di Rinaldo».221. La descrizione completa è: «Castello d’Armida in forma sferica ed ampia
figura, bagnato in parte da un fiume; con mura adorne pomposamente di statue,balaustri, fontane e colti arboscelli. Porta magnifica con ponte levatoio che appog-gia sul margine d’ampia fossa ripiena di limpidissime acque. Luna che va tramon-tando».
222. Continua: «Vasta deliziosa peschiera nel mezzo ai giardini del castello d’Ar-mida tutta adorna di balaustri, statue, vasi e fontane, e cinta da maestosissime fab-briche sfericamente disposte ed adorne nella lor somità di platani e statue. Conchi-glia tirata da due cavalli marini, e corteggiata da tritoni ed amori portanti un sericopanno per difende dal sole Armida e Rinaldo che vanno in essa galeggiando su quel-l’acque a diporto».
223. Continua: «Ameno ritiro de’ Carpani adorno di fiori, statue e sedili nelledelizie d’Armida».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 345
346
FRANCESCA FANTAPPIÈ
cantato224; Atto secondo: Appartamenti terreni d’Armida225; Spiag-gia del mare226.
DEDICATARIO: Francesco Rota capitanioDEDICANTE/IMPRESARIO: Francesco Puttini. Data: Bergamo, 15 ago-
sto 1758.CANTANTI: Angelica Sayz (Armida), Francesco Rolfi (Rinaldo), Erco-
le Ciprandi (Rambaldo), Antonio Priora (Tancredi), Francesca Muc-ci (Erminia), Bartolomeo Agazzi (Ubaldo).
COREOGRAFO: Carlo SabbioniBALLERINI: Carlo Sabbioni, Domenico Ciutti, Ignazio Clerico, Anto-
nio Mojoli, Margarita Fusi, Angiola Agostinelli, Teres Vismara, Cri-stina Colombi.
FONTI: [Libretto], Armida maga abbandonata. Dramma per musica darappresentarsi nel Teatro di Bergamo in occasione della solita fiera del1758. Dedicato a Sua Eccellenza il N. O. Francesco Rotta capitan gran-de di detta Città, in Milano, Per Carlo Ghislandi, Con licenza de’Superiori, [1758]227.
DATA: 1759, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro provvisorio in legno sotto la loggia del Pa-
lazzo della Ragione.TITOLO: I due vecchi rivali228
AUTORE: Autore non specificato.
224. Continua: «Bosco incantato con gran cipresso nel mezzo a cui stanno ap-pesi l’elmo, l’usbergo e la spada di Rinaldo con quella ancora di Tancredi custoditeda mostri infernali che compariscon tra fiamme e indi piomban fugati sotterra».
225. Continua: «Appartamenti terrreni d’Armida con origlieri che servono di se-dili all’uso orientale».
226. Continua: «Spiaggia del mare da cui si vede sopra d’un eminente scoglioil grande incantato castello d’Armida, che poi ad una scossa di terremoto si accen-de, rovina e piomba tra fiamme in una voragine. Navicella retta dalla fortuna, cheapproda al lido, e carro infernale tirato da tue mostruosi dragoni che porta Armidafra nubi infocate per l’aria».
227. Il libretto è conservato nella Music Library dell’Università di Berkeley inCalifornia.
228. Unica opera conosciuta con questo titolo, altrimenti nota come La facen-diera di autore e musica sconosciuti.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 346
347
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
COMPOSITORE: [Giovan Battista Pergolesi]GENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Filauro; Elisa; Baldone vecchio avaro amante di Cec-
china; Cecchina; Don Scialappa; Flavia; Lelio.SCENA: LivornoCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Porto di Livorno; Casa di Cecchina229.DEDICATARIO: Francesco Rota capitanio e vicepodestà.DEDICANTE/IMPRESARIO: Francesco Puttini. Data: Bergamo gennaio
1759.CANTANTI: Giuseppa Uzedo Bigiogero (parte seria, Filauro); Perina
Rampazzi (parte seria, Elisa); Carlo Paganini cantante di Sua Mae-stà di Prussia (parte buffa, Baldone); Teresa Alberis cantante del redi Polonia (parte buffa, Chechina); Pietro Bigiogero (parte buffa, donScialappa); Rosa Banti (parte buffa, Flavia); Gaetano Monza (par-te buffa, Lelio).
COSTUMISTA: Francesco MaininiCOREOGRAFO: Giuseppe De StefaniFONTI: [Libretto], I due vecchi rivali. Dramma giocoso per musica da rap-
presentarsi nel teatro della magnifica città di Bergamo. Dedicato a Sua Ec-cellenza il signor Francesco Rotta capitano v. podestà di detta città, In Ber-gamo, Per F. Traina, MDCCLIX, Con Licenza de’ Superiori230;[Suppliche e deliberazioni], Documenti 1758: 4-5, in Regesto.
DATA: 1761, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: Il mercato di MalmantileAUTORE: [Carlo Goldoni]COMPOSITORE: Domenico Fischietti napoletano231
GENERE: Opera buffa
229. Non esiste una tavola iniziale delle scene. Le indicazioni si ricavano dalledidascalie del testo che, purtroppo, è mutilo e si conclude con l’atto II, scena VIII.
230. L’unico esemplare esistente è conservato nella Biblioteca Nazionale Mar-ciana di Venezia alla collocazione DRAMM. 1123.004.
231. Segue nella tavola iniziale la seguente precisazione: «E la musica del secon-do dramma N. N. è del celebre sig. Piccini napolitano». Nel corso del Carnevale era,quindi, prevista una seconda opera buffa, con musica di Nicola Piccinni.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 347
348
FRANCESCA FANTAPPIÈ
PERSONAGGI: La Marchesa Giacinta vedova; Il Conte della Rocca giu-risdicente; Brigida figliuola di Lampridio; Lena contadina; Ceccacontadina; Rubiccone ciarlatano; Lampridio governatore di Mal-mantile; Berto contadino sciocco.
CAMBI DI SCENA: Atto primo: Piazza rustica in pianura con fabbri-che antiche e in distanza il castello di Malmantile sopra collina232;Camera in casa di Lampridio; Atto secondo: Giardino in casa diLampridio; Camera in casa di Lampridio con tavolino e sedie; At-to terzo: Sala.
SCENOGRAFO: Giacomo RodegarioDEDICATARIO: Cataruzza Grimani Pisani capitania.DEDICANTE: «Li Direttori»CANTANTI: Perina Rampazzi (La marchesa Giacinta vedova, parte seria),
Francesca Crescenti (Il conte della Rocca, parte seria), Lavinia Gua-dagni (Brigida, parte buffa), Anna Valsecchi (Lena, parte buffa), An-giola Todeschini (Cecca, parte buffa), Giovan Battista Zonca (Rubic-cone, parte buffa), Giuseppe Guadagni (Lampridio, parte buffa), Giu-seppe Fonti (Berto, parte buffa).
COSTUMISTA: Francesco MaininoCOREOGRAFO: Giovan Battista BorsettiniBALLERINI: Madama Lionet Borsettini, Giovan Battista Borsettini,
Vittoria Varè, Bortolo Benaglia, Antonia Negrini, Francesco Sedi-ni.
FONTI: [Libretto], Il mercato di Malmantile dramma giocoso per musica.Da rappresentarsi nel Teatro di Cittadella di Bergamo, nel Carnovale del-l’anno 1761. Umiliato a Sua Eccellenza la nob. donna Cattaruzza Gri-mani Pisani capitania degnissima d’essa città, In Bergamo, MDCCLX,Per Francesco Traina, Con licenza de’ Sup233.
DATA: 1762AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Teatro religioso]
232. Continua: «Varie botteghe ammovibili con merci e venditori che formanoil mercato e vari contadini e contadine che vendono i loro prodotti». Non esiste unatavola delle scene, ma i dati sui cambi di scena si ricavano dalle didascalie interneal libretto.
233. Il libretto è conservato nella Music Library dell’Università di Berkeley inCalifornia.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 348
349
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
LUOGO: Bergamo, chiesa di S. Rocco in Borgo San Leonardo.TITOLO: Componimento drammatico sopra la nascita di San Rocco.AUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Quirino Gasparini234
GENERE: [Cantata]PERSONAGGI: Fedele vescovo di Narbona; Giovanni e Libera genito-
ri di San Rocco.DEDICATARIO: Carlo Barca ministro della chiesa di San Rocco.FONTI: [Libretto], Componimento drammatico sopra la nascita di S. Roc-
co da cantarsi nella sua chiesa in Borgo S. Lionardo la sera precedente ladi lui festa offerto all’illustrissimo signor Carlo Barca ministro vigilantis-simo della chiesa stessa, Bergamo, MDCCLXII, Appresso Pietro Lan-cellotti, Con Licenza de’ Superiori235.
DATA: 1762, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’amante di tutteAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Baldassarre GaluppiGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: «Parte seria»: Rosaura amante del conte Eugenio; «Par-
ti buffe»: Conte Eugenio amante di tutte; Clarice donna affettata;Don Orazio uomo vecchio e marito di Lucinda; Marchese Can-ppio povero e superbo; Lucinda moglie di Orazio; Dorina came-riera di Lucinda; Mingone contadino di don Orazio.
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Campagna con palazzetto con portaaperta in prospetto e casa rustica da una parte; Sala; Camera oscu-ra con porte laterali; Camera236.
SCENOGRAFO: Giovanni Maria Giussani237
234. La descrizione completa è la seguente: «La Musica è del signor abbate donQuerino Gasparini accademico filarmonico di Bologna e maestro di cappella nel-l’insigne metropolitana di Torino».
235. Il libretto consultato si trova in BAM, S. I. F. V. 29 (6).236. I cambi di scena si ricavano dalle didascalie del testo, in quanto non esiste
una tavola iniziale delle scene.237. Nel libretto registrato come «Gio. Ghusani».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 349
350
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DEDICATARIO: Marin Cavalli capitanio e vicepodestà.DEDICANTE/IMPRESARIO: «Gl’impresari».CANTANTI: Francesca Corsini (Rosaura), Michelangelo Potenza (conte
Eugenio), Valburga Compassi «virtuosa di SAS Elettoral di Bavie-ra» (Clarice); Domenico Poggi (don Orazio); Gaetano Baldi (marche-se Canoppio); Anna Gallo (Lucinda); Annunziata Stelzer (Dorina);Ventura Cavalli (Mingone).
COSTUMISTA: Francesco MaininoCOREOGRAFO: Bartolomeo CambiBALLERINI: Bartolomeo Cambi; Anna Bresciani; Mauro Zaccarini;
Maria Teresa Mombelli; Carlo Finetti; Signora Caterina Verga; Na-tal Croce; Giuseppe Olivaris; Maria Picca (fuori d’e concerti); Gio-vanni Guidetti (fuori de’ concerti).
FONTI: [Libretto], L’amante di tutte. Dramma giocoso per musica di AgeoLiteo da rappresentarsi nel teatro della fiera di Bergamo l’anno 1762. De-dicato a S. E. il signor Marin Cavalli capitanio e vicepodestà, In Berga-mo, MDCCLXII, Per li Fratelli Rossi, Con licenza de’ superiori238.
DATA: 1763AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: Il conte ChiccheraAUTORE: Carlo GoldoniCOMPOSITORE: Giovan Battista LampugnaniGENERE: Opera buffa239
PERSONAGGI: Parti serie: Lucrezia cittadina vedova; Don Ippolito. Par-ti buffe: Il conte Chicchera; Madama Lindora; Mantecca servito-re; Cavallina cameriera; Don Orazio.
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Camera in casa di Mada-ma; Gabinetto di Madama; Atto secondo: Giardino in casa di don-na Lucrezia; Galeria in casa di donna Lucrezia; Camera in casa diMadama; Atto terzo: Camera in casa di donna Lucrezia240.
238. Il libretto consultato si trova in BCMR, Carvallais 596.239. Anche definita, nella dedica, un «dramma bernesco» dai «direttori» dell’ope-
ra.240. I cambi di scena non sono riportati in alcuna tavola iniziale, ma si ricava-
no dalle didascalie del libretto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 350
351
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
SCENOGRAFO: Giovanni Maria Giussani241.DEDICATARIO: Carlo Zino podestà; Marin Cavalli capitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: «Li direttori».CANTANTI: Francesca Corsini (Lucrezia), N. N. (Don Ippolito), Miche-
langelo Potenza (Il conte Chicchera), Valburga Compassi (MadamaLindora), Gaetano Baldi (Mantecca), Annunziata Stelzer (Cavallina),Ventura Cavalli (Don Orazio).
COSTUMISTA: Francesco MaininoCOREOGRAFO: Bartolomeo CambiBALLERINI: Bartolomeo Cambi, Anna Bresciani, Mauro Zaccherini,
Maria Teresa Monbelli, Carlo Finetti, Caterina Verga.FONTI: [Libretto], Il conte Chicchera. Dramma giocoso per musica da ra-
presentarsi in Bergamo nel teatro di Cittadella nel Carnovalle dell’anno1763 dedicato a Sue Eccellenze Carlo Zino podestà e Marin Cavalli ca-pitanio, In Bergamo, per fratelli Rossi stampatori pubblici, Con Li-cenza de’ Superiori242.
DATA: 1763, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, [teatro provvisionale di fiera]TITOLO: Opera non idenficataGENERE: Opera in musicaDEDICATARIO: Dolfin Donado Zino podestadessaDEDICANTE/IMPRESARIO: «Li direttori»243.FONTI:[Libretto], La scaltra letterata. Dramma giocoso per musica da rap-
presentarsi nel teatro della Cittadella di Bergamo il Carnovale dell’anno1764. Dedicato a S. E. la Nobil Donna Dolfina Donado Zino Podesta-dessa di Bergamo, In Bergamo, 1763.
DATA: 1764, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.
241. Nel libretto indicato come «Giovanni Gusani».242. Il libretto consultato si trova in BCPd, H 47568.243. Si veda la nota apposta alla voce «Dedicante/Impresario» relativa a La scal-
tra letterata, Teatro della Cittadella, Carnevale 1764.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 351
352
FRANCESCA FANTAPPIÈ
TITOLO: La scaltra letterataAUTORE: [Antonio Palomba]COMPOSITORE: Nicola Piccinni «napolitano»GENERE: Dramma giocosoPERSONAGGI: Giulia giovine savia ed astuta direttrice di Dorimene;
Mommo Patacca sciocco e benestante di Val Brembana promessosposo a Dorimene; Lesbina giovine scaltra; Dorimene amante diFlaminio; Don Pippo del Gallo giovine allegro e strambo fratellodi Dorimene; Flaminio amante di Dorimene; Camillo cugino diDorimene.
SCENA: VeneziaCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Camera; Strada con
canale in prospetto; Atto secondo: Sala; Atto terzo: Strada; Sa-la244.
DEDICATARIO: Dolfin Donado Zino podestadessaDEDICANTE/IMPRESARIO: «Li direttori»245.CANTANTI: Maria Cappellini (Dorimene, parte seria), Anna Maria Cor-
sini (Flaminio, parte seria), Angiola Paganini «virtuosa di Sua Mae-stà Prussiana» (Giulia, parte buffa), Carlo Paganini «virtuosa di SuaMaestà Prussiana» (Mommo Patacca, parte buffa), Angiola Brusa(Lesbina, parte buffa), Vincenzo Coresi/Goresi (Don Pippo, parte buf-fa), Giuseppe Fonti (Camillo, parte buffa).
COSTUMISTA: Francesco Mainini «milanese».BALLERINI: Vittoria Varré di Milano, Bortolo Benaglia, Marianna Ce-
riati di Firenze, Antonio Busida di Venezia, Maria Roda, France-sco Stimi.
244. Non esiste una tavola iniziale dei cambi di scena che si ricavano dalle di-dascalie interne al testo.
245. Nella dedica non dichiarano la propria identità, ma affermano di aver giàallestito un’opera nel corso della fiera del 1763. «Siccome nella scorsa Fiera s’è de-gnata Vostra Eccellenza non solo gradire l’umile offerta che le abbiamo fatto del-l’opera, ma di più ci ha, con nostro sommo contento e vantaggio, onorati dell’altasua presenza, tutto che il fervido caldo, il teatro disadattato e lontano, e i molti enon spregevoli divertimenti che in quell’occasione al pari che in ogn’altra città poe-tano ricrearla l’avessero dovuta tenere assente, così sull’esempio d’allora, vieppiù in-coraggiti osiamo di bel nuovo rassegnarle questa seconda in Carnovale, sperandoche la vicinanza del luogo, il sito un po’ meno inconveniente, la stagione più op-portuna e la privazione di ogni trattenimento debbano rendergliela meno incresce-vole» (cc. 3-4).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 352
353
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
FONTI: [Libretto], La scaltra letterata. Dramma giocoso per musica da rap-presentarsi nel teatro della Cittadella di Bergamo il Carnovale dell’anno1764. Dedicato a S. E. la Nobil Donna Dolfina Donado Zino Podesta-dessa di Bergamo, In Bergamo, 1763, Per Francesco Traina, Con li-cenza de’ superiori246; [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli tea-trali per il Carnovale dell’anno 1764. Dedicato a’ signori maestri di ca-pella e virtuosi di canto e ballo, In Milano, Nella stampa di PietroAgnelli, Con licenza de’ superiori247.
DATA: 1764AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Teatro religioso]LUOGO: Bergamo, chiesa di San Rocco in Borgo San Leonardo.TITOLO: La morte di San Francesco SaverioAUTORE: Paolo Borgogna248
COMPOSITORE: Quirino Gasparini249
GENERE: [Cantata]PERSONAGGI: San Francesco Saverio; Giorgio Alvarez; Antonio di
Santa Fede; Giovane indiano.DEDICATARIO: Rocco Gherardi e Giuseppe Gavazzoli «preposti della
chiesa di S. Alessandro in Colonna».DEDICANTE: «Gli associati».FONTI: [Libretto], La morte di S. Francesco Saverio cantata da farsi la se-
ra precedente la di lui festa nella chiesa di S. Rocco del Borgo S. Lionardoumiliata alli reverendissimi signori Rocco Gherardi e Giuseppe Gavazzo-li prevosti degnissimi del’insigne basilica di S. Alessandro in Colonna, InBergamo MDCCLXIV, Per Francesco Locatelli, Con Licenza de’Superiori250.
246. I dati si ricavano dall’unico libretto esistente, conservato nella collezioneprivata Thomas Walker di Ferrara.
247. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, pp. 7-8.248. L’identità dell’autore è registrata in una successiva edizione del testo, avve-
nuta nel 1771, in occasione di una nuova rappresentazione dello spettacolo, per ilquale si rimanda alla voce relativa nella cronologia.
249. La descrizione completa è la seguente: «La Musica del signor abbate donQuerino Gasparini accademico filarmonico di Bologna, maestro di cappella dell’il-lustrissimo e reverendissimo capitolo dell’insigne metropolitana e dell’augusta cittàdi Torino».
250. Il libretto consultato si trova in BAM, S. N. P. VIII. 7 (2).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 353
354
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DATA: 1764, 18 giugnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Teatro religioso]LUOGO: Bergamo, Duomo.TITOLO: Componimento drammatico da cantarsi in musica nella cattedrale
di Bergamo nella solennità del B. Gregorio BarbarigoAUTORE: Carlo Ottavio Bolgeni «rettore di Carvico».COMPOSITORE: Carlo LenziGENERE: [Cantata]PERSONAGGI: Beato Gregorio; Angelo; La città di Padova; La città di
Bergamo.DEDICATARIO: Andrea Zucchi canonico del Duomo.FONTI: [Libretto], Componimento drammatico da cantarsi in musica nel-
la cattedrale di Bergamo nella solennità del B. Gregorio Barbarigo cardi-nale e vescovo di Bergamo il dì XVIII giugno MDCCLXIV. Offerto al-la divozione e distinto merito del nobile e reverendissimo monsignor An-drea Zucchi canonico arciprete della cattedrale medesima, In Bergamo.MDCCLXIV, Con licenza de’ superiori251.
DATA: 1765, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Il re alla cacciaAUTORE: [Carlo Goldoni]COMPOSITORE: Baldassarre GaluppiGENERE: Opera buffa con balliPERSONAGGI: [Enrico IV, milord Fidelingh, miledi Marignon, Riccar-
do, Giannina, Giorgio, Lisetta, Pascale].CANTANTI: «Parti Buffe»: Antonio Nasolini di Padova, Rosa Barattie-
ri di Napoli, Giuseppe Secchioni di Firenze, Angiola Agostinelli diVenezia, Francesco Ceni di Firenze; «Parti Serie»: Teresa Torre, diLucca, Angelica Cambi di Firenze.
COREOGRAFO: Bartolomeo Cambi di FirenzeBALLERINI: Bartolomeo Cambi, Luigia Agostinelli di Venezia, Gio. Bat-
tista Vimercati di Milano, Veronica Cocchi di Bologna, GasparoMattaliani di Venezia, Giovanna Mattaliani di Venezia.
251. Il libretto consultato si trova in BAM, S. I. F. IV 6 (9).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 354
355
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
FONTI: [Indice di spettacoli], Laberinto degli amanti. Fabbricato in XLIIIteatri dell’Europa. Disposto per ordine d’Alfabeto a comodo de’ Grandi,de’ Mezzani, e de’ Piccioli a Piacere de’ Nobili, de’ Cittadini, e de’ Plebei.Per il Carnevale dell’Anno MDCCLXV. Dedicato all’Illustrissimo. Sig.Sig. Pat. Colendiss. Il sig. Giuseppe dall’Oglio Agente di S. M. Il Re diPolonia presso la Sereniss. Repubblica Veneta, Venezia, MDCCLXV. PerAntonio Bassanese, Con Licenza de’ Superiori252.
DATA: 1765, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’isola disabitataAUTORE: [Carlo Goldoni]COMPOSITORE: Giuseppe ScarlattiGENERE: Opera buffa con balliPERSONAGGI: [Gianchira, Roberto, Carolina, Valdimonte, Giacinta,
Garamone, Panico, Marina/Marinella]CANTANTI: «Parti Buffe»: Antonio Nasolini di Padova, Rosa Barattie-
ri di Napoli, Giuseppe Secchioni di Firenze, Angiola Agostinelli diVenezia, Francesco Ceni di Firenze; «Parti Serie»: Teresa Torre, diLucca, Angelica Cambi di Firenze.
COREOGRAFO: Bartolomeo Cambi di FirenzeBALLERINI: Bartolomeo Cambi, Luigia Agostinelli di Venezia, Gio. Bat-
tista Vimercati di Milano, Veronica Cocchi di Bologna, GasparoMattaliani di Venezia, Giovanna Mattaliani di Venezia.
FONTI: [Indice di spettacoli], Laberinto degli amanti. Fabbricato in XLIIIteatri dell’Europa. Disposto per ordine d’Alfabeto a comodo de’ Grandi,de’ Mezzani, e de’ Piccioli a Piacere de’ Nobili, de’ Cittadini, e de’ Plebei.Per il Carnevale dell’Anno MDCCLXV. Dedicato all’Illustrissimo. Sig.Sig. Pat. Colendiss. Il sig. Giuseppe dall’Oglio Agente di S. M. Il Re diPolonia presso la Sereniss. Repubblica Veneta, Venezia, MDCCLXV. PerAntonio Bassanese, Con Licenza de’ Superiori253.
252. L’opera non è registrata in C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit.. L’in-dice di spettacoli teatrali dal titolo Laberinto degli amanti è conservato in CGV, 57F 74/7.
253. L’opera non è registrata in C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit.. L’indicedi spettacoli teatrali dal titolo Laberinto degli amanti è conservato in CGV, 57 F 74/7.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 355
356
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DATA: 1766, 18 giugnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Teatro religioso]LUOGO: Bergamo, DuomoTITOLO: Componimento drammatico da cantarsi in musica nella cattedrale
di Bergamo nella festa del B. Gregorio BarbarigoAUTORE: Carlo Ottavio Bolgeni254.COMPOSITORE: Carlo LenziGENERE: CantataPERSONAGGI: Beato Gregorio; Angelo; La città di Padova; La città di
Bergamo.DEDICATARIO: Il capitolo della cattedrale.FONTI: [Libretto], Componimento drammatico da cantarsi in musica nel-
la cattedrale di Bergamo nella festa del B. Gregorio Barbarigo cardinale evescovo di Bergamo il dì XVIII giugno dedicato alla divozione ed impa-reggiabile merito del reverendissimo capitolo della cattedrale medesima, InBergamo. MDCCLXVI, Appresso Lodovico Gavazzoli, Con li-cenza de’ superiori255.
DATA: 1766, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro provvisionale in fiera.TITOLO: SemiramideAUTORE: Pietro MetastasioCOMPOSITORE: Joseph Mysliwecek «detto il Boemo».GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Semiramide in abito virile sotto nome di Nino re de-
gli Assiri, amante di Scitalce conosciuto ed amato da lei antece-dentemente nella corte d’Egitto, come Idreno; Scitalce principe rea-
254. Il nome è inserito manoscritto nel frontespizio tra il titolo e lo stampato-re.
255. Il libretto consultato si trova conservato in BAM, S. I. F. IV 6 (10) il qua-le, con la sola eccezione del titolo, che riporta una data ed un dedicatario differen-ti, è identico a quello dell’edizione datata 18 giugno 1764, per cui si veda questaCronologia, ad annum. L’ipotesi di un errore nell’intestazione, dovuta ad un’inversio-ne di V e I e quindi di una confusione tra MDCCLXIV e MDCCLXVI, non è daescludere. In questo caso saremmo di fronte ad un unico spettacolo. Resta da stabi-lire se tenuto nel 1764 o nel 1766.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 356
357
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
le d’una parte dell’Indie creduto Idreno da Semiramide pretenso-re di Tamiri ed amante di Semiramide; Tamiri principessa Real de’Battriani, amante di Scitalce; Mirteo principe reale d’Egitto fratel-lo di Semiramide da lui non conosciuta ed amante di Tamiri; Si-bari confidente ed amante occulto di Semiramide.
SCENA: Babilonia reggia de’ monarchi assiri.CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Gran portico del palazzo
reale256; Orti pensili. Atto secondo: Sala Regia257; Atto terzo: Cam-pagna sulla riva dell’Eufrate258; Gabinetti reali; Anfiteatro con can-celli chiusi dai lati e trono da una parte.
SCENOGRAFO: Gaetano RachettiDEDICATARIO: Marchesa Caterina MartinengoDEDICANTE/IMPRESARIO: Francesco Puttini259.CANTANTI: Caterina Galli «virtuosa di Sua Altezza Serenissima il du-
ca di Modena» (Semiramide), Carlo Nicolini (Scitalce), Mariana Bu-cinelli (Tamiri), Adamo Solzi (Mirteo), Antonio Pini (Ircano), RosaPolidora (Sibari).
COREOGRAFO: Vincenzo GaleottiBALLERINI: Vincenzo Galeotti, Teresa Steffanis, Gio. Grazioli detto
Schizza, Marianna Fiorilli, Pietro Ricci, Caterina Verga, FrancescaPaccini, Anna Porzi, Gio. Battista Ajmi, Teodora Ricci, DomenicoRiccardi (fuori de’ concerti), Madmoisele Maria Germò (fuori de’concerti).
FONTI: [Libretto], Semiramide dramma per musica del signor abate PietroMetastasio poeta cesareo nel teatro di fiera di Bergamo, dedicato a sua Ec-cellenza la nob. donna la signora marchesa Catterina Martinengo, In Ber-
256. La descrizione completa riportata nella tavola delle scene è la seguente:«Gran portico del palazzo reale corrispondente alle sponde dell’Eufrate. Trono dauna lato alla sinistra del quale un sedile più basso per Tamiri. In faccia al suddettotrono tre altri sedili. Ara nel mezzo col simulacrdo di Bello deità de’ Caldei. Granponte praticabile, qualche nave sul fiume. Vista di tende sull’altra sponda».
257. Descrizione completa: «Sala Regia, illuminata in tempo di notte. Varie cre-denze intorno con vasi trasparenti. Gran mensa imbandita nel mezzo con quattrosedili intorno ed una sedia in faccia».
258. Descrizione completa: «Campagna sulle rive dell’Eufrate con navi che poisono incendiate. Mura de’ giardini reali da un lato, con cancelli di ferro aperti».
259. Il quale nella dedica afferma di offrire «in ossequio il dramma, che rappre-sentare si deve sul nuovo teatro di cui per quest’anno ne ho assunta la sì ardua im-presa» (cc. 3, 4).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 357
358
FRANCESCA FANTAPPIÈ
gamo, MDCCLXVI, Per Francesco Traina, Con Licenza de’ Supe-riori260.
DATA: 1768, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Il re pastoreAUTORE: [Pietro Metastasio]COMPOSITORE: Pietro Guglielmi napoletanoGENERE: Opera seria con intermezzi ridicoli.CANTANTI: Giuseppe Gallieni bresciano, Marianna Demena Lombar-
di di Milano, Angelo Cantoni veronese, Stella Zuccaro veronese,Margarita Paganina di Bergamo.
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carnova-le dell’anno bisestile MDCLXVIII. Dedicato alli spiriti curiosi dell’uno edell’altro sesso, In Milano, Nella stamperia di Pietro Agnelli, Con li-cenza de’ superiori261.
DATA: 1768, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’eroe cineseAUTORE: [Pietro Metastasio]COMPOSITORE: Carlo Lenzi di BergamoGENERE: Opera seria [con intermezzi ridicoli].CANTANTI: Giuseppe Gallieni bresciano, Marianna Demena Lombar-
di di Milano, Angelo Cantoni veronese, Stella Zuccaro veronese,Margarita Paganina di Bergamo.
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carnova-le dell’anno bisestile MDCLXVIII. Dedicato alli spiriti curiosi dell’uno edell’altro sesso, In Milano, Nella stamperia di Pietro Agnelli, Con li-cenza de’ superiori262.
260. Il libretto si trova conservato in BCBg, Salone Piccola 21 1. 8 (13).261. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, pp. 27-28.262. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, pp. 27-28.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 358
359
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DATA: 1768, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Il Ferravecchio, ossia la moglie vanaAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Antonio Buroni263.GENERE: Intermezzi ridicoli.CANTANTI: Gabriella Tagliaferri milanese; Alessandro Giovanola lo-
digiano.FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carnova-
le dell’anno bisestile MDCLXVIII. Dedicato alli spiriti curiosi dell’uno edell’altro sesso, In Milano, Nella stamperia di Pietro Agnelli, Con li-cenza de’ superiori264.
DATA: 1768, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’ipocondriacoAUTORE: Autore non specificato.GENERE: Intermezzi ridicoli.COMPOSITORE: Florian Leopold GassmannCANTANTI: Gabriella Tagliaferri milanese; Alessandro Giovanola lo-
digiano.FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carnova-
le dell’anno bisestile MDCLXVIII. Dedicato alli spiriti curiosi dell’uno edell’altro sesso, In Milano, Nella stamperia di Pietro Agnelli, Con li-cenza de’ superiori265.
DATA: 1768, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.
263. Nell’indice definito come «Antonio Boroni romano».264. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, pp. 27-28.265. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, pp. 27-28.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 359
360
FRANCESCA FANTAPPIÈ
TITOLO: L’uccellatriceAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Nicola Jommelli266.GENERE: Intermezzi ridicoli.CANTANTI: Gabriella Tagliaferri milanese; Alessandro Giovanola lo-
digiano.FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carnova-
le dell’anno bisestile MDCLXVIII. Dedicato alli spiriti curiosi dell’uno edell’altro sesso, In Milano, Nella stamperia di Pietro Agnelli, Con li-cenza de’ superiori267.
DATA: 1768AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Teatro religioso]LUOGO: Bergamo, chiesa dei somaschi in Borgo San Leonardo.TITOLO: Cantata per musica per la canonizzazione di San Girolamo Mia-
niAUTORE: Francesco Venini «c. r. somasco».COMPOSITORE: Francesco Venini «c. r. somasco».GENERE: CantataPERSONAGGI: Leonardo Loredan doge di Venezia; Dianora Morosini
madre del santo; San Girolamo Miani col nome latino d’Emilio.DEDICATARIO: Pietro Manin podestà e Giovan Francesco Raspi capi-
tanio.DEDICANTE: «Li padri di S. Leonardo».FONTI: [Libretto], Cantata per musica nell’ottavaro che si celebra in S. Lio-
nardo da’ cherici regolari somaschi per la canonizzazione di San Girola-mo Miani loro fondatore, In Bergamo, MDCCLXVIII, Per France-sco Locatelli, Con Licenza de’ Superiori268.
DATA: 1770, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’impresa d’opera
266. Nell’indice definito come «Nicolò Jomella napolitano».267. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, pp. 27-28.268. Il libretto consultato si trova in BAM, S. N. P. IX. 16 (11).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 360
361
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
AUTORE: [Bartolomeo Cavalieri]COMPOSITORE: Pietro Guglielmi napoletanoGENERE: Opera buffaCANTANTI: Gerolamo Vedova veneziano, Angelica Maggiori venezia-
na, Dionigi Merlini di Ferrara, Agata Fiorilli napoletana, France-sco Gaglieni di Bergamo, Cattarina Grazioli tedesca, Giacomo Da-vile di Bergamo.
COREOGRAFO: Gaspare Bonuci di FirenzeBALLERINI: Gaspare Bonuci, Antonia Colombi di Venezia, Bartolo-
meo Costantini detto il Moscovito, Giuseppa Tizzoni di Milano,Antonio Tizzoni di Milano, Serafina Burati di Bologna.
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carnova-le dell’anno 1770. Dedicato alli spiriti curiosi dell’uno e dell’altro sesso, InMilano, Nella stamperia di Pietro Agnelli, Con licenza de’ supe-riori269.
DATA: 1770, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La sposa fedeleAUTORE: [Pietro Chiari]COMPOSITORE: Pietro Guglielmi napoletanoGENERE: Opera buffaCANTANTI: Gerolamo Vedova veneziano, Angelica Maggiori venezia-
na, Dionigi Merlini di Ferrara, Agata Fiorilli napoletana, France-sco Gaglieni di Bergamo, Cattarina Grazioli tedesca, Giacomo Da-vile di Bergamo.
COREOGRAFO: Gaspare Bonuci di FirenzeBALLERINI:Gaspare Bonuci, Antonia Colombi di Venezia, Bartolomeo
Costantini detto il Moscovito, Giuseppa Tizzoni di Milano, An-tonio Tizzoni di Milano, Serafina Burati di Bologna.
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carnova-le dell’anno 1770. Dedicato alli spiriti curiosi dell’uno e dell’altro sesso, InMilano, Nella stamperia di Pietro Agnelli, Con licenza de’ supe-riori270.
269. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 39.270. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 39.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 361
362
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DATA: 1770, Carnevale (rappresentazione solo presunta)271
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La cameriera astutaAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Alessandro Felici fiorentinoGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Fiammetta cameriera; Monsieur Bigiò sarto francese;
Geronio vecchio; Ser Imbroglio notaio; Clarice moglie di Lucin-do; Dorina figlia di Geronio; Lucindo figlio di Geronio.
SCENA: BolognaCAMBIAMENTI DI SCENA: Atto primo: Sala. Strada; Atto secondo: Ca-
mera. Giardino con palazzina; Atto terzo: Camera con lumi. Stra-da con veduta della casa di Gerionio, notte; Sala con lumi.
DEDICATARIO: Tommaso Mocenigo Soranzo capitanioDEDICANTE/IMPRESARIO: «Gli impresari».CANTANTI: Angelica Maggiori (Fiammetta); Girolamo Vedova (Mon-
sieur Bigiò), Francesco Gallieni (Geronio); Dionigio Merlini (Imbro-glio); Giacomo Davide (Lucindo).
COREOGRAFO: Gasparo BonucciBALLERINI: Antonia Colombi, Gasparo Bonucci, Beppa Tizzoni, Bor-
tolo Costantini, Serafina Baratti, Antoni Tizzoni, sei figuranti.FONTI: [Libretto], La cameriera astuta. Dramma giocoso da rappresen-
tarsi nel teatro di Bergamo il Carnovale dell’anno 1770. Dedicato a SuaEccellenza Toma’ Mocenigo Soranzo Capitanio della suddetta Città, inBergamo, 1770, Per Francesco Locatelli, Con Licenza de’ Supe-riori272.
DATA: 1771AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Teatro religioso]
271. Impossibile determinare se l’opera sia stata realmente messa in scena. Gliindici teatrali registrano, infatti, due opere: L’impresa d’opera e La sposa fedele. Ciono-nostante l’unico libretto a noi giunto per il Carnevale del 1770 è quello della Came-riera astuta. Indici e libretto coincidono nel riportare il cast dei cantanti e dei balle-rini con relativi ruoli.
272. Il libretto consultato si trova in BCBg, Sala 32 D 2 5 (5).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 362
363
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
LUOGO: Bergamo, chiesa di San Rocco in Borgo San Leonardo.TITOLO: La morte di San Francesco SaverioAUTORE: Paolo Borgogna273
COMPOSITORE: Quirino Gasparini274
GENERE: CantataPERSONAGGI: San Francesco Saverio; Giorgio Alvarez; Antonio di
Santa Fede; Giovane indiano.DEDICATARIO: Rocco Gherardi e Giuseppe Gavazzoli preposti della
chiesa di S. Alessandro in Colonna.DEDICANTE: «Gli associati».FONTI: [Libretto], La morte di S. Francesco Saverio cantata da farsi la
sera precedente la di lui festa nella chiesa di S. Rocco del Borgo S. Lio-nardo umiliata alla spettabile reggenza della chiesa medesima, In Ber-gamo MDCCLXXI, Per Francesco Locatelli, Con Licenza de’ Su-periori275.
DATA: [1772]276
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Spettacolo encomiastico]LUOGO: Bergamo, luogo non identificato.TITOLO: Cantata per la partenza di Nicolò BarbarigoAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Carlo Lenzi maestro di capella di Santa Maria Mag-
giore.GENERE: [Cantata]CANTANTI: Angelo Cantoni (Gloria), Giuseppe Galieni (Genio del Bar-
barigo), Carlo Nicolini (Genio dell’Adria), Francesco Frassine (Geniodell’Orobia).
PERSONAGGI: Gloria; Genio del Barbarigo; Genio dell’Adria; Geniodell’Orobia.
273. Il nome è inserito manoscritto in interlinea tra il titolo dell’opera e lo stam-patore: «Autore signor dottor Paolo Borgogna bergamasco».
274. Descrizione completa: «La Musica del signor abbate don Querino Gaspa-rini accademico filarmonico di Bologna, maestro di cappella dell’illustrissimo e re-verendissimo capitolo dell’insigne metropolitana e dell’augusta città di Torino».
275. Il libretto consultato si trova conservato in BAM, S. N. P. VIII. 7 (3).276. La data è presunta. Si deduce dal fatto che Nicolò Barbarigo fu capitanio
di Bergamo dal 1770 al 1772, cfr. B. Belotti, Storia di Bergamo e dei bergamaschi, Ber-gamo, 1989, vol. IV, p. 488.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 363
364
FRANCESCA FANTAPPIÈ
FONTI: [Libretto], Cantata nella partenza da Bergamo di S. E. il N. H.Nicolò Barbarigo capitanio grande, s. l. e s. d.277.
DATA: 1772, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Il matrimonio per concorsoAUTORE: [Gaetano Martinelli]COMPOSITORE: Compositore non specificato278.GENERE: Opera buffaCANTANTI: Domenico Negri, Luigi Corsi, Domenico Cappellari, Ma-
rianna Uttini, Maura Coronati, Paola Borelli.COREOGRAFO: Giacomo BedottiBALLERINI: Giacomo Bedotti, Giovan Battista Vimercati, Giovanni
Odini, Maria Picca, Maria Gambelli, Maria Casia.FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carnova-
le dell’anno 1772. Alli signori maestri e virtuosi di canto e ballo, In Mi-lano, Nella stamperia di Pietro Agnelli, Con Permissione279.
DATA: 1772, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Titolo non specificato.GENERE: Opera buffaCANTANTI: Domenico Negri, Luigi Corsi, Domenico Cappellari, Ma-
rianna Uttini, Maura Coronati, Paola Borelli.COREOGRAFO: Giacomo BedottiBALLERINI: Giacomo Bedotti, Giovan Battista Vimercati, Giovanni
Odini, Maria Picca, Maria Gambelli, Maria Casia.
277. I libretti consultati sono conservati in BCBg, Salone Piccola 21. 4. 3 e inBAM, S. I. G. V. 24 (14).
278. Compositore della musica per gli allestimenti di Firenze (1767), Venezia(1767), Pavia (1770), Lisbona (1773) è Felice Alessandri, mentre per quelli di Luisburg(1766), Milano (1768), Lisbona (1770) è Nicola Jommelli, cfr. C. Sartori, I libretti ita-liani a stampa, cit., libretti 15189-15195.
279. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 68.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 364
365
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carnova-le dell’anno 1772. Alli signori maestri e virtuosi di canto e ballo, In Mi-lano, Nella stamperia di Pietro Agnelli, Con Permissione280.
DATA: 1772, 18 aprile- post 13 giugnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.COMPAGNIA: Capocomico Antonio SaccoTITOLO DELLE OPERE RAPPRESENTATE: La caduta di donna Elvira di Car-
lo Gozzi; La punizione del precipizio di Carlo Gozzi (13 giugno)281.ATTORI: Francesco Bartoli, Teodora Ricci, Angela Vitalba, Antonio
Sacco.FONTI: [Descrizione] Francesco Saverio Bartoli, Le pitture, sculture ed
architetture delle chiese e d’altri luoghi pubblici in Bergamo, in Vicenza,Per Carlo Bressan, [1774]; [Documenti epistolari], Lettera di Teo-dora Ricci a Carlo Gozzi, Bergamo 18 aprile 1772 in M. Gorla, Cin-que lettere di Teodora Ricci a Carlo Gozzi, in Studi gozziani, a cura diM. G. Cambiaghi, Milano, 2006, pp. 107-132: 125; Lettera di Fran-cesco Bartoli a Carlo Gozzi, Bergamo 13 giugno 1772 in P. Mol-menti, Carlo Gozzi inedito, in «Giornale Storico della Letteratura Ita-liana», LXXXVII (1926), pp. 63-64.
DATA: 1773AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Spettacolo encomiastico]LUOGO: Bergamo, luogo non identificato.TITOLO: Cantata per la partenza di Francesco SavorgnanAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Compositore non specificato.GENERE: Cantata
280. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 68.281. Nella programmazione della compagnia era inserita anche La Virginia (11
giugno) di autore ignoto, rappresentazione probabilmente rimandata. Vi avrebbe,infatti, dovuto recitare Teodora Ricci, la quale nel corso della preparazione dello spet-tacolo, sorpresa dai dolori del parto, fu costretta ad abbandonare le prove per darealla luce una bambina la sera stessa. Il 13 giugno, per motivi non meglio specifica-ti, venne sospesa la rappresentazione della La principessa filosofa di Carlo Gozzi, cfr.P. Molmenti, Carlo Gozzi inedito, in «Giornale Storico della Letteratura Italiana»,LXXXVII (1926), pp. 63-64.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 365
366
FRANCESCA FANTAPPIÈ
PERSONAGGI: Alcide; Genio della Società; Egisto uomo di Lerna;Aspasia donna di Lerna.
FONTI: [Libretto], Cantata nella partenza da Bergamo di S. E. il N. H.C. Francesco Savorgnan podestà, In Bergamo, MDCCLXXIII, PerFrancesco Locatelli, Con licenza de’ superiori282.
DATA: 1773, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, [Teatro della Cittadella].TITOLO: L’isola d’AlcinaAUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: Giuseppe Gazzaniga «di Verona».GENERE: Opera buffaCANTANTI: Guglielmo Iermoli, Pietro Bizozero, Costantino Chigi,
Leonzio Spiegel, Marianna Rusfler, Genovieffa Germò, GiuseppaPerega.
COREOGRAFO: Giuseppe De SteffaniBALLERINI: Giuseppe De Steffani, Antonio Sanquirico, Gianni Oddi-
ni, Maria Meroni, Maria Sanquirico, Giuseppa Manni.FONTI: [Indice di spettacoli]: Indice de’ spettacoli teatrali per il Carnova-
le dell’anno 1773. Alli signori maestri e virtuosi di canto e ballo, In Mi-lano, Nella stamperia di Pietro Agnelli, Con Permissione283.
DATA: 1773, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, [Teatro della Cittadella].TITOLO: Il cavaliere villano o sia la lavandara astuta284
AUTORE: [Pietro Chiari]COMPOSITORE: [Baldassarre Galuppi]GENERE: Opera buffa
282. Il libretto consultato si trova in BCBg, Salone Piccola 21 6 16 (3).283. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 86.284. Unica opera conosciuta sotto questo titolo, altrimenti nota come: La la-
vandara astuta, Il marchese Tulipano, Il marchese villano, La lavandara astuta o sia il mar-chese Tulipano.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 366
367
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
PERSONAGGI: Vespina lavandara; Dorilla; Bellisa; Giorgino; Il mar-chese Tulipano padre di Giorgino; Galarino sindaco della Villa; Pa-lamede.
CAMBI DI SCENA: Atto primo: Bosco ed in prospetto marina; Atto se-condo: Stanze della casa di Tulipano, Sala con tribunale; Atto ter-zo: [scena non specificata].
DEDICATARIO: Zuanne Grassi capitanio e vicepodestàIMPRESARIO: Giovan Battista LombardiCANTANTI: Guglielmo Iermoli/Jermoli (Giorgino), Pietro Bizoze-
ro/Biggiogero (Il marchese Tulipano padre di Giorgino), CostantinoChigi (Galarino sindaco della Villa), Leonzio Spiegel/Spighel (Pala-mede), Marianna Rusfler detta la Calcettina (Vespina lavandara), Ge-novieffa Germò (Dorilla), Giuseppa Perega (Bellisa).
COREOGRAFO: Giuseppe De SteffaniBALLERINI: Giuseppe De Steffani, Antonio Sanquirico, Gianni Oddi-
ni, Maria Meroni, Maria Sanquirico, Giuseppa Manni.FONTI: [Indice di spettacoli]: Indice de’ spettacoli teatrali per il Carnova-
le dell’anno 1773. Alli signori maestri e virtuosi di canto e ballo, In Mi-lano, Nella stamperia di Pietro Agnelli, Con Permissione285; [Libret-to], Il cavaliere villano o sia la lavandara astuta, dramma giocoso da rap-presentarsi nel teatro di Bergamo per il corrente Carnovale 1773, umiglia-to a Sua Eccellenza Zuanne Grassi capit. e v. podestà, In Bergamo,MDCCLXXIII, Con licenza de’ superiori286.
DATA: 1773, giugnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.GENERE: CommediaATTORI: Nicola Menichelli (Arlecchino)287.FONTI: [Nota di repertorio], Documento 1773: 2, in Regesto.
285. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 86.286. Il libretto consultato si trova in Germania, Harburg über Donauwörth, Für-
slich Öttingen-Wallersteinsche Bibliothec.287. Per il nome e la parte cfr. O. Giardi, I comici dell’arte perduta. Le compagnie
comiche italiane alla fine del secolo XVII, Roma, 1991, p. 154. Non è purtroppo possi-bile risalire alla composizione della compagnia di cui, a quest’altezza cronologica,faceva parte l’attore. Sappiamo però che almeno dal 1777 Nicola Menichelli è co-direttore della compagnia di Pietro Ferrari.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 367
368
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DATA: 1774, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’incognita perseguitataAUTORE: [Giuseppe Petrosellini]COMPOSITORE: Pasquale AnfossiGENERE: Opera buffaCANTANTI: Domenico Negri, Antonio Calenzoli, Giuseppe Gervaso-
ne, Maria Teresa Piatti, Maria Teresa Negri, Felice Canti.COREOGRAFO: Gasparo CattaneoBALLERINI: Gasparo Cattaneo, Cecilia Cattaneo, Giacomo Ublò, Eu-
genia Bogini, Giovanni Bini, Giuseppa Barlassina.FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carno-
vale dell’anno 1774. Alli maestri e virtuosi di canto e ballo, In Mila-no, Presso Gianbatista Bianchi regio stampatore, Con permissio-ne288.
DATA: 1774, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’innocente fortunataAUTORE: [Filippo Livigni]COMPOSITORE: Giovanni Paisiello «di Taranto»GENERE: Opera buffaCANTANTI: Domenico Negri, Antonio Calenzoli, Giuseppe Gervaso-
ne, Maria Teresa Piatti, Maria Teresa Negri, Felice Canti.COREOGRAFO: Gasparo CattaneoBALLERINI: Gasparo Cattaneo, Cecilia Cattaneo, Giacomo Ublò, Eu-
genia Bogini, Giovanni Bini, Giuseppa Barlassina.FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carno-
vale dell’anno 1774. Alli maestri e virtuosi di canto e ballo, In Mila-no, Presso Gianbatista Bianchi regio stampatore, Con permissio-ne289.
288. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., p. 101.289. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., p. 101.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 368
369
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DATA: 1774, Carnevale (rappresentazione solo presunta)290
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: La buona figliuolaAUTORE: Carlo GoldoniCOMPOSITORE: Niccolò Piccinni napoletanoGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: La marchesa Lucinda; Cavaliere Armidoro; Cecchina
giardiniera; Sandrina contadina; Il marchese Conchiglia; Tagliafer-ro tedesco; Mengotto contadino
CAMBI SCENA: Atto primo: Orti pensili, Loggie terrene, Campagna; At-to secondo: Boschetto delizioso, Loggie, Campagna amena con se-dili d’erbe; Atto terzo: Luogo di delizie, Sala preparata per le nozze.
DEDICATARIO: Elena Baglioni DiedoDEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista Lombardi «impresario».CANTANTI: «Parti serie»: Felicia Campi (Marchesa Lucinda), Giuseppe
Tomaselli (Cavaliere Armidoro); «Parti buffe»: Maria Teresa Piatti(Cecchina), Maria Teresa Negri (Sandrina), Domenico Negri (Mar-chese della Conchiglia), Antonio Calenzuoli (Tagliaferro), GiuseppeGervasoni (Mengotto)
COSTUMISTA: Giuseppe Bacchetta di MilanoCOREOGRAFO: Gasparo CattaneoBALLERINI: Cecilia Cattaneo [prima ballerina], Gasparo Cattaneo [primo
ballerino], Eugenia Bogini (prima grottesca), Giacomo d’Oblò (primogrottesco), Giuseppa Barlasina (prima grottesca), Giovanni Oddini(primo grottesco), Signor N. N. (figurante), Signor N. N. (figurante).
FONTI: [Libretto], La Buona figliuola. Dramma giocoso per musica da rap-presentarsi in Bergamo nel teatro di Cittadella il carnovale dell’annoMDCCLXXIV. Umiliato alle L.L. E.E. Gio. Paolo Baglioni Capitanioe Vice Podestà ed Elena Baglioni nata Diedo, Bergamo, 1774, Per Fran-cesco Locatelli, Con Licenza de’ Superiori291.
290. Impossibile determinare se l’opera sia stata realmente messa in scena. Gliindici teatrali registrano due opere: L’incognita perseguitata e L’innocente fortunata. Cio-nonostante l’unico libretto a noi giunto per il Carnevale del 1774 attesta la rappre-sentazione della Buona figliuola. Indici e libretto coincidono nella registrazione delcast di cantanti e di ballerini, con relativi ruoli.
291. Il libretto consultato si trova in CGV, 57 F 68/6.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 369
370
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DATA: 1774, 24 luglioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Teatro religioso]LUOGO: Bergamo, Duomo.TITOLO: Componimento drammatico da cantarsi in musica nella cattedrale
di Bergamo nella festa del beato Gregorio BarbarigoAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Compositore non specificato.GENERE: [Cantata]PERSONAGGI: Beato Gregorio; Angelo; La città di Padova; La città di
Bergamo.FONTI: [Libretto], Componimento drammatico da cantarsi in musica nel-
la cattedrale di Bergamo nella festa del B. Gregorio Barbarigo cardinale evescovo il dì xxiv luglio dedicato alle loro Eccellenze il N. H. GiovanniPaolo Baglioni capitano e vicepodestà e la nobile donna Elena Diedo suadegnissima sposa, In Bergamo, MDCCLXXIV, Appresso FrancescoLocatelli, Con licenza de’ superiori292.
DATA: 1775, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: L’astratto ovvero il giocatore fortunatoAUTORE: [Giuseppe Petrosellini]COMPOSITORE: Niccolò PiccinniGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Laurina giardiniera amante di Leandro; Leandro giova-
ne astratto e giocatore di lotto, figlio di Timoteo; Clarice figlia didon Timoteo; Il Capitan Facenda fratello di Laurina; Don Timo-teo uomo stravagante; Vespina cameriera; Giocondo cameriere.
COMPARSE: Lacché; Altri servitori che non parlano.SCENA: Vicinanze di Genova.DEDICATARIO: Elena Baglioni Diedo capitania.DEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista Lombardi «impresario».CANTANTI: Rosa Scanavini (Laurina); Ignazio Granatelli (Leandro); Ma-
ria Teresa Negri (Clarice); Giuseppe Scardavi (Capitan Facenda);
292. Il libretto consultato si trova in FGCV.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 370
371
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
Alessandro Giovanola (Don Timoteo); Maria Teresa Greca (Angeli-ca); Giuseppa Sanviti (Vespina); Giuseppe Gervasoni (Giocondo).
COREOGRAFO: Francesco MarinelliBALLERINI: Francesco Marinelli, Barbara Marinelli, Gaetano Masna-
go, Margherita Fusi, Giovanni Oddini, Antonia Ferraria; IgnazioRossi; Caterina Fusi.
COSTUMI: Giuseppe Bacchetta di Milano.FONTI: [Libretto], L’astratto ovvero il giocatore fortunato. Dramma gioco-
so per musica da rappresentarsi nel teatro della Cittadella per il prossimoCarnovale dell’anno MDCCLXXV. Umiliato a Sua Eccellenza Elena Ba-glioni nata Diedo Capitania di Bergamo, in Bergamo, 1775, Per Fran-cesco Locatelli, Con Licenza de’ Superiori293; [Indice di spettaco-li], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carnovale dell’anno 1775, In Mi-lano, Presso Gaetano Motta, posto al Malcamone vicino l’Osteriadel Pozzo, Con Permissione294.
DATA: 1775, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, [Teatro della Cittadella]TITOLO: La contessa di BinbimpoliAUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: [Gennaro Astarita]GENERE: Opera buffaCANTANTI: Rosa Scanavini; Ignazio Granatelli; Maria Teresa Negri;
Giuseppe Scardavi; Alessandro Giovanoli; Maria Teresa Greca;Giuseppa Sanviti (Vespina); Giuseppe Gervasoni.
COREOGRAFO: Francesco MarinelliBALLERINI: Francesco Marinelli, Barbara Marinelli, Gaetano Masna-
go, Margherita Fusi, Giovanni Oddini, Antonia Ferraria; IgnazioRossi; Caterina Fusi.
COSTUMI: Giuseppe Bacchetta di Milano.FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carnova-
le dell’anno 1775, In Milano, Presso Gaetano Motta, posto al Mal-camone vicino l’Osteria del Pozzo, Con Permissione295.
293. I libretti consultati si trovano in BCBg, Sala 32 D 2 5 (6) e CGV, 57 F 68/7.294. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 122.295. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 122.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 371
372
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DATA: 1775, post 24 aprileAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Spettacolo encomiastico]LUOGO: Bergamo, Sala Grande del Palazzo della Ragione.TITOLO: L’omaggio sinceroAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Carlo LenziGENERE: [Cantata]PERSONAGGI: Eurillo, Fileno, Tirsi, Damone, pastori.CANTANTI: Carlo Niccolini (Eurillo), Giovanni Tajana (Fileno), Giaco-
mo Davide (Tirsi), Angelo Cantoni (Damone).FONTI: [Libretto], L’omaggio sincero cantata nella partenza da Bergamo di
Sua Eccellenza il N. H. Gio. Paolo Baglioni capitanio di Bergamo, InBergamo, MDCCLXXV, Per Francesco Locatelli, Con licenza de’superiori296; [Suppliche e delibere], Documenti 1775: 6-7, in Rege-sto.
DATA: 1775, estateAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Il geloso in cimentoAUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: [Pasquale Anfossi]GENERE: Opera buffaCANTANTI: Guglielmo Jermoli, Geltrude Flavia, Giuseppe Bertocchi-
ni, Teresa Giberti, Alessandro Giovanola, Maria Antonio Grassi,Giuseppe Monti.
COREOGRAFO: Riccardo BlakeBALLERINI: Riccardo Blake, Cristina Voller, Antonio Bossi, Marianna
Daselli, Salvatore la Rose, Teresa Caspani, N. N., Antonia Ferraria.FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-
ra, estate ed autunno 1775 e del corrente Carnevale 1776. Alli signori mae-stri e virtuosi di canto e danza, In Milano, Per Gaetano Motta Stamp.al Malcantone, Con licenza de’ Superiori, c. 10297.
296. Il libretto consultato si trova in BMF. Sulla carta a fianco del titolo è col-locato un ritratto del capitanio Giovan Paolo Baglioni e la moglie Elena.
297. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 142.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 372
373
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DATA: 1776, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Li visionariAUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: Gennaro Astarita/«Asteritta di Napoli»GENERE: Opera buffaSCENOGRAFO: Pietro GualdoCANTANTI: Angelica Maggiori Gallieni (prima buffa), Michele Zanca
(primo buffo caricato), Francesco Benati (primo buffo mezzo cari-cato), Rosalinda Buzzi (seconda buffa), Gaetano Terraneo (secondobuffo), Anton Viscardini (terzo buffo), Paolo Mori (terzo buffo).
COSTUMISTA: Giuseppe ArpesaniCOREOGRAFO: Benedetto LombardiBALLERINI: Benedetto Lombardi, Michele Seraceni, Giovanni Oddi-
ni, Angelo Lombardi, Anna Polzelli, Marianna Monti, FrancescaTolvi, N. N., Luigi Ronzi (ballerino fuori de’ concerti), Anna Ga-buti (ballerina fuori de’ concerti).
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-ra, estate ed autunno 1775 e del corrente Carnevale 1776. Alli signori mae-stri e virtuosi di canto e danza, In Milano, Per Gaetano Motta Stamp.al Malcantone, Con licenza de’ Superiori, cc. 37-38298.
DATA: 1776, estateAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: L’avaroAUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: [Pasquale Anfossi]GENERE: Opera buffaCANTANTI: Michele Del Zanca, Giacomo Rizzoli, Michele Ferrario,
N. N., Gabriella Rizzoli, Rosa Pallerini, Teresa Lozza.
298. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 149. L’indice registra,oltre a Li visionari, la rappresentazione di una seconda opera buffa per il Carnevaledel 1776, ma non riporta il titolo.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 373
374
FRANCESCA FANTAPPIÈ
TITOLO DEI BALLI: Armida e Rinaldo (primo ballo); Li tre antiquari (se-condo ballo).
COREOGRAFO: Antonio Bossi (primo ballo); Filippo Pallerini (secon-do ballo).
BALLERINI: Antonio Bossi, Margherita Rossi, Gerolamo Corsi, Marian-na Fortuni, Carlo Talioni, Innocente Villa, Giovanni Odini, AnnaRossi, Gaetano Lombardi, Celeste Rossi, Francesco Roncali, N. N.,Filippo Pallerini (ballerino fuori de’ concerti), Marianna Signorini(ballerina fuori concerti).
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-ra, estate ed autunno 1776 e del corrente Carnevale 1777. Alli signori mae-stri e virtuosi di canto e danza, In Milano, Per Gaetano Motta Stamp.al Malcantone, Con licenza de’ Superiori, c. 18299.
DATA: 1777, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Le villane astuteAUTORE: [Carlo Goldoni]COMPOSITORE: Nicola PiccinniGENERE: Opera buffaCANTANTI: Antonio Cattaneo (primo mezzo carattere), Pietro Bigio-
gero (primo buffo caricato), Anna Benini (prima buffa), GiovanniPolini (altro buffo), Antonio Grassi (altro buffo), Giuseppe Viga-noni (altro buffo).
COREOGRAFO: Vincenzo De BustisBALLERINI: Vincenzo De Bustis, Marianna Signorini, Gerolamo Cor-
si, Camilla Zanetti, Giovanni ordini, Orsola Pecci, Giuseppe Pa-racca, Francesca Lazari.
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-ra, estate ed autunno 1776 e del corrente Carnevale 1777. Alli signori mae-stri e virtuosi di canto e danza, In Milano, Per Gaetano Motta Stamp.al Malcantone, Con licenza de’ Superiori, cc. 127-128300.
299. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 196.300. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 224.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 374
375
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DATA: 1777, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La critica teatraleAUTORE: [Ranieri De Calzabigi]COMPOSITORE: Gennaro Astarita/«Asteritta».GENERE: Opera buffaCANTANTI: Antonio Cattaneo (primo mezzo carattere), Pietro Bigio-
gero (primo buffo caricato), Anna Benini (prima buffa), GiovanniPolini (altro buffo), Antonio Grassi (altro buffo), Giuseppe Viga-noni (altro buffo).
COREOGRAFO: Vincenzo De BustisBALLERINI: Vincenzo De Bustis, Marianna Signorini, Gerolamo Cor-
si, Camilla Zanetti, Giovanni ordini, Orsola Pecci, Giuseppe Pa-racca, Francesca Lazari.
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-ra, estate ed autunno 1776 e del corrente Carnevale 1777. Alli signori mae-stri e virtuosi di canto e danza, In Milano, Per Gaetano Motta Stamp.al Malcantone, Con licenza de’ Superiori, cc. 127-128301.
DATA: 1777, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA: Capocomico Francesco PaganiniATTORI: Antonio Camerani, Luigi Lazzarini, Francesco Paganini, N.
N., Anna Corona Paganini, Laura Checcati/Coccati, Francesca Bo-vari, Elena Paganini, Francesco Argante (Pantalone), Luigi Marzoc-chi (Dottore), Giovanni Fortunati (Arlecchino), Francesco Maja-ni/Moiani (Brighella).
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-ra, estate ed autunno 1777 e del corrente Carnevale 1778, coll’elenco de’signori maestri di cappella, In Milano, Presso Gaetano Motta Stam-pat. al Malcantone, Con licenza de’ Superiori, c. 37302; O. Giardi,I comici dell’arte perduta. Le compagnie comiche italiane alla fine del se-colo XVII, Roma, 1991, pp. 215-220.
301. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 224.302. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 240.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 375
376
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DATA: 1777, estateAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Le gelosie villaneAUTORE: [Tommaso Grandi]COMPOSITORE: Giuseppe SartiGENERE: Opera buffaSCENOGRAFO: «Signori Mauri».CANTANTI: Angelica Maggiori Galieni (prima buffa), Paolo Bonaveri
(primo caricato), Matteo Babini (primo mezzo carattere), MicheleFerrari (altro buffo), Teresa Gherardi (altra buffa), Giuseppe Viga-noni (altro buffo), Teresa Scotti (altra buffa), Gaetano Pontiggia (al-tro buffo).
COSTUMISTA: Antonio DianTITOLO DEI BALLI: Lauro e Lidia (primo ballo); I due avari (secondo
ballo).COREOGRAFO: Stefano MagagniniBALLERINI: Giacomo Ferini, Teresa Casacci, Stefano Magagnini, Mad-
dalena MagagniniFONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-
ra, estate ed autunno 1777 e del corrente Carnevale 1778, coll’elenco de’signori maestri di cappella, In Milano, Presso Gaetano Motta Stam-pat. al Malcantone, Con licenza de’ Superiori, c. 58303.
DATA: 1778, 21 febbraioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, luogo non identificato.TITOLO: DidoneAUTORE: Pietro MetastasioCOMPAGNIA: [Compagnia di attori dilettanti]ATTORI: Francesco LocatelliFONTI: [Nota di repertorio], Documento 1778: 1, in Regesto.
DATA: 1778, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]
303. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 240.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 376
377
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
TIPOLOGIA: [Commedia]304
LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA: Compagnia non identificata.ATTORI: Giacomo Torri (Dottore)305, [Luigi Delicati, Margherita Gri-
smondi «detta la bella Becherina»]306.FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali per il Carneva-
le 1778. Alli signori maestri, e virtuosi di canto e ballo, In Milano, PerGiacomo Agnelli, Con permissione, c. 7307; [Nota di repertorio],Documento 1778: 2, in Regesto; [Repertorio biografico], FrancescoSaverio Bartoli, Notizie istoriche de’ comici italiani, cit., vol. II, p. 253.
DATA: 1778, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «nuovo teatro» di fiera.TITOLO: Il curioso indiscretoAUTORE: [Giovanni Bertati]308
COMPOSITORE: Pasquale AnfossiGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Emilia nipote del marchese; Aurelio amico del marche-
se; Clorinda dama promessa sposa al marchese; Il Contino di Ri-paverde prima amante di Emilia, poi di Corinda; Il marchese Ca-landrano curioso destinato sposo a Clorinda; Serpina cameriera diClorinda; Prospero maggiordomo e condottiero di Clorinda.
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Giardino; Camera concanapé; Orti pensili; Atto secondo: Cortile; Boschetto delizioso;Atto terzo: Cortile; Portici309.
304. La sintetica indicazione riportata nell’indice è: «BERGAMO. Si rappresen-tano Commedie».
305. Giacomo Torri, dopo aver militato nelle formazioni di Girolamo Medebache Pietro Rossi, «impiegossi in deboli e vaganti compagnie e finalmente morì in Ber-gamo la primavera del 1778», cfr. F. Bartoli, Notizie istoriche de’ comici italiani, cit., vol.II, p. 253.
306. Sulla base di una nota di repertorio delle Carte di casa Quarenghi sappiamoche i due attori erano presenti a Bergamo il 15 marzo del 1778.
307. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., p. 274.308. Attribuzione incerta cfr. F. Bascialli, Opera comica e opéra comique al teatro Ar-
ciducale di Monza (1778-1795), Lucca, 2002, p. 64 e note.309. Non esiste una tavola iniziale delle scene. Le indicazioni sono tratte dalle
didascalie interne al testo.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 377
378
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DEDICATARIO: Contessa Berlenda Eleonora Adriana Berlendis pode-staressa
DEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista Lombardi «impresario»310.CANTANTI: Rosa d’Orta (Emilia); Gregorio Gili/Gillj (Aurelio); Racche-
le/Rachele d’Orta (prima buffa, Clorinda); Stefano Mandini (pri-mo buffo mezzo carattere, Il contino di Ripaverde); Serafino Blasi(primo buffo caricato, Il marchese Calandrano); Francesca Brendi (se-conda buffa, Serpina); Luigi Trentanove (secondo buffo caricato,Prospero).
COMPOSITORE DELLA MUSICA DEI BALLI: Filippo MatteiCOREOGRAFO: Filippo BerettiBALLERINI: Filippo Beretti (primo ballerino serio); Anna Favier Beret-
ti (prima ballerina seria); Riccardo Blech/Blek «di S.A.R. il signorInfante duca di Parma» (primo grottesco); Anna Zoccoli (primagrottesca); Luigi Brendi (terzo ballerino); Maddalena Brendi (ter-za ballerina); Giovanni Pitrò (terzo ballerino); Rosa Masnieri (ter-za ballerina); Ignazio Rossi (figurante); Giovanni Oddini (figuran-te); Angiola Badi (figurante); Luigia Badi (figurante); GirolamoGreco (fuori de’ concerti); Marianna Franchi (fuori de’ concerti)311.
FONTI: [Libretto], Il curioso indiscreto. Dramma giocoso per musica da rap-presentarsi nel nuovo teatro di Bergamo, per la prossima fiera d’agosto del-l’anno 1778. Umiliato a Sua Eccellenza la nobil donna Berlenda Eleono-ra Andrianna Berlendis contessa Barzizza podestadessa, In Bergamo1778, Per Francesco Locatelli, Con Licenza de’ Superiori312; [Indi-ce di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primavera, estate edautunno 1778 e del corrente Carnevale 1779, In Milano, Per GiacomoAgnelli, Con Permissione Privilegiata313.
DATA: 1779, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]
310. Nella dedica il Lombardi afferma: «Per quanto è stato in me possibile ionon ho certamente risparmiata fatica, attenzione e spesa sia per gli attori della mu-sica sia per quelli del ballo di maniera che da molti e molti anni su le nostre scenenon si è veduta una scelta migliore».
311. I ballerini riportati sono quelli dell’indice. Nel libretto differiscono in no-mativi di tre figuranti: in luogo di Giovanni Oddini, Angiola Badi e Luigia Badi so-no registrati Bartolo Stradiotto, Flavia Badi e Maria Badi.
312. Il libretto consultato si trova in FGCV.313. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, pp. 301-302.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 378
379
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: La virtuosa alla modaAUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: Luigi Caruso «maestro di cappella napoletano».GENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Mirandolina virtuosa di musica; Monsieur Ralph capi-
tano olandese; Calinfronio padre di Mirandolina e Perinella; Giu-lietta loncandiera; Monsieur Petit francese; il conte Policastro; Pe-renella sorella di Mirandolina.
DEDICATARIO: Alessandro Barziza Podestà e Vicecapitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista Lombardi «impresario».CANTANTI: Margherita Giovanelli (Mirandolina, prima buffa); Stefa-
no Mandini (Monsieur Ralph, primo buffo mezzo carattere); Giu-seppe Cosimi (Calinfronio, primo buffo caricato); Rosa Casazza(Giulietta, seconda buffa); Giuseppe Puttini (Monsieur Petit, secon-do mezzo carattere); Gasparo Angiolini (Policastro, secondo buffo);Maria Citteria/Citeria (Perenella, terza buffa).
SCENA: «Locanda di Livorno»CAMBI DI SCENA: Sala con quattro porte praticabili; Altra camera;
Giardino.COREOGRAFO: Gaetano PacciniBALLERINI: Gaetano Paccini (primo ballerino), Marianna Paccini (pri-
ma ballerina), Pietro Zampieri (secondo ballerino), Maria Zampie-ri (seconda ballerina), Giovanni Odini (terzo ballerino), Orsola Pe-zis (terza ballerina), Bernardino Gabuti (figurante), La signora N.N. (figurante)314.
FONTI: [Libretto], La virtuosa alla moda. Dramma giocoso per musica darappresentarsi nel teatro di Cittadella in Bergamo. Nel Carnovale dell’an-no 1779. Dedicato a Sua Eccellenza il N. H. e Co. Alessandro BarzizaPodestà Vice Capitanio, in Bergamo, MDCCLXXIX, Per l’Erede de’fratelli Rossi. Con licenza de’ Superiori315; [Indice di spettacoli],Indice de’ spettacoli teatrali della primavera, estate ed autunno 1778 e del
314. I ballerini riportati sono quelli indicati nell’indice. Nel libretto i nomina-tivi differiscono: in luogo di Giovanni Odini, Orsola Pezis e Bernardino Gabuti so-no registrati Udini, Anna Pezis e «il signor N. N.».
315. Il libretto consultato si trova in CGV, 59 A 245/2.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 379
380
FRANCESCA FANTAPPIÈ
corrente Carnevale 1779, In Milano, Per Giacomo Agnelli, Con Per-missione Privilegiata, cc. 65-66316.
DATA: 1779, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, [Teatro della Cittadella].TITOLO: La vendemiaAUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: Giuseppe GazzanigaGENERE: Opera buffaCANTANTI: Margherita Giovanelli (prima buffa); Stefano Mandini
(primo mezzo carattere); Giuseppe Cosimi (primo caricato); RosaCasazza; Giuseppe Puttini; Gasparo Angiolini; Maria Citeria.
COREOGRAFO: Gaetano PacciniBALLERINI: Gaetano Paccini, Marianna Paccini, Pietro Zampieri, Ma-
ria Zampieri, Giovanni Odini, Orsola Pezis, BernardinoGabuti,«La signora N. N.».
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-ra, estate ed autunno 1778 e del corrente Carnevale 1779, In Milano, PerGiacomo Agnelli, Con Permissione Privilegiata, cc. 65-66317.
DATA: 1779, estateAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La forza delle donneAUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: Pasquale AnfossiGENERE: Opera buffaCANTANTI: Maddalena Mori Della Casa (prima buffa); Stefano Man-
dini (primo mezzo carattere); Angelo Bonifazio (primo carattere);Teresa Roffi (seconda buffa); Carlo Rossi, N. N.; Elisabetta Mar-chesini.
COREOGRAFO: Innocente Parodi
316. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 313.317. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 313.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 380
381
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
BALLERINI: Innocente Parodi, Anna Agostini, Giovan Battista Grazio-li detto Schizza (grottesco); Teresa Damiani (grottesca), Rainero Paz-zini (grottesco fuori de’ concerti), Francesca Banti (grottesca fuoride’ concerti), Luigi Zurli (mezzo carattere fuori de’ concerti); Ce-cilia Castelini (mezzo carattere fuori de’ concerti), Gaetano DeStefani (figurante), Giovanni Odini (figurante), Giuseppe Zappino(figurante), Angiola Rasmi (figurante), Ortensia Agostini (figuran-te), Giovanna Castelini (figurante).
FONTI:[Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primavera,estate ed autunno 1779 e del corrente anno 1780. Coll’elenco de’ signorimaestri di cappella, In Milano, Appresso Gio. Batista Bianchi RegioStampatore, Colla Permissione, cc. 20-21318.
DATA: 1780, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La vera costanzaAUTORE: Francesco PuttiniCOMPOSITORE: Pasquale Anfossi319
GENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Rosina pescatrice fedele; la baronessa Irene zia del con-
te Enrico; il conte Enrico sposo secreto di Rosina; Villotto cittadi-no richissimo destinato sposo di Rosina; il marchese Ernesto ami-co del conte Enrico; Masino pescatore fratello di Rosina; Lisettacameriera della baronessa.
SCENA: BelforteCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Spiaggia di mare termi-
nata dall’orizonte e lateralmente ingombrata di folti alberi, fra’quali diverse casette rustiche e capanne pescareccie320; Atto secon-
318. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 341.319. Nel libretto descritto come «maestro di cappella napolitano e del pio luo-
go de’ derelitti di SS. Giovanni e Paolo».320. La didascalia continua con la descrizione dell’azione: «Terminato il grave
della sinfonia s’alzerà il sipario e si vedrà il mare in fiorissima borrasca. Nave den-tro la quale vi saranno la baronessa Irense, il marchese Ernesto, Villotto e Lisetta. Ilmuggito del mare, il balenar de’ lampi, il rimbombo de’ tuoni verrrà accompagna-to dall’ultima parte della sinfonia; si vedranno li suddetti personaggi scendere dallanave coll’aiuto de’ marinari in un palischermo, che sarà alzato in qua e in là a di-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 381
382
FRANCESCA FANTAPPIÈ
do: Cortile nel castello di Belforte; Sala; Campagna con casa ru-stica di Rosian e torre in parte diruta contigua alla medesima321.
DEDICATARIO: Alvise Contarini podestà e vicecapitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista Lombardi «impresario».CANTANTI: Anna Pagnanelli (Rosina, prima buffa), Vincenzo Uti-
ni/Uttini (conte Enrico, primo mezzo carattere), Giuseppe Scarda-vi/Scardovi (Villotto, primo buffo caricato), Lucia Poletti (la baro-nessa Irene), Antonio Pagnanelli (marchese Ernesto, secondo buffomezzo carattere), Giovanni Addoni (Masino, secondo buffo cari-cato), Liberata Livignani (Lisetta, terza buffa).
COSTUMISTA: Signor Bacchetta di MilanoCOREOGRAFO: Giacomo Ricciardi (ballo primo), Vincenzo Tagliavi-
ni (secondo ballo)BALLERINI: Giacomo Ricciardi (primo ballerino), Maria Sermò (pri-
ma ballerina), Giovanni Barberis (pirmo grottesco); Marianna Ser-ra (prima grottesca), Giovanni Oddini/Udini (terzo ballerino), Lu-cia Neri322 (terza ballerina), «sei figuranti», Vincenzo Tagliavini (pri-mo ballerino fuori de’ concerti), Antonia Bossi (prima ballerina fuo-ri de’ concerti).
FONTI: [Libretto], La vera costanza. Dramma giocoso da rappresentarsi nelteatro di Bergamo il Carnovale 1780. Dedicato a Sua Eccellenza il NobilHomo Avlise Contarini 2° Podestà e Vice Capitanio, In Bergamo,MDCCLXXX, Per l’Erede de Fratelli Rossi. Con Licenza de’ Su-periori323; [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della pri-mavera, estate ed autunno 1779 e del corrente anno 1780. Coll’elenco de’signori maestri di cappella, In Milano, Appresso Gio. Batista BianchiRegio Stampatore, Colla Permissione, c. 57324.
DATA: 1780, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]
screzione dell’onde; calmata qualche poco la tempesta si vedrà avvicinarsi al lido.Rosina e Masino escono da una casetta spaventati».
321. Non esiste una tavola iniziale delle scene che si ricavano dalle didascalieinterne al testo.
322. Registrata solo nell’indice, mentre nel libretto è indicata come «la sig. N.N.».
323. Il libretto consultato si trova in BCBg, Sala 32 D 2 5 (8).324. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 350.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 382
383
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La scuola dei gelosiAUTORE: [Caterino Mazzolà]COMPOSITORE: Antonio SalieriGENERE: Dramma giocosoCANTANTI: Anna Pagnanelli (prima buffa), Vincenzo Utini (primo
mezzo carattere), Giuseppe Scardavi (primo caricato), Lucia Polet-ti, Antonio Pagnanelli, Giovanni Addoni, Liberata Livignani.
COREOGRAFO: Giacomo Ricciardi; Vincenzo Tagliarini.BALLERINI: Giacomo Ricciardi (primo ballerino), Maria Germò (pri-
ma ballerina), Giovanni Barberis (grottesco); Marianna Serra (grot-tesca), Giovanni Oddini, Lucia Neri, sei figuranti.
FONTI:[Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primavera,estate ed autunno 1779 e del corrente anno 1780. Coll’elenco de’ signorimaestri di cappella, In Milano, Appresso Gio. Batista Bianchi RegioStampatore, Colla Permissione325.
DATA: 1780, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA: Capocomico Antonio CameraniATTORI: Antonio Camerani, Angiola Rebecchi, Luigi Colombini,
Maddalena Paganini, Giacomo Porcieri, Eugenia Paganini, Gaspe-ro Valenti, Teresa Colombini, Domenico Mangano (Pantalone),Francesco Tomasoli (Brighella), Antonio Parucchetta (Arlecchino).
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-ra, estate ed autunno 1780 e del corrente Carnevale 1781, In Milano,Appresso Gio. Batista Bianchi Regio Stampatore, Colla Permissio-ne, c. 2326; O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., p. 127.
DATA: 1780, agosto-settembreAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro provvisorio in fiera.TITOLO: La contessinaAUTORE: [Marco Coltellini–Carlo Goldoni]
325. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 350.326. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 370.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 383
384
FRANCESCA FANTAPPIÈ
COMPOSITORE: Florian Leopold GassmannGENERE: Opera buffaIMPRESARIO: Giovan Battista LombardiCANTANTI: Maddalena Granuti (prima buffa), Pietro Urbani (primo
mezzo carattere), Giovanni Morelli (primo caricato), Rosa Gerli,Francesco Cocchi.
COREOGRAFO: Luigi DupenBALLERINI: Luigi Dupen (primo ballerino), Giuseppa Precopia (prima
ballerina), Carlo Taglioni (grottesco), Veronica Cocchi Morelli (grot-tesca), Agostino Bertorelli (mezzo carattere), Cristina de’ Agostini(mezzo carattere), Giovanni Barberis (grottesco fuori de’ concerti),Rosa Viganò (grottesca fuori de’ concerti), Giuseppe Anselmi (fi-gurante), Serafina Viganò (figurante), Antonio Sala (figurante), Ma-ria Taglioni (figurante).
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-ra, estate ed autunno 1780 e del corrente Carnevale 1781, In Milano,Appresso Gio. Batista Bianchi Regio Stampatore, Colla Permissio-ne, c. 23327; [Avviso], Documento 1780: 4, in Regesto.
DATA: 1780, settembreAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, luogo non identificato.COMPAGNIA: Attori dilettanti capeggiati da Paolina Grismondi Sec-
co Suardo.GENERE: TragediaATTORI: Paolina Grismondi Secco SuardoFONTI: [Nota di repertorio], Documento 1780: 5, in Regesto.
DATA: 1781, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.GENERE: OperaFONTI: [Nota di repertorio], Documento 1781: 3, in Regesto.
DATA: [1781, marzo]328
327. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 375.328. La rappresentazione e il periodo indicato per la sua messa in scena sono
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 384
385
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.IMPRESARIO: Giovan Battista LombardiCOMPAGNIA: Compagnia Perelli329.ATTORI: Luigi Perelli (Arlecchino).FONTI: [Nota di repertorio], Documento 1781: 5, in Regesto.
DATA: 1781, estateAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA: Capocomico Girolamo Medebach330.FONTI: O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., pp. 192-193.
DATA: 1781, estate (fiera)AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro provvisionale in fiera.TITOLO: I viaggiatori feliciAUTORE: Filippo LivigniCOMPOSITORE: Pasquale Anfossi «maestro del pio luogo dell’Ospita-
letto».GENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Bettina giovane allegra e di spirito moglie di Giannet-
to; Giannetto fuggitivo di casa sua e dato al buon tempo; Don Ga-stone spagnuolo stambo cavaglier; Don Isabella amante prima diDon Gastone e promessa sposa a Giannetto da lei non conosciu-to; Pancrazio ricco mercante e padre di Giannetto; Lauretta locan-diera; Pasquino cameriere di locanda; Servitori di Pancrazio, tre no-tari, due camerieri di locanda che non parlano.
SCENA: Milano «proprio nella locanda di Lauretta».
del tutto ipotetici. La data che riportiamo è quella della scrittura teatrale tra il capo-comico e l’impresario. Ciò non determina necessariamente la presenza dell’interacompagnia a Bergamo, ma soltanto la stesura del contratto. Secondo gli Indici tea-trali, infatti, nella primavera del 1781 la formazione è presente a Bologna e nella pri-mavera del 1782 a Brescia, cfr. O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., p. 237.
329. Compagnia costituitasi dal 1778 secondo O. Giardi, I comici dell’arte perdu-ta, cit., p. 235.
330. I componenti della compagnia per l’anno comico 1781-1782 non sono co-nosciuti, cfr. O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., p. 192.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 385
386
FRANCESCA FANTAPPIÈ
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Gran camera comune del-la locanda, con porte che introducono a vari appartamenti ed unain prospetto che dimostra la parte superiore d’un giardino; Atto se-condo: Piazzetta con veduta della locanda; Camera della locanda;Galleria illuminata con tavolini e sedie331.
DEDICATARIO: Girolamo Ascanio Zustinian podestà e vicecapitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista Lombardi «impresario».CANTANTI: Maddalena Alegranti (Bettina); Giuseppe Pinetti (Giannet-
to); Francesco Cavalli (Don Gastone); Teresa Gilardi (Don Isabella);Paolo Alessandri (Pancrazio); Antonia Lombardi (Lauretta); IgnazioBignotti (Pasquino).
MUSICISTI: Giovan Battista Rovelli (primo violino dell’opera); Filip-po Mattei (primo violino de’ balli).
COSTUMISTA: Giuseppe Bachetta di MilanoTITOLO DEI BALLI: Arianna abbandonata da Teseo (primo ballo); Ballo
pantomimo (secondo ballo).COREOGRAFO: Filippo BerettiBALLERINI: Filippo Beretti (primo ballerino serio); Anna Favier Beret-
ti (prima ballerina seria); Francesco Cipriani (primo grottesco); Te-resa Damiani (prima grottesca); Pietro Viganò (figurante), FilicitaAsperti (figurante), Bortolo Stradiotto (figurante), Maria Burci (fi-gurante), Giovanni Trusiani (figurante), Teresa Oliva (figurante),Giuseppe Bartolomei (mezzo carattere fuori de’ concerti), France-sco Bracci (mezzo carattere fuori de’ concerti), Gaspare Burci (mez-zo carattere fuori de’ concerti), Clementina Burci (mezzo caratte-re fuori de’ concerti).
FONTI: [Libretto], I Viaggiatori felici. Dramma giocoso per musica di Fi-lippo Livigni da rappresentarsi nel teatro di fiera nell’estate 1781. Dedi-cato a Sua Eccellenza Girolamo Ascanio Zustinian podestà e vice-capita-nio di Bergamo, In Bergamo, 1781, Da Vincenzo Antoine, Con per-missione332; [Nota di repertorio], Documento 1781: 7, in Regesto.
DATA: 1782, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]
331. Non esiste una tavola iniziale dei cambi di scena che pertanto si ricavanodalle didascalie interne al testo.
332. Dati ricavati dall’unico libretto esistente dell’opera conservato nella colle-zione privata Thomas Walker di Ferrara.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 386
387
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, [Teatro della Cittadella].TITOLO: L’Italiana in LondraAUTORE: [Giuseppe Petrosellini]COMPOSITORE: Domenico CimarosaGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Livia dama genovese sotto nome di Mademoiselle Er-
richetta; Sumers mercante olandese; Don Polidoro viaggiatoresciocco; Madama brillante locandiera; Laurina caffettiera; MilordArespingh amante di Livia.
SCENA: LondraCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Piazza con bottega di caf-
fè. Unita alla medesima vi è la locanda con portone praticabile;Sala nella locanda; Giardino; Atto secondo: Appartamenti terreninella locanda.
DEDICATARIO: Girolamo Ascanio Giustiniani podestà e vicecapitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: Carlo Giuseppe Fossati «impresario».CANTANTI: Giulia Moroni (Livia, prima buffa); Nicola del Sole (Su-
mers); Giacomo Pedrinelli (Don Polidoro, primo carattere); MariaMoroni (Madama); Antonia Fava (Laurina); Giuseppe Lorenzi (Mi-lord Arespingh, primo mezzo carattere).
COSTUMISTI: «Signori Motta e Mazza di Milano».COREOGRAFO: Leopoldo Campilli/Campigli.MUSICISTI: Michele Melani (cembalo); Giambattista Rovelli (capo
d’orchestra); Giuseppe Sanpieri (primo violino per li balli).TITOLI DEI BALLI: Le vindemmie disturbate (primo ballo); Le nozze con-
trastate (secondo ballo).BALLERINI: Leopoldo Campilli/Campigli (primo ballerino); Stella Cel-
lini (prima ballerina); Luigi Brendi (primo ballerino mezzo carat-tere fuori de’ concerti); Maddalena Brendi (prima ballerina mezzocarattere fuori de’ concerti); Giuseppe Marconi (primo grottesco);Luigia Cellini (prima grottesca); Pietro Brendi (ballerino di mezzocarattere); Nicola Testini (ballerino di mezzo carattere); AngiolaLazzari/Lazari (figurante); Gaetano Gaffino (figurante); Maria Poz-zi (figurante); Giacomo Zilli (ballerino); Giacomo Danieletti (figu-rante), Cecilia Precopia (ballerina)333.
333. Si riportano i nominativi secondo l’indice. Nel libretto Giacomo Zilli viene re-gistrato come «Giacomo Zini», mentre mancano Nicola Testini e Giacomo Danieletti.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 387
388
FRANCESCA FANTAPPIÈ
FONTI: [Libretto], L’Italiana in Londra. Comedia per musica da rappre-sentarsi nel teatro di Bergamo in città il Carnevale 1782. Umiliata a SuaEccellenza il Signor Girolamo Ascanio Zustinian Podestà e Vice Capita-nio, In Bergamo, Con Lincenza de’ Superiori, [1782]334; [Indice dispettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primavera, estate ed autun-no 1781 e del corrente Carnevale 1782, In Milano, Appresso Gio. Ba-tista Bianchi Regio Stampatore, A spese di Gio. Batista Cacciò, ConPermissione Privilegiata, c.42335.
DATA: 1782, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: Gli amanti canutiAUTORE: Carlo Lanfranchi RossiCOMPOSITORE: Pasquale Anfossi «maestro di cappella napolitano».GENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Madama Vistosa, vedova di pochi mesi amante di Gia-
cinto; Giacinto giovane amante di Madama Vistosa; Buonatuttogiovine raggiratore; Droghetta cameriera di Madama; Mestolinascufiara; Papavero vecchio settagenario amante di Madama Visto-sa; Flaterio vecchio ottagenario amante di Madama.
SCENA: ChioggiaCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Piccola piazzetta avanti
la casa di Madama Vistosa; Vago giardino con vasi di fiori, viali estatue che lo circondano; Camera; Strada; Camera in casa di Ma-dama; Atto secondo: Strada; Piazzetta con case all’intorno; Came-ra; Strada di campagna con alberi; Piccola largura circondata dagrossi alberi che introduce in foltissimo bosco336.
DEDICATARIO: Girolamo Ascanio Zustinian podestà e vicecapitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: Carlo Giuseppe FossatiCANTANTI: Giulia Moroni (Madama Vistosa), Nicola del Sole (Giacin-
to), Giacomo Pedrinelli (Buonatutto), Maria Moroni (Droghetta), An-
334. I libretti consultati sono conservati in CGV, 59 A 245/5 e in FGCV.335. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 416.336. Non esiste una tavola iniziale delle scene che si ricavano dalle didascalie
interne del testo.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 388
389
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
tonia Fava (Mestolina), Francesco Morella (Papavero), Giuseppe Lo-renzi (Flaterio).
MUSICISTI: Michele Melani (cembalo), Giambatista Rovelli (capod’orchestra), Giuseppe Sanpieri (primo violino de’ balli).
COSTUMISTA: Motta e Mazza di Milano.COREOGRAFO: Leopoldo CampilliBALLERINI: Leopoldo Campilli (primo ballerino), Stella Cellini (pri-
ma ballerina), Giuseppe Marconi (primo grottesco), Luigia Cellini(prima grottesca), Nicola Testini (mezzo carattere), Sig. N. N. (mez-zo carattere), Pietro Brendi (mezzo carattere), Luigi Brendi (primoballerino mezzo carattere fuori de’ concerti), Maddalena Brendi(prima ballerina mezzo carattere fuori de’ concerti), Gaetano Gaf-fino (altro ballerino del concerto), Angiola Lazari (altra ballerinadel concerto), Giacomo Zilli (altro ballerino del concerto), MariaPozzi (altra ballerina del concerto), Giacomo Daneletti (altro bal-lerino del concerto), Cecila Precopia (altra ballerina del concerto),«sei figuranti».
FONTI: [Libretto], Gli amanti canuti. Dramma giocoso per musica del no-bile signore Carlo Lanfranchi Rossi gentiluomo toscano fra gli arcadi Egi-sippo Argolide da rappresentarsi nel teatro della Cittadella il Carnovale1782. Dedicato a Sua Eccellenza il signor Girolamo Ascanio ZustinianPodestà e Vicecapitanio, In Bergamo, Con Licenza de’ Superiori337.
DATA: 1782, autunnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Il convitoAUTORE: [Filippo Livigni]COMPOSITORE: Domenico CimarosaGENERE: Opera buffaCANTANTI: Francesca Buccarelli (prima buffa), Vincenzo del Moro
(primo mezzo carattere), Agostino Liparini (primo caricato), Ma-ria Clementi, Giovanni marini, Giuseppe Marchesi, Giovanna Ce-resina.
337. Il libretto consultato si trova conservato in BIMDBg, I° 8336 I 572.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 389
390
FRANCESCA FANTAPPIÈ
COREOGRAFO: Alberto CovosBALLERINI: Carlo Fiorillo (primo ballerino), Costanza Bernabei (pri-
ma ballerina), Giuseppe Casacci (primo grottesco), Marianna Fran-chi (prima grottesca), Pietro Santi (terzo ballerino), AnnunziataBrunoni (terza ballerina), Gioacchino Mari (primo ballerino fuoride’ concerti), Violante Torti (prima ballerina fuori de’ concerti), An-drea Marlotti (primo ballerino fuori de’ concerti), Teresa Mariotti(prima ballerina fuori de’ concerti), Gaetano Biffi (figurante), Gio-vanna Castagna (figurante), Giovanni Checchi (figurante), Gaeta-na Corsoli (figurante), Francesco Zappa (figurante), Vittoria Chen-na (figurante), Francesco Durello (figurante), Giuseppe Frigeria (fi-gurante), Camilla Bedotti (figurante), Teresa Mattioli (figurante).
SCENOGRAFO: FossatiCOSTUMI: Carlo CorelliTITOLI DEI BALLI: La vedova fiaminga (primo ballo), Gli amanti burlati
(secondo ballo)FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-
ra, estate ed autunno 1782 e del corrente Carnevale 1783, In Milano, PerGiambatista Bianchi Reg. Stampatore, A spese di Gio. Batista Cac-ciò, Con Permissione Privilegiata, c. 25338.
DATA: 1783, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: Il matrimonio per inganno339
AUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: Pasquale AnfossiGENERE: Opera buffa con balliPERSONAGGI: Giannina, figlia di don Fabrizio; Florindo, giovane di
spirito amante di Giannina; Don Fabrizio, ricco mercante; Giuliet-ta, pupilla di don Fabrizio; Don Volpone, notaio della curia aman-te di Giannina; Valerio, giovane collegiale ignorante promesso spo-so a Giannina; Rosina, cameriera in casa di don Fabrizio.
DEDICATARIO: Francesco Morosini podestà e vicecapitanio.
338. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 440.339. Nell’indice è registrato come Il matrimonio per forza.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 390
391
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
IMPRESARIO: Giovan Battista LombardiCANTANTI: Clementina Clos340 (Giannina, prima buffa); Andrea
Chiappini (Florindo, primo buffo mezzo carattere); Vincenzo Go-resi (Don Fabrizio, primo buffo caricato); Rosa Cataldi Pizzoli (Giu-lietta, seconda buffa); Francesco Morella (Don Volpone, secondo[buffo] mezzo carattere); Camillo Pizzoli (Valerio, secondo buffocaricato); Ester Grassi (Rosina, terza buffa).
COSTUMISTI: Motta e Mazza di Milano.COREOGRAFO: Carlo Fiorillo/FiorilliBALLERINI: Carlo Fiorillo (p rimo ballerino serio), Livia Maffei (pri-
ma ballerina seria), Stefano Magagnini (primo grottesco), Madda-lena Porci Magagnini (prima grottesca), Paolo Softer (terzo balle-rino), Anna Mantecassi/Mantegassi (terza ballerina), Carlo Duello(figurante), Anna Maffei (figurante), Giuseppe Rossi (figurante),Antonia Asperti (figurante).
FONTI: [Libretto], Il matrimonio per inganno. Dramma giocoso per musicada rappresentarsi nel teatro di Cittadella in Bergamo nel Carnovale del 1783.Dedicato a Sua Eccellenza Francesco Morosini primo cavaliere e Podestà eVicecapitanio, In Bergamo MDCCLXXXII, Da Vincenzo Antoine,Con Permissione341; [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatralidella primavera, estate ed autunno 1782 e del corrente Carnevale 1783, InMilano, Per Giambatista Bianchi Reg. Stampatore, A spese di Gio.Batista Cacciò, Con Permissione Privilegiata, c. 97342.
DATA: 1783, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Giannina e BernardoneAUTORE: [Filippo Livigni]COMPOSITORE: Domenico CimarosaGENERE: Opera buffaCANTANTI: N. Cloché (prima buffa), Andrea Chiappini (primo mez-
zo carattere), Vincenzo Goresi (primo caricato), Rosa Pizzoli, Ca-millo Pizzoli, N. N., Estera Grassi.
340. Nell’indice egistrata come «N. Cloché».341. Il libretto consultato si trova in BCBg, Sala 32 C 8 21 (1).342. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 458.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 391
392
FRANCESCA FANTAPPIÈ
COREOGRAFO: Carlo FiorilliBALLERINI: Carlo Fiorilli (primo ballerino), Livia Maffei (prima bal-
lerina), Stefano Magagnini (grottesco), Maddalena Magagnini (grot-tesca), Paolo Soster (terzo ballerino), Anna Mantegazzi (terza bal-lerina); «2 figuranti».
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-ra, estate ed autunno 1782 e del corrente Carnevale 1783, In Milano, PerGiambatista Bianchi Reg. Stampatore, A spese di Gio. Batista Cac-ciò, Con Permissione Privilegiata, c. 97343.
DATA: 1783, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA: Compagnia Nicola Menichelli.ATTORI: Nicola Menichelli (Arlecchino)344.FONTI: O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., pp. 198-199.
DATA: 1783, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro in fiera.TITOLO: ErifileAUTORE: [Giovanni De Gamerra]COMPOSITORE: Giuseppe Giordani345
GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Erifile regina di Zacinto promessa sposa a Cleomene;
Cleomene principe reale di Nasso; Learco comandante dell’armi ereggente del Regno di Zacinto; Ermione principessa amica d’Erifi-le; Cresfonte confidente di Learco; Idaspe capitano delle reali guar-die.
DEDICATARIO: «Dame e cavalieri»346.
343. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 458.344. Formazione costituita nel 1780 sotto il capocomicato di Nicola Menichel-
li. I componenti della formazione per l’anno comico 1783-1784 non sono conosciu-ti, cfr. O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., p. 198.
345. Nel libretto indicato come «maestro Giordanello napolitano».346. L’opera viene offerta direttamente al pubblico. Nella dedica interna al te-
sto l’impresario Giovan Battista Lombardi chiede, però, la protezione «dell’Eccel-lentissimo Kr. Morosini illustre rappresentante di questa provincia».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 392
393
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista Lombardi «impresario».CANTANTI: Anna Pozzi, cantante dell’Infante Duca di Parma (Erifile);
Domenico Bedini (Cleomene); Giacomo David, cantante di came-ra dell’Infante Duca di Parma e cantante della cappella di corte diMilano (Learco, tenore); Susanna Contini (Ermione); Francesco Ci-beli (Cresfonte); Santo/Santino Sala (Idaspe).
MUSICISTI: Carlo Lenzi (cembalo), N. Sant’Angiolino (capo d’orche-stra), Antonio Enrico (primo violino per i balli).
SCENOGRAFI: «Fratelli Galliari».CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Gran piazza festivamen-
te adorna per l’arrivo di Learco; Sala; Tempio con simulacro dellaDea Giunone; Atto secondo: Giardino; Sala Reggia con Trono; Sot-terraneo languidamente illuminato; Atto terzo: Recinto de’ sepol-cri con porta; Sotterraneo con sepolcro e sedile per Erifile; Reggiacon trono.
COSTUMISTI: Motta e Mazza di Milano.BALLI: La Semiramide (ballo primo); Le Tableau Parland/Parlant (ballo
secondo).COREOGRAFO: Giovan Battista GianniniBALLERINI: Giovan Battista Giannini (primo ballerino serio); Madda-
lena Caterina Vilneou/Villeneuve (prima ballerina seria); GuglielmoBanti (primo grottesco); Felicita Banti (prima grottesca); Semarita-na Destefani (terza ballerina); Luigi Zurli (terzo ballerino); FelicitaDucot (terza ballerina fuori di concerto); Giuseppe Buden/Boudet(figurante); Rosa Masnieri (figurante); Carlo Vilneous/Villeneuve (fi-gurante); Serafina Viganò (figurante); Giuseppe Lena (figurante);Margherita Ducot (figurante); Gaetano Biffi (figurante); Maria Isa-cha/Isacca (figurante); Francesco Vertova/Vertua (figurante); MariaOsti (figurante); Stefano Magagnini (grottesco fuori de’ concerti);Maddalena Magagnini (grottesca fuori de’ concerti).
FONTI: [Libretto], Erifile. Dramma per musica da rappresentarsi nel teatrodi Bergamo nella prossima fiera dell’anno 1783. Dedicato alle nobiliss. da-me, e nobiliss. cavalieri, In Bergamo, Per l’Erede Rossi, Con appro-vazione347; [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della pri-mavera, estate ed autunno 1783 e del corrente Carnevale 1784, A spesedi Gio. Batista Cacciò, Con Permissione Privilegiata, cc.17-18348.
347. Il libretto consultato si trova in CGV, 59 A 245/6.348. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, pp. 468-469.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 393
394
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DATA: 1783, autunnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA: Compagnia Mazzotti349.FONTI: [Nota di repertorio], Documento 1783: 7, in Regesto.
DATA: 1784, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La finta principessaAUTORE: [Filippo Livigni]COMPOSITORE: Felice Alessandri romano.GENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Rosina villanella; Ruggiero principe di Taranto; Don Se-
sto Pappamosca; Bortolina villanella; Don Quinzio fratello di don Se-sto Pappamosca; Berenice principessa di Salerno; Leonzio torriere.
SCENA: Vicinanze di SalernoCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Villaggio in riva del Ma-
re, con nobile palazzo de’ fratelli Pappamosca da un lato, dall’al-tro casa rustica di Bortolina. In prospetto antica torre, situata trafolti alberi; Atto secondo: Camera con due porte laterali, tavolinoe sedie; Parte di cupa e oscura valle con fiume e ponte praticabile.Grotta da un lato350.
CANTANTI: Palmira Saffi Nencini (Rosina, prima buffa), ArmandoChiaracci/Chiavacci (Ruggiero, primo buffo mezzo carattere), Gio-van Battista Seni351 (primo buffo caricato), Gaetana Crespi (Borto-lina, seconda buffa), Francesco Negri (don Quinzio, secondo buffocaricato), Adamo/Adamino Bianchi (Leonzio, secondo buffo mez-zo caricato), Teodolinda Bossi (Berenice, terza buffa).
COSTUMISTA: Gaetano Erba di Milano
349. Impossibile determinare i componenti della formazione per l’anno comi-co 1783-1784. È solo dal 1789-1790 che conosciamo l’interna formazione posta sot-to il capocomicato dell’attore Luigi Mazzotti-Malipiero, cfr. O. Giardi, I comici del-l’arte perduta, cit., p. 186.
350. Non esiste una tavola iniziale delle scene che pertanto si ricavano dalle di-scalie interne al testo.
351. Nel libretto, in luogo di Giovan Battista Seni, viene registrato Carlo Alip-pi.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 394
395
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
COREOGRAFO: Antonio CrespiBALLERINI: Antonio Crespi (primo ballerino), Anna Agostini (prima
ballerina), Gaetano Lombardini/Lombardi (primo grottesco), An-giola Chiocchia (prima grottesca), Luigi Zurli (ballerino di mezzocarattere), Marianna Belazzi (ballerina di mezzo carattere), France-sco Rossini (terzo ballerino), Rosa Masnieri Zuri (terza ballerina),«sei figuranti»352.
FONTI: [Libretto], La finta principessa. Dramma giocoso per musica da rap-presentarsi nel Teatro di Bergamo nel Carnovale 1784, In Bergamo, Perl’Erede Rossi, Con Approv. [1784]353; [Indice di spettacoli], Indicede’ spettacoli teatrali della primavera, estate ed autunno 1783 e del corren-te Carnevale 1784, A spese di Gio. Batista Cacciò, Con Permissio-ne Privilegiata, c. 51354.
DATA: 1784, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: La ballerina amanteAUTORE: [Cesare Augusto Casini]COMPOSITORE: Domenico CimarosaGENERE: Opera buffaCANTANTI: Palmira Saffi (prima buffa), Armando Chiaracci (primo
mezzo carattere), Giambatista Seni (primo caricato), Gaetana Cre-spi, Adamo Bianchi, Carlo Alippi, Teodolinda Bossi.
COREOGRAFO: Antonio CrespiBALLERINI: Antonio Crespi (primo ballerino), Anna Agostini (prima
ballerina), Gaetano Lombardini (grottesco), Angiola Chiocchia(grottesca), Luigi Zurli (mezzo carattere), Marianna Belazzi (mez-zo carattere), Francesco Rossini (terzo), Rosa Masnieri Zuri (terzo),«sei figuranti».
352. Nel libretto Luigi Zurli e Marianna Belazzi sono iscritti come terzo balle-rino e terza ballerina, mentre Francesco Rossini e Rosa Masnieri Zuri sono indicaticome quarto ballerino e quarta ballerina.
353. L’unico libretto rimasto dell’opera è conservato in BCBg, Sala 32 D 2 5 (9).Si tratta, purtroppo, di un esemplare mutilo. Mancano le carte, poste tra il fronte-spizio e l’elenco degli interpreti, normalmente contenenti l’Avvertimento a chi leggedell’impresario.
354. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 477.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 395
396
FRANCESCA FANTAPPIÈ
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-ra, estate ed autunno 1783 e del corrente Carnevale 1784, A spese di Gio.Batista Cacciò, Con Permissione Privilegiata, c. 51355.
DATA: 1784, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Fra i due litiganti il terzo godeAUTORE: [Carlo Goldoni]COMPOSITORE: Giuseppe Sarti «di Faenza»GENERE: Dramma giocosoCANTANTI: Angelo Bonifazi (primo buffo caricato), Marianna de Mar-
chi (prima buffa), Andrea Chiappini (primo buffo mezzo caratte-re), Giacomo Alessandri (primo buffo mezzo carattere), GiuseppeCavenaga Bianchi, Carlo Barlassina, Giovanna Barlassina
COREOGRAFO: Alessandro GuglielmiBALLERINI: Alessandro Guglielmi (primo ballerino), Lucia Fabris Mo-
nari (prima ballerina), Antonio Sirletti (primo grottesco), OrsolaGoresi (prima grottesca), Luigi Zurli (mezzo carattere), Elena Fusi(mezzo carattere), Stefano Magagnini (fuori de’ concerti), Giamba-tista Nichili (fuori de’ concerti), Maddalena Magagnini (fuori de’concerti), Francesco Durelli (figurante), Anna Fusi (figurante), An-gelo Beretti (figurante), Rosa Zurli (figurante), Carlo Castellini (fi-gurante), Rosa Alessandri (figurante).
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primave-ra, estate ed autunno 1784 e del corrente Carnevale 1785. Dedicato allacelebre virtuosa di musica la signora Anna Morichelli Bosello, In Mila-no, Per Giambatista Bianchi Reg. Stampatore, A spese di Gio. Ba-tista Cacciò, Con Permissione Privilegiata, c. 2356.
DATA: 1784, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «Nobile provisionale teatro di Fiera».TITOLO: Medonte
355. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 477.356. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 499.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 396
397
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
AUTORE: [Giovanni De Gamerra]COMPOSITORE: Giuseppe Sarti «maestro di cappella della metropoli-
tana di Milano».GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Medonte re di Epiro amante e promesso sposo di Se-
lene; Selene principessa figlia di Aglauro re d’Argo amante d’Arsa-ce; Arsace principe reale di Dodone supremo generale dell’armid’Epiro; Zelinda principessa reale di Larissa tributaria ed amica diMedonte; Evandro grande del regno d’Epiro e capitano delle regieguardie; Talete uno dei principali del regno d’Argo; Sacrificatori abi-tatori del Tempio della Vendetta; Ministri del Tempio della Ven-detta; Capi di principe vassalli di Medonte; Soldatesche del regnod’Argo del seguito di Selene; Grandi del regno d’Argo del seguitodi Selene
DEDICATARIO: Girolamo Giustinian podestà e vicecapitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: Giuseppe LombardiCANTANTI: Matteo Babbini (Medonte, tenore), Anna Morichelli Bo-
sello (Selene), Michel Angelo Neri «virtuoso di camera di S. A. R.Infante di Spagna e Duca di Parma» (Arsace), Paula Balduni (Zelin-da), Marianna Franceschetti (Evandro, da secondo uomo), Giusep-pe Desirò (Talete).
MUSICISTI: Michele Melani (cembalo), Gio. Battista Rovelli (primoviolino dell’opera), Antonio Strinasachi (primo violino de’ balli),Cristoforo Caffi (primo oboe), Gaetano Zanetti (primo violoncel-lo), Francesco Bolognesi (primo contrabbasso).
COSTUMISTA: Motta e Mazza di MilanoCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Corpo di guardia nella
reggia illuminato di notte. Vasta piazza piena di popolo per il fe-stivo ingresso di Selene. Appartamenti nella Reggia destinati a Se-lene; Atto secondo: Appartamenti. Antico tempio sotterraneo il-luminato, con orrido simulacro della vendetta. Appartamenti; At-to terzo: Cortile. Parte della Reggia d’onde si scuopre il campo di-sfatto di Medonte.
SCENOGRAFO: Gasparo e Fabrizio Galleari.MACCHINISTA: Alessandro Paese e compagni di Milano.TITOLO DEI BALLI: Atridate e Farnace (ballo primo); Soccorso inaspetta-
to (ballo secondo)SCENE DEL PRIMO BALLO: Scena prima: Folto bosco con veduta in
distanza fra gli alberti la città di Raclè con porta praticabile in avan-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 397
398
FRANCESCA FANTAPPIÈ
ti di detta città. Scena seconda: Antico e magnifico sottorraneo do-ve vi sono tutti li depositi del re di ponte illuminato a lampade.Scena terza: Grande galleria che conduce alli appartamenti di Pom-peo. Scena quarta: Grande piazza della città di Raclè con rogo ac-ceso nel mezzo. Scena quinta: Grande appartamento illuminato intempo di notte ove vi sono schierati li due eserciti di Pompeo eFarnace.
SCENE DEL SECONDO BALLO: Bosco con collina amena.COREOGRAFO: Giovanni FavierBALLERINI: Carlo Augusto Favier (primo ballerino serio); Catarina Wil-
lneuve/Villeneuve (prima ballerina seria); Giuseppe Scalesi (primogrottesco), Domenica Ferri (prima grottesca), Francesco Citte-rio/Citerio (terzo ballerino), Maria Garibotti357 (terza ballerina),Giuseppe Boudet358 (terzo ballerino), Marianna Beldeschi (terzaballerina), Carlo Willneuve/Villeneuve (figurante), Rosa MasnieriZurli (figurante), Francesco Zappa (figurante), Maria Maggioni (fi-gurante), Giuseppe Ambrosini (figurante), Teresa Olliva/Oliva (fi-gurante), Luigi Perri (figurante), Rosa Toscanini (figurante), CarloCastellini (figurante), Clara Majer (figurante)359, Luigi Zurli (primoballerino mezzo carattere fuori dei concerti), Violante Torri (primoballerino mezzo carattere fuori dei concerti), Alessandro Guliel-mi/Guglielmi (primo grottesco fuori dei concerti), Angiola Chio-chia/Chiocchia (prima grottesca fuori dei concerti), Gaetano Lom-bardini (primo grottesco fuori dei concerti).
FONTI: [Libretto], Medonte. Dramma per musica da rappresentarsi nel no-bile provisional teatro di fiera in Bergamo umiliato a S. E. nobil uomo s.Girolamo Zustinian Podestà e Vice Capitanio, in Bergamo, per Fran-cesco Locatelli, Con Licenza de’ Superiori, 1784360; [Indice di spet-tacoli], Indice de’ spettacoli teatrali della primavera, estate ed autunno1784 e del corrente Carnevale 1785. Dedicato alla celebre virtuosa di mu-sica la signora Anna Morichelli Bosello, In Milano, Per Giambatista
357. Nel libretto in luogo di Maria Garibotti viene registrata Vittoria Chenni.358. Nel libretto è registrato come Carlo Boudet.359. Si riportano i ballerini registrati nell’indice. Nel libretto i nominativi pre-
sentano leggere differenze: in luogo dei figuranti Francesco Zappa, Giuseppe Am-brosini, Luigi Perri, Rosa Toscanini, figurano Antonio Ugetta, Silvestro Perri, LuigiAmbrosiani, Maria Toscanini.
360. Il libretto non è registrato in C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit. Si tro-va conservato in CGV, 59 A 246/1.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 398
399
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
Bianchi Reg. Stampatore, A spese di Gio. Batista Cacciò, Con Per-missione Privilegiata, c. 15361.
DATA: 1784, agostoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Balletto]LUOGO: Bergamo, teatro provvisionale in fiera.TITOLO: Atridate e FarnaceAUTORE: Giovanni FavierCOMPOSITORE: Giovanni FavierGENERE: Ballo eroico-pantomimoPERSONAGGI: Farnace re di Ponto; Tamiri sua moglie; Atridate padre
di Tamiri; Zelinda sorella di Farnace; Pompeo proconsole roma-no; Aquilio generale romano; un fanciullo figlio di Farnace e diTamiri; principale officiale di Farnace; prime dame della corte diTamiri; altre dame seguaci di Tamiri e di Zelinda; soldati di Farna-ce; soldati Romani.
SCENA: EracleaDEDICANTE: Giovanni FavierIMPRESARIO: [Giovan Battista Lombardi]COREOGRAFO: Giovanni FavierBALLERINI: Carlo Augusto Favier (Farnace); Catarina Willneuve (Ta-
miri); Giuseppe Boudet (Atridate); Violante Torri (Zelinda); LuigiZurli (Pompeo); Giuseppe Scalesi (Aquilio); Alessandro Guglielmi(fanciullo); Francesco Ciaterio (principale ufficiale); Domenica Ferri(dama di corte); Angiola Chiochia (dama di corte).
FONTI: [Libretto], Atridate e Farnace. Ballo eroico-pantomimo in cinqueatti, composto e diretto dal signor Giovanni Favier. Posto in scena per laprima volta nel Nobile Provisionale Teatro di Bergamo, in occasione del-la solita Fiera d’Agosto nell’Anno MDCCLXXXIV, Bergamo, Per Fran-cesco Locatelli, Con Licenza de’ Superiori, 1784362.
DATA: 1784, agostoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Balletto]LUOGO: Bergamo, teatro provvisionale in fiera.
361. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 502.362. Il libretto consultato si trova in BCBg, 20 R 3 (6).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 399
400
FRANCESCA FANTAPPIÈ
TITOLO: Il soccorso inaspettatoAUTORE: Giovanni FavierCOMPOSITORE: Giovanni FavierGENERE: Ballo pantomimoDEDICANTE: Giovanni FavierIMPRESARIO: [Giovan Battista Lombardi]COREOGRAFO: Giovanni FavierFONTI: [Libretto], Secondo ballo. Il soccorso inaspettato. Ballo pantomimo
preso dalle favole di Mr. De La Fontaine. La Musica de’ suddetti balli èdella composizione del detto signor Giovanni Favier, Bergamo, Per Fran-cesco Locatelli, Con Licenza de’ Superiori, 1784.
DATA: 1785, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: Il pittor pariginoAUTORE: [Giuseppe Petrosellini]COMPOSITORE: [Domenico Cimarosa]GENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Madamoiselle Eurilla giovane ricca dedita alla poesia;
Monsieur di Crotignac pittore amante d’Eurilla; Il baron Criccapromesso sposo d’Eurilla uomo collerico e geloso; Cintia cuginad’Eurilla ragazza di spirito amante del barone; Sandra cameriera diCintia; Broccardo agente d’Eurilla; Serpione primo giovine di mon-sieur di Crotignac; Studenti di pittura; Servitori di Madama; Ame-ricani finti.
DEDICATARIO: Girolamo Zustinian podestàDEDICANTE/IMPRESARIO: «Associati all’impresa».CANTANTI: Barbara Saffi (Eurilla, prima buffa); Dionigio Merlini (Mon-
sieur di Crotignac, primo mezzo carattere); Michele Ferrari (Il baronCricca, primo buffo caricato); Teresa Lozza (Cintia, seconda buffa);Rosa Pizzoli (Sandra, altra buffa); Camillo Pizzoli (Broccardo, secon-do mezzo carattere); Francesco Rasetti (Serpione, secondo buffo ca-ricato).
COREOGRAFO: Luigi GoriBALLERINI: Luigi Gori (primo ballerino); Teresa Colombi (prima bal-
lerina); Felice Masan (primo grottesco); Rosa Masan (prima grot-tesca); Luigi Zurli (fuori de’ concerti); Rosa Zurli (terza ballerina);
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 400
401
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
Giuseppe Moler (terzo ballerino); Angiola Boldoni (terza balleri-na); Giovanni Ambrosioni (terza ballerina); Giuseppe Paris (terzoballerino).
FONTI: [Libretto], Il pittor parigino dramma giocoso in musica da rappre-sentarsi nel teatro della Cittadella 1785. Umiliato a S. E. il N. H. Giro-lamo Zustinian podestà di Bergamo, Bergamo, Dalla Stamparia Ros-si, Con Approv.363; [Documento epistolare], Documento 1784: 5,in Regesto.
DATA: 1785, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.TITOLO: Il vecchio gelosoAUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: Felice Alessandri «di Roma».GENERE: Opera buffaCANTANTI: Barbara Sassi (prima buffa), Dionigi Merlini (primo mez-
zo carattere), Michele Ferrari (primo caricato), Teresa Lozza, Fran-cesco Rasetti, Camillo Pizzoli, Rosa Pizzoli
COREOGRAFO: Luigi GoriBALLERINI: Luigi Gori (primo ballerino), Teresa Colombi (prima bal-
lerina), Felice Masan (primo grottesco), Rosa Masan (prima grot-tesca), Angiola Boldona (terza), Giuseppa Moler (terza).
FONTI: Indice de’ spettacoli teatrali della primavera, estate ed autunno 1784e del corrente Carnevale 1785. Dedicato alla celebre virtuosa di musica lasignora Anna Morichelli Bosello, In Milano, Per Giambatista BianchiReg. Stampatore, A spese di Gio. Batista Cacciò, Con PermissionePrivilegiata, c. 47364.
DATA: 1785, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato365.
363. Il libretto consultato si trova in CGV, 59 A 246/2.364. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 510.365. Nel repertorio, o Tavola dell’ubicazioni de’ spettacoli teatrali ne’ rispettivi paesi e
città descritti in questo libro, redatto alla fine dell’indice degli spettacoli teatrali trovia-mo: «Bergamo, teatro nuovo in fiera». L’indicazione si riferisce sicuramente al luo-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 401
402
FRANCESCA FANTAPPIÈ
COMPAGNIA: Capocomico Antonio Camerani366.FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali di tutto l’anno,
dalla primavera 1785 a tutto e il Carnevale 1786, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, c. 11367; O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit.,p. 128.
DATA: 1785, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA: Capocomico Daniele del Puppo368.FONTI: O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., p. 146.
DATA: 1785, estateAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro in fiera detto «Nuovo provvisional teatro»369.TITOLO: L’OsmaneAUTORE: Gaetano SertorCOMPOSITORE: Giuseppe Giordani370
GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Zadira creduta suddita e sorella d’Amente, ma figlia del
re; Osmane generale dell’armata reale già deposto, amante di Za-dira; Zoaspe re di Bratta; Azema, altra figlia di Zoaspe; Ametegrande del regno amico d’Osmane; Arsamo capo delle guardie rea-li e nemico d’Osmane
SCENA: Battra sul fiume ZariaspeCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Luogo magnifico nella
Regia, ornato di statue, vasi di fiori e piramidi; Sala regia vagamen-
go di rappresentazione dell’opera in musica Osmane. Difficile stabilire, però, se pos-sa associata anche agli spettacoli della compagnia Camerani.
366. La composizione della formazione nell’anno comico 1785-1786 è scono-sciuta, cfr. O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., p. 127.
367. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 528.368. La composizione della formazione nell’anno comico 1785-1786 è scono-
sciuta, cfr. O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., p. 145.369. Si veda l’indice degli spettacoli teatrali (c. 11). Nel libretto viene erronea-
mente indicata come occasione «la solita fiera di San Bartolomeo».370. Il libretto continua come segue: «detto Giordaniello, maestro di cappella
napolitano».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 402
403
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
te ornata; Deliziosa; Atto secondo: Portici reali; Appartamenti ri-moti; Parte della città di Battra con strada solitaria ingombrata davecchie inselvatichite piante e da fabbriche diroccate che conduceal fiume Zariaspe; Oscuro sotterraneo; Atto terzo: Luogo destina-to a’ rei condannati a morte, chiuso all’interno da cancelli e cir-condato da guardie.
SCENOGRAFO: Antonio Baila milanese371
DEDICATARIO: Girolamo Giustinian podestàDEDICANTE/IMPRESARIO: «Gli associati»372.CANTANTI: Anna Pozzi cantante del duca di Parma (Zadira, prima don-
na seria); Domenico Bruni (Osmane, primo uomo); Gaetano Sco-velli (Zoaspe, primo tenore); Carolina Paracca (Azema, secondadonna); Felicita Zolla (Amete, secondo uomo); Giovanni Costa(Arsamo, secondo tenore).
COSTUMISTA: Motta e Mazza di MilanoTITOLO DEI BALLI: La Galzeuca, o sia la Gioconda liberata dalla Tiranni-
de di Scour-Malou (primo ballo); Il matrimonio per concorso (secondoballo).
COREOGRAFO: Paolino FranchiBALLERINI: Paolino Franchi (primo ballerino serio); Elena Dondi (pri-
ma ballerina seria); Antonio Maraffi (primo grottesco); Teresa Da-miani (prima grottesca); Felice Masan (primo grottesco); Rosa Ma-san (prima grottesca); Luigi Zurli (ballerino di mezzo carattere); Lo-renzo Giannini (figurante); Rosa Masnieri Zurli (figurante); Giu-seppe Verselotti/Verzellotti (figurante); Maria Zanardi (figurante);Camillo Lena373 (figurante); Teresa Toscanini (figurante); VincenzoCasabona (figurante); Felicita Rovis (figurante); Giovanni Ambro-sioni (figurante); Metilde Verselotti/Verzellotti (figurante); Carlo Pa-pini (figurante); Teresa Ravarina (figurante); Carlo Sechio-ni/Secchioni (figurante); Francesca Barazza (figurante); VincenzoMigliorucci (primo ballerino mezzo carattere fuori de’ concerti as-soluto); Giuseppe Herlisca/Herdlitzka (primo ballerino mezzo ca-
371. Libretto: «Lo scenario sarà tutto nuovo, d’invenzione ed esecuzione del sig.Antonio Baila milanese».
372. I quali nella dedica del libretto specificano: «l’Osmane dramma serio, che sirappresenterà colla più decente decorazione nel ricorso della vicina fiera, avendosiabbandonata anche ogni vista economica pel maggiore riuscimento del decoro».
373. Nel libretto è registrato come Giuseppe Lena.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 403
404
FRANCESCA FANTAPPIÈ
rattere fuori de’ concerti assoluto); Foscarina Evangelista (prima bal-lerina mezzo carattere fuori de’ concerti assoluta).
FONTI: [Libretto], L’Osmane. Dramma serio per musica da rappresentarsinel teatro di fiera nell’estate 1785. Dedicato a Sua Eccellenza GirolamoZustinian podestà di Bergamo, In Bergamo MDCCLXXXV, Da Vin-cenzo Antoine, Con permissione374; [Indice di spettacoli], Indice de’spettacoli teatrali di tutto l’anno, dalla primavera 1785 a tutto il Carne-vale 1786, In Milano, Con Privilegio di Privativa, cc. 11-12375; [No-ta di repertorio], Documento 1785: 7, 12, in Regesto.
DATA: 1786, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «Teatro in Città».TITOLO: La villanella rapitaAUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: Francesco BianchiGENERE: Opera buffaCANTANTI: Angelica Maggiori Gallieni (prima buffa), Luigi Monti
(primo mezzo carattere), Giovan Battista Viscardi (primo buffo ca-ricato), Teresa Lozza (seconda buffa), Antonia Castiglioni (terza buf-fa), Ignazio Bignotti (secondo mezzo carattere), Alessandro Giova-nola (secondo buffo caricato), Maddalena Mori Della Casa (altraprima buffa).
COREOGRAFO: Vincenzo MonariBALLERINI: Antonio Buggini (primo ballerino), Elena Bossi (prima bal-
lerina), Ortensia Agostini (prima ballerina), Angiola Boldoni (mez-zo carattere), Santo Meregato (mezzo carattere), Luigi Zurli (mez-zo carattere), Luigia Acerbi (fuori de’ concerti), Rosa Masnieri Zur-li (figurante), Paolo Cavazza (figurante), Laura Zanetti (figurante),Carlo Bedotti (figurante).
TITOLI DEI BALLI: Il barone e baronessa burlati (primo ballo), Lo svizze-ro ingannato (secondo ballo).
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ spettacoli teatrali di tutto l’anno,dalla primavera 1785 a tutto il Carnevale 1786, In Milano, Con Pri-
374. Il libretto consultato si trova conservato in FGCV.375. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 528.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 404
405
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
vilegio di Privativa, cc. 12-13376; [Note di repertorio], Documenti1786: 2-6, in Regesto.
DATA: 1786, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella o «Teatro in Città»377.TITOLO: Le gelosie villaneAUTORE: [Tommaso Grandi]COMPOSITORE: Giuseppe SartiGENERE: Opera buffaCANTANTI: Angelica Maggiori Gallieni (prima buffa), Luigi Monti
(primo mezzo carattere), Giovan Battista Viscardi (primo buffo ca-ricato), Teresa Lozza (seconda buffa), Antonia Castiglioni (terza buf-fa), Ignazio Bignotti (secondo mezzo carattere), Alessandro Giova-nola (secondo buffo caricato), Maddalena Mori della Casa (altraprima buffa).
COREOGRAFO: Vincenzo MonariBALLERINI: Antonio Buggini (primo ballerino), Elena Bossi (prima bal-
lerina), Ortensia Agostini (prima ballerina), Angiola Boldoni (mez-zo carattere), Santo Meregato (mezzo carattere), Luigi Zurli (mez-zo carattere), Luigia Acerbi (fuori de’ concerti), Rosa Masnieri Zur-li (figurante), Paolo Cavazza (figurante), Laura Zanetti (figurante),Carlo Bedotti (figurante).
TITOLI DEI BALLI: Il barone e baronessa burlati (primo ballo), Lo svizze-ro ingannato (secondo ballo).
FONTI: [Indici teatrali], Indice de’ spettacoli teatrali di tutto l’anno, dallaprimavera 1785 a tutto il Carnevale 1786, In Milano, Con Privilegiodi Privativa, cc. 12-13378; [Note di repertorio], Documenti 1786: 2-6, in Regesto.
DATA: 1786, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.
376. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, pp. 528-529.377. Definito «Teatro in Città» nell’indice degli spettacoli.378. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, pp. 528-529.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 405
406
FRANCESCA FANTAPPIÈ
COMPAGNIA: Capocomico Giuseppe Pellandi.TITOLO DI OPERE RAPPRESENTATE: Dario; Gabriella di Vergi; La Virgi-
nia di Vittorio Alfieri (13 maggio); Gli oracoli funesti di Diana supe-rati dalla forza dell’amore con Trufaldino trionfatore del Minotauro al-l’isola de’ mostri (14 maggio).
ATTORI: Giovanni Androux (ruolo di padre), Maria Angiola Androuxdetta la Pispola (serva), Domenico Barsanti (tiranno), Chiara Be-nedetti, Luigi Benedetti, Maria Donati, Dorotea Donati, Anna Fio-rilli, Agostino Fiorilli (Tartaglia), Antonio Martelli (Brighella), Ago-stino Minnelli, Giulio Minnelli (Pantalone), Antonio Pellandi, Giu-seppe Pellandi (Arlecchino), Pietro Rinaldi, Elisabetta Vinacesi, Al-fonso Zanoni (Agonia) e «subalterni».
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1786 a tutto il Carnevale 1787, In Milano, Con Privi-legio di Privativa379; [Avvisi teatrali e note di repertorio], Documen-ti 1786: 18-19, in Regesto; O. Giardi, I comici dell’arte perduta, p. 230.
DATA: 1786, agostoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «Teatro di Prato in Fiera»380.TITOLO: La Didone abbandonataAUTORE: [Pietro Metastasio]COMPOSITORE: «Musica di vari autori»GENERE: Dramma serioPERSONAGGI: Didone; Enea; Jarba; Araspe; Selene; Osmida.DEDICATARIO DEL LIBRETTO: Andrea Da Mula podestà.DEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista Vitali Rota. Dedica: 22
agosto 1786.CANTANTI: Anna Benini Mengozzi (Didone, prima donna); Gaspa-
ro/Gaspare Savoi/Savoj (Enea, primo soprano/uomo); BernardoMengozzi (Jarba, primo tenore); Cecilia Bolognesi (Araspet, secon-do soprano/uomo); Vincenza Ponticelli (Selene, seconda donna);Carolina Cavaglieri/Cavalieri (Osmida, secondo tenore).
SCENOGRAFO: Gasparo e Fabricio fratelli Galeari.COSTUMISTI: Motta e Mazza di Milano.
379. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, pp. 588, 591.380. Definito «Teatro di Prato in fiera» nell’indice degli spettacoli.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 406
407
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
MUSICISTI: Giovanni Rovelli (primo violino dell’opera).COREOGRAFO: Pietro AngioliniBALLERINI: Pietro Angiolini (primo ballerino serio), Eularia Coppini
(prima ballerina seria), Giovanni Codacci (primo grottesco), Tere-sa Dolci Pitrot (prima grottesca), Eleonora Coppini (prima grotte-sca), Lorenzo Cavaglieri/Cavalieri (primo grottesco); Giovanni Pi-trot (terzo ballerino), Eugenia Sperati (terza ballerina), Stefano Ma-gnini (primo grottesco fuori de’ concerti), Maddalena Magagnini(prima grottesca fuori de’ concerti), Giovanni Ambrosio-ni/Ambrosiani (figurante), Assunta Scanza/Scanzi (figurante), Lo-renzo Gianni (figurante); Benedetta Bedotti (figurante), FrancescoVitali (figurante), Orsola Strada (figurante), Francesco Badei (figu-rante), Benedetta Strada (figurante), Camillo Bedotti (figurante),Laura Zanetti (figurante), N. N. (figurante), Anna Coppini (figu-rante).
BALLI: Ercole negli Orti Esperidi, ballo favoloso pantomimo (primo bal-lo); Le reclute del villaggio, ballo comico (secondo ballo).
DIRETTORE DEI BALLI: Giuseppe ZampieriFONTI: [Libretto], La Didone abbandonata. Dramma serio da rappresen-
tarsi in Bergamo l’anno 1786 umiliato a Sua Eccellenza il N. H. AndreaDa Mula podestà di Bergamo, MDCCLXXXVI, da Vincenzo Antoi-ne, Con Permissione381; [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spet-tacoli di tutto l’anno dalla primavera 1786 a tutto il Carnevale 1787, InMilano, Con Privilegio di Privativa, c. 11382; [Avviso teatrale e no-te di repertorio], Documenti 1786: 34, 43, in Regesto.
DATA: 1787, settembreAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, «Teatro in Fiera».COMPAGNIA: Capocomico Francesco Menichelli383.TITOLO DELLE OPERE RAPPRESENTATE: Le glorie di Kouli-Kano innalza-
to al trono di Persia, dramma favoloso di Pietro Chiari (2 settembre);
381. Il libretto consultato si trova conservato in CGV, 59 A 246/3.382. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, pp. 591-592.383. Nell’avviso teatrale la formazione è definita «compagnia di Francesco Me-
nichelli». Secondo O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., pp. 194, 199, invece, il ca-pocomicato è da attribuire a Nicola Menichelli, mentre Francesco avrebbe assuntola guida della troupe solo dal 1789.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 407
408
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Le convulsioni delle donne e suo rimedio per guarirle, farsa (3 settembre);Il pazzo ragionevole, farsa di Joseph Patrat (3 settembre); La morte diKouli-Kano a cavallo alla testa del suo esercito, dramma favoloso di Pie-tro Chiari (4 settembre); Ludovico Sforza detto il moro, dramma sto-rico (12 settembre).
ATTORI: Francesco Menichelli, Gaetano Businelli, Francesco Testeri,N. Gattinari, Caterina Fiorilli, Teresa Donati, Elisabetta Gattinari,N. Costanti (serva), Raimondo Costantini (caratterista), GiovanBattista Gozzi (Pantalone), Innocente De Cesari (Brighella), Anto-nio Fiorilli (Tartaglia), N. Mancini (Arlecchino), «subalterni».
FONTI: [Avvisi], Documenti 1787: 25, 27, in Regesto; [Indice di spet-tacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno, dalla primavera 1787a tutto il Carnevale 1788, Con Privilegio di Privativa, cc. 11-12384; O.Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., p. 199.
DATA: 1788, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: I castellani burlati385
AUTORE: [Filippo Livigni]COMPOSITORE: Vincenzo Fabrizi napoletanoGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Zefferina cantatrice, moglie di Valerio del medesimo ab-
bondata per gelosia e pretesa da due castellani; Gradasso naso stor-to, sciocco castellano tedesco pretendente di Zefferina; Valerio, uo-mo geloso povero e vagabondo; Spaccamonte, castellano spagno-lo pretendente di Zeffirina; Giulietta, birriera del tedesco; Carlot-ta, ostessa italiana; Pippetto, fratello di Zeffferina.
SCENA: vicinanze di VarsaviaDEDICATARIO: conte Leonardo Valmarana capitanio e vicepodestàIMPRESARIO: Giovan Battista Lombardi «impresario»CANTANTI: Teresa Benvenuti (Zefferina, prima buffa), Camillo Bastia-
nelli (Gradasso naso storto, primo buffo caricato), Andrea Urbani (Va-
384. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 659.385. Nell’indice degli spettacoli il titolo è leggermente diverso: I due castellani
burlati.386. Nel libretto indicato come «il signor N. N., altro mezzo carattere».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 408
409
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
lerio, primo mezzo carattere), Dionigi Merlini386 (Spaccamonti, se-condo mezzo carattere), Vittoria Bastianelli (Giulietta, seconda buf-fa), Maria Valeri387 (Carlotta, terza donna), Antonio Berino388 (Pip-petto, secondo buffo caricato).
COREOGRAFO: Luigi CorticelliBALLERINI: Luigi Corticelli (primo ballerino), Teresa Melacci/Melazzi
(prima ballerina), Carlo Banti (primo grottesco), Cristina Agosti-ni/De Agostini (prima grottesca), Francesco Vitali (figurante), Giu-seppe Vitali389 (figurante), Rosa Zurli (figurante), Maria Vitali (figu-rante), Luigi Zurli390 (terzo ballerino), Antonia Vittori (terza balle-rina).
FONTI: [Libretto], I castellani burlati. Dramma giocoso per musica da rap-presentarsi nel teatro di Cittadella il Carnovale 1788. Dedicato a Sua Ec-cellenza il Nobil Uomo Co. Leonardo Valmarana Capitanio e Vice Pode-stà, in Bergamo, Dalla Stamperia Rossi, Con Licenza de’ Superio-ri, [1788]391; [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tuttol’anno, dalla primavera 1787 a tutto il Carnevale 1788. Con Privilegiodi Privativa, cc. 11-12392; [Avviso], Documento 1788: 15, in Rege-sto.
DATA: 1788, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella o «Teatro in Città»393.TITOLO: Le gelosie fortunateAUTORE: [Filippo Livigni]COMPOSITORE: Pasquale AnfossiGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Madonna Giuditta giovane bizzarra supposta vedova
di don Ricardo e perciò destinata sposa di don Pompeo; Don Pom-
387. Registrata come «Maria Valeria» nell’indice.388. Secondo il libretto con il ruolo di terzo buffo.389. Nel libretto indicato come «signor N. N.».390. Nel libretto Luigi Zurli e Antonia Vittori sono registrati come «mezzo ca-
rattere fuori dei concerti».391. Il libretto si trova conservato in BCBg, Sala 32 C 8 21 (2) e CGV, 59 A
246/7.392. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 659.393. Definito «Teatro in Città» nell’indice degli spettacoli.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 409
410
FRANCESCA FANTAPPIÈ
peo ricco genovese, ma sciocco e faceto; Don Ricardo marito diMadama Giuditta, ma dalla medesima diviso; Monsignor Giròviaggiatore affettato e cavalier servente di Madama; Barberina go-vernante di casa di don Pompeo; Nicoletta cameriera; Giacominocameriere.
SCENA: «La scena si finge in Genova nella propria casa di Don Pom-peo»
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Sala magnifica con varierporte; Atto secondo: Camera; Antico sotterraneo.
DEDICATARIO: Leonardo Valmarana capitanio e vicepodestà.DEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista LombardiCANTANTI: Teresa Benvenuti (Madonna Giuditta, prima buffa), Camil-
lo Bastianelli (Don Pompeo, primo buffo caricato), Andrea Urbani(Don Ricardo, primo mezzo carattere), Dionigi Merlini394 (MonsignorGirò, secondo mezzo carattere), Antonio Berino (Giacomino, secon-do buffo caricato), Vittoria Bastianelli (Barberina, seconda donna),Maria Valeri395 (Nicoletta, terza donna).
MUSICISTI: Antonio Gonzales (maestro di cembalo), Giovan BattistaRovelli (primo violino dell’opera), Giuseppe Lombardi (primo vio-lino de’ balli).
COREOGRAFO: Luigi CorticelliBALLERINI: Luigi Corticelli (primo ballerino), Teresa Melac-
ci/Melazzi (prima ballerina), Carlo Banti (primo grottesco), Cri-stina De Agostini (prima grottesca), Francesco Vitali (figurante),Giuseppe Vitali396 (figurante), Rosa Zurli (figurante), Maria Vita-li (figurante), Luigi Zurli397 (terzo ballerino), Antonia Vittori (ter-za ballerina).
FONTI: [Libretto], Le gelosie fortunate dramma giocoso per musica da rap-presentarsi nel Teatro di Cittadella il Carnevale 1788 dedicato a Sua Ec-cellenza il Nobil Huomo conte Leonardo Valmarana capitanio e vicepo-destà, In Bergamo, Dalla stamperia Rossi, Con Licenza de’ Supe-riori, [1788]398; [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di
394. Nel libretto indicato come «il signor N. N.».395. Registrata come «Maria Valeria» nell’indice.396. Nel libretto indicato come «signor N. N.».397. Nel libretto Luigi Zurli e Antonia Vittori sono registrati come «mezzo ca-
rattere fuori dei concerti».398. Il libretto consultato si trova in BSCr, PP. 23. 8.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 410
411
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
tutto l’anno, dalla primavera 1787 a tutto il Carnevale 1788, Con Pri-vilegio di Privativa, cc. 11-12399.
DATA: 1788, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: Le trame deluseAUTORE: [Giuseppe Maria Diodati]COMPOSITORE: Domenico CimarosaGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Ortensia sotto nome di Lucinda, donna astuta che si
finge figlia di don Anselmo negoziante romano promessa sposa adon Artabano; Glicerio, cavalier bolognese tradito da Ortensia inBologna amante di Olimpia; Don Artabano, vecchio sciocco esemplice che per trama di don Nardo si crede sposo di Ortensiacol finto nome di Lucinda; Dorinda, gentildonna senese in quali-tà di giardiniera in casa di don Artabano, giovane tradita e rubatada don Nardo Fionda; Olimpia, nipote di don Artabano, amantedi Glicerio; Don Nardo Fionza, uomo vagabondo e raggiratore cheviene in casa di don Artabano in compagnia di Ortensia.
SCENA: NapoliDEDICATARIO: conte Leonardo Valmarana capitanio e vicepodestà.DEDICANTE/IMPRESARIO: «Li quattro associati».CANTANTI: Luigia Benvenuti «detta la Fiamminga» (Ortensia, prima
buffa); Paolo Villa, detto il Catalano (Glicerio, mezzo carattere), Do-menico Madrigali (Don Artabano, primo buffo caricato), CandidaCerati (Dorinda, seconda donna a vicenda), Giuseppa Masan (Olim-pia, seconda donna a vicenda), Antonio Viscardini (Don NardoFionza, secondo buffo).
COREOGRAFO: Francesco Cipriani; Felice Masan.BALLERINI: Francesco Citerio (primo ballerino), Margherita Prada (pri-
ma ballerina), Felice Masan (primo grottesco assoluto), Rosa Ma-san (prima grottesca assoluta), Gaetano De Stefani (terzo balleri-no), Vittoria Cheni (terza ballerina), Angelo Masan (altro balleri-no), Angelo Ferinini (altro ballerino), Maria Codaci (altro balleri-
399. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 659.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 411
412
FRANCESCA FANTAPPIÈ
no), Maria Stradiotti (altro ballerino), Giacomo Tarapaton (secon-do grottesco), Margherita Cipriani (seconda grottesca), FrancescoCipriani (primo grottesco assoluto fuori dei concerti), GeltrudeGelasi (prima grottesca assoluta fuori de’ concerti).
FONTI: [Libretto], Le trame deluse. Dramma giocoso per musica da rappre-sentarsi nel teatro della Cittadella la primavera 1788 dedicato a Sua E. ilN. H. Sig. Conte Leonardo Valmarana Capitanio e Vice Podestà di Ber-gamo, in Bergamo, Con Licenza de’ Superiori, [1788]400; [Indice dispettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera1788 a tutto il Carnevale 1789, In Milano, Con Privilegio di Priva-tiva, cc. 17-18401; [Avviso], Documento 1788: 8, in Regesto.
DATA: 1788, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: Il Capriccio drammatico ed il Convitato di Pietra ossia il don Gio-
vanni402
AUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: Diversi autori per Il Capriccio drammatico; Giuseppe
Gazzaniga per Il Convitato di Pietra.GENERE: Opera buffaPERSONAGGI DEL PRIMO ATTO: Policastro impresario; Guerina; Pasqui-
no; Ninetta; Il cavalier Tempesta protettore; Calandra; Valerio;Suggeritore dell’opera; «maestro di cembalo che non parla».
PERSONAGGI DEL SECONDO ATTO: Don Giovanni, Donna Anna fi-glia del commendatore d’Oliota, Donna Elvira sposa di don Gio-vanni, Donna Ximena dama di Villena; Il Commendatore padredi donna Anna; Duca Ottavio sposo promesso della medesima, Ma-turina sposa promessa di Biaggio; Pasquariello servo confidente didon Giovanni; Biagio contadino sposo di Maturina; Lanterna al-tro servo di don Giovanni.
400. Libretti consultati conservati in BCBg, Sala 32 C 8 21 (3) e CGV, 59 A246/4.
401. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 722.402. Secondo l’indice degli spettacoli l’opera era suddivisa in due parti: «Primo
atto. Il Capriccio drammatico. Musica di vari autori. Secondo atto. Il Convitato di Pie-tra. Musica del sig. Maestro Gazzaniga».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 412
413
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DEDICATARIO: Leonardo Valmarana podestà e vicecapitanioDEDICANTE/IMPRESARIO: «Gli associati»403.CANTANTI: Domenico Madrigali (Policastro, primo buffo caricato);
Luigia Benvenuti detta la Fiaminga (Guerina, prima buffa); PaoloVilla detto il Catalano (Pasquino, primo mezzo caricato); CandidaCerati (Ninetta, seconda buffa a vicenda), Antonio Viscardini (Il ca-valier Tempesta, secondo buffo caricato); Giuseppa Masan (Calan-dra, seconda buffa a vicenda); Gaetano Bianchi (Valerio, secondomezzo carattere).
SCENA DEL PRIMO ATTO: Città della GermaniaSCENA DEL SECONDO ATTO: Villena nell’AragonaCAMBI DI SCENA PER IL SECONDO ATTO: Giardino con appartamen-
to vicino; Campagna con case rustiche e casino nobile; Luogo ri-moto circondato da cipressi con urna sepolcrale e statua equestre;Sala che si trasforma in scena infernale.
MUSICISTI: Gio. Antonio Gonsales (cembalo); Giovan Battista Rovel-li (direttore dell’orchestra); [Giuseppe] Lombardi (primo violino deiballi).
TITOLO DEI BALLI: Il ratto de’ zingari (ballo primo); I cacciatori felici (bal-lo secondo)404.
COREOGRAFO: Francesco Cipriani; Felice Masan.BALLERINI: Francesco Citerio/Citterio (primo ballerino), Margherita
Prada (prima ballerina), Felice Masan (primo grottesco assoluto),Rosa Masan (prima grottesca assoluta), Gaetano De Stefani (terzoballerino), Vittoria Cheni/Chenni (terza ballerina), Angelo Masan(ballerino di concerto), Maria Codaci/Codacci (ballerin di concer-to), Angelo Ferinini/Ferini (ballerino di concerto), Teresa Stradiot-to405 (ballerina di concerto), Giacomo Tarapaton/Trabattoni (se-condo grottesco), Margherita Cipriani (seconda grottesca), France-sco Cipriani (primo grottesco assoluto fuori dei concerti), Geltru-de Gelasi/Galassi (prima grottesca assoluta fuori dei concerti).
FONTI: [Libretto], Il Capriccio drammatico per il primo atto ed il Convita-to di Pietra ossia il Don Giovanni per il secondo atto. Rappresentazione
403. I quali nel libretto dichiarano che si tratta della seconda opera del Teatrodella Cittadella, dove si sta svolgendo ancora la prima, ossia Le trame deluse.
404. Titoli registrati nell’indice degli spettacoli teatrali.405. Nel libretto registrata come Maria Stradiotti, con il ruolo di «altra balleri-
na», da lei condiviso con Angelo Masan, Maria Codacci, Angiolo Ferini.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 413
414
FRANCESCA FANTAPPIÈ
giocosa per la second’opera nel teatro di Cittadella la primavera dell’anno1788. Dedicata a Sua E. il N. H. il sig. conte Lionardo Valmarana Ca-pitanio e V. Podestà di Bergamo, in Bergamo, Con Licenza de’ Supe-riori406; [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’an-no dalla primavera 1788 a tutto il Carnevale 1789, In Milano, ConPrivilegio di Privativa, cc. 17-18407; [Avviso], Documento 1788: 19,in Regesto.
DATA: 1788, post 14 giugno–ante 17 luglioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, [Teatro della Cittadella].COMPAGNIA: Capocomico Gregorio Cicuzzi e Giovanni Marchesi-
ni.TITOLO DELLE OPERE RAPPRESENTATE: L’amore irritato dalla difficoltà o
sia Teresa e Claudio di Giovanni Greppi (14 giugno); La donna archi-bugier francese di Francesco di Sangro (28 giugno); Il fanatismo allaberlina di Francesco di Sangro (30 giugno e 17 luglio); La favola delcorvo di Carlo Gozzi (29 giugno).
ATTORI: Gregorio Cicuzzi (caratterista), Giovanni Marchesini (Arlec-chino), [Gennaro Petruzzi, Girolamo Pinzelli, Francesco Taddei Lui-gi Marchesini, Angiola Cicuzzi Marchesini, Carolina Ferro, Regi-na Marchesini (madre), Giuseppa Meraviglia, Anna Morini (serva),Alberto Ferro (Pantalone), Battista Donati (Brighella), Giuseppe Ruf-fo (Tartaglia)]408.
FONTI: [Avvisi], Documento 1788: 24, 26-27, in Regesto409.
406. Il libretto consultato si trova in CGV, 59 A 246/5-6.407. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 722.408. La composizione della compagnia non è registrata negli Avvisi stampati a
Bergamo, dove sono riportati solo i nominativi di Gregorio Cicuzzi e Giovanni Mar-chesini in qualità di capocomici, ma si ricava da quella indicata negli indici deglispettacoli per l’anno comico 1788-1789. Cfr. anche O. Giardi, I comici dell’arte perdu-ta, cit., p. 179.
409. La tournée non è registrata negli indici degli spettacoli, né in O. Giardi, I co-mici dell’arte perduta, cit.
410. Secondo l’indice degli spettacoli gli attori rimasero in città per pochi gior-ni e solo per l’espresso volere del capitanio: «nel suddetto teatro fece tre rappresen-tazioni la compagnia comica italiana diretta dal sig. Luigi Perelli per conto ed ordi-ne di S. Eccellenza il sig. conte Valmarana capitano di Bergamo, cioè nel giorno 1,9, 10 agosto 1788».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 414
415
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DATA: 1788, 1, 9, 10 agosto410
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.COMPAGNIA: Capocomico Luigi Perelli.ATTORI: Francesco Martelli, Antonio Belloni, Domenico Nerini, Fer-
dinando Pelizza, Pietro Venerio, Raimondo Costanti, Luigia Bel-loni, Laura Checcati, Teresa Consoli, Anna Perelli, Chiara Mattor-dici, Rosa Bossi, Santo Bossi, Maria Costanti (serva), DomenicoLucchesi (primo amoroso all’improvviso), Vincenzo Mattordici(Pantalone), Claudio Borghieri (Dottore), Giovanni Bossi (Brighella),Luigi Perelli (Arlecchino), «subalterni»411.
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1788 a tutto il Carnevale 1789, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, c. 18412.
DATA: 1788, agostoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, casotto provvisorio in fiera con due ordini di logge413.TITOLO: I due supposti conti ossia lo sposo senza moglieAUTORE: [Angelo Anelli]COMPOSITORE: Domenico Cimarosa414
GENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Beatrice donzella scaltra ed allegra sorella di don Panta-
leo; Don Pantaleo gentiluomo di Monza fratello di Beatrice; Mar-cotondo rustico agricoltore di Crema che si finge il conte Farfallo-ne; Caramella fittaiuolo mantovano; Fidalma parente ed amante didon Pantaleo; Laurina cameriera di Beatrice; Pippetto caffettiere; Co-ro di convitati; Coro di seguaci di don Pantaleo; Coro di finti me-dici; Comparse di Sonatori; di Birri; di Sgherri; di Servitori.
411. La composizione è quella registrata nell’indice degli spettacoli per l’annocomico 1788-1789, cfr. O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., pp. 233-234. Ciò nonsignifica, però, che nel corso delle rappresentazioni tenute a Bergamo fossero pre-senti tutti i membri del gruppo.
412. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 722.413. Costruttori dell’edificio teatrale provvisorio furono Francesco Cipriani e
Giuseppe Gattai, cfr. Documento 1788: 28, in Regesto.414. Il libretto continua: «maestro di cappella napolitano all’attual servizio del-
la Real Cappella e maestro del conservatorio detto l’Ospedaletto di Venezia».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 415
416
FRANCESCA FANTAPPIÈ
SCENA: MonzaCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Galleria illuminata con
specchi e lampadari; Piazza di Monza con bottega di caffè; Stan-za; Fabbriche dirute con varie caverne e nascondigli con scala inprospetto; Atto secondo: Piazza con caffè come nell’atto primo;Camera con porte che introducono a varie stanze; Giardino conveduta nel circondario di Monza.
SCENOGRAFO: Gaspare Galliari415
DEDICATARIO: Contessa Elisabetta Duodo Widmann.DEDICANTE/IMPRESARIO: «Gli associati dell’impresa»CANTANTI: Susanna Contini (Beatrice, prima buffa); Paolo Villa il Ca-
telano (Don Pantaleo, primo mezzo carattere); Lorenzo Cipriani can-tante del Duca di Parma (Marcotondo, primo buffo caricato); Lui-gi Monti (Caramella, altro primo buffo caricato); Luigia Vigorelli(Fidalma, seconda donna); Giuseppa Masan (Laurina, terza don-na); Antonio Bini (Pippetto, secondo mezzo carattere).
MUSICISTI: Antonio Gonzales (cembalo); Giovanni Rovelli (primoviolino dell’opera); Giuseppe Lombardi (primo violino per i bal-li).
COSTUMISTA: Giuseppe Arpisani milanese416.MACCHINISTA: Mattia Vacchino milanese.TITOLO DEI BALLI: La morte di Temisto (primo ballo); Amore all’azzar-
do (secondo ballo).COREOGRAFO: Domenico Ballon417.BALLERINI: Domenico Ballon (primo ballerino serio); Teresa Ballon
(prima ballerina seria); Felice Masan (primo grottesco a perfetta vi-cenda estratti a sorte per i loro rispettivi posti); Francesco Cipria-ni (primo grottesco a perfetta vicenda); Rosa Masan (prima grotte-sca a perfetta vicenda); Marianna Monti Papini (prima grottesca aperfetta vicenda); Giovanni Cipriani (primo grottesco a perfetta vi-cenda)418; Francesco Testini (terzo ballerino); Margherita Cipriani
415. Nel libretto: «Il scenario, sia dell’opera che de’ balli è tutto nuovo inven-tato dal celebre pittore architetto Gasparo Galeari».
416. Nel libretto: «Il vestiario tutto nuovo del sig. Giuseppe Arpisani milanese».417. Nel libretto: «Li balli saranno inventati e composti dal signor Domenico
Ballon al servizio di S. A. Elett. Palatina Duca di Baviera».418. In merito al ruolo di Felice Masan, Francesco Cipriani, Rosa Masan, Ma-
rianna Monti Papini, Giovanni Cipriani, nel libretto si specifica: «primi grotteschi aperfetta vicenda estratti a sorte per i loro rispettivi posti».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 416
417
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
(terza ballerina); Maria Mariati (altra ballerina); Giovanni Fonta-nella (altro ballerino); Carlo Calvi (altro ballerino); Vincenzo Ca-sabona (corpo di ballo); Maria Codacci (corpo di ballo); AntonioPetrelli (corpo di ballo); Anna Petrelli (corpo di ballo); Giovan Bat-tista Marchesini (corpo di ballo); Maria Guidi (corpo di ballo); Gio-vanni Ferrari (corpo di ballo); Antonia Cervi (corpo di ballo); An-giolo Masan (corpo di ballo); Teresa Fontanella (corpo di ballo);Antonio Cenni (corpo di ballo); Giustina Nolis (corpo di ballo);Antonio Ferini/Ferrini (corpo di ballo); Anna Feroni/Ferroni (cor-po di ballo); Giuseppe Conti (corpo di ballo); Giulia Crespi (cor-po di ballo); Antonio Papini (primo ballerino fuori di concerto);Marianna Mariati/Mariatti (prima ballerina fuori di concerto); «2amorini».
FONTI: [Libretto], I due supposti conti ossia lo sposo senza moglie. Dram-ma giocoso per musica da rappresentarsi nella fiera di Bergamo per la pros-sima fiera d’agosto 1788 dedicato a Sua Eccellenza la nobil donna contes-sa Elisabetta Duodo Widmann, In Bergamo, Con Approv., [1788]419;[Avvisi], Documenti 1788: 33-34, in Regesto; [Indice di spettacoli],Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1788 a tuttoil Carnevale 1789, In Milano, Con Privilegio di Privativa, cc. 18-19420.
DATA: 1789, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: La modista raggiratriceAUTORE: [Giambattista Lorenzi]COMPOSITORE: Giovanni PaisielloGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Madama Perlina innamorata di don Gavino; Gianfer-
rante maestro di spada promesso a Ninetta e amante di Madama;Don Gavino maestro di scuola latina uomo sciocco; Mitridate spe-ciale di medicina promesso a Chiarina e amante di Madama; Ni-netta figlia di Mitridate e promessa sposa di Gianferrante; Chiari-na sorella di Gianferrante e promessa sposa di Mitridate; Cicottogiovane della bottega di Madama
419. Il libretto consultato si trova in FGCV.420. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 723.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 417
418
FRANCESCA FANTAPPIÈ
SCENA: NolaDEDICATARIO: Elisabetta Duodo contessa Widmann.DEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista Lombardi «impresario».CANTANTI: Rosa Bassoli Madrigali cantante della Duchessa di Mode-
na (Madama Perlina, prima buffa); Giovanni Pezzani (Gianferrante,primo mezzo carattere); Domenico Madrigali (Don Gavino, primobuffo caricato); Filippo Bandini (Mitridate, altro buffo), Teresa Mo-linari (Ninetta, seconda donna), Teresa Giurini (Chiarina, secondadonna), Antonio Berino/Berini (Cicotto, secondo mezzo carattere).
MUSICISTI: Antonio Gonzales (cembalo); Giovan Battista Rovelli(primo violino dell’opera); Giuseppe Lombardi (primo violino deiballi).
COSTUMISTA: Giovan Battista PiccalugaCOREOGRAFO: Pietro GiudiceBALLERINI: Pietro Giudice (primo ballerino), Teresa Sedini (prima bal-
lerina), Salvatore La Ros/La Rose (primo grottesco assoluto), An-nunziata Albertini (prima grottesca assoluta), Carlo Banti (primogrottesco fuori de’ concerti), Teresa Ravarina (prima grottesca fuo-ri dei concerti), Luigi Zurli (primo ballerino di mezzo carattere fuo-ri de’ concerti), Margarita Albertini (prima ballerina di mezzo ca-rattere fuori dei concerti).
BALLI: Egisto e Clorinice, ballo pantomimo (primo ballo), L’amante sta-tua (secondo ballo).
FONTI: [Libretto], La Modista raggiratrice. Dramma giocoso per musicada rappresentarsi nel Teatro di Cittadella il carnevale 1789. Dedicato a S.E. Elisabetta Duodo contessa Widmann, in Bergamo, Con Approv.,[1789]421; [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’an-no dalla primavera 1788 a tutto il Carnevale 1789, In Milano, ConPrivilegio di Privativa, c. 20422; [Avvisi e componimenti poetici],Documenti 1789: 1, 3, 6, 8-13, in Regesto.
DATA: 1789, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella o «Teatro in Città»423.
421. Il libretto consultato si trova in CGV, 59 A 246/8.422. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 723.423. Definito «Teatro in Città» nell’indice degli spettacoli.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 418
419
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
TITOLO: Il marito disperato424
AUTORE: [Giambattista Lorenzi]COMPOSITORE: Domenico CimarosaGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Gismonda, moglie di don Corbolone e figliuola del mar-
chese Castagnacci; Valerio, amante di Eugenia; Don Corbolone,marito di Gismonda; Marchese Castagnacci, padre di Gismonda;Dorina, cameriera di Gismonda; Eugenia, amante di Valerio; con-te Fanfalucchi.
SCENA: NapoliCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: 1. Atrio di casa corri-
spondente ai giardini. 2. Piazza di città. 3. Galleria; Atto secon-do: 4. Atrio suddetto. 5. Giardini. 6. Piazza suddetta. 7. Galleriasuddetta.
DEDICATARIO: Zuanne Widmann podestà; conte Lunardo Valmara-na capitanio.
DEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista LombardiCOSTUMISTA: Giovan Battista PiccalugaCANTANTI: Rosa Bossoli Madrigali, cantante della duchessa di Mode-
na (Gismonda, prima buffa); Giovanni Pezzani (Valerio, primo mez-zo carattere); Domenico Madrigali (Don Corbolone, primo buffo ca-ricato); Filippo Bandini (Marchese Castagnacci, altro buffo); TeresaMolinari (Dorina, seconda donna); Teresa Giurini (Eugenia, secon-da donna); Antonio Berini425 (Conte Fanfalucchi, secondo mezzo ca-rattere).
MUSICISTI: Antonio Gonzales (maestro al cembalo), Giovan BattistaRovelli (primo violino dell’opera), Giuseppe Lombardi (primo vio-lino dei balli).
COREOGRAFO: Pietro GiudiceBALLERINI: Pietro Giudice (primo ballerino), Teresa Sedini (prima bal-
lerina), Salvatore La Ros/La Rose (primo grottesco assoluto), An-nunziata Albertini (prima grottesca assoluta), Carlo Banti (primogrottesco fuori de’ concerti), Teresa Ravarina (prima grottesca fuo-ri de’ concerti), Luigi Zurli (primo ballerino mezzo carattere fuoride’ concerti), Margherita Albertini (prima ballerina mezzo caratte-re fuori de’ concerti), «vari figuranti».
424. O anche Lo sposo disperato titolo registrato in Ivi, c. 20.425. Nel libretto viene registrato in suo luogo il cantante Carlo Rossi.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 419
420
FRANCESCA FANTAPPIÈ
FONTI: [Libretto], Il marito disperato. Dramma gioco per musica da rap-presentarsi nel teatro di Cittadella il Carnovale 1789. Dedicato a Sua Ec-cellenza conte Zuanne Widmann Podestà e a Sua Eccellenza conte Lunar-do Valmarana capitanio, rettori degnissimi di detta città, In Bergamo,Con approvazione, [1789]426; [Indice di spettacoli], Indice de’ tea-trali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1788 a tutto il Carnevale1789, In Milano, Con Privilegio di Privativa427.
DATA: 1789, post 13 aprile–ante 20 maggioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.COMPAGNIA: Capocomico Carlo BattagliaTITOLO DELLE OPERE RAPPRESENTATE: Agrippina tragedia di Ippolito
Pindemonte (27 aprile); La figlia dell’aria di Carlo Gozzi (4 mag-gio); Guerino meschino (10 maggio); Meleagro (11 maggio); La prin-cipessa filosofa di Carlo Gozzi (13 maggio); Il pittore naturalista di Ot-to Henrich Gemmingen (18 maggio).
ATTORI: Carlo Battaglia, Luigia Belloni (prima attrice) [Antonio Bel-loni (innamorato), Gaetano Fiorio (innamorato), Giacomo Mode-na, Giuseppe Zannoni, Carlo Serramondi, Maddalena Battaglia(prima donna a vicenda), Gaetana Cavalletti, Elena Papi, Giusep-pa Segalini Marzocchi e Pierina Cardosi (serva), Vincenzo Bugani(Arlecchino), Gaspare Marzocchi (Anselmo), Giovan Battista Gozzi(Pantalone) Fausto Segalini Marzocchi (Brighella)]428.
FONTI: [Avvisi teatrali e note di repertorio], Documenti 1789: 15-29,in Regesto.
DATA: 1789, post 20 agostoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro provvisionale in fiera.TITOLO: Alessandro nell’IndieAUTORE: Pietro Metastasio
426. Il libretto consultato si trova in BCBg, Sala 32 C 8 21 (4).427. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 723.428. La composizione della compagnia per l’anno comico 1789-1790 è registra-
ta nell’indice degli spettacoli. Cfr. anche O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., p.104.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 420
421
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
COMPOSITORE: Francesco Bianchi «cremonese accademico filarmo-nico».
GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Alessandro; Poro re d’una parte dell’Indie ed amante
di Cleofide; Cleofide regina di un’altra parte dell’Indie ed amantedi Poro; Gandarte generale dell’armi di Poro ed amante d’Erisse-na; Erissena sorella di Poro; Timagene confidente d’Alessandro enemico occulto del medesimo; Parte di supplimento.
CAMBIAMENTI DI SCENA: Atto primo: Campo di battaglia; Atrio deltempio di Bacco; Padiglione d’Alessandro; Atto secondo: Appar-tamenti; Campagna con Fabbriche rotte ed allogiamenti militaricon ponte sopra d’Idaspe che si rompe; Appartamenti; Atto terzo:Portici dei giardini reali; Tempio magnifico dedicato a Bacco conrogo nel mezzo
DEDICATARIO: contessa Elisabetta Duodo WidmannDEDICANTE/IMPRESARIO: «Il direttore dello spettacolo».CANTANTI: Adamo Bianchi (Alessandro, primo tenore); Gasparo Pa-
chiarotti (Poro, primo uomo); Anna Casentini (Cleofide, prima don-na), «Signor N. N.» (Gandarte); Giuseppe Nèttèlèt (Erissena, secon-da donna); Giuseppe Benigni (Timagene, secondo uomo)429; PaolaBalduni (secondo tenore, parte di supplimento).
MUSICISTI: Michele Milani (cembalo), Giovan Battista Rovelli (primoviolino dell’opera), Giuseppe Lombardi (primo violino dei balli).
SCENOGRAFO: Giuseppe MarchesiCOSTUMISTA: Giuseppe Monti; Antonio Spinelli.BALLI: Giulietta e Romeo (primo ballo); Militare (secondo ballo).COREOGRAFO: Filippo BerettiBALLERINI: Filippo Beretti (primo ballerino serio); Caterina Villeneu-
ve (prima ballerina seria); Carlo Villenueve (primo ballerino serio),Andrea Mariotti (primo grottesco assoluto), Teresa Mariotti (primagrottesca assoluta), Giuseppe Passaponte (primo grottesco assolu-to), Caterina Monti (terza ballerina), Giuseppe Bolla (terzo balle-rino), Foscarina Evangelista (terza ballerina), Antonio Paris (figu-rante), Antonio Bigiogera/Bigioggero (figurante), Giovanni Drusia-ni (figurante), Cesare Bescapé (figurante), Giuseppe Barbieri (figu-rante), Pietro Bresciani (figurante), Antonio Franchi (figurante),
429. In luogo di Giuseppe Benigni nel libretto è registrato Francesco Albani.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 421
422
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Antonia Bescapé (figurante), Maria Giudi (figurante), MariannaBurla (figurante), Giuseppe Valensiani (figurante), Marianna Gol-doni (figurante), Teresa Guidi (figurante), Violante Alfonsi (figuran-te), Marianna Franchi (prima grottesca fuori dei concerti assoluta),Giuseppe Erlisca (primo ballerino mezzo carattere fuori dei con-certi assoluto), Maria Casentini (prima ballerina mezzo caratterefuori dei concerti assoluta), Luigi Zurli (ballerino per far le parti).
FONTI: [Libretto], Alessandro nell’Indie. Dramma del signor abate PietroMetastasio da rappresentarsi in Bergamo nella fiera d’agosto 1789. Dedi-cato a Sua Eccellenza la nobil donna contessa Elisabetta Duodo Wid-mann, in Bergamo, Con approvazione, [1789]430; [Indice di spetta-coli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1789 atutto il Carnevale 1790, In Milano, Con Privilegio di Privativa, c.11431; [Note di repertorio], Documento 1789: 44, 46, in Regesto.
DATA: 1790, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: I viaggiatori feliciAUTORE: [Filippo Livigni]COMPOSITORE: Pasquale AnfossiGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Bettina giovine allegra e di spirito moglie di Giannet-
to; Giannetto fuggitivo di casa sua e dato al buon tempo; Don Ga-stone spagnuolo strambo; Donna Isabella amante prima di don Ga-stone e promessa sposa a Giannetto da lui non conosciuto; Pan-crazio ricco mercante e padre di Giannetto; Lauretta locandiera;Pasquino cameriere della locanda; [Comparse] che non parlano:tre notari, due camerieri di locanda, servitori di Pancrazio.
DEDICATARIO: Laura Zusta Pisani podestaressaDEDICANTE: Teresa OltrabelliSCENA: Locanda di Lauretta.CANTANTI: Teresa Oltrabelli (Bettina, prima buffa assoluta); Andrea
Urbani (Giannetto, primo mezzo carattere assoluto); Giuseppe Scar-sella (Don Gastone, primo buffo assoluto); «Sig. N. N.» (Donna Isa-
430. Il libretto consultato si trova conservato in BCBg, Sala 32 D 1 2 (21).431. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 793.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 422
423
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
bella); Antonio Bini (Pancrazio, altro primo buffo); Paulina Baldui-ni (Lauretta); Antonio Buffi (Pasquino, secondo mezzo carattere).
COREOGRAFO: Giovacchino MariBALLERINI: Giovacchino Mari (primo ballerino assoluto), Livia Maf-
fei (prima ballerina assoluta), Innocente Baratti (primo grottesco),Assunta Sassoni (prima grottesca); Luigi Zurli (terzo ballerino);Giuditta Mari (terza ballerina); Pietro Paris (figurante); MariannaSalucci (figurante); Carlo Ronsi (figurante), Maria Bencini (figuran-te), Carlo Banti (primo grottesco fuori dei concerti), Anna Maffei(prima grottesca fuori dei concerti).
FONTI: [Libretto], I viaggiatori felici. Dramma giocoso per musica da rap-presentarsi nel teatro della Cittadella in Bergamo il Carnevale 1790 stam-pato a spese della signora Teresa Oltrabelli prima buffa assoluta. Dedica aS. E. la nobil donna Laura Zusta Pisani podestaressa, In Bergamo, Dal-la Stamperia Rossi, con permissione, [1790]432; [Note di reperto-rio], Documenti 1790: 2-3, 8-10, in Regesto.
DATA: 1790, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella o «Teatro di Città»433.TITOLO: Una cosa rara, ossia bellezza ed onestàAUTORE: [Lorenzo Da Ponte]COMPOSITORE: Vincenzo Martini di SpagnaGENERE: Opera buffa con intermezzi danzati.PERSONAGGI: Isabella regina di Spagna; Giovanni infante di Spagna;
Corrado gran scudiere; Lilla; Ghita; Lubino; Tita; Lisargo podestàdel villaggio; Coro di cacciatori; Coro di pastori e pastorelle.
SCENA: Adra, villaggio della Sierra MorenaDEDICATARIO: Laura Zusta Pisani podestaressaDEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista LombardiCANTANTI: Antonia Viscardini (Isabella, prima donna), Andrea Urba-
ni (Infante di Spagna, primo mezzo carattere); Nicola Buzzi (Corra-do, secondo buffo)434; Teresa Oltrabelli (Lilla, prima buffa assolu-ta/prima donna); Paula Balduini (Ghita, prima donna); Giuseppe
432. Il libretto consultato si trova in CGV, 59 A 247/1.433. Definito «Teatro di Città» nell’indice degli spettacoli.434. In luogo di Nicola Buzzi nel libretto è registrato Antonio Buovi.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 423
424
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Scarsella (Lubino, primo buffo); Antonio Bini (Tita, primo buffo);Giuseppe Grimaldi (Lisargo, secondo mezzo carattere).
TITOLO DEI BALLI: La baldanza punita (ballo primo); Il matrimonio peringanno (ballo secondo).
COREOGRAFO: Giovacchino MariBALLERINI: Giovacchino Mari (primo ballerino assoluto), Livia Maf-
fei (prima ballerina assoluta), Innocente Baratti (primo grottesco),Assunta Sassoni (prima grottesca); Luigi Zurli (terzo ballerino);Giuditta Mari (terza ballerina); Pietro Paris (figurante); MariannaSalucci (figurante); Carlo Ronsi/Ronzi (figurante), Maria Bencini(figurante), Carlo Banti (primo grottesco fuori dei concerti), AnnaMaffei (prima grottesca fuori dei concerti).
FONTI: [Libretto], Una Cosa rara ossia bellezza ed onestà. Dramma gioco-so per musica da rappresentarsi nel Teatro di Cittadella in Bergamo il car-novale 1790 dedicato a S. E. la nobil donna Laura Zusta Pisani pode-stadessa, In Bergamo, Dalla Stamperia Rossi, Con permissione[1790]435; [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’an-no dalla primavera 1789 a tutto il Carnevale 1790, In Milano, ConPrivilegio di Privativa, c. 12436.
DATA: 1790, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «Teatro in Città»TITOLO: Bertoldo e BertoldinoAUTORE: [Lorenzo Da Ponte]COMPOSITORE: Antonio BrunettiGENERE: Opera buffaCANTANTI: Odoardo Bianchi (primo buffo mezzo carattere), Giusep-
pa Nèttèlet (prima donna), Antonia Viscardini (prima donna), Qui-rino Stevignoni (primo mezzo carattere assoluto), Antonio Viscar-dini (primo buffo caricato), Rosa Moro (seconda donna), Giovan-ni Costa (secondo buffo caricato), Nicola Buzzi (secondo mezzocarattere).
COREOGRAFO: Giovacchino Mari, Francesco D’Amato.BALLERINI: Giovacchino Mari (primo ballerino assoluto), Francesco
435. Il libretto consultato si trova in CGV, 59 A 247/3.436. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. I, p. 793.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 424
425
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
D’Amato (primo ballerino assoluto), Francesca Coppini (prima bal-lerina assoluta), Silvestro Peri (primo grottesco), Cristina De Ago-stini (prima grottesca), Giacomo Bizarelli (primo grottesco fuori de’concerti), Anna Coppini (prima grottesca fuori de’ concerti), Ga-spare Rossari (terzo ballerino), Giuditta Mari (terza ballerina), An-na Orti (prima ballerina fuori de’ concerti), «vari figuranti».
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1790 a tutto il Carnevale 1791, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, cc. 11-12437.
DATA: 1790, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «Teatro in Città».TITOLO: La pastorella nobileAUTORE: [Saverio Zini]COMPOSITORE: Pietro GuglielmiGENERE: Opera buffaCANTANTI: Odoardo Bianchi (primo buffo mezzo carattere), Giusep-
pa Nèttèlet (prima donna), Antonia Viscardini (prima donna), Qui-rino Stevignoni (primo mezzo carattere assoluto), Antonio Viscar-dini (primo buffo caricato), Rosa Moro (seconda donna), Giovan-ni Costa (secondo buffo caricato), Nicola Buzzi (secondo mezzocarattere).
COREOGRAFO: Giovacchino Mari, Francesco D’Amato.BALLERINI: Giovacchino Mari (primo ballerino assoluto), Francesco
D’Amato (primo ballerino assoluto), Francesca Coppini (prima bal-lerina assoluta), Silvestro Peri (primo grottesco), Cristina De Ago-stini (prima grottesca), Giacomo Bizarelli (primo grottesco fuori de’concerti), Anna Coppini (prima grottesca fuori de’ concerti), Ga-spare Rossari (terzo ballerino), Giuditta Mari (terza ballerina), An-na Orti (prima ballerina fuori de’ concerti), «vari figuranti».
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1790 a tutto il Carnevale 1791, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, cc. 11-12438.
437. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 867.438. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 867.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 425
426
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DATA: 1790, estateAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, teatro provvisionale439; «Teatro di Fiera»440.TITOLO: La molinara o l’amor contrastatoAUTORE: [Giuseppe Palomba]COMPOSITORE: Giovanni Paisello «celebre maestro napoletano»441.GENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Rachelina ricca molinara e dispettosa in amore; Don
Calloandro giovine vanaglorioso cugino di donna Eugenia cui stain obbligo di sposarsi che poi s’innamora di Rachelina; Notar pi-stoloso notaio di casa della baronessa, uomo ignorante nel suo me-stiere; Eugenia baronessa promessa sposa di don Calloandro; donRospolone officiale governatore; don Luigino giovine di poca for-tuna che fa il servente mal’aggradito di donna Eugenia; Amarantacameriera di donna Eugenia.
SCENA: Feudo della baronessa Eugenia nelle vicinanze di Napoli.DEDICATARIO: Laura Zusto PisaniDEDICANTE/IMPRESARIO: Giovan Battista LombardiCANTANTI: Teresa Vestris (Rachelina, prima buffa); Gioachi-
no/Giovachino Belandi/Bellandi (Don Calloandro, primo mezzocarattere), Giovan Battista Viscardi (Notar pistoloso, primo buffo ca-ricato), Caterina Anselmetti (Eugenia baronessa, seconda donna),Giuseppe Tavani (Don Rospolone, secondo buffo caricato), Giovan-ni Costa (Don Luigino, secondo mezzo carattere), Silvia Ponzoni(Amaranta, altra seconda buffa).
COSTUMISTA: Giuseppe ArpesaniTITOLO DEI BALLI: Adelasia in Italia (ballo primo); Il divertimento alla
Marina (ballo secondo).COREOGRAFO: Luigi DupenBALLERINI: Luigi Dupen (primo ballerino), Marianna Mariati/Mariatti
(prima ballerina), Stefano Cherubini (primo grottesco), GeltrudeGalassi (prima grottesca), Agostino Bertorelli (altro primo grotte-
439. Nella dedica del libretto l’impresario Giovan Battista Lombardi scrive: «Ildrama giocoso intitolato La Molinara sarà lo spettacolo che si riprodurrà su le pro-visionali scene in Prato per la fiera di quest’anno 1790».
440. Nell’Indice de’ teatrali spettacoli.441. Secondo il libretto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 426
427
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
sco), Antonia Tomasini (altra prima grottesca), Giuseppe Cingar-li/Cingherli (terzo ballerino), Maria Magioni/Maggioni (terza bal-lerina), Giuseppe Verzelotti (ballerino per le parti), Giacomo Mo-retti/Moriti (figurante), Teresa Mariatti (figurante), Antonio Bigio-gero (figurante), Teresa Soffietti/Sofietti (figurante), Pietro Barbe-ris (figurante), Giustina Nolis (figurante), Francesco Durello (figu-rante), Santa Rigò (figurante), Carlo Arusati (figurante), Anna Bon-di (figurante), Giuseppe Paliari (altro figurante), Rosa Paliari (altrofigurante), Pietro Paladini (primo ballerino mezzo carattere fuoridei concerti), Rosa Viganò Dupen (prima ballerina mezzo caratte-re fuori dei concerti), Marina Dupen (amorino), Giuseppe Fanciul-li (amorino).
SCENOGRAFO: Giuseppe MarchesiMACCHINISTA: Giuseppe Lombardi LumaghinoCAMBI DI SCENA: Atto primo: Camera; Casa del notaro di cui vede-
si da una parte la casa della baronessa. In fondo la capanna ed ilmolino; Camera; Campagna con molino e case rustiche. Atto se-condo: Strada; Camera rustica con due stanze laterali; Bosco conrupi praticabile.
FONTI: [Libretto], La Molinara o l’Amor contrastato. Dramma giocoso permusica da rappresentarsi in fiera di Bergamo nell’estate 1790. Dedicatoalle loro eccellenze Laura Zusto Pisani podestessa ed Elena Sagredo Buz-zacarini capitania, In Bergamo, Dalla Stamperia Antoine, Con Li-cenza de’ Superiori, cc. 12-13442; [Indice di spettacoli], Indice de’ tea-trali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1790 a tutto il Carnevale1791, In Milano, Con Privilegio di Privativa, cc. 12-13443.
DATA: 1790, estateAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Balletto]LUOGO: Bergamo, teatro provvisionale in fiera.TITOLO: Atridate e FarnaceAUTORE: Luigi DupenCOMPOSITORE: Compositore non specificato.GENERE: «Ballo eroicomico»
442. Il libretto consultato si trova in CGV, 59 A 247/4.443. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 867.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 427
428
FRANCESCA FANTAPPIÈ
PERSONAGGI: Ottone Imperatore e padre di Adelasia; Adelasia in abi-to di Pastorella, moglie di Alerano; Alerano in abito di patore; Usin-da altra figlia di Ottone sorella di Adelasia e promessa sposa adEvandro; Evandro gran maresciallo dell’armi imperiali; Corilla ami-ca di Adelasia; Lido e Doralice piccoli figli di Alerano e Adelasia.Capi pastori. Cacciatori. Emissari e soldati di Ottone. Pastorelle ePastori. Alcuni schiavi greci e saraceni del seguito di Evandro.
SCENA: «Nelle vicinanze di Alba Pompeja».CAMBI DI SCENA: Atto primo: campagna sparsa all’intorno di verdi
colline; Atto secondo: padiglione di ottone; Atto terzo: interno diantica fortezza di riseva ai delinquenti; Atto quarto: la scena rap-presenta un campo tutto attendato e adorno festosamente di tro-fei di bandiere per l’ottenuta vittoria.
IMPRESARIO: [Giovan Battista Lombardi]COREOGRAFO: Luigi DupenBALLERINI: Pietro Paladini (Ottone), Marianna Mariatti (Adelasia), Lui-
gi Dupen (Alerano), Rosa Viganò (Usinda), Giuseppe Verzellotti(Evandro), Caterina Monti (Corilla), Gertrude Galassi (capo pasto-re), Stefano Cherubini (capo pastore), Antonia Tomasini (capo pa-store), Agostino Bertorelli (capo pastore), Giacomo Trabattoni (ca-po pastore).
FONTI: [Libretto], Adelasia in Italia ballo eroicomico inventato, ed esegui-to dal sig. Luigi Dupen da rappresentarsi in Fiera di Bergamo l’estate delMDCCXC, [1790]444.
DATA: 1790, estateAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Balletto]LUOGO: Bergamo, teatro provvisionale in fiera.TITOLO: Il divertimento alla marinaAUTORE: Luigi DupenCOMPOSITORE: Luigi DupenGENERE: Ballo comico pantomimo. [Ballo secondo]IMPRESARIO: [Giovan Battista Lombardi]COREOGRAFO: Luigi Dupen
444. Il libretto non è segnalato in C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit. Si tro-va conservato in CGV, 59 A 247/2.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 428
429
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
FONTI: [Libretto], Adelasia in Italia ballo eroicomico inventato, ed esegui-to dal sig. Luigi Dupen da rappresentarsi in Fiera di Bergamo l’estate delMDCCXC, [1790]445.
DATA: 1791, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella o «Teatro in Città»446.TITOLO: I zingari in fieraAUTORE: [Giuseppe Palomba]COMPOSITORE: Giovanni PaisielloGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Lucrezia zingara furba e spiritosa, Messer Pandolfo be-
nestante sciocco e creduto nelle cose astronomiche, Barbadoro zin-garo fratello di Lucrezia, Stellidaura ragazza nobile ma incognitaa se stessa serva di messer Pandolfo, Cecca ostessa astuta ed intra-prendente, Eleuterio nobile cosentino cugino non conosciuto allamedesima destinato in consorte.
COMPARSE: Coro di zingari; camieriere d’osteria; giovine di caffè; zin-gari.
SCENA: Cillaggio nelle vicinanze d’Ancona.DEDICATARIO: Pietro Pisani podestà, Pattaro Buzzacarini capitanio.DEDICANTE/IMPRESARIO: «Gli impresari».CANTANTI: Giulia Ronchetti447 (Lucrezia, prima buffa); Paolo Boscoli
(Pandolfo, primo buffo assoluto caricato), Fabiano Mora (Barbado-ro, altro primo buffo), Giuseppe Cocchi (Scevola, primo mezzo ca-rattere), Teodolinda Bossi (Stellidaura, seconda buffa), Elisabetta Ne-gri (Cecca, terza buffa), Giuseppe Grassi (Eleuterio, secondo mezzocaricato).
MUSICISTI: Michele Melani (cembalo), Gio. Rovelli (primo violino),Carlo Fortis (primo oboe), Giuseppe Lombardi (primo violino deiballi).
445. Il libretto non è segnalato in C. Sartori, I libretti italiani a stampa, cit. Si tro-va conservato in CGV, 59 A 247/2.
446. «Teatro della Cittadella» per il libretto e «Teatro in Città» per l’indice.447. Nel libretto viene registrata la prima buffa Maddalena Loqui, ma secondo
l’indice degli spettacoli di quell’anno: «Per la malattia della Signora Maddalena Lo-qui suddetta fu presa per altra: Prima buffa, Giulia Ronchetti».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 429
430
FRANCESCA FANTAPPIÈ
COSTUMISTA: Giovan Battista Picaluga milanese.SCENOGRAFO: Giuseppe MarchesiCOREOGRAFO: Giuseppe ParaccaBALLERINI: Giuseppe Paracca (primo ballerino), Antonia Canzi (pri-
ma ballerina), Carlo Calvi (secondo grottesco), Antonia Airoldi (se-conda grottesca), Giovanni Cipriani (primo grottesco assoluto),Antonio Bescape (figurante), Carlo Arruzati (figurante), Cesare Be-scape (figurante), Gaetana Paracca (figurante), Giuseppa Longhina(figurante), Giacoma Banfi (figurante), Sara Bola (ballerina grotte-sca).
FONTI: [Libretto], I Zingari in fiera. Dramma giocoso per musica da rap-presentarsi nel teatro di Cittadella in Bergamo il Carnovale 1791. Dedi-cato alle L. L. E. E. Pietro Pisani podestà e Pattaro Buzzacarini capita-nio, In Bergamo, Dalla stamperia Rossi448; [Indice di spettacoli], In-dice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1790 a tutto ilCarnevale 1791, In Milano, Con Privilegio di Privativa, cc. 13-14449;[Note di repertorio], Documenti 1791: 3, 5-6, in Regesto.
DATA: 1791, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «Teatro in Città».TITOLO: Fra i due litiganti il terzo godeAUTORE: [Carlo Goldoni]COMPOSITORE: Giuseppe SartiGENERE: Opera buffaCANTANTI: Giulia Ronchetti450 (prima buffa), Paolo Boscoli (primo
buffo assoluto caricato), Teodolinda Bossi (seconda buffa), Fabbia-no Mora (altro primo buffo), Elisabetta Negri (terza buffa), Giu-seppe Grassi (secondo mezzo caricato), Giuseppe Cocchi (primomezzo carattere).
COREOGRAFO: Giuseppe Paracca
448. Il libretto si trova conservato in CGV, 59 A 247/6.449. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 868.450. Secondo l’indice degli spettacoli la cantante Giulia Ronchetti sarebbe pre-
sente in sostituzione della prima buffa Maddalena Loqui, assente per malattia. Cio-nonostante i sonetti composti dagli ammiratori bergamaschi sono in lode di entram-be le cantanti.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 430
431
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
BALLERINI: Giuseppe Paracca (primo ballerino), Antonia Canzi (pri-ma ballerina), Giovanni Cipriani (primo grottesco assoluto), Car-lo Calvi (secondo grottesco), Antonio Airoldi (seconda grottesca),Antonio Bescape (figurante), Carlo Arruzati (figurante), Cesare Be-scape (figurante), Gaetana Paracca (figurante), Giuseppa Longhina(figurante), Giacoma Banfi (figurante), Sara Bola (ballerina grotte-sca), Sara Bolla (ballerina grottesca).
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1790 a tutto il Carnevale 1791, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, c. 14451; [Note di repertorio], Documenti 1791:3, 5-6, in Regesto.
DATA: 1791, 7 maggio–13 giugnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, «Teatro di quella Città»452.TITOLO DELLE OPERE RAPPRESENTATE: Un salutare avviso ai maritati,
commedia di Camillo Federici (7 maggio), Penelope tragedia [diGiuseppe Salio] (4 giugno), Nitocri tragedia [di Giacinto Magno-cavallo] (13 giugno).
COMPAGNIA: Compagnia Segalini453
ATTORI: Giuseppa Segalini Marzocchi (prima donna), Laura Lapy,Angela Paliotti, Anna Alessandri, Caterina Rosa, Giovanni Liban-ti, Andrea Lapy, Francesco Regoli, Leonardo Alessandri, Caroli-na Bottari (serva), Andrea Zurli (padri e tiranni), Fausto Segalini(padri e tiranni), Carlo Fidanza (caratterista e Dottore), Pietro Ro-sa (Pantalone), Fausto Marzocchi (Brighella), Angelo Negri (Arlec-chino).
FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1791 a tutto il Carnevale 1792, In Milano, Con Pri-
451. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 868.452. Secondo l’indice.453. La denominazione «compagnia Segalini» è contenuta negli avvisi raccolti
da Francesco Maria Quarenghi. Orietta Giardi la registra, invece, come «compagniaRosa», fondata nel 1775 e diretta da Pietro Rosa il quale, dall’anno comico 1791-1792, avvrebbe condiviso il capocomicato con Fausto Marzocchi, cfr. O. Giardi, Icomici dell’arte perduta, cit., p. 250 e sgg. Nell’indice degli spettacoli la notizia com-pare nel modo seguente: «BERGAMO. Primavera 1791. Nel teatro di quella cittàrappresentò commedie e tragedie la compagnia comica italiana diretta da’ signoriMarzocchi e Rosa».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 431
432
FRANCESCA FANTAPPIÈ
vilegio di Privativa, c. 13454; O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit.,pp. 250-252; [Avviso teatrale e note di repertorio], Documenti1791: 9, 12, 14, in Regesto.
DATA: 1791, agosto–settembreAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi; «Nell’apertura del nuovo Teatro
Ricardi in Fiera»455.TITOLO: La Didone abbandonataAUTORE: [Pietro Metastasio]COMPOSITORE: «Diversi celebri autori».GENERE: Dramma serioPERSONAGGI: Didone regina di Cartagine ed amante di Enea; Enea;
Jarba re de’ mori sotto il nome d’Arbace; Selene sorella di Didoneed amante occulta d’Enea; Araspe confidente di Jarba ed amantedi Selen; Osmida confidente di Didone; guardie di Dione; segui-to di mori.
SCENA: CartagineCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: 1. Luogo magnifico de-
stinato alle pubbliche udienze con trono da un lato. Veduta in pro-spetto della città di Cartagine che sta edificandosi. 2. Galleria. 3.Sala Reale dalla quale discendendo si pasa al tempio di Nettuno.Atto secondo: 4. Galleria con tavolino e sedie. 5. Gabinetto consedie. Atto terzo: 6. Reggia con veduta in prospetto della città diCartagine che poi s’incendia.
SCENOGRAFO: Pietro Gonzaga veneziano «pittore delle scene tuttenuove»456.
DEDICATARIO: Alvise Bernardo podestà e Pataro Buzzacarini capita-nio.
DEDICANTE/IMPRESARIO: Gaetano Bellone457
CANTANTI: Luigia Todi (Didone, prima donna), Rosalinda Marconi Mo-linelli (Enea, primo uomo), Michele Schira (Jarba, primo tenore),
454. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 945.455. Dall’indice degli spettacoli.456. Dall’indice degli spettacoli.457. Il quale nella dedica del libretto afferma di «agire su questo nuovo teatro
in occasione del suo primo aprimento».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 432
433
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
Teresa Giurini (Selene, seconda donna), Angiolo Testori/Testorri(Araspe, primo soprano), Gio. Batista Casalini (Osmida, altro pri-mo tenore), Gaetana Augè (parte di supplemento).
COREOGRAFO: Urbano GarziaBALLERINI: Urbano Garzia (primo ballerino serio), Geltrude Burazzi-
ni Garzia (prima ballerina seria), Giovan Battista Checchi (primoballerino), Vincenzo Cosentini (primo ballerino), Margarita FusiScardavi/Cipriani (primo grottesco a vicenda), Eularia Coppini(primo grottesco a vicenda), Gioachino/Giovacchino Brunetti (pri-mo grottesco a vicenda), Giovanni Cipriani (primo grottesco a vi-cenda), Eleonora Diani (primo grottesco a vicenda), Pietro Diani(primo grottesco a vicenda), Giacomo Trabattoni (primo grottescoa vicenda)458, Vincenzo Montignani (primo grottesco a vicenda),Giovanni Ambrosiani (primo ballerino mezzo carattere fuori de’concerti), Gaetana Vezzoli (primo ballerino mezzo carattere fuoride’ concerti), Gaetano Fava (ballerino per le parti), Teresa Monti-ni (ballerina per le parti), Angiolo Tinti (ballerino di concerto), An-giola Rossi (ballerino di concerto), Marco Cola/Colla (ballerino diconcerto), Teresa Bossi (ballerina di concerto), Francesco Durelli(ballerino di concerto), Chiara Acorsi (ballerina di concerto), Lui-gi Gerodini (ballerino di concerto), Celestina Zanni/Zani (balleri-na di concerto), Girolamo Introini (ballerino di concerto), Massi-milla Pontiggia (ballerina di concerto), Gaspare Menghini (balleri-no di concerto), Benedetta Strada (ballerina di concerto), Luigi Mo-retti (ballerino di concerto), Laura Fava (ballerina di concerto),Francesco Granetti (ballerino di concerto), Cecilia Precopia (balle-rina di concerto), Paolo Grossi (ballerino di concerto), RosalindaGloria (ballerina di concerto), Paolo Tavernari (ballerino di concer-to), Maria Paladini (ballerina di concerto), Giuseppe Precopio (bal-lerino di concerto), Giovanna Paganini (ballerina di concerto), An-tonio Reina (ballerino di concerto), Giuditta Pontiggia (ballerinadi concerto).
CAMBI DI SCENA PER IL PRIMO BALLO: 1. Luogo magnifico destinatoalle pubbliche udienze. Archi in prospetto chiusi da tende d’ondealzandosi a suo tempo si vede indietro la gran piazza d’Oviedo. 2.
458. Nominativo registrato solo nell’indice degli spettacoli: «Giacomo Trabat-toni per n. 10 recite, indi Vincenzo Montignani».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 433
434
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Camera di Cimene. 3. Antichi sotterranei acquedotti in parte rui-nati con scala di lato. 4. Piazza della città con cortile in prospettochiuda da cancelli. 5 Gran sala regia illuminata.
CAMBI DI SCENA PER IL SECONDO BALLO: GiardinoTITOLO DEL BALLO: La morte del conte di Saldagna ballo pantomimo eroi-
co-tragico composto e diretto dal sig. Urbano Garzia (primo ballo tragi-co); Divertimento pubblico (secondo ballo).
SCENA DEL BALLO: Oviedo capitale dell’Asturia. Le scene di questoballo saranno di stil moresco, la qual maniera di fabbricare duròmolto tempo nella Spagna dopo ancora l’espulsione de’ Saracenie fu di moda come fra noi il gotico, essendo molto probabile cheal tempo d’Alfonso II fosse questo il gusto dominante.
PERSONAGGI DEL BALLO: Alfonso II re d’Asturia e di Leone (Vincen-zo Cosentini); Cimene sua sorella segreta moglie di Ramiro (Gel-trude Garzia); Ramiro conte di Saldagna supremo generale dell’ar-mi (Urbano Garzia); Consalvo grande d’Asturia e nemico di Ra-miro (Giovan Battista Checchi); Usinda confidente di Climene(Gaetano Vezzoli); Rodrigo altro grande d’Asturia amico di Rami-ro (Giovanni Ambrosioni); Un messo; Cortigiani e cortigiane; Da-migelle di Cimene; Guardie del Re Guerrieri; Soldati spagnuoli;Schiavi mori.
SCENE DEL BALLO: Atto primo: Innanzi luogo magnifico destinatoalle pubbliche udienze con trono da un alto e vari sedili all’in-torno. Archi in prospetto chiusi da tende, d’onde alzandosi a suotempo le dette tende si vede indietro la gran piazza d’Oviedocon parte della città; Atto secondo: Camera di Cimene; Atto ter-zo: Antichi sotteranei acquedotti in parte ruinati che ricevonosoltanto una scarsa luce dai fori che vi sono dall’alto. Angustascala da un lato per cui vi si discende; Atto quarto: Piazza dellacittà con cortile in prospetto chiuso da cancelli, per cui si passaad antica torre, ove è ritenuto Ramiro. Porta che da l’ingresso al-la medesima e guardie che la custodiscono; Atto quinto: Gransala regia superbamente illuminata in tempo di notte. Tavola rea-le preparata nel mezzo con quattro sedili e varie credenze all’in-torno.
FONTI: [Libretto], Didone abbandonata. Dramma per musica da rappre-sentarsi nell’apertura del Nuovo Teatro Ricardi la fiera di agosto dell’an-no 1791. Umiliato alle LL. EE. li NN. HH. Alvise Bernardo podestà ePataro Buzzacarini capitanio, In Milano, Per il Bianchi, Con Supe-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 434
435
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
riore Permesso, [1791]459; [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spet-tacoli di tutto l’anno dalla primavera 1791 a tutto il Carnevale 1792, InMilano, Con Privilegio di Privativa, cc. 13-14460; [Note di reperto-rio], Documenti 1791: 38, 47-48, in Regesto.
DATA: 1792, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Teatro della Cittadella o «Teatro in Città»461.TITOLO: Il fanatico burlatoAUTORE: [Saverio Zini]COMPOSITORE: Domenico CimarosaGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Doristella figlia di Fabrizio donzella scaltra e che finge
la semplice col padre, fedele amante del conte Romolo; Il conteRomolo romano volubile e strambo promesso sposo di Doristel-la; Don Fabrizio vecchio fanatico per divenir nobile che fa chia-marsi il barone del Cocomero; Lindoro avventuriere uomo furboed allegro amante di Doristella; Giannina giovinetta spiritosa alle-vata in casa di don Fabrizio che pretende le nozze del medesimostata prima amante di Lindoro e da esso tradita; Valerio fattore didon Fabrizio.
SCENA: Villa di NapoliCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: 1. Anticamera in casa di
don Fabrizio. 2. Galleria per le nozze; Atto secondo: 3. Anticame-ra come nell’Atto primo. 4. Bosco con collina e case. 5. Anticame-ra come sopra. 6. Galleria come sopra. 7. Delizioso giardino.
SCENOGRAFO: Giuseppe Costa milaneseDEDICATARIO: Elena Soranzo Bernardo podestadessa; Elena Sagredo
Buzzacarini capitania.DEDICANTE/IMPRESARIO: «Gli impresari».CANTANTI: Giovanna Chatillon/Satillon Codecasa (Doristella, prima
buffa assoluta), Giuseppe Lambertini (Il conte Romolo, primo mez-zo carattere), Pietro Righetti (Don Fabrizio, primo buffo), Maria Ta-
459. I libretti consultati sono conservati in CGV, 59 A 247/5, in FGCV e inBCBg.
460. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 945.461. Teatro della Cittadella per il libretto e «Teatro in Città» per l’indice.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 435
436
FRANCESCA FANTAPPIÈ
delieri/Tadilieri (Giannina, seconda buffa), Francesco Negri (Vale-rio, secondo mezzo carattere), Gio. Batista Binaghi (Lindoro, altroprimo buffo)
MUSICISTI: Michele Melani (cembalo), Giovan Battista Rovelli (capodell’orchestra), Giuseppe Lombardi (primo violino per i balli), Pie-tro Fortis (primo oboe).
TITOLO DEI BALLI: L’innocenza protetta dal caso (ballo primo); Il finto cie-co (ballo secondo).
CAMBI DI SCENA NEI BALLI: Ballo primo: Bosco. Camera Rustica; Bal-lo secondo: Marina illuminata.
COREOGRAFO: Giovanni Marsigli/Marsilj.BALLERINI: Giovanni Marsigli (primo ballerino serio), Giuseppa Ra-
daelli (prima ballerina seria), Pietro Franchi (primo grottesco), Giu-seppa Santambrogio (prima grottesca), Luigi Gilardini462 (secondogrottesco), Antonia Airoldi (seconda grottesca), Angiola Pirova-ni/Perovani (terza ballerina), Luigi Moretti (ballerino nel concer-to), Maria Franchi (ballerina nel concerto), Pietro Paris (ballerinonel concerto), «vari figuranti».
FONTI: [Libretto], Il fanatico burlato dramma giocoso per musica da rap-presentarsi nel Teatro di Cittadella in Bergamo nel Carnevale dell’anno1792. Dedicato alle LL. EE. NN. DD. Elena Soranzo Bernardo Pode-stadessa ed Elena Sagredo Buzzacarini capitanessa di Bergamo, Milano,Nella Stamperia Pulini, [1792]463; [Indice di spettacoli] Indice de’ tea-trali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1791 a tutto il Carnevale1792, In Milano, Con Privilegio di Privativa, cc. 14-15464; [Note direpertorio], Documenti 1791: 50; 1792: 2-5, in Regesto.
DATA: 1792, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «Teatro in Città».TITOLO: I due baroni di rocca azzurraAUTORE: [Giuseppe Palomba]COMPOSITORE: Domenico Cimarosa di NapoliGENERE: Opera buffa
462. Nel libretto il nominativo è Giuseppe Gilardini.463. Il libretto consultato si trova conservato in BCBg, Sala 32 D 2 6 (4).464. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 946.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 436
437
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
CANTANTI: Giovanna Chatillon Codecasa (prima buffa assoluta), Giu-seppe Lambertini (primo mezzo carattere), Pietro Righetti (primobuffo caris.), Maria Tadelieri (seconda buffa), Francesco Negri (se-condo mezzo carattere), Gio. Batista Binaghi (altro primo buffo).
TITOLO DEI BALLI: L’innocenza protetta dal caso (ballo primo); Il finto cie-co (ballo secondo).
COREOGRAFO: Giovanni MarsigliBALLERINI: Giovanni Marsigli (primo ballerino), Giuseppa Radaelli
(prima ballerina), Pietro Franchi (primo grottesco), Giuseppa San-tambrogio (prima grottesca), Luigi Gilardini (secondo grottesco),Antonia Airoldi (seconda grottesca), Angiola Pirovani (terza balle-rina), Luigi Moretti (altro ballerino nel concerto), Maria Franchi(altra ballerina nel concerto), Pietro Paris (altro ballerino nel con-certo), «vari figuranti».
FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1791 a tutto il Carnevale 1792, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, cc. 14-15465; [Note di repertorio], Documenti1791: 50; 1792: 2-5, in Regesto.
DATA: 1792, aprile–luglioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.COMPAGNIA: Capocomico Pietro PolinàTITOLI DELLE OPERE RAPPRESENTATE: La figlia dell’aria di Carlo Goz-
zi (24 maggio); Geltrude e Roberto tragedia (29 maggio); La presa diBelgrado di Francesco Avelloni (primo giugno); Convulsioni farsa,Pazzo ragionevole farsa (primo giugno); Il calderaio di San Germano osia la contessa di Varan, dramma (9 giugno), Rutzanzcat il giovine tra-gedia di Zaccaria Vallaresso (23 giugno), Clementina e Desombres (25giugno), Aristodemo tragedia di Vincenzo Monti (7 luglio), Il re Fe-derico di Prussia (21 luglio).
ATTORI: Margarita Polinà, Giuseppa Lombardi, Angiola Paleotti, Eli-sabetta Polinà, Angiola Polinà, Federico Lombardi, Francesco Bal-di, Giuseppe Battistini, Giuseppe Palmadi, Giuseppe Gambini, An-tonia Gambini (serva), Alberto Ugolini (padre nobile), FrancescoRigoli (altro padre), Pietro Polinà (Pantalone), Giuseppe Palmato
465. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 946.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 437
438
FRANCESCA FANTAPPIÈ
(Brighella), Antonio Battistini (Tartaglia), Giuseppe Casolini (Dot-tore), Giovanni Paleotti (suggeritore).
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1792 a tutto il Carnevale 1793, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, c. 14466; [Avvisi teatrali e note di repertorio],Documenti 1792: 10, 14, 18, 20, 21, 23, 25, in Regesto; O. Giardi,I comici dell’arte perduta, cit., pp. 242-244.
DATA: 1792, estateAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «Nuovo Teatro Riccardi».TITOLO: La morte di SemiramideAUTORE: Antonio Simone Sografi467
COMPOSITORE:Giovan Battista Borghi «maestro di cappella dell’insi-gne basilica di Loreto».
GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Semiramide regina di Babilonia; Arsace comandante
dell’armi babilonesi poi scoperto Ninia figlio di Semiramide; Azurprincipe del sangue di Belo padre di Azema; Azema amante di At-saca; Mitrane capo delle guardie reali e confidente di Semiramide;Oroe sommo sacerdote; Omgra di Nino; Grandi del Regno; Da-migelle; Guerrieri; Popolo.
SCENA: BabiloniaCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: 1. Logge reali introducen-
ti agli appartamenti di Semiramide; 2. Gran piazza di Babliloniacon veduta in prospetto di un ponte che attraversa l’Eufrate, vedu-ta della reggia e di porzione del tempio di Belo; 3. Logge suddet-te; 4. Atrio magnifico contiguo alla reggia con veduta del mauso-leo di Nino; Atto secondo: 5. Atrio; 6. Tempio di Belo con volteoscure sul fondo; 7. Logge suddette; 8. Gran piazza suddetta; At-to terzo: 9. Logge suddette; 10. Vastissimo sotterraneo dove si veg-gono i sepolcri dei re di Babilonia.
DEDICATARIO: Elena Soranzo podestaressaDEDICANTE/IMPRESARIO: «Gl’impresari».
466. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1006.467. Il libretto riporta una versione distorta del nome: «La poesia è del signor A.
S. Socrati avvocato veneto».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 438
439
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
CANTANTI: Caterina Himel detta la Celestini (Semiramide, prima don-na), Girolamo Crescentini «virtuoso all’attuale servizio della R.Cappella e Camera di S. M. il Re delle due Sicilie» (Arsace, primouomo), Paolo Benigni detto il Parmigianino (Azur, primo tenore),Cecilia Cattaldi (Azema, seconda donna), Pietro Bonini (Mitrane,secondo uomo), Francesco Savinelli (Oroe, secondo tenore), Tere-sa Cattaneo Marchesini (parte di supplemento e corista soprano),Giovanna Cattaneo Marchesini (corista soprano), Maria Bianchi(corista contralto), Maria Castellini (corista contralto), Carlo Ros-si (corista tenore), Giuseppe Bianchi (corista tenore), Giuseppe Lo-renzi (corista tenore), Giuseppe Marchesini (corista tenore), Gio-vanni Pedroni (corista basso), Angelo Cantoni (corista basso), Pie-tro Terraneo (corista basso), Antonio Polinetti (corista basso).
MUSICISTI: «L’orchestra sarà composta di varii rinomati e celebri pro-fessori nazionali ed anche milanesi».
TITOLO DEI BALLI: Il ritorno d’Iddomeneo in Creta (ballo primo); Diver-timento (ballo secondo).
COMPOSITORE DELLA MUSICA DEL PRIMO BALLO: Vittorio TrentoCOREOGRAFO: Giuseppe BartolomeiBALLERINI: Giuseppe Bartolomei (primo ballerino serio), Marianna
Schmaus/Schamaus Leoni (prima ballerina seria), Luigi Casali (pri-mo ballerino serio), Giovanni Codacci (primo grottesco a perfettaa vicenda), Giuseppe Calvi (primo grottesco a perfetta a vicenda),Gio. Batista Orti/Orri (primo grottesco a perfetta a vicenda), An-giola Chiocchia Codacci (prima grottesca a perfetta a vicenda),Giuseppa Santambrogio/Santambroggio (primo grottesco a perfet-ta a vicenda), Giuseppe Cortesi (secondo grottesco), Luigi Ghelar-dini/Gillardini (secondo grottesco), Gaetano Berri/Beri (terzo bal-lerino), Gasparo Menghini (figurante), Luigi Giordino/Girodino (fi-gurante), Luigi Moretti (figurante), Antonio Voltolina (figurante),Pietro Giannini (figurante), Giuseppe Barberis (figurante), Giusep-pe Carles (figurante), Giuseppe Zurlini (figurante), Pietro Paris (fi-gurante), Pietro Salici/Salice (figurante), Teresa Bossi (figurante), Ca-terina Bellini (figurante), Maria Regini (figurante), Maria Guidi (fi-gurante), Metilde/Metilda Calvi (figurante), Francesca Guidi (figu-rante), Domenica Folunguelli (figurante), Teresa Bigiogera (figuran-te), Elisabetta Romeo (figurante), Lucia Bonetti (figurante), Ambro-gio Cajani (primo ballerino di mezzo carattere fuori de’ concerti),Anna Orti (prima ballerina di mezzo carattere fuori de’ concerti).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 439
440
FRANCESCA FANTAPPIÈ
FONTI: [Libretto], La morte di Semiramide dramma tragico in musica darappresentarsi nel nuovo teatro Riccardi in Bergamo per la prossima fieradell’anno 1792 dedicato a S. E. la Nobil donna Elena Soranzo Bernardopodestadessa, In Bergamo, Dalla Stamperia Rossi, [1792]468; [Indicedi spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primave-ra 1792 a tutto il Carnevale 1793, In Milano, Con Privilegio di Pri-vativa, cc. 14-15469.
DATA: 1792, fiera470
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro circense]TIPOLOGIA: [Spettacoli acrobatici]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.COMPAGNIA: Saltatori e funamboli diretti da Placido Bologna.ATTORI: Placido Bologna (capocomico), Nicolina Bologna (per il bal-
lo da corda e pantomima), Emanuele Malestino spagnolo e mo-glie (per il ballo da corda molle), Giuseppe Jompson inglese (sal-tatore), Pietro Magrini inglese (saltatore), Carlo Ciminè spagnolo(saltatore), Giuseppe Landini milanese e moglie (per il filo di fer-ro), Carlo Depuit irlandese e moglie (per il filo di ferro), GiovanBattista Spinacuta olandese e moglie (pagliaccio e Pierotto per lapantomima), «con ragazze e ragazzi».
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1792 a tutto il Carnevale 1793, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, cc. 15, 106-107471.
DATA: 1793, primavera (maggio)AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.TITOLO: Il fanatico in berlina472
468. Il libretto consultato si trova in BCBg, Sala 32 D 1 2 (24).469. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1006.470. Secondo l’indice gli spettacoli acrobatici seguono quelli operistici: «Dopo
le suddette recite nel detto teatro vi fu a rappresentare la compagnia de’ funambolie saltatori diretta dal sig. Placido Bologna».
471. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1006.472. Conosciuta anche sotto il titolo La locanda. Nell’indice si registra la pro-
grammazione nel Teatro Riccardi, per la primavera del 1793, di una seconda operabuffa con il medesimo cast, della quale, purtroppo, non viene specificato il titolo.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 440
441
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
AUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: Giovanni PaisielloGENERE: Opera buffaCANTANTI: Metilde Pugmetti (pima buffa), Felice Simi (primo mezzo
carattere), Tomaso Carmanini (primo buffo a perfetta vicenda), Fi-lippo Bandini (primo buffo a perfetta vicenda), Violante Pugnetti(seconda buffa), Maria Carmanini (seconda buffa), Enrichetta Ro-berti (terza buffa).
TITOLO DEI BALLI: La Rossana (ballo primo), Lo sposalizio campestre (se-condo ballo).
COREOGRAFO: Eusebio Luzzi (primo ballo)473, Giovanni Monticini(secondo ballo).
BALLERINI: Giovanni Monticini (primo ballerino), Teresa MarzoaratiMonticini474 (prima ballerina), Geltrude Danunzio (prima grotte-sca estratta a sorte), Giuseppe Calvi (primo grottesco estratto a sor-te), Guglielmo Banti (primo grottesco estratto a sorte), Anna Be-dotti (terza ballerina), Gasparo Arosio (terzo ballerino), ChiaraConti (terza ballerina), Silvestro Peri (grottesco fuori de’ concerti),Giuditta Pontiggia (grottesca fuori de’ concerti), Pietro Danunzio(ballerino per le parti comiche), Giuseppe Mora (corpo di ballo),Paolo Grossi (corpo di ballo), Serafino Serafini (corpo di ballo), Giu-seppe Perfetti (corpo di ballo), Giuseppe Quaccio (corpo di ballo),Antonio Finocchi (corpo di ballo), Massimilla Pontiggia (corpo diballo), Metilde Calvi (corpo di ballo), Luigia Grossi (corpo di bal-lo), Beatrice Piccioni (corpo di ballo), Anna del Serio (corpo di bal-lo), Rosalia Zoccoli (corpo di ballo).
FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1793 a tutto il Carnevale 1794, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, c. 8475.
DATA: 1793, «Principio dell’estate»AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.COMPAGNIA: Capocomico Francesco Menichelli
473. Nell’indice si precisa: «Il ballo alla mutazione dell’opera fu composto dalsignor Eusebio Luzi suddetto».
474. Dal 16 maggio sostituita da Sara Bolla.475. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1066.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 441
442
FRANCESCA FANTAPPIÈ
POETA DI COMPAGNIA: Filippo CasariATTORI: Gaetana Menichelli, Teresa Ristori, Giovanna Deceseri, Marga-
rita Pollinà, Laura Lustrini, Elisabetta Pollinà, Giovanna Ristori (percantare), Anna Arisi (parti da ragazza), Francesco Menichelli, France-sco Batistini, Giuseppe Palmato, Giuseppe Sproccani, Vincenzo For-tunati, Pietro Pollinà, Francesco D’Este (parti da padre), GeminianoLustrini (tiranno), Giuseppe Jagher (caratterista), Giovan Battista Goz-zi (caratterista), Giuseppe Jagher (Anselmo), Innocente De Cesari (Bri-ghella), Francesco Arisi (Arlecchino), Antonio Benaglia (suggeritore).
FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1793 a tutto il Carnevale 1794, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, c.9476; O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit.,pp. 194-195, 197.
DATA: 1793, 22 maggioAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: [Bergamo], teatro non identificato477.TITOLO: Nina pazza per amoreGENERE: Opera buffaFONTI: [Nota di repertorio], Documento 1793: 2, in Regesto.
DATA: 1793, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.TITOLO: Il PirroAUTORE: [Giovanni De Gamerra]COMPOSITORE: Nicola Zingarelli di Napoli.GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Pirro, Polissena, Ulisse, Climene, Darete, Eleno, il Gran
Sacerdote, sacerdoti, sagrificatori, principi confederati, capi delletribù, generali dell’armata, capitani della flotta, guardie reali, eser-cito greco, troiani destinati per il sagrifizio.
476. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1067.477. Nella nota di repertorio non viene indicata la città in cui si svolge l’opera.
In mancanza di ulteriori riscontri documentari, la localizzazione dell’allestimento èincerta.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 442
443
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
SCENA: Troia e campi Frigi vicino alla città.CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Vasto terreno con fabbri-
che diroccate; Galleria; Giardini danneggiati dal fuoco e rovinatiin parte; Atto secondo: Galleria; Cortile dinanzi il Mausoleod’Achille; Tempio; Atto terzo: Vasto terreno come nell’atto primo.
SCENOGRAFO: Lorenzo Sacchetto padovano.DEDICATARIO: Ottavio Trento capitanio e vicepodestà.CANTANTI: Caterina Lang «al servizio di S. A. S. Elett. Palat. e Duca
di Baviera» (Polissena, prima donna), Luigi Marchesi «al servizio diS. M. il Re di Sardegna» (Pirro, primo soprano), Giuseppe Carri(Ulisse, primo tenore), Teresa Franchetti (Climene, seconda donna),Rosa De Stefani478 (Darete, secondo soprano), Giuseppe Cocchi(Eleno, secondo tenore).
TITOLO DEI BALLI: Armida abbandonata (primo ballo); La Forza d’Amo-re (secondo ballo).
COMPOSITORE DEL PRIMO BALLO: Luigi MarescalchiCAMBI DI SCENA PER IL PRIMO BALLO: Scena prima: orrida torre; Sce-
na seconda: un bosco.PERSONAGGI DEL PRIMO BALLO: Armida principessa di Damasco, Ri-
naldo, Ubaldo, Carlo, Sofira, Julda, drappello di damigelle segua-ci d’Armida, giardinieri, Amore, Odio, Vendetta, Ferro, Fuoco, Fu-rie.
COREOGRAFO: Onorato ViganòBALLERINI: Giulio Viganò (Rinaldo, primo ballerino serio assoluto),
Maria Casentini479 (Armida, prima ballerina seria assoluta), Giusep-pe Benvenuti (Ubaldo, primo grottesco a perfetta vicenda), Angio-la/ Angela Chiocchia (Sofira, prima grottesca a perfetta vicenda),Nicola Andreoni (Carlo, primo grottesco a perfetta vicenda), Bri-gida Cappelletti (Julda, prima grottesca a perfetta vicenda), Ales-sandro Lonati (ballerino per le parti), Margarita Cortesi (terza bal-lerina), Giuseppe Cortesi (terzo ballerino), 12 coppie di balleriniper il corpo di ballo.
478. Secondo l’indice degli spettacoli Rosa De Stefani viene inserita in sostitu-zione del secondo soprano Pietro Gasparini «per di lui malatia», cantante registratocon la parte di Darete nel libretto.
479. «Essendo partita per Venezia il giorno 17 settembre la suddetta prima bal-lerina Maria Casentini è subentrata al posto di essa la signora Teresa Buffi», in Indi-ce de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1793 a tutto il Carnevale 1794, c.10.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 443
444
FRANCESCA FANTAPPIÈ
FONTI: [Libretto], Pirro dramma per musica da rappresentarsi nel teatroRicardi in Bergamo la fiera dell’anno 1793. Dedicato a Sua Eccellenza ilnobil huomo signor conte Ottavio Trento capitano e vice podestà, In Ber-gamo, Dalla stamperia Rossi, MDCCXCIII480; [Indice di spettaco-li], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1793 atutto il Carnevale 1794, In Milano, Con Privilegio di Privativa, cc.9-10481.
DATA: 1793, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.TITOLO: Alessandro nell’IndieAUTORE: [Pietro Metastasio]COMPOSITORE: Angiolo Tarchi di Napoli.GENERE: Opera seriaCANTANTI: Caterina Lang (prima donna), Luigi Marchesi (primo so-
prano), Giuseppe Carri (primo tenore), Teresa Franchetti (secondadonna), Rosa De Stefani482 (secondo soprano), Giuseppe Cocchi(secondo tenore).
TITOLO DEI BALLI: Armida abbandonata (primo ballo).COREOGRAFO: Onorato ViganòBALLERINI: Giulio Viganò (primo ballerino serio assoluto), Maria
Casentini483 (prima ballerina seria assoluta), Giuseppe Benvenuti(grottesco a perfetta vicenda), Angiola Chiocchia (grottesca a per-fetta vicenda), Nicola Andreoni (grottesco a perfetta vicenda), Bri-gida Cappelletti (grottesca a perfetta vicenda), Alessandro Lonati(ballerino per le parti), Margarita Cortesi (terza ballerina), Giu-seppe Cortesi (terzo ballerino), «con num. 12 coppie di ballerinipel corpo di ballo».
FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno
480. Il libretto consultato si trova in BCBg, OP II 8358.481. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1067.482. Rosa De Stefani viene inserita in sostituzione del secondo soprano Pietro
Gasparini «per di lui malatia» in Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla prima-vera 1793 a tutto il Carnevale 1794, c. 10.
483. Secondo l’indice sostuita, nel corso delle recite, da Teresa Buffi: «Essendopartita per Venezia il giorno 17 settembre la suddetta prima ballerina Maria Casen-tini è subentrata al posto di essa la signora Teresa Buffi».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 444
445
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
dalla primavera 1793 a tutto il Carnevale 1794, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, cc. 9-10484.
DATA: 1793, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro circense]TIPOLOGIA: [Spettacoli acrobatici]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.COMPAGNIA: Saltatori e funamboli diretti da Giovanni Coppini mi-
lanese.ATTORI: Giovanni Coppini; la moglie Maria Rachele Coppini; i figli
Pio, Filippo, Ferdinando, Giuseppa, Maria, Orsola.FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno
dalla primavera 1793 a tutto il Carnevale 1794, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, c. 10485.
DATA: 1793, autunnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.COMPAGNIA: Capocomico Nicola Aratta e Antonio Romagnoli.ATTORI: Antonia Gambini, Angiola Pagliotti, Barbara Romagnoli, Te-
resa Romagnoli, Nicolò Aratta, Francesco Arigoli, Gaetano Bassi,Giuseppe Gambini, Brigida Aratta (serva), Alberto Ugolini (padrenobile), Francesco Baldi (Pantalone), Antonio Romagnoli (Brighel-la e caratterista), Matteo Rinaldi (Dottore), Giuseppe Casolini (Ar-lecchino), Giovanni Pagliotti (suggeritore).
FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1793 a tutto il Carnevale 1794, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, c. 11486; O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit.,p. 98.
DATA: 1794, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella o «Teatro di Città»487.
484. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1067.485. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1067.486. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1067.487. Teatro della Cittadella per il libretto e «Teatro di Città» per l’indice.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 445
446
FRANCESCA FANTAPPIÈ
TITOLO: La virtuosa bizzarraAUTORE: [Saverio Zini]COMPOSITORE: Pietro Guglielmi «celebre maestro di cappella napo-
litano».GENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Adalinda cantarina ed incostante; Don Mercurio uo-
mo ignorante che fa il dotto e s’innamora di Adalinda; Lelio aman-te di Rosmira ed amico di don Ercolino; Don Ercolino amante cre-duto d’Adalinda; Livietta giardiniera amante di Mercurio; Rosmi-ra amante di Lelio; Pancrazio vagabondo e fratello d’Adalinda.
CAMBI DI SCENA PER L’OPERA488: Atto primo: Veduta di Margellinacon vari casini, tra quali quello di don Ercolino da un lato, acco-sto cancello che conduce al giardino; Camera con specchi cemba-lo e tavolino; Cortile nobile di trattoria dall’uno e l’altro lato spal-liere di verdura. In fondo scalinata che conduce ad una loccia. Ta-vola preparata; Atto secondo: Camera; Sala con tavolino; Parte in-terna di ruinoso palazzo con archi che sporgono al mare.
SCENOGRAFO: «Lo scenario sarà dipinto dal signore Gaetano Came-roni di Treviglio allievo de’ signori Gagliari».
DEDICATARIO: Niccolò Corner capitanio e vicepodestà.DEDICANTE/ IMPRESARIO: «Li cavalieri associati».CANTANTI: Teresa Calvesi (Adalinda, prima buffa assoluta); Tomma-
so Carmanini (don Mercurio, primo buffo a perfetta vicenda); Pom-pilio Panizza (Lelio, primo mezzo carattere); Tommaso Marchi (donErcolino, primo buffo a perfetta vicenda); Maria Carmanini (Liviet-ta, seconda buffa); Chiara Carmanini (Rosmira, terza buffa); CarloMeroni489 (Pancrazio, secondo mezzo carattere), Maria Panizza490 (al-tra buffa).
MUSICISTI: Michel Melani (cembalo); Giambattista Rovelli (primo vio-lino dell’opera); Giuseppe Zampieri (primo violino per i balli).
COSTUMISTA: Francesco Piattoli fiorentino.TITOLO DEI BALLI: L’Amor riconosciuto (primo ballo); La villana di spi-
rito (secondo ballo).
488. Non esiste una tavola iniziale delle scene che si ricavano dalle didascalieinterne al testo del libretto.
489. Nominativo leggermente differente nel libretto che riporta quello di Gio-vanni Meroni.
490. Maria Panizza è registrata nell’indice, ma non nel libretto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 446
447
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
COREOGRAFO: Luigi BrendiBALLERINI: Luigi Brendi (primo ballerino), Maria Brendi (prima bal-
lerina), Pietro Franchi (primo grottesco a vicenda estratto a sorte),Francesco Quattrini (primo grottesco a vicenda estratto a sorte), Bar-bara Monterumisi Marchi (prima grottesca a vicenda estratta a sor-te), Maria Brugnoli (prima grottesca a vicenda estratta a sorte),«con vari figuranti».
FONTI: [Libretto], In Bergamo nel teatro della Cittadella il Carnovale 1794si rappresenterà la Virtuosa bizzarra dramma giocoso in musica dedicatoa S. E. il nobil uomo Nicolò Corner capitano e vicepodestà di Bergamo,In Bergamo, Dalla stamperia Rossi491; [Indice di spettacoli] Indicede’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1793 a tutto il Car-nevale 1794, In Milano, Con Privilegio di Privativa, c. 11492.
DATA: 1794, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella o «Teatro di Città»493.TITOLO: La Nina o sia la pazza per amore494
AUTORE: [Giovan Battista Lorenzi]COMPOSITORE: Giovanni Paisiello napoletano.GENERE: Dramma giocosoPERSONAGGI: Nina amante di Lindoro; Lindoro amante di Nina; Con-
te padre di Nina; Giorgio balio del conte; Marianna governante diNina; Pastore; Villanelle; Villani; Servi del conte; Guardie di caccia.
CORO: Villani e villane.SCENOGRAFO: Gaetano Cameroni di Treviglio, allievo dei fratelli Gal-
liari.MUTAZIONI DI SCENE DEL DRAMMA: Delizioso giardino, che confi-
na da un lato col parco e dall’altro con una strada maestra nellaquale si passa per un maestoso cancello. Piccioli risalti nel giardi-no su de’ quali alcuni verdi sedili ombreggiati da pochi alberi, unode’ quali è prossimo alla strada che conduce alle collinette dallequali si va al villaggio, non molto distante dal castello del conte.
491. Il libretto consultato si trova in FGCV.492. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1067.493. Definito «Teatro di Città» negli indici.494. La Nina pazza per amore secondo l’indice.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 447
448
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DEDICATARIO: Niccolò Corner vicepodestàDEDICANTE/IMPRESARIO: «Cavalieri associati».CANTANTI: Teresa Calvesi (Nina, prima buffa assoluta); Pompilio Pa-
nizza (Lindoro, primo mezzo carattere); Tommaso Marchi (Conte,primo buffo a perfetta vicenda); Tommaso Carmanini (Giorgio, pri-mo buffo a perfetta vicenda); Maria Carmanini (Marianna, secon-da buffa); Carlo Meroni495 (Pastore, secondo mezzo carattere), Chia-ra Carmanini496 (terza buffa), Maria Panizza497 (altra buffa).
TITOLO DEI BALLI: L’amor riconosciuto (ballo primo), Ballo secondo LaVillana di spirito (ballo secondo).
COREOGRAFO: Luigi BrendiBALLERINI: Luigi Brendi (primo ballerino), Maria Brendi (prima bal-
lerina), Pietro Franchi (primo grottesco a vicenda); Francesco Qua-trini/Quattrini (primo grottesco a vicenda), Barbara MonterumisiMarchi (prima grottesca a vicenda estratta a sorte), Maria Brugno-li (prima grottesca a vicenda estratta a sorte), «vari figuranti».
FONTI: [Libretto], Nina o sia la pazza per amore opera tradotta dal fran-cese da rappresentarsi nel teatro di Cittadella il Carnovale 1794. Dedi-cato a S. E. il nobil uomo Nicolò Corner Capitano e Vice Podestà di Ber-gamo, in Bergamo, Dalla Stamperia Rossi, [1794]498; [Indice dispettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera1793 a tutto il Carnevale 1794, In Milano, Con Privilegio di Priva-tiva, c. 11499.
DATA: 1794, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: PimmalioneAUTORE: [Antonio Simone Sografi]COMPOSITORE: [Giovan Battista Cimador]GENERE: «Scena Drammatica in Musica»
495. Nominativo leggermente differente nel libretto che riporta quello di Gio-vanni Meroni.
496. Chiara Caraminini è registrata nell’indice, ma non nel libretto.497. Chiara Caraminini è registrata nell’indice, ma non nel libretto.498. Il libretto consultato si trova in BCBg, Sala 32 C 8 21 (5).499. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1067.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 448
449
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
PERSONAGGI: Pigmalione; Galatea.SCENA: Laboratorio di uno scultore.DEDICATARIO: Niccolò Corner capitanio vicepodestàCANTANTI: Pompilio Panizza; Maria Panizza.FONTI: [Libretto], Pimmalione. Scena drammatica in musica eseguita nel
teatro di città dalli signori Pompilio e Maria Panizza, umiliata a S. E. ilN. H. Signor Niccolò Corner Capitano Vice Podestà, In Bergamo, Dal-la Stamperia Rossi, 1794500.
DATA: 1794, estateAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, «in quel teatro»501
COMPAGNIA: Capocomico Antonio Goldoni.POETA DI COMPAGNIA: Francesco AvelloniATTORI: Gaetana Andolfati Goldoni, Giuseppa Meravigli, Angiola
Pezzaglia, Maria Costanti, Maria Biaggiotti, Luigia Riva, GiacomaMazzioli, Anagilda Arrisi (serva), Angelo Venier, Gaetano Panizza,Lorenzo Obizzo, Giuseppe Rola, Antonio Goldoni (padre), Ales-sandro Riva (tiranno e caratterista), Serafino Valeriani (Dottore),Giovan Battista Pozzi (Pantalone), Domenico Sala (Brighella), Fran-cesco Arrisi (Arlecchino), Anna Arrisi (per la parti da ragazzi), Fer-dinando Maravigli (per la parti da ragazzi), Luigi Rola (per le par-ti da ragazzi), Paolo Bassi (suggeritore).
FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1794 a tutto il Carnevale 1795, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, c. 7502; O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit.,pp. 164-165, 167.
DATA: 1794, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.TITOLO: L’Epponina503
500. Il libretto consultato si trova in BCBg, Sala 32 D 2 6 (5).501. Indicazione riportata nell’indice.502. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1124.503. Altro titolo dell’opera: Giulio Sabino.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 449
450
FRANCESCA FANTAPPIÈ
AUTORE: Autore non specificato504.COMPOSITORE: Sebastiano NasoliniGENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Tito figlio di Vespasiano imperatore di Roma amante
di Epponina; Epponina creduta vedova di Sabino; Sabino sposodi Epponima; Voadice sorella di Sabino ed amante di Arminio; Ar-minio governatore di Langres e confidente di Sabino; Annio pre-fetto delle armi romane e confidente di Tito; Due figli di Sabinoche non parlano.
SCENA: Castello di Sabino in vicinanza di Langres o antica Lingona.CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Veduta interiore dell’an-
tico Castello di Langres o antica Lingona505; Interno di magnificopadiglione506; Atto secondo: Fuga di camere; Parte solitaria d’ungiardino; Veduta interiore dell’antico Castello di Langres o Lingo-na; Volte sotterranee507; Carcere lugubre508.
SCENOGRAFO: Giovanni PedroniDEDICATARIO: Marina Pisani Correr capitania e vicepodestaressa.IMPRESARIO: Gaetano Belloni/Bellone. Dedica: Bergamo 13 agosto 1794.CANTANTI: Filippo Sassaroli (Tito, primo uomo), Giuseppa Grassini
(Epponina, prima donna), Giacomo David/Davide (Sabino, primotenore), Pompea De Stefani (Arminio, secondo uomo), ElisabettaMaschietti (Voadice, seconda donna)509, Michele Vaccani (Annio, se-condo tenore).
504. L’attribuzione è incerta. Autore del testo nella prima edizione dell’opera èGiovan Francesco Fattiboni (Cesena, 1770), mentre per tutte quelle rappresentatedal 1781 al 1798 sotto il titolo Giulio Sabino è Pietro Giovannini, in C. Sartori, I li-bretti italiani a stampa, cit., libretti 8966, 12223-12252.
505. La descrizione completa delle scene nel libretto è la seguente: «Veduta in-teriore dell’antico Castello di Langres o antica Lingona, in cui morto credevasi Sa-bino. Da un alto recinto di folti e solitari cipressi. Dall’altro muraglie e torri diroc-cate, il tutto avanzo d’incendio e di ruine. Fra queste scorgesi un tempio dedicato aMercurio, antica Deità delle Gallie, sotto del quale è il sotterraneo di Sabino a cuisi passa per un sentiero incognito e nascosto tra le ruine. Accanto al tempio vedesiil mausoleo innalzato da Epponima al suo sposo Sabino».
506. Descrizione completa: «Interno di magnifico padiglione che occupat tuttala scena, accanto del quale scorgesi accampato l’esercito romano».
507. Descrizione completa: «Volte sotterranee sostenute da un colonnato mez-zo devastato dal tempo, a cui si scende per una grande scala».
508. Descrizione completa: «Carcere lugubre destinata al supplizio di Sabino».509. L’indice indica Elisabetta Maschietti, mentre il libretto Bettina Borselli.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 450
451
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
MUSICISTI: Michele Milani (maestro di cembalo), Giovan BattistaRovelli (primo violino dell’opera). Giuseppe Lombardi (primo vio-lino de’ balli), Carlo Fortis (primo oboe e corno inglese), GaetanoZanetti (primo violoncello), Aniceto Sala (primo contrabbasso),Giovan Battista Bonavina (primo fagotto).
SUGGERITORE: Carlo BordoniCOSTUMISTA: Gerolamo Introini (invenzione), Antonio Battaglia (ese-
cuzione).TITOLO DEI BALLI: Eschilla e Timoleone ossia la caduta di Tiromane tiran-
no di Corinto (primo ballo eroico tragico), Giannina e Bernardone (se-condo ballo campestre).
COMPOSITORE DEL PRIMO BALLO: Carlo Canevazzi torinese.PERSONAGGI DEL PRIMO BALLO: Telecide signor di Corinto; Ortogo-
ra di lui moglie; Timofane principe Corinzio comandante dell’ar-mi; Eschila figlia di Telecide; Timoleone fratello di Timofane; no-bili corinzi; dame corinzie; sacerdoti; capitani e soldati con Tele-cide; capitani, soldati e prigionieri con Timofane.
SCENA DEL PRIMO BALLO: Atto primo: Gran piazza della città di Co-rinto; Atto secondo: Sala negli appartamenti reali; Atto terzo:Oscuro ma magnifico tempio sottorraneo510.
COREOGRAFO: Federico Terrades (Timofane, primo ballerino).BALLERINI: Nicola Ferlotti (Timoleone, primo ballerino serio), Stella
Cellini (Eschila, prima ballerina seria), Raffaele Ferlotti (primo grot-tesco a vicenda), Teresa Dolce Bolini (prima grottesca a vicenda),Ignazio Quattrini511 (prima grottesco a vicenda), Rosa Vitali (pri-ma grottesca a vicenda), Luigi Focosi (primo grottesco a vicenda),
510. La descrizione completa delle scene nel libretto è la seguente: «Atto primo:Gran piazza nella città di Corinto con mura, torri e porte praticabili corrisponden-ti al porto. Da una parte braccio del palazzo reale sostenuto da maestoso colonna-to, con trono a lato di questo, dall’altra veduta esteriore del tempio d’Ercole col dilui simulacro e porta pure praticabile. Atto secondo: Sala negli appartamenti realiche mette al gabinetto destinato per soggiorno di Timoleone e della sua sposa, condue porte laterali ed una maggiore in facciata. Alcuni fanali che illuminano la stan-za. Atto terzo: Oscuro ma magnifico tempio sottorraneo dedicato alla Verità, orna-to da superbi colonnati, da ringhiera e da scalinate che conducono al medesimo. Il-luminato egli si vede da pochi fanali. Nel mezzo vi è il simulacro della Verità conara e fuoco accesso. Alla destra quello della Giustizia e alla sinistra quello del Gasti-go».
511. Ignazio Quattrini per l’indice, mentre nel libretto è Francesco Quattrini.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 451
452
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Domenico Grimaldi (Telecide, primo ballerino fuori de’ concerti),Carolina Barbina (Ortogora, prima ballerina fuori de’ concerti), Se-rafino Blasi512 (terzo ballerino), Caterina Cibrari (terza ballerina),Giacomo Costa (ballerino di concerto), Vincenzo Casabona (bal-lerino di concerto), Antonio Battaglia (ballerino di concerto), Pao-lo Grossi (ballerino di concerto), Marco Colla (ballerino di con-certo), Felice Paris (ballerino di concerto), Giulio Canavesi (balle-rino di concerto), Alessandro Croci (ballerino di concerto), Ma-rianna Barbina (ballerina di concerto), Marianna Quattrini513 (bal-lerina di concerto), Marianna Merli514 (ballerina di concerto), Lui-gia Grossi (ballerina di concerto), Caterina Seilingher/Selingher(ballerina di concerto), Beatrice Pizzoni (ballerina di concerto), Ra-chele Somaruga (ballerino di concerto), Teresa Merli (ballerino diconcerto).
FONTI: [Libretto], L’Epponima. Dramma per musica da rappresentarsi nelnuovo teatro Riccardi di Bergamo la fiera di agosto dell’anno 1794 dedi-cato a Sua Eccellenza la nobil donna Marina Pisani Corner capitania evicepodestaressa di Bergamo, Milano, nella Stamperia Pulini al Boc-chetto, colla superior permissione515; [Indice di spettacoli] Indicede’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1794 a tutto il Car-nevale 1795, In Milano, Con Privilegio di Privativa, cc. 7-8516.
DATA: 1794, post fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi517.
512. Serafino Blasi per l’indice, mentre nel libretto è Gerolamo Introini.513. Marianna Quattrini per l’indice, mentre nel libretto è Gaetana Quattrini.514. Marianna Merli per l’indice, mentre nel libretto è Marianna Roati.515. Il libretto consultato si trova in BCBg, Sala 32 D 2 6 (6).516. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1124.517. La compagnia rappresenta le proprie opere al termine della fiera nel Teatro
Riccardi. Successivamente, in un periodo non meglio precisato, passa al Teatro del-la Cittadella: «Dopo la Fiera. Rappresentò nello stesso Teatro varie opere buffe inmusica la compagnia de’ giovani cantanti napolitani diretta dal sig. Giovanni Bassie le opere furono: La sposa contrastata, Nina pazza per amore, La virtuosa bizzarra, De-bora e Sifara, Le due gemelle. Indi passò la detta compagnia nel teatro di questa Città,ed ivi rappresentò le opere intitolate: Le due gemelle, La sposa contrastata, Debora e Si-fara».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 452
453
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
TITOLO: La sposa contrastata; Nina pazza per amore; La virtuosa bizzar-ra; Debora e Sifara; Le due gemelle (cinque opere).
GENERE: Opera buffaCOMPAGNIA DI CANTANTI: «Compagnia de’ giovani cantanti napoli-
tani diretta dal sig. Giovanni Bassi».CANTANTI: Carolina Bassi, Adolfo Bassi, Giovacchino Ancora, Raj-
monda Bassi, Nicola Bassi, Anna Sanvito, Giovanni Radice, PietroAncora, Giovanni Ascolesi, Monsieur Sanvito.
DIRETTORE DELLA MUSICA: Giovan Battista PennéCOSTUMISTA: Gaetana Bassi «inventrice e direttrice del vestiario».FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno
dalla primavera 1794 a tutto il Carnevale 1795, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, cc. 8-9518.
DATA: 1794, post le rappresentazioni in Teatro Riccardi.AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: Le due gemelle; La sposa contrastata; Debora e Sifara (tre opere).GENERE: Opera buffaCOMPAGNIA DI CANTANTI: «Compagnia de’ giovani cantanti napoli-
tani diretta dal sig. Giovanni Bassi».CANTANTI: Carolina Bassi, Adolfo Bassi, Giovacchino Ancora, Raj-
monda Bassi, Nicola Bassi, Anna Sanvito, Giovanni Radice, PietroAncora, Giovanni Ascolesi, Monsieur Sanvito.
DIRETTORE DELLA MUSICA: Giovan Battista PennéCOSTUMISTA: Gaetana Bassi «inventrice e direttrice del vestiario».FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno
dalla primavera 1794 a tutto il Carnevale 1795, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, cc. 8-9519.
DATA: 1794, autunnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, «in quel teatro»520.
518. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1124.519. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1124.520. Indicazione riportata nell’indice.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 453
454
FRANCESCA FANTAPPIÈ
COMPAGNIA: Capocomico Bartolomeo Zuccato521.ATTORI: Pierina Salvioni Fava, Rosa Sormani, Clementina Medebach,
Bartolomeo Zuccato, Giuseppe Demarini, Filippo Fava, MarcoGuerrini, Giuseppe Maruzzi, Giovan Battista Medebach, CarloCerchi, Giovanni Vimercati (suggeritore), «senza maschere».
FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1794 a tutto il Carnevale 1795, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, c. 9522; [Note di repertorio], Documento 1794:7, in Regesto; O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., pp. 203, 273.
DATA: 1795, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro di Cittadella.TITOLO: Il matrimonio segretoAUTORE: Giovanni BertatiCOMPOSITORE: Domenico Cimarosa523
GENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Geronimo ricco mercante; Elisabetta e Carolina sue fi-
glie; Eidalma sorella del signor Geronimo vedova ricca; Il conteRobinson; Paolino giovine di negozio del sig. Geronimo.
SCENA: In città nella casa del sig. Geronimo.CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Sala che corrisponde a va-
ri appartamenti; Gabinetto; Atto secondo: Gabinetto come sopra;Sala come sopra.
SCENOGRAFO: Galeazzo Pivetti «inventore e pittore delle scene».DEDICATARIO: Niccolò Corner capitanio e vicepodestà.DEDICANTE/IMPRESARIO: «Li cavalieri associati».CANTANTI: Giacomo Gruppi (Geronimo); Giuseppa Serena (Elisabet-
ta); Marianna Laurenti (Carolina); Chiara Ciccerelli (Eidalma); Lui-gi Monti (conte Robinson); Gaetano Bianchi (Paolino).
521. Secondo Orietta Giardi la compagnia si costituisce nel 1794 quando Bar-tolomeo Zuccato rileva la conduzione da Giacomo Moggio, cfr. O. Giardi, I comicidell’arte perduta, cit., p. 273. Le note di repertorio di casa Quarenghi indicano peròcome capocomico l’attore Giacomo Maggio, cfr. Documento 1794: 7, in Regesto.
522. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1124.523. Il libretto prosegue nel modo seguente: «maestro di cappella napolitano al-
l’attual servizio di S. M. il re delle due Sicilie».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 454
455
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
COSTUMISTA: Francesco Piattoli fiorentino.TITOLO DEI BALLI: La capanna incantata (primo ballo); Campestre (se-
condo ballo).COREOGRAFO: Francesco CitterioBALLERINI: Francesco Citterio (primo ballerino assoluto); Francesca
Parassi (prima ballerina assoluta); Rosa Vitali (prima grottesca a per-fetta vicenda); Francesco Pirola (primo grottesco a perfetta vicen-da); Annunc[iata] Paladini (prima grottesca a perfetta vicenda);Francesco Vitali (figurante); Angiola Meda (figurante); Pietro Paris(figurante); Teresa Merli (figurante); Antonio Dedrais (primo grot-tesco assoluto fuori dei concerti).
FONTI: [Libretto], Il matrimonio segreto. Dramma giocoso da rappresentar-si in musica nel teatro della Cittadella in Bergamo il Carnovale dell’anno1795 dedicato a S. E. il N. H. Nicolò Corner capitanio e v. podestà, Ber-gamo, Dalla Stamperia Rossi, [1795]524.
DATA: 1795, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.COMPAGNIA: Compagnia Paganini (capocomico Pietro Pianca)525.ATTORI: Salvatore Fabbrichesi, Carlo Fabbrichesi, Giambatista Pucci,
Giuseppe De Marini, Francesco Montauti, Enrico Paganini, Boni-fazio Vellenfelt/Wellenfelt (caratterista), Pietro Pianca (per i padri),Elisabetta Grassellini, Francesca Pontevichi Fabbrichesi, Maddale-na Zamboni, Margherita Vellenfelt/Wellenfelt, Anna Paganini (ma-dre), Giuseppa Marzocchi (serva), Luigi Marzocchi (Dottore), LuigiLazzarini (Pantalone), Fausto Segalini Marzocchi (Brighella), Giusep-pe Casolini (Arlecchino).
FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1795 a tutto il Carnevale 1796, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, c. 6526.
DATA: 1795, 10–25 giugnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro dei burattini]
524. Il libretto consultato si trova in FGCV.525. Compagnia attiva tra 1794 e 1800, cfr. O. Giardi, I comici dell’arte perduta,
cit., pp. 213-215.526. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1171.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 455
456
FRANCESCA FANTAPPIÈ
LUOGO: Bergamo, teatro non identificato.COMPAGNIA: Giovanni Franchini e moglie, Giovanni Ferrari.FONTI: [Documento epistolare], Documento 1795: 2, in Regesto.
DATA: 1795, giugnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.COMPAGNIA: Capocomico Luigi Mazzotti MalipieroATTORI: Angiola Bruni, Barbara Romagnoli, Anna Maria Seramondi,
Margherita Mazzotti, Rosa Brambilla, Teresa Romagnoli, Elisabet-ta Seramondi, Fermina Villani (serva), Giuseppe Taleri/Teleri, Giu-seppe Chiesa, Marco Guerini, Pietro Ventura, Luigi Mazzotti Ma-lipiero, Angelo Broglio, Vincenzo Fidora, Giacomo Agostini, Fran-cesco D’Este (padre), Luigi Benedetti (padre), Antonio Romagno-li (Pantalone), Carlo Fidanza (Anselmo), Carlo Seramondi (Brighel-la), Antonio Brambilla (Arlecchino), Nicola Merea (suggeritore).
FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1795 a tutto il Carnevale 1796, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, c. 8527; [Documenti epistolari], Documento1795: 4-6, in Regesto528; O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., pp.188-189.
DATA: 1795, 15 agosto-settembre529
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.TITOLO: La morte di CleopatraAUTORE: Antonio Simone SografiCOMPOSITORE: Sebastiano NasoliniGENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Cleopatra regina d’Egitto; Marco Antonio; Ottaviano
527. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1172.528. Le note dei forestieri del capitanio Alessandro Ottolini segnalano l’arrivo
a Bergamo «per recitare nelle commedie» degli attori Antonio Romagnoli (28 giu-gno), Nicola Merea e Giuseppe Teleri (30 giugno), Marco Guarini, Giovanni Miler,Vicenzo Tedora, Angela Ghedini (8 luglio), Rosa Maja, Francesco Musobrio, Giu-seppe Duranti (22 luglio).
529. Nell’indice si legge: «prima recita il 15 di agosto».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 456
457
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
Augusto; Ottavia; Tianeo sommo sacerdote capo degli astrologi;Eros amico di Marco Antonio e di Ottavia; Cleopatra e Alessan-dro piccoli figli di Cleopatra e Marco Antonio; Coro di astrologiegizi; Coro di sacerdoti d’Osiri; Coro di damigelle di Cleopatra;Coro di sacerdotesse d’Iside; Baccanti; Soldati egizi; Popolo.
SCENA: Alessandria d’EgittoCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Cortile530; Piazza d’Ales-
sandria531; Gran portico d’Alessandro532; Atto secondo: Porticod’Alessandro; Valle tempio d’Iside533; Interno d’una piramide egi-zia.
SCENOGRAFO: Luigi FerrariMACCHINISTA: Vincenzo ZambelliATTREZZISTA: Girolamo IntroiniDEDICATARIO: Margherita Ottolini nata QueriniDEDICANTE/IMPRESARIO: Gaetano Belloni. Dedica: Bergamo 15 ago-
sto 1795.CANTANTI: Anna Davija De Bernucci «virtuosa di camera di S. M. l’Im-
peratrice delle Russie» (Cleopatra, prima donna), Vitale Damiani(Marco Antonio, primo soprano), Vincenzo Praun (Ottaviano Augu-sto, primo tenore), Domenica Nolfi (Ottavia, seconda donna), Giu-seppa Sereni/Serena (Eros, secondo soprano), Giuseppe Taiola (Tia-neo, parte di buffo), Girolamo Micheli (corista tenore), Giovan Bat-tista Scuri (corista tenore), Antonio Cocchi (corista tenore), Leo-nardo Mori (corista tenore), Giuseppe Barboglio (corista tenore),Alessandro Conti (corista tenore), Giacomo Gruppi (corista bas-
530. La descrizione completa nel libretto è la seguente: «Cortile corrisponden-te da molti lati alla Regia ed al soggiorno degli astrologi e di Tianeo contraddistin-to da molti geroglifici e segni astronomici ed a cui si ascende per una gran scala».
531. Descrizione completa: «Piazza d’Alessandria con veduta di obelischi, pira-midi, ec. Ippodromo al dià delle mura dove scorgesi l’armata d’Augusto posta in di-sordine. Esternamente dall’alto vedesi in lontananza la flotta romana. Nell’internodella piazza da una parte vedesi il Tempio d’Osiri festivamente adornato per la ce-lebrazione dei gran misteri; dall’altra la galea di Cleopatra».
532. Descrizione completa: «Gran portco d’Alessandro d’architettura greca constatua equestre nel fondo. Varie imprese del medesimo scolpite. Trono da un latoper Cleopatra e M. Antonio».
533. Descrizione completa: «Vasto tempio d’Iside. Ordine triplicato di vestibu-li che conduce alla gran navata adorno di molte sfingi, mani votive ed idoli egiziqua e là sparsi nel tempio. Simulacro della Dea tra il primo vestibulo e il secondo».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 457
458
FRANCESCA FANTAPPIÈ
so), Giuseppe Lorenzi (corista basso), Girolamo Alessandri (cori-sta basso), Luigi Vignati (corista basso), Guglielmo Bianchi (cori-sta basso), Angiolo Pietri (corista basso).
MUSICISTI: Michele Melani (maestro di cembalo), Pietro Caffi (pri-mo clarinetto e flauto), Giovan Battista Rovelli (primo violino edirettore d’orchestra), Francesco Perico (primo corno di caccia),Giuseppe Lombardi (primo violino de’ balli), Gaetano Zanetti (pri-mo violoncello), Carlo Fortis (primo oboe e corno inglese), LuigiPighi (primo contrabbasso).
COSTUMISTA: Giovan Battista PiccalugaTITOLO DEI BALLI: Il trionfo d’Arbace, ballo eroico in cinque atti (pri-
mo ballo); Il momento vien per tutti, ballo comico (secondo ballo).PERSONAGGI DEL PRIMO BALLO: Dario re di Persia; Aspasia sua pri-
mogenita promessa ad Arbace; Arbace generalissimo dell’armi per-siane e sposo segreto di Rosane; Rosane altra figlia di Dario; Arta-bano nipote di Dario; Eolinda piccola figlia d’Arbace e Rosane; Al-zora confidente di Rosane; dame e cavalieri persiani; schiavi ribel-li; soldati persiani; popolo; Ircano vecchio pastore.
MUSICA DEL PRIMO BALLO: «Mr. D’Anglois virtuoso di S. M. Re diSardegna».
SCENA DEL PRIMO BALLO: Persepoli città reale di Persia e sue vicinanze.CAMBI DI SCENA PER IL PRIMO BALLO: Atto primo: Piazza di Perse-
poli adorna all’uso persiano. Trono da un lato con altri sedili piùbasso per il seguito dei grandi del Regno; Atto secondo: Atrio cor-rispondente a diversi appartamenti; Atto terzo: Bosco foltissimo,caverna in fondo; Atto quarto: Gabinetto reale; Atto quinto: Ma-gnifica galleria nella reggia di Dario.
COREOGRAFO: Luigi DupenBALLERINI: Luigi Dupen (Dario, primo ballerino), Michele Fabiani «al
servizio di S. A. R. l’Infante del Duca di Parma» (Arbace, primo bal-lerino serio), Luigia Demora (Rosane, prima ballerina seria), Rosa Du-pen (prima grottesca a perfetta vicenda estratta a sorte), Teresa Gra-netti (prima grottesca a perfetta vicenda estratta a sorte), DomenicoTurchi (Ircano, primo grottesco a perfetta vicenda estratto a sorte),Vincenzo Ricci (primo grottesco a perfetta vicenda estratto a sorte),Gaspare Cenni (Artabano, primo grottesco a perfetta vicenda estrat-to a sorte), Paolo Mersi (primo grottesco a perfetta vicenda estrattoa sorte), Francesco Zappa (terzo ballerino), Anna Sarti (terza balle-rina), Alessandro Viglioli (ballerino di concerto), Giovanni Vaceri
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 458
459
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
(ballerino di concerto), Carlo Ristori (ballerino di concerto), Dome-nico Borello (ballerino di concerto)534, Vincenzo Casabona (balleri-no di concerto), Paolo Grossi (ballerino di concerto), Giacomo Co-sta (ballerino di concerto), Antonio Battaglia (ballerino di concer-to), Pietro Pernetta (ballerino di concerto), Caterina Brighi (balleri-na di concerto), Antonia Toschi (ballerina di concerto)535, FrancescaPuricelli (ballerina di concerto), Luigia Grossi (ballerina di concer-to), Barbara Ricci (ballerina di concerto), Annamaria Majer (balleri-na di concerto), Angiola Poloni (Alzora, ballerina di concerto), Te-resa Bianchi (ballerina di concerto), Vincenzo Rastelli (primo balle-rino fuori di concerto), Giuseppa Dalmas (Aspasia, primo ballerinofuori de’ concerti), Celestina Dupen (Eolinda).
FONTI: [Libretto], La morte di Cleopatra tragedia per musica del signor A.S. Sografi avvocato veneto da rappresentarsi nel teatro Riccardi di Berga-mo la fiera dell’anno 1795 dedicata a Sua Ecc. la nobil donna Margari-ta Ottolini nata Querini, Bergamo, Per l’erede Rossi lecitamente[1795]536; [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’an-no dalla primavera 1795 a tutto il Carnevale 1796, In Milano, ConPrivilegio di Privativa, cc. 6-7537; [Documenti epistolari], Docu-mento 1795: 7-9, in Regesto538.
DATA: 1795, autunnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.
534. Alessandro Viglioli, Giovanni Vaceri, Carlo Ristori, Domenico Borello so-no registrati nell’indice, mentre nel libretto risultano Pietro Paris, Paolo Ristori, Fran-cesco Paravicini.
535. Caterina Brighi, Antonia Toschi sono registrate nell’indice, mentre Beatri-ce Pizzoni e Caterina Grossi compaiono nel libretto.
536. Il libretto consultato si trova in BCBg, Sala 32 D 1. 2 (25).537. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1172.538. Secondo le note rilasciate dal capitanio Alessandro Otttolini gli artisti per-
venuti a Bergamo «per l’opera» come «cantarini» e come «suonatori» sono i seguen-ti: Anna Sarti (26 luglio), Luigi Dupen, Gasparo Cenni (27 luglio), Angela Bologna,Giovanni Valchiari, Pietro Pernella, Vincenzo Raselli, Giuseppe Chioccia (28 luglio),Vincenzo Prava, Luigi Gighi (3 agosto), Maria Fizzera, Carolina Bellazzi, GiuseppeGai, Francesco Pirola (19 agosto), Giovanni Riccardi, Luigi Guidotti, Teresa Landi-ni, Antonio Lusardi, Gerolamo Vedrali, Giuseppe Grania, Antonio Perotti, Dome-nico Bonapese (20 agosto), Giuseppe Rigoli, Felice Marchi, Luigi Coliati, Felice Far-neris (21 agosto).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 459
460
FRANCESCA FANTAPPIÈ
COMPAGNIA: Capocomico Antonio MarianiATTORI: Pietro Buonagamba (primo amoroso), Luigi Bonasi (secon-
do amoroso), Baldassarre Ventura (terzo amoroso), Maddalena Ma-riani (prima amorosa), Teresa Buonagamba (seconda amorosa), Ma-ria Mariani (quarta amorosa), Teresa Mariani (serva), Enrico Ma-sgomieri (Pantalone), Antonio Mariani (Brighella), Francesco Ferra-ri (Arlecchino), Paolo Bandini (padre nobile), Vincenzo Augusta (pa-dre nobile).
FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1795 a tutto il Carnevale 1796, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, c. 8539; O. Giardi, I comici dell’arte perduta, cit.,pp. 181-182.
DATA: 1796, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: Gli artigianiAUTORE: [Giuseppe Maria Foppa]COMPOSITORE: Pasquale AnfossiGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Bernardo calzolaio padre di Rosina; Rosina sarotra
amante di Giannino; Giannino legnaiolo amente di Rosina; Tittafabbro amante di Rosina; Angiolina cuffiara amante di Giannino,Costanza cittadina amante di Giannino, Fabrizio cameriere di Co-stanza, garzoni di tre artigiani, scolare di Rosina, scolara d’Angio-lina, servitore di Costanza, garzoni d’Osteria.
CAMBI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: 1. Piazza con botteghe e stra-de. 2. Camera nobile. 3. Piazza suddetta; Atto secondo: 4. Came-ra plebea. 5. Cortile ad uso d’Osteria. 6. Camera plebea suddetta.7. Giardino con terrazza.
SCENOGRAFO: Gaetano PivettiDEDICATARIO: Margherita Ottolini QueriniIMPRESARIO: «Fratelli Lombardi impresari».CANTANTI: Antonio Coldani540 (Bernardo, primo buffo a perfetta vi-
cenda); Maria Brunetti (Rosina, prima buffa); Giovanni Prada (Gian-
539. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II p. 1172.540. Nel libretto viene erroneamente registrato come «Antonio Soldani».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 460
461
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
nino, primo mezzo carattere); Gaetano Pasini (Titta, primo buffo aperfetta vicenda); Glacinta Catenacci (Angiolina, seconda buffa);Carolina Parodi (Costanza, altra seconda buffa); Filippo Fragni (Fa-brizio, secondo buffo caricato)
MUSICISTI: Michele Melani (cembalo); Giovan Battista Rovelli (pri-mo violino dell’opera); Giuseppe Lombardi (primo violino dei bal-li); Gaetano Zanetti (primo violoncello); Carlo Fortis (primo oboe);Francesco Bolognesi (primo contrabasso); Francesco Perico (primocorno).
COSTUMISTA: Giovanni LoterioTITOLO DEI BALLI: La schiava spagnola o sia il sultano generoso (ballo pri-
mo di mezzo carattere); Il raggiri di Faloppa servo astuto (ballo se-condo comico).
PERSONAGGI DEL PRIMO BALLO: Carolina schiava spagnola; Rodrigosuo sposo; Sulmano gran signore; Mazzar suo figlio; un eunucoconfidente di Mazzar; schiave favorite di Sulmano; turchi eunuchidel seguito di Sulmano; spagnoli del seguito di Carolina.
COREOGRAFO: Ranieri PazziniBALLERINI: Ranieri Pazzini (primo ballerino assoluto), Caterina Save-
si (prima ballerina assoluta), Stefano Cherubini (primo grottesco),Clara Boggio (prima grottesca), Luigi Focosi (secondo grottesco),Marianna Majer (seconda grottesca), Giuseppe Incontri (altro bal-lerino), Maria Pazzini (altra ballerina), «vari figuranti», «signor N.N.» (ballerino per le parti), Luigi Zurli541 (primo ballerino di mez-zo carattere).
FONTI: [Libretto], Gli artigiani. Dramma giocoso per musica da rappresen-tarsi nel teatro di Cittadella in Bergamo il Carnevale 1796. Umiliato aS. E. la nobil donna Margarita Ottolini nata Querini, In Bergamo, perl’erede Rossi, [1796]542; [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spet-tacoli di tutto l’anno dalla primavera 1795 a tutto il Carnevale 1796, InMilano, Con Privilegio di Privativa, cc. 8-9543; [Documento episto-lare], Documento 1795: 13; 1796: 8, 11, in Regesto.
DATA: 1796, CarnevaleAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]
541. Registrato solo nell’indice.542. Il libretto consultato si trova conservato in BCBg, Sala 32 C 8 21 (7).543. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1172.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 461
462
FRANCESCA FANTAPPIÈ
TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «in quel teatro di Città».TITOLO: Il mercato di MonfregosoAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Nicola ZingarelliGENERE: Opera buffaCANTANTI: Maria Brunetti (prima buffa), Giovanni Prada (primo mez-
zo carattere), Antonio Coldani (primo buffo a perfetta vicenda),Gaetano Pasini (primo buffo a perfetta vicenda), Giacinta Catenac-ci (seconda buffa), Filippo Fragni (secondo buffo caricato), Caro-lina Parodi (altra seconda buffa).
TITOLO DEI BALLI: La schiava spagnuola ossia il sultano generoso (balloprimo di mezzo carattere); I raggiri di Faloppo servo astuto (ballo se-condo).
COREOGRAFO: Ranieri PazziniBALLERINI: Ranieri Pazzini (primo ballerino assoluto), Caterina Seve-
si (prima ballerina assoluta), Stefano Cherubini (primo grottesco),Clara Boggio (prima grottesca), Luigi Focosi (secondo grottesco),Marianna Majer (seconda grottesca), Giuseppe Incontri (altro bal-lerino), Maria Pazzini (altra ballerina), Luigi Zurli (primo ballerinodi mezzo carattere), «con vari figuranti».
FONTI: [Indice di spettacoli] Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1795 a tutto il Carnevale 1796, In Milano, Con Pri-vilegio di Privativa, cc. 8-9544.
DATA: 1796, Carnevale (rappresentazione solo presunta)545
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro della Cittadella.TITOLO: Le gelosie villaneAUTORE: [Tommaso Grandi]COMPOSITORE: Giuseppe Sarti
544. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1172.545. Impossibile determinare se l’opera sia stata realmente messa in scena. Se-
condo gli indici degli spettacoli le uniche due opere rappresentate nel Carnevale so-no Gli artigiani e Il mercato di Monfregoso, mentre è solo il libretto che segnala Le ge-losie villane. Indici e libretto coincidono nel riportare il cast dei musicisti e dei bal-lerini con relativi ruoli.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 462
463
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
GENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Il marchese Roberto feudatario del Castel Formicolo-
ne; Cecchino deputato della Comunità; Giannina figlia di Cecchi-no promessa in moglie a Tonina; Tonino laterale della Comunità;Olivetta moglie di Narduccio; Narduccio sindaco della Comuni-tà; Sandrina sorella di Tonino546.
MUTAZIONI SCENE PER L’OPERA: Atto primo: 1. Sala della comunitàadorna di quadri antichi con ritratti in abito nero e colaro e paruc-ca. Tavolini rozzi sedie d’appoggio all’antica. 2. Piazza del Castel-lo con vaerie botteghe di legno disposte per il mercato. Contadi-ni con cesti di commestibili da vendere. 3. Camera del marchesecon canapè. Atto secondo: 4. Camera della Comunità come pri-ma. 5. Veduta di campagna con monte. In cima di esso Casino diGiannina, lateralmente le case di Olivetta e di Sandrina, alberi, ec.6. Camera rustica con due cantonali particabili. Sedie rustiche. 7.Bosco. 8. Veduta del Casino di Giannina come sopra.
SCENOGRAFO: Gaetano PivettiDEDICATARIO: Contessa Marianna Ottolini MaffeiDEDICANTE/IMPRESARIO: «Fratelli Lombardi impresari».MUSICISTI: Michele Melani (cembalo); Giovan Battista Rovelli (pri-
mo violino dell’opera); Giuseppe Lombardi (primo violino dei bal-li); Gaetano Zanetti (primo violoncello); Carlo Fortis (primo oboe);Francesco Bolognesi (primo contrabasso); Francesco Perico (primocorno).
COSTUMISTA: Giovanni LoterioTITOLO DEI BALLI: La schiava spagnola o sia il sultano generoso (ballo pri-
mo di mezzo carattere); Il raggiri di Faloppa servo astuto (ballo se-condo comico).
COREOGRAFO: Ranieri PazziniBALLERINI: Ranieri Pazzini (primo ballerino assoluto), Caterina Save-
si (prima ballerina assoluta), Stefano Cherubini (primo grottesco),Clara Boggio (prima grottesca), Luigi Focosi (secondo grottesco),Marianna Maier (seconda grottesca), Giuseppe Incontri (altro bal-lerino), Maria Pazzini (altra ballerina), vari figuranti, Signor N. N.(ballerino per le parti).
546. Bisogna segnalare che, al contrario di quanto avveniva normalmente, nonsono indicati i nomi dei cantanti accanto alla definizione dei personaggi.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 463
464
FRANCESCA FANTAPPIÈ
FONTI: [Libretto], Le gelosie villane. Dramma giocoso per musica da rap-presentarsi nel teatro di Cittadella in Bergamo il Carnovale 1796 umilia-to a Sua Eccellenza Marianna co. Ottolini nata Maffei, In Bergamo, perl’erede Rossi, [1796]547.
DATA: 1796, primaveraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.COMPAGNIA: «Compagnia comica toscana diretta da Luigi Del Buo-
no».ATTORI: Faustina Zandonati (prima donna), Marianna Cenerini (se-
conda donna), Anna Lampredi (seconda donna), Anna Roffi (ser-va), Francesca Carlini, Girolama Carlini, Teresa Casini, Maria Lel-li, Anna Lelli («per le picciole figlie»), Simone Carlini (primo amo-roso), Giuseppe Vidari (secondo amoroso), Giuseppe Cenerini(amoroso), Pietro Marroncini (amoroso e Arlecchino), Lorenzo Pa-ni (tiranno e caratterista), Luigi Del Buono (generico e caratteristabuffo), Tomaso Marini (padri seri), Domenico Lelli (generico eDottore), Giovanni Ceccherini (servitore di raggiro), Giuliano Ba-roni (servitore di raggiro), Giovanni Del Buono, Gaetano Baroni,Vincenzio Crescini, Lorenzo Carlini («per li piccioli figli»), Gaeta-no Tardini («per le picciole parti»), Giuseppe Perini (suggeritore),Giovanni Roffi («picciole parti»).
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1796 a tutto il Carnevale 1797, In Milano, c. 6548; O.Giardi, I comici dell’arte perduta, cit., pp. 142-145.
DATA: 1796, estateAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.TITOLO DELLE OPERE RAPPRESENTANTE: L’amore immaginario; Nina
pazza per amore; Le astuzie femminili; Lisetta e Giannina; La Bonghi.GENERE: Opera buffaCOMPAGNIA DI CANTANTI: «Compagnia di cantanti napoletani diret-
ta da Giovanni Bassi».
547. Il libretto consultato si trova conservato in BCBg, Sala 32 C 8 21 (6).548. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1221.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 464
465
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
CANTANTI: Carolina Bassi (prima buffa), Raimonda Bassi (prima don-na seria), Adolfo Bassi (primo mezzo carattere), Nicola Bassi (pri-mo buffo), Anna Trevisi Bassi (seconda donna), Ferdinando Aulet-ta (secondo buffo a perfetta vicenda), Giovanni Ascolesi (secondobuffo a perfetta vicenda).
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1796 a tutto il Carnevale 1797, In Milano, c. 6549.
DATA: 1796, giugnoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.TITOLO: L’amore immaginarioAUTORE: Autore non specificato.COMPOSITORE: Valentino Fioravanti romano.GENERE: Opera buffa550
PERSONAGGI: Fioretta giardiniera amante di Don Tolipano; Don To-lipano giovine brillante promesso sposo di Doralice; Doraliceamante del marchese Alberico; Marchese Alberico sotto le spogliedi cameriere; Checchina cameriera di Doralice; Don Tibullo me-dico ignorante e zio di Doralice; Cattullo discepolo del suddetto.
SCENA: vicinanze di Firenze.CAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Ameno giardino con di-
versi poggi su d’uno de’ quali sarà seduta Doralice leggendo; Giar-dino con berso nel mezzo; Atto secondo: Camera; Campagna diFiesole con capanne.
SCENOGRAFO: Girolamo Rossetti veneziano «macchinista».DEDICATARIO: Alessandro Ottolini capitanio e vicepodestà.DEDICANTE/IMPRESARIO: Giovanni Bassi. Dedica: 22 giugno 1796.CANTANTI: Carolina Bassi (Fioretta, prima buffa), Nicola Bassi (Don
Tolipano, primo buffo), Raimonda Bassi (Doralice, donna seria),Adolfo Bassi (Marchese Alberico, tenore); Anna Trevisi Bassi (Chec-china, seconda buffa), Giovanni Ascolese (Don Tibullo, secondo buf-fo), Ferdinando Auletta (Cattullo, secondo mezzo carattere).
DIRETTORE DELLA MUSICA: Giovan Battista Pennè
549. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1221.550. Nella dedica l’impresario Giovanni Bassi definisce l’opera un «dramma ber-
nesco».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 465
466
FRANCESCA FANTAPPIÈ
COSTUMISTA: Gaetana BassiFONTI: [Libretto], L’amore immaginario. Opera buffa da rappresentarsi nel
nobile teatro Ricardi nell’estate 1796. Dedicato a Sua Eccellenza il NobilHuomo Signor Alessandro Ottolini capitano rappresentante e vice podestàdell’inclita città di Bergamo, in Bergamo, Dalla stamperia Rossi, ConApprov.551; [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tuttol’anno dalla primavera 1796 a tutto il Carnevale 1797, In Milano, c. 6552.
DATA: 1796, 26 agosto–settembre553.AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.TITOLO: MeropeAUTORE: [Mattia Botturini]COMPOSITORE: Sebastiano NasoliniGENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Merope regina de’ Messeni e vedova di Cresfonte; Ti-
mante figlio di Merope sotto il nome d’Egisto; Polifonte tiranno;Adrasto generale de’ Messeni confidente di Merope; Ismene prin-cipessa confidente di Merope; Nearco generale confidente di Poli-fonte; Polidoro aio di Timante sotto il nome di Eufemio; Coro dinobili donzelle amiche di Merope; Di guerrieri seguaci di Polifon-te; Di popolo di Messene; Ombra di Cresfonte; Gran sacerdote diErcole; Ministri del tempio di Ercole; Guardie di Merope; Guar-die di Polifonte.
SCENA: MesseneCAMBI DI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: Recinto ove sono le tom-
be dei re di Messene; Gabinetto; Sala reale; Atto secondo: Sala Rea-le; Luogo delle tombe dei re di Messene illuminato in tempo dinotte come nell’atto primo; Strada; Galleria; Atto terzo: Fabbrichein parte diroccate; Tempio554.
551. Il libretto consultato si trova in BSCr, 3 F 66.552. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1221.553. In fondo alla lista degli interpreti riportata nell’indice si legge: «Nel decor-
so delle recite vi furono illuminazioni in detto teatro ed altri diverimenti di sorte,fuochi artificiali ec. Prima recita il 26 agosto».
554. Nel libretto è inserita la seguente precisazione: «L’atto secondo cominceràdalla Scena III, mentre l’opera si rappresenterà come fu rappresentata a Venezia laprima volta che fu condotta sulle scene».
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 466
467
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
DEDICATARIO: Alessandro Ottolini capitanio vicepodestàDEDICANTE/IMPRESARIO: Onorato ViganòCANTANTI: Domenico Mombelli (Polifonte, primo tenore), Francesco
Rossi (Timante, secondo soprano), Elisabetta Billington (Merope, pri-ma donna), Teresa Marchesini Cattaneo (Ismene, seconda donna),Filippo Martinelli (Adrasto, tenore), Giacomo Filippo Zamboni(Nearco, secondo tenore), Carlo Rinaldi (Polidoro, basso), France-sco Negri (corista), Carlo Rossi (corista), Girolamo Barison (cori-sta), Antonio Ricci (corista), Tommaso Bassi (corista), Gaetano Vit-tieri (corista), Giuseppe Lerenzi (corista), Andrea Marchetti (cori-sta), Antonio Cantaruti (corista), Giacomo Barbieri (corista), Filip-po Carazzi (corista), Lorenzo Campana (corista).
DIRETTORE DE’ CORI: Filippo ZamboniTITOLO DEI BALLI: Il Meleagro (ballo serio); Amore vendicato (ballo co-
mico).COREOGRAFO: Onorato ViganòBALLERINI: Maria Del Caro (prima ballerina assoluta), Domenico de
Rossy (primo ballerino), Lorenzo Banti (primo ballerino), Giusep-pe Garbagnati (altra ballerina), Simon Ramaccini (primo grottescoa vicenda), Luigi Ghilardini (primo grottesco a vicenda), CaterinaRamaccini (prima grottesca a vicenda), Giovanna Tiberti (primagrottesca a vicenda), Antonio Landini (ballerino di mezzo caratte-re), Giuseppe Verzelotti (ballerino per le parti).
BALLERINI DEL CORPO DI BALLO: Gaetano Gorla, Francesca Bendi-nelli, Andrea Rabai, Luigia Beccaccini, Antonio Ricci, Catterina Se-lingher, Francesco Rizzati, Teresa Capra, Fedele Baratozzi, Rosa Ba-ratozzi, Bortolo Stradiotto, Candida Faenza, Tommaso Bassi, Te-resa Ricci, Girolamo Longo, Maria Gorla, Pietro Paris, Rosa Riz-zati, Giovanni Gazzola, Teresa Flauto.
FONTI: [Libretto], Merope. Dramma per musica da rappresentarsi nel no-bile teatro Riccardi in Bergamo l’agosto dell’anno 1796. Dedicato a S. E.il N. H. signor conte Alessandro Ottolini capitano e vicepodestà, In Ber-gamo, Dalla Stamperia Rossi, con Approv., [1796]555; [Indice dispettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera1796 a tutto il Carnevale 1797, In Milano, cc. 6-8556.
555. L’unico esemplare del libretto si trova in BMF.556. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II; pp. 1221-1222.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 467
468
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DATA: 1796, 26 agosto–settembreAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.TITOLO: Ines de CastroAUTORE: [Luigi De Santis]COMPOSITORE: «Diversi celebri maestri»: Francesco Bianchi, Sebastia-
no Nasolini, Ignazio Gerace, Giuseppe Cervellini.GENERE: Opera seriaPERSONAGGI: Alfonso re di Portogallo; Don Pietro suo figlio; Ines
principessa, segreta sposa di don Pietro e dama d’onore; Isabellaregina, seconda consorte d’Alfonso; Rodrigo principe del sanguereale; Fernando confidente del re, amico di don Pietro; Cori: digrandi del regno; donzelle amiche d’Ines; guardie reali; duchi e sol-dati; di popolo; [Comparse]: «due piccioli figli di don Pietro ed’Ines che non parlano», schiavi mori.
SCENA: Reggia di LisbonaCAMBI SCENA: Atto primo: Piazza festivamente adornata: elevato tro-
no da un lato, in fondo porto con navi approdate da una delle qua-li sbarca don Pietro che ritorna in Lisbona vincitore. Gabinetto ne-gli appartamenti d’Ines. Sala con varie porte che introducono a di-versi appartamenti. Notte; Atto secondo: Sala. Luogo destinao allepubbliche udienze. Orrida prigione con varie porte e scale pratica-bili. Alcuni sedili di pietra; Atto terzo: Piazza come nell’atto primo.
DEDICATARIO: conte Alessandro Ottolini capitanio e vicepodestàDEDICANTE/IMPRESARIO: Onorato ViganòCANTANTI: Domenico Mombelli (Alfonso, primo tenore), Francesco
Rossi (Don Pietro, secondo soprano), Elisabetta Billington (Ines, pri-ma donna), Teresa Cattaneo Marchesini (Isabella, seconda donna),Filippo Martinelli (Rodrigo, tenore), Giacomo Filippo Zamboni(Fernando, secondo tenore), Carlo Rinaldi (basso), Francesco Negri(corista), Carlo Rossi (corista), Girolamo Barison (corista), Anto-nio Ricci (corista), Tommaso Bassi (corista), Gaetano Vittieri (cori-sta), Giuseppe Lerenzi (corista), Andrea Marchetti (corista), Anto-nio Cantaruti (corista), Giacomo Barbieri (corista), Filippo Caraz-zi (corista), Lorenzo Campana (corista).
DIRETTORE DE’ CORI: Filippo ZamboniTITOLO DEI BALLI: Il Meleagro (ballo serio); Amore vendicato (ballo co-
mico).
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 468
469
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
COREOGRAFO: Onorato ViganòBALLERINI: Maria Del Caro (prima ballerina assoluta), Domenico de
Rossy (primo ballerino), Lorenzo Banti (primo ballerino), Giusep-pe Garbagnati (altra ballerina), Simon Ramaccini (primo grottescoa vicenda), Luigi Ghilardini (primo grottesco a vicenda), CaterinaRamaccini (prima grottesca a vicenda), Giovanna Tiberti (primagrottesca a vicenda), Antonio Landini (ballerino di mezzo caratte-re), Giuseppe Verzelotti (ballerino per le parti).
BALLERINI DEL CORPO DI BALLO: Gaetano Gorla, Francesca Bendi-nelli, Andrea Rabai, Luigia Beccaccini, Antonio Ricci, Catterina,Selingher, Francesco Rizzati, Teresa Capra, Fedele Baratozzi, RosaBaratozzi, Bortolo Stradiotto, Candida Faenza, Tommaso Bassi, Te-resa Ricci, Girolamo Longo, Maria Gorla, Pietro Paris, Rosa Riz-zati, Giovanni Gazzola, Teresa Flauto.
FONTI: [Libretto], Ines de Castro. Dramma per musica da rappresentarsinel nobile teatro Riccardi in Bergamo il settembre dell’anno 1796. Dedi-cato a Sua Eccellenza il N. H. signor conte Alessandro Ottolini capita-no e vice podestà di detta provincia, In Bergamo, Per l’Erede Rossi,[1796]557; [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tuttol’anno dalla primavera 1796 a tutto il Carnevale 1797, In Milano, cc.6-8558.
DATA: 1796, agostoAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Balletto]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.TITOLO: Meleagro ballo favoloso tragico pantomimoAUTORE: Onorato ViganòCOMPOSITORE: Luigi MarescalchiGENERE: Ballo favoloso tragico pantomimo.PERSONAGGI: Ineo re di Calidonia marito d’Altea; Altea regina di Ca-
lidonia madre di Meleagro; Meleagro amante d’Atalanta; Atalantaprincipessa d’Arcadia e famosa cacciatrice; Plesippo e Tosseo prin-cipi fratelli d’Altea; Principesse al seguito d’Atalanta; Principi fore-stieri concordi alla gran caccia del cignale di Calidonia; Cavalieri
557. Il libretto consultato si trova in CGV, 59 A 247/8.558. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, pp. 1221-1222.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 469
470
FRANCESCA FANTAPPIÈ
seguaci del re; Cavalieri seguaci di Meleagro; Cavalieri seguaci de’principi greci; Dame seguaci della Regina; Damigelle seguaci d’Ata-lanta; Amore; Vendetta; Ombre di due fratelli d’Altea; Furie.
CAMBI DI SCENA: Piazza della città di Calidonia illuminata in tempodi notte (parte prima); Un gabinetto reale con sofà da riposo (par-te seconda); Un luogo magnifico destinato per la pubblica udien-za con trono da un lato (parte terza); La foresta di Calidonia (par-te quarta); Gabinetto (parte quinta); Luogo di sepolcri contiguo altempio ed alla reggia e rogo acceso dove ardono le ceneri dei dueestini principi (parte sesta).
SCENOGRAFO: Antonio Mauro venezianoIMPRESARIO: [Onorato Viganò]COREOGRAFO: Onorato ViganòBALLERINI: Antonio Landini (ballerino di mezzo carattere, Ineo); Giu-
seppa Garbagnati (altra ballerina, Altea); Domenico De Rossi/Rossy(primo ballerino, Meleagro); Maria Del Caro (prima ballerina as-soluta, Atalanta); Lorenzo Banti (primo ballerino, Plesippo); An-tonio Majer (Tosseo); Giovanna Tiberti (primo grottesco a vicen-da, principessa al seguito); Caterina Ramaccini (prima grottesca avicenda, principessa al seguito); Simon Ramaccini (primo grotte-sco a vicenda, principe forestiero); Luigi Ghilardini (primo grotte-sco a vicenda, principe forestiero).
FONTI: [Libretto], Meleagro ballo favoloso tragico pantomimo d’invenzio-ne del signor Onorato Viganò da rappresentarsi in Bergamo l’agosto del-l’anno 1796, In Bergamo, L’erede Rossi con App.559; [Indice di spet-tacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1796a tutto il Carnevale 1797, In Milano, cc. 6-8560.
DATA: 1796, dicembreAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in prosa]LUOGO: Bergamo, «Teatro in Città»561.COMPAGNIA: «Compagnia comica italiana diretta da Francesco Bu-
ratti»
559. Il libretto consultato si trova in FGCV. L’esemplare è mutilo della paginafinale e di due pagine poste tra l’elenco dei personaggi e il primo atto. In fondo: «Sistampi G. Lambertini Deput.».
560. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1222.561. Indicazione riportata nell’indice.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 470
471
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
ATTORI: Francesco Buratti, Carlo Fagioti, Pietro Buonagamba, Giu-seppe Cavalli, Francesco Olivari, Paolina Gnudi (prima attrice), An-na Olivari, Amalia Gnudi, Rosalia Cavalli (serva), Paolo Bernareg-gi (padre nobile e Tartaglia), Vincenzo Gnudi (caratterista e Panta-lone), Francesco Gnudi (Brighella), Francesco Ferrari (Arlecchino),Carlo Fresia (suggeritore).
FONTI: Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla primavera 1796 atutto il Carnevale 1797, In Milano, c. 8562; O. Giardi, I comici dell’ar-te perduta, cit., pp. 124-126; [Nota di repertorio], Documento 1796:30, in Regesto.
DATA: 1797, Carnevale (rappresentazione programmata e annullata)563
AMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, Teatro Riccardi.GENERE: Opera buffaCANTANTI: Maddalena Bollo (prima buffa assoluta), Antonio Berini
(primo mezzo carattere), Filippo Senesi (primo buffo caricato a per-fetta vicenda), Gio. Battista Binaghi (primo buffo caricato a perfet-ta vicenda), Giacinta Catenacci (seconda buffa), Carolina Ramaz-zini (terza buffa), Giuseppe Fossati (secondo mezzo carattere), Gio-vanni Corini (secondo buffo).
BALLERINI: Vincenzo Cosentini (primo ballerino serio), Aurora Bena-glia Cosentini (prima ballerina seria), Giovanni Codacci (pimogrottesco assoluto), Maria Brugnoli (prima grottesca a perfetta vi-cenda estratta a sorte), Laura Carlini (prima grottesca a perfetta vi-cenda estratta a sorte), Marco Rossetti (secondo grottesco), Giusep-pa Brugnoli (seconda grottesca), Stefano Cherubini (primo grotte-sco fuori de’ concerti), Giuseppe Fossati (figurante), Maria Sinistri(figurante).
FONTI: [Libretto], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’anno dalla prima-vera 1796 a tutto il Carnevale 1797, In Milano, c. 8564.
562. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1222.563. Lo spettacolo non si tenne né al Teatro della Cittadella, smantellato il 6
gennaio, né al Riccardi bruciato cinque giorni dopo. Dopo l’elenco dei cantanti l’in-dice riporta: «Transunto della compagnia de’ cantanti e ballerini che dovea agire nel-lo stesso Teatro Riccardi in Carnevale, se non fosse abbruciato».
564. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1222.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 471
472
FRANCESCA FANTAPPIÈ
DATA: 1797, post 26 agosto–inizio settembreAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «Nuovo provvisionale Teatro»565.TITOLO: L’astuta in amore o sia li raggiri scopertiAUTORE: [Giuseppe Palomba]COMPOSITORE: Valentino FioravantiGENERE: Opera buffaPERSONAGGI: Amaranta, astuta villanella, che affetta semplicità, cre-
duta pupilla di messer Bobolo e destinata sposa a Poliboro; Poli-boro, giovane bizzarro allevato in Londra, amante di Celidea; Ce-lidea, gentildonna fiorentina che vive soggetta al signor Massimo;Massimo maestro di ballo giovane astuto e vantaggioso; Messer Bo-bolo villano astuto che si è messo in nobiltà, uomo furbo e goffoche aspira elle nozze d’Amaranta sua finta pupilla; Don Zenobbio,saltimbanco napoletano; Orsolina, locandiera.
SCENA: FirenzeCAMBI SCENA PER L’OPERA: Atto primo: piazza con varie abitazioni,
in prospetto veduta di una parte della città. In un lato caffè, e dal-l’altro casa della posta, e porta che introduce ad un orto; camera;giardino con alcuni villani che zappano. Atto secondo: Camera condue bussole ed un pianoforte; Notte. Loggia della locanda con por-te praticabili nei laterali. In prospetto veduta di amene colline convari casinetti in lontananza.
DEDICATARIO: Repubblica CisalpinaIMPRESARIO: Francesco ScottiCANTANTI: Concetta Cinquemani (Amaranta, prima buffa assoluta),
Pietro Guariglia/Guarilla (Poliboro, altro primo buffo), Teresa Fran-chetti (Celidea, seconda donna), Francesco Scaccia (Massimo, pri-mo buffo a vicenda, Massimo), Gaetano Passini/Pasini (Messer Bo-bolo, primo buffo caricato), Giuseppe Tajola (Don Zenobbio, altroprimo buffo), Angiolina Cinquemani (Orsolina, seconda donna).
MUSICISTI: Carlo Fortis (primo oboe e corno inglese), Giuseppe Lom-bardi (primo violino di balli), Michele Melani (cembalo), GiovanBattista Rovelli (primo violino dell’opera e direttore d’orchestra),Gaetano Zanetti (primo violoncello).
565. Indicazione riportata nell’indice.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 472
473
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
COSTUMISTA: Luigi MagrinoMACCHINISTA: Antonio GallinaSCENOGRAFO: Giovanni Pedroni «milanese, pittore delle nuove sce-
ne»566.ATTREZZISTA: Giuseppe TanziPARRUCCHIERE: Luigi NavaTITOLO DEI BALLI: Attila (primo ballo tragico); campestre (secondo bal-
lo).MUSICA DEL PRIMO BALLO: Vittorio TrentoCOREOGRAFO: Domenico BallonBALLERINI: Giuseppe Paracca (primo ballerino serio), Teresa Ballon
(prima ballerina seria), Pietro Paladini (primo ballerino), N. N. (pri-mo mezzo carattere assoluto), Ranieri Pazzini (primo grottesco avicenda), Giovan Battista Ortis/Orti (primo grottesco a vicenda),Giuseppa Santambrogio/Santambroggi (prima grottesca a vicenda),Teresa Brizzi (prima grottesca a vicenda), Marco Rossetti (secondogrottesco), Giuseppa Coleoni/Colleoni (prima ballerina di mezzocarattere), Luigi Bianchi (ballerino per le parti), Pietro Messa (bal-lerino per le parti), Marco Colla (ballerino di concerto), Luigi Schi-ra (ballerino di concerto), Gaspare Bianchi (ballerino di concerto),Giovanni Drusiani (ballerino di concerto), Giuseppe Berandi567
(ballerino di concerto), Francesco Germonio568 (ballerino di con-certo), Giovanni Maria Rossi (ballerino di concerto), FrancescaPazzini (ballerina di concerto), Carolina Coleoni/Colleoni (balle-rina di concerto), Maria Garibotti (ballerina di concerto), France-sca Rossi (ballerina di concerto), Giustina Nolis (ballerina di con-certo), Rosa/Rosina Ricci (ballerina di concerto), Carolina Ferrari(ballerina di concerto), Maddalena Vaghi (ballerina di concerto),Lorenzo Villa (ballerino di concerto), Marco Bonetti (ballerino diconcerto e suggeritore).
FONTI: [Libretto], L’astuta in amore ossia li raggiri scoperti. Dramma gio-coso per musica da rappresentarsi nel nuovo provisionale teatro di fiera di
566. Secondo l’indice.567. Nominativo riportato nel libretto. Scritturato il 15 agosto 1797 in Milano
dall’impresario Francesco Scotti per otto zecchini, cfr. Documento 1797: 43, in Re-gesto.
568. Nominativo riportato nell’indice. Scritturato da Francesco Scotti il 9 ago-sto in Bergamo per sei zecchini, cfr. Documento 1797: 32, in Regesto.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 473
474
FRANCESCA FANTAPPIÈ
Bergamo l’anno 1791. Sotto la protezione della Repubblica Cisalpina,[1797]569; [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’an-no dalla primavera 1797 a tutto il Carnevale 1798, In Milano, c. 6570;[Avviso], In Bergamo nel nuovo teatro provisionale per la solita fiera del-l’anno 17[97] si rappresenteranno due drammi giocosi intitolati L’astutain amore musica del maestro Fioravanti, il matrimonio segreto musica delcelebre maestro Cimarosa. Titolo dei balli, primo ballo tragico Attila, bal-lo secondo Campestre571; [Scritture teatrali], Documenti 1797: 11-46,in Regesto.
DATA: 1797, fieraAMBITO DELL’EVENTO: [Teatro in musica]TIPOLOGIA: [Melodramma]LUOGO: Bergamo, «Nuovo provvisionale Teatro»572.TITOLO: Il matrimonio segretoAUTORE: [Giovanni Bertati]COMPOSITORE: Domenico CimarosaGENERE: Opera buffaIMPRESARIO: Francesco ScottiCANTANTI: Concetta Cinquemani (prima buffa assoluta), Angiolina
Cinquemani (seconda donna), Teresa Franchetti (seconda donna),Gaetano Passini (primo buffo caricato), Francesco Scaccia (primobuffo a vicenda), Giuseppe Tajola (altro primo buffo) Pietro Gua-riglia/Guarillia/Guerilia (altro primo buffo).
MUSICISTI: Carlo Fortis (primo oboe e corno inglese), Giuseppe Lom-bardi (primo violino di balli), Michele Melani (cembalo), GiovanBattista Rovelli (primo violino dell’opera e direttore d’orchestra),Gaetano Zanetti (primo violoncello).
COSTUMISTA: Luigi MagrinoMACCHINISTA: Antonio GallinaSCENOGRAFO: Giovanni Pedroni «milanese, pittore delle nuove sce-
ne»573.ATTREZZISTA: Giuseppe Tanzi
569. Il libretto consultato si trova in BCBg, Sala D 1 2 (28).570. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1260.571. L’avviso si trova conservato in BCBg, Sala 32 C 8 25 1.1.572. Indicazione riportata nell’indice.573. Indicazione riportata nell’indice.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 474
475
CRONOLOGIA DEGLI EVENTI SPETTACOLARI
PARRUCCHIERE: Luigi NavaTITOLO DEI BALLI: Attila (primo ballo tragico); campestre (secondo bal-
lo).MUSICA DEL PRIMO BALLO: Vittorio TrentoCOREOGRAFO: Domenico BallonBALLERINI: Giuseppe Paracca (primo ballerino serio), Teresa Ballon
(prima ballerina seria), Pietro Paladini (primo ballerino), N. N. (pri-mo mezzo carattere assoluto), Ranieri Pazzini (primo grottesco avicenda), Giovan Battista Ortis/Orti (primo grottesco a vicenda),Giuseppa Santambrogio/Santambroggi (prima grottesca a vicenda),Teresa Brizzi (prima grottesca a vicenda), Marco Rossetti (secondogrottesco), Giuseppa Coleoni/Colleoni (prima ballerina di mezzocarattere), Luigi Bianchi (ballerino per le parti), Pietro Messa (bal-lerino per le parti), Marco Colla (ballerino di concerto), Luigi Schi-ra (ballerino di concerto), Gaspare Bianchi (ballerino di concerto),Giovanni Drusiani (ballerino di concerto), Giuseppe Berandi (bal-lerino di concerto), Giovanni Maria Rossi (ballerino di concerto),Francesca Pazzini (ballerina di concerto), Carolina Coleo-ni/Colleoni (ballerina di concerto), Maria Garibotti (ballerina diconcerto), Francesca Rossi Puricelli (ballerina di concerto), Giusti-na Nolis (ballerina di concerto), Rosa/Rosina Ricci (ballerina diconcerto), Carolina Ferrari (ballerina di concerto), Maddalena Va-ghi (ballerina di concerto), Lorenzo Villa (ballerino di concerto),Marco Bonetti (ballerino di concerto e suggeritore).
FONTI: [Indice di spettacoli], Indice de’ teatrali spettacoli di tutto l’annodalla primavera 1797 a tutto il Carnevale 1798, In Milano, c. 6574; [Av-viso], In Bergamo nel nuovo teatro provisionale per la solita fiera dell’an-no 17[97] si rappresenteranno due drammi giocosi intitolati L’astuta inamore musica del maestro Fioravanti, il matrimonio segreto musica del ce-lebre maestro Cimarosa. Titolo dei balli, primo ballo tragico Attila, ballosecondo Campestre575; [Scritture teatrali] Documenti 1797: 11-46, inRegesto.
574. In R. Verti, Un almanacco drammatico, cit., vol. II, p. 1260.575. In BGBg, Sala 32 C 8 25 1.1.
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 475
477
Fonti inedite
BERGAMO
ARCHIVO DI STATO: Accademia degli Eccitati. Catasto napoleonico. Cata-sto lombardo veneto. Estimi veneti. Dipartimento del Serio, Spettacoli pub-blici. Notarile.
BIBLIOTECA CIVICA ANGELO MAI: Archivio Calepio, carteggio. ArchivioStorico del Comune, Antico Regime, Archivi contrade e vicinie; Collegiodelle Affittanze; Ducali e Azioni; Estimi; Giudici alle vettovaglie; Rela-zioni ai Consigli; Suppliche; Vicario Pretorio. Archivio Storico dei Retto-ri Veneti, Atti della Cancelleria pretoria; Lettere; Registri di Ducali. Ber-gamo Illustrata. Carte Angelo Mazzi. Francesco Maria Quarenghi, Du-cali et altre cose diverse; Documenti di casa Quarenghi. Raccolta di Pro-clami. Manoscritti. Misericordia Maggiore. Vimercati Sozzi.
ARCHIVIO DELLA CURIA VESCOVILE: Registri di battesimi e morti dellavicinia di San Salvatore. Registri di battesimi e morti della vicinia di San-t’Agata.
ARCHIVIO DEGLI OSPEDALI RIUNITI: Istrumenti. Note. Parti.
BERGAMO, PONTE SAN PIETRO
FONDAZIONE LEGLER: Libri mastri dell’Ospedale di Bergamo.
LURANO
ARCHIVIO SECCO SUARDO: Inventario. Serie I-IV; Censimento. Sezione I.
VENEZIA
ARCHIVIO DI STATO: Capi del Consiglio dei Dieci. Lettere dei Rettori; No-tatori. Compilatori di leggi. Consiglio de’ Dieci. Registri; Filze. Inquisito-ri di Stato. Dispacci dai rettori di Bergamo; Dispacci ai rettori di Berga-
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 477
478
mo; Provveditori alle Fortezze. Senato. Deliberazioni dei Rettori. Rubri-che; Dispacci dei rettori di Bergamo; Provveditori di Terra e Mar; Terra.Registri; Terra. Filze.
BIBLIOTECA CASA GOLDONI: Collezione di libretti. Raccolta Vendramin.BIBLIOTECA CORRER: Fondo Cicogna. Manoscritti Correr.
FONTI INEDITE
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 478
479
Angelini Giovan Battista, Avanzi rifiutati alle glorie di S. E. Pietro Del-fin podestà di Bergamo, composti dal prete Gio. Battista Angelini e dalmedemo offerti a Sua Eccellenza Vincenzo Gradenigo procurator di S.Marco, Bergamo, Fratelli Rossi, 1712.
Angelini Giovan Battista, Per darti notizie del paese: descrizione di Berga-mo in terza rima 1720, a cura di V. Marchetti, con la collaborazio-ne di D. Polini, Bergamo, 2002.
Angelini Giovan Battista, Capitolo contro la parola schiavo comunementeusata per saluto, Bergamo, Fratelli Rossi, 1725.
Angelini Giovan Battista, Le glorie del Giglio e della Rosa considerate airiflessi del merito delle Illustrissime Eccellenze del signor Sebastian Conta-rini podestà di Bergamo e la signora Contarina Soranzo dignissima di luiconsorte, dal prete Gio. Battista Angelini et dal medemo consacrate al-l’Ill.mo et Ecc.mo Sig. Marin Contarini padre di S. E. e Senatore amplis-simo, Bergamo, Fratelli Rossi, 1725.
Angelini Giovan Battista, Capitolo nel quale si descrive Bergomo a musai-co equivoco, Bergamo, Fratelli Rossi, 1730.
Angelini Giovan Battista, Bergomo nobile in sé, ed in più città d’Italia, Ber-gamo, Fratelli Rossi, 1731.
Angelini Giovan Battista, Il trionfo di Cibele. Rappresentato nella nobile,e pomposa mascherata, fatta in Bergomo, Bergamo, Fratelli Rossi, 1733.
Angelini Giovan Battista, Capitolo sopra il provvedersi a sua posta la pa-natica, Bergamo, Fratelli Rossi, 1739.
Angelini Giovan Battista, Catalogo cronologico dei Rettori di Bergamocioè dei Podestà e Capitani, formato da Giovan Battista Angelini di det-
Fonti edite
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 479
480
tà Città dall’anno 1173 infino al corrente anno 1742, Bergamo, Ros-si, 1742.
Bartoli Francesco Saverio, Le pitture, sculture ed architetture delle chiese ed’altri luoghi pubblici di Bergamo. Descritte da Francesco Bartoli bologne-se e dedicate al nobile ed eruditissimo signor conte Giacomo Carrara gen-tiluomo della stessa città, Vicenza, Carlo Bressan, [1774].
Bartoli Francesco Saverio, Notizie istoriche de’ comici italiani che fioriro-no intorno all’anno MDL fino a’ giorni presenti. Opera ricercata, raccol-ta ed estesa da Francesco Bartoli bolognese, accademico d’onore clementi-no, [2 voll.], Padova, Conzatti a S. Lorenzo, 1781-1782 (rist. anast.Bologna, Forni, 1976).
Bartoli Francesco Saverio, Le pitture, sculture e architetture di Rovigo, conindici ed illustrazioni, operetta di Francesco Bartoli accademico d’onore Cle-mentino, Venezia, Pietro Savioni, 1793.
Caccia Ferdinando, Della cittadinanza di Bergamo. Trattato dedicato adessa Magnifica Città, Bergamo, Lodovico Gavazzoli, 1776.
Calvi Donato, Scena letteraria degli scrittori Bergamaschi, Bergamo, Fi-gliuoli di Marc’Antonio Rossi,1664.
Calvi Donato, Effemeride sagro-profana di quanto di memorabile sia suc-cesso in Bergamo, sua diocese et territorio da’ suoi principii fin’al corren-te anno, [3 voll.], Milano, Francesco Vigone, 1676-1677.
Castiglione Giovan Battista, Sentimenti di S. Carlo Borromeo intorno aglispettacoli, Bergamo, Pietro Lancellotti, 1759.
Colleoni Celestino, Historia Quadripartita di Bergomo et suo territorio na-to Gentile & rinato Christiano, raccolta da diversi autori stampati e ma-nuscritti per F. Celestino Sacerdote Capucino, [I parte], Bergamo, Vale-rio Ventura, 1617, [II parte], Brescia, Paolo Bizardo, 1618.
Corbella Pietro Bonoreno, De genealogia Illustrissimae Soardorum Fami-liae, Brevis Epitome. Ex multis Auctoribus, et Monumentis fide difni exac-te collecta, Bergamo, Comin Ventura, 1612.
Da Lezze Giovanni, Descrizione di Bergamo e suo territorio 1596, a curadi V. Marchetti e L. Pagani, Bergamo, 1988.
Dolci Elia, Spettacoli lirici nei teatri di Bergamo. Riccardi, Cerri, Società, Ros-si, Politeama Givoli 1784-1894. Testo. Dedica. Dichiarazione. Illustrazio-ni artistiche bergamasche. Teatro Riccardi. Teatro Cerri. Teatro della Socie-tà. Teatro Rossi. Politeama Rivoli. Notabilità artistiche che vi agirono, Edi-zione fuori commercio, Copie 10 a spese dell’autore, [1894].
FONTI EDITE
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 480
481
Gozzi Carlo, Opere, vol. IV, Venezia, Colombani, 1772.Gozzi Carlo, La figlia dell’aria o sia l’innalzamento di Semiramide. Dram-
ma favoloso allegorico in tre atti e in verso sciolto del conte Carlo Gozzi,Seconda edizione emendata e corretta, Venezia, Gio. Antonio Cur-ti q. Vitto, 1791.
Gozzi Carlo, Memorie inutili, [3 voll.], Venezia, 1797.Gozzi Carlo, Lettere, a cura di F. Soldini, Venezia, 2004.Gozzi Gasparo, Lettere, a cura di F. Soldini, Parma, 1999.Ingegneri Angelo, Della poesia rappresentativa e del modo di rappresenta-
re le favole sceniche, a cura di M. L. Doglio, Modena, 1989.Ingegneri Angelo, Della poesia rappresentativa et del modo di rappresenta-
re le favole sceniche. Discorso del sig. Angelo Ingegneri all’Illustrissimo sig.Marin Garzoni camerlingo e primo prencipe della nuova accademia di Ber-gamo, Bergamo, Comin Ventura, 1604.
Lalande Jérôme de, Voyage d’un françois en Italie fait dan les annés 1765& 1766, 8 voll., A Venise, et se trouve a Paris chez Desaint, 1769.
Legrenzi Giovanni, Basso. Harmonia d’affetti devoti a due, tre e quattrovoci consagrata all’Altezza Serenissima del Signor Prencipe Alessandro Far-nesi di Parma da Giovanni Legrenzi, primo organista di S. Maria Mag-giore di Bergamo et accademico Eccitato, Libro primo, Opera terza, Ve-nezia, Alessandro Vicenti, 1655.
Locatelli Zuccala Giovan Battista, Memorie storiche di Bergamo dal 1796alla fine del 1813, Bergamo, 1938.
Lupis Antonio, Il simolacro della gloria in lode dell’Eccellenza del sig. Pie-tro Dolfino capitanio di Bergamo inalzato da Antonio Lupis nel palazzopublico di essa città in nome dell’Accademia degl’Eccitati e consegrato al-l’Illustrissimo & Eccellentissimo Signor Cavalier Proc. Pietro Basadon-na, Bergamo, Figliuoli di Marcantonio Rossi, [1669].
Mayr Giovanni Simone, Biografie di scrittori e artisti musicali bergamaschinativi od oriundi, Bergamo, 1875 (rist. anast. Bologna, Forni, 1969).
Tentori Cristoforo, Saggio sulla storia civile, politica, ecclesiastica e sulla co-rografia e topografia degli Stati della Repubblica di Venezia ad uso dellanobile e civile gioventù, [12 voll.], Venezia, Giacomo Storti, 1785-1790.
Tentori Cristoforo, Raccolta cronologico-ragionata di documenti inediti cheformano la storia diplomatica della Rivoluzione e della caduta della Re-pubblica di Venezia, corredata da critiche osservazioni, Venezia, Augu-sta, 1799.
FONTI EDITE
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 481
483
Alberti C. (a cura di), Pietro Chiari e il teatro europeo del Settecento, Vi-cenza, 1986.
Angelini L., Il volto di Bergamo nei secoli, Bergamo, 1951.Angelini L., Lo sviluppo urbanistico di Bergamo nei secoli. La progressiva
configurazione della “forma urbis”, in L’Urbanistica a Bergamo, Berga-mo, 1962, pp. 1-36.
Angelini S., Giacomo Quarenghi, testo di V. Piljavskij, catalogo di V.Zanella, Bergamo, 1984.
Angelini S. (a cura di), Bergamo: città alta. Una vicenda urbana, con scrit-ti di L. Angelini, W. Barbero, P. Capellini, V. Landolfi, Bergamo,1989.
Annibaldi C. (a cura di), La musica e il mondo. Mecenatismo e commit-tenza musicale in Italia tra Quattro e Settecento, Bologna, 1993.
Aragona L., Bellotto F., Eynard M. (a cura di), Mayr a S. Maria Mag-giore 1802-2002, Atti del Convegno di Studi per il Bicentenario del-la nomina di Giovanni Simone Mayr a Maestro della Cappella inBergamo, Bergamo, 2004.
Arcaini R. G., I comici dell’Arte a Milano: accoglienza, sospetti, riconosci-menti, in La scena e la gloria, a cura di A. Cascetta e R. Carpani, Mi-lano, 1995, pp. 265-326.
Barblan G., Il teatro musicale a Milano nei secoli XVI e XVIII, in Storiadi Milano, vol. XII, Milano, 1959, pp. 947-996.
Bascialli F., Opera comica e opéra comique al teatro Arciducale di Monza(1778-1795), Lucca, 2002.
Battaglia S., Grande dizionario della lingua italiana, 21 voll., Torino,1962-2002.
Bibliografia
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 483
484
Battistella A., I vecchi teatri udinesi, Udine, 1929.Belfanti C. M., Dalla stagnazione alla crescita: la popolazione di Bergamo
dal Cinquecento a Napoleone, in Storia economica e sociale di Bergamo,Il tempo della Serenissima. L’immagine della bergamasca, Bergamo, 1995,pp. 173-214.
Bellocchi U., La fiera di Reggio compie 400 anni, Reggio Emilia, 1998.Beloch G., La popolazione d’Italia nei secoli sedicesimo, diciassettesimo e di-
ciottesimo, in Storia dell’economia italiana, a cura di C. M. Cipolla,vol. I, Secoli settimo – diciassettesimo, Torino, 1959, pp. 449-500.
Belotti B., L’inchiesta di Venezia sulla Rivoluzione di Bergamo del 1797, in«Bergomum», XXXI (1937), fasc. 4, parte speciale, pp. 1-18; XXXIII(1938), fasc. 1, parte speciale, pp. 19-38.
Belotti B., Venezia e la visita di San Carlo Borromeo a Bergamo nel 1575,in «Bergomum», XXXIII (1939), fasc. 2, pp. 72-85.
Belotti B., Storia di Bergamo e dei bergamaschi, 9 voll., Bergamo, 1989-1990.
Beltrami D., Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVIalla caduta della Repubblica, Padova, 1954.
Bentoglio A., L’arte del capocomico: biografia critica di Salvatore Fabbri-chesi (1772-1827), Roma, 1994.
Benzoni G., La storiografia e l’erudizione storico-antiquaria. Gli storici mu-nicipali, in Storia della cultura veneta, vol. IV, t. 2, Il Seicento, Vicen-za, 1984, pp. 67-93.
Berbenni G., L’organaria del ‘600 nelle relazioni a padre Donato Calvi, in«Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo», LXV (a.a. 2001-2002), Bergamo, 2003, pp. 299-343.
Berengo M., La società veneta alla fine del ‘700, Firenze, 1956.Berengo M., Il problema politico-sociale di Venezia e della sua Terraferma,
in La civiltà veneziana del Settecento, Firenze, 1960, pp. 69-96.Berengo M., L’Europa delle città. Il volto della società urbana europea tra
Medioevo ed Età moderna, Torino, 1999.Bernardi C., La drammaturgia della settimana santa in Italia, Milano,
1991.Bernardi C., Il tempo sacro: «Entierro». Riti drammatici del venerdì santo,
in La scena e la gloria, a cura di A. Cascetta e R. Carpani, Milano,1995, pp. 585-620.
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 484
485
Bertetto P., Pesenti Campagnoni D. (a cura di), La magia dell’immagi-ne. Macchine e spettacoli prima dei Lumière nelle collezioni del Museo Na-zionale del Cinema, Milano, 1996.
Besutti P., La corte musicale di Ferdinando Carlo Gonzaga ultimo duca diMantova. Musici, cantanti e teatro d’opera tra il 1665 e il 1707, Man-tova, 1989.
Bianchini M., Intellettuali, città e governo: le Accademie tra Chiesa e aristo-crazia, in Storia economica e sociale di Bergamo. Il tempo della Serenis-sima. Settecento, età del cambiamento, Bergamo, Fondazione per la sto-ria economica e sociale di Bergamo, 2006, pp. 215-248.
Bianconi L., Il teatro d’opera in Italia, Bologna, 1993.Bianconi L., Walker T., Production, consumption and political function of
seventeenth – century opera, in «Early Music History», IV (1984), pp.209-296.
Bianconi L., Walker T., Forme di produzione del teatro d’opera italiano nelSeicento, in La musica e il mondo, a cura di A. Annibaldi, Bologna,1993, pp. 221-252.
Bonicelli G., Rivoluzione e restaurazione a Bergamo. Aspetti sociali e re-ligiosi della vita bergamasca alle soglie dell’età contemporanea (1775-1825). Con documenti inediti, presentazione di F. Boulard, Berga-mo, 1961.
Bosisio P., Carlo Gozzi e Goldoni, Firenze, 1979.Bosisio P., Goldoni e il teatro comico, in Storia del teatro moderno e contem-
poraneo. Il grande teatro borghese. Settecento-Ottocento, Torino, 2000, pp.137-188.
Bosisio P., Teatro e teatranti nelle «Memorie inutili» di Carlo Gozzi, in Stu-di gozziani, a cura di M. G. Cambiaghi, Milano, 2006, pp. 9-60.
Bravi G. O., Guida all’Archivio Storico del Comune di Bergamo, in «Ar-chivio Storico Bergamasco», II (1982), fasc. 2, pp. 63-89.
Brunetta G. P., Il viaggio dell’iconauta dalla camera oscura di Leonardo al-la luce dei Lumière, Venezia, 1997.
Buonincontri F., Il sistema teatrale a Bergamo tra il XVIII e il XIX secolo,in «Storia della città», 22 (1982), pp. 65-90.
Burino C., Garbari C., Jelen A. K., Patui P. (a cura di), Alla ricerca deiteatri perduti: appunti per una storia delle sale teatrali nel Friuli VeneziaGiulia, Udine, 1990.
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 485
486
Burattelli C., Landolfi D., Zinanni A. (a cura di), Comici dell’arte. Cor-rispondenze, ed. diretta da Siro Ferrone, 2 voll., Firenze, 1993.
Busetto G. (a cura di), Pietro Longhi, Gabriel Bella. Scene di vita venezia-na, Milano, 1995.
Caizzi B., Industria e commercio nella Repubblica di Venezia nel XVIII se-colo, Milano, 1965.
Cappellini P., Ravanelli R., I borghi di Bergamo, con cinquanta acque-relli di M. Jannucci, Bergamo, 1984.
Caprioli A., Rimoldi A., Vaccaro L. (a cura di), Diocesi di Bergamo, Bre-scia, 1988.
Cascetta A., La spiritual tragedia e l’azione devota. Gli ambienti e le forme,in La scena e la gloria, a cura di A. Cascetta e R. Carpani, Milano,1995, pp. 115-218.
Cascetta A. e Carpani R. (a cura di), La scena e la gloria: drammaturgiae spettacolo a Milano in età spagnola, Milano, 1995.
Carlsmith C., Le “scholae” e la scuola: l’istruzione “Amore Dei” in Berga-mo tra ‘500 e ‘600, in «Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Artidi Bergamo», LX (a. a. 1996-1997), Bergamo,1999, pp. 235-256.
Carlsmith C., Schooling and Society in Bergamo 1500-1650, A disserta-tion presented to the Graduate Faculty of the University of Virgi-nia in Candidacy for the degree of Doctor of Philosophy, Depar-tment of History, University of Virginia, May 1999.
Carlsmith C., Il Collegio Patavino della Misericordia Maggiore di Berga-mo, 1531-ca.1550, in «Bergomum», XCIII (1998), pp. 75-98.
Carlsmith C., Una scuola dei putti: L’Accademia dei Caspi a Bergamo, in«Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo», LXI (a.a. 1997-1998), Bergamo, 2000, pp. 291-302.
Carlsmith C., The Jesuits in Bergamo, 1570-1729, in «Archivum Histo-ricum Societatis Iesu», LXX (2001), 139, pp. 71-93.
Chiodi L., Osterie ed alberghi a Bergamo fino al sec. XVIII, in «Bergo-mum», LIV (1960), fasc. 2, pp. 27-44.
Chiodi L., L’archivio del Comune di Bergamo durante il periodo della Re-pubblica Veneta, in Storia della Repubblica Veneta nei secoli XV e XVI.Atti del Convegno di Bergamo, 6-8 settembre 1963, in «Bergomum»,LVIII (1964), fasc. 2, pp. 119-126.
Cicali G., Attori e ruoli nell’opera buffa italiana del Settecento, Firenze, 2005.
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 486
487
Colmuto Zanella G., Le fortificazioni di Bergamo nel Medioevo, in Le mu-ra di Bergamo, Bergamo, 1977, pp. 281-282 e 315-317.
Colmuto Zanella G., La fortezza cinquecentesca di Bergamo, in L’architet-tura militare veneta del Cinquecento, Milano, 1988, pp. 110-124.
Colzani A., La cappella musicale di Santa Maria Maggiore a Bergamo do-po Legrenzi, in F. Passadore, F. Rosi (a cura di), Giovanni Legrenzi ela cappella ducale di San Marco, Atti dei convegni internazionali distudi (Venezia - Clusone, 1990), Firenze, 1994, pp. 29-46.
Comuzio E., Il teatro Donizetti. Due secoli di storia, Bergamo, 1990, 2voll.
Comuzio E., Il teatro Donizetti, Bergamo, 1995.Comuzio E., Moretti A., Il Teatro Riccardi ora Teatro Donizetti: racconto
illustrato 1789-1897, Bergamo, 2004.Cozzi G., Cultura, politica e religione nella ‘Pubblica storiografia’ venezia-
na del ‘500, in «Bollettino dell’Istituto di Storia della Società e del-lo Stato Veneziano», V-VI (1963-64), pp. 215-294.
Cozzi G., Knapton M., Scarabello G., La Repubblica di Venezia nell’etàmoderna. Dal 1517 alla fine della Repubblica, in Storia d’Italia, direttada G. Galasso, vol. XII, t. 2, Torino, 1992.
Daolmi D., Le origini dell’opera a Milano: (1598-1649), Turnhout, 1998.Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Ita-
liana, 1960.De Florentis G., Martinotti S., Tintori G., Vita teatrale in Lombardia.
L’opera e il balletto, Milano, 1982.De Martino C., L’Accademia Economico-Arvale di Bergamo nel XVIII se-
colo, in Atti e Memorie del III Congresso Storico Lombardo (Cremona1938), Milano, 1939, pp. 407-417.
De Michelis C., Letterati e lettori nel Settecento veneziano, Firenze, 1979.Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, diretto da
A. Basso, Il lessico, 4 voll., Torino, 1983-1984.Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, diretto da
A. Basso, Le biografie, 8 voll., Torino, 1985-1988.Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, diretto da
A. Basso, I titoli e i personaggi, 3 voll., Torino, 1999.Donati Petteni G., L’arte della musica in Bergamo, Bergamo, 1930.
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 487
488
Enciclopedia dello Spettacolo, ed. diretta da S. D’Amico, voll. 11, Roma,1958-1968.
Eynard M. e Tibaldi R., Per una bibliografia delle opere a stampa dei mu-sicisti nati o attivi a Bergamo nei secoli XVI-XVII, in «Bergomum»,LXLI (1996), fasc. 3, pp. 7-252.
Fabbri M., Garbero Zorzi E., Petrioli Tofani A. M. (a cura di), Il luo-go teatrale a Firenze. Brunelleschi, Vasari, Buontalenti, Parigi. Spettaco-lo e musica nella Firenze medicea, introd. di L. Zorzi, Milano, 1975.
Fabbri P., Il secolo cantante. Per una storia del libretto d’opera nel Seicento,Bologna, 1990.
Fanfani A., Il mancato rinnovamento economico, in La civiltà venezianadel Settecento, Firenze, 1960, pp. 27-68.
Fantappiè F., L’immagine di Bergamo nella traslazione dei Santi Fermo, Ru-stico e Procolo del 1766, in Il paesaggio tra realtà e rappresentazione, Stu-di in memoria di Lelio Pagani, a cura di J. Schiavini Trezzi, Berga-mo, pp. 85-116.
Ferrone S., Carlo Goldoni. Vita, opere, critica, messinscena, Firenze,1990.
Forcella P., Musica e musicisti a Bergamo. Dalle origini ai contemporanei,Bergamo, 1992.
Francovich C., Storia della massoneria in Italia. Dalle origini alla Rivolu-zione francese, Firenze, 1989.
Frati V., Il Teatro Grande di Brescia. Spazio urbano forme istituzioni nellastoria di una struttura culturale, 2 voll., Brescia, 1985.
Fumagalli A., Bergamo. Origini e vicende storiche del centro antico, Mila-no, 1981.
Gambassi O., Fanciulli cantori in S. Maria Maggiore tra la fine del XVIIIe l’inizio del XIX secolo: l’opera riformatrice di Mayr, in Aragona L., Bel-lotto F., Eynard M. (a cura di), Mayr a S. Maria Maggiore 1802-2002,Bergamo, 2004, pp. 119-149.
Gatti M., Liturgia e architettura. L’antica cattedrale di Bergamo attraversoil libro ordinario del vescovo Giovanni Barozzi (sec. XV), Tesi di laureain Storia dell’Arte Medioevale, rel. prof. P. Piva, correl. prof. M.Della Valle, Università Statale di Milano, a. a. 2005-2006.
Geddo A., Bergamo e la musica: sintesi storico biografica e critica, prefaz.di F. Abbiati, Bergamo, 1958.
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 488
489
Gelfi M., La fiera di Bergamo: il volto di una città attraverso i rapporti com-merciali, presentazione di L. Pagani, postfazione G. Della Valenti-na, Bergamo, 1993.
Gennaro E., Atti dell’Accademia degli Eccitati. L’Accademia degli Eccitatiattraverso l’indagine filologica dei suoi verbali settecenteschi, in «Atti del-l’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo», LV (a. a. 1992-1993), Bergamo, 1994, t. I, pp. 47-512.
Gennaro E., L’omaggio dell’Accademia degli Eccitati a Gregorio Barbarigo,in «Atti dell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo», LXI(a. a. 1997-1998), Bergamo, 1999, pp. 121-140.
Gennaro E., Documenti secenteschi dell’Accademia degli Eccitati, in «Attidell’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo», LXII (a. a. 1998-1999), Bergamo, 2001, pp. 415-434.
Gennaro E., Mascheroni e l’Accademia degli Eccitati di Bergamo, in Loren-zo Mascheroni tra scienza e letteratura nel contesto culturale della Berga-mo settecentesca, Bergamo, 2002, pp. 21-33.
Giardi O., I comici dell’arte perduta. Le compagnie comiche italiane alla fi-ne del secolo XVII, Roma, 1991.
Giazotto R., La guerra dei palchi, in «Nuova Rivista Musicale Italiana»,2-3 (1967), pp. 465-508.
Ginatempo M., Sandri L., L’Italia delle città. Il popolamento urbano traMedioevo e Rinascimento (secoli XIII-XVII), Firenze, 1990.
Gorla M., Cinque lettere di Teodora Ricci a Carlo Gozzi, in Studi gozziani,a cura di M. G. Cambiaghi, Milano, 2006, pp. 107-132.
Guaita O., I teatri storici in Italia, introduz. di S. Mazzoni, Milano, 1994.Guardenti R., Le fiere del teatro. Percorsi del teatro forain del primo Sette-
cento, Roma, 1995.Guccini G. (a cura di), Il teatro italiano nel Settecento, Bologna, 1988.Gullino G., Il ceto dirigente tra Bergamo e la Serenissima, in Storia econo-
mica e sociale di Bergamo. Il tempo della Serenissima. Il lungo Cinquecen-to, Bergamo, Fondazione per la storia economica e sociale di Ber-gamo, 1998, pp. 121-144.
Knapton M., Le istituzioni centrali per l’amministrazione ed il controllo del-la Terraferma, in Venezia e le Istituzioni di Terraferma, Bergamo, 1988,pp. 35-56.
Labaa G., Le cittadelle e la «Forma Fides» di Bergamo: vicende e problemi,Bergamo, 1983.
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 489
490
Lanaro P., Periferie senza centro. Reti fieristiche nello spazio geografico dellaterraferma veneta in età moderna, in Sistemi di fiere, mercanti e città inEuropa (1400-1700), Venezia, 2003, pp. 21-51.
Locatelli G., La Rivoluzione di Bergamo del 1797, Bergamo, 1897.Locatelli G., L’istruzione a Bergamo e la Misericordia Maggiore, in «Bergo-
mum», IV (1910), fasc. 4, pp. 57-169; V (1911), fasc. 1, pp. 21-100.Locatelli S., Edizioni teatrali nella Milano del Settecento. Per un dizionario
bio-bibliografico dei librai e degli stampatori milanesi e annali tipograficidi testi drammatici pubblicati a Milano nel XVIII secolo, Milano, 2007.
Locatelli Milesi A., Pubbliche cerimonie cittadine nei secoli XVII e XVIII,in «Bergomum», XXIII (1929), fasc. 1, pp. 58-67.
Locatelli Milesi G., L’anno 1797 a Bergamo, in Atti e Memorie del secon-do Congresso Storico Lombardo (Bergamo 1937), Milano, 1938, pp.173-194.
Locatelli Milesi S., Bergamo vecchia e nuova, Bergamo, 1966.Mancini F., Muraro M. T., Povoledo E., I teatri del veneto, vol. II: Ve-
rona Vicenza Belluno e il loro territorio, Venezia, 1985.Mancini F., Muraro M. T., Povoledo E., I teatri del veneto, vol. III: Pa-
dova e Rovigo e il loro territorio, Venezia, 1988.Mancini F., Muraro M. T., Povoledo E., I teatri del veneto, vol. IV: Tre-
viso e la marca trevigiana, Venezia, 1994.Mancini F., Muraro M. T., Povoledo E., I teatri del veneto, vol. I, t. 1:
Venezia. Teatri effimeri e nobili imprenditori, Venezia, 1995.Mancini F., Muraro M. T., Povoledo E., I teatri del veneto, vol. I, t. 2:
Venezia e il suo territorio. Imprese private e teatri sociali, Venezia, 1996.Mancini F., Muraro M. T., Povoledo E., I teatri del veneto, vol. V: Indi-
ci, Venezia, 2000.Mangini N., I teatri di Venezia, Milano, 1974.Marchetti V. (a cura di), Giovan Battista Angelini erudito bergamasco del
Settecento. Antologia di scritti, Bergamo, 1991.Marchetti V., Per un censimento dei luoghi destinati a Sant’Alessandro, in
Bergamo e Sant’Alessandro. Storia, culto, luoghi, a cura di L. Pagani,Bergamo, 1999, pp. 97-114.
Martini A., Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e monte in uso attual-mente e anticamente presso tutti i popoli, Torino, 1883 (rist. anast. Ro-ma, Multigrafica, 1976).
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 490
491
Martinuzzi P., Le “pièces par écriteaux” nel teatro della Foire (1710-1715).Modi di una teatralità, Milano, 2007.
Maylender M., Storia delle Accademie d’Italia, Bologna, 1929-1930, 4voll.
Mazzi A., Corografia Bergomense nei sec. VIII-IX-X, Bergamo, 1880.Mazzi A., Le vicinie di Bergamo, Bergamo, 1884.Mazzi A., Note suburbane, Bergamo, 1892.Mazzi A., Le mura di Bergamo, in «Bollettino della Civica Biblioteca
di Bergamo», II (1908), fasc. 3, pp. 197-219.Mazzoni S., L’Olimpico di Vicenza: un teatro e la sua «perpetua memoria»,
Firenze, 1998.Mazzoni S., Lo spettacolo delle accademie, in Storia del teatro moderno e
contemporaneo. La nascita del teatro moderno, Torino, 2000, pp. 880-894.
Medolago G., Il Castello di Cenate di Sotto e la famiglia Lupi, Cenate diSotto, 2003.
Mello B., Trattato di scenotecnica, Novara, 1999.Mencaroni Zoppetti M., …Orobia pendice teatro felice… La festa nella Ber-
gamo del Settecento, in «La Rivista di Bergamo», n. s., n. 6 (luglio-agosto-settembre 1996), pp. 36-41.
Mencaroni Zoppetti M., Sul teatro Sociale, in «Atti dell’Ateneo di Scien-ze, Lettere ed Arti di Bergamo», LXIV (a. a. 2000-2001), Bergamo,2002, pp. 479-487.
Mencaroni Zoppetti M. (a cura di), L’ospedale nella città. Vicende stori-che e architettoniche della Casa Grande di S. Marco, Bergamo, 2002.
Messora N., Il teatro lombardo sotto la Repubblica veneta. Commedie bre-sciane del ‘500, Bergamo, 1978.
La Misericordia Maggiore di Bergamo tra passato e presente, Bergamo, 2003.Milesi F. (a cura di), Giacomo Torelli. L’invenzione scenica dell’Europa ba-
rocca, Fano, 2000.Molmenti P., Carlo Gozzi inedito, in «Giornale Storico della Letteratu-
ra Italiana», LXXXVII (1926), pp. 36-73.Monaldini S., L’orto dell’Esperidi. Musici, attori e artisti nel patrocinio del-
la famiglia Bentivoglio (1646-1685), Lucca, 2000.Montanari D., Gregorio Barbarigo a Bergamo (1657-1664). Passi di gover-
no e missione pastorale, Milano, 1997.
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 491
492
Mora V., L’Accademia Economico-Arvale di Bergamo (1769-1816), in «At-ti dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo», LV (a. a. 1992-1993), t. II, Bergamo, 1995, pp. 11-169.
Morelli A., Legrenzi e i suoi rapporti con Ippolito Bentivoglio e l’ambien-te ferrarese. Nuovi documenti, in Giovanni Legrenzi e la cappella duca-le di San Marco, Atti dei convegni internazionali di studi (Vene-zia-Clusone, 1990), a cura di F. Passadore, F. Rosi, Firenze, 1994,pp. 47-86.
Moretti A. (ideazione, progetto, realizzazione di), Viaggio alla ricercadei teatri scomparsi di Bergamo: mostra iconografica, con la collaboraz.di E. Comuzio, Bergamo, 2003.
Mosca P., Arte e costume a Bergamo. Seicento, presentazione di A. Pos-senti, Bergamo, 2003.
Muraro M. T. (a cura di), Scenografie di Pietro Gonzaga, presentaz. di G.Folena, Vicenza, 1967.
Nicastro G., Goldoni e il teatro del secondo Settecento, Bari, 1974.Occhipinti E., Immagini di città. Le «laudes civitatum» e le rappresentazio-
ni dei centri urbani nell’Italia settentrionale, in «Società e Storia», XIV(1991), fasc. 51, pp. 23-52.
Ortalli G., Terra di San Marco: tra mito e realtà, in Venezia e le Istituzionidi Terraferma, Bergamo, 1988, pp. 9-21.
Ottolini A., Alessandro Ottolini e la Rivoluzione di Bergamo nel 1797, inAtti e Memorie del secondo Congresso Storico Lombardo (Bergamo 1937),Milano, 1938, pp. 195-210.
Padoan M., La musica in S. Maria Maggiore a Bergamo nel periodo di Gio-vanni Cavaccio (1598-1626), Como, 1983.
Padoan M., Bergamo e la musica sacra nel primo Seicento: un modello esem-plare di mediazione tra Oriente ed Occidente, in Venezia e la Terraferma.La cultura, Bergamo, 1990, pp. 53-58.
Padoan M., Giovanni Legrenzi in Santa Maria Maggiore a Bergamo, inin F. Passadore, F. Rosi (a cura di), Giovanni Legrenzi e la cappella du-cale di San Marco, Atti dei convegni internazionali di studi (Vene-zia-Clusone 1990), Firenze, 1994, pp. 9-28.
Pagani L., Le condizioni demografiche ed economiche di Bergamo e del suoterritorio secondo l’anagrafe veneta del 1766, in «Atti dell’Ateneo diScienze, Lettere ed Arti di Bergamo», XLII (a. a. 1980-1982), Ber-gamo, 1983, pp. 77-116.
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 492
493
Pagani L., Il volto della città nel catasto napoleonico, in in «Atti dell’Ate-neo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo», XLII (a. a. 1980-1982),Bergamo, 1983, pp. 781-804.
Pagani L., Marchetti V. (a cura di), Chiesa, istituzioni e territorio, Atti delCorso (Bergamo 1988), Bergamo, 1991.
Paglicci Brozzi A., Contributo alla storia del Teatro: il Teatro a Milano nelsecolo XVII. Studi e ricerche negli archivi di Stato Lombardi, Milano, 1892.
Paglicci Brozzi A., Il Regio Ducal Teatro di Milano nel Secolo 18: notizieaneddotiche 1701-1776, Milano, 1894.
Palermo P., La Cappella musicale di Santa Maria Maggiore dal 1657 al1759 attraverso i documenti dell’Archivio della Misericordia Maggiore, inMayr a S. Maria Maggiore 1802-2002, a cura di L. Aragona, F. Bel-lotto, M. Eynard (a cura di), Bergamo, 2004, pp. 103-117.
Pallotti D., Pugliatti P., La guerra dei teatri. Le controversie sul teatro inEuropa dal secolo XVI alla fine dell’Ancien Régime, Pisa, ETS, 2008.
Passadore F., Rosi F. (a cura di), Giovanni Legrenzi e la cappella ducale diSan Marco, Atti dei convegni internazionali di studi (Venezia-Clu-sone 1990), Firenze, 1994.
Pederzani I., Venezia e lo «Stado de Terraferma». Il governo delle comunitànel territorio bergamasco (secc. XV-XVIII), Milano, 1992.
Pelandi L., Dal prato di Sant’Antonio a piazza Dante. La piazza Baroni ei suoi spettacoli, in «Rivista di Bergamo», IV (1925), fasc. 48, pp. 2637-2646.
Pelandi L., I teatri di Bergamo dal provvisionale al Riccardi, in «Rivista diBergamo», aprile 1928, pp. 113-121.
Pelandi L., Ha centosessant’anni il nostro teatro Donizetti, in «Eco di Ber-gamo», 19 settembre 1950.
Pelandi L., Vicende storiche del massimo teatro bergamasco nel 1800 nel ri-costruito Riccardi si facevan lotterie e si giocava a tombola, in «Eco diBergamo», 21 settembre 1950.
Pelandi L., Teatri scomparsi. Il teatro della Cittadella ed il Cerri nel palazzodella Ragione, in «Gazzetta di Bergamo», luglio 1952, pp. 17-18.
Pelandi L., Attraverso le vie di Bergamo scomparse, 6 voll., Bergamo, 1963.Pesenti Campagnoni D., Verso il cinema. Macchine spettacoli e mirabili vi-
sioni, appendice di D. Robinson, Torino, 1995.Petrocchi M., Il tramonto della Repubblica di Venezia e l’assolutismo illu-
minato. Miscellanea di studi e memorie, Venezia, 1950.
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 493
494
Pezzolo L., Podestà e capitani nella Terraferma veneta (secoli XV-XVIII), inVenezia e le Istituzioni della Terraferma, Bergamo, 1988, pp. 57-65.
Pilon L., Il Teatro della Società di Bergamo Alta, in «Bergamo Arte», IV(giugno 1973) n. 14, pp. 5-20; (settembre 1973), n. 15, pp. 23-35.
Pilon L., L’Accademia degli Eccitati e la musica, «Atti dell’Ateneo di Scien-ze, Lettere ed Arti di Bergamo», LXII (a. a. 1998-1999), Bergamo,2001, pp. 415-434.
Pilon L., Una dinastia di violinisti: i Rovelli, in «Atti dell’Ateneo diScienze, Lettere ed Arti di Bergamo», LXVI (a. a. 2002-2003), Ber-gamo, 2004, pp. 425-450.
Pinetti A., Francesco Bartoli comico ed erudito bolognese e la prima guidaartistica di Bergamo, in «Bollettino della Civica Biblioteca di Berga-mo», X (1916), fasc. 4, pp. 157-186.
Pinetti A., Nunzi e ambasciatori della Magnifica Città di Bergamo nellaRepubblica di Venezia, in «Bergomum», XXIII (1929), fasc. 1, pp. 35-57.
Pinetti G. B., Teatro Donizetti (già Riccardi). La stagione d’opera alla fieradi agosto. Cronistoria illustrata dal 1784 al 1936, Bergamo, 1937.
Piperno F., Buffe e buffi (considerazioni sulla professionalità degli interpretidi scene buffe ed intermezzi), in «Rivista italiana di musicologia», XVII(1982), pp. 240-284.
Piperno F., Il sistema produttivo fino al 1780, in Storia dell’opera italiana,vol. IV: Il sistema produttivo e le sue competenze, a cura di L. Bianco-ni e G. Pestelli, Torino, 1987, pp. 3-73.
Previtali A., Bergamo e Clusone nel ‘600, in Giovanni Legrenzi e la cappel-la ducale di San Marco, Atti dei convegni internazionali di studi (Ve-nezia - Clusone, 1990), a cura di F. Passadore, F. Rosi, Firenze, 1994,pp. 1-8.
Pullini G., Il teatro fra polemica e costume, in Storia della cultura veneta. IlSettecento, vol. V, t. 1, Vicenza, 1985, pp. 277-307.
Quondam A., L’accademia, in Letteratura italiana. Il letterato e le istituzio-ni, cura di A. Rosa, Torino, vol. I, 1982, pp. 823-898.
Rabaglio M., Drammaturgia popolare e teatro sacro. Riti e rappresentazio-ni del Venerdì Santo bergamasco, Bergamo, 1989.
Rasi L., I comici italiani. Biografia, bibliografia, iconografia, 2 voll., Firen-ze, 1897-1905.
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 494
495
Ricci G., Teatri d’Italia dalla Magna Grecia all’Ottocento, presentaz. C.Perogalli, Milano, 1971.
Ricciardelli F. (a cura di), I luoghi del sacro. Il sacro e la città tra Medioe-vo ed Età moderna, Atti del Convegno (Firenze-Georgetown Uni-versity, 12-13 giugno 2006), Firenze, Pagliai, 2008.
Robecchi R., Il Teatro Sociale di Brescia, Brescia, 2000.Romagnoli A., “Fra catene, fra stili e fra veleni…” ossia sulla scena di pri-
gione nell’opera italiana (1690-1724), Lucca, 1995.Roncalli A. G., Gli atti della visita apostolica di San Carlo Borromeo
(1575), 5 voll., Firenze, 1936-1957.Rosenfeld S., The Theatre of the London Fairs in the Eighteenth-Century,
London, 1960.Rota S., Per una storia dei rapporti fra Bergamo e Venezia durante il perio-
do della dominazione (secoli XV-XVIII). Rassegna bibliografica, Berga-mo, 1987.
Rota S., Politica di Venezia nei confronti del territorio bergamasco nel primosecolo della dominazione, in Venezia e le Istituzioni della Terraferma, Ber-gamo, 1988, pp. 67-77.
Sartori C., I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, A-Z, 5 voll.,Cuneo, 1990-1992.
Sartori C., I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, Indici, 2 voll.,Cuneo, 1993-1994.
Scalvini M. L., Calza G. P., Finardi P., Le città nella storia d’Italia. Ber-gamo, Bari, 1987.
Scarabello G., La Repubblica di Venezia: Signoria di uno stato o di una cit-tà?, in Venezia e le Istituzioni di Terraferma, Bergamo, 1988, pp. 23-34.
Schiavini Trezzi J., Dal Collegio dei notai all’Archivo notarile: fonti per lastoria del notariato a Bergamo, Bergamo, 1997.
Schiavini Trezzi J., Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo. Inventa-rio dell’archivio (secoli XVII-XX), Bergamo, 2005.
Scotti G., Bergamo nel Seicento, Bergamo, 1897.Secco Suardo G., Il palazzo della Ragione di Bergamo ed edifici ad esso adia-
centi, Bergamo, 1901.Sella D., L’Italia del Seicento, Bari, 2000.Serena A., Storia del circo, prefazione di P. Bosisio, Milano, 2008.Serra P. (a cura di), Antiche stampe di Bergamo, 3 voll., Bergamo, 1990.
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 495
496
Tadini F., Lesbia Cidonia: società, moda e cultura nella vita della contes-sa Paolina Secco Suardo Grismondi, Bergamo 1746-1801, Bergamo,1995.
Tagliaferri A. (a cura di), Relazioni dei Rettori veneti in Terraferma, XII,Podesteria e capitanato di Bergamo, Milano, 1978.
Targhetta R., La massoneria veneta dalle origini alla chiusura delle logge(1729-1785), Udine, 1988.
Taviani F., La commedia dell’arte e la società barocca. La fascinazione delteatro, Roma, 1969.
Taviani F., Schino M., Il segreto della Commedia dell’Arte. La memoria del-le compagnie italiane del XVI, XVII e XVIII secolo, Firenze, 1982.
Tessari R., Teatro e spettacolo nel Settecento, Bari, 1995.Testaverde A. M., L’officina delle nuvole. Il Teatro Mediceo nel 1589 e gli
“Intermedi” del Buontalenti nel “Memoriale di Girolamo Seriacopi, in«Musica e teatro. Quaderni degli amici della Scala», 11-12 (giugno-ottobre 1991).
Testaverde A. M. (a cura di), Prime attrici e primi attori. Storie di attorilombardi fra Settecento e Ottocento, ricerca storica di C. Bettinelli e M.Gorla, Bergamo, 2007.
The new Grove dictionary of music and musicians, second edition, editedby Stanley Sadie, 29 voll., London, 2001.
Tironi L., Paolina Secco Suardo Grismondi: Lesbia Cidonia, la vita e le ope-re, Trescore Balneario, 2001.
Todeschini G., Carlo Lenzi. Maestro di cappella della basilica di S. MariaMaggiore in Bergamo, Azzone,1985.
Torri T., Dalle antiche Accademie all’Ateneo. Contributo alla storia della cul-tura in Bergamo, Bergamo, 1975.
Tosi V., Il cinema prima del cinema, Milano, 2007.Varese C., Per un’imparziale rilettura, in Pietro Chiari e il teatro europeo del
Settecento, a cura di C. Alberti, Vicenza, 1986, pp. 47-75.Ventura A., Nobiltà e popolo nella società veneta del ‘400 e ‘500, Bari,
1964.Verga M., Appunti per una storia politica del granducato di Cosimo III
(1670-1723), in La Toscana nell’età di Cosimo III, Atti del convegno(Pisa–Firenze 1990), a cura di F. Angiolini, V. Becagli, M. Verga,Firenze, 1993, pp. 335-354.
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 496
497
Verti R. (a cura di), Un almanacco drammatico. L’indice de’ teatrali spetta-coli 1764-1823, 2 voll., Pesaro, 1996.
Viale Ferrero M., Luogo teatrale e spazio scenico, in Storia dell’opera ita-liana, vol. V: La spettacolarità, a cura di L. Bianconi e G. Pestelli,Torino, 1988, pp. 3-122.
Vianello C. A., Teatri spettacoli musiche a Milano nei secoli scorsi, Mila-no, 1941.
Vitali R., La Misericordia Maggiore di Bergamo (1265-1978), Bergamo,1978.
Volpi L., Tre secoli di cultura bergamasca. Dalle Accademie degli Eccitati edegli Arvali all’Ateneo, Bergamo, 1952.
Zacchi R., La scena contestata, Liguori, 2006Zaghi C., L’Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, in Storia d’Ita-
lia, diretta da G. Galasso, vol. XVIII, t. 1, Torino, 1986.Zanella V., Formazione di Bergamo moderna riepilogo delle vicende urbani-
stiche dal 1797 al 1951, in L’Urbanistica a Bergamo, Bergamo, 1962,pp. 37-109.
Zorzi L., Il teatro e la città, Torino, 1977.
BIBLIOGRAFIA
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 497
499
Abbatoni, Giovan Battista; 79ACCADEMIA DEGLI AIRONI; 83, 112, 141ACCADEMIA DEGLI ARVALI, BERGAMO;
20, 44-45, 50ACCADEMIA DEGLI ECCITATI, BERGA-
MO; 20, 46, 50, 59-61, 112, 149ACCADEMIA DEGLI ELEVATI, PADOVA;
35ACCADEMIA DEGLI EMI, BERGAMO; 46ACCADEMIA DEGLI ERRANTI, BRESCIA;
34, 46, 56, 149ACCADEMIA DEGLI ETEREI, PADOVA; 35ACCADEMIA DEGLI INFIAMMATI, PADO-
VA; 35ACCADEMIA DEI COSTANTI, PADOVA;
35, 40ACCADEMIA DEI RINASCENTI, PADOVA;
35ACCADEMIA DI MUSICA, BERGAMO; 64ACCADEMIA ERETENIA, VICENZA; 41Acchiappati, Bernardino; 239Adami, Giovanni Antonio; 211Adelasio, Antonio; 61,Adelasio, Giovan Battista; 185Adelasio, Girolamo; 73Agazzi, Benedetto; 72-73Agliardi, Bonifacio; 45, 59, 153Agliardi, Camillo; 81Agosti, Francesco; 185Agosti, Giulio Cesare; 46Aimo, M.A.; 161Akenheil, […]; 173Albani, Antonio; 69, 84Albani, Giovanni; 80, 151Albani, Girolamo; 185, 187-188
Albani, Giuseppe; 80Albani, Mario; 46Albani, Teodoro; 185, 188Alberghetti, Antonio; 185, 188Alberis, Teresa; 75-76Alberti, C.; 159Albertini, Margherita; 126Alborghetti, Giordano; 240Alcaini, Giorgio Jacopo; 79Alessandri, Antonio; 72Alessandri, Guglielmo; 73Alfieri, Vittorio; 157, 159Altavista, C.; 50Aman, Giorgio; 176Ambivere, Ferrante di; 46Ambrosioni, Giuseppe; 236Andolfati, Pietro; 235Andreini, Francesco; 147Andreini, Giovan Battista; 39Andreini, Isabella; 53, 147-148Anelli, Angelo; 217Anfossi, Pasquale; 74, 114, 124-125, 200Angaran, Marzio; 40Angelini, Giovan Battista; 9, 20, 41, 45-
47, 52, 65-66, 93, 109, 140, 145, 154-156, 164-172, 176-178, 180-182
Angelini, L.; 63Angelini, S.; 63Antonietti, Bernardo; 67Antonioli, Giuseppe; 175Apolloni, Apollonio; 69, 80Aratta, Nicola; 163, 288Arcaini, R.G.; 147Aregazzolo, Clemente; 112-113Arganini, Carlo; 213
Indice dei nomi e delle Istituzioni
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 499
500
Argo, Pietro; 112-113Arnauld de Baculard, Francois Thomas
Marie de; 136Arrigoni, Francesco; 185Arrigoni, Giovan Giacomo; 76, 111, 188,
199, 209-215, 220-222, 244Asburgo-Lorena, Ferdinando (arciduca
d’Austria e governatore di Milano);52, 179, 235
Aureli, Aurelio; 69, 79, 84Avelloni, Francesco; 133, 157, 162-163Averara, Pietro; 112-113Azzolini, Agostino; 100Azzolini, Caterina; 100
Baglioni, Giovan Paolo; 64,Baglioni, Giovanni Antonio; 184, 186-
188, 242, 245Ballarotti, Francesco; 48, 85, 108,Balletti, Elena; 37, 39Ballio, Antonio; 46Balp, […]; 177Bana, Giovanni; 46Banti, Rosa; 76Barbarigo, Gregorio; 45-46, 49, 149Barberino, Andrea da; 134Barbero, W.; 63Barbieri, Nicolò; 166Barblan, G.; 68Bartoli, coniugi; 130Bartoli, F.S.; 35, 42, 132Bartoli, Francesco; 38, 41, 130-131, 156,
158Bartolomei, Giuseppe; 228Bascialli, F.; 129Bassi, Giovanni; 228, 235Basso, A.; 35, 62, 65Bassoni, Benedetto; 229Bastianelli, Camillo; 126Bastianelli, Vittoria; 126Battaglia, Carlo; 41, 124, 129, 133, 135Battaglia, Maddalena; 39, 133Battaglia, S.; 106Battistella, A.; 34Beauharnais, Giuseppina; 237Beccaccini, Marianna; 237Belfanti, C.M.; 51, 178, 243Bella, Gabriel; 154Bellocchi, U.; 144Belloni, Gaetano; 55, 224, 228
Belloni, Luigia; 133-135Beloch, G.; 30Belotti, B.; 20, 49, 140, 231, 235Beltramelli, Giuseppe; 229Beltrami, D.; 29, 243Benaglio, Carlo; 185, 187-188Benaglio, Giovanni; 64, 73Benaglio, Girolamo; 70, 84Benaglio, Ottavio; 185Benaglio, Gherardo; 98Benaglio, famiglia; 189Benincasa, Sebastiano; 127-128Benni Venturini, Clarice; 85Bentivoglio, Cornelio; 79-80, 149-150Bentivoglio, famiglia; 53, 149Bentivoglio, Ippolito; 81-82, 131, 150-
152Benvenuti, A.; 50Benvenuti, Giovan Battista; 185, 187-189Benzoni, G.; 44Beregani, Niccolò; 69, 82Berengo, M.; 17, 19, 226, 230-232, 235-
236, 240Bernandoni, Virgilio; 14Bernardi, Agostino; 172Bernardi, C.; 50Bertati, Giovanni; 126, 199Bertetto, P.; 169, 174Berti, Francesco in arte Brighella; 156Bertini, Carlo; 85Berzalli, Antonio; 72-73Besutti, P.; 99Bettinelli, Chiara; 129Bianchi, Francesco; 218Bianchi, Ludovico de’; 147Bianconi, L.; 16, 32, 99, 105, 124-125,
128Bibiena, Francesco; 37BIBLIOTECA ANGELO MAI, BERGAMO;
14, 20, 22, 52, 63, 113BIBLIOTECA DEL MUSEO CIVICO, BAS-
SANO DEL GRAPPA; 130BIBLIOTECA DEL MUSEO CIVICO, PADO-
VA; 22Biffi, Filippo; 112Biffi, Nicolò; 112Bigiogero Uzedo, Giuseppa; 75Bigiogero, Pietro; 75Bissari, Gualdinello; 41Bissoni, Camilla; 72, 156
INDICE DEI NOMI E DELLE ISTITUZIONI
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 500
501
INDICE DEI NOMI E DELLE ISTITUZIONI
Bjuström, Per; 108Bolgeni, Pietro Ottavio; 46Bolognese, Francesco; 56, 191-195, 202,
243, 245Bonaparte, Napoleone; 113, 179, 231,
235, 137Bonduri, Girolamo; 185Bonicelli, G.; 240Bonora, Ettore; 161Bonzi, Antonio; 230Bordoni, Placido; 160Boretti, Giovanni Antonio; 70Borghi, Giovan Battista; 228Borromeo, Carlo; 49, 139-140, 147Bosisio, P.; 30, 129, 143, 157-158Bottagisi, Giuseppe; 46Bottalino, Giovan Battista; 81Bottani, Carlo Ippolito; 89Bottani, Gio Antonio; 86, 89, 96Bottinelli, Stefano; 176Botturini, Mattia; 236Boussion, […]; 240Braga, Giacomo; 147Bragadino, Lorenzo; 82, 152Brembati, Coriolano; 183, 185Brembati, famiglia; 184Bresciani, Giovan Battista; 63Brevi, Giovan Battista; 48, 180Brini, Lorenzo; 136, 229Briolo, Gianmichele; 161Broglia, Antonio; 67Brunetta, G.P.; 170Bucchia, Girolamo; 150Buonincontri, F.; 18, 73, 76, 111, 121-
122, 137, 199-200, 206, 241Burattelli, C.; 53, 154Burigotti, Santo; 55, 181Burino, C.; 29, 33-35Busetto, G.; 154Bussani, Giacomo Francesco; 103-104Buzzetti, Sandro; 14, 23
Caccia, Ferdinando; 43, 137Cadonici, Giorgio; 115-117, 120Cagnola, Francesco; 171, 178Calderoni, famiglia; 151Calderoni, Francesco; 150-151Calderoni, Maddalena; 150Calepio, famiglia; 84Calepio, Pompilio; 64, 73
Calvi, D.; 45-48, 59-61, 83, 112, 145,148-149, 169
Calza, G.P.; 63Cambiaghi, M.G.; 130Camerani, Antonio; 158Camilla Bissoni, detta Franceschina; 72,
156Caminèer Turra, Elisabetta; 41Cannata, N.; 161Canossa, Orazio; 151Capella, Chiara; 87Capellini, P.; 63Cappellino, Antonio; 171Caprioli, A.; 49Carissimi, Francesco; 46Carlsmith, C.; 17, 47-49, 140Carminati, Girolamo; 87Carpani, R.; 50, 147Carrara, Alessandro; 48Carrara, Francesco Michele; 80Carrara, Giacomo; 42, 131Caruso, Luigi; 125Casanova, Girolamo; 126Cascetta, A.; 10, 50, 147Casotti, Giuseppe; 73Castelli Filippo; 40Castiglione, G.B.; 147Cavaccio, Giovanni; 47Cavagna, Giovanni Antonio; 80Cavalli, Francesco; 79Cazzati, Maurizio; 48, 60, 80, 150Ceccarelli, Eleonora; 81Ceccarelli, Leonora vedi Ceccarelli, Eleo-
noraCecchini, Pier Maria; 39Cedrelli, Rocco; 91Ceresola, Andrea; 63Ceresolo, Carlo Francesco; 48Cerri, Francesco; 241Cesti, Antonio; 61, 80Chiapella, Emanuele; 166Chiappati, Giuseppe; 190Chiappati, Nicola; 239Chiari, Pietro; 157, 159Cicali, G.; 14, 22, 124Cicognini, Giacinto Andrea; 80Cimarosa, Domenico; 125, 129, 200, 217Cipolla, C.M.; 30Cipriani, Francesco; 217Cipriotti, Giacomo; 52, 99, 103-104,
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 501
502
106, 108, 180Collegio Mariano, Bergamo; 48Colleoni, Celestino; 47Colleoni, Paolo; 216, 229Colmuto Zanella, G.; 17Coltellini, Marco; 199Compagnoni, Domenico; 54, 115-117,
142, 190, 207Compagnoni, famiglia; 117, 142Comuzio, E.; 18, 25, 200, 217-218, 225,
227, 239Contarini, Girolamo; 50Contarini, Pietro; 59Contarini, Alvise; 166Coppini, Giovanni; 228Corbella Bonoreno, P.; 86Cornaro, Alvise; 36Cornaro, Federico; 49Corner, Niccolò; 178Correr, Francesco; 115Cortesi, Giuseppe; 171Cosetti, Giacomo;Costantini, Girolamo Antonio; 218Cozzi, G.; 44, 226, 235Crivelli, Giovan Battista; 47Cucchi, Francesco; 46
D’Amico, S.; 108Da Lezze, G.; 20, 111-112Da Ponte, Lorenzo; 126Dal Borgo, Michela; 14Dall’Olmo, Giovanni; 185David, Giacomo; 65De Gamerra, Giovanni; 157, 200, 228De Luca, Giuseppe; 14De Santis, Luigi; 236De Stefani, Giuseppe; 76Dehe, Antonio; 72, 77, 117-118Dehe, famiglia; 117, 142, 190, 207Dehe, Francesco; 54Dehe, Nazario; 54, 72, 141Dehe, Scipione; 117Del Buono, Luigi in arte Stenterello;
163, 235Del Puppo, Daniele; 158Delicati, Luigi; 158Della Torre, Alfonso; 61Della Valentina, G.; 20, 145della Valle, Federico; 147Denzio, Pietro; 55
Diodati, Giuseppe Maria; 126Doglio, F.;162Doglio, M.L.; 148Dolci, E.; 201Dolfin Bonfadini, Adriana; 65-66Dolfin, Alvise; 89, 96, 101, 108Dolfin, famiglia; 34Dolfin, Pietro; 44, 46, 60, 83, 112, 141Dolfin, vescovo; 240Donado, Giulio; 87-88, 93, 95, 97, 100Donati Petteni, G.; 18, 117Dupen, Luigi; 218
Emo, Giovanni; 46Este, Francesco III (di) duca di Modena;
52, 179Este, Maria Beatrice (di); 160, 235
Fabbri, M.; 51, 71Fabbri, P.; 30, 79Fabrizi, Vincenzo; 125Facchetti, Antonio; 46Facchinetti, Pietro; 96Facheris, Bartolomeo;112, 167Falconetto, Giovanni Maria; 36Fantappiè, F.; 5, 9, 49-50, 100Farnese, famiglia; 153Faustini, Giovanni; 69, 79Favier, Giovanni; 200Fedeli Bianchi Romagnesi, Brigida in ar-
te Aurelia; 149Federici, Camillo pseudonimo di Gio-
van Battista Viassolo; 157, 161Feramosca, Vincenzo; 40Ferrari, Ignazio; 181Ferrone, S.; 14, 157Ferzi, Lorenzo; 175Fiala, Giuseppe; 53, 80, 150-151Fiala, Marzia Narici; 150Finardi, P.; 63Fischietti, Domenico; 125Flury, Fridolin; 174Fogaccia, Girolamo; 223Folena, G.; 227Foppa, Giuseppe Maria; 114, 124Forcella, P.; 18, 19, 48, 61, 117, 201Franceschini, Petronio; 85Franchetti, Antonio; 64Franchetti, Giovan Paolo; 185Franchetti, Paolo; 188
INDICE DEI NOMI E DELLE ISTITUZIONI
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 502
503
INDICE DEI NOMI E DELLE ISTITUZIONI
Francovich, C.; 226Frangiosi, Caterina; 100Frati, V.; 29, 35Freschi, Giovan Domenico; 84Fugazza, Vittorio Maria; 84
Gabrielli, Domenico; 100Gabrielli, Federico in arte Mario; 150Gabrielli, Ippolita; 150Galasso, G.; 226, 231Gallazi, Geltrude; 126Galliari, fratelli; 200, 208, 227Gallo, F.; 50Galuppi, Baldassarre; 114, 124-125Galuppi, Antonio; 190Gamba, Marta, 14Garbari, C.; 29, 33-35Garbero, Zorzi, E.; 51, 71Garzoni, Marino; 148Gathan, Maia; 14Gattai, Giuseppe; 217Gatti, M.; 14, 24, 49Gazzaniga, Giuseppe; 125Gelfi, M.; 20, 145Gemmingen, Otto Henrich; 135Gennaro, Erminio; 60Ghedini, Giovan Maria; 46Gherardini, Rinaldo; 108Ghirardelli, A.; 45Ghirardelli, L.; 45Ghislanzoni, Giovan Battista; 190Giardi, O.; 21, 24, 130, 133, 157, 163Giazotto, R.; 43, 243Gillet, […]; 177Ginatempo, M.; 30, 66Giordani, Giuseppe; 200Giudice, Pietro; 127Giuliani, Filippo; 67Giupponi, Francesca; 14, 23Giurini, Teresa; 127Giussani, Giovanni Maria; 125Giustinian, Sebastian; 40, 80Giustiniani, casata; 98Golcio, Antonio; 67Goldoni, Antonio; 163Goldoni, Carlo; 34, 38-39, 74, 124-125,
154, 157, 199, 226Gonzaga, Ferdinando Carlo; 71, 99-101Gonzaga, Pietro; 227Gorla, M.; 129-131, 235
Gozzi, Carlo; 130-131, 133-136, 157, 162Grandi, Alessandro; 47Graziani, Girolamo; 153Greppi, Giovanni; 132-133,157Grimani Calergi, Vincenzo; 152Grimani, Alvise; 45Grimani, casata; 98, 152Grisanti, Agostino; 150Grismondi Secco Suardo, Paolina; 120,
124, 136-137, 233Grismondi, Dora Paula; 229Grismondi, Luigi; 64, 215-216, 219, 221-
222Grismondi, Margherita; 158Grumello, Fermo; 81Guaita, O.; 91Guardenti, R.; 144Guccini, G.; 128, 158Guerrini, Antonio; 60Guglielmi, Pietro; 125Gujot, […]; 178Gullino, G.; 44
Händel, George Friedrich; 104Haym, Nicola Francesco; 104
Imer, Giuseppe; 39Ingegneri, Angelo; 46, 148Isola Torri, Antonia in arte Lavinia; 151
Jelen A.K.; 29, 33-35Jonas, […]; 177
Knapton, M.; 33, 110, 226, 235
L’Hermite, Louis; 234La Ros, Salvatore; 127Labbia, Paolo Antonio; 110Ladin, Ignazio; 229Lalande, Jérôme de; 63, 111, 146Lanaro, P.; 145Landolfi, D.; 53, 154Landolfi, V.; 63Lanfranchi Rossi, Carlo; 125Lapy, Giuseppe; 41Legrenzi, Giovanni; 47, 150Lenzi, Carlo; 48, 65Lesbia Cidonia vedi Grismondi Secco
Suardo, PaolinaLivigni, Filippo; 125-126, 200
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 503
504
Locatelli Milesi, A.; 44, 65Locatelli Milesi, G.; 234Locatelli Zuccala, G.B.; 122, 234-235,
237-239Locatelli, Francesco; 46, 57, 233-234Locatelli, G.; 48Locatelli, Giuseppe; 46Locatelli, Pietro Antonio; 48Lolli, Antonio; 48Lombardi, Antonio; 127Lombardi, famiglia; 142Lombardi, fratelli; 200, 238-239Lombardi, Giovan Battista; 54, 56, 118-
119, 122, 159, 199-200, 203, 207, 213,218
Lombardi, Giuseppe; 56, 119, 200Longhi, famiglia; 238Longhi, Ridolfo; 122, 238Loredan, Lorenzo; 83Lorenzi, Giambattista; 126Lucchini, Giovan Francesco; 6, 206, 218Lupis, A.; 45, 60, 112-113Lupo, Mario; 86Lupo, Vittorio; 46
Macazzoli, Giovan Battista; 183, 185-186
Madrigali, Domenico; 127Madrigali, Rosa; 127Maffei, Livia; 127Maffei, Scipione; 37-40Magili, Andrea; 46Magni, Pietro; 235Magno, Michele; 120Magnocavallo, Giacinto conte di Varen-
go; 161Mainino, Francesco; 76Majeroni, Tiberio; 35Mamone, Sara; 14Manca, Maria Elisabetta; 14Mancini, F.; 29-30, 33-35, 37-40, 74, 98-
99, 118, 128, 135, 140, 154, 192, 236Mandolino, Giovanni; 81Mandolino, Tommaso; 81Manfredi, Muzio; 147-148, 275-276Manfredini, Marc’antonio; 35Manganoni, Bernardino; 81-82Manganoni, Domenico Angelo; 82Manganoni, Tobia; 82Mangeani, fratelli; 174
Mangini, N.; 43, 98, 243Manni, Francesco; 69Manni, Pietro; 69-71, 84Mantica, Carlo; 34Marchesi, Flaminio; 63Marchetti, V.; 20, 47, 144Marcolla, Marco; 38, 154Marescand, Giandomenico; 75Marescand, Salvatore; 75Mari, Giovacchino; 127Mariani, Antonio; 163, 229Martelli, Pier Jacopo; 39Martinelli, Bortolo; 175Martinenga, Grandilia; 84Martinengo, Bartolomeo; 79, 84Martinengo, famiglia; 79-80, 84, 141, 233Martinengo, Francesco Amedeo; 80,
149-150Martinengo, Gaspare Antonio; 79, 151Martinengo, Gaspare; 80, 148, 149Martinengo, Roberto; 70Martini, A.; 121Martini, Vincenzo; 125Martinoni, Giacomo; 92Martinuzzi, P.; 144Masan, Rosa; 126Matos Fragoso, Giovanni; 130Maylender, M.; 46Mayr, G.S.; 117Mazzi, A.; 17, 144Mazzoleni, G.;45Mazzoleni, Gasparo; 46Mazzoleni, Giovan Battista; 48Mazzoleni, Paolo; 230Mazzoni, S.; 32, 39, 91Mazzotti Malipiero, Luigi; 163, 229Medebach, Girolamo; 39, 158Medici, Cosimo III de’; 62Medolago, G.; 86Melani, Jacopo; 62Mello, B.;106-107Mencaroni Zoppetti, M.; 19-20, 61, 65,
90Menichelli, Francesco; 159, 162-163Menichelli, Nicola in arte Arlecchino;
158Merula, Tarquinio; 47Messora, N.; 33Metastasio, Pietro; 36, 74, 190, 208, 218,
226, 233
INDICE DEI NOMI E DELLE ISTITUZIONI
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 504
505
INDICE DEI NOMI E DELLE ISTITUZIONI
Michiel, Marco; 89, 96, 108Milesi, F.; 46, 108Minato, Niccolò; 69, 83Mocenigo, Luigi; 110Moiolo, Giovanni; 61Molin, Girolamo Ascanio; 115-116Molmenti, P.; 130-131Monaldini, S.; 21, 79-80, 83, 131, 150-
152Moniglia, Giovanni Andrea; 62Montanari, D.; 49Monti, Vincenzo; 157, 162Monza, Gaetano; 76Morelli, A.; 150Moretti, A.; 18, 25, 200Morone, Antonio; 84Moroni, Antonio; 229Moroni, Francesco; 79Moroni, Pietro Giacomo; 73Morselli, Adriano; 103-104Mosca, P.; 164, 169Mozzi, Giovan Battista; 185, 187-188Muletti, Giacomo; 136Muraro, M.T.; 29-30, 33-35, 37-40, 74,
98-99, 128, 135, 140, 154, 192, 227,236
Muttoni, Girolamo; 41
Nani, Agostino; 85Navaglia, Paolo; 55Negri, Cristoforo; 136Negri, Marco; 46Negroni, Giacomo; 150Nella, Giacomo; 177Nelli, Jacopo Antonio; 75Nicastro, G.; 157Noris, Matteo;70, 85Nota, Alberto; 157Novelli, Pier Antonio; 38, 154
Obizzi, Pio Enea; 36, 52Occhipinti, E.; 156Oltrabelli, Teresa; 127Onigo, Fiorino; 34Orleans, Margherita Luisa di; 62Ortalli, G.; 44Osio, Felice; 48Ottolini, A.; 229, 232, 235, 237-239Ottolini, Alessandro;57, 122-123, 178,
232-235, 237-240
Ottonelli, Giovan Domenico; 139
Pacella, Maria; 14Padoan, M.; 47-48, 150Pagani, L.; 20, 30, 49, 51, 53, 66, 144-
145, 178, 243Paganini, Carlo; 75Paganini, Francesco; 158Paghetti, Giovan Battista; 150, 151Paglicci Brozzi, A.; 68Paisiello, Giovanni; 125, 128, 218, 228Palazzi, Odoardo; 81-82, 131, 151-152Palazzo, Giovanni; 61Palomba, Giuseppe; 126, 218Panceri, Giulio; 69Partenio, Giovanni Domenico; 85Parziale, Lavinia; 14Pasqual, Margherita; 180Passadore, F.; 150Passarelli, Almerico; 60, 79-80, 150Passi, Benedetto; 46Pastina, G.; 133Patrat, Joseph; 160, 162Patui, P.; 29, 33-35Pazzini Carli, Vincenzo; 159Pelandi, L.; 18, 121, 200, 241Pelandi, Ugo; 25Pellandi, Giuseppe; 39, 41, 159Pellesini, Giovanni; 147Pelliccioli, Andrea; 14, 22Pelliccioli, Giovan Battista; 79Perelli, Luigi; 39, 41, 124, 129, 132-133,
159Pergolesi, Giovan Battista; 75Perogalli, C.; 91Perucchetti, C.; 35Pesenti Campagnoni, D.; 169-170, 174Pesenti, Pietro; 240Pestelli, G.; 16, 105Petrioli Tofani, A.M.; 51, 71Petrosellini, Giuseppe; 125-126Pezzoli, Cammillo; 237Pezzoli, Carlo; 233, 236Pezzoli, famiglia; 238Pezzoli, Ferdinando; 204Pezzoli, Gaetano;122-123, 233-234, 238Pezzoli, Giovanni; 64Pezzoli, Giuseppe; 73, 185, 188Pezzolo, Innocenzo;61Pezzolo, L.; 30, 82
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 505
506
Pianca, Pietro; 163Piantanida, Antonio; 104Piccinni, Niccolò; 125Piccolomini, Alessandro; 40Pieghevoli, Volontario; 75Piermarini, Giuseppe; 91Pietrobelli, Benedetto; 185Pilon, L.; 18, 61, 86, 125Pindemonte, Ippolito; 135Pinetti, A.; 44, 65, 131Pinetti, G.B.; 201Pio VI (Giovanni Braschi); 173Piperno, F.; 16, 32, 99, 124, 140Pisani, Pietro; 87-88, 93, 95, 97, 100Polinà, Pietro; 162, 228Poncino, Mario; 87Portalupi, Pietro; 81Povoledo, E.; 29-30, 33-35, 37-40, 74, 98-
99, 118, 128, 135, 140, 154, 192, 227,236
Praignoni; 177Prezzati, Giovanni; 185, 188Puttini, Francesco; 55, 73-77
Quadri, Carlo Francesco; 156Quaglia, Giovan Battista; 48Quarenghi, Francesco Maria; 24, 117-
118, 120, 127, 133, 136-137, 156-157,164, 177, 227
Quarenghi, Giacomo; 48Quarismini, Maria; 86Querini, Angelo Maria; 26, 35Quinto, Francesco; 41
Rabaglio, M.; 49Ragazzoni, Carlo; 92Ragazzoni, Girolamo; 49Rampazzi, Perina; 75-76Raparini, Pietro; 141Rasi, L.; 153Recrosio, Giuseppe; 46Repetta, Scipione; 40Riccardi, Bartolomeo; 180,Riccardi, Bortolo; 6, 56-57, 78, 123, 142,
162, 199, 201-208, 210-216, 218-226,229, 234-235, 239, 244-245
Riccardi, Girolamo; 233, 239Riccardi, Giuseppe; 238Riccardi, famiglia; 225Ricci, G.; 91
Ricci, Teodora; 130-131, 133Ricciardelli, F.; 50Riccoboni, Luigi; 37-39Richardson, Samuel; 125, 133Rigamonti, Giuseppe; 46Rimoldi, A.; 49Ripellino, A.M.; 157Rivola, Clemente; 45, 59,Rivola, famiglia; 184-185Rivola, Girolamo; 183Robecchi, R.; 29, 35Roberti, Giacomo; 116Robinsono, D.; 170Rocca, Gaetano; 213Rodegario, Giacomo; 125Rodler, L.; 133Romagnoli, Antonio; 105, 228Roncalli, A.; 49, 140Roncalli, Francesco; 85Roncalli, Lodovico Maria; 64Rondis, Giuseppe; 229-230Ronzoni, Domenico; 46Rosenfeld, S.; 144Rosi, F.; 150Rossi, Pietro; 156, 158Rota Vitali, Giovan Battista; 57, 203, 208,
218, 223, 233-234Rota, Pietro; 48Rota, S.; 20, 43Rucellai, Giovanni; 40Rupano, Francesco; 175
Sacchi, Antonio; 39Sacco, Antonio; 27, 124, 129-130Sacco, Gennaro; 39Salio, Giuseppe; 161Salvagni de’ Roteri, Giovanni Battista;
136Salvagno, Pietro; 87Sandri, L.; 30, 66Sangro, Francesco; 132-133, 163Santi, Carlo; 185, 189Sarti, Giuseppe; 125, 128, 200Sartori, C.; 21, 55, 65, 69-70, 74-76, 79-
85, 99-101, 104, 108, 180, 236Sartorio, Antonio; 83, 104Sassoni, Assunta; 127, 179Savoia, Vittorio Amedeo III di; 231Savoldi Giovanni; 46Scaccia, Giuseppe; 85
INDICE DEI NOMI E DELLE ISTITUZIONI
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 506
507
INDICE DEI NOMI E DELLE ISTITUZIONI
Scalvini, M.L.; 63Scamozzi, Vincenzo; 63Scappi, Antonio; 52, 67, 70-71, 88, 96,
99-103, 108, 139Scarabello, G.; 43, 226, 235Scarpino, Antonio; 67Scauso, M.L.; 163Schiavini Trezzi, J.; 14, 20, 24, 45-46, 49,
51, 60, 83Schino, M.; 26, 38, 139, 147Scotti, famiglia; 238Scotti, Francesco; 122-123, 238Scotti, G.; 17Scotti, Giovanni Maria; 185, 188Secco Suardo di Sant’Agata, famiglia; 90Secco Suardo Grismondi, Paolina vedi
GrismondiSecco Suardo, Alessandro; 92Secco Suardo, Bartolomeo; 91Secco Suardo, Carlo; 110Secco Suardo, David; 61Secco Suardo, famiglia; 86, 88-94, 97-98,
109, 141-142, 225Secco Suardo, Francesco; 81Secco Suardo, G.; 86Secco Suardo, Galeazzo; 73Secco Suardo, Girolamo; 91, 204, 229Secco Suardo, Giuseppe; 22, 52, 78, 81,
86-88, 94, 96-98, 100-101, 106, 108,110, 139, 142, 225, 244
Secco Suardo, Lanfranco; 14, 22, 90Secco Suardo, Leonino; 191Secco Suardo, Ludovico; 85-87Secco Suardo, Ludovico di Carlo; 110Secco Suardo, Marco; 96Sedini, Teresa; 126Seiano, Elio; 83Selva, Giannantonio; 91Semenzi, Michelangelo; 81Semenzi, Michele vedi Semenzi, Miche-
langeloSEMINARIO DI BERGAMO; 46, 49, 148Serassi, Pier Antonio; 233Serena, A.; 143, 176Serlio, Sebastiano; 40Serra, P.; 131Sertor, Gaetano; 160, 200Silvani, Francesco; 181Simoncini, Francesca; 14Soffietti, Pietro; 224
Sografi, Antonio; 228Solza, Annibale; 48Solza, Girolamo; 73Somaschi, Carlo; 171Sozzi, Giorgio; 123Spini, Marc’Antonio; 185, 188Stefanini, Carlo; 46
Tadini, F.; 86Tajana, Giovanni; 65, 229Tanfani, C.E.; 133, 163Tanzi, Giuseppe; 174Targhetta, R.; 226Tasca, Tommaso; 185Tassi, F.M.; 137Tasso, Torquato; 39, 147-148Taviani, F.; 26, 38, 139, 147Terzi, Alessandro; 46, 148-149Terzi, Giovan Battista; 149Terzi, Nicola; 73Tessari, R.; 39Testaverde, A.M.; 10, 14, 106, 129, 135, 235Testi, Simone; 14Testi, Giovan Battista; 73Tironi, L.; 86Todi, Luigia; 227Tognetti, Sergio; 14Torelli, Gaspare; 67, 108Torri, Giacomo; 158Tosi, V.; 170Trento, Ottavio; 231Tresino, Teodoro; 67Trissino, Alvise; 41Trissino, Gian Giorgio; 39-40Tron, casata; 98
Ungarelli, Rosa; 181
Vaccaro, L.; 49Vailetti Salvagno, famiglia; 184Vailetti Salvagno, Francesco; 183Valerini, Adriano; 53, 147Valier, Giulio; 148Vallaresso, Zaccaria; 162Valle, Andrea; 112-113Valmarana, Leonardo; 132-133, 136, 217Valois, Carlo ottavo di; 160Varese, C.; 159Varò, Cornelio; 176Vecchi, Pietro; 113
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 507
508
Vecchietti, Strinato; 75Velo, Girolamo Giuseppe di; 41Vendramin, casata; 98Ventura, A.; 42Ventura, Comin; 45, 86, 147-149Verti, R.; 24, 132, 157, 161, 163, 227Vertova, Carlo; 218Vertova, Giovan Battista; 215-216, 219,
221-222Verzelli, Giovan Battista; 150Viale Ferrero, M.; 105Vicario, Francesco; 166Viganò, Onorato; 228, 236Viganò, Ottavio; 227Vignola, Angelo; 63Vignola, Ignazio; 166Vimercati Sozzi, Cristoforo; 114Vimercati Sozzi, fratelli; 120Vimercati Sozzi, Girolamo; 81Vimercati Sozzi, Marc’Antonio; 114Vimercati Sozzi, Paolo; 64, 120Vimercati, Ettore; 67Viscardini, Antonia; 127Vitalba, Angela; 130Vitalba, Filippo; 64Vitalba, Vincenzo; 167Vitali Rota, Giovan Battista; 57, 203, 208,
218, 223, 233-234
Vitaloni, Angelica; 101Volpe, Zavario; 229Volpi, L.; 51, 83
Walker, T.; 16, 22, 32, 99Willi, Andrea; 157
Zaghi, C.; 231Zanchi, Alessandro; 163Zanchi, Cristoforo; 185, 187, 188-189Zanchi, famiglia; 238Zanchi, G.; 49Zanchi, Girolamo; 73, 185, 189Zanchi, Vincenzo; 122, 239Zanella, V.; 63, 111Zanetti, R.; 35Zanotti, Giovan Antonio; 153Zenni, Ludovico; 79Zenucchi, Antonio; 92Zerbi, Luigia; 237Ziani, Pietro Andrea; 47-48, 79, 82Zinanni, A.; 53, 154Zoppa, Maria Teresa; 116Zoppi, Domno; 73Zoppi, Giovan Maria; 73Zorzi Garbero, E.; 51, 71Zorzi, L.; 16, 36, 51, 71Zuccato, Bartolomeo; 163
INDICE DEI NOMI E DELLE ISTITUZIONI
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 508
509
Alba Longa; 101Alessandria; 76
BASSANO; 29-30, 33-34Palazzo Pretorio; 33Teatro Brocchi; 98
Bayreuth (Germania); 70BELLUNO; 29-30, 33, 144, 227
Palazzo della Ragione; 33Teatro della Caminada; 33
BERGAMO; 5-7, 9, 16-27, 29, 41-43, 46-53,55-57, 60-61, 66, 69-70, 75-76, 78-85,87, 91, 94-95, 98-101, 103-104, 106,109-111, 113, 116, 118, 122, 124-125,127-133, 135, 139-140, 144-164, 172,174, 178-179, 181-183, 187-188, 191,193-194, 199-203, 208, 212, 216-217,220, 222-223, 225-227, 229-230, 232-235, 237, 239, 241-244Cattedrale di; 46, 149Chiesa di Santa Maria Maggiore; 47-48, 60, 80-81Misericordia Maggiore; 47-48Palazzo del Capitanio; 19, 23, 37,51, 54, 76, 111, 118, 128, 132, 139,240Palazzo del Podestà; 65-66, 86, 240Palazzo del vescovo; 59Palazzo della Ragione; 40, 51, 57, 59-64, 68, 70-71, 73, 76, 78, 84, 96, 100,108, 117, 124, 139, 141, 156, 202,231, 240-241, 246Palazzo Nuovo; 63-64, 67Palazzo Secco Suardo di via Corsa-rola; 87, 91
Piazza Vecchia; 66, 95, 141Sant’Agostino, convento di; 45, 59-60, 74Santa Marta, convento di; 174, 176-177Teatro Cerri; 57, 123, 246Teatro della Cittadella; 54, 57, 76-77,110-111, 119, 121-126, 128-129, 132-133, 136, 138-139, 141, 146, 158,161, 179, 191, 199-200, 231, 238, 246Teatro Donizetti; 5, 18, 201Teatro Riccardi; 18, 24, 56, 78, 115,122-123, 146, 161-164, 171, 176, 199-201, 209, 212, 217-218, 223, 228,238-239, 241, 245Teatro Secco Suardo; 19, 41, 51, 71,78, 85, 96, 98, 100-101, 103, 106,108, 109, 179, 182Teatro Sociale; 57, 86, 124, 241, 246
Biella; 145Bologna; 70, 76, 84, 101, 104, 125, 144-
145, 163-164, 236-237, 287, 318BRESCIA, 29, 30, 33-34, 53, 55, 69, 76,
101, 104, 131, 145, 150, 153, 237, 240Teatro degli Erranti; 26, 34, 74, 242Bressanone; 55, 74
Cadice (Spagna); 76Casale Monferrato; 76Conegliano; 99Corinto; 100-101Crema; 29-30, 33, 55, 66-68, 76, 81, 100,
103-104, 108-109, 140, 144-145, 180,235
Cremona; 70, 104, 145, 150
Indice dei luoghi
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 509
510
Fano; 70, 99FELTRE; 26, 29, 30, 33-34, 140
Palazzo della Ragione; 34Teatro della Senna; 34
Ferrara; 22, 53, 55, 84, 101, 104, 144,147, 149, 151-152, 237
FIRENZE, 75, 79, 101, 104, 160Teatro del Cocomero;74, 235Teatro della Pergola; 62
Francia; 144-145, 157, 174, 176, 226, 230,232-233, 236
GENOVA; 69-70, 83, 101, 145, 235Teatro Sant’Agostino; 55, 74
Ginevra; 145
Inghilterra; 145, 157Innsbruck (Austria); 69
LISBONATeatro di Salvaterra; 76
LIVORNO; 75, 101, 104Teatro San Sebastiano; 100
Lodi; 76, 104, 145, 163Londra, King’s Theatre vedi Londra, Tea-
tro RealeLondra, Teatro Reale; 104Lucca; 84, 101, 145, 287Lugo; 76Lurano; 22, 90
Macerata; 99Mantova; 17, 39, 55, 72, 76, 99-100, 104,
151, 239Messina; 104, 109, 144MESTRE
Teatro Balbi; 236MILANO; 22, 27, 55, 60, 67, 76, 69-70,
74, 76, 79, 81-82, 89, 99, 104, 108,123, 125, 130, 140, 145, 147, 156,160, 176, 179, 217, 232, 234-235,237Teatro della Scala; 91, 128, 227, 236Teatro Ducale; 69, 74, 76, 103Teatro Interinale; 55, 74Teatro Salone Margherita; 109
MODENA; 17, 100, 104, 163, 237Teatro Ducale; 85
Monte Albano; 101Monte Celio; 101
MURANOTeatro della Pescaria; 99
NAPOLI; 60, 69-70, 100-101, 104, 144,160, 163Teatro del Fondo; 163
Novi; 74
Olanda; 236
PADOVAPalazzo del Capitanio; 36Palazzo del Podestà; 36Teatrino del Recinto detto TeatroVacca;Teatro del Prato della Valle vedi Pado-va, Teatrino del RecintoTeatro dello Stallone;Teatro Nuovo della Nobiltà;Teatro Obizzi;Teatro Tavola;
Parma; 17, 22, 76, 101, 104, 108, 145,153, 162
PAVIA, 55, 76, 81, 104, 160Teatro Omodeo; 74
Piacenza; 76, 144-145Pisa; 101Pontevico; 131, 152
Ravenna; 144Reggio Emilia; 70, 76, 108, 144-145ROMA; 69, 99, 101-102, 104, 158, 160,
163, 288Teatro Argentina; 100, 104Teatro Capranica; 100Teatro della Valle; 162
ROVIGO, 29-30, 33-34, 42, 76, 99, 132,141, 144Teatro della Campagnella; 34, 98-99Teatro Manfredini; 35
San Pietroburgo (Russia); 48, 227Savona; 145SIENA; 101
Teatro degli Intronati; 70Svizzera, cantone di Glarus; 174
TORINO; 55, 74-75, 79, 135, 145Teatro Carignano; 159Teatro Regio; 76, 160
INDICE DEI LUOGHI
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 510
511
INDICE DEI LUOGHI
TREVISO; 29-30, 33-34, 141, 144, 236Teatro Dolfin; 98, 127Teatro Onigo; 98Teatro Santa Margherita; 98
UDINE; 29-30, 33-34, 70, 99-100, 104,135Teatro Contarini; 33Teatro della Nobile Società; 35Teatro della Racchetta; 35Teatro Mantica; 26, 34,Teatro Sociale; 35
Varese; 55VENEZIA; 17, 22, 26-27, 30, 33, 35, 57,
60, 75, 79-80, 84, 96, 98, 104,116, 122, 124-125, 127, 129, 140,144-145, 147, 161, 163, 184-189, 198,202, 207, 210-211, 216, 222-224,226, 227, 229-232, 234-236, 238, 244-245San Marco; 99, 154Teatro di San Giovanni Grisostomo;134Teatro Fenice; 91, 236Teatro Grimani; 70, 80Teatro Salvadore; 70Teatro San Cassiano; 74, 176Teatro San Luca; 133Teatro San Moisé; 55, 74Teatro San Salvatore; 83, 101, 104,135Teatro Sant’Angelo; 84, 161
Teatro Vendramin; 108Tribunale di; 115
Vercelli; 74-75VERONA; 29-30, 37-38, 55, 60, 75-76, 81,
99, 101, 118, 144- 145, 147, 153-154,221, 237, 241Nuovo Teatro Diurno in Cittadella;118Palazzo del Capitanio; 99Santa Maria antica; 59Teatro dei Temperati; 37-38Teatro del Palazzo del Capitanio; 99Teatro dell’Accademia Vecchia; 38Teatro dell’Arena; 38, 42, 74, 154Teatro dell’Isolo; 37Teatro della Cittadella; 118Teatro Filarmonico; 74, 242Teatro Prefettizio; 38
VICENZA, 29-30, 39, 41, 99, 101, 104,144, 237, 243Cortile di Ca’ da Porto; 40Palazzo della Ragione; 40Teatro Berico poi Teatro Garibaldi;41Teatro delle Garzerie detto Teatro diPiazza; 40, 98Teatro Eretenio detto anche NuovoTeatro;Teatro Olimpico; 39-40Teatro Tornieri detto Teatro delleGrazie; 40, 98
Vienna; 72, 84, 129Viterbo; 69, 287
Impaginato OK:Layout 1 23-04-2010 18:29 Pagina 511