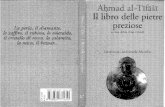Marketing virale: analisi di due pubblicità virali - Lauree e ...
Paratesto e pubblicità del privilegio (Venezia, sec. XV)
Transcript of Paratesto e pubblicità del privilegio (Venezia, sec. XV)
i
Angela Nuovo
PARATESTO E PUBBLICITÀ DEL PRIVILEGIO
(VENEZIA, SECOLO XV)
l paratesto delle edizioni a stampa riveste funzioni così comples-se che si potrebbe giungere a identificare in esso tutto ciò che fa sìche un testo possa diventare un libro, possa cioè divenire un oggetto
materiale tale da rendere possibile la fruizione, la lettura, il commercio, loscambio, la conservazione, la censura, la distruzione del testo stesso. Il pa-ratesto, oltre a dar forma all’edizione, immette il testo in un costellazionedi rapporti sociali, in una temporalità precisa, legata principalmente (manon esclusivamente) al momento della produzione del libro e della suaprima fruizione. Grazie a una serie di autorevoli interventi nonché a sva-riate indagini specifiche, la percezione dell’importanza del paratesto nellastoria del libro è andata molto crescendo. Tuttavia esiste ancora un aspettotanto diffuso quanto trascurato, la cui frequenza pare abbai fatto velo, pa-radossalmente, a una sua piena valutazione: la pubblicazione del privile-gio. Nella visione di Genette, il privilegio incarna perfettamente la feno-menologia di epitesto pubblico, ovvero di ciò che si colloca esternamenteal testo ma nei suoi immediati dintorni, e ne influenza la ricezione. � In più,al momento della sua pubblicazione, il privilegio viene a far parte inte-grante del peritesto editoriale. Parallelamente infatti all’affermazione del-l’istituto del privilegio, fondamentale per la tutela del commercio librarioe degli investimenti degli editori,2 prende forma l’idea di notificare la con-cessione della grazia sugli oggetti stessi (i libri) che fruivano della protezio-ne. Modi e forme di tale pubblicazione cambiano profondamente nei primidecenni di stampa, secondo un’evoluzione della quale si cercheranno dicogliere i primi passi.
� Una veloce schematizzazione delle caratteristiche dell’epitesto nella voce ad esso dedica-ta in Il paratesto, a cura di Cristina Demaria e Riccardo Fedriga, Milano, Bonnard, 200�, pp.��8-�20.
2 Non è qui la sede per proporre una storia dei privilegi librari, neppure per sommi capi.Mi sia consentito rimandare il lettore al capitolo �� (La tutela del commercio librario) del miovolume Il commercio librario nell’Italia del Rinascimento, nuova ed., Milano, Angeli, 2003, pp.�82-209, e soprattutto al capitolo 4 (Il sistema dei privilegi librari nel XVI secolo) del volume Ange-
la Nuovo, Christian Coppens, I Giolito e la stampa nell’Italia del XVI secolo, Genève, Droz, 2005,pp. �7�-2�2. In entrambi i testi si troverà ampia bibliografia precedente. Essenziale per il pre-sente lavoro è il riferimento a Renato Fulin, Documenti per servire alla storia della tipografiaveneziana, «Archivio Veneto», 22 (�882), pp. 82-2�2 (d’ora in poi: Fulin).
angela nuovo18
Lo scarso peso che il privilegio sembra rivestire nell’analisi del peritestoeditoriale riflette anche una tradizione bibliografica. Non solo la notizia del-la presenza del privilegio viene sistematicamente eliminata in tutti i princi-pali codici di catalogazione del libro antico,� ma persino nei grandi repertoriincunabolistici, quando il fenomeno si poteva osservare al di qua di ogni cri-stallizzazione, al momento della sua nascita, la notizia non viene fornita si-stematicamente.2 In ogni caso, nei repertori di incunaboli il testo del privile-gio effettivamente pubblicato è trascritto nella sua interezza solo se brevissi-mo (esattamente il contrario di quel che servirebbe). La secondarietà dell’in-formazione è pienamente rivelata dall’assenza di un’indicizzazione specifica:nessun catalogo, nessun repertorio, a mia conoscenza, indicizza le edizioniprivilegiate, raggruppandole solo per questo aspetto. L’aggiunta di immagi-ni digitali nei repertori può oggi aiutare il ricercatore, che però ritroverà lanotizia solo dove già sa di poterla rinvenire.3
Senza una solida base catalografica, la ricerca sistematica sulla presenza delprivilegio soffre sicuramente di imprecisione. Ben pochi interventi nell’analisistorico-bibliografica cercano di trarne una visione generale, a partire dalla casi-stica della pubblicazione.4 Eppure tale elemento è ineliminabile da un grannumero di edizioni, dato che la maggior parte delle principes durante l’AncienRégime venivano per l’appunto protette tramite la richiesta di questa conces-sione. La richiesta del privilegio è volontaria e certamente fin dalle origini re-golata da una procedura che prevedeva un certo esborso di denaro da parte delrichiedente. La natura dell’istituto del privilegio è tale per cui, infatti, solo unaparte, non mai quantificata, ma certo minoritaria, delle edizioni prodotte nepuò esibire uno: tra queste, principalmente, le prime edizioni di testi inediti.5
� Secondo il codice più in uso in Italia, sbn(a): «Si omettono senza segnalazioni espressionicome “ con licenza dei superiori” o “cum privilegio” e simili»: Marina Venier, Andrea De
Pasquale, Il libro antico in SBN, Milano, Editrice Bibliografica, 2002, p. 38. Nel codice statunitenseDescriptive Cataloging of Rare Books, Washington, Library of Congress, �99�2, si prescrive di inse-rire nelle note i ‘publication details’ come il privilegio, ma solo se li si considera importanti.
2 Come si constata facilmente alla consultazione di gw e bmc, che non adottano un com-portamento costante in presenza di privilegio. Solo h presenta una specifica sensibilità alproblema.
3 Mi riferisco principalmente al repertorio The illustrated ISTC on CD-ROM, a cura della BritishLibrary, Reading, Primary Source Media, �997. Non ho potuto purtroppo avere accesso allaseconda edizione.
4 A parte naturalmente il capitolo 7 (Display and advertisement of privileges) del volume diElisabeth Armstrong, Before Copyright. The French book-privilege system 1498-1526, Cambridge,Cambridge University Press, �990, pp. �40-�64. Si veda anche Annie Parent-Charon, La prati-que des privilèges chez Josse Bade (1510-1535), in Printers and Readers in the Sixteenth Century, ed. byChristian Coppens, Turnhout, Brepols, 2005, pp. �5-26.
5 Il concetto di novità che andava connesso obbligatoriamente alla richiesta si mise a fuo-co lentamente. Fu la Parte del �5�7 ad affrontare, insieme ad altri, questo tema. La raccolta
paratesto e pubblicità del privilegio 19
Il privilegio annullava la concorrenza, almeno per un numero di anni rite-nuto congruo al recupero dell’investimento. Consapevole di porre lo stam-patore privilegiato in posizione di vantaggio sui concorrenti, l’autorità pote-va riservarsi la facoltà di fissare il prezzo del libro, come si fece regolarmentein Spagna con la cosiddetta tansa: ecco perciò, in quel Paese, l’obbligatorietàdella pubblicazione del privilegio sui libri, contestualmente alla tansa ad essorelativa. L’uno senza l’altra infatti non poteva sussistere. �
Venezia invece, l’unico Stato che fin da primordi della stampa espresse inItalia una coerente politica dei privilegi con connessa legislazione,2 non ri-tenne di dover fissare il prezzo del libro insieme alla concessione del privile-gio, ma si limitò ad esprimere di tanto in tanto inviti all’indicazione di prezzigiusti. Il problema del prezzo equo era ovviamente chiaro ai richiedenti, cheimpegnandosi a una politica corretta su questo punto usavano l’argomento arinforzo delle loro richieste.3 Ma probabilmente ai governanti era noto cheun sano regime di concorrenza costituiva il primo fattore di equilibrio deiprezzi, e ogni ulteriore intervento avrebbe potuto danneggiare la fiorenteindustria tipografica lagunare.
Di fatto, non rivestendo la concessione del privilegio alcun interesse pub-blico, quale sarebbe la fissazione del prezzo, ma limitandosi a proteggere gliinteressi economici di soggetti privati (in primis dell’editore), non esisteva aVenezia e poi in Italia l’obbligatorietà della pubblicazione del privilegio sullibro. Una volta ottenuta la grazia, solo l’editore avrebbe tratto vantaggiodalla sua pubblicità: egli quindi risulta libero di porre in essere i mezzi piùefficaci alla diffusione della notizia. La pubblicazione sul libro è solo una dellepossibili soluzioni, e all’inizio non apparve spontaneamente la più efficace nél’unica percorribile.
La pubblicazione del privilegio sul volume, rientrando nelle opzioni para-testuali disponibili all’editore, assume perciò un valore considerevole nell’equi-
completa della legislazione veneziana sulla stampa emessa durante il secolo xvi è in Horatio
F. Brown, The Venetian Printing Press. An historical study based upon documents for the most parthitherto unpublished, London, J. C. Nimmo, �89�, pp. 207-222. Per la Parte del �5�7, vedi p. 74 ep. 505.
� Per la legislazione spagnola in materia, si veda Fermín de los Reyes Gómez, El libro enEspaña y America. Legislación y censura (siglos XV-XVIII), Madrid, Arco/Libros, 2000, 2 v.
2 Anche Milano fu attiva nel periodo incunabolistico nella concessione di patenti e privile-gi, ma non nell’emanazione di una legislazione riconoscibile in quanto tale. Roma svolsenella politica dei privilegi un ruolo fondamentale, ma in un periodo successivo.
3 Non mancano infatti affermazioni di questo tenore nelle suppliche: «offerendosi tamenvendere dicte opere pretio onestissimo, sì in grosso come menudo» (ovvero sia all’ingrosso cheal dettaglio), scrive Matteo Codecà chiedendo privilegio per varie opere nel �494 (Fulin n. 34);nel chiedere il privilegio per importanti edizioni giuridiche, Bernardino Landriano promettevadi non abusarne, vendendo le copie «più care a li studenti, come fano alcuni»: Fulin n. 5�.
angela nuovo20
librio dei diversi fattori costitutivi l’identità di mercato di un libro. L’editorepoteva pubblicare o meno la «gratia» nell’edizione, citarla sul frontespizio onel colophon, trascriverla per intero oppure limitarsi a una veloce menzione,ricordarne le caratteristiche di durata e le pene connesse, oppure affermaresoltanto che la concessione c’era. Lentamente alcune tipologie costanti dipubblicazione sembrano prendere piede, ma si tratta pur sempre di un equi-librio dinamico. Nel mondo del libro a stampa non esistono segreti, e unaformula ritenuta brillante ed efficace viene subito ripresa dai concorrenti,alla costante ricerca di elementi in grado di fornire al proprio prodotto lemigliori caratteristiche di vendibilità, visibilità, risonanza.
Dalla concessione alla pubblicazione
Data la difficoltà di identificare le edizioni privilegiate traendole dai reperto-ri, si è quindi pensato di legare l’analisi storica della pubblicazione del privile-gio alla serie dei privilegi editi da Renato Fulin spogliando le serie del Nota-torio del Collegio, del Notatorio dei Capi del Consiglio dei Dieci e degli Attidel Senato (Terra) presso l’Archivio di Stato di Venezia.� La Serenissima fuinfatti tra le prime amministrazioni a concedere privilegi di stampa, sullafalsariga dei privilegi di invenzione o sfruttamento che si concedevano dasecoli.2 La serie fornita da Fulin occupa un lasso di tempo notevole (�469-�526), e a tutt’oggi è la più ampia pubblicata. Lo stesso studioso curòun’identificazione tra privilegi ed edizioni effettivamente prodotte; a dispet-to della scarsità di repertori allora disponibili, la qualità del suo lavoro biblio-grafico è eccellente, al punto che ben poco si può correggere o integrareoggi.3 Il magnifico lavoro di Fulin costituisce il punto di partenza più affidabi-le per osservare l’evoluzione storica del fenomeno della pubblicazione delprivilegio, a partire dalla certezza (archivistica) dell’avvenuta concessione.
Si sono perciò esaminati un centinaio incunaboli, corrispondenti ai pri-vilegi nn. �-73 di Fulin.4 L’analisi si ferma al �497, prendendo in considera-
�R. Fulin, Documenti per servire …, cit.
2 Al proposito dei quali, si vedano: Roberto Berveglieri, Inventori stranieri a Venezia, 1474-1788: importazione di tecnologia e circolazione di tecnici artigiani inventori. Repertorio, Venezia,Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, �995 e, dello stesso autore, Le vie di Venezia. Canalilagunari e rii a Venezia: inventori, brevetti, tecnologia e legislazione nei secoli XIII-XVIII, Sommacam-pagna (Verona), Cierre, �999.
3 Si può ad esempio sanare la mancata identificazione del privilegio n. 44 con igi 245�, dovutaal fatto che Fulin trascrive erroneamente «Bernardino Rasma» anziché «Rasina», e che questonome, del concessionario del privilegio nonché finanziatore dell’edizione, compare solo nelladedica. Ugualmente non è scattata l’identificazione del privilegio n. 59 con igi �550.
4 La maggior parte di tali incunaboli sono stati esaminati autopticamente presso le biblio-teche Nazionale Braidense, Ambrosiana e Trivulziana di Milano, Nazionale Centrale di Roma,Statale di Cremona, i cui bibliotecari ringrazio per la cortese collaborazione. Ringrazio cor-
paratesto e pubblicità del privilegio 21
zione il primo affermarsi dell’istituto del privilegio di stampa, in un arcocronologico che presenta la copertura bibliografica più garantita. � Inol-tre, a partire dal �498 anche in Francia si iniziò a concedere privilegi distampa (che poi diverranno vero e proprio sistema stabilizzato intorno al�509), 2 dunque dopo quella data l’evoluzione dell’istituto, soprattutto perl’aspetto della pubblicazione, non è più fatto esclusivamente venezia-no.
La repertoriazione degli incunaboli consente oggi di sapere quante copiedi ogni edizione vengono conservate nelle biblioteche pubbliche di tutto ilmondo. È una visione generale altamente istruttiva (benché essa ovviamen-te, per l’assenza delle copie attualmente in mani private, non possa dirsi esau-stiva), in particolare nella prospettiva che anima la presente indagine. A unconfronto con la serie dei privilegi pubblicati da Fulin, è facile infatti rendersiconto che, nella maggior parte dei casi, le edizioni privilegiate sono quelle dicui si conservano più copie: indicazione, sia pure indiretta, di tirature alte, didistribuzione programmata efficacemente, insomma di prospettive di mer-cato. Dunque il privilegio veniva richiesto in occasione di edizioni con mag-gior ambizioni del consueto, o per le quali gli investimenti erano stati mag-giori: si tratta perciò di una piccola parte delle edizioni che pure ne avrebbe-ro avuto diritto.
Altresì chiaro è il fenomeno della richiesta di protezione non per un deter-minato testo, ma per il suo peritesto editoriale; in altre parole, la consapevo-lezza che è quest’ultimo a fornire il valore aggiunto all’impresa. Commenti,naturalmente; tavole e indici; ma anche, molto spesso, disegni geometrici ediagrammi marginali, atti all’esemplificazione del calcolo.
Dopo un avvio molto lento, al punto che i primi due privilegi sono separa-ti da diciassette anni, negli anni Novanta si assiste a un incremento assai velo-ce delle richieste. Sulla base del numero delle pratiche perfezionate, ovverodi privilegi ufficialmente concessi e registrati, ognuno dei quali contiene fre-quentemente privilegi per più di un’edizione, il numero di concessioni rad-doppia e poi triplica all’interno dello stesso decennio, l’ultimo del Quattro-cento. Questo è però soltanto l’avvio, perché nel Cinquecento tale istitutovedrà una rigogliosa affermazione e sarà alla base, in tutta Europa, del disci-plinamento della stampa nel settore della tutela degli interessi economicidegli editori.
dialmente il dott. Silvano Groff che ha effettuato per me alcuni controlli sulla formidabilecollezione incunabolistica (soprattutto di ambito giuridico) conservata presso la BibliotecaComunale di Trento.
� Infatti, decorrendo spesso un intervallo di uno o più anni tra la concessione e la realizza-zione dell’opera, per i privilegi posteriori la realizzazione si viene talvolta a collocare in etàpost-incunabolistica. 2 E. Armstrong, Before Copyright…, cit., p. 206.
angela nuovo22
I primi tre privilegi concessi, per altro celeberrimi, si inscrivono in trecasistiche differenti. Il primo (Fulin n. �), rilasciato a Johannes de Spira il �8settembre �469 è un vero privilegio «pro arte introducenda» e concede alsoggetto l’assoluta esclusiva dell’esercizio della nuova arte a Venezia inquanto ne è il riconosciuto importatore nello Stato. Il secondo e il terzofurono invece concessi a due autori per due specifiche loro opere: all’uma-nista Marc’Antonio Sabellico, il �o settembre �486, per la sua opera Decadesrerum Venetarum (igi 8487, Fulin n. 3), � e al Magister memoriae Pier FrancescoTomai da Ravenna, il 3 gennaio �492, per la sua Phoenix seu De artificiosamemoria (igi 7666, Fulin n. 4). Non è qui la sede per analizzare nel dettagliole differenze intercorrenti tra le tre diverse concessioni, che hanno comun-que in comune il tratto della mancanza del termine di validità, sintomodell’ancora incerto trattamento dell’istituto. Basterà almeno accennarequale sensibilità la Serenissima dimostrasse fin dall’inizio per la figura del-l’autore, tanto da riconoscere ad essa il privilegio letterario ben prima chequello di stampa divenisse di routine.
È invece da sottolineare che, stando alle edizioni stampate, verremmo asapere dell’esistenza del privilegio solo per quanto riguarda la Phoenix. NéJohannes de Spira, nell’unica edizione realizzata in validità di privilegio tota-le, né Marc’Antonio Sabellico, pensarono infatti di dover comunicare pubbli-camente, tramite l’oggetto stesso della protezione accordata cioè il volumeprivilegiato, l’esistenza della concessione.
Solo Tomai, il maestro della memoria, 2 ebbe questa idea, un piccolocolpo di genio che lo rende autore del primo esempio di uso del parate-sto (e quindi, del libro stesso) come notifica del privilegio. 3 Il privilegioviene pubblicato nella sua integrità documentaria, completo delle illustrifirme che lo hanno votato. La pubblicazione integrale serve innanzi tuttoper chiarire le proibizioni ai concorrenti, già formalizzate in quelle chesaranno le caratteristiche dell’istituto per parecchi decenni: divieto distampare e far stampare l’opera, o di venderla stampata da altri, sotto lepene enumerate; simmetricamente, libertà dell’autore di scegliere lo stam-patore cui affidare l’impresa con facoltà di trasferire su di lui l’esclusiva dicui è titolare (Fig. �).
� Non è un caso che Sabellico, autore di un’opera di spiccato interesse locale, pensasse aneutralizzare la concorrenza locale e ad assicurarsi nel contempo il ricco mercato del domi-nio che comprendeva città come Padova e Verona.
2 A proposito di questa interessante figura, si veda Giorgio Montecchi, Autori e iniziativeeditoriali in una città senza tipografie: Ravenna in età veneziana, in Id., Il libro nel Rinascimento.Saggi di bibliologia, Milano, Ed. La storia, �994, pp. �65-�83, con bibliografia.
3 Phoenix è davvero la prima opera stampata a includere il privilegio; fu infatti pubblicatail �0 gennaio del �492. L’altra edizione stampata nel �492 con privilegio (igi 780, Fulin n. 5) èinfatti del �9 luglio.
paratesto e pubblicità del privilegio 23
Privilegio e paratesto finale
Appare quindi per la prima volta la pubblicità del privilegio sul libro protet-to.� La posizione prescelta da Tomai è quella del paratesto finale, e l’esempiosarà seguito subito da molti altri stampatori. È chiaro che il colophon, o co-munque le parti finali del libro, costituiscono ancora la sede ideale in cui ilettori e gli acquirenti erano abituati a trovare i dettagli relativi alle circostan-ze della pubblicazione, secondo quella che era anche la tradizione mano-scritta precedente. L’invenzione e poi affermazione del frontespizio è un pro-cesso non rapido.2
� A rigore, la prima in assoluto ebbe luogo a Milano, nell’edizione Bettino da Trezzo,Letilogia, Milano, Antonio Zanotto, [dopo il �0.iii.�488], igi 9722 : ma la curiosa forma pre-scelta per la pubblicazione (traduzione in versi volgari della lettera ducale) non crea unvero precedente nella pubblicità del privilegio, almeno stando al suo sviluppo storico aVenezia. Si legga al proposito Emilio Motta, Di Filippo di Lavagna e di alcuni Tipografi-Edito-ri milanesi del quattrocento (nuovi documenti), «Archivio Storico Lombardo», �0, Fasc. �9,(sett. �898), pp. 28-72.
2
Lorenzo Baldacchini, Aspettando il frontespizio, Milano, Bonnard, 2004.
Fig. �.
angela nuovo24
La pubblicazione integrale del testo del privilegio, attuata da Tomai, sirivelerà invece poco usuale, pur non essendo affatto rara, e induce l’impres-sione, almeno nel lettore di oggi, che ad essa si volesse conferire anche unacerta solennità, legata al riconoscimento da parte del Senato della qualità edei meriti dell’opera e quindi, alla fin fine, un ulteriore valore pubblicitario edi mercato. In questo senso, a un secondo livello di lettura, la pubblicità delprivilegio, almeno come la concepì l’intraprendente Tomai, si rivolge ancheal lettore-acquirente. Di fatto però, nel suo mimetismo grafico del documentodi segreteria, rimane prima di tutto attestazione del possesso del rilascio,perseguendo lo stesso obiettivo che oggi si otterrebbe allegando una copiaconforme all’originale.
I volumi pubblicati pochi mesi dopo da Bernardino Rizzo a spese di Gio-vanni Domenico del Negro, � che aveva chiesto e ottenuto il privilegio (Fu-lin n. 5) presentano la pubblicazione del privilegio ancora nel paratesto fina-le. Ma per la prima volta appare una versione abbreviata del rilascio, quindisi opera un’ulteriore mediazione tra la realtà del documento e il destinata-rio della notizia. In essa, si specifica la titolarità (del Negro), l’esclusione aiconcorrenti nella città di Venezia e in tutto il dominio veneto di produzio-ne e di vendita (di copie altrove stampate), e per la prima volta si precisa ladurata (dieci anni). Il testo è inserito in un continuum vero e proprio con ilcolophon dell’opera, soluzione graficamente interessante che di certo sot-tolinea l’appartenenza del privilegio alla dimensione giuridica dell’edizio-ne.Impressum Venetijs opera Bernardino Riçi de Novaria, emendatumque per excel-lentissimum artium et medicine doctorem dominum magistrum Dominicum deCanali Feltrensem. Impensa vero excellentissimi artium et medicine doctoris domi-ni magistri Ioannis Dominici de Nigro, qui obtinuit ex speciali gratia a serenissimodominio Venetiarum quod nemini quicumque fuerit liceat tam hic Venetijs quam inuniversa ditione veneto imperio subiecta imprimere sive imprimi facere hoc volu-men: aut alibi impressum in predicta ditione vendere per decem annos sub penaimmediate et irremisibilis amissionis omnium similium librorum. Et preterea libra-rum quinquaginta pro quolibet volumine: que quidem pena applicetur recupera-tioni Montis Novi.2
� Su questa innovativa figura di medico-editore-libraio, si vedano Myriam Dal Zio Billa-
novich, L’attività editoriale di Giovanni Domenico del Negro e i Consilia di Angelo da Castro, «Qua-derni per la storia dell’Università di Padova» �5 (�982), pp. �07-��3 e A. Nuovo, Il commerciolibrario…, cit., p. �66.
2 L’edizione è: Santes de Ardoynis, De venenis, Venezia, Bernardinus Rizus, Novariensis,per Johannes Dominicus de Nigro, �9.vii.�492, igi 780. Il colophon è a c. [�06]r. La stessa solu-zione grafica verrà adottata per la successiva edizione, protetta dallo stesso privilegio: Abbas
Haly, Liber medicinae, sive Regalis dispositivo, Venezia, Bernardinus Rizus, Novariensis, perJohannes Dominicus de Nigro, 25.ix.1492, igi 4644.
paratesto e pubblicità del privilegio 25
Non va però dimenticato che ancora una volta il motore della richiesta delprivilegio e quindi della sua pubblicazione è, se non un autore, un intellet-tuale prestato all’imprenditoria tipografica, che qui agiva come acquirentedei manoscritti originali. Non sono quindi i veri e propri stampatori, ma gliautori, o comunque gli intellettuali, a richiedere i primi privilegi e a farnemenzione nelle loro edizioni. Questo naturalmente non toglie che gli stam-patori colsero velocemente le opportunità dell’istituto e la necessità di unasua ampia notifica a mezzo del libro a stampa; e agli uomini del mestiere sideve infatti l’evoluzione successiva della pubblicità del privilegio.
Il �492 è l’anno in cui la concessione del privilegio diventa meno ecceziona-le, pur rimanendo assai inconsueta. Al contrario di quel che si cercherà difare in seguito, il privilegio fu concesso anche ad uno stampatore padovano(che lo ottenne anche grazie alle insistenze del Rettore dell’Università, Fulinn. 7), tanto che il 24 maggio del �493 l’edizione degli aristotelici Parva natura-lia con il commento di Tommaso d’Aquino (igi 837) uscirono a Padova conun esplicito avvertimento rivolto ai concorrenti. In fine al volume, infatti,ma stavolta ben separato dalle note tipografiche, si legge un avviso che èpiuttosto una chiara diffida (Fig. 2):Noverit omnes quod supernominatus huius voluminis opifer videlicet Magister Hie-ro. Durante obtinuit de speciali gratia ab Illustrissimo venet. Dominio ut neminiliceat per se vel per alium tam Venetiis quam in universo venet. Dominio imprimereaut imprimi facere dictum volumen, at alibi impressum in terris dicti dominij ven-dere per annos x a die suprascripta sub irrevocabili pena perdendi omnes libros. Etulterius solvendi ducatos quingentos quorum tertia ad accusatorem vel repertoremapplicetur, tertia ad magistratum vel officium cui hoc erit denuntiatum, tertia veroad ipsum magistrum Hiero. opificem devolvatur.
Rispetto alle precedenti pubblicazioni di privilegio, la funzione di notifica edi ammonizione si è molto accentuata. È stato rilevato anche da ElisabethArmstrong, nel suo studio sui privilegi francesi, il fatto che il tono con cui glistampatori veneziani comunicano, sui libri, l’avvenuta concessione, ha unacoloritura decisamente aggressiva, piuttosto minatoria, cosa che non accadein Francia.� Forse le condizioni della concorrenza portavano a simile atteg-giamento, riflesso d’altra parte anche nelle pene pecuniarie, assai pesanti, incaso di inosservanza. Il fenomeno d’altronde trova origine nelle concessionistesse, perché la pena prevista dall’Amministrazione, che per questo aspettosi limitava, probabilmente, a concedere il richiesto, era andata sempre au-mentando: le 25 lire di multa per ogni copia abusiva nel caso della Phoenix,erano divenute 50 per le concessioni a Del Negro, �00 nel privilegio a Benali,e qui assurgono alla ragguardevole cifra di 500 ducati forfetari a carico di
� E. Armstrong, Before Copyright…, cit., p. 5 e p. �55.
angela nuovo26
colui che stamperàabusivamente l’opera,indipendentementedal numero delle co-pie. Anche la divisio-ne in tre parti dellamulta, che poi diven-terà la prassi, sembraqui comparire per laprima volta : prece-dentemente solo unamagistratura pubblicaavrebbe goduto del-l’importo della multa;ora la multa è divisa intre, per cointeressareil funzionario che daràluogo alla procedura esoprattutto «accusato-rem vel repertorem», ildelatore insomma,una figura tradizional-mente gratificata nel-
la legislazione veneziana. Un ultimo aspetto merita attenzione. La durata,dieci anni, è per la prima volta specificata come decorrente dalla data ‘so-prascritta’ ovvero dalla data del colophon, quindi dalla realizzazione del li-bro, e non dalla concessione. Dettaglio non irrilevante, dato che potevanopassare anni dalla concessione alla realizzazione e ciò darà origine ben pre-sto al fenomeno dell’incetta dei privilegi, contro il quale il Senato Venetolegifererà nel �5�7.
Nel frattempo, è giusto ricordare che, in numerosi casi, la concessione delprivilegio non dà origine ad alcuna pubblicazione sul volume.� Talvolta lapubblicazione del volume avviene prima della concessione del privilegio, equindi non può legalmente portarne menzione.2 Ma certamente erano in
� Ad esempio, nel caso del privilegio n. 9 di Fulin, richiesto da Paganino de’ Paganini per lapubblicazione della Bibbia con il commento di Nicolò di Lyra (igi �69�), un’edizione che oggipresenta un’elevatissima sopravvivenza degli esemplari. Nessuna pubblicazione di privilegioanche sulle edizioni corrispondenti ai privilegi n. �2 (igi 7�7 e 2522), �3 (igi 5822), �4 (igi 3539), �8(igi �2��), edizioni disparate per genere e impegno.
2 Cosa che invece avverrà tranquillamente nel Cinquecento, tanto scontata era ormai di-venuta la concessione del privilegio.
Fig. 2.
paratesto e pubblicità del privilegio 27
uso altri modi di pubblicità del privilegio, come la distribuzione di copie delrilascio tra i concorrenti anche sotto forma di lettere circolari, ovviamente aspese del titolare; del privilegio veniva infatti non solo fatta la registrazione,ma anche rilasciata una copia ai richiedenti. A Milano il privilegio veniva‘gridato’ e probabilmente anche a Venezia esistevano forme di pubblicazio-ne di questo tipo.� Di fatto, era necessario che la notizia circolasse soprattut-to in città, in uno spazio ristretto benché assai affollato, e quindi, anche se illibro era privo di tale notizia, il privilegio poteva ugualmente essere risaputoagli altri stampatori. In più, era importante fermare la concorrenza al piùpresto, prima che il libro fosse prodotto e pubblicato. Che l’osservanza deidivieti non fosse pacifica e generalizzata è dimostrato non solo dal non esi-guo fenomeno delle edizioni prodotte in violazione di privilegio ma anche, alivello documentario, dalla ripetuta richiesta che il privilegio venisse intima-to dalle stesse magistrature che l’avevano concesso, come supplicò AntonioMoretto nel �499.2
La prima edizione in volgare ad ottenere il privilegio risale al �493 (Fulin n.�7). Si tratta del volgarizzamento di Sebastiano Manilio delle Epistolae ad Lu-cilium di Seneca (IGI 8865). L’edizione, pubblicata il �4 Aprile �494 dai fratellidi Nallis, presenta, in un testo unico con il colophon, la pubblicazione del pri-vilegio, per la prima volta in lingua volgare (Fig. 3).
La pubblicazione del privilegio in lingua volgare segnala una precisa sceltadell’editore: infatti la concessione originaria era, come di regola, in latino.Dal punto di vista linguistico, la raccolta di Fulin dimostra che i privilegivennero rilasciati in latino quasi costantemente fino al �494 (le suppliche in-vece potevano essere spesso in volgare); da questa data, le concessioni co-minceranno ad essere rilasciate in volgare, il che significa che sarà cura dellostampatore tradurle in latino sulle proprie edizioni, rimanendo per tutto ilQuattrocento privilegi stampati in volgare del tutto eccezionali. Si capisceche la proibizione doveva essere chiara a tutti, in quanto anche nei territoriove il divieto di stampare non avrebbe avuto validità, doveva però esser no-tificato il fatto che il libro, altrove stampato, non poteva essere importato neldominio di Venezia.
Tra i pochi privilegi per opere in volgare si segnala il privilegio chiesto (inlatino) dall’editore Pietro de Benali per l’opera Dell’arte militare di AntonioCorazzano (Fulin n. �9), pubblicata ovviamente postuma, nel �493 (igi 3�97).Questa volta il privilegio inizia per la prima volta a spostarsi dalla sua posi-
� Nel �505 la lettera patente concedente il privilegio per dodici diverse opere in favore deifratelli Da Legnano veniva «gridata et pubblicata ad scala pallatii Broleti communis Mediola-ni et ad et per omnia Carubia portarum Civitatis Milani»: Guido Sutermeister, Gli editori «daLegnano», 1470-1525, Varese, Tip. arcivescovile dell’Addolorata, �946-�948, p. 247.
2 Fulin n. 92.
angela nuovo28
zione finale, e siinstalla nel parate-sto preliminare: inparticolare, al ver-so del frontespizio,alla fine delle dedi-ca, dopo una rigadi intervallo.
Incomenza la operade miser AntonioCornazano de l’artemilitare che fa stam-par miser pre’ PieroBenayo el qual ha pergratia da la Illustrissi-ma S. de Venesia cheper anni x. niuno al-tro la possi stamparene stampata per altriin le sue terre vendersotto pena de ducativinticinque per ogniopera et de perdere ledicte opere la qualepena la terza parte siade l’Arsenal de Vene-sia, l’altra terza partesia de lo Hospedal dela pietà, l’altra terzaparte sia di esso mi-ser pre’ Piero supli-cante.
Ma intanto, le cruciali opportunità offerte dal privilegio in ordine alla riuscita del-l’operazione commerciale cominciano ad essere chiare agli editori, ai veri e propriimprenditori del libro. Il primo a farne richiesta in modo sistematico è Lazzaro deSoardi, che dal �494 (Fulin nn. 2� e 22) inaugura anche l’usanza della richiesta nonper un titolo o due, ma per un gruppo consistente di opere.� La mancanza di san-zioni per la mancata realizzazione dell’opera privilegiata si avverte in questo primoaccumulo e nella crescente percentuale di titoli non realizzati.
Fig. 3.
� Su Soardi si può consultare la monografia di Dennis Rhodes, Annali tipografici di Lazzarode’ Soardi, Firenze, L. S. Olschki, �978, che comunque non tratta questo aspetto.
paratesto e pubblicità del privilegio 29
La forma di pubblicazione prescelta da Soardi inizia anch’essa a offrire ele-menti di standardizzazione: collocata in fine volume, in chiusura del colophon,menziona la presenza del privilegio come mero promemoria: «Cum privile-gio nequis audeat hoc opus imprimere citra decem annos: sub pena in eo-dem contenta».� Evidentemente la minaccia di pene pesanti (in questo caso,25 ducati per copia) è già nota ai concorrenti, o almeno così Soardi sembracredere. Aperte comunque rimangono varie opzioni. Lo stesso Soardi, inoccasione della pubblicazione del testo di Terenzio commentato da GuidoGiovenale, anticipa la posizione paratestuale della notifica fino a c. 6v, conl’intestazione Ad lectorem.2
Progressivamente, gli editori diventano più efficienti nella pianificazionedelle edizioni e nella richiesta dei privilegi. Della lunga lista di protezionirichiesta da Gregorio de’ Gregori nel �494 (Fulin n. 29) non tutto verrà realiz-zato; vale comunque la pena di constatare che in occasione della pubblica-zione della Logica di Alberto Magno (igi 202), il privilegio verrà per la primavolta incorporato non nel colophon ma in un lungo testo di carattere spiccata-mente pubblicitario, come si desume facilmente dall’indirizzo al lettore («Nul-lum habebas Candidissime lector impressum…»). In più, il lungo testo verràcollocato sul frontespizio, a seguire il titolo vero e proprio, e con l’uso di undifferente carattere tipografico non solo a rimarcare la discontinuità, ma pro-babilmente anche a imitare graficamente l’originale della segreteria ducale,ove naturalmente non si usava il gotico, viceversa ancora irrinunciabile per iltitolo di un testo universitario. Si tratta perciò del primo caso, a quanto mirisulta, di privilegio pubblicato sul frontespizio (Fig. 4).3
� Esempio tratto da Johannes Gritsch, Quadragesimale, Venezia, Lazarus de Suardis,2�.iii.1495, igi 4499, Fulin n. 22. Tipologia di pubblicazione ripetuta da Soardi per esempio inoccasione della pubblicazione, nel �497, dei Sermones quadragesimales di Jacopo da Varazze, igi
5060.2
Publius Terentius Afer, Comoediae. Comm: Donatus; Guido; Calphurnius, Venezia,Simon Bevilaqua, per Lazarus de Suardis, de Saviliano, 20 Feb. �494, igi 946�.
3 L’esempio verrà seguito in pochissime altre occasioni, come nell’edizione Johannes de
Sancto Geminiano, Liber de exemplis ac similitudinibus rerum, Venezia, Johannes and Grego-rius de Gregoriis, per Stephanus e Bernardinus de Nallis, �0 Apr. �497, igi 5355. Anche qui lanotizia del privilegio ottenuto (Fulin n. 60) è incorporata in un lungo testo esplicativo-pub-blicitario, smorzando in definitiva il potere informativo-dissuasivo del solo privilegio. Piùoriginale, autobiografica, la formula adottata da Giacomo Britannico nell’edizione Gabriel
de Barletta, Sermones quadragesimales et de sanctis, Brescia, Jacobus Britannicus, �497-98, igi
4�09, in cui, dopo il titolo (Sermones fratris Gabrieli Barerete) si legge: «Cum ego Jacobus Bri-tannicus horum sermonum impressor industria mea hi sermones in lucem venerint. Ut sump-tus meos redimere possim impetravi ab excellentissimo Venetorum senatu ne quis alius pos-sit preter me eos ab hinc ad decem annos imprimere aut alibi impressos in dominio suoapportare, sub pena amissionis librorum ac decem aureorum pro quolibet opere solvendo-rum ut continetur in privilegio mihi concesso» (seguono le firme dei Magnifici Consiliarii).
angela nuovo30
L’innovazionetuttavia non venneseguita, segno chene non fu compre-sa l’efficacia. Lagrande edizionedegli Specula diVincent de Beau-vais, attuata daglieredi di HermannLiechtenstein nel�494 in quattro vo-lumi (igi �03�2,�03�7, �0322, �0325)pubblica solo in uncaso il privilegio,nello Speculum hi-storiale (igi �03�7).�
Tre dei quattro vo-lumi erano infattigià pubblicati almomento dell’ot-tenimento dellagrazia. Il colophondel quarto includeun’ampia informa-zione del privilegioottenuto, spe-cificando che essova esteso ai volumiprecedenti.
In seguito la pubblicazione sembra confermarsi nella posizione finale, contesti che possono essere alquanto estesi, ricordando specificità dei divieti edelle multe (come nel caso dello Specchio della fede di Roberto Caracciolo, igi
2507), o anche tornare alla pubblicazione integrale del privilegio, con la stes-sa impaginazione proposta in passato dalla Phoenix di Tomai, ovvero con ilprivilegio seguito dal marchio della stampatore. Sembra insomma che ognieditore segua i modelli allora già sperimentati, ma che la pubblicazione ten-da a divenire più comune.
Fig. 4.
� Il privilegio fu concesso il 3 settembre �494 ai commissari ed eredi di Liechtenstein, ma lastampa è assegnata a quest’ultimo dai repertori.
paratesto e pubblicità del privilegio 31
Emergono abitudini aziendali. Uno stampatore di intensa attività comeGiovanni Tacuino, specializzato nella pubblicazione dei classici latini con icommenti degli umanisti, ricorre preferibilmente alla pubblicazione integra-le del testo del privilegio, completa dei nomi dei nobili firmatari, sia in fine,dopo il colophon, come avviene nella sua edizione dell’Ars amandi di Ovidiocon il commento di Bartolomeo Merula (�494, igi 7056),� o di Giovenale concommenti di Calderini, Valla e Mancinelli (�498, igi 5602, Fulin n. 37), sia anti-cipandola nei preliminari, dopo la dedica, come avviene nella sua edizione diCatullo con commento di Palladio Fusco (�496, igi 26�7, Fulin n. 45).2 Insiemealla pubblicazione per esteso della concessione, che comunque è fenomenoattestato ancora nel pieno Cinquecento, si fa evidente anche la ricerca di unafrase sintetica che indichi la presenza del privilegio, facendo implicito appel-lo all’esperienza dei concorrenti al riguardo delle caratteristiche dell’istituto.Gli scritti retorici di Cicerone con i commenti di Maturanzio e Vittorino sonopubblicati di Filippo Pincio l’8 luglio del �496 (igi 2972) chiudendo il colophoncon la semplice formula «cum privilegio ne quis audeat imprimere usque adannos decem sub pena in eo contenta». Nello stesso �496 si legge per la primavolta l’enunciazione con l’incipit poi canonico «Cum gratia & privilegio de-cem annorum ne imprimatur neque cum Commentariis neque sine & caete-ra quae in ipso privilegio contenentur».3
Iniziano quindi a ricorrere le stesse opzioni: nessuna pubblicazione (solu-zione ancora molto diffusa), pubblicazione riassuntiva delle caratteristichefondamentali del privilegio in fine (Fulin nn. 52, 53, 54 via via fino al privilegio72, ovvero all’edizione igi 89��), con una formula che chiaramente esprimal’esistenza di un impedimento e di un divieto rivolta a coloro i quali intenda-no stampare lo stesso testo,4 e infine pubblicazione più estesa, al limite com-pleta, in posizione paratestuale ancora non fissa. Se la pubblicazione è inte-grale, essa ha sede preferibilmente nel fascicolo dei preliminari, insieme alla
� Fulin n. 24. In questo caso esiste una discrepanza tra la notizia fornita da Fulin, ove ilrichiedente e titolare risulta essere Merula, e il testo del privilegio pubblicato sull’edizione, anome di Tacuino.
2 In quest’ultimo caso, il privilegio era stato concesso al commentatore padovano cheperò aveva indicato fin dalla sua supplica lo stampatore (Tacuino) cui avrebbe fatto realizzarel’opera.
3 Fulin n. 48. L’edizione (Vicenza, Henricus de Sancto Ursio, �6 Dic. �499) è tra le pochissi-me con privilegio non stampate a Venezia, ma la concessione era stata chiesta e ottenuta nondallo stampatore, ma da Girolamo Biondo e Giambattista suo compagno. Girolamo Biondo,personaggio importante nella stampa di questi anni ma dai contorni ancora indefiniti, avreb-be gravitato a Venezia nell’entourage dei Giunti (Aldo Manuzio tipografo 1494-1515, catalogo acura di Luciana Bigliazzi, [et al.], Firenze, Octavo-Franco cantini editore, �994, pp. 45 e 7�-73).
4 Una delle più ricorrenti è «cum privilegio ne quis audeat imprimere usque ad annosdecem sub pena in eo contenta» (Fulin n. 36, igi 2972).
angela nuovo32
dedica. Occasionalmente, si trova il privilegio anche in fine dedica, comenell’edizione dei Sermones di Roberto Caracciolo (igi 245�, Fulin n. 44) firma-ta da Giorgio Arrivabene il �6 maggio �496.�
Tra il �496 e il �497 la pubblicazione del privilegio sulle edizioni si fa in-dubbiamente più frequente.2 Desta quindi una certa sorpresa che uno deigrandi editori del periodo, Ottaviano Scoto, nella sua ampia produzione rea-lizzata in società con Boneto Locatello, pur richiedendo privilegi in modomassiccio e sistematico, non ne faccia mai menzione sui libri. Uno straordi-nario sforzo produttivo fu attuato per la programmazione e poi la pubblica-zione in tempi molto stretti di un’intera serie, quasi una collana, di testi difilosofia e medicina, comprendenti opere di Mesue, Serapion, Argelata, Rha-sis, Savonarola, Montagnani, Dino del Garbo, Guainerio, e molti altri, tutticon la stessa impaginazione a due colonne e lo stesso carattere gotico (Fulinn. 67). I diciassette titoli per i quali Locatello chiese ed ottenne il privilegiofurono tutti stampati nel giro di un paio d’anni;3 dunque il progetto venneperfettamente realizzato. Ma chiaramente l’assenza della menzione del pri-vilegio sui libri sta a significare che persistevano mezzi altrettanto efficaci perla notifica ai concorrenti.
I tempi erano comunque maturi per la prima vera svolta. Il �0 marzo del�499 fu pubblicato dai fratelli de’ Gregori per l’editore Guglielmo Pincio,un’edizione giuridica, nella quale sia nel frontespizio che nel colophon eraaggiunta la sintetica avvertenza Cum privilegio.4 Giungere a tale sintesi nonpuò che significare che il lettore, il concorrente anzi, è pienamente in gradodi sviluppare da questa sola affermazione tutte le sue conseguenze.
� «Obtentum fuerit privilegium ab Excellentissimuo & Illustrissimo Dominio Vene-torum quod nullus existentium sub prefato Dominio valeat vel presumat ipsum impri-mere, vel imprimi facere, aut alibi impressum vendere in terris eiusdem, usque ad annosdecem proxime futuros: pena amissionis librorum et centum librarum pro qualibet vicecontrafacientibus imminente: et aliis quam plurimis pro ut in ipso privilegio latius con-tinetur» (c. 2r).
2 Anche Sabellico, detentore del primo privilegio concesso (e non pubblicato sul libro), sicomporterà in tutt’altro modo, ottenendo nel �497 il privilegio per le sue Enneades (3�.iii.1498,
igi 8489): lo pubblicherà nella sua integrità sull’ultima carta del volume.3 Si tratta di igi 5229, 343�, 3078, 3080, 468�, 785, ��06, 3590, 4508, 498�, 6392, 6699, 835�, 8350,
88�3, 8924. Del Luminare maius in medicina pure compreso nel privilegio non sembrano rima-ste copie.
4
Justinianus. Institutiones, Venezia, Johannes and Gregorius de Gregoriis, per GulielmusPincius, �0 Mar. �499, igi 5523. Il frontespizio (epigrafico) legge: «Instituta cum multis additio-nibus / a precipuis: et neothericis docto / ribus extractis: et suis locis / pro textuum etglosarum / veritate enucleando / opportune appo / sitis: noviter / impressa / Cum privile-gio». Il colophon: «Impressum venetijs opera Joannis et Gregorij de Gregorijs fratrum. Im-pensis vero Guielmi pincij astensis. Anno a nativitate domini �499 die �0 Marcii. Cum privile-gio».
paratesto e pubblicità del privilegio 33
Verso il frontespizio
I due massimi editori italiani (Aldo Manuzio e Luc’Antonio Giunta) che ini-ziarono la loro attività in quest’ultimo decennio del Quattrocento nutrironoben pochi dubbi nei confronti dell’importanza del privilegio, nonché dellasua notifica sulle edizioni. Nel periodo preso in considerazione sta infatti ilprimo privilegio, richiesto e concesso ad Aldo Manuzio. È quello per le sue«lettere greche», rilasciato il 25 febbraio �495 (Fulin n. 4�), vero e proprioprivilegio industriale che gli assicura per 20 anni lo sfruttamento della pro-pria invenzione (il suo nuovo carattere greco). Di fatto però tale privilegiopuò essere reso effettivo solo applicandolo ad ogni edizione greca prodottada Aldo. È ciò che avverrà, a partire dall’Organon di Aristotele del �°.xi.�495
(igi 79�), ove il privilegio verrà stampato (ovviamente in latino, per renderlocomprensibile a tutti) in chiusura di edizione, e il titolare definito «Aldo in-ventori» (Fig. 5). Notevole anche la formula adottata da Manuzio, con l’inci-pit «Impetratum est» che è la sua preferita, tanto più in quanto la supplica, ilcui contenuto è accettato dal privilegio, è scritta in volgare.
Non solo le edizioni greche di Aldo recheranno sempre nel colophon lamenzione del privilegio, ma tale concessione verrà ricordata anche quandorilasciata agli autori, come nel caso dei Diaria de bello Carolino di AlessandroBenedetti ([�496], igi �460, Fulin n. 50) nella cui ultima pagina si legge la frase«Impetratum est ab Illustriss. S. Veneto ne liceat cuiquam has ephemeridasimprimere nec latino sermone nec vulgario &c. ut in privilegio». Sempreattento a stampare sul libro la notizia del privilegio, Aldo Manuzio, tra glistampatori più sensibili alla tutela giuridica del suo operato, sarà forse tra iprimi a cogliere la novità della pubblicazione sul frontespizio e a portare asua volta con chiarezza e sintesi la notizia sulla pagina del titolo. Ciò avverràper la prima volta nel �499, in due occasioni. La prima, nel luglio, con lastampa della Cornucopia di Perotti (igi 7428), ove si menziona alla fine deltitolo la protezione concessa «vocabulorum ordine, a nobis nuper invento»;�
e la seconda volta, nel dicembre, nel celeberrimo ed elegantissimo frontespi-zio dell’Hypnerotomachia Poliphili, (igi 3062) ove si legge, nella stessa letteracapitale del titolo, «Cautum est, ne quis in dominio Ill. S. V. impune hunclibrum queat impprimere [sic]».2
Giungiamo così a una conclusione. Sono i privilegi che vengono rilasciatitra la fine del �497 e l’inizio del �498 ad approdare sui volumi seguendo queltipo di formalizzazione che poi diventerà canonica, ovvero con la semplice
� Non è noto l’originale di tale privilegio, ma nella serie di Fulin, proprio il n. 89 (serie diprivilegi ad Aldo Manuzio, per vari testi, rilasciati il 6 dicembre �498) risulta incompleto.
2 I due frontespizi sono riprodotti in Aldo Manuzio tipografo …, cit., pp. 63 e 69.
angela nuovo34
citazione «Cum privi-legio» sul frontespizio,distaccata dal titoloper rilevarne l’impor-tanza e la diversa na-tura.� L’instaurazionedefinitiva della formu-la si deve probabil-mente a Luc’AntonioGiunta, alle prese datempo nel tentativo difarsi largo nel redditi-zio settore delle edi-zioni liturgiche vene-ziane grazie alla suaforza industriale. Èun’operazione ingrande stile ad adotta-re massicciamente lanuova formula. Dallafine del �498 Giuntapubblica, con la colla-borazione dell’eccel-lente tipografo JohannEmerich da Spira, unaserie di edizioni conprivilegio : prima ilMartyrologium Roma-num, in 4° (�498, igi
6254) e poi soprattut-to le due gigantesche edizioni musicali in folio del Graduale Romanum (il pri-mo volume datato 28 sett. �499, gli altri �500, igi 4357),2 dell’Antiphonarium
Fig. 5.
� Per dare un’idea del diverso ritmo di evoluzione, ovvero di spostamento dal colophon alfrontespizio con connessa affermazione della formula sintetica, la canonica frase cum privile-gio comparirà in Francia sui frontespizi a partire dal �508, e l’innovazione si deve ad AntoineVérard (E. Armstrong, Before Copyright…, cit., p. �4�).
2 Graduale Romanum (Ed: Franciscus de Brugis), Venezia, Johannes Emericus, de Spira,per Lucantonio Giunta, 28.ix.�499; �4.i.�499/�500; �°.iii. �500, igi 4357. Approfondita descri-zione in Mary Kay Duggan, Italian Music Incunabula: printers and type, Berkeley, Los Angeles,Calif., Oxford, University of California Press, �992, pp. 207-208 e in Giuseppe Massera, Lamano musicale perfetta, di Francesco de Brugis. Dalle prefazioni ai corali di L. A. Giunta, Venezia,1499-1504. Firenze, Olschki, �963, pp. 28-33.
paratesto e pubblicità del privilegio 35
Romanum (�50�-02 circa, gw 206�),� di dimensioni prima mai viste, veri monu-menti tipografici.2 La connessione tra i tre titoli è stabilita dal frontespizio,stampato in rosso, del Graduale ove è chiarito che un unico privilegio proteg-ge le tre edizioni: « Impressum Venetiis cum privilegio concesso cum quoetiam imprimunturantiphonarium etpsalmista sub pena utin gratia» (Fig. 6).3
Si tratta in effetti diuna concessione otte-nuta da Tommaso ve-neto, personaggionon altrimenti iden-tificato, al quale vienerilasciato un privilegioil 5 marzo del �497 perl’Antifonario, il Gra-duale e il Salmista incoro (Fulin n. 64). 4
L’Antiphonarium, rea-lizzato però qualche
Fig. 6.
� Antiphonarium Roma-num. Ed : Franciscus deBrugis. [Venezia, JohannesEmericus, de Spira, per]Lucantonio Giunta, [circa�50�-02], gw 206�. G. Mas-
sera, La mano musicale …,cit., pp. 3�-33.
2 «They were multivo-lume editions in a largefolio size (565 x 383 mm),the largest paper used foran incunabulum. The twoworks, the Graduale Romanum and its companion title the Antiphonarium Romanum, togethercontain �.2�8 pages, almost all with printed music»: M. K. Duggan, Italian music Incunabu-la…, cit., p. �30).
3 Esiste una variante del frontespizio (G. Massera, La mano musicale …, cit., p. 28) ma chenon pregiudica ruolo e disposizione della pubblicazione del privilegio.
4 Sarebbe bello sapere di più di Tommaso di Venezia, forse in rapporti costanti con Luc’An-tonio, dato che già nel �495 aveva ottenuto il privilegio (Fulin n. 38) per edizioni poi in realtàprodotte da Luc’Antonio, come Ovidio in volgare (igi 7�28) e Livio in volgare e in latino (igi
5786). Tali edizioni non recano comunque notizia di privilegi.
angela nuovo36
anno dopo, sintetizza ormai chiaramente sul frontespizio la formula «Cumgratia et privilegio». A quell’epoca però la dicitura «cum privilegio» avrà tro-vato una sua diffusione, che annovera tra le altre le edizioni di Giovan Batti-sta Sessa (Lucianus, Vera historia, �500, igi 5844) e la serie dei commentari diGiason del Mayno editi da Bernardino Stagnino (igi 5995, 6004, 6007, 60�0),sempre del �500. Da questa convenzione ormai diffusa e comune, la pubblica-zione paratestuale dell’ottenimento della grazia riprenderà il suo camminocinquecentesco.
Concludendo, il frontespizio e, prima di questo, il colophon, sono le sediparatestuali investite della funzione di presentare le notizie sulla specificaidentità dell’edizione: luogo e data di pubblicazione, editore e tipografo re-sponsabile, spesso anche il suo marchio in grado di veicolare visivamentesignificati particolarmente rilevanti per l’orientamento della clientela. Talinotizie costituiscono, come è stato detto da Roger Chartier, la realtà delmercato, che va ad affiancarsi talvolta alla realtà del patrocinio (più spessoreperibile nei preliminari del libro, sotto forma di dedica) e alla realtà princi-pale dell’oggetto, ovvero quella della paternità letteraria dell’autore e del-l’identità (ovvero dell’argomento) dell’opera. La prima di tali realtà, quelladel mercato, esplicita «le indicazioni proprie del regime dell’editoria»: traqueste ultime, la menzione del privilegio è «segno dell’autorità».� In questaschematizzazione, Chartier si ispira da vicino al lavoro di Roger Laufer ilquale, discorrendo per l’appunto dello spazio visivo del frontespizio e dellasua evoluzione nei primi due secoli di stampa, afferma che «le marchands’adresse au pouvoir par le privilège, au public par son adresse et sa marque,au lecteur en tant qu’acheteur par son avis».2
Quanto visto fin qui invita però a riconsiderare tali definizioni, pur sugge-stive. Non pare infatti che la pubblicazione del privilegio, sul libro, possaindirizzarsi al potere, ovvero all’amministrazione concedente, nemmenometaforicamente. Sarebbe in questione il riconoscimento dell’autorità, comepare credere Chartier? O la messa in scena dei rapporti sociali e legali posti inessere dall’editoria nel suo farsi, come adombra Laufer? Forse entrambe que-ste interpretazioni non sono atte a cogliere la sostanza della pubblicazione.
La pubblicazione del privilegio sul libro ha infatti una precisa finalità, tipi-ca del sistema editoriale dell’epoca: quella della notifica ai librai concorrentidell’avvenuta concessione, con implicita (o esplicita) diffida della contraffa-zione, ovvero del «fare contro» quanto concesso al titolare, in forza dell’ec-cezionale «gratia». La pubblicazione quindi informa del contenuto sostan-ziale del privilegio, quello di impedire agli altri di stampare lo stesso libro per
�Roger Chartier, L’ordine dei libri, Milano, Il Saggiatore, �994, pp. 59-6�, in part. p. 59.
2
Roger Laufer, L’espace visuel du livre ancien, in Histoire de l’édition française, vol. i: Le livreconquérant, Paris, Promodis, �982, pp. 579-60�: 584.
paratesto e pubblicità del privilegio 37
un certo numero di anni: lo «jus prohibendi» o «excludendi». Essa perciò èindirizzata non all’autorità che ha concesso il privilegio, ma ai soggetti suiquali fa valere i suoi effetti. Il contenuto principale della concessione non è,come troppo spesso si ripete, il diritto di stampare in esclusiva, dato che idiritti non si concedono. Il privilegio conferisce allo stampatore/editore lafacoltà di stampare lui solo, e soltanto lui, una certa opera per un certo nu-mero di anni, fornendo sostanzialmente la garanzia temporanea di un mer-cato protetto, quello coincidente con l’estensione territoriale dell’autoritàche rilascia il privilegio, dove inoltre è parimenti proibito importare edizionidello stesso testo stampate altrove. La funzione di vera e propria notifica aiconcorrenti è certo prevalente, ma anche i lettori potevano essere richiamatiall’attenzione su questo punto, anche perché esisteva un preciso ruolo rico-nosciuto (e remunerato) per colui che denunciava le violazioni, il quale pote-va non essere un professionista del mondo del libro.
Il ruolo di notifica ai concorrenti, piuttosto che di messa in scena di rapportipreferenziali con il potere o di autorizzazioni prestigiose, sembra confermatodalla circostanza che, negli esemplari di dedica, il privilegio spesso veniva eli-minato.� Poteva essere sconveniente, donando un oggetto al quale si eranoconferite caratteristiche uniche (come ornamentazione e legatura), ricordarecon la pubblicazione del privilegio che quell’oggetto non era altro che uno deitanti, e che l’investimento attuato nella produzione era così ingente da avermeritato la protezione legale. Una copia destinata a non incontrare il mercatonon necessitava di quelle cautele delle quali veniva dotata proprio per difender-la dalla concorrenza. Pubblicazione del privilegio da una parte, e distribuzionee mercato dall’altra, sono due facce della stessa medaglia.
Abstract
Fin dai primi privilegi concessi a Venezia nel Quattrocento, gli editori e i librai fece-ro uso dei libri stessi per rendere noto a un vasto pubblico l’ottenimento del privile-gio, e quindi l’esistenza di una particolare protezione commerciale della singolaedizione. Il presente articolo analizza forme e modi di tale pubblicazione, ne rico-struisce il passaggio progressivo dal colophon al frontespizio e infine ne precisa natu-ra e finalità comunicative.
Starting with the first printing privileges in 15th-century Venice, publishers and book-sellers used books to communicate to a large public the attainment of the privilege,and thus the existence of a certain legal protection for the single edition. The presentarticle analyses the forms of display and advertisement of the privilege, reconstructsits passage from the colophon to the title-page, and, lastly, specifies its communica-tive nature and aims.
� E. Armstrong, Before Copyright…, cit., pp. �60-�64.