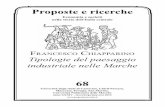Esposizione ad amianto e mortalità per tumore maligno della pleura in Italia (1988-1994
Novara 1926: la città e la grande Esposizione agricola, zootecnica, industriale
Transcript of Novara 1926: la città e la grande Esposizione agricola, zootecnica, industriale
Storia in Lombardia, anno XXXI, n. 3, 2011
Ricerche
NOVARA 1926: LA CITTÀ E LA GRANDE ESPOSIZIONE
AGRICOLA ZOOTECNICA INDUSTRIALE*
di Massimiliano Savorra
La provincia in mostra
«L’Esposizione di Novara, Egli ha detto, rappresenta indubbiamente la sinte-si della complessa attività di questa provincia che, strappata per volere e valore del Fascismo all’ozio bolscevico, ha ripreso in breve tempo il suo meraviglioso cammino ascensionale»1. Così, riportando il pensiero del Duce, il giovane Italo Balbo – prima di essere protagonista di una ben più importante esposizione americana2 – interveniva a Novara il giorno dell’inaugurazione (il 5 settembre 1926) come rappresentante del governo e plaudiva la “fiorente” agricoltura e la “promettente” industria della provincia italiana3. Proseguiva Balbo:
* Documenti, immagini, testi d’epoca, relazioni a stampa e giornali sono stati reperiti all’Archivio di
Stato di Novara (Asn), all’Archivio storico della Camera di commercio di Novara (Asccn), alla Biblio-teca centrale del Politecnico di Milano (Bcpm), e soprattutto alla Biblioteca civica Carlo Negroni di Novara (Bccnn). Per la gentilezza e la disponibilità dimostrate, ringrazio sentitamente il personale di tutte le istituzioni su menzionate.
1. S. E. Balbo ringrazia e plaude, in «Esposizione agricola zootecnica industriale», 8 settembre 1926, s.n.p.
2. Cfr. Lodovico Spada Potenziani, L’Italia all’Esposizione mondiale di Chicago, Roma, G. Mena-glia, 1933, passim.
3. All’inaugurazione intervennero, oltre a Balbo e al comitato dell’Esposizione, il prefetto Decio Cantore, il viceprefetto Fronteri, il presidente della Commissione reale provinciale Trichero, il commis-sario prefettizio di Novara, il general Ferrario comandante della Divisione militare, il monsignor Castel-li, vescovo di Novara, il barone Basile, segretario provinciale della Federazione fascista, i senatori Bol-lati e Fracassi, gli onorevoli Alice, Buratti, Gray, Mecco, Olmo, Peroni, Ponti, Rossini, il commissario prefettizio di Vercelli generale conte Nasalli Rocca, il generale Perol della Milizia di Torino, il colon-nello dei carabinieri Eichelburg, il console Rizzoli, il presidente del tribunale Bonelli, il procuratore Marchisio, il provveditore agli studi Renda, il commendatore Rinaldo Panzarasa, il grande ufficiale Bruhgera, il professor cavalier Morengo, l’ingegner Beldì, Romano Cocchi per la Federazione delle corporazioni sindacali, il cavalier Steiner, podestà di Varallo e segretario degli Enti autarchici, il com-mendator Erba, sindaco di Pallanza e il cavalier Andreoletti. Cfr. Inaugurandosi l’Esposizione, in «La Provincia di Novara», 3 settembre 1926; I trecento Gagliardetti fascisti ed i quattrocento Gonfaloni
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
M. Savorra
97
L’appello del Duce per la battaglia economica trova presenti nei ranghi gli agricoltori novaresi fierissimi, degni di tanto condottiero. La vostra Esposizione è veramente il quadro della vostra attività produttiva. Da esso si rileva che qui né la fiorente agricoltu-ra, né la promettente industria sostano mai […] Il rappresentante del Governo non si sofferma tanto a rilevare il valore materiale della Mostra, che apparve evidente a tutti, quanto l’altissimo valore morale, perché qui si può constatare dove può giungere il la-voro fecondo, disciplinato secondo di dettami del Fascismo4.
Concepito nell’autunno del 1925 dai soci del Comizio agrario5 e in seguito
organizzato da un comitato di autorevoli cittadini presieduto dall’ingegnere, fu-turo podestà, Filippo Oddone Mazza6, l’ambizioso evento del 1926 segnò un periodo di incubazione in cui si cercava di mettere a confronto il ciclo degli af-fari con l’immaginario, non solo simbolico, delle piccole-medie città del paese, come Novara, cresciute senza precedenti nei primi anni del Novecento. L’Esposizione di Novara diventò così occasione per mostrare le iniziative che
Municipali della Provincia s’inchinano a S. E. Balbo, tempra magnifica d’Italianità, che rappresenta il Governo ed il Partito all’inaugurazione della nostra esposizione, in «L’Italia giovane», 4 settembre 1926. Si veda anche La “Provincia operosa” celebra la sagra della produzione e del commercio nella solenne cerimonia inaugurale, in «Corriere di Novara», 7 settembre 1926; L’inaugurazione dell’Esposizione, in «La Provincia di Novara», 10 settembre 1926; L’inaugurazione dell’Esposizione, in «L’Ossola», 11 settembre 1926; Terre vercellesi alla mostra di Novara, in «Rinascita», 17 settembre 1926; L’on. Balbo inaugura la magnifica Esposizione di Novara, in «L’Italia giovane», 11 settembre 1926; L’Esposizione di Novara, in «L’Italia giovane», 25 settembre 1926. Inoltre, il Comitato incaricò il tecnico Rossarola di Torino di “cinematografare” oltre che la cerimonia inaugurale, anche tutte le mo-stre dei padiglioni e i vari festeggiamenti. Cfr. L’inaugurazione dell’Esposizione, in «La Gazzetta di Novara», 4-5 settembre 1926.
4. S. E. Balbo ringrazia e plaude, in «Esposizione agricola zootecnica industriale», 8 settembre 1926, s.n.p. Concluso il suo discorso, Baldo ripartì nel pomeriggio dall’aerodromo di Cameri per volare verso Venezia. Piccoli echi di cronaca dell’avvenimento furono pubblicati per tutta la durata della mani-festazione su «La Gazzetta del popolo di Torino», «Corriere di Torino», «L’Assalto di Vercelli», «Se-sia» di Vercelli, «Corriere di Novara», «Il Popolo d’Italia», «Il Momento» di Torino, «La Gazzetta di Novara». Altre segnalazioni e recensioni apparvero nei giorni seguenti su «Il Cittadino d’Asti», «La Ri-nascita», «L’Italia giovane», «L’Ossola», «La Provincia di Novara». In tutte si rimarcavano i caratteri e le attrattive di una vera e propria esposizione nazionale, più che provinciale.
5. Resisi conto di un considerevole fondo cassa avanzato, i soci del Comizio agrario proposero l’idea della manifestazione, che venne subito accolta dagli altri enti (Comune, Provincia, Camera di commercio e Consorzio agrario). Cfr. La caratteristica Esposizione di Novara illustrata dalla “Gazzetta del Popolo”, in «Corriere di Novara», 31 agosto 1926. Il resto del finanziamento avvenne anche con contributi dei singoli cittadini mediante una sottoscrizione rimborsabile di obbligazioni da L. 50 e da L. 100.
6. Il comitato esecutivo era composto da Oddone Mazza, dal consigliere delegato Guido Acerbi, dal segretario Ettore Torti, dal presidente del Comizio agrario Emilio Massara (anche commissario straor-dinario della Camera di commercio), dal presidente del Consorzio agrario cooperativo di Novara Carlo Faà, da Giulio Carnevale, commissario dei Sindacati degli agricoltori fascisti della provincia, da Aldo Acerbi, amministratore della Banca Popolare di Novara. Cfr. Esposizione agricola zootecnica industria-le di Novara, Catalogo Ufficiale (5 settembre - 15 ottobre 1926), Novara, Stabilimento tipografico E. Cattaneo, 1926. Il comitato aveva fissato la sua sede al palazzo della Camera di commercio in Via Avo-gadro. Cfr. La grande Esposizione agricola zootecnica industriale di Novara, in «Bollettino del Comi-zio agrario novarese», a. V, 1925, n. 12, p. 5.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
Novara 1926: la città e la Grande Esposizione agricola zootecnica industriale
98
il regime stava varando in quel periodo su scala nazionale in campo economico e sociale (la battaglia del grano, le bonifiche, la nuova legislazione nazionale), e per presentare la “fascistizzazione” di realtà e istituzioni già esistenti come l’Opera nazionale combattenti o il movimento cooperativo. Dal punto di vista organizzativo, in questo modo l’evento doveva seguire, per volontà del comita-to, i criteri, all’epoca considerati razionali, usati nelle coltivazioni e nelle a-ziende agricole.
Come le grandi esposizioni universali, fin dal secolo precedente – come ha scritto Carlo Olmo7 – metafora esclusiva del progresso o della classificazione, anche le manifestazioni “periferiche”, come quella novarese, rappresentano in-teressanti soggetti di studio, capaci in primo luogo di restituire i frammenti del-la società di provincia dei primi venti anni del Novecento, finora poco conside-rati nelle analisi di crescita urbana. Inoltre, va considerato che l’Esposizione di Novara – del tutto assente nelle riviste di architettura dell’epoca e nelle disa-mine storiografiche – fu caratterizzata dall’impegno economico di una vivace piccola-media industria, la quale – con l’occasione del clima frivolo dell’evento mondano – mise in gioco forme e tecniche della comunicazione d’impresa, con la creazione di “macchine” architettoniche ideate per informare. Retoriche di strapaese, enfasi delle élites che ambivano a tessere trame influen-ti non solo in provincia, eloquenza delle immagini e delle iconografie ufficiali (come il manifesto di Marcello Dudovich)8, benché limitate nel loro raggio d’azione, erano evidenti nei padiglioni ideati con l’obiettivo di esibire i riflessi della nuova congiuntura politica.
Gli espositori che aderirono all’iniziativa furono 8179: va osservato, in effetti, che nell’area novarese si era consolidato un tessuto industriale, già robusto negli anni precedenti l’avvento del fascismo, disseminato nell’intero territorio: nell’Alto Novarese l’industria siderurgica, mineraria, chimica ed elettrica; nel Verbano quella tessile, chimica e cartaria; nel Cusio stabilimenti di siderurgia,
7. Linda Aimone, Carlo Olmo, Le esposizioni universali 1851-1900. Il progresso in scena, Torino, Al-
lemandi, 1990, p. 9. Sul tema delle esposizioni in Italia, la letteratura è assai vasta; comunque, per una vi-sione di sintesi, si rimanda a Mariantonietta Picone Petrusa, Maria Raffaela Pessolano, Assunta Bianco, Le grandi esposizioni in Italia 1861-1911. La competizione culturale con l’Europa e la ricerca dello stile na-zionale, Napoli, Liguori, 1988; Maria Cristina Buscioni, Esposizioni e “stile nazionale” (1861-1925). Il linguaggio dell’architettura nei padiglioni italiani delle grandi kermesses nazionali ed internazionali, Fi-renze, Alinea, 1990; Le Esposizioni del 900 in Italia e nel mondo, Napoli, Liguori, 1991.
8. Utilizzata come immagine ufficiale in locandine e catalogo, l’illustrazione di Dudovich è riprodot-ta per la prima volta – insieme a uno schizzo di Crippa dell’arco di ingresso – nel periodico mensile «L’Industria zootecnica novarese», organo del Comitato zootecnico provinciale dei Novara, nel numero di marzo 1926, che esponeva il programma e il regolamento generale.
9. Cfr. In margine all’Esposizione, in «La Gazzetta di Novara», 11-12 settembre 1926. Da questo numero sulla rivista cittadina si inaugura una rubrica sugli eventi quotidiani della manifestazione.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
M. Savorra
99
meccanica e utensileria; nella Bassa imprese agricole e industrie varie (solo nel 1927 con la costituzione della Provincia di Vercelli si persero settori industriali di rilevante valore, come quello del Biellese). Basti pensare, inoltre, che al cen-simento industriale del 1927, nella provincia novarese soltanto gli esercizi indu-striali nel settore tessile erano 172 con 25.704 addetti (oltre un terzo degli opifici erano ubicati a Novara, Galliate e Intra), e nel settore cartario vi erano 28 stabi-limenti e 107 aziende tipografiche con 2.807 lavoratori nel complesso10.
Tra stagionale fiera di paese ed eccezionale sagra mercato (Guido Bustico scriveva che doveva essere considerata al pari di una “festività cittadina”)11, l’Esposizione – aperta al pubblico dalle 8 del mattino fino alle ore 24, e ordina-ta da un rigido regolamento generale12 – si caratterizzò dunque per le grandi “vetrine” industriali e per il fitto calendario di mostre d’arte (spiccava la sezio-ne futurista)13, rassegne e congressi organizzati con un orgoglioso obiettivo propagandistico. Che fossero dedicati alla bachicoltura, all’enologia e alla viti-coltura14, i congressi – tenuti in buona parte al Teatro Coccia – divennero il motore attrattivo di un pubblico colto, proveniente da tutta Italia, interessato non solo ai momenti ludici come le mostre canine, le manifestazioni sportive, i
10. I dati sono riportati in Umberto Chiaramonte, Economia e società in provincia di Novara durante
il fascismo 1919-1943, Milano, FrancoAngeli, 1987, p. 210. Dello stesso autore si veda anche Il sistema produttivo del novarese durante il fascismo, in Novara fa da sé, a cura di Adolfo Mignemi, atti del con-vegno (Belgirate 1993), Novara, Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nel No-varese e nel Verbano, Cusio, Ossola “Piero Fornara”, 1999, pp. 125-135.
11. Guido Bustico, L’Esposizione agricola zootecnica industriale, in «L’Industria zootecnica nova-rese», a. VII, 1 gennaio 1926, p. 2.
12. Cfr. Esposizione agricola zootecnica industriale di Novara, Programma e regolamento, Novara, G. Parzini, 1926.
13. Cfr. Esposizione agricola zootecnica industriale Novara, Mostra d’Arte. Catalogo, Novara, Stabi-limento Tipografico E. Cattaneo, 1926. Tra i 93 pittori in mostra: Arada. Bosso, Gazzone, Garrone, Ma-linverni, Rinzi, Lampugnani, Bruni, Bozzalla, Delleani, Miradio, De Benedetti, Vanzaghi, Palestrini, Bigli, Serra, Bagnati, Boffa, Ubertalli, Bozino, Aimone, Calderini, Verno, Contini, Gilardi-Mazza, Ra-vello, Ceratto, Vertice, Fazzone, Ravaglione, Ferrero. Tra i 9 scultori: Pecora, Cattaneo, Cantone, Cap-pellan. Inoltre vi erano anche delle sezioni dedicate alla fotografia, all’arte applicata, alle scuole e alle piccole industrie. Nella sala 8 riservata ai futuristi esponevano Caligaris, Fillia, Curtoni, Farfa, Pozzo, Ferinando, Zucco, Costantini, Martinola, Carrascosa, Casanova, Reycend, Solaro, Biroli, Talman. Si veda anche Mostra d’arte all’Esposizione di Novara, in «Corriere di Novara», 3 agosto 1926; Pittori e scultori all’Esposizione di Novara, in «La Provincia di Novara», 15 ottobre 1926. Alcuni quadri furono acquistati dalla Camera di commercio di Novara. Si veda la delibera del 6 ottobre 1926 del commissario straordinario della Camera di commercio conservata in Asccn, Deliberazioni del Commissario governa-tivo straordinario.
14. I temi affrontati nei congressi furono: La bachicoltura e l’industria della seta (G. Pigorini), Im-portanza e funzione delle cantine sociali in Italia (G. Freidman), Come aumentare il consumo del vino in Italia (G. Dalmasso), Intorno all’avvenuta ricostituzione del vigneto novarese (C. Fabiani), Alleva-mento e coltivazione moderna della vite (M. Cacciatore), Associazione dei viticoltori, per la coltivazio-ne industriale del vigneto (B. Balsari). Cfr. Congresso nazionale agrario all’Esposizione, in «L’Italia giovane», 13 ottobre 1926.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
Novara 1926: la città e la Grande Esposizione agricola zootecnica industriale
100
concorsi vari (ippici, ciclistici, floreali, frutticoli, orticoli, di bellezza) o gli spettacoli organizzati invece nel grande salone teatro15. A latere, una grande mostra didattica fu organizzata anche dal prestigioso Istituto geografico De Agostini, fiore all’occhiello dell’industria novarese, che portava a conoscenza del grande pubblico le più importanti produzioni cartografiche ed editoriali. I-noltre, il grande evento fu il motore in città di altre iniziative e piccole mostre, come quella della “Scuola nuova”, organizzata nelle aule dell’istituto “Galileo Ferraris” in Corso D’Azeglio, in cui tutte le scuole del circondario della pro-vincia esponevano i materiali prodotti dagli studenti e i risultati della didattica rinnovata dalla riforma gentiliana16.
A fare da guida alla mostra, e allo stesso tempo, da giornale di tutti gli even-ti, venne edita la rivista «Esposizione agricola zootecnica industriale», pubbli-cata settimanalmente dall’8 settembre al 17 ottobre 1926, e promossa dalla pic-cola industria locale e da istituti bancari per divulgare le attività in corso nell’intero territorio provinciale17. La rivista nacque grazie agli editori “compi-latori” Pietro Grassi della Camera di commercio, e don Andrea Pagani18, ma soprattutto grazie al sostegno del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Novara, società anonima a capitale illimitato, con sedi e succursali in nume-rose località. Peraltro, il Consorzio pubblicava anche il periodico «Cooperazio-ne e agricoltura», che si affiancava, nei giorni dell’Esposizione, alla rivista uf-ficiale. Tra gli istituti bancari (la Cassa di risparmio delle province lombarde e la Banca popolare di Novara) sostenitori della rivista e dell’intero evento spic-
15. Nel grande salone, dove era ospitato un ristorante sempre aperto, si esibiva di giorno a intervalli
regolari un’orchestra, mentre di sera andarono in scena nel corso dei giorni la Compagnia De Marco, il tenore Aldo Fiore, le operette della Compagnia Bertini Gioana.
16. Alla mostra – ideata da Michele Gallasso, ispettore scolastico circondariale – parteciparono oltre alle scuole comunali cittadine, anche quelle di San Martino, Sant’Agabio, Sant’Andrea, di Bicocca, Lumellogno, Pernate, Biandrate, Vespolate, Borgomanero, Galliate, Cameri, Romentino, Momo, Oleg-gio, Orta, Arona, Romagnano, Boca. Cfr. La chiusura della mostra didattica circondariale novarese, in «Esposizione agricola zootecnica industriale», 29 settembre 1926, s.n.p. Inoltre, per assecondare le poli-tiche fasciste nella battaglia per il prodotto nazionale, con l’occasione dell’Esposizione, il presidente della Federazione novarese fascista dei commercianti, Angelo Martinola, lanciò in tutta la provincia le “Settimane del prodotto nazionale”, un vero e proprio concorso tra gli esercenti al dettaglio per valoriz-zare i manufatti, le merci e i frutti della terra italiana. Su idea del cav. Grassi della Camera di commer-cio, tra gli esercenti si ebbe anche una gara all’allestimento della migliore vetrina. Cfr. La solenne inau-gurazione della nostra grandiosa Esposizione, in «La Gazzetta di Novara», 7-8 settembre 1926. Si veda anche la delibera del 24 settembre 1926 del commissario straordinario della Camera di commercio con-servata in Asccn, Deliberazioni del Commissario governativo straordinario.
17. I numeri della rivista sono ancora oggi consultabili, in forma rilegata, presso Bccnn. Tutte le foto ufficiali furono scattate dalla Fotografia ambrosiana di Via Carlo Alberto 33 (Novara). Cfr. L’Esposizione di Novara, in «Corriere di Novara», 21 agosto 1926.
18. Al termine dell’evento si sarebbe dovuto dare alle stampe anche una grande pubblicazione, in carta lusso con 200 facciate, a cura dei due artefici della rivista. Cfr. Una pubblicazione illustrativa dell’Esposizione di Novara, in «Corriere di Novara», 26 ottobre 1926.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
M. Savorra
101
cava la cattolica Banca del piccolo credito novarese, quest’ultima fondata nel 1903 e che al 31 agosto 1926 poteva vantare – ancora lontana dalla crisi falli-mentare di tre anni dopo – un «capitale sociale di lire 24.030.517,21»19.
Dal punto di vista della sistemazione urbana, l’Esposizione si articolava nel grande spazio intorno al vecchio castello (da alcuni definito il “Valentino Nova-rese”)20, nell’area da tempo tradizionalmente assegnata alla fiera annuale. Da un lato, a partire dal Teatro Coccia, si staccava il Viale Bellini sul quale si affaccia-vano i padiglioni, e subito accanto, parallelamente, il grande viale alberato, detto delle Carrozze, che congiungeva l’entrata con il padiglione dei festeggiamenti. Da qui si dipartivano una serie di vialetti fino al Rondò di San Luca, dove sareb-be dovuto inaugurarsi per l’occasione il monumento ai Caduti novaresi21, opera dello scultore Arturo Stagliano22. Dall’altro lato del castello, un viale, l’Allea, collegava una fontana, creata in corrispondenza dell’ingresso di Piazza Vittorio Emanuele, con il Rondò di San Luca. L’area sottostante l’Allea venne sistemata a grande prato con viali che delimitavano gli spazi destinati a eventi all’aperto e agli stands e alle tettoie per la mostra della zootecnia e delle macchine agricole. Segnati da trionfali ingressi, gli accessi ai viali principali della mostra costituiva-no gli elementi scenografici di chiusura della Piazza Vittorio Emanuele antistante il castello (attuale Piazza Martiri), fino a quel momento indefinita.
Chiusosi in pompa magna (il 17 ottobre 1926) con banchetti e fuochi d’artificio23, l’evento novarese per taluni versi è paragonabile all’Esposizione di Torino del 1928 (ma come è noto ideata già nel 192624), certo non tanto «per l’affermazione del gusto moderno»25, come scrisse Edoardo Persico, né tanto meno per l’entità delle risorse investite, quanto piuttosto per le strategie comu-
19. Come era riportato negli inserti pubblicitari della rivista, in cui una mappa della provincia segna-
lava il vasto raggio d’azione della banca e la capillare diffusione in ogni grande e piccolo centro con se-di, succursali, agenzie e recapiti. Sulla crisi successiva della banca, culminata nel 1930 con l’assorbimento dalla parte della Banca popolare di Novara, si veda il capitolo 7 in Umberto Chiaramon-te, Economia e società in provincia di Novara durante il fascismo 1919-1943, Milano, FrancoAngeli, 1987, pp. 273-320.
20. Cfr. In margine all’Esposizione, in «La Gazzetta di Novara», 15-16 settembre 1926. 21. L’inaugurazione del monumento fu poi rimandata al 4 novembre 1926. Cfr. La “Provincia ope-
rosa” celebra la sagra della produzione e del commercio nella solenne cerimonia inaugurale, in «Cor-riere di Novara», 7 settembre 1926.
22. Per il monumento ai caduti novaresi si vedano i documenti conservati nel Fondo Stagliano presso il Cassero per la scultura italiana dell’Ottocento e del Novecento di Montevarchi (AR).
23. Cfr. La grandiosa manifestazione di chiusura dell’Esposizione agricola industriale, in «L’Italia giovane», 20 ottobre 1926.
24. Sull’evento torinese si veda il fondamentale e ancora valido studio di Chiara Baglione, Torino 1928: architetti e architetture all’Esposizione del Valentino, tesi di laurea, 2 voll., relatore Giorgio Ciucci, Istituto universitario di architettura Venezia, 1989.
25. Edoardo Persico, Moda e ambiente a Torino, in «La Casa bella», giugno, 1932, ora in Idem, Tut-te le opere (1923-1935), a cura di Giulia Veronesi, Milano, Comunità, 1964, vol. II, p. 83.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
Novara 1926: la città e la Grande Esposizione agricola zootecnica industriale
102
nicative applicate e per i ruoli dei gruppi dirigenti piemontesi coinvolti, e so-prattutto per le prospettive degli attori economici agenti sul centro cittadino e sul territorio circostante, che – come vedremo più avanti – fornirono una visio-ne decisiva per lo sviluppo successivo della città26.
Le architetture e i padiglioni di Angelo Crippa «Dalle ricolorate guglie dei meravigliosi padiglioni, dai pinnacoli e dalle snelle
antenne che s’alzano maestose nell’azzurro spazio, l’italico vessillo sventolerà segnacolo della potenza lavorativa della nostra provincia»27. L’Esposizione no-varese non fu certo un momento di confronto tra intellettuali, progettisti e com-mittenti sul terreno comune della cultura architettonica, come dicevamo accadde invece a Torino, ma fu senza dubbio l’occasione per verificare da una prospettiva “periferica” nuovi linguaggi adatti alle fiere temporanee. Protagonista assoluto del grande evento fu l’architetto Angelo Crippa, curatore dell’impianto generale e progettista sia di tutti i padiglioni principali (Consorzio agrario cooperativo, Sa-lone-Teatro, Cusio, Oleggio, Sindacati fascisti della Provincia di Novara, Cine-ma di propaganda agraria, Prodotti chimici per agricoltura, Sport, Tripolitania, Cirenaica, Somalia)28, sia di tutti gli elementi architettonici come i chioschi e i trionfali ingressi29. Nato a Genova e vissuto a Varallo Sesia, Crippa si era forma-to prima all’Accademia di Belle arti di Brera, poi all’Accademia ligustica geno-vese e infine a Roma grazie al Pensionato di architettura. Nel momento in cui ebbe l’incarico dell’Esposizione era un professionista affermato e poteva vantare numerose opere realizzate e progetti in corso per committenti privati (Roma, No-vara, Genova), e pubblici in tutta Italia (come le case coloniche antisismiche ad Avezzano per l’Istituto nazionale dell’industria e del commercio, o come l’Istituto Giannina Gaslini di Genova), oltre che piani urbanistici ambiziosi e vi-sionari (Milano, Comacchio)30.
26. Novara: l’evoluzione urbanistica attraverso l’iconografia storica, a cura di Alberto Oliaro e An-
dreino Coppo, catalogo della mostra, Novara, Comune di Novara, 1983. 27. Cfr. L’inaugurazione dell’Esposizione, in «La Gazzetta di Novara», 4-5-settembre 1926. 28. Direttore aiutante dei lavori fu lo scultore Carlo Cantoni, mentre il costruttore fu Italo Boggio di
Torino. 29. Elaborati tra febbraio e aprile 1926, i disegni furono esposti al pubblico – e riportati dai giornali
– nei mesi subito precedenti l’esposizione. Cfr. La grande Esposizione di Novara, in «Corriere di Nova-ra», 23 luglio 1926. Alcuni documenti riguardanti la sistemazione dell’area per la fiera sono in Asn, Atti della Giunta municipale, allegati 108; Asn, Fondo Provincia, f. 2/2030, cat. 20, cl. 3, fasc. 3.
30. Su Crippa non esiste purtroppo una bibliografia esauriente e aggiornata. Si rimanda pertanto a Angelo Crippa architetto, Genova, Grafica D. B. Genova, s.d. [1973?].
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
M. Savorra
103
Un arco trionfale d’ingresso alto 17 metri con bugnati e ordini reinventati, cupole di ispirazione Beaux-Arts e portici con tettoie in legno in stile montani-no, torrette e pinnacoli ovunque sovrastati da bandierine, erano tutti elementi di un linguaggio architettonico multiforme. In alcuni padiglioni Crippa dimostrò di sapere padroneggiare sapienti allusioni stilistiche regionali e rurali, riferiti a una precisa area geografica (dalla Valsesia al Cusio), mescolati a un moderni-smo di maniera da alcuni rubricato come “neo-eclettismo” o “eclettismo di ri-torno”, dando vita a una architettura “fantastica”31.
A Novara, Crippa elaborò un linguaggio monumentale, e al contempo pub-blicitario, originale per le architetture che avrebbero ospitato le mostre e gli e-venti: assemblando elementi fantasmagorici frutto di pura invenzione, l’architetto plasmò così un’insolita immagine di città-parco di divertimenti, in cui i singoli edifici – costruiti in pietra, legno, tela e gesso – si ponevano come affascinanti attrattori per svaghi paesani e, al contempo, come perfetti conteni-tori, da un lato, per mercanzie pronte alla vendita, e, dall’altro, per prodotti-simbolo del progresso, esposti con il mero obiettivo didattico. Esemplare fu il padiglione dei Sindacati degli agricoltori fascisti della provincia, all’interno del quale, organizzata in 1500 mq, la mostra delle colture erbacee – divisa tra Col-lettiva del grano, Selezionatori e Aziende agricole – forniva, con campioni di-mostrativi (plastici, grafici e fotografie), i materiali didattici, in linea con le di-rettive della propaganda agraria, utili a far conoscere tanto i comportamenti delle varietà di frumento nelle diverse regioni agrarie, quanto i prodotti in ven-dita delle aziende agricole specializzate in grano, segale, avena, riso e grano-turco. Nel padiglione era sistemato anche un grande stand per la mostra della tenuta di Sali Vercellese, di proprietà di Eusebio Saviolo, che illustrava, tra l’altro, anche il castello trasformato qualche anno prima da Luigi Broggi e Ce-sare Nava32. Non va trascurato il fatto che, in seguito ai patti firmati il 19 luglio 1926 per i salariati delle zone risicole del novarese, l’Esposizione avveniva in un momento importante per il sindacalismo fascista che dominava nella con-trattazione agraria e industriale, con l’azione di sindacalizzazione dell’intera provincia ad opera di Edoardo Malusardi.
31. Cfr. Rossana Bossaglia, Dopo il liberty: considerazioni sull’Eclettismo di ritorno e il filone
dell’architettura fantastica in Italia, in Studi in onore di Giulio Carlo Argan, Roma, Multigrafica Edi-trice, 1984, ora in Eadem, Il giglio, l’iris, la rosa, Palermo, Sellerio, 1988, pp. 287-298.
32. Cfr. Paola Gallo, Luigi Broggi. Un protagonista dell’architettura eclettica a Milano, Milano, FrancoAngeli, 1992, p. 274. Si veda anche Luigi Broggi, I miei ricordi 1851-1924. Settant’anni di vita italiana nelle memorie di un architetto milanese, a cura di Maria Canella, Milano, FrancoAngeli, 1989, p. 109.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
Novara 1926: la città e la Grande Esposizione agricola zootecnica industriale
104
Più vicina alla mostra etnografica romana del 191133, che all’Esposizione parigi-na del 192534, la manifestazione orchestrata da Crippa dunque si rivolgeva ad am-biti di confronto locali per affermare che, anche in una città di provincia come No-vara, era sentito il bisogno di ricerca di un’identità autentica. Comunque, se le fonti di ispirazione per le architetture-contenitore si basavano su esempi degni di consi-derazione per il carattere locale dell’evento, gli interni – lasciati ovviamente vuoti a disposizione dei singoli espositori – si adattavano ai materiali e agli oggetti da mo-strare. Con una facciata evocante le chiesette alpine, il padiglione del Consorzio agrario, il primo dei quattro prospettanti il Viale Bellini, ad esempio, raccoglieva nello spazio di 500 mq foto, cartelli, opuscoli relativi alla Miniera di Sache, dalla quale il Consorzio traeva la pirite per la produzione dell’acido solforico, utile per la Fabbrica di concimi novarese. Tra numerosi diagrammi di produzione, nel padi-glione si esponeva il ciclo del processo industriale, dalla materia prima, come nel caso del fosfato che arrivava dai giacimenti del Nord Africa, fino alla successiva macinazione in polvere, e al prodotto greggio ottenuto dalla miscela della farina di fosfati con l’acido solforico. All’interno del padiglione, particolare attenzione era riservata all’Opera nazionale combattenti, associata del Consorzio, la quale presen-tava i grani prodotti nelle terre da essa tenute in coltivazione, mentre nel cinema adiacente si proiettavano filmati di propaganda agraria35.
Nei viali intorno al castello, il tema dell’architettura pubblicitaria si affaccia-va in alcune opere significative come la torre della radio della Sipel-Ericsson, il padiglione della Benzina Shell, la Casa elettrica della Sip, lo stand della Socie-tà Tedeschi della elettricità e il padiglione della Società vercellese di elettricità. Anche nella città di Novara si sondò così il terreno per la sperimentazione delle possibilità “propagandistiche” dell’architettura-réclame, come è noto, adottate nelle Fiere campionarie in tutta Italia (la più nota, con cadenza annuale, quella di Milano a partire dal 1920)36.
33. Si veda Roma 1911, a cura di Gianna Piantoni, catalogo della mostra, Roma, De Luca Editore,
1980. Va rilevato che Crippa per l’esposizione romana aveva elaborato un progetto per l’ingresso. 34. Cfr. Rossana Bossaglia, L’Art déco, Roma-Bari, Laterza, 1984, pp. 49-70; Gabriella D’Amato,
Fortuna e immagini dell’Art Déco. Parigi 1925, Roma-Bari, Laterza, 1991. 35. Il cinema di propaganda agraria sorse nei pressi del padiglione con il contributo del Consorzio
agrario, la Banca popolare, la Montecatini, la Delegazione del nitrato e l’Ufficio della potassa. Va ricor-dato che sorto nel 1899 con soli 208 soci, il Consorzio vide crescere il numero dei suoi associati in ma-niera esponenziale, tanto che nel 1925 ne risultavano iscritti oltre 6.000, con un capitale sociale passato da 30.000 lire a 8 milioni (tra quelli agrari, il Consorzio di Novara presieduto dall’ingegnere Carlo Faà risultava essere al primo posto in Italia). Cfr. Nel grande padiglione del Consorzio agrario, in «Esposi-zione agricola zootecnica industriale», 15 settembre 1926, s.n.p.
36. Cfr. Aldo Castellano, Modelli espositivi e architetture alla Fiera di Milano, e Giampiero Bosoni, Architetture provvisorie alla Fiera Campionaria, in Fiera di Milano 1920-1995. Un percorso tra eco-nomia e architettura, Milano, Electa, 1995, pp. 85-139, 173-205. Si veda anche Giuseppe Maria Lon-goni, La Fiera nella storia di Milano, Milano, Federico Motta Editore, 1987.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
M. Savorra
105
Anticipando la celebre casa elettrica presentata all’Esposizione di Monza del 193037, la casa elettrica della Sip – voluta, insieme agli altri padiglioni “elettrici”, da Gian Giacomo Ponti38 – era l’ideale ambientazione dei prodotti che avrebbero fatto la «gioia della massaia»: la casa – sebbene ancora lontana dalla “modernità architettonica” del progetto del padiglione monzese – con le sue decorazioni in-terne neorinascimentali, opera di valenti artigiani, diventava il “regno dell’elettricità” con le sue “modernità industriali”, in cui ogni locale, dalla cucina alla camera da letto, si trasformava in un luogo abitato da strabilianti marchinge-gni (dai bollitori, scaldapiatti ed “elettrosguattere” fino ai pianoforti, ai decatizza-tori, agli scaldapiedi, mescolabibite, biberon, cuffie e lenzuolini elettrici). Per dimostrare i vantaggi dell’elettricità applicata all’agricoltura, inoltre, l’ingegner Gregotti impiantò una risaia modello, in cui si potevano vedere gli effetti nel ri-scaldamento artificiale delle acque, nella lavorazione del terreno, nei sollevamen-ti delle acque dal sottosuolo per irrigare, nella trebbiatura, nella produzione dei concimi e nella conservazione dei foraggi.
Evocante le costruzioni del lago d’Orta, il grande padiglione del Cusio rac-coglieva i prodotti di oltre cinquanta aziende dell’Omegnese. Oltre all’attività delle ditte collocate da Crusinallo a Gravellona, da Cireggio alle due Quarne, particolare risalto era dato al ruolo dell’artigianato, come quello della Val Strona. Altre costruzioni erano ammantate di una originale veste tardo ecletti-ca, tra regionalismo ed ambientismo, tipica dei nuovi orizzonti espressivi dei primi anni venti del Novecento39. In tal senso, l’Esposizione rappresentò un singolare tentativo, da parte della cultura architettonica dei primi anni venti, di individuare una forma rappresentativa di monumentalismo pompier coerente per l’insieme delle costruzioni effimere.
37. Ampia è la letteratura di riferimento. Si rimanda, tra le ultime pubblicazione, a 1923-1930 Monza
verso l’unità delle arti. Oggetti d’eccezione dalle Esposizioni internazionali di arti decorative, a cura di Anty Pansera con Mariateresa Chirico, catalogo della mostra, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2004, passim.
38. L’On. Prof. G. G. Ponti e le Mostre elettriche, in «Esposizione agricola zootecnica industriale», 22 settembre 1926, s.n.p. Sull’attività di Ponti si veda Gaudenzio Barbè, Dizionario biografico e dei pe-riodici. Novara fa da sé, Novara, Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nel No-varese e nel Verbano, Cusio, Ossola “Piero Fornara”, 1999, ad vocem.
39. Cfr. Guido Zucconi, Gli anni dieci tra riscoperte regionali e aperture internazionali, in Storia dell’architettura italiana. Il primo Novecento, a cura di Giorgio Ciucci e Giorgio Muratore, Milano, E-lecta, 2004, pp. 38-55.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
Novara 1926: la città e la Grande Esposizione agricola zootecnica industriale
106
M. Dudovich, Manifesto ufficiale dell’Esposizione di Novara, 1926
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
M. Savorra
107
Prospettiva d’ingresso dell’Esposizione di Novara, 1926
A. Crippa, Prospettiva del Teatro-Salone dei ricevimenti all’Esposizione di Novara, 1926
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
Novara 1926: la città e la Grande Esposizione agricola zootecnica industriale
108
Non sono chiare fino in fondo le istanze del progettista e dei committenti, ma sta di fatto che le retoriche comunicative degli spazi allestiti furono conce-pite per favorire l’accoglienza dell’idea di progresso (scientifico, agricolo, in-dustriale) come esito del nuovo corso politico, senza aderire né allo stile deco-rativo delle architetture caratterizzate dal geometrismo déco – prevalente nelle esposizioni d’oltralpe e in alcune architetture ideate per l’industria e per le fiere milanesi (si pensi alle creazioni portaluppiane)40 –, né tanto meno a quello del “barocchetto”, tipico di innumerevoli episodi architettonici di questi anni. Il regionalismo “estetico” si manifestava a Novara in forme e simboli di un con-testo geografico orgoglioso della propria fisionomia; non a caso, negli articoli apparsi a chiusura dell’evento si sottolineava il senso, fino a quel momento mai materializzato, di una formidabile identità locale: «Guardando ora i viali ma-gnifici che si vanno mano mano spopolando, ci assale un senso di nostalgia e ci pare che con l’abbattimento dei padiglioni, con lo sfollarsi delle merci e dei prodotti se ne vada anche un po’ della nostra anima, del nostro orgoglio, della nostra passione»41.
L’Esposizione e il piano per una “più grande Novara”
Gli ingressi dell’Esposizione sulla Piazza del castello segnavano le direttrici d’espansione urbana, grazie anche alla costruzione dei palazzi Venezie delle Assicurazioni Generali in Via di completamento sempre su progetto di Crippa (con la direzione dei lavori di Enrico Agostino Griffini)42. In questo modo, la Piazza Vittorio Emanuele riusciva finalmente ad avere una forma quasi chiusa, dopo annose discussioni urbanistiche: l’area, infatti, era stata al centro di inte-ressi speculativi, palesati sin dal secolo precedente, che prevedevano la siste-mazione della piazza con la creazione di un quartiere, “Nuova Novara”, e con la distruzione del castello e la conservazione, con destinazione a verde, soltanto della parte del baluardo e dell’area riservata alla fiera stagionale43.
40. Cfr. Piero Portaluppi. Linea errante nell’architettura del Novecento, a cura di Luca Molinari e
Fondazione Piero Portaluppi, catalogo della mostra, Milano, Skira, 2003. 41. La chiusura dell’Esposizione, in «La Gazzetta di Novara», 20-21 ottobre 1926. Si veda anche
Cala il sipario (dopo la chiusura dell’Esposizione), in «Corriere di Novara», 19 ottobre 1926, in cui l’Esposizione venne definita come una «candida città delle cento meraviglie».
42. Cfr. Massimiliano Savorra, Enrico Agostino Griffini. La casa, il monumento, la città, Napoli, E-lecta, 2000, p. 166.
43. Cfr. Considerazioni intorno al progetto presentato al Municipio della Città di Novara per l'ere-zione di un nuovo Quartiere denominato nuova Novara, Novara, Tip. Fratelli Miglio, 1899. Si veda an-che Nuova Novara. Progetto Giachi-Andreoni, in «Gazzetta di Novara», 14-15 dicembre 1901.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
M. Savorra
109
Dal confronto della pianta del 1883, redatta da Antonio Dell’Ara dell’ufficio tecnico municipale44, con la pianta di Novara del 1922, stampata dall’Istituto ge-ografico De Agostini, è possibile comprendere come si stesse espandendo in ma-niera disordinata la zona compresa tra le frazioni di San Martino e di Cittadella, e questo nonostante che i piani regolatori edilizi, sia quello del 1891 che quello del 1909, prevedessero l’ampliamento della fascia esterna ai baluardi con razionali rettilinei e rondò circondati da ampi giardini45. Ma soprattutto si evince come il “Prato della Fiera”, l’area destinata alle manifestazioni di mostre-mercato, fosse stata spostata in una zona delimitata dalle vie Gnifetti e Barazzuolo, nelle vici-nanze della stazione delle Ferrovie Ticino. La presenza di stabilimenti industriali (Officine Falcone, Fonderia Fauser, Calzificio Barozzi, Officine Dell’Erra) e di case come quelle per i ferrovieri nel borgo di San Martino aveva però determina-to la necessità di ripensare agli spazi riservati alla fiera. Infatti, organizzata anco-ra nel vecchio campo a ridosso del castello, l’Esposizione del 1926 mostrò i limi-ti del piano del 1909 e innescò un’accelerazione dei processi decisionali sulle nuove aree di espansione periferiche.
In questi anni il dibattito sul controllo e la pianificazione stava conoscendo punte di notevole fervore, dovute alle politiche del regime fascista sulla città e sulla riorganizzazione del paese; dibattito che vide, come momento centrale, il noto discorso dell’Ascensione tenuto da Mussolini il 26 maggio del 1927. Riorganizzate tra il 1923 e il 1926 e vigilate grazie alla fascistizzazione dei prefetti e all’istituzione del podestà (“primo magistrato cittadino”), le province italiane conobbero una stagione di riassetto, non solo amministrativo, che pre-vedeva la realizzazione di opere pubbliche capaci di ridefinire i servizi a rete a carattere territoriale; piani di riassetto del territorio, che – come ha scritto Giorgio Ciucci – furono concepiti «in funzione della riorganizzazione agricola e industriale»46. Proprio nel 1926, del resto, si tenne a Torino il congresso in-ternazionale di urbanesimo che mise a fuoco, tanto la questione dello sviluppo delle grandi e medie città (e del loro buon governo edile, igienico, sociale), quanto il tema delle città italiane come elemento dinamico47.
44. Asn, Pianta della città di Novara, Dell’Ara 1883, cassetta L/26. 45. Asn, Piano regolatore di Novara, Bonfantini 1891, Disegni L/25; Piano regolatore di Novara, Ba-
raggioli 1909, Disegni LI/2. 46. Cfr. Giorgio Ciucci, Gli architetti e il fascismo. Architettura e città 1922-1944, Torino, Einaudi,
1989, p. 25. Sul ruolo determinate di Mussolini nella “costruzione” delle città italiane, si veda da ultimo Paolo Nicoloso, Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell’Italia fascista, Torino, Ei-naudi, 2008 (2011).
47. Cfr. Fabrizio Bottini, Dall’utopia alla normativa. La formazione della legge urbanistica nel di-battito teorico: 1926-1942, in La costruzione dell’utopia. Architetti e urbanisti nell’Italia fascista, a cu-ra di Giulio Ernesti, Roma, Edizioni Lavoro, 1988, pp. 207-221.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
Novara 1926: la città e la Grande Esposizione agricola zootecnica industriale
110
Per di più, durante i giorni dell’Esposizione apparve un articolo sul «Corriere di Novara», significativamente intitolato Per la più grande Novara48, in cui si rimarcava come nel rinnovato clima del “consenso” fosse arrivato il tempo di migliorare il centro cittadino, visti i compiti maggiori che i capoluoghi di provin-cia andavano assumendo: «la nuova tendenza, più razionale, più logica, accentra ed armonizza nei maggiori centri uffici e funzioni». L’anonimo articolista ricor-dava la soppressione delle sottoprefetture e dei tribunali di circondario a favore di un unico tribunale provinciale, e l’elezione di Novara a sede delle grandi or-ganizzazioni dell’industria e del commercio. Una serie di motivazioni economi-che e storiche venivano rammentate per sostenere l’idea di costruire una città «degna del suo rango» che avrebbe dovuto evolversi «dalla mediocrità provincia-le a più vasto respiro». Sull’onda dell’eccezionale evento cittadino in corso si ri-scontrava come in realtà a Novara mancasse tutto (dalla casa municipale alle aule di giustizia, dalle sedi dei mercati alle scuole, alle vie di comunicazione), e come la stretta cerchia dei baluardi avesse soffocato il nucleo urbano.
La grande Esposizione mise in evidenza la mole dei problemi, elencati nell’articolo, che solo il concepimento di un piano organico avrebbe invece po-tuto risolvere. Si avviò così un dibattito, che coinvolse personalità cittadine e tecnici professionisti, che si concluse sette anni dopo con il concorso per il nuovo piano regolatore bandito dal podestà Luigi Tornielli (31 gennaio 1933). La gara venne vinta dall’architetto Oscar Prati e dagli ingegneri Rocco Nicolò e Andrea Visioli; successivamente, con deliberazione podestarile, si costituì la commissione esecutiva (Oscar Prati, Marco Cassinis e Federico Magistrini) per compilare il piano definitivo, mentre l’8 ottobre 1934 Mussolini in persona diede il colpo di piccone per l’inizio ai lavori del Piano regolatore che rappre-sentò il «punto di partenza per l’attuazione di un «cospicuo complesso di opere destinato a segnare in forma definitiva i lineamenti della più grande Novara»49.
Tra demolizioni e risanamenti igienico-sanitari, il piano approvato prevedeva la riattivazione dei “quartieri morti” e il decongestionamento del traffico citta-
48. Per la più grande Novara, in «Corriere di Novara», 12 ottobre 1926. 49. Bcpm, Fondo Luigi Lorenzo Secchi, Il piano regolatore di Novara, a cura dell’Ufficio stampa
del comune di Novara, 1938, p. 6. Il piano è adottato con deliberazione del podestà del 28 giugno 1935, n. 5878, ed esaminato dal Consiglio dei lavori pubblici nell’adunanza dell’assemblea generale del 28 dicembre 1936, n. 2020. Cfr. Approvazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Novara con le relative norme di attuazione viene pubblicato in «Gazzetta ufficiale», 8 novembre 1937, n. 258. La legge 3 febbraio 1938, con la quale si converte il regio decreto 14 luglio 1937, n. 1824, rela-tivo all’approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Novara, è pubblicato in «Gazzetta ufficiale», 17 marzo 1938, n. 63.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
M. Savorra
111
dino e l’allargamento delle strade esterne ai baluardi50. Al di là della trasforma-zione del centro e la creazione di nuovi edifici pubblici (le Poste, la Casa del Littorio, il mercato coperto, la sede dell’Ufficio provinciale del lavoro, i palaz-zi Ina, Inail, Credito italiano, Cariplo, scuola Ferrandi, asilo san Lorenzo), in linea del resto con le istanze celebrative delle architetture in costruzione in buona parte della nazione, il piano destinava l’area della fiera nella zona di San Martino alla creazione di un nuovo complesso sportivo (stadio Alcarotti), men-tre confermava la destinazione del vecchio campo, quello nelle vicinanze del castello, a verde pubblico e prevedeva il nuovo “Prato della Fiera” in una zona a ovest nei pressi della ferrovia Torino-Milano. Tuttavia, va rilevato che per lo sviluppo della viabilità, soprattutto a sud, vennero seguiti gli allineamenti trac-ciati dall’Esposizione del 1926.
La zona della Piazza Vittorio Emanuele e tutta l’area dell’Esposizione erano invece nuovamente interessate da operazioni immobiliari che prevedevano la creazione di “un altro centro cittadino”: nella relazione della commissione giu-dicatrice del concorso si valutarono attentamente le sistemazioni previste da numerosi partecipanti, vista «la inesistenza di gravi ostacoli naturali all’estensione della Città»51. In particolare, tutta la superficie sede dell’evento diventava, nei propositi di molti, il perno di un vero e proprio centro degli affa-ri, in cui era prevista anche la collocazione del futuro municipio prospettante la piazza e sovrapposto al vecchio castello visconteo. In tal senso, la commissione – pur rispettosa delle indicazioni del bando – si premurò di esprimere all’unanimità il parere di non ricostruire il castello arbitrariamente in stile «considerando che i pochi ruderi esistenti rivestono scarso valore paesistico ed ambientale».
A prescindere dalle singolari opinioni espresse dalla commissione, va rileva-to quanto la questione della chiusura a sud della piazza fosse presente nelle a-nalisi urbane, come nelle relazioni di piano e nei documenti. Tutte le proposte presentate dedicavano particolare attenzione alla trasformazione dell’area del castello, anche se alla fine nel progetto definitivo dei vincitori, il monumento e l’intera area utilizzata per il grande evento del 1926 fu lasciata libera ad uso di “verde urbano”. Non sono ancora del tutto noti i motivi che indussero
50. Cfr. Plinio Marconi, Concorso per il piano regolatore di Novara, in «Architettura», 1935, fasc. III, p. 173. Si veda anche Marco Gramigni, Il piano regolatore di Novara del 1936 come esempio di pianificazione fascista, in L’evoluzione della forma urbana di Novara dalle origini al piano regolatore del 1936. Proposte interpretative, a cura di Idem, Milano, Guerini e Associati, 1997, pp. 153-167.
51. Firmata da Luigi Tornielli, Ercole Varzi, Paolo Napoli, Cesare Albertini, Guglielmo Pacchioni, Roberto Papini, Paolo Rossi, Giuseppe Pagano, e datata 24 gennaio 1934, la relazione è pubblicata in Bcpm, Fondo Luigi Lorenzo Secchi, Il piano regolatore di Novara, a cura dell’Ufficio stampa del co-mune di Novara, 1938, pp. 27-44 [la citazione è a p. 28].
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.
Novara 1926: la città e la Grande Esposizione agricola zootecnica industriale
112
all’abbandono dell’idea di trasformare il castello, sta di fatto che l’Esposizione, se da un lato riuscì di sicuro ad alimentare il dibattito sulla città e sul suo rin-novamento complessivo, dall’altro, fu in grado di far crescere – negli estensori del piano – la sensibilità verso la conservazione di una zona-simbolo per i no-varesi, dando al pubblico la possibilità di godere di uno spazio e di un giardino, unico in città per molto tempo e ancora oggi assai frequentato. In questo, le pa-role del duce – in una lettera scritta al presidente dell’Esposizione – furono profetiche: «Balbo mi comunica che l’Esposizione di Novara è riuscita splen-didamente»52.
52. Il Capo del Governo plaude all’Esposizione di Novara, in «Esposizione agricola zootecnica indu-
striale», 15 settembre 1926, s.n.p.
Copyright © FrancoAngeli N.B: Copia ad uso personale. È vietata la riproduzione (totale o parziale) dell’opera con qualsiasi
mezzo effettuata e la sua messa a disposizione di terzi, sia in forma gratuita sia a pagamento.