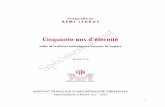L'abecedario di un pensionnaire du roi: Carle Vanloo a Roma (1728-1732)
Transcript of L'abecedario di un pensionnaire du roi: Carle Vanloo a Roma (1728-1732)
«Je suis charmé de tout le bien que vousme mandés du Sr. Vanloo»Carle Vanloo entra all’Accademia di Fran-cia a Roma nel 1728, dopo aver vinto quat-tro anni prima il Grand Prix, di cui eranoinsigniti i migliori allievi dell’AcadémieRoyale di Parigi. Il pittore condivide il sog-giorno nell’istituzione romana, fondata nel1666 per volere di Luigi XIV e di Jean-Bap-tiste Colbert, con artisti che saranno il van-to del Regno di Luigi XV, come FrançoisBoucher, Pierre-Charles Trémolières,Charles Natoire, Pierre Subleyras, Lam-bert-Sigisbert Adam, Edme Bouchardon,Michel-Ange Slodtz1.L’ingresso di Carle Vanloo in Accademia èfavorito dal fratello maggiore, il pittore Je-an-Baptiste, che nel 1728 facilita l’arrivopresso la medesima istituzione anche del fi-glio Louis-Michel. A Parigi Jean-BaptisteVanloo frequenta le corti del re e dei prin-cipi di Carignano, ed è in confidenza conLouis de Pardaillan de Gondrin, ducad’Antin, sovrintendente alle Fabbriche diLuigi XV, che in una lettera del 4 marzo1730 lo definisce «mon ami intime»2. Lostesso artista aveva potuto perfezionarsi aRoma, a spese di Vittorio Amedeo Filippodi Savoia-Carignano, fra il 1715 e il 1719,anni in cui è pittore nella Torino di Vitto-rio Amedeo II, senza però diventare allievodell’Accademia di Francia3.
Nel 1728, a Parigi, le fila dell’Accademiasono tirate dal duca d’Antin; a Roma, inve-ce, gli artisti vengono accolti dal pittore Ni-colas Vleughels, direttore dell’istituzione,coadiuvato dal potente cardinale Melchiorde Polignac, ambasciatore di Francia pressola Santa Sede fino al 17314.Il 10 febbraio 1729 il duca d’Antin esprimesoddisfazione a Nicolas Vleughels per labravura degli allievi: «Je suis charmé detout le bien que vous me mandés du Sr.Vanloo et en général de tous vos élèves;continuez à les entretenir dans l’émulationoù il sont et dans le désir où ils semblentêtre de devenir d’habiles gens et de fairehonneur à notre nation»5. Questa frase sin-tetizza bene le due tendenze che animanol’Accademia francese a Roma a partire dal-la sua fondazione: i migliori artisti di Fran-cia (pittori, scultori, ma anche architetti,per la cui formazione a Parigi era invece ri-servata un’istituzione separata) venivanoinviati nella città papale al fine di perfezio-narsi attraverso la copia delle opere d’artedell’antichità e dei grandi maestri, in pre-valenza del Cinque e Seicento, per poi tor-nare in patria e dare lustro alla proprianazione; allo stesso tempo, le sculture e i di-pinti eseguiti dagli allievi erano trasportatiin Francia per decorare i giardini e le resi-denze reali, oppure lasciati a Roma per ar-ricchire la sede dell’Accademia, che nel
1725 si trasferisce da Palazzo Capranica aPalazzo Mancini, su via del Corso, sede piùadatta alle attività degli artisti6. È propriol’intraprendente Nicolas Vleughels, arriva-to nel 1724 da Parigi, in un primo mo-mento per affiancare il direttore CharlesPoerson, e poi da solo al comando dell’isti-tuzione romana dal 1725 al 1736, a incen-tivare e a rinnovare l’esercizio della copia.
La svolta di Nicolas VleughelsNegli ultimi anni del direttorato di CharlesPoerson l’Accademia è cristallizzata in unarilassatezza improduttiva. La Correspon-dance riporta infatti scarsi riferimenti ad at-tività didattiche compiute dagli allievi, ecita pochissime copie inviate a Parigi, siadipinti, sia sculture. Ne conseguono rap-porti sempre più tesi con d’Antin, che il 16ottobre 1724 redarguisce così CharlesPoerson: «Je veux encore absolument quevous occupiez vos élèves, par préférence àtout, à faire des copies»7.La svolta di Nicolas Vleughels non si fa at-tendere, e coinvolge subito gli allievi pit-tori; Poerson scrive al duca d’Antin il 7novembre 1724: «les élèves de peinture, quine perdent point de temps, sont allées estu-dier d’après nature des beaux restes de l’an-tiquité, à Tivoli et Frascati, avec M.Vleughels, lequel est amoureux des bellesveuës de ce pays»8. Si avvia dunque all’Ac-
53
L’abecedario di un pensionnaire du roi: Carle Vanloo a Roma (1728-1732)Alessia Rizzo
François Boucher, Veduta del Palatino, 1728-1731, matita nera e gessetto bianco su carta azzurra.Parigi, Bibliothèque nationale de France, Département des Estampes et de la Photographie.
Michel-Ange Slodtz da Annibale Carracci, Fauno,1728-1736, incisione manière de crayon.Roma, Istituto Nazionale per la Gra!ca.
53-60 Rizzo:Layout 1 28-06-2011 8:25 Pagina 53
cademia di Francia, negli stessi anni in cuila campagna romana è terreno di numerosiscavi e ritrovamenti archeologici, una prati-ca di insegnamento che diventerà prestoconsueta, amata in modo particolare dalpittore Charles Natoire, successore di Vleu-ghels; gli allievi esplorano Roma e i suoidintorni, in particolare Villa d’Este a Tivo-li, e Frascati, per osservare e copiare la natu-ra9. Lo studio del paesaggio «d’aprèsnature», dal vivo, rappresenta una novitàrispetto alla didattica impartita a Parigi;Vleughels scrive a d’Antin l’8 novembre1724: «Ils [gli allievi] iront avec moy à Ti-voli, où il ya de belles choses et extraordi-naires; la bisarrerie de la nature, les sites
merveilleux, l’arangement des fabriques,tout cela leur ouvrira le génie et leur ap-prendra à composer d’une manière ingé-nieuse et nouvelle»10.Attualmente non sono pubblicati studi dipaesaggio realizzati da Carle Vanloo, ma sene può avere un’idea guardando ai disegnieseguiti a Tivoli, al Palatino, o nei giardinidi Villa Farnese, dai pensionnaires a lui con-temporanei, come François Boucher, artistaparticolarmente vicino al nostro pittore ne-gli anni romani, soprattutto per la scelta deimodelli su cui posare lo sguardo. Le scenedisegnate da quest’ultimo mostrano ampiscorci di vegetazione e radure, in cui talvol-ta sono inserite figure umane, percorsi a
tratti da templi, statue, edifici antichi, rea-lizzate per lo più a matita nera su carta az-zurra, ricreando l’effetto naturale del cielo11.Il metodo del direttore «ouvrira le génie»dei pensionnaires, e difende dunque la li-bertà della creazione artistica. Sappiamoinfatti che Nicolas Vleughels (sulla cui per -sonalità va ancora misurata l’influenza del-le Réflexions critiques sur la poésie et lapeinture dell’abate Jean-Baptiste Dubos,pubblicate a Parigi nel 1719), a differenzadei sui predecessori lascia agli allievi pitto-ri, scultori, architetti, la scelta dei capola-vori da copiare, limitandosi a indirizzarliverso gli aspetti a cui prestare attenzioneper migliorare la tecnica: «Je les laisse choi-sir, car il ne faut pas contraindre le génie»12.Nonostante qualche apertura durante il di-rettorato di Charles Poerson, la svolta nelladidattica si deve a Nicolas Vleughels, che facoesistere la copia dai Carracci, Raffaello,Guido Reni, Domenichino, con quella daartisti precedentemente lasciati in secondopiano, come gli esponenti della Roma a luicontemporanea e i maestri della pittura ve-neziana; è proprio da questi ultimi, in par-ticolare Paolo Veronese, che Vleughelsviene attratto, grazie anche al soggiorno ef-fettuato a Venezia nel 1707 (prima che Se-bastiano Ricci, Giovanni AntonioPellegrini, Rosalba Carriera approdassero aParigi), e ai rapporti di amicizia con PierreCrozat, Pierre-Jean Mariette, Antonio Ma-ria Zanetti e Jean de Jullienne13.Con il nuovo direttore dunque molte cosecambiano; resta tuttavia intatta l’attenzioneprestata dai pensionnaires allo studio dellaprospettiva e dell’anatomia (il detta glia -tissimo volume di Bernardino Genga e Gio-vanni Maria Lancisi, Anatomia per uso etintelligenza del disegno, pubblicato a Roma
54
Carle Vanloo, Il Festino di Baldassarre, 1728, matita nera e sanguigna.Roma, Accademia Nazionale di San Luca.
Louis-Gabriel Blanchet, Testa di vecchio,1728-1732, incisione manière de crayon.Roma, Istituto Nazionale per la Gra!ca.
Edme Bouchardon, Testa di vecchio,1730-1740 circa, incisione manière de crayon.Roma, Istituto Nazionale per la Gra!ca.
Carle Vanloo, Nudo accademico,1728-1732, incisione manière de crayon.Roma, Istituto Nazionale per la Gra!ca.
53-60 Rizzo:Layout 1 28-06-2011 8:25 Pagina 54
nel 1691 ad hoc per l’Accademia di Francia,continua ad essere ristampato nel Settecen-to), discipline considerate importanti giànel primo, e severo, regolamento dell’istitu-zione, stilato da Charles Errard il 6 marzo166614. A Parigi solo dopo aver copiato imaestri del passato, prima attraverso disegni,poi attraverso opere tridimensionali, gli arti-sti possono accostarsi ai modelli viventi, a na -liz zandone la muscolatura del corpo, latensione dei nervi (pratica già effettuata aRoma alla scuola di Sebastiano Conca, pri-ma dell’apertura dell’Accademia del Nudonel 1754), partendo dai dettagli per poi pas-sare alla figura intera solo in un secondo
momento15. Nella succursale romana inve-ce non era raro che gli allievi, anche i nuoviarrivati, affiancassero in una stessa giornatalo studio dall’Antico, l’attività di copia inchiese e palazzi, e il disegno dal modello vi-vente, senza gerarchie, come spiega NicolasVleughels: «Après le souper [...] on dessined’après l’antique pendent environ deuxheures, ce qui est une merveilleuse étudeaprès qu’on a étudié le naturel, ce qui se faitavant souper»16.Ogni epoca ha criteri diversi nella scelta del-le pose accademiche per l’esercizio degli al-lievi nel disegno, a Parigi come a Roma: senel Seicento le pose prescelte fanno esplici-
to riferimento alle più celebri sculture anti-che, nel Settecento si preferisce mettere inrisalto l’espressività del corpo, senza schemiprecostituiti, pur restando frequenti l’acco-stamento ai modelli scultorei più conosciu-ti, come il Laocoonte, l’Ercole Farnese, ilFauno Barberini, l’Ares Ludovisi (le stessestatue illustrate già nel volume del Lancisi),e le citazioni dai fauni e dai telamoni dipin-ti da Annibale Carracci nella Galleria Far-nese. Le accademie eseguite da CarleVanloo a Roma, ad oggi conosciute, a san-guigna su carta bianca, caratterizzate daltratto sicuro dei contorni, ritraggono nudimaschili nell’attimo di uno sforzo fisico, di-scostandosi dal modello antico17.A Roma Nicolas Vleughels introduceanche un’altra attività didattica, volta aesaltare l’abilità degli allievi nel disegno; sitratta dello studio delle figure drappeg-giate, condiviso da pittori e scultori, chesembra rievocare le disquisizioni di GiovanPietro Bellori e Carlo Maratta sul «panneg-giamento»: «Aujourd'hui et ce soir, on re-commence de nouvelles études; c'est ce quin'avoit jamais été pratiqué dans l'Acadé-mie; ce sont des figures drapées sur le natu-rel, quelquefois moitié nües et moitiéhabillées; on donne quelque chose au ha-zard, on laisse faire à la nature, qui produitpresque toujours des choses nouvelles etmerveilleuses»; si scelgono panneggi ampi,meglio se voluminose vesti di ecclesiastici«pour s’impatroniser du vrai, qui est l’âmede notre métier». Le lettere qui citate risal-gono all’aprile e al settembre 1732, quandoCarle Vanloo aveva già lasciato l’Accade-mia; il metodo descritto da Nicolas Vleu-
55
Carle Vanloo da Angelo de’ Rossi, Particolaredella Canonizzazione di cinque santi, 1728-1732,matita nera e gessetto bianco. Collezione privata.Angelo de’ Rossi, Canonizzazione di cinque santi,bassorilievo per la tomba di papa Alessandro VIII,1695-1725, marmo. Roma, Basilica di San Pietro.
Edme Bouchardon da Angelo de’ Rossi, Canonizzazione di cinque santi, 1723-1732, sanguigna.Parigi, Louvre, Département des Arts graphiques.
Carle Vanloo, Personaggio vestito all’orientale,1728-1732, da Receuil de Di!erentes charges Dessignéea Rome par Carloo Vanloo Peintre du Roy, Paris, post 1762.
Carle Vanloo, Personaggio vestito all’orientale,1728-1732, da Receuil de Di!erentes charges Dessignéea Rome par Carloo Vanloo Peintre du Roy, Paris, post 1762.
53-60 Rizzo:Layout 1 28-06-2011 8:25 Pagina 55
ghels si riallaccia però a una pratica eserci-tata già in precedenza dai pensionnaires, e dicui il nostro pittore dà prova in numerosidisegni, raccolti in una serie a stampa dopoil 1762: il Receuil de Differentes charges Des-signée a Rome par Carloo Vanloo Peintre duRoy, con tavole raffiguranti personaggi av-volti da ampie vesti di gusto orientale, ispi-rate alle mascarades del Carnevale romano,su cui Vanloo si esercita nel delineare le pie-ghe e nel dosaggio di luce e ombra18.Apprendiamo da una lettera di Charles Po-erson del 3 ottobre 1724 che i pensionnai-res si applicano all’esercizio di copia tutta lasettimana, escluse le domeniche e le festivi-tà, giorni in cui possono studiare per pro-
prio conto19. I disegni degli allievi sonoespressione di un insegnamento sensibilealla permeabilità fra pittura e scultura: perfare qualche esempio, conosciamo studi amatita di Edme Bouchardon dagli affreschidei Carracci alla Galleria Farnese, da Raffa-ello, da numerose opere di Carlo Maratta,da alcuni dipinti di Giovanni FrancescoRomanelli e di Giovanni Lanfranco, non-chè uno schizzo à la plume di François Bou-cher da Bernini20. Anche Carle Vanloo aRoma si esercita nella copia di opere scul-toree: lo dimostra con chiarezza il disegnodi un particolare della Canonizzazione dicinque santi, bassorilievo scolpito da Ange-lo de’ Rossi per il monumento funebre dipapa Alessandro VIII in San Pietro, copia-to negli stessi anni romani anche da EdmeBouchardon, scultore con cui il nostro arti-sta condivide diverse volte la scelta dei mo-delli di studio21. Per Nicolas Vleughels ildisegno è l’espressione più immediata delgenio di un artista, e deve costituire un fon-damentale oggetto di studio non solo per ipittori, ma anche per gli scultori e gli ar-chitetti, dal momento che è, indiscutibil-mente, «la base de nos métiers»22.Ottime occasioni per i pensionnaires perfarsi conoscere nell’ambiente artistico ro-mano erano i concorsi promossi dall’Acca-demia di San Luca, a cui potevanoprendere parte in virtù dell’aggregazionefra le due istituzioni, datata 167623. CarleVanloo vi partecipa nel 1728, vincendo, apari merito con il milanese Francesco Cac-cianiga, nella Prima Classe di disegno conil Festino di Baldassare, e riscuotendo le lo-di di Vleughels. L’elogio del maestro si giu-stifica guardando la perizia con cui sonotracciati, a matita nera e sanguigna, il bor-do ricamato e frangiato della tovaglia, i det-tagli dei raffinati vasi d’oreficeria edell’insolita lampada appesa sopra il tavolo,su cui si arrampicano paffuti puttini congambe serpentiformi; le gestualità articola-te dei personaggi (gli stessi profili torneran-no nelle teste degli apostoli dell’UltimaCena, dipinta da Vanloo, insieme alla Mol-tiplicazione dei pani, nel 1733 nella chiesadi Santa Croce a Torino), movimentanoun’affollata composizione ispirata alle sce-ne di banchetto della pittura veneziana,punto di riferimento per la formazione diCarle Vanloo, prima a Parigi, poi a Roma24.
Paolo Veronese «lui sera d’un grandprofit»L’esercizio della copia affrontato da CarleVanloo a Roma risente delle innovazioniintrodotte da Nicolas Vleughels. Il 7 luglio1729 il nostro artista «va se mettre à copierun beau tableau de Pierre de Cortone quiest aux Capucins», vale a dire la tela raffi-gurante Anania che ridà la vista a san Paolo
in Santa Maria della Concezione. La copiadi opere chiesastiche era da sempre uno deipunti forti della formazione dei pittori al-l’Accademia di Francia, ma Vleughels ne faemergere il limite: nelle chiese «on voitbien la beauté des tableaux, mais on n’estpas asséz près pour en copier toutes les fi-nesses»25. Il nuovo direttore ha altre mire, efin dai primi anni della sua permanenza aRoma si adopera instancabilmente per farentrare i suoi allievi in cabinets prima inac-cessibili: «Malgré le chaud extraordinaire,j’ai parcouru tous les cabinets de Rome, etmalgré ce qu’en dit Monsieur Poerson j’y aitrouvé de très excellents tableaux», scrive alduca d’Antin il 26 settembre 172426. Pro-prio su questo terreno iniziano le incom-prensioni con Charles Poerson, accusato daNicolas Vleughels di fare ben poco per ac-cedere a luoghi inesplorati, preferendo labasilica di San Pietro, la cappella di SantaCecilia affrescata da Domenichino in SanLuigi dei Francesi, le Stanze di Raffaello inVaticano27.Nel dicembre 1729 i pensionnaires ottengo-no il permesso di copiare il Bacco e Ariannadi Tiziano, il Ratto delle Sabine di Pietro daCortona, entrambi in collezione Pamphili,e l’Europa del Veronese, proprietà dei prin-cipi Pio28; nello stesso anno Nicolas Vleu-ghels, grazie al futuro cardinale FrancescoScipione Maria Borghese, riesce a far innal-zare in Vaticano dei ponteggi, per vedere gliaffreschi più da vicino, e può quindi affer-mare con gioia: «Voilà, Dieu merci, le beautemps est venu; les pensionnaires sont di-spersez dans différens palais, qui m'appor-tent le butin qu'ils y font, ce qui leur serad'une grande utilité dans la suite»29.L’attività di copia si intensifica dunque nel-le più belle gallerie nobiliari della città (lemete più ambite continuano ad essere Pa-lazzo Farnese, per gli affreschi dei Carracci,e la Farnesina, o «petit Farnèze», per gli af-freschi di Raffaello), ma continua a svol-gersi anche, come da tradizione, nellechiese («Ansi les campagnes, les églises, lespalais, tout concours à notre education»,dice Vleughels nel 1725)30: il dipinto raffi-gurante San Paolo e Anania, in Santa Mariadella Concezione, è di frequente oggettodell’esercizio degli allievi, insieme al SanMichele di Guido Reni, molto probabil-mente perché entrambi visibili sugli altari adistanza ravvicinata. Carle Vanloo terminala copia della tela di Pietro da Cortona neldicembre 1729, pochi mesi dopo aver con-cluso «pour son étude et par pure charité»,l’affresco sulla volta della chiesa romana diSant’Isidoro, retta dai Francescani irlande-si, raffigurante il santo titolare, legato amodelli cortoneschi; il volto di Isidoro è re-so con intensa carica espressiva, e rifletteinequivocabilmente lo studio delle teste di
56
Edme Bouchardon da Carlo Maratta,La Vergine Assunta, 1723-1732, sanguigna.Parigi, Louvre, Département des Arts graphiques.
Carle Vanloo da Carlo Maratta,Testa della Vergine, 1728-1732, sanguigna.Stoccolma, Nationalmuseum.
53-60 Rizzo:Layout 1 28-06-2011 8:25 Pagina 56
carattere condotto all’Accademia di Francia(«Il y a du génie, de la couleur et de l’exé-cution» commenta Nicolas Vleughels il 7luglio 1729)31.Nel luglio 1730 Carle Vanloo si accinge acopiare un dipinto di Paolo Veronese, dellacollezione Colonna, considerata da NicolasVleughels «sans contredit, la plus belle quisoit dans Rome». Si tratta di una tela raffi-gurante Venere, e viene terminata circa unmese dopo. Vleughels è molto soddisfatto:per la prima volta il principe Colonna ave-va acconsentito a far copiare un’opera al-l’interno del suo palazzo, staccandola dallaparete in modo da rendere più agevolel’operazione32.I Colonna non sono gli unici a esaudire idesideri di Nicolas Vleughels: nel giugno1730 Pierre-Charles Trémolières esegueuna copia dal dipinto di Guido Reni nelpalazzo del principe Giustiniani, aperto perla prima volta agli artisti (la Madonna con ilBambino e i santi Antonio e Paolo); un mesedopo il direttore aspira a «un excellenteVierge du Guide», di proprietà del marche-se Bolognetti; il 28 settembre 1730 il prin-cipe Barberini acconsente a far copiare laMorte di Germanico di Nicolas Poussin; nelnovembre 1724 la meta agognata è il cabi-net del marchese Sacchetti, dove si conser-va il Rapimento delle Sabine di Pietro daCortona, «exstimé de tous les connois-seurs»33. Per i propri scopi Nicolas Vleu-ghels chiede inoltre l’aiuto del cardinaleMelchior de Polignac, che sempre nel no-vembre 1724 si impegna a intercedere pres-so la principessa Pio per far copiare il Rattodi Europa del Veronese. Il prelato si reca so-vente in Accademia, dove si ferma ad osser-vare «les models et les dessins despensionnaires», e coinvolge spesso questiultimi nel restauro dei tesori di antichità dalui ritrovati nelle campagne romane34.Il risultato del frenetico esercizio di copiapromosso da Nicolas Vleughels è la par-tenza, il 25 ottobre 1730, di casse piene didipinti, imbarcate a Livorno con destina-zione Marsiglia: «Il y a cinq caisses: deux trèsgrandes où sont les marbres; une petite oùil y a un modèle de plâtre qu'Adam ose pré-senter à V. G.; une caisse longue où il y aquatre tableaux, sçavoir: une copie de l’En-lèvement des Sabines de P. de Cortone, parNatoire; une d'un Baccanal du Titien, parDelobel; une du Guide du Saint-Michel, parle frère de M. Vanloo; et le Saint Antoine etle saint Paul hermite, par Trémouillère,d'après le même»35. Riguardo alla sculturaNicolas Vleughels è animato dalla stessabrama d’inedito: su suo ordine, infatti, nel1730 viene eseguita per la prima volta lacopia del Fauno Barberini da Edme Bou-chardon, che l’anno successivo terminal’alunnato presso l’Accademia36.
Il 15 marzo 1731 Carle Vanloo sta compo-nendo su indicazione di Nicolas Vleughelsuna tela raffigurante Venere, «dans le goût»di quella del Veronese copiata in Casa Co-lonna. Il nostro pittore affina dunque losguardo e la mano su un rappresentante diprimo piano dell’Ecole de Venise, secondo ildirettore fondamentale modello per il colo-re (come sistematizzato da Roger de Piles),utilizzando poi le conoscenze acquisite percreare un’opera propria37. Grazie al suo gu-sto personale, Nicolas Vleughels focalizzal’attenzione di Carle Vanloo verso la pittu-ra veneziana, a cui il nostro artista si era giàaccostato durante il periodo di studio pres-so l’Académie Royale di Parigi, e a cui si av-vicinerà anche durante il soggiornopiemontese, fra il 1732 e il 1734. È ben co-nosciuta la lettera in cui Nicolas Vleughelsconsiglia agli allievi di recarsi a Venezia, «leplus beau lieu du monde pour la peintureet la couleur», presso il pittore SebastianoRicci, «qui s’offre volontiers à avoir soin desélèves». Insieme a Giovanni Antonio Pelle-grini, Ricci rappresenta un punto di riferi-mento per gli artisti dell’Académie Royaledi Parigi, delle cui adunanze Vleughels è,nei primi anni venti del Settecento, assiduofrequentatore38. Bisogna però aggiungereche Venezia è solo una delle sei città in cuiil direttore consiglia di recarsi, insieme a Fi-renze, Bologna, Parma, Modena, Napoli(dove vive un «très habile peintre nomméSolimène»). Si delinea così un percorso diformazione ideale per i pittori, simile aquello che Vleughels stesso aveva compiu-to una prima volta fra il 1703 e il 1714 cir-ca, e poi all’inizio del 1725, in occasionedel viaggio, favorito dal duca d’Antin, fraFirenze, Piacenza, Parma, Bologna, Mode-na e Venezia, «pour arranger le projet desAcademies d’Italie», discusso a più ripresecon Pierre Crozat39. È in vista di questoprogetto, mai portato a termine, che Nico-las Vleughels in breve tempo intreccia rela-zioni non solo con la nobiltà e il clerofrancesi e romani, ma anche con persone eistituzioni di altre città, come l’AccademiaClementina di Bologna («une des plus bel-les qui soit en Italie»), che nel 1725 chiededi potersi aggregare a quella di Parigi40.
In Piemonte, «con Gallico, E Veneziancarattere»Nicolas Vleughels ha probabilmente influi-to sull’educazione di Carle Vanloo ancheper un altro aspetto: il direttore aveva in-fatti numerose amicizie a Firenze, strette siadurante la sosta in città nel 1725, sia con lafrequentazione, a Roma, del marchese Gre-gorio Alessandro Capponi e del circolo diClemente XII Corsini. Non va escluso che,proprio grazie a questi contatti, fra cui siannoverano anche Francesco Maria Gabur-
ri, e importanti collezionisti come i Mar-telli, egli decida di mandare a Firenze, nelmarzo 1732, Carle Vanloo, colpevole diaver avviato una relazione con una popola-na di Roma, per allontanarlo dall’Accade-mia. Nella città toscana, dove qualchesettimana dopo lo raggiunge il nipote Fran-çois, il pittore continua la sua formazione,prima di arrivare in Piemonte nel luglio173241.
57
Carle Vanloo, Armida trova Rinaldo addormentato,1733. Torino, Palazzo Reale.
Sebastiano Ricci, Mosé salvato dalle acque,particolare, 1727. Torino, Palazzo Reale.
53-60 Rizzo:Layout 1 28-06-2011 8:25 Pagina 57
È infatti con lo stile di Paolo Veronese ne-gli occhi, copiato ripetutamente a Roma, edi Sebastiano Ricci, suo portavoce sette-centesco, ammirato con tutta probabilitàpochi mesi prima a Firenze in Palazzo Ma-rucelli Fenzi, che Carle Vanloo giunge aTorino, in realtà come tappa intermedia delviaggio di ritorno dall’Italia a Parigi, pro-lungatosi poi per due anni42. In Piemontele prime committenze sono ottenute daVanloo grazie a Carlo Emanuele III, salitoal trono nel 1730, e promotore del rinno-vamento delle principali residenze sabaude.Il pittore rende omaggio ai suoi studi filo-veneziani proprio nel primo lavoro esegui-to a Torino, le undici tele con episodi dellaGerusalemme Liberata, previste per l’attualeGabinetto del Pregadio della Regina in Pa-lazzo Reale, pagate interamente nel novem-bre 173343: le pieghe pizzicate, illuminateda rialzi più chiari, delle vesti degli eroi delTasso, rimandano alle soluzioni di Seba-stiano Ricci, in particolare a quelle mostra-te nei lavori della stagione matura, deglianni venti e trenta del Settecento44. Nonsembra un caso che i dipinti del pittore ve-neziano commissionati dalla famiglia Savo-ia risalgano al periodo 1724-1730: eranoquelli i modelli ricceschi che Carle Vanlooaveva sotto gli occhi, mentre procedevanell’esecuzione delle tele per la residenza diCarlo Emanuele III; proprio in PalazzoReale, e nel castello di Rivoli, si potevanovedere molte opere piemontesi del famosoartista, in cui emerge con evidenza lo stu-dio sulla pittura di Paolo Veronese45.Con l’affresco raffigurante il Riposo di Dia-na dalla caccia, sulla volta della Camera daLetto della Regina nella Palazzina di Stupi-
nigi, eseguito dopo il maggio 1733, CarleVanloo dà ulteriore esempio della sua ete-rogenea formazione46. Il confronto con ilvivace e affollato Sacrificio di Ifigenia, di-pinto dal veneziano Giovanni Battista Cro-sato, nel medesimo anno 1733, sul soffittodella contigua Anticamera, porta a vederel’affresco di Vanloo come un lento, elegan-te, scorrere di episodi, che si accostano soloparzialmente al racconto del mito ovidia-no. È la prima volta che il pittore si cimen-ta nella tecnica ad affresco su grandisuperfici: per la costruzione della sua scena,che si dispiega lungo i quattro lati della vol-ta lasciando libero lo spazio centrale, CarleVanloo non ha di certo ignorato due cele-bri modelli, che credo abbia potuto osser-vare dal vivo a Firenze poco tempo prima,nel 1732, durante la sosta in città favoritada Nicolas Vleughels: la grande volta conL’Apoteosi dei Medici, affrescata da LucaGiordano fra il 1683 e il 1685 in PalazzoMedici Riccardi, e La Giovinezza al bivio,affresco realizzato nei primi anni del XVIIIsecolo da Sebastiano Ricci in Palazzo Ma-rucelli Fenzi. Di fronte però alla portata in-novativa di questi due esempi, frutto dellasfolgorante cultura barocca di derivazionecortonesca, il risultato raggiunto da Vanlooa Stupinigi, guardato nei singoli dettagli, sidimostra un tuffo nella pittura mitologica,di ispirazione pastorale e galante, che neglistessi anni arreda le residenze aristocraticheparigine, fatta di bamboleggianti figurefemminili, espressivamente molto simili fraloro (a riguardo Joseph-Jêrome de Lalande,che visita la Palazzina trent’anni dopo, nel1765, commenta: «les compagnes de Dia-ne ont des jolis caractères; mais la figure de
cette Déesse est manquée, il y a trop de res-semblance entr’elle & les Nimphes», disso-ciandosi dagli elogi sull’affresco espressinegli anni Cinquanta da Charles-NicolasCochin e dalla coppia Saint-Non Frago-nard)47. Ma a differenza delle composizioniorchestrate negli hôtels nobiliari francesi,nella prima metà del Settecento, da pittoricome Nicolas Bertin, François Lemoyne,François Boucher, l’affresco di Vanloo ap-pare libero da fronzoli, pacata espressionedel sentimentalismo d’Arcadia. La materiaa cui il pittore dà forma è concreta, croma-ticamente quieta, cristallina nella definizio-ne dei particolari, scelti per ambientare ilracconto in un mondo realmente esistente:basta osservare la trasparenza del ruscello,affiancato da piante lacustri e piccoli arbu-sti, i tronchi a tratti scorticati degli alberisvettanti, le rocce percorse da cascate d’ac-qua, e le pietre grezze su cui siedono alcunedelle ninfe. Un’alternativa alla decorazione,più consapevolmente di rappresentanza,fatta di figure eteree, che emergono flut-tuanti da nuvole leggere e talvolta da vege-tazioni rade e sfumate, proposta daClaudio Francesco Beaumont negli annitrenta del Settecento per le residenze sa-baude, prima della partenza definitiva diCarle Vanloo dal Piemonte alla volta di Pa-rigi, all’inizio del 173448.
Note1 L’elenco degli artisti presenti all’Accademia diFrancia negli anni in cui a Roma è testimoniatoCarle Vanloo comprende inoltre: Nicolas-SébastienAdam, Pierre-François Bernard, Louis-GabrielBlanchet, Michel-François Dandré-Bardon, PierreCoustillier, Guillaume Coustou, Nicolas Delobel,Claude Francin, Etienne Jeaurat, Touissaint Lavoi-sier, Pierre-Etienne Le Bon, Pierre Lestache, Ron-chi, Claude Sordeau, Louis-Michel e FrançoisVanloo: J. Guiffrey, Brevets de pensionnaires à l'Aca-démie de Rome et à l'École des élèves protégés de Paris,in «Nouvelles Archives de l'Art français», I, 1879,pp. 350-392; idem, Liste des pensionnaires de l’Aca-démie de France à Rome, Paris 1908, p. 54; O. Mi-chel, Vivre et peindre à Rome au XVIIIème siècle,Roma 1996, fig. 8-9. Sull’Accademia di Francia cfr.I. Valetta, L’Académie de France à Rome 1666-1903,Torino 1903; H. Lapauze, Histoire de l’Académie deFrance à Rome, 2 voll., Paris 1924; J.-P. Alaux,L’Académie de France à Rome. Ses directeurs, ses pen-sionnaires, 2 voll., Paris 1933. Questi testi si fon-dano principalmente sulla Correspondance desDirecteurs de l'Académie de France à Rome, avec lesSurintendants des Bâtiments du Roi (1666-1903), acura di A. de Montaiglon, 18 voll., Paris 1887-1912, pubblicata a partire dalle lettere conservateall’Archives Nationales di Parigi. Il presente artico-lo costituisce il punto d’avvio delle ricerche per lamia tesi di dottorato in Storia e Critica d’Arte, pres-so l’Università degli Studi di Torino, dedicata allaformazione di Carle Vanloo a Roma e all’ambienteculturale dell’Accademia di Francia fra gli anni ven-ti e trenta del Settecento (relatori G. Dardanello, G.Romano).2 Correspondance, VIII, 1898, p. 93.3 Le spese sostenute dai principi di Carignano per ilsoggiorno a Roma di Jean-Baptiste Vanloo, arrivato
58
Carle Vanloo, Studio per una "gura di ninfa, sanguigna, 1733. Digione, Musée des Beaux-Arts.
53-60 Rizzo:Layout 1 28-06-2011 8:25 Pagina 58
in Piemonte da Nizza nel 1713 con il ruolo di ritrat-tista per la corte sabauda, si seguono bene dai docu-menti conservati all’Archivio di Stato di Torino(Corte, Materie politiche per rapporto all’interno,Archivio Savoia-Carignano, cat. 101, par. 4, n. 1, Li-bro dell’esatto e spese di S.A.S. la Principessa di Cari-gnano, 1714-1720; ivi, n. 3, Registro mandati e spesedella Casa della Principessa di Carignano in Piemon-te, 1720; cat. 102, par. 1, vol. 36, Conti 1714-1716;ivi, vol. 37, Conti 1716-1731; cat. 2, par. 2, vol. 91,Conto dell’anno 1715; ivi, vol. 92, Conto dell’anno1716; Principi del Sangue, Principi di Carignano,mazzo 2, fasc. 19, Stati diversi de Cavalieri, Dame,Officiali e Domestici della Casa del Principe di Cari-gnano). I dati presentati in questo articolo, riguardoai fratelli Vanloo in Piemonte, sono frutto delle ri-cerche condotte per la mia tesi di laurea: A. Rizzo,L’attività di Carle Vanloo in Piemonte, tesi di laureamagistrale in Storia e Conservazione del PatrimonioArcheologico e Storico Artistico, Università degliStudi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, relato-re G. Romano, a.a. 2007-2008.4 È nota la lettera del 27 maggio 1728, in cui Vleu-ghels descrive l’arrivo a Roma di Carle e Louis-Mi-chel Vanloo, accompagnati dal pittore FrançoisBoucher: «Il vient, avec les S.rs Vanloo (qui devro-ient être arrivez), un jeune homme qui a bien du ta-lent»: Correspondance, VII, 1897, p. 420. SuNicolas Vleughels cfr. P. Rosenberg, A propos de Ni-colas Vleughels, in «Pantheon», XXXI, II, 1973, pp.143-153; B. Hercenberg, Nicolas Vleughels peintre etdirecteur de l’Académie de France à Rome 1668-1737, Paris 1976; O. Michel, 1996, pp. 115-138.Riguardo a Polignac: J. Guiffrey, Inventaire du mo-bilier et des collections antiques et modernes du cardi-nal de Polignac, 1738, in «Nouvelles Archives del'Art français», XV, 1899, pp. 252-297; F. de Poli-gnac, Archéologie, prestige et savoir. Visage et itiné-raires de la collection du cardinal de Polignac,1724-1742, in L’Anticomanie. La collection d’anti-quités aux 18e et 19e siècles, a cura di A.-F. Laurens,K. Pomian, Paris 1992, pp. 19-29; A. Dostert, F. dePolignac, La Description historique des antiques ducardinal de Polignac par Moreau de Mautour: unecollection “romaine” sous le regard de l’érudition fran-çaise, in «Journal des Savants», gennaio-giugno2001, pp. 93-151. 5 Correspondance, VIII, 1898, p. 8. Nicolas Vleu-ghels aveva una grande stima sia per Carle, sia perFrançois Vanloo, figlio di Jean-Baptiste, che arrivaall’Accademia di Francia alla fine del 1729 per in-tercessione del cardinale Louis-René-Edouard diRohan e della principessa Pamphili: ivi, pp. 85, 89.6 Parigi, Archives Nationales (d’ora in poi AN), 0/11959, p. 90; Correspondance, VII, 1897, p. 145, 4aprile 1725. Lo studio e la copia delle più belleopere d’arte di Roma erano punti saldi dell’insegna-mento all’Accademia di Francia, come specificatoanche da Jean-Baptiste Colbert nel 1679 a CharlesErrard, primo direttore dell’istituzione: «Il est né-cessaire que vous fassiez un mémoire de tout ce qu’ilya de beaux à Rome, en statues, bustes, vases an-tiques et tableaux en marquant en marge ce quevous avez desja fait copier et ceux qui restent encoreà faire copier»: ivi, I, 1887, p. 92. Sulla questionecfr. F. Haskell, N. Penny, L’antico nella storia del gu-sto. La seduzione della scultura classica 1500-1900,Torino 1984 (ed. or. New Haven-London 1981),pp. 37-42; si leggano anche le osservazioni di A. Le-coy de la Marche, L’Académie de France à Rome, Pa-ris 1874, pp. 1-37; M. Roland Michel, Le dessinfrançais au XVIIIe siècle, Freiburg 1987, pp. 73-85;C. Henry, Lo studio dell’antico nell’Accademia diFrancia a Roma, in Roma e l’Antico. Realtà e visionenel ‘700, a cura di C. Brook, V. Curzi, catalogo del-la mostra (Roma, Fondazione Roma Museo, 30 no-vembre 2010-6 marzo 2011), Milano 2010, pp.139-142.
7 Correspondance, VII, 1897, p. 77. Sul pittoreCharles Poerson, direttore dell’Accademia di Fran-cia dal 1704 al 1724: O. Michel, Charles Poerson, inL’idéal classique. Les échanges artistiques entre Rome etParis au temps de Bellori (1640-1700), a cura di O.Bonfait, Roma 2002, pp. 186-208. Nel 1703, an-cora prima di diventare accademico di San Luca,Poerson entra a far parte dell’Accademia d’Arcadia,con il nome di Timante Cochiano: A.M. GiorgettiVichi, Gli Arcadi dal 1690 al 1800. Onomasticon,Roma 1977, p. 251; O. Michel, 1996, pp. 95-107.8 Correspondance, VII, 1897, pp. 84-85.9 Il 3 agosto 1730 Vleughels commenta: «II ne sefait plus de peintre de paysage; c'est domage, carc’est une belle partie de la peinture. [...]; on ne voitplus de Carache, de Claude Lorrain, de Poussain, deMole, de Fouquières, de Francisque, etc. Peut-êtreviendra-t-il quelqu'un qui relèvera cette partie, quiest presque éteinte» (Correspondance, VIII, 1898, p.131). Vleughels apprezzava inoltre la pittura di pae-saggio di Gaspard Dughet, di cui nel 1730 possede-va dei dipinti: ivi, pp. 103-104; O. Michel, 1996, p.137.10 Correspondance, VII, 1897, p. 86.11 Sui paesaggi di Boucher: R. Shoolman Slatkin,Two Early Drawings by François Boucher, in «MasterDrawings», IX, 4, 1971, pp. 398-403; François Bou-cher 1703-1770, a cura di A. Laing, catalogo dellamostra (New-York, Metropolitan Museum of Art,17 gennaio-4 maggio 1986; Detroit, Institute ofArts, 27 maggio-17 agosto 1986; Paris, GaleriesNationales d’Exposition du Grand Palais, 18 set-tembre 1986-5 gennaio 1987), Paris 1986, pp. 136,157; François Boucher et l’art rocaille dans les collec-tions de l’Ecole des beaux-arts, a cura di E. Brugerol-les, catalogo della mostra (Paris, Ecole NationaleSupérieure des Beaux-Arts, 16 ottobre-21 dicembre2003; Sydney, Art Gallery of New South Wales, 5marzo-1 maggio 2005; Ottawa, National Gallery ofCanada, 16 settembre 2005-1 gennaio 2006), Paris2003, p. 118.12 Correspondance, VIII, 1898, p. 29, 26 maggio1729. Il 24 giugno 1729 Vleughels ribadisce: «Ilfaut, que je croi, dans les beaux-arts, choisir la ma-nière qui nous inspire de l'amour; il ne faut pascontraindre le génie» (ivi, p. 33).13 Ancora nel 1708 Charles Poerson, che entra a farparte dell’Accademia di San Luca nel 1711, diven-tandone principe nel biennio 1721-1722, indicacome unici esempi da studiare a Roma Michelange-lo, Raffaello, i Carracci e Domenichino, salvandotra i contemporanei soltanto Maratta: ivi, III, 1889,p. 241; è solo in seguito alla sua nomina all’Accade-mia di San Luca che compaiono citati per la primavolta nella Correspondance artisti come GiuseppeBartolomeo Chiari, Luigi Garzi, Angelo de’ Rossi eCamillo Rusconi, nel 1715 sconosciuto al ducad’Antin («Je n’avois jamais ouy parler de CamilleRusconi»: ivi, IV, 1893, p. 421). Sui debiti artistici,nel primo Settecento, fra Parigi e Venezia: N. Iva-noff, La France et Venise au dix-huitième siècle. Rela-tions artistiques, in Venise au dix-huitième siècle,catalogo della mostra (Paris, Musée de l’Orangerie,21 settembre-29 novembre 1971), Paris 1971, pp.17-29; P. Rosenberg, Da Raffaello alla Rivoluzione.Le relazioni artistiche fra l’Italia e la Francia, Milano2005, pp. 115-137; V. Toutain-Quittelier, AntonioMaria Zanetti à Paris. L’inspiration retrouvée, in«Revue de l’Art», 157, 3, 2007, pp. 9-22.14 H. Lapauze, 1924, I, pp. 7-9.15 N. Pevsner, Le Accademie d’Arte, Torino 1982 (ed.or. Cambridge 1940), p. 117; E. Coquery, L’anato-mie d’une Académie, in L’idéal classique, 2002, pp.140-161; S. Raux, La reconnaissance des institutions,de l’utilité des nouvelles techniques de fac-similés desdessins, in Quand la gravure fait illusion. Autour deWatteau et Boucher, le dessin gravé au XVIIIe siècle, acura di E. Delapierre, S. Raux, catalogo della mos-
tra (Valenciennes, Musée des Beaux-Arts, 11 no-vembre 2006-26 febbraio 2007), Valenciennes2006, pp. 75-80; L’Académie mise à nu. L’Ecole dumodèle à l’Académie royale de Peinture et de Sculp-ture, a cura di E. Brugerolles, catalogo della mostra(Paris, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts,26 ottobre 2009-29 gennaio 2010), Paris 2009.16 Correspondance, IX, 1899, p. 44.17 Per le accademie sia romane sia parigine di Van-loo cfr. principalmente: Carle Vanloo premier peintredu roi 1705-1765, a cura di M.-C. Sahut, catalogodella mostra (Nice, Musée des Beaux-Arts JulesChéret, 21 gennaio-13 marzo; Clermont-Ferrand,Musée Bargoin, 1 aprile-30 maggio; Nancy, Muséedes Beaux-Arts, 18 giugno-15 agosto, 1977), Nice1977, pp. 169-181.18 Correspondance, VIII, 1898, pp. 324, 373. Un al-tro insegnamento proposto da Vleughels a Roma èl’analisi delle teste di carattere, che aveva radici nel-le teorie sull’espressione di Charles Le Brun, e siesplicava attraverso lo studio sia dei rilievi della Co-lonna Traiana, sistematizzato nelle raccolte di inci-sioni di François Boucher ed Edme Bouchardon(La Colonna Traiana e gli artisti francesi da LuigiXIV a Napoleone I, a cura di P. Morel, catalogo del-la mostra [Roma, Accademia di Francia, 12 aprile-12 giugno 1988], Roma 1988, pp. 68-80), sia dei«veillards d’après nature», una variante didatticanon ancora in uso, negli anni trenta del Settecento,all’Académie Royale di Parigi: Correspondance, VIII,1898, p. 352. Per l’esercizio sulle figure drappeggia-te e sulle teste di carattere favorito da Nicolas Vleu-ghels, con particolare attenzione agli scultori: G.Scherf, Un sculpteur qui dessine: Michel-Ange Slodtz,in Dessins français aux XVIIe et XVIIIe siècles, a curadi N. Sainte Fare Garnot, Atti del Convegno (Paris,24-25 giugno 1999), Paris 2003, pp. 351-366.19 Correspondance, VII, 1897, p. 66.20 F. Joulie, in Esquisses, pastels, dessins de FrançoisBoucher dans les collections privées, a cura di F. Jou-lie, catalogo della mostra (Versailles, Musée Lambi-net, 12 ottobre 2004-9 gennaio 2005), Paris 2004,p. 48, cat. 20. Gli studi romani di Edme Bouchar-don si conservano in larga parte al Département desArts graphiques del Louvre, e nel Vademecum in 2volumi alla Pierpont Morgan Library di New York(Department of Drawings and Prints, B3 030A22).21 Il disegno di Vanloo, a matita nera, viene presen-tato in Carle Vanloo, 1977, p. 140, e più di recenteè comparso nell’asta Piasa a Parigi il 4 dicembre2002, lotto 70, senza indicazioni sul soggetto. Lasanguigna di Edme Bouchardon si trova al Louvre,Département des Arts graphiques (INV 23912recto).22 Correspondance, VIII, 1898, p. 462, 2 luglio1733. Nel Sei e Settecento, a differenza di quantoavviene all’Accademia di San Luca, i direttori del-l’Accademia di Francia sono, per espressa richiestadi Luigi XIV, di norma pittori, come a Parigi, «par-ceque le dessin est la base et le fondement de laSculpture et de l’Architecture»: ivi, III, 1889, p.218, 21 luglio 1708, lettera di Charles Poerson.23 A tal proposito si veda M. Missirini, Memorie perservire alla Romana Accademia di S. Luca fino allamorte di Antonio Canova, Roma 1823, p. 141.24 Lo stravagante modello di lampada si ritrova,schizzato più sommariamente, in un disegno diFrançois Boucher raffigurante proprio il Festino diBaldassarre, riferito al periodo giovanile dell’artista(nello specifico la fine degli anni Venti), e con tut-ta probabilità realizzato a Roma. Per il disegno diBoucher cfr. da ultimo: Esquisses, pastels, dessins,2004, pp. 46-47. Il resoconto del concorso vintoda Carle Vanloo si legge in L’eccellenza delle tre no-bili, e belle Arti, pittura, scultura e architettura...M.DCC.XX.VIII, Roma 1729; Nicolas Vleughels ècitato a p. 67 fra i «Signori Accademici di merito»,
59
53-60 Rizzo:Layout 1 28-06-2011 8:25 Pagina 59
carica che assume su invito di Giuseppe BartolomeoChiari dal settembre 1725, subito dopo la morte diCharles Poerson. A differenza di quest’ultimo, assi-duo frequentatore delle congregazioni accademi-che, Nicolas Vleughels è citato poche volte neglielenchi dei partecipanti (Roma, Archivio dell’Acca-demia di San Luca, Verbali delle Congregazioni,voll. 47-49). Sul disegno di Vanloo: A. Cipriani, E.Valeriani, I disegni di figura nell’Archivio Storico del-l’Accademia di San Luca, 3 voll., Roma 1989, II, pp.181-190; A. Pampalone, in Aequa potestas. Le arti ingara a Roma nel Settecento, a cura di A. Cipriani, ca-talogo della mostra (Roma, Accademia Nazionale diSan Luca, 22 settembre-31 ottobre 2000), Roma2000, cat. II.17, pp. 68-69. Il giorno prima dellapremiazione, il 9 novembre 1728, muore CamilloRusconi, principe dell’Accademia di San Luca dal1727, considerato da Nicolas Vleughels il migliorescultore in Italia, che spesso si recava in PalazzoMancini per osservare i lavori degli allievi: Corre-spondance, VII, 1897, p. 297.25 Ivi, p. 321, 13 febbraio 1727.26 Ivi, p. 64. Cfr. anche la lettera del 27 giugno1724: «J’aurai soin de chercher dans les Cabinetsdes tableaux qui n’ayent point été coppiez, affind’envoyer en France quelque chose excellent et denoveau» (Parigi, AN, 0/1 1959, p. 6).27 Correspondance, VIII, 1898, p. 15. Ne conseguo-no ripicche e scambi di battute velenose: nel no-vembre 1724 Nicolas Vleughels, alla proposta diCharles Poerson di far copiare agli allievi gli affre-schi di Domenichino nella chiesa di San Silvestro,commenta perentorio: «Ce sont des fresque quisont assurément belles, mais qui sont toujours desfresques, c’est-à-dire qu’il y a peu de couleur et parconséquent peu d’effet» (ivi, VII, 1897, p. 90).28 Ivi, pp. 102-103, 109.29 Ivi, VIII, 1898, p. 22, 13 aprile 1729. «A la fin,nous sommes installez au Vatican [...]. C'est la meil-leure étude que l’on puisse faire, surtout pour ceuxqui ont assez de goût pour connoître bien les beau-tez qui sont répandues dans les tableaux de Ra-phaël»: ivi, p. 26, 12 maggio 1729. Anche in SanLuigi dei Francesi vengono installati dei ponteggi,per copiare da vicino gli affreschi del Domenichinonella cappella di Santa Cecilia: ne è bellissima pro-va il disegno di Edme Bouchardon raffigurante ildettaglio della testa della santa dalla scena dell’Ele-mosina, nel registro più alto della parete, a cui loscultore sembra aggiungere una sfumatura veneta eneocinquecentesca (Parigi, Louvre, Départementdes Arts graphiques, INV. 24193 recto).30 Correspondance, VII, 1897, p. 224, 25 ottobre1725.31 Ivi, VIII, 1898, pp. 37, 80. Nell’inventario post-mortem di Vanloo, datato 1765 (Parigi, AN, Minu-tier Central, LV, 122, Inventaire de Carle Vanloo,foll. non numerati), vengono annoverati «Soissanteétudes faites à Rome d’après les plus grands Maîtrespar Carl Vanloo», solo in piccola parte oggi cono-sciuti (possiamo almeno qui citare gli esercizi di co-pia da Carlo Maratta, conservati al Départementdes Arts graphiques del Louvre e al Nationalmu-seum di Stoccolma, e il disegno della Testa di Baccodagli affreschi di Raffaello alla Farnesina, inciso daLouis-Marin Bonnet e da Jean Pelletier). Ma è an-che dall’osservazione dei dipinti della maturità cheemergono alcuni dei modelli da lui studiati a Roma:è il caso ad esempio della tela con San Pietro cheguarisce lo zoppo, realizzata dal pittore nel 1742 perla chiesa parigina di Saint-Louis-en-l’Ile (Carle Van-loo, 1977, p. 55), che rimanda nella scelta composi-tiva alla tela con Sant’Antonio che resuscita un morto,di Andrea Sacchi, visibile a Roma in Santa Mariadella Concezione.32 Di Veronese si conservava in Casa Colonna, nelSettecento, una Venere che disarma Amore: T. Pi-gnatti, F. Pedrocco, Veronese. Catalogo completo
1528/1588, Firenze 1991, p. 246. L’11 luglio 1730Vleughels informa d’Antin che «Hier, j’envoyaiprendre la mesure d’un beau P. Veronese que le frèrede M. Vanloo ira copier avec plaisir et qui, commeje l’espère, lui sera d’un grand profit»; il 24 agosto1730 lo stesso Vleughels afferma: «Hier, Vanlooacheva, au palais Colonne, la copie d’après P. Vero-nese, qui est fort bien; cette manière de peindre luifera grand bien; je chercherai à lui en trouver d’au-tres du même auteur» (Correspondance, VIII, 1898,pp. 124, 136).33 Ivi, p. 118, 15 giugno 1730; p. 126, 20 luglio1730; pp. 145-146, 28 settembre 1730; Parigi, AN,0/1 1959, pp. 32-33.34 Ivi, pp. 7, 23.35 Correspondance, VIII, 1898, p. 154.36 Ivi, p. 145, 30 settembre 1730; F. Haskell, N.Penny, 1984, pp. 286-290; J.-F. Méjanès, Les pen-sionnaires de l’Académie de France à Rome et l’Anti-quité, in La fascination de l’antique 1700-1770.Rome découverte, Rome inventée, a cura di J. RaspiSerra, F. de Polignac, catalogo della mostra (Lyon,Musée de la Civilisation Gallo-Romaine, 20 dicem-bre 1998-14 marzo 1999), Paris 1998, pp. 95-97. 37 R. de Piles, Cours de Peinture par Principes, Ams-terdam-Leipzig 1766 (ed. or. Paris 1708), p. 91. Perla lettera del 13 marzo 1731: Correspondance, VIII,1898, p. 189.38 Ivi, VII, 1897, p. 321, 13 febbraio 1727.39 Parigi, AN, 0/1 1959, p. 73.40 Ivi, p. 132. Nel 1725 Nicolas Vleughels diventaaccademico d’onore dell’istituzione bolognese: G.Zanotti, Storia dell’Accademia Clementina di Bolo-gna aggregata all’Instituto delle Scienze e delle Arti, 2voll., Bologna 1739, II, p. 330. Una prima richiestadi unione fra le istituzioni era già stata avanzata nel1710 dall’Accademia di Bologna attraverso GiovanPietro Zanotti e Luigi Ferdinando Marsili: S. Be-nassi, L’Accademia Clementina. La funzione pubbli-ca. L’ideologia estetica, Bologna 2004, p. 271.41 La vicenda dello scandalo amoroso di Carle Van-loo si segue in Correspondance, VIII, 1898, pp. 318-320. Per i legami di Nicolas Vleughels con Capponie con i Corsini: G. Magnanimi, Inventari della colle-zione romana dei principi Corsini, in «Bollettinod’Arte», 7, 1980, pp. 91-126; O. Michel, 1996, pp.116-134. Si veda anche: F. Borroni Salvadori, Fran-cesco Maria Gabburri e gli artisti contemporanei, in«Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa.Classe di Lettere e Filosofia» serie III, vol. IV, 4, Pisa1974, pp. 1503-1564, in particolare pp. 1515-1526. 42 Correspondance, VIII, 1898, p. 305.43 Le tele della Gerusalemme Liberata incorniciano leporte che mettono in comunicazione il piccolo am-biente del Pregadio, orchestrato nella sua totalità diarredi da Filippo Juvarra fra il 1730 e il 1733, conle due stanze attigue, vale a dire la Camera da Lettoe il Vestibolo dell’Appartamento d’Inverno del Re(le attuali Camera del Lavoro della Regina e Gabi-netto della Toeletta): A. Griseri, Pittura, in Mostradel Barocco Piemontese, a cura di V. Viale, catalogodella mostra (Torino, Palazzo Madama e PalazzoReale; Stupinigi, Palazzina di Caccia, 22 giugno-10 novembre 1963), 3 voll., Torino 1963, II, p. 79;S. Ghisotti, Gabinetto del Pregadio della Regina giàGabinetto dell’Appartamento d’inverno del Re, in Vil-la della Regina. Il riflesso dell’Oriente nel Piemontedel Settecento, a cura di L. Caterina, C. Mossetti, To-rino 2005, pp. 466-469. Per l’iconografia di unadelle undici tele, la Liberazione di Olindo e Sofronia,Carle Vanloo fa riferimento all’analoga scena cheaccompagna il Canto II dell’edizione della Gerusa-lemme Liberata illustrata da Antonio Tempesta nel1735 (La Gerusalemme liberata..., Urbino 1735, p.48). I disegni del Tempesta per questa edizione delpoema, eseguiti fra il 1607 e il 1630, dovevano cir-colare, in fogli sciolti o in raccolta, ben prima del1735, e già nel 1725 ne sono testimoniate delle ri-
produzioni in stampa: N. Bastogi in Torquato Tassofra letteratura, musica, teatro e arti figurative, a curadi A. Buzzoni, catalogo della mostra (Ferrara, Ca-stello Estense, Casa Romei, 6 settembre-15 novem-bre 1985), Bologna 1985, cat. a p. 129.44 La più lucida osservazione sullo stile delle tele diCarle Vanloo è espressa dal pittore Ignazio Nepotenel poema Il Pregiudizio smascherato, Venezia 1770,p. 40: «Nel Gabinetto in piccolo/ Del Tasso son lefavole, /Che fè Vanlò con Gallico, /E Venezian ca-rattere». Ad oggi non abbiamo testimonianza di unsoggiorno del pittore a Venezia, che sarebbe co-munque potuto avvenire nei mesi centrali del 1732,prima della sosta a Torino, lungo la strada di ritor-no verso la Francia.45 Sulle tele di Ricci in Piemonte: N. Gabrielli, Ag-giunte a Sebastiano Ricci, in «Proporzioni», III,1950, pp. 204-211; C. Mossetti, Approfondimentisul Settecento a Torino dai cantieri di restauro, in Sto-ria di Torino, IV, La città fra crisi e ripresa (1630-1730), a cura di G. Ricuperati, Torino 2002, pp.1013-1038; A. Scarpa, Sebastiano Ricci, Milano2006, pp. 308-314. Inoltre nel 1733 è segnalato aTorino in collezione Somis, famiglia a cui apparte-neva la moglie di Vanloo, Cristina, un piccolo di-pinto di Ricci raffigurante «La Fortuna, e LaGiustizia», che ad oggi non compare nel corpus del-l’artista veneziano: A. Baudi di Vesme, I Van Loo inPiemonte, in «Archivio Storico dell’Arte», 1893, VI,fasc. V, p. 359.46 La commissione affidata a Vanloo rientra nel pro-getto di ammodernamento, avviato sotto la guida diFilippo Juvarra nei primi anni trenta del Settecento,che interessa l’ala est del palazzo, in tale periodo adi-bita ad Appartamento del Re. Nell’impresa juvar-riana sono inoltre coinvolti, fra gli altri, i fratelliGiuseppe e Domenico Valeriani, con il loro baga-glio di formazione veneziana e romana, lo sceno-grafo bolognese Girolamo Mengozzi Colonna e ilpittore Giovanni Battista Crosato. Per una biblio-grafia essenziale riguardo a questa fase decorativa al-la Palazzina di Stupinigi: G. Gritella, Stupinigi. Dalprogetto di Juvarra alla premesse neoclassiche, Torino1987, pp. 55-96; A. Griseri, «Aequa potestas» fra ar-chitettura e pittura, in Stupinigi luogo d’Europa, a cu-ra di R. Gabetti, A. Griseri, Torino 1996, pp.59-82; R. Pommer, Architettura del Settecento inPiemonte. Le strutture aperte di Juvarra, Alfieri, Vit-tone, edizione a cura di G. Dardanello, Torino2003, pp. 138-155; G. Dardanello, Circa 1730: Fi-lippo Juvarra e le origini del rococò a Torino, in Dise-gnare l’ornato. Interni piemontesi di Sei e Settecento, acura di Idem, Torino 2007, pp. 173-202.47 J.-J. de Lalande, Voyage d’un françois en Italie..., 8voll., Yverdon 1769-1770, I, 1769, p. 201; C.-N.Cochin, Voyage d’Italie..., 3 voll., Paris 1758, I, p.31; J.-C.-R. de Saint-Non, J.-H. Fragonard, Panop-ticon italiano. Un diario di viaggio ritrovato 1759-1761, edizione a cura di P. Rosenberg, Roma 1986,p. 76.48 Il termine post quem per la partenza di Vanloo edella sua famiglia si ricava da: Torino, Archivio diStato, Insinuazione di Torino, 1734, libro 2, Procu-ra di Madama Christina Antonia Vanlò, 8 gennaio1734, cc. 509r e v. Nel documento Cristina Somisnomina procuratore per i suoi beni in Piemonte ilpadre Francesco Maria; dopo la morte di quest’ulti-mo (avvenuta nel 1735), il compito passa al fratelloLorenzo Somis, che nel 1764 compare come testi-mone, insieme all’ebanista Giovanni Galletti, in unatto notarile riguardante Francesco Ladatte, artistain contatto con i Vanloo sia a Torino sia a Parigi: ibi-dem, Archivio Notarile, Notai di Torino, I versa-mento, Minutario n. 6154, Notaio GaspareTommaso Sella, Quiettanza passata dalli Signori Vit-torio Amedeo e Francesca Rosalia Ladatte Giugali Ci-gnaroli al Sig. Francesco Ladatte, suo suocero, e Padre,1764, cc. 219r-220v.
60
53-60 Rizzo:Layout 1 28-06-2011 8:25 Pagina 60