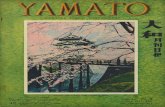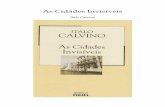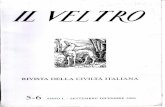La Prefazione 64 di Italo Calvino e la Nota 65 di Carlo Bernari: due manifesti del neorealismo
-
Upload
middlebury -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La Prefazione 64 di Italo Calvino e la Nota 65 di Carlo Bernari: due manifesti del neorealismo
di Enrico Bernard
Carlo Bernari e Italo Calvino non si frequentavano, pur stimandosi e ricambiandosi apprezzamenti in alcuni occasionali incontri. Non vi è traccia di scambi epistolari significativi. Varie circostanze hanno tenuti lontani i due scrittori, che pure militarono nella Resistenza e che, come vedremo, coltivavano molti argomenti ed idee in comune. Non contribuì ai loro rapporti la differenza di età (14 anni) e relative lotte generazionali fino alle contestazioni del Gruppo 63.
Peraltro, la natura riservata dello scrittore ligure poco si confaceva all'esuberanza e alla vena partenopea, schietta e immediata, di Bernari; per cui fino a oggi sono mancate pezze d'appoggio per un confronto ravvicinato tra due dei maggiori autori del Novecento. Calvino ha poi quasi sempre tralasciato di citare Bernari, ma i suoi interventi sul neorealismo non possono non tener conto, anche se indirettamente, di Tre operai del 1934 che rappresenta comunque la vera scintilla, l'incunabolo -‐ lo definì Montale1 -‐ del "nuovo stile" da cui anche la poetica di Calvino prende le mosse. Lo dimostra ad esempio una lettera al traduttore russo Lev Verscinin (Torino, 28 novembre 1957) che segnala Tre operai come uno dei libri da tradurre assolutamente. 2
Alla differenza umana e caratteriale va aggiunto lo "scoglio" rappresentato per Bernari da Vittorini. Lo scrittore di origine siciliana, quando si adoperava all'ombra del fascismo e scriveva sul «Bargello», aveva risposto a spron battuto all'invito di Mussolini nel 1934 di stroncare o ignorare Tre operai. 3 Successivamente nel 1944 Bernari straccia la domanda di iscrizione al PCI, perché 1 MONTALE EUGENIO, Tre operai, in «Corriere della Sera» del 29 maggio 1957, p. 3. 2 CALVINO ITALO, Letters 1941-1985, selected by M. Wood and translated by M. McLaughlin, Princeton, Usa, University Press, 2013, p. 153. 3 E.V [Elio Vittorini], Tre operai che non fanno popolo, in «Il Bargello», VI, 22 luglio 1934, p. 7; poi in: Letteratura arte società. Articoli e interventi 1926-1937, a cura di R. Rodondi, Torino, Einaudi, 1997.
in disaccordo con la politica egemonica in campo intellettuale di Togliatti, così Vittorini, che ne frattempo ha cambiato il tiro e fonda la rivista programmatico-culturale di area PCI «il Politecnico», si sente autorizzato a non ritornare sul suo giudizio, dettato forse anche da una forma di iniziale gelosia4. Quando poi nel 1949 Pavese tenta di portare Bernari alla Einaudi strappandolo alla Mondadori, trova proprio in Vittorini e nel suo influente gruppo un ostacolo ideologico ancorché letterario. "Bada - gli scrive Pavese - i tuoi <amici> a Milano faranno di tutto per farti saltare il premio"5; e ancora: "ti si imputa un certo sinistrismo anarcoide" 6
Naturalmente la posizione di Calvino sul tema dell'engagement e della libertà dell'artista, anche a costo di scontentare l'amico Vittorini che invece idealizza l'eroe positivo - salvo poi dimettersi da "pifferaio" della rivoluzione comunista -, non lascia adito a dubbi. Sia ne Il midollo del leone (1955) che ne Il mare dell'oggettività (1959) Calvino si dimostra in piena sintonia con le posizioni di Bernari e di molti intellettuali e scrittori nel dopoguerra. 7 Tuttavia, il rapporto "privilegiato" con Vittorini, indubbiamente fondato sulla stima - non si discute il valore dell'autore di Conversazioni in Sicilia - ma basato anche su interessi editoriali specifici legati alla Einaudi e a collaborazioni varie, insieme dirigevano Menabò, non agevolò gli scambi con Bernari.
4 Prima della lettura e stroncatura politica di Mussolini (marxista e disfattista, sottolineò il Duce) il fascismo aveva individuato in Tre operai il prototipo del romanzo realista, così come successivamente divenne per il realismo socialista un esempio di nuova letteratura operaia. Di qui l'invidia di Vittorini che si sentì esautorato dal ruolo di avanguardia letteraria cui lo scrittore siciliano aspirava. 5 Il Premio Viareggio fu comunque vinto da Bernari con Speranzella, sia pur ex aequo con Le terre del Sacramento di Jovine. 6 Del caso Bernari-Togliatti e Bernari-Einaudi si è occupato Dario Fertilio. Cfr. FERTILIO DARIO, Carlo Bernari, l'esiliato in casa, in «Corriere della Sera» del 26 novembre 2011, p. 57. Cfr. FERTILIO DARIO, Togliatti censore: «correggete Gramsci,» in «Corriere della Sera» del 2 dicembre 1996, p. 27. Riprova di questo clima di ostilità è anche il rifiuto nel 1949 di «Società», la rivista di area PCI diretta da Gastone Manacorda, un saggio di Bernari sulla paura Nel 1949 Bernari propone a «Società», rispondendo ad un invito della rivista a presentare un intervento sulla condizione operaia, il saggio L'arte è paura i cui appunti risalgono al 1929. La proposta viene rifiutata da Gastone Manacorda e il testo viene pubblicato nel 1950 da «Ulisse». Il manoscritto originario dei 32 pensieri sulla paura del 1929 è pubblicato a cura di Enrico Bernard in «Forum Italicum». Cfr. BERNARD ENRICO, Bernari tra natura e paura con la trascrizione dei 32 pensieri sulla paura di Carlo Bernari, in «Forum Italicum», New York, vol. 42, nr. 2, 2009, pp. 403-15. 7 Cfr. MILANINI CLAUDIO (a cura di), Neorealismo, poetiche e polemiche, Milano, Il Saggiatore, 1980.
Conseguentemente la carenza di rapporti personali ha indotto la critica a non considerare l'importanza del fatto che Bernari e Calvino redigono un intervento critico sulle loro opere giovanili, quindi le più "sentite", quelle dell'esordio, con significativa contemporaneità. Ci riferiamo alla Prefazione 64 per la ristampa de Il sentiero dei nidi di ragno e alla Nota 65 che accompagna la prima edizione Oscar Mondadori (1966) di Tre operai. L'analisi di questi due brani coevi svela invece una rete sotterranea di correlazioni. Va premesso che il periodo è quello conclusivo di un decennale dibattito sull'esito e sul futuro del neorealismo che ispirò anche un poemetto di Pasolini del quale citiamo qualche verso:
Tutti l’avete amato quello stile, ai giorni della speranza: e non senza motivo. Che motivo ora vi impedisce di rimpiangerlo? Ah, ragione! Perduto di nuovo negli oscuri meandri dell’irrazionalità! Elusione, riduzione, elezione stilistica: atti, tutti, alla resa davanti alla reazione! Scusate... il mio cuore è là dentro la bara, con quello stile... Vorrei tacere e basta.8
Dal momento che sia la Prefazione 64 che la Nota 65 nascono in questo clima polemico spesso al limite della disputa e della rissa culturale e ideologica - poiché in discussione è centralmente l'idea di engagement - i versi di Pasolini ne sono evidente testimonianza - e dato che ambedue gli scritti vertono sulle rispettive opere prime, giovanili, bisogna anzitutto individuarne gli elementi in comune, che sono so-stanzialmente duplici: 1) la questione teorica del neorealismo e, 2) la considerazione del significato intimo e spirituale di "giovanilismo".9
Iniziamo da quest'ultima implicazione, perché è la più semplice e immediata da chiarire. La bernariana Nota 65 parte in effetti di slancio, ciò a differenza dello scritto di Calvino che si sofferma inizialmente su argomenti più generali, sul valore e significato di "opera giovanile". Nel 1964 sono passati trent'anni dall'esordio di Bernari e quasi venti da quello di Calvino, così le rispettive "opere prime" sembrano ricadere in una sorta di limbo creativo, in un incunabolo di forze e slanci che suscita qualche comprensibile rossore e qualche inevitabile rimpianto. Scrive Bernari:
Ho esitato a lungo prima di decidermi. Tenerezza e furore, è ciò che provo rileggendo Tre operai. Furore, per quel che esso mi restituisce di arcaico e di falso; tenerezza, per il ventenne che mi ritorna da queste pagine soffuse di mestizia, contrassegno di maturità, direi, se non mi smentissero le lingue di fuoco che spuntano tra rigo e rigo, ad annunciare sdegno, sentimenti di rivolta, paure, da attribuirsi al
8 PASOLINI PIER PAOLO, La religione del mio tempo, Milano, Garzanti, 1961, p. 140. 9 "Giovanilismo" è il neologismo usato da Bernari nella commemorazione di Massimo Bontempelli. BERNARI CARLO, Commemorazione di Massimo Bontempelli», in «L’europa Letteraria», ottobre 1960, p. 7-8.
giovane che non vuol stare al gioco. Quale fosse poi questo gioco dirò meglio avanti rifacendo a ritroso la genesi di questo libro, che apparve il 9 febbraio del 1934.10
Calvino esprime uno stato d'animo analogo:
[…] il primo libro diventa subito un diaframma tra te e l'esperienza, taglia i fili che ti legano ai fatti, brucia il tesoro di memoria - quello che sarebbe diventato un tesoro se avessi avuto la pazienza di custodirlo, se non avessi avuto tanta fretta di spenderlo, di scialacquarlo, d'imporre una gerarchia arbitraria tra le immagini che avevi immagazzinato, di separare le privilegiate, presunte depositarie d'una emozione poetica, dalle altre, quelle che sembravano riguardarti troppo o troppo poco per poterle rappresentare […] le pagine scritte sono lì nella loro sfacciata sicurezza che so bene ingannevole […]11
Non c'è bisogno di citare molto altro per cogliere un comune sentimento tra i due scrittori nei confronti della rispettiva "creatura" giovanile, nonché una riflessione sul dato soggettivo dell'esperienza che nella memoria si oggettivizza, si esterna nella scrittura, cominciando una vita autonoma, nei confronti della quale lo scrittore che guarda se stesso giovane nello specchio del libro si commuove e appassiona. Sarebbe tuttavia ingeneroso e fuorviante pensare solo lontanamente ad una sorta di autocompiacimento letterario in Bernari e Calvino. Quando piuttosto va tenuto presente che questo sentimento ("tenerezza e furore" per Bernari o la "sfacciata sicurezza" di Calvino) comporta un risvolto teorico che va oltre la semplice questione giovanile e un po' sentimentalistica concernente l'opera prima. Non può infatti sfuggire che l'aspetto intimo e riservato è il grimaldello per penetrare nella coscienza dei due scrittori impegnati, proprio nei giorni in cui redigono i loro "paralipomeni", in un dibattito accesissimo sulla problematica soggettivismo-oggettivismo, impegno-fantasia, contenuto-forma, una discussione su cui si gioca la partita dell'interpretazione del neorealismo. E su questo punto le convergenze tra lo scrittore ligure e il suo collega napoletano emergono a tutto tondo.
10 BERNARI CARLO, Nota 65, in Tre operai, Milano, Oscar Mondadori, 2005, p. 159. 11 CALVINO ITALO, Prefazione 1964, in Romanzi e racconti, Milano, Mondadori,, vol. I, pp. 1203-4.
In effetti, la contemporaneità della Prefazione 64 e della Nota 65 non è causale, essa si spiega altresì con le temperie culturali e sulla base del dibattito intorno al neorealismo degli anni Cinquanta e Sessanta che videro i due scrittori tematicamente e ideologicamente solidali, sia pur ciascuno per conto proprio, nel rifiuto di un'idea di engagement da cui lo stesso Vittorini, non volendo passare per "pifferaio della rivoluzione", aveva iniziato a prendere le distanze.12 Nella Nota 65 Bernari riassume la sua posizione retrodatando la nascita della problematica allo scorcio 1929-1934, periodo in cui vide la luce il trittico di opere 13 del protoneorealismo, un genere che scaturisce nell'ottica bernariana da un reazione :
al rifugio dell'ermetismo, dove, scompigliati tutti i moduli formali, molti giovani poterono finalmente riannodare un colloquio con la propria coscienza in un linguaggio sofisticato ma inaccessibile al fascismo.14
Così per Bernari l'impegno dell'artista, l'engagement, scaturisce in primo luogo come diretta, spontanea conseguenza di una riflessione formale, di una nuova idea di rappresentare criticamente la realtà, piuttosto che il risultato di una scelta del contenuto, pur determinante come spiega lo scrittore:
Io non fui tra quei giovani. Commisi altri errori; non per aver chiuso i varchi di comunicazione con la realtà o per aver imboccata una strada interrotta; ma perché avevo raccattato strada facendo qualche scoria. Attaccato su due fronti, politico e letterario, fui tuttavia istigato a difendermi anziché sottoporre il libro a una serena critica. Sentivo di aver adempiuto ad un dovere civile; già l'aver affidato il messaggio a tre operai, invece che a tre piccolo-borghesi mi pareva costituire di per sé un atto di liberazione.15
Non sufficientemente realista nel 1934 per Elio Vittorini, e considerato da alcuni critici in maniera negativa per la "secchezza"16, il romanzo d'esordio di Bernari viene preso tra due fuochi: da un lato "le vie del bello scrivere, dell'ermetismo, del realismo magico, dell'evavasione"17, dall'altro i fautori del realismo fascista, che poi saranno arruolati nel realismo socialista, i quali accusano il romanzo di un approccio individualistico e soggettivistico alla realtà che verrebbe così ad essere deformata coi
12 Cfr. BERNARI CARLO, Risposte a «Questioni sul neorealismo», in «Tempo presente», a. II, n. 7, luglio 1957, pp. 57-60; poi rielaborato col titolo Questioni sul neorealismo in: Non gettate via la scala (v.), pp. 107-12. BERNARI CARLO, Esiste una crisi del neorealismo, in «Rinascita», nr.12, 1953, pp. 684-7. 13 Il riferimento è ovviamente a Moravia (Gli indifferenti, 1929), Alvaro (Gente in Aspromonte, 1928), Bernari (Tre operai, 1934, ma iniziato nel 1928--30 col titolo Gli Stracci). 14 BERNARI Nota 65, cit. p. 162. 15 Ivi. 16 Di "secchezza" parla ad esempio Eurialo De Michelis in una lettera personale a Bernari del marzo 1934. La missiva è stata pubblicata da Francesca Bernardini nell'edizione da lei curata per l'Oscar Mondadori 2005 di Tre operai (pp. 230-232). 17 TOSCANI CLAUDIO, Introduzione a: BUZZATI DINO, Il segreto del bosco vecchio, Milano, Mondadori, 1979, p. 9.
toni propri della fiaba18. Quella stessa fiaba proletaria che sarà il canone espressivo, e non è un caso, dell'editor di Tre operai Cesare Zavattini per il romanzo Totò il buono (1943) e il film Miracolo a Milano (1951). A questo proposito Bernari spiega:
Così la riduzione di quanto ancora risultava oggettivo - senza peraltro diventare oggettivante - in "Tempo passato" (la prima stesura di "Tre operai" datata 1928-30, ndr.), a quel particolare soggettivismo in terza persona di Tre operai, si avvaleva anche di quel processo presentificante, grazie all'accumulo di materiali realistici - fatti, cose, ambienti, personaggi - sottratti alla realtà viva e collocati a una distanza caliginosa e polverosa che facesse memoria.19
Ma il concetto di "memoria" assume centralità anche nell'autoanalisi letteraria di Calvino:
Per coloro che da giovani cominciarono a scrivere dopo un'esperienza di quelle con "tante cose da raccontare" (la guerra, in questo e in molti altri casi), il primo libro diventa subito un diaframma tra te e l'esperienza, taglia i fili che ti legano ai fatti, brucia il tesoro di memoria - quello che sarebbe diventato un tesoro se avessi avuto la pazienza di custodirlo, se non avessi avuto tanta fretta di spenderlo, di scialacquarlo, d'imporre una gerarchia arbitraria tra le immagini che avevi immagazzinato, di separare le privilegiate, presunte depositarie d'una emozione poetica, dalle altre, quelle che sembravano riguardarti troppo o troppo poco per poterle rappresentare, insomma d'istituire di prepotenza un'altra memoria, una memoria trasfigurata al posto della memoria globale coi suoi confini sfumati, con la sua infinita possibilità di recuperi… Di questa violenza che le hai fatto scrivendo, la memoria non si riavrà più […]20
Il richiamo alla "memoria coi suoi confini sfumati" può coincidere con una forma storica, oggettivante, di recupero del passato, ma rappresenta, per lo meno in campo creativo, letterario, un fattore soggettivo che richiama l'artista alla forma tipica della "rimembranza" spesso nebulosa, avvolta nel mito, in cui i ricordi stessi si mescolano a sensazioni, percezioni, odori e sapori che rivivono nello spazio chiuso e ristretto del "vissuto" interiorizzato. Lo scrive Calvino a chiare lettere:
Così mi guardo indietro, a quella stagione che mi si presentò gremita d'immagini e di significati: la guerra partigiana, i mesi che hanno contato per anni e da cui per tutta la vita si dovrebbe poter continuare a tirar fuori volti e ammonimenti e paesaggi e pensieri ed episodi e parole e commozioni: e tutto è lontano e nebbioso, e le pagine scritte sono lì nella loro sfacciata sicurezza che so bene ingannevole, le
18 Carlo Bernari parla di "favola" a proposito di Tre operai: "fu così che invece della storia scrissi una storia, un romanzo, cioè, o se più piace una favola" (sottolineatura nell'originale, ndr). BERNARI CARLO, Ciminiere e rifiuti, in Bibbia napoletana, Vallecchi, Firenze 1960, p. 67. 19 BERNARI Nota 65, cit. p. 166. L'espressione "facesse memoria" è sottolineata nel testo originale. 20 CALVINO, Prefazione 1964, in Romanzi e racconti, cit., p. 1203.
pagine scritte già in polemica con una memoria che era ancora un fatto presente, massiccio, che pareva stabile, dato una volta per tutte […]21
Di qui il rimpianto di una realtà "vera" sfuggente, inenarrabile, proprio perché offuscata dalla "materia interiore, spirituale" come afferma Bernari proseguendo o anticipando la riflessione di Calvino:
Quante cose, certo, avrei potuto dir meglio; non scriverle meglio, ma dirle meglio; riuscire a mettere più cose, più sentimenti, più significati nella parola: aprirla, dilatarla a maggiori profondità, moltiplicandone gl'interni echi, affinché dal testo emergessero con evidenza le allegorie, i simboli che forse confusamente vi avevo disseminato. 22
L'impossibilità, visti i limiti confessati sia da Bernari che da Calvino, di pervenire ad una rappresentazione veristica, oggettiva, laddove piuttosto la memoria si perde nel meccanismo rappresentativo propria della "memoria creativa", ossia la fantasia, smentisce in partenza l'ipotesi di engagement sul piano contenutistico sia di Tre operai che de Il sentiero dei nidi di ragno. Così infatti prosegue Bernari nella Nota 65:
Mi sarebbe piaciuto, allora, difendere il contenuto di verità del libro da ambizioni allegoriche del genere; ma la critica del tempo era troppo ligia al potere per inseguire i miti del proletariato; mentre quella posteriore, ormai abbacinata dal neorealismo, si sperdeva nella ricerca dei prototipi dell'engagement. È vero che se un movente allegorico c'era io stesso avevo contribuito a obliterarne le linee con riferimenti realistici, ora troppo evidenti, ora troppo sfumati.23
Va notato come, in entrambi gli scritti, si ripeta il concetto di una "memoria dai confini sfumati" (Calvino), quasi un richiamo senz'altro involontario, ma che stabilisce una consonanza particolare tra i due scrittori. In conclusione Bernari tira le somme con una commovente ammissione:
Quelle erano le mie forze; e nel tempo in cui scrivevo non potevo rammaricarmi di non aver gettato il sasso abbastanza lontano; già molto mi pareva averlo lanciato e averne fatto avvertire la pericolosità.24
21 CALVINO, Prefazione 1964, in Romanzi e racconti, cit., pp. 1203-4. 22 BERNARI Nota 65, cit. p. 171. 23 BERNARI Nota 65, cit. p. 174. 24 BERNARI Nota 65, cit. p. 175.
Italo Calvino scrive Il sentiero una dozzina di anni dopo la pubblicazione di Tre operai. La caduta del fascismo, la mitizzazione di fatti e personaggi della Resistenza, l'apertura del mondo letterario a nuove tecniche ed esigenze narrative, una visione più chiara e cosciente del rapporto tra pagina e schermo, tra letteratura e cinema, tra narrativa e arti visive più in generale; e ancora, la soluzione del problema affrontato da Bernari, ma ancor prima di lui da Verga25, della questione del realismo e del verismo che viene risolta, sia da Verga che in seguito da Bernari, sul piano della forma26 come incunabolo di ogni contenuto reale, politico o sociale - ebbene, a queste conclusioni, difficili nei primi anni Trenta come accenna Bernari nella Nota 65, ma scontate quando lo scrittore ligure comincia a scrivere Il sentiero a conflitto concluso, Calvino perviene elaborando un concetto di realtà attraverso la "sfumata" memoria. È grazie ad essa che lo scrittore recupera alcuni episodi e racconti che vengono mano a mano avvolti nel mito e nella nebbia del tempo, alterandoli e modificandoli in base a suggestioni che trasformano la realtà in una sorta di iperrealismo fantastico, che sarà poi la connotazione specifica delle opere calviniane e anche un terreno di confronto con Carlo Bernari.
Nella Prefazione 1964 Calvino naturalmente non si esime dall'intervento a favore di una interpretazione più soggettiva e formalistica che oggettivo-contenutistica con la nota frase:
[…] mai si videro formalisti così accaniti come quei contenutisti che eravamo, mai lirici così effusivi come quegli oggettivi che passavamo per essere.27
Il plurale, non solo majestatis, di Calvino rappresenta un'allusione o indicazione importante. Noi, già, ma noi chi? Così insiste Calvino, con quel "noi" ripetuto:
Il "neorealismo" per noi che comiciammo di lì, fu quello […] Perché chi oggi ricorda il "neorealismo" soprattutto come una contaminazione o coartazione subita dalla letteratura da parte di ragioni extraletterarie, sposta i termini della questione; in realtà gli elementi extraletterari stavano lì tanto massicci e indiscutibili che parevano un dato di natura; tutto il problema ci sembrava fosse di poetica, come trasformare in opera letteraria quel mondo che era per noi "il" mondo.28
Tra i compagni di viaggio in questa avventura del neorealismo nel dopoguerra Calvino cita alcuni coetanei, in particolare Pavese e Fenoglio. E, a proposito di un 25 Non casualmente Bernari fu inizialmente definito dalla critica "neoverista". Cfr. ARISTARCO [E. Zazo], Un neo-verista: Carlo Bernard , in «L'Italia Letteraria», anno X, n. 14, 8 aprile 1934, pp. 9-10. Per un approfondimento cfr. BERNARD ENRICO, I più segreti legàmi. Sinergie neorealiste nel carteggio Bernari-Zavattini, Roma-Trogen, BeaT, 2014. 26 Cfr. BONTEMPELLI MASSIMO, Verga, Discorso pronunziato il 15 febbraio 1940 alla Reale Accademia d'Italia in Roma, in Sette discorsi, Milano, Bompiani, 1942, pp. 123-55. 27 CALVINO, Prefazione 1964, in Romanzi e racconti, cit., p. 1187. 28 Ivi.
"nostro realismo che doveva essere il più possibile distante dal naturalismo" l'autore del Sentiero individua una linea, "una specie di triangolo: I Malavoglia, Conversazione in Sicilia, Paesi tuoi, da cui partire".29 Però a questo punto, un po' bruscamente, Calvino apre una parentesi e ammette candidamente:
(Continuo a parlare al plurale, come se alludessi a un movimento organizzato e cosciente, anche ora che sto spiegando che era proprio il contrario. Come è facile, parlando di letteratura, anche nel mezzo del discorso più serio, più fondato sui fatti, passare inavvertitamente a contar storie… Per questo, i discorsi sulla letteratura mi danno sempre più fastidio, quelli degli altri come i miei).30
Calvino taglia insomma corto, salvo riprendere la polemica letteraria con maggiore veemenza qualche pagina dopo. Soffermiamoci per un istante su quel "triangolo" cui egli accenna: Verga, Vittorini, Pavese. Una triade che ha una forte valenza anche per Bernari. Come precedentemente accennato, Verga è indubbiamente il punto di partenza dell'evoluzione narrativa di Bernari alla fine degli anni Venti, tanto da essere definito egli stesso "neoverista".31 Ma se Verga rappresenta per lo scrittore napoletano una piattaforma di lancio nell'elaborazione di un nuovo stile, di una nuova forma espressiva in sinergia con le arti visive, a partire dalla fotografia32, Vittorini è indubbiamente per Bernari come abbiamo visto uno scoglio insormontabile. E Pavese interviene come mentore nel tentativo, un po' ingenuo per la verità, di "sdoganare" Bernari e introdurlo alla Einaudi.33 Insomma, quella "specie di triangolo da cui partire", cui accenna Calvino, diventa nel bene e nel male anche la via crucis di Bernari .
È indubbio peraltro che nella polemica sul formalismo Bernari e Calvino si ritrovano fianco a fianco, non certo fautori di disimpegno effimero, ma per garantire all'artista (Moravia in un famoso intervento propugna le stesse idee34) la più ampia autonomia creativa e critica della realtà.
Occorre a questo punto introdurre la lettera di Bernari a Zavattini del 21 febbraio 1933 che segue la spedizione a Milano del dattiloscritto di Tre operai. In particolare bisogna valutare con attenzione il paragone che propone Bernari a proposito della letteratura sradicata dall’impegno come un “fiore” profumato ma inutile; un paragone che, vent’anni dopo, torna nel succitato intervento di Moravia.
Non so questo libro come potrà sembrarti dal punto di vista puramente estetico. Non per mettere le mani avanti, ma per chiarire la sua funzione in questo 29 Ivi. 30 CALVINO, Prefazione 1964, in Romanzi e racconti, cit., p. 1188. 31 ARISTARCO [E. Zazo], Un neo-verista: Carlo Bernard , in «L'Italia Letteraria», anno X, n. 14, 8 aprile 1934, pp. 9-10. 32 Per i rapporti di Vetga con le arti visive cfr. MINGHELLI GIULIANA, L’occhio di Verga. La pratica fotografica nel Verismo italiano, online: http://ebookbrowsee.net/003-minghelli-verga-x-doc-d132393274 33 Le lettere di Pavese a Bernari, in cui emerge l'ammissione "a Milano non ti vogliono… ti imputano un anarchismo sinistrorso" sono pubblicate da Dario Fertilio nel «Corriere della Sera», v. nota precedente. 34 MORAVIA ALBERTO, Il comunismo al potere e i problemi dell’arte, in «Nuovi Argomenti», a. I, n. 1 (1953), marzo-aprile, p. 3-4.
ambiente e in questo momento, vorrei dirti alcune cose: credo che la parte, diciamo “programmatica”, abbia inficiato il suo significato puramente lirico. Chi infatti lo giudicasse coi metri dell’estetica idealistica, lo troverebbe certamente arido e senza respiro; chi lo giudicherà invece – come potrai farlo tu, per la posizione che hai assunto nella letteratura italiana – fuori dalle file del crocianesimo, tenendo d’occhio, ossia, prima che l’ispirazione lirica, la sua funzione etica e politica, potrà forse – dico: forse! – trovarvi qualche cosa di buono, potrà forse vedere nella sua aridezza il mezzo più onesto per il fine che la mia posizione ideologica mi consentiva di raggiungere. – Non vorrei adesso accodarmi al treno della rettorica corrente intorno ad un’arte a contenuto sociale; ma penso, dal mio modesto punto di vista, – senza per questo voler dar spago ai gazzettieri che si sono messi a strombazzare ai quattro venti la necessità di un’arte di contenuto, fino a far perdere a questo concetto il suo valore – ma penso, dicevo, che l’arte sradicata dal terreno della lotta economica e politica, è un bel fiore di cartapesta: avrà colori smaglianti, ma sa sempre d’anilina; potrà essere profumata, ma sentirà sempre di morte.35
A distanza di trent'anni, nella Prefazione 1964, Calvino chiude la polemica sull'engagement con una dichiarazione netta in sintonia con quanto sostenuto da Bernari: Oggi, in genere, quando si parla di “letteratura impegnata” ci se ne fa un’idea sbagliata, come d’una letteratura che serve da illustrazione a una tesi già definita a priori, indipendentemente dall’espressione poetica. Invece, quello che si chiamava “engagement”, l’impegno, può saltar fuori a tutti i livelli; qui vuole innanzitutto essere immagini e parola, scatto, piglio, stile, sprezzatura, sfida.36
Calvino, parlando del contesto in cui nacque il romanzo Il sentiero dei nidi di ragno, storicizza insomma la sua osservazione facendone un vero e proprio caso, anche personale, con un esplicito riferimento a Vittorini quando accenna criticamente alla questione dell’Eroe positivo:
Cominciava appena allora il tentativo d’una “direzione politica” dell’attività letteraria: si chiedeva allo scrittore di creare l’”eroe positivo”, di dare immagini normative, pedagogiche, di condotta sociale, di milizia rivoluzionaria. Cominciava appena, ho detto: e devo aggiungere che neppure in seguito, qui in Italia, simili pressioni ebbero molto peso e molto seguito. Eppure, il pericolo che alla nuova letteratura fosse assegnata una funzione celebrativa e didascalica, era nell’aria: quando scrissi questo libro l’avevo appena avvertito, e già stavo a pelo ritto, a unghie sfoderate contro l’incombere d’una nuova retorica.37 La testimonianza di Capozzi, definito da Bernari stesso “il mio biografo”, dell’ultimo incontro con lo scrittore napoletano in un ristorante nei pressi di Ponte Milvio a Roma rappresenta l'ideale suggello a questa analisi e il raccordo perfetto con le tesi di Calvino:
35 Lettera dattiloscritta, con correzioni e aggiunte manoscritte, firma manoscritta “Bernard”, datata 21 febbraio 1933, pubblicata in Tre operai, a cura di F. Bernardini, cit. pp. 215–7 (Archivio Cesare Zavattini, Biblioteca Panizzi, Reggio Emilia). 36 CALVINO, Prefazione 1964, cit., p. 1192. 37 CALVINO, Prefazione 1964, cit., p. 1193.
Alla fine di agosto del 1988, in un piccolo ristorante buio nei pressi di Ponte Milvio, ebbi l’ultimo colloquio con Carlo e gli chiesi se voleva essere conosciuto come un autore impegnato; la sua risposta ci riporta all’inizio del nostro discorso e ai rapporti tra Paolo Ricci e Bernari: «Se per impegno s’intende l’engagement sartriano, cioè quell’obbedienza alle regole politiche di questo o quel partito, mestiere che fu battezzato da pifferai, certamente mi trovi congedato. Se invece per impegno vuol intendersi rettamente quel processo che trova lo scrittore come coscienza e come conoscenza conflittuale del mondo reale, allora mi reputo più che impegnato, asservito a quest’opera alla quale mi sono votato da molti decenni.» E quindi, realismo spettrale, realismo critico, realismo linguistico, o qualsiasi altro tipo di realismo che possiamo identificare nelle opere di Bernari, va ribadito che alla base della sua narrativa c’è sempre la realtà socio–storica abbinata all’arte e alla cultura del tempo. La sua finzione è sempre ricchissima di richiami alla realtà e alle verità nascoste della società che viene descritta e indagata in ogni opera. In breve, è sempre la realtà a mettere in moto la fantasia dell’autore. Ma una volta che la realtà, come quella della sua città nativa, entra nell’immaginazione di Carlo Bernari, e cioè una volta che si dissolve in “libera fantasia”, ecco come questa diventa una menzogna narrativa ben costruita, o meglio, un’ingegnosa macchina conoscitiva alla ricerca di verità nascoste sotto la cosiddetta realtà che ci circonda.38 Gli assunti teorici dei due scrittori hanno naturalmente comportato numerose ricadute ed effetti sulle rispettive opere. La rivendicazione calviniana di una realtà rimodellata, rielaborata attraverso "la memoria globale coi suoi confini sfumati" (Calvino) che "si avvaleva anche di quel processo presentificante, grazie all'accumulo di materiali realistici - fatti, cose, ambienti, personaggi - sottratti alla realtà viva e collocati a una distanza caliginosa e polverosa che facesse memoria" (Bernari) contribuisce a creare una forma letteraria in cui l'Io narrante deve in qualche modo ripresentificare il vissuto sotto forma di riminiscenza. Così scrive Calvino: Il protagonista simbolico del mio libro fu dunque un'immagine di regressione: un bambino. Allo sguardo infantile e geloso di Pin, armi e donne ritornavano lontane e incomprensibili; quel che la mia filosofia esaltava, la mia poetica trasfigurava in apparizioni nemiche, il mio eccesso d'amore tingeva di disperazione infernale [...] Se un valore oggi riconoscoa questo libro è lì: l'immagine d'una forza vitale ancora oscura in cui si saldano l'indigenza del "troppo giovane" e l'indigenza degli esclusi e dei reietti.39
38 Rocco Capozzi ha intervistato per l’ultima volta Carlo Bernari a Roma nel luglio del 1989, circa sei mesi prima dell’ictus che colpì lo scrittore. La risposta citata da Capozzi è quella rielaborata da Bernari in una lettera, l’ultima indirizzata al “suo biografo”, del settembre 1989. L’intervista a Carlo Bernari di Rocco Capozzi è pubblicato su «Forum Italicum» nr. 1, 1994, p. 381 e seg. 39 CALVINO, Prefazione 1964, cit., p. 1200.
I sentimenti espressi da Calvino trovano però piena corrispondenza nell'incipit della Nota 65, laddove Bernari parla di "tenerezza e furore per il ventenne che mi ritorna da queste pagine […] contrassegno di maturità, direi, se non mi smentissero le lingue di fuoco che spuntano tra rigo e rigo, ad annunciare sdegno, sentimenti di rivolta, paure, da attribuirsi al giovane che non vuol stare al gioco".40 Si potrebbe a questo punto obiettare che il paragone tra il bambino Pin, l'Io narrante del Sentiero e Teodoro, il ventenne protagonista di Tre operai, risulta azzardato, se non altro per via della differenza d'età tra i due personaggi. Tuttavia, bisogna ricordare che mentre Pin è comunque una sorta di versione infantile di un ragazzo più grande -‐ la distanza della memoria calviniana rimpiccolisce e allontana la figura del romanzo nel tempo del mito come abbiamo visto -‐ Teodoro Barrin di Bernari è ach'egli un bambino cresciuto, un immaturo che trova o meglio smarrisce a sua volta "il sentiero", ossia, fuor di metafora, la strada della rivoluzione proletaria. Con la quale Teodoro sembra voler giocare come un bambino con una pistola giocattolo, le armi che stringe nelle tasche del pastrano prima di essere arrestato nel corso di una manifestazione sindacale. Certo è che Teodoro affronta la sua parabola esistenziale, la sua caduta, proprio con l'ingenuità e l'incoscienza tipiche di un fanciullo. Dimensione, questa, che Bernari sottolinea nelle battute conclusive del romanzo per ben due volte: "Non mandarmi via!" fa Teodoro, intuendo che la cosa sta risolvendosi in suo favore. E si appoggia con un fianco alla spalliera del letto, come a voler stabilire con quel contatto una familiarità. Da quel punto vede in uno specchio la sua faccia di bambino. Moreau41 malediva quella sua faccia da bambino.42 In questo frangente allo scrittore suona certamente un campanello, poiché nel romanzo è presente un'altra figura di bambino, Pippetto il figlio di Anna che muore di stenti nel sonno tra le braccia di Marco. Così pare di rivivere la scena della fine del piccolo, anche se in questo caso a concludersi tragicamente è la vicenda di Teodoro: La fronte gli si imperla di sudore. A chiudere gli occhi gli pare che il suo corpo si gonfi, mentre il letto nella mente diventa sempre più piccolo. Suda, col capo chino sul letto: l'odore nauseante dei suoi panni gli torna alle nari e nella mente gli appare il suo corpo sempre più grosso e disfatto. Solo il viso gli è rimasto, quel maledetto viso da bambino […]43 Non bisogna trascurare il fatto che la figura del bambino o del giovane immaturo assumono un ruolo centrale nella letteratura italiana, soprattutto in questa fase del neorealismo. Vale la pena di ricordare alcuni esempi: I bambini ci
40 Brano precedentemente citato. 41 Frederic Moureau giovane personaggio de L'educazione sentimentale di Gustave laubert. 42 BERNARI , Tre operai, cit.. p. 156. 43 BERNARI , Tre operai, cit.. p. 157.
guardano il film di De Sica del 1943 tratto dal romanzo di Pricò che inaugurò la collaborazione con Cesare Zavattini. Collaborazione bissata nel 1948 con Ladri di biciclette, tratto dal romanzo di Luigi Bartolini, in cui ancora una volta il protagonista è un bambino. Non più bambino, ma un bambinone cresciuto è anche Totò il buono, romanzo di Zavattini da cui poi il grande binomio del cinema italiano trasse Miracolo a Milano. L'insistenza su Zavattini non è del resto casuale, dato che fu proprio il genio di Luzzara a "scoprire" Carlo Bernari nel 1934 e a fare da editor a Tre operai. Ma al di là di queste significative relazioni, il tema del bambino si potrebbe sviluppare in più direzioni, dalla raccolta di racconti dello stesso Bernari Siamo tutti bambini pubblicata da Vallecchi nel 1951 al più recente (1968) Mondo salvato dai ragazzini di Elsa Morante. La lista potrebbe allungarsi di parecchio, ma non è nostra intenzione concentraci sul tema del bambino nella letteratura italiana. Tuttavia bisogna riscontare una profonda sintonia, una corrispondenza tra l'intuizione di Bernari dei racconti di Siamo tutti bambini e Il sentiero di Calvino. Uno sguardo al testo pubblicitario dell'edizione Vallecchi del 1951 di Siamo tutti bambini è illuminante: […] trovano posto nove racconti che rappresentano i nove momenti dell'Anima Bambina; quale alberga non solo nel fanciullo, bensì anche nel petto dell'adulto, portato, dalla sua stessa brutalità e dalla stessa dinamica della sua corrotta morale, a fingersi bambino per sfuggire alla Punizione. La Punizione del Cattivo non è un'invenzione della favola, destinata al libro per l'infanzia, ma è un pericolo che noi ci portiamo dietro dai miti della fanciullezza fino all'orlo della tomba, il cui presagio condiziona la nostra vita seminandola di Paure. Nascono così, intorno al più lungo (intitolato "Il pedaggio si paga all'altra sponda", quasi un romanzo) i nove racconti che rappresentano i nove momenti che la Paura sceglie per manifestarsi a noi, sia attraverso la credulità del bambino, sia attraverso la maschera bambinesca che l'uomo adotta nel fingersi bambino, illudendosi di sottrarre così al Terrore, tra un gioco e l'altro gioco. Nove può sembrare persino un numero-‐cabala, o un numero iniziatico, tanto assomiglia ai nove sensi del concepimento; talché ogni racconto sembra rispondere con un'avventura terrena, dominata da uno spavento, ai grandi "Perché" che i "bimbi-‐adulti" e gli "adulti-‐bimbi" si pongono.
Il volantino ha di certo una paternità autoriale e non solo redazionale. Lo stile, la tematica, i concetti sono farina del sacco di Bernari. Tuttavia, se si prendessero pensieri e concetti e li si trasferissero, sotto mentite spoglie, in una presentazione del Sentiero di Calvino, essi non sfigurerebbero minimamente. Tanto da far nascere il velato sospetto di un collegamento più diretto e meno casuale. A ben vedere le date non contraddirebbero questa ipotesi. Siamo tutti bambini è datato editorialmente 1951. Ma il volumetto è una raccolta di racconti precedentemente scritti e pubblicati da Bernari tra il 1937 e il 1943. In
particolare Il pedaggio si paga all'altra sponda, che è la narrazione su cui si impernia la raccolta di Siamo tutti bambini, viene pubblicato nel 1943 nel periodico «Lettere d'Oggi». Dal momento che Bernari rappresenta proprio in quegli anni una sorta di modello letterario per la nuova generazione di scrittori, infatti Tre operai fu pubblicato da Zavattini proprio nella collana Rizzoli "I giovani", risulta impossibile che Calvino non li abbia, se non tutti almeno Il pedaggio, attentamente letti. Oltretutto, proprio nel 1943 «l'Unità» affida a Bernari il compito di redigere una corrispondenza sui GAP romani durante l'occupazione nazista. Una vicenda che per ovvie ragioni Calvino segue da vicino. Pur non volendo montare un "giallo" letterario risulterebbe, alla luce di queste osservazioni, che Calvino nella stesura del Sentiero non possa non essersi in qualche modo riferito, basato e ispirato all'opera e all'attività politico-‐giornalistica di Bernari. Così la funzione del "bambino" di Calvino, quella fuga nei ricordi della memoria sfumata come esorcizzazione di un mondo pauroso e violento abitato dal Pericolo e della Punizione, ci riporta al mito della fanciullezza la cui origine si perde nei tempi antichi della filosofia e della letteratura, ma che trova nel binomio Paura=Fascismo teorizzato da Bernari un fondamento moderno e attuale. Tanto che la "novità" de Il sentiero non gli sfugge. In particolare il personaggio del bambino protagonista, Pin, al quale Bernari sembra ispirarsi nella stesura della sceneggiatura del capolavoro del cinema sulla Resistenza, Le quattro giornate di Napoli diretto da Nanni Loy nel 1962. Infatti uno dei protagonisti del film è un bambino, Gennaro Capuozzo ribattezzato "Cazzillo" perché molto piccolo, il quale, esattamente come Pin, confonde la lotta armata con un gioco eroico e vi si unisce, tirato dietro da una banda di scugnizzi -‐ la banda Ajello -‐ che fuggono dal riformatorio per farsi combattenti antinazisti e liberare la città, con tutta la santa ingenuità e spontaneità della sua tenera età. Solo che "Cazzillo", alias Gennaro Capuozzo, è un personaggio reale, Medaglia d'Oro al valor militare alla Memoria44, caduto in battaglia. In uno scatto storico di Frank Capa potrebbe proprio esserci lui, il grande-‐piccolo "Cazzillo".
44 Questa la motivazione depositat presso l'archivio del Quirinale: Appena dodicenne durante le giornate insurrezionali di Napoli partecipò agli scontri sostenuti contro i tedeschi, dapprima rifornendo di munizioni i patrioti e poi impugnando egli stesso le armi. In uno scontro con carri armati tedeschi, in piedi, sprezzante della morte, tra due insorti che facevano fuoco, con indomito coraggio lanciava bombe a mano fino a che lo scoppio di una granata lo sfracellava sul posto di combattimento insieme al mitragliere che gli era al fianco. Prodigioso ragazzo che fu mirabile esempio di precoce ardimento e sublime eroismo. Napoli, 28-29 settembre 1943.
Nel film, scritto da Bernari con Vasco Pratolini e Festa Campanile, la vicenda del bambino-‐partigiano che muore tirando una bomba a mano contro un tank nazista non mira a enfatizzare il tema dell'eroismo popolare e della "rivolta eroica". Infatti la figura del bambino in armi, in sintonia col Pin di Calvino, non viene ideologizzata con finalità retoriche, ma è trattata all'interno del fenomeno della guerra, nella sua tragica e inintellegibile realtà. Pin e Cazzillo non sono così testimoni di una scelta ponderata e ragionata: si trovano per puro caso con le armi in pugno al fianco dei partigiani, come in un gioco avvincente più grande di loro che li spinge ad emulare comportamenti adulti. Alcuni fotogrammi del film confermano questa interpretazione senza bisogno di ulteriori commenti.
Occorre però fare una precisazione: come detto, Gennaro Capuozzo non rappresenta un personaggio di fantasia, quindi la fonte di ispirazione di Bernari non può essere direttamente il Pin di Calvino. Salvo ovviamente l'uso letterario che entrambi, sia Calvino che Bernari, fanno del mito del bambino-‐partigiano. In effetti sia Pin che il Cazzillo del film nascono sulla base di un personaggio reale e ben noto della storia della Resistenza opportunamente messo in risalto da una ricostruzione di Edoardo Pansini del 194445 che lo stesso Calvino dovrebbe aver fatto in tempo a leggere prima della sua creazione letteraria. Sarebbe oltretutto di una semplicità estrema, finanche imbarazzante, se si dovessero spiegare, al lettore e allo spettatore di due capolavori della narrativa e del cinema come Il sentiero e le Quattro giornate, le coincidenze e le similitudini che modellano dui personaggi "bambini" come Pin e "Cazzillo". Basti qui dire che il loro rapporto con la vita difficile di quei giorni, le loro "prese di campo" ingenue, infantili, di fronte a quei terribili epifenomeni degli adulti che si chiamano guerra, violenza, terrore, paura, morte, sono talmente correlati che potrebbero fondersi in un unico personaggio: il bambino stritolato dalla guerra che si eleva eroicamente a coscienza morale, osservatore e giudice, ancorché attore in prima persona dell'immane tragedia cui prende parte per emulazione, gioco, spirito e appartenenza di gruppo. Bernari, raccontando l'estenuante lavoro di preparazione e sceneggiatura del film durato ben quattro anni a partire dal 1958, si sofferma sui tagli occorsi durante la lavorazione al piano originale; ebbene, uno di questi riguarda il finale dedicato, nelle intenzioni degli sceneggiatori, proprio a "Cazzillo", ovvero Gennarino Capuozzo. Ma prima di dire della nona scena tagliata, vorrei accennare ai finali: nel copione ve ne erano due, uno più autentico (la morte del sottocapo Pitrella che non ce la fa a raggiungere Sorrento) l’altro più tragico, che più avanti descriverò. Ne fu preferito, in sede di montaggio, un terzo, che non era un vero e proprio finale, ma che aveva l’unico pregio di non chiudere su un singolo personaggio, che avrebbe per ciò solo assunto l’importanza di protagonista, guastando la coralità del film. Il finale a cui mi ero affezionato narrava la processione delle bare dei caduti, fra le quali, quasi nascosta, c’era una piccolissima bara, quella di Gennarino, che sua madre Concetta, ancora cerca fra le gambe della gente che si è riversata sulla via. Concetta viene assalita, nella commozione generale, da un tragico presentimento. Attraversa allora la strada, urtando la folla che si assiepa ai due bordi, raggiunge i ragazzi che portano in spalla quel piccolo feretro e chiede loro: “Come si chiamava?” Ma i compagni non hanno mai saputo il suo nome: lo avevano ribattezzato con un nomignolo e rispondono: “E chi lo sa. Noi lo chiamavamo Cazzillo”. Concetta non sa trattenere un egoistico sospiro di sollievo; meno male, non è lui. Ma subito si pente, consapevole che quel suo sospiro significherà lagrime per un’altra mamma. E mai immaginando che lì dentro quelle rozze assi c’è il corpicino del suo Gennarino, un minuscolo eroe, essa chiede perdono al cielo e non riesce a cancellarsi un sorriso
45 PANSINI EDOARDO, Goliardi e scugnizzi nelle Quattro Giornate napoletane, Napoli, Edizioni Cimento, 1944. Questo è il testo che precede la stesura de Il sentiero di Calvino.
fra le lagrime. Sorriso che diventa un tragico riso quando una polvere bianca comincia a caderle addosso, e tutti intorno a lei si trasformano in bianchi fantasmi disperdendosi mentre un camion avanza dietro le bare aspergendo dall’altro il ddt in polvere. Sono arrivati gli Alleati, sterilizzano, disinfettano prima di prendere possesso della città che si è liberata da sé. E su quel bianco che si espande e s’infittisce, il quadro si chiude.46
Sarebbe difficile e sicuramente forzato cercare ulteriori analogie tra il finale tagliato delle Quattro giornate e la conclusione del Sentiero. In entrambi tuttavia appare la figura materna, evocata da Cugino nelle ultime pagine del romanzo e rappresentata da Bernari come la Mater dolorosa in cerca del corpicino del figlio falciato da una raffica di mitraglia che avrebbe dovuto chiudere il film. La prova decisiva? La "pistola fumante" di questa "sintonia a distanza" di due scrittori così diversi, eppure così vicini? Ebbene, in questa sorta di inchiesta letteraria tornano utili alcune concomitanze editoriali. Nel 1973 Bernari raccoglie in volume per la Mondadori una parte della sua saggistica letteraria ed altri scritti; il titolo del volume è molto significativo Non gettate via la scala.47 Il titolo prende spunto da una citazione di Wittgenstein in calce all'edizione, ma è in realtà un messaggio più o meno in codice lanciato… a chi, se non a Italo Calvino? Lo scritto di apertura della raccolta bernariana La zanzara industriale cita e commenta direttamente alcuni interventi di Calvino, nominato espressamente a pagina 15, in particolare gli scritti calviniani su Fourier e l'utopia48. Su questi argomenti occorrerà ampliare la disamina, ma è indubitale che tra Calvino e Bernari intercorra un "botta e risposta" a suon di interventi che si integrano e comprendono a vicenda, come ad esempio quelli sulla natura e teoria del romanzo, sull'engagement, sul marxismo, e tanti altri temi. Proprio in questa prospettiva si spiega il titolo che Bernari sceglie da una asserzione di Wittgenstein: Non gettate via la scala. Si tratta di una frase rivolta direttamente a Calvino. Infatti lo scrittore ligure all'inizio degli anni Sessanta comincia a spingere sull'acceleratore della dimensione fantastica, dell'ironia e del tragicomico, della leggerezza (che sarà ampiamente teorizzata in una delle sue Conferenze americane). Il barone rampante, personaggio che per alienarsi dalla realtà va a vivere sulle cime degli alberi, è un romanzo del 1957 che anticipa il crescente desiderio di isolamento di Calvino stesso che in seguito decide di trasferirsi a Parigi per concentrarsi sul suo lavoro e riflettere sulla sua esperienza interiore e la sua attività letteraria. Bernari non critica né boccia 46 BERNARI CARLO, Le mie faticose quattro giornate, in «Cinema Nuovo», novembre- dicembre 1963, pp. 428-35. Cfr. BERNARD ENRICO, Mio padre Carlo Bernari e le Quattro giornate di Napoli. Vi racconto io come è nata l’idea del film, in «Corriere del Mezzogiorno», martedì 12 giugno 2007, p. 10. BERNARD ENRICO, Bernari e il cinema, in «Esperienze Letterarie», Pisa, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, XXXI, 2006, n. 4, pp. 5-26. 47 BERNARI CARLO, Non gettate via la scala, Milano, Mondadori 1973. 48 Cfr. FOURIER CHARLES , Teoria dei quattro movimenti, Il nuovo mondo amoroso e altri scritti sul lavoro, l'educazione, l'architettura nella società d'Armonia. Scelta e introduzione di Italo Calvino; traduzione di Enrica Basevi, Einaudi, Torino 1971. I saggi su Fourier e l'utopia marxista sono poi stati raccolti in: Calvino Italo, Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1981
l'evoluzione letteraria di Calvino, sempre più orientato al genere "fantastico", anzi considera questo sviluppo intrinseco e necessario allo stesso neorealismo49. Una dimensione che, del resto, Zavattini aveva già ampiamente raggiunto con Totò il buono e col film Miracolo a Milano. Tuttavia, e in questo "tuttavia" è racchiuso il messaggio, più o meno cifrato, che Bernari spedisce a Calvino, l'artista nel suo volo pindarico, nella sua dimensione fantastica, nel suo isolamento, non può chiudersi in una "torre d'avorio"; e non deve mai gettare via la scala che lo collega alla realtà, la vita, da cui parte ogni rappresentazione che voglia elevarsi a critica, anche se astratta, del mondo. Per dirla chiaramente con una battuta di Goethe sulla funzione dell'artista: "testa fra le nuvole, ma piedi piantati per terra."50 Nel 1981 Calvino raccoglie i suoi scritti e saggi fiolosofico-‐politici e letterari nel volume Einaudi Una pietra sopra. Naturalmente non si tratta di una risposta diretta a Bernari. Ma l'ennesimo "caso" che unisce i destini, insomma li fa diventare universi paralleli, dei due scrittori che sembrano così lontani, monadi di una ricercata dimensione solitaria e individualistica, ma che in realtà corrispondono intellettualmente e idealmente. Ripetiamo che Calvino con Una pietra sopra non intende rispondere direttamente a Non gettate via la scala. Ma appunto: non direttamente, ma indirettamente sì -‐ o meglio lo segue in questa esigenza di chiudere il proprio percorso e discorso teorico. A differenza di Bernari, Calvino non cita lo scrittore napoletano, il quale però a sua volta segue il più giovane autore del Sentiero passo passo, facendogli addirittura, come si suol dire, "le pulci". Nella biblioteca51 di Carlo Bernari abbiamo rinvenuto una copia del volume Einaudi chiosata a matita dall'autore di Tre operai che meticolosamente segna pagine e argomenti di suo interesse. Sia perché sono punti che egli stesso ha affrontato in precedenza, sia perché gli possono fornire nuovi spunti per successive analisi. L'ultima pagina bianca del libro elenca i passi che Bernari ritiene di maggior interesse e degni di essere sottolineati, la calligrafia è indiscutibilmente sua. Scriver chiaro 119 Dialetto 121 Lingua 122 Scienza e letteratura 129 Lingua e discorso sul mondo 131 Beckett catastrofe 134 Opere come 1/2 (mezzo, ndr.) di prod. " " 138 Letteratura e filosofia 151 Filosofia della scienza 154 Satira comico 157 Il nemico da espellere 198 Illuministi Fourier 238 Socialismo avvenire 251 49 Cfr. CAPOZZI ROCCO, Bernari tra fantasia e realtà, Napoli Società Editrice Napoletana, 1984. 50 ECKERMANN, Colloqui con Goethe, a cura e traduzione di Enrico Bernard, Roma, E&A, 1992. 51 Il "Fondo Carlo Bernari" si trova presso la Biblioteca Alessandrina di Roma.