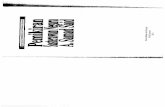La critica come vocazione: Edward W. Said e l'etica dell'intellettuale
Transcript of La critica come vocazione: Edward W. Said e l'etica dell'intellettuale
Idee
SEMESTRALE DI FILOSOFIA E SCIENZE SOCIALI ED
ECONOMICHE
Nuova serie N. 4 2012
MILELLA
ISSN 0394-3054
Anno II/Nuova Serie, n. 4, Luglio/Dicembre 2012 Direttore responsabile: Mario Signore Proprietà: Lecce Spazio Vivo S.r.l. Via Palmieri, 30 • 73100 Lecce Tel. 0832.241131 Iscrizione Tribunale di Lecce: n. 666 del 14.10.2011 • Semestrale Direzione e redazione e amministrazione della rivista hanno sede presso il Monastero delle Benedettine Via delle Benedettine, 5 • 73100 Lecce Ogni corrispondenza concernente abbonamenti, fascicoli e/ o annate arretrate, ecc. deve essere inviata a: Editrice Milella - Lecce Spazio Vivo Viale De Pietro, 9 73100 Lecce [email protected] Abbonamento annuale: euro 30,00 • Un fascicolo: euro 18,00 Abbonamento per l’estero: € 50,00
Idee
SEMESTRALE DI FILOSOFIA E SCIENZE SOCIALI ED ECONOMICHE
Nuova serie N. 4 2012
Direttore: Mario Signore Comitato scientifico: Stefano Adamo (Università del Salento), Luigi Alici (Università di Macerata), Carlo Alberto Augieri (Università del Salento), Emilio Baccarini (Università di Roma “Tor Vergata”), Ferdinando Boero (Università del Salento), Francesco Botturi (Università Cattolica di Milano), Cosimo Caputo (Università del Salento), Franco Cassano (Università di Bari), Virgilio Cesarone (Università di Chieti), Claudio Ciancio (Università del Piemonte Orientale), Ivo De Gennaro (Università di Bolzano), Pietro De Vitiis (Università di Roma "Tor Vergata”), Vito A. Gioia (Università del Salento), Maria Giordano (Università di Bari), Alberto Granese (Università di Cagliari), Piergiorgio Grassi (Università di Urbino), Klaus Held (Universität Wuppertal), Michele lndellicato (Università di Bari), Alberto Nave (Università di Cassino), Paolo T. Pellegrino (Università del Salento), Raffaele Persico (IBAM-CNR Lecce), Antonio Pieretti (Università di Perugia), Bernardo Razzotti (Università di Chieti-Pescara), Armando Rigobello (Università di Roma), Franco Rizzi (Università di Roma 3 - Unimed), Giorgio Rizzo (Università del Salento), Mario Signore (Università del Salento), Christian Smekal (Universität Innsbruck), Rainer Thurner (Universität Innsbruck), Franco Totaro (Università di Macerata), Lorenzo Vasanelli (Università del Salento), Wilhelm Vossenkuhl (Universität München), Stefano Zamagni (Università di Bologna).
Comitato di redazione: Antonio Aresta, Michele Bee, Lidia Caputo, Flora Colavito, Luca Cucurachi, Claudio D'Alessandro, Emanuela De Riccardis, Giulia D'Andrea, Maurizio Daggiano, Roberta Fasiello, Giacomo Fronzi, Luca Nolasco. Segretario di redazione: Emanuela De Riccardis Progetto grafico della copertina: Yukiko Tanaka Semestrale di Filosofia e scienze sociali ed economiche aperto alla collaborazione di specialisti italiani e stranieri si raccomanda agli studiosi e agli appassionati di una cultura del confronto e della ricerca libera e propositiva. Accoglie contributi di orientamento multidisciplinare raccolti in miscellanee, anche se sono previsti fascicoli monotematici (vedere informazioni a fine fascicolo).
VINCENZO SALVATORE
La critica come vocazione: Edward W. Said el’etica dell’intellettuale
From his first publications to the last posthumous writings, inconnection with Gramsci’s political reflection, Vico’s philologicalapproach and in regard to the American academic world, the intellectualwork of Edward W. Said has always been presented as a free anddemocratic, skeptic and genuinely critical instance, aimed at highlightingall the mundane implications of worldwide cultural productions. Fightingagainst the growing specialization of the scientific discourse whichtransformed the criticism in a very powerful instrument for thetransmission or exclusion of particular messages, Said claimed for areconsideration of Humanism in order to recover the moral value of theintellectual activity as a way to enlighten the understanding of reality,rather than to obscure it. Said founded in Vico and Auerbach that ethicalvocation to science, that is criticism, which the German philosopher MaxWeber had depicted in his 1917 remarkable conference Science as aVocation. The result is a radical democratic criticism grounded on a highlyrigorous method of analysis capable of facing the complex challenges of amodern globalized world, while providing a valuable syntheticcomprehensive understanding of global topics and issues.
Dall’analisi letteraria alla critica postcoloniale il pensiero diEdward W. Said ha fortemente caratterizzato il dibattito culturalecontemporaneo ed ha radicalmente ridefinito l’ambito degli studiumanistici: al centro di tutto viene posto il rapporto tra i testi ed ilpotere, in maniera più specifica tra la cultura e l’imperialismo. Nellesue reminiscenze biografiche il critico arabo-palestinese sottolinea lanatura paradossale dell’identità come concetto fondamentale dellacultura nel mondo globalizzato e migrante. Il paradosso dell’identitàposto a confronto con l’ambizione egemonica della cultura dominantedispiega una diversa storia della letteratura e del pensiero rispetto alla
Laureato in Lingue e Letterature Moderne presso l’Università degli Studi diBari Aldo Moro
78 Vincenzo Salvatore
progressione della storiografia tradizionale: in tutti i testi letterari sievince questa ‘realtà’ di forze contrapposte e di lotte tra dominanti edominati che si oppone radicalmente alla lettura lineare dell’interesseegemonico.
Parallelamente al discorso postcoloniale Said approfondisceampiamente il ruolo dell’umanesimo e dell’intellettuale in seno allacultura euro-americana e lo rende il punto pivotale del suo pensierosocio-politico rispetto alle analisi letterarie e storiche.
Il rapporto tra l’intellettuale e l’umanesimo nella contemporaneità èil tema portante del volume emblematicamente postumo Humanism andDemocratic1 Criticism, in cui vengono rielaborate alcune conferenzetenute negli anni tra l’11 settembre 2001 e la morte del critico nelsettembre 2003. I cinque brevi capitoli di questo volume tentano di dareuna rappresentazione dello stato attuale della critica accademica aconfronto con le istanze conservative ed eversive della società, delruolo pubblico dell’intellettuale contemporaneo nel mondo globalizzatodella guerra al terrorismo, e dello “stato delle lettere”. Il punto dipartenza è la “sfera umanistica”2 nella sua accezione generale:
[…] il vero soggetto di questo libro non è l’umanesimo tout court,tema in ogni caso troppo vago e vasto, ma il rapporto tra l’umanesimo ela pratica critica, l’approccio umanistico, cioè, in quanto capace diinformare il modo di agire di un intellettuale di un accademico cheinsegna discipline umanistiche oggi, nel nostro mondo turbolento. […]Mi interessa piuttosto considerare gli studi umanistici come unostrumento per gli intellettuali e gli accademici che vogliano essereconsapevoli di ciò a cui sono chiamati in quanto studiosi e chedesiderino mettere in relazione questi principi con il mondo in cuivivono come cittadini.3
Prendendo come pubblico di riferimento l’accademia americana, ilsuo scopo è cercare di ridefinire la sfera umanistica nelle suecomponenti fondamentali: attacca l’umanesimo nel nome
1 E. W. SAID, Humanism and Democratic Criticism, Columbia UniversityPress, New York 2004; traduzione italiana a cura di M. FIORINI, Umanesimo ecritica democratica, Il Saggiatore, Milano 2007.2 Op. cit., p. 31.3 Op. cit., pp. 32 e 36.
La critica come vocazione 79
dell’umanesimo stesso, per ritrovare quel senso genuino di attivitàintellettuale aperta e cosmopolita, un approccio scevro da ambizionesistematiche, radicato nei testi e nelle lingue, tanto legato alla tradizionequanto attento alle ‘voci’4 emergenti provenienti dai nuovi luoghi delmondo globalizzato, spesso prodotte in condizioni eccezionali didisagio e sofferenza, e perciò fonti vive della letteratura dellacontemporaneità. Non si tratta di stilare una serie di attributi per un’umanista tipo’, ma di concentrarsi sul senso concreto dell’attivitàumanistica:
Siamo inoltre continuamente spinti a riflettere sul sensodell’umanesimo perché tante parole del discorso dominante hanno nellaloro radice l’“umano”, e lo declinano nel senso di umanistico eumanitario.5
Come possiamo opporci a tale usurpazione? Come possiamocondividere la definizione di un bombardamento o di un’azione militarecome “intervento umanitario”6? In che modo è possibile guardareall’umanesimo per il nostro futuro? Secondo Said “il modo più diretto econcreto per giungere al cuore dell’umanesimo è passare perl’esperienza personale”7. Le particolari esperienze biografiche vissutehanno reso Said un essere umano, prima ancora che un intellettuale,esiliato, rifugiato, migrante, senza patria, senza casa, decentrato:
Una delle più infelici caratteristiche della nostra epoca è quella diaver prodotto profughi, migranti, senza patria, esuli in misura superiorea tutta la storia precedente, in gran parte come corollario e, ironia dellasorte, come conseguenza dei grandi conflitti post-coloniali e imperiali.Così come la lotta per l‘indipendenza ha generato nuovi stati e nuoviconfini, ha generato anche vagabondi senza casa, nomadi, accattoni,non assimilati alle strutture del potere istituzionale che andavaemergendo, rifiutati dall’ordine stabilito a causa della loro intransigenza
4 Op. cit., p. 72.5 Op. cit., p. 36.6 Ibid. Said fa riferimento ad Ulrich Beck che definì l’intervento della Natonella guerra in Kosovo una “nuova politica post-nazionale di ‘umanesimomilitare’ per il rispetto dei diritti umani, […] una miscela di generositàumanitaria e logica di potenza” in BECK, Ecco l’era delle guerre post-nazionali, “Reset” 54, 1999.7 Op. cit., p. 38.
80 Vincenzo Salvatore
e ostinata ribellione. E fintanto che tra il vecchio e il nuovo, tra ilvecchio impero e il nuovo stato, esisterà questa gente, la lorocondizione non potrà che esprimere le tensioni, le indecisioni e lecontraddizioni presenti nei territori che vengono parzialmente acoincidere, e che possiamo osservare sulla mappa culturaledell’imperialismo.8
Essere genuinamente umani ed umanistici significa essere sempre‘nel mezzo’, sempre ‘interessati’, sempre pronti ad incrinare il dominiodell’interesse egemonico che informa qualunque tipo di tradizione perriappropriarsi dell’agency umana negata dal sistema dominante.L’elemento soggettivo è pertanto connaturato all’umanesimo stesso enon può essere ignorato, come allo stesso tempo non può essereignorato il contesto del mondo secolare: la fallibilità del soggetto è lacondizione necessaria per lo sviluppo della storia, perché la storia è ilsusseguirsi delle azioni umane.
1. La tragica imperfezione della conoscenza
La parola chiave che collega i vari nodi del piano saidiano è“mondano”. Questo termine indica il rapporto tra i testi, il mondostorico reale, le sue circostanze concrete e le sue rappresentazioni nellaletteratura e nel discorso intellettuale da cui non è possibile prescindere.Scrive a proposito di Orientalism9:
Le mie critiche si basavano sulla consapevolezza della naturaimperfetta di tutte le rappresentazioni e sul fatto che ognirappresentazione è radicata nella <<mondanità>>, ovvero è legata alpotere, alla posizione sociale e agli interessi. […] nessun processo ditraduzione dell’esperienza in espressione è scevro da contaminazioni.Ogni processo di rappresentazione è ab origine necessariamente
8 E. W. SAID, Culture and Imperialism, Knopf Publishing Group, New York1993; traduzione italiana a cura di M. A. Saracino, S. Chiarini e A. Tagliavini,Cultura e imperialismo. Letteratura e consenso nel progetto colonialedell’Occidente, Gamberetti, Roma 1998, p. 363.9 E. W. SAID, Orientalism, Penguin Classics, London 2003; pubblicatooriginariamente negli USA da Pantheon Books, New York 1978; traduzioneitaliana a cura di S. GALLI, Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente,Feltrinelli, Milano 2008.
La critica come vocazione 81
contaminato dal coinvolgimento con il potere, la posizione sociale e gliinteressi, che ne sia vittima o no. La mondanità […] implica lacontaminazione e il coinvolgimento, poiché in ogni caso la storia e lapresenza di molti altri gruppi e individui rendono impossibile liberarsidalle proprie condizioni materiali di vita.10
Said nota come proprio nel cuore dell’umanesimo ci sia laconcezione del mondo storico come una realtà ‘secolare’ e ‘mondana’,dove gli uomini e le donne sono i principali attori della storia. Unmondo che deve essere interpretato esclusivamente secondo principirazionali e umani, cioè storici. Giambattista Vico ne La Scienza Nuovapresentava per la prima volta la fondamentale comprensionedell’insostenibilità di una concezione eterna ed immutabile della naturaumana, perché è l’uomo che produce attivamente la conoscenza e lastoria:
Nihil est in intellectu quin prius fuerit in sensu, cioè che la menteumana non intenda cosa della quale non abbia avuto alcun motivo (ch’imetafisici d’oggi dicono occasione) da’ sensi, la quale allora usal’intelletto quando, da cosa che sente, raccoglie cosa che non cade sottode’ sensi, lo che propiamente a’ latini vuol dir intelligere.11
Tale conoscenza è però caratterizzata dalla “indiffinita natura dellamente umana”12 che pone un’irriducibile imperfezione, personalistica,inesatta e drammaticamente tragica nella costituzione dell’umanesimo.Questa imperfezione connaturata è in realtà la forza principaledell’umanesimo come progetto di emancipazione ed edificazionedell’essere umano. Per Said l’umanista è l’intellettuale che accettaquesta visione radicalmente ‘tragica’ dell’essere umano e decide diagire e pensare secondo l’imperativo etico dell’interesse per l’altro. Ladecadenza delle discipline umanistiche deriva allora da un complessoquanto inesorabile processo di aziendalizzazione delle accademie daparte degli interessi commerciali del mercato che contemporaneamentedelegittima il senso di una attività intellettuale ‘disinteressata’:
10 SAID, Umanesimo e critica democratica, pp. 75-76.11 G. VICO, La Scienza Nuova, 1744, a cura di F. NICOLINI, Opere, BibliotecaTreccani, Roma 2006, [363].12 Op. cit., [120].
82 Vincenzo Salvatore
E così ci inaridiamo senza che nessuno ci compianga e ci ricordi.Le discipline umanistiche sono ormai considerate innocue e incapaci diesercitare un qualche effetto su chicchessia.13
L’umanesimo dovrebbe riguardare l’educazione e lo studioformativo di alto livello in senso universale secondo una prospettivache riguarda: […] la storia secolare, i prodotti del lavoro umano e lacapacità umana di espressione articolata. […] L’umanesimo è laconquista della forma tramite la volontà e l’azione umane.14
Un’attività, ancora meglio una ‘attitudine’, che deve essere intesacome un processo di democratizzazione dell’interesse critico, non comeun sapere segreto di una tradizione secolare riservato ad un éliteristretta. L’umanismo non è esclusione, oscurantismo, elitarismo econtrollo egemonico. Al contrario, bisogna intenderlo comedemocratico, egalitario, solidale, interessato all’uomo perché esso possaessere un: processo di rivelazione e scoperta senza fine, un processo diautocritica e di liberazione. Potrei addirittura arrivare a dire chel’umanesimo è critica, critica diretta allo stato attuale delle cose, fuori edentro l’università, e che trae la sua forza dal proprio caratteredemocratico, secolare e aperto.15
L’umanesimo deve essere considerato il risvolto partecipativo dellacittadinanza, come responsabilità dell’individuo nella società collettiva:perché l’interpretazione del passato, la comprensione del presente e laprevisione del futuro sono il prodotto del lavoro civile. Un lavoro che èun diritto, inteso come agency, cioè come la concreta possibilità diazione dell’uomo nel mondo. Un agire che, però, è anche un dovere darispettare in un esercizio per il bene comune, scevro da pregiudizi,egoismi e intolleranze. La diffusione della cultura e della tolleranza, deidiritti e delle responsabilità dell’individuo sono i cardini di questaattitudine alla conoscenza, senza mai dimenticare, però, la graveosservazione di Walter Benjamin che: «il patrimonio culturale haimmancabilmente un’origine a cui non [si] può pensare senza orrore.Esso deve la propria esistenza non solo alla fatica dei grandi geni che lohanno creato, ma anche alla schiavitù senza nome dei loro
13 SAID, Umanesimo e critica democratica, p. 44.14 Op. cit., p. 45.15 Ibid.
La critica come vocazione 83
contemporanei. Non è mai documento di cultura senza essere, nellostesso tempo, documento di barbarie. E come, in sé, non è immunedalla barbarie, non lo è nemmeno il processo della tradizione per cui èpassato dall’uno all’altro»16.
Bisogna sempre essere consci che il potere presente si autorizza innome del patrimonio culturale di cui si proclama erede. Se la barbarie èil prodotto del processo attraverso il quale la cultura viene trasmessa oimposta, la responsabilità dell’umanesimo è quella di restituire la giustainterpretazione di tale patrimonio, di tale processo e di tale cultura. Sela tradizione è la barbarie, bisogna recuperare ciò che è statoconsiderato abietto perché: “l’inumano sta tra noi come messaggero diun più reale umanesimo.”17 Per questo motivo Said si scaglia contro gliumanisti che considerano la ‘loro’ cultura come intoccabile euniversale, come unica fonte di salute e redenzione. Perché è proprio“nel contatto con le energie, gli scossoni, le sorprese e le deviazioni diciò che da sempre si presenta sotto forma del nuovo e del diverso”18 chesi può sviluppare una società gravida di promesse e speranze per ilfuturo. Se è vero, come avevano già rilevato Hobsbawn e Ranger19, cheil tentativo di omogeneizzare le molteplicità e soffocare le diversitàattraverso l’imposizione di un’unica identità è alla base dellacostituzione delle nazioni moderne, Said ne denuncia la trasformazionein un business: “L’invenzione di una tradizione è diventata un affareanche troppo fiorente”. Ecco perché è necessario un rinnovamentodell’idea dell’umanesimo per fare fronte alle sfide globali dellacontemporaneità:
[…] non è un modo per consolidare e affermare quello che <<noi>>abbiamo sempre saputo e sentito, ma piuttosto un mezzo per
16 W. BENJAMIN, Schriften, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Mein 1955;traduzione italiana a cura di R. SOLMI, Angelus Novus, Einaudi, Torino 1962-1995, p. 79.17 W. BENJAMIN, Karl Kraus, Frankfurter Zeitung, 1931; traduzione italiana acura di E. GIANNI, Opere complete III. Scritti 1928-1929, Einaudi, Torino2010.18 SAID, Umanesimo e critica democratica, p. 53.19 E. J. HOBSBAWN e T. RANGER (a cura di), The Invention of Tradition,Cambridge University Press, New York 1983; traduzione italiana a cura di E.BASAGLIA, L’invenzione della tradizione, Einaudi, Torino 2002.
84 Vincenzo Salvatore
interrogare, mettere in discussione e riformulare ciò che ci vienepresentato sotto forma di certezze già mercificate, impacchettate,epurate da ogni elemento controverso e acriticamente codificate.20
Contro queste tendenze oscurantiste Said propone uno“sconfinamento della letteratura”21 negli ambiti considerati oggettivi eimpegnati come il giornalismo e la produzione dell’informazione.Bisogna uscire dai ghetti disciplinari per ripristinare il dialogo socialeparalizzato dall’unidirezionalità della rappresentazione oggettiva delmondo da parte del potere egemone e per riaprire la culturaall’esperienza dell’Altro che è rimasto “fuori”22 dalle norme stabilite.Ma come è possibile rinnovare la critica per articolare questa‘interferenza programmatica’?
La cultura egemonica della ragione imperialistica ha manipolato larappresentazione e l’interpretazione di tutto ciò che le fosse estraneo eresistente per controllarlo, delimitarlo, geolocalizzarlo econseguentemente inglobarlo nella propria Weltanschauung. La“critica” non deve essere confinabile in un ambito preciso, la suadimensione mondana deve essere talmente vasta da potersidiametralmente opporre all’egemonia sul piano globale. Lo scontrodell’intellettuale umanistico contemporaneo con l’egemonia interessatutte le diverse realtà civili del pianeta: metropoli, campagne, statidemocratici, dittature, popolazioni indigene, ordini religiosi,organizzazioni sindacali e movimenti giovanili. A maggior ragione,colui che si trova tra l’Occidente e l’Altro è in una posizioneprivilegiata per svelare l’interesse e l’azione della ragione egemonica,per parlare al potere, per dare voce alle vittime, per rilevarel’importanza dell‘umano per il bene del mondo. Quale può essere,dunque, il luogo prediletto della critica? Sarebbe forse più giusto direche il “sito” della critica è proprio nella responsabilità del singolointellettuale:
20 SAID, Umanesimo e critica democratica, cit., p. 57.21 SAID, Reflections On Exile and Other Essays, Haward University Press,Cambridge, Massachussetts 2000; traduzione italiana a cura di M. GUARESCHI
e F. RAHOLA, Nel segno dell’esilio, Feltrinelli, Milano 2008, p. 187.22 Op. cit., p. 188.
La critica come vocazione 85
Ogni atto di critica è sempre letteralmente legato ad una serie dicircostanze sociali e storiche, e il problema consiste nel fatto dispecificare o caratterizzare questo tipo di relazioni e nonsemplicemente affermarne l’esistenza; a queste condizioni la critica puòprocedere e scegliere tra tendenze sociali in competizione. Ogni atto dicritica viene concepito e portato avanti sul presupposto che debba avereun futuro; idealmente, quindi, obiettivi intrinseci, come una piùesaustiva interpretazione dell’autore o del genere X o Y, potrebberocollegarsi ad altri più estrinseci e generali come il cambiamento o ilmiglioramento della società. 23
Il critico deve prendersi la responsabilità di operare quella scelta equella caratterizzazione, senza però sacrificare il risvolto sociale delproprio lavoro per la ricerca di un’estrema astrazione intellettuale. Saidricorre ai concetti della critica dell’ideologia formulata da Gramsci: lacritica va intesa come “un fenomeno potenzialmente direttivo”24,ovvero che interviene sulla realtà, sulla rappresentazione e sullaconseguente interpretazione di essa.
2. La critica come vocazione
E’ possibile ricondurre, allora, l’istanza di rinnovamentodell’attitudine critica dell’intellettuale contemporaneo propugnata daSaid all’accorato appello del sociologo tedesco Max Weber. Alla finedella tragica esperienza della Prima Guerra Mondiale, Weber incitava igiovani studenti tedeschi a riconsiderare il proprio rapporto con lascienza nella splendida conferenza Wissenschaft als Beruf.25 Latraduzione italiana La scienza come professione non riesce a rendere inmaniera efficace quella sfumatura intima e superiore di ‘vocazioneinteriore’ che caratterizza il termine tedesco Beruf. Anche il termineWissenschaft risulta problematico perché Weber non si riferisce alla‘scienza’ come settore disciplinare, cioè scienza sociale opposta alla
23 Op. cit., p. 213.24 Ibid.25 M. WEBER, Wissenschaft als Beruf, 1919; traduzione italiana a cura di P.ROSSI e F. TUCCARI, La scienza come professione – La politica comeprofessione, Einaudi, Torino 2004.
86 Vincenzo Salvatore
sociologia umanistica, bensì a quell’atteggiamento propulsivo chenell’esercizio di tale professione combina lavoro e passione “persuscitare l’Idea.”26 Si potrebbe proporre quindi come interpretazionepiù fedele ‘la scientificità come vocazione’ per sottolineare quelprincipio di onestà intellettuale, di senso della misura nelcomportamento e nel sentimento di responsabilità, di sobrietà e rigoreche Weber cercava di trasmettere ai suoi ascoltatori propugnando unnecessario “sacrificio dell’intelletto”27 da parte del docente. Saidaffermava nel ‘92: I’ve been very conscious, for example, of notwanting to impose myself on students […], to become part of a school,to formalize what it is that I do in teachable ways or anything like that.I’ve always thought of my teaching, which I do all the time with greatexcitement and nervousness, as actually performing acts of analysis orreading or interpretation, rather than providing students withmethodologies that they can go out and apply to situations. In otherwords, I think of myself as providing opportunities for students andfriends, rather than encoding insights in some way that can make themuseful tools later on.28
La responsabilità dell’intellettuale è nell’atto interpretativo, ma siconcretizza umanamente nel momento professionale: l’insegnamento eil dibattito sono le occasioni per esporre le ragioni della propriainterpretazione, di cosa essa significhi per l’opera d’arte e di comeinterroghi il ruolo dell’uomo, di come si confronti con la storia e dicome metta in discussione il mondo che ci circonda; non possono
26 Op. cit., p. 15.27 Op. cit., p. 42.28 SAID, Power, Politics and Culture – Interviews with Edward W. Said, a curadi G. Viswanathan, Pantheon Books, New York 2001, p. 146: “Sono semprestato conscio, ad esempio, di non volermi imporre sugli studenti, di diventareparte di una scuola, di formalizzare quello che faccio in una modalitàd’insegnamento o qualcosa di simile. Pratico l’insegnamento ogni volta congrande eccitazione e nervosismo, e lo considero sempre come una performancedi atti di analisi, lettura o interpretazione, piuttosto che come un dare aglistudenti mere metodologie da applicare a determinate situazioni. In altreparole, mi sento di dare opportunità a studenti e amici, piuttosto che codificareilluminazioni che essi possano sfruttare in un secondo momento.” [traduzionemia].
La critica come vocazione 87
essere occasioni per salmodiare contro chi non è “uno dei nostri”29 oper affermare la purezza ed essenzialità assoluta di questa o quell’altraidea. Weber è categorico:
[…] la politica non si addice all’aula di lezione. […] Ma non siaddice neppure da parte del docente: non si addice proprio quandoquesti si occupa di politica dal punto di vista scientifico, e allora menoche mai. […] Da lui si può pretendere soltanto l’onestà intellettuale diriconoscere che la constatazione dei fatti […] e la risposta allaquestione del valore della cultura […] sono due problemi assolutamenteeterogenei. […] perché il profeta ed il demagogo non si addicono allacattedra universitaria. […] Parla [per le strade], cioè, dov’è possibile lacritica.30
Anche per il sociologo tedesco la critica deve essere intesa comel’attività dell’intellettuale nello spazio pubblico condotta secondo unaresponsabilità di tipo esclusivamente personale. In risposta a chiutilizza l’università per legittimare il potere e la cultura egemonica Saidrisponde che: If one is working with text of English literature, then onefeels a great constraint. The problem there is that you have aresponsibility to the material, which is a real one; but the main goal isto create in your students a critical consciousness. The last thing I’minterested in is disciples. Any kind of overt communication of amessage or method is the last thing I want to do. In that respect, it’svery difficult to be a teacher, because in a certain sense you oughtalways to be undercutting yourself. You’re teaching, performing, doingthe kinds of things that students can learn from, but at the same timecutting them off and saying “Don’t try to do this”. You’re telling themto do it, and not to do it.31
29 SAID, Umanesimo e critica democratica, p. 56.30 WEBER, La scienza come professione, p. 29-30.31 SAID, Power, Politics and Culture, p. 90: “Quando si lavora con testi dellaletteratura inglese, si percepisce una grande sensazione di costrizione. Ilproblema è che devi avere senso di responsabilità nei confronti del materiale,che è alquanto reale, ma l’obiettivo principale è creare nei tuoi studenti unacoscienza critica. L’ultima cosa che mi interessa è avere dei discepoli, men chemai la possibilità di trasmettere deliberatamente certi messaggi o metodi. A talproposito è veramente difficile essere un insegnante, perché in una certamisura devi sempre ridimensionarti. Insegni, agisci, fai il genere di cose da cui
88 Vincenzo Salvatore
Già Weber indicava il crescente sviluppo degli istituti universitaricon la conseguente trasformazione in imprese di “capitalismo distato”32, dove i docenti erano si erano trasformati in manager di attivitàredditizie (in quanto i corsi prevedevano tasse più o meno alte aseconda della fama del relatore, senza dimenticare il business delleresidenze nelle città universitarie). A fronte di ciò denunciava appuntocome “l’insegnamento scientifico sia una faccenda di aristocrazia dellospirito”33 che direttamente si collega al desiderio di fare ricerca e ditrasmetterla pedagogicamente. Weber propone una stima meritocraticache trascenda il mercimonio quantitativo sulla base del successonumerico dei singoli corsi per riqualificare il lavoro e la passioneindividuale che portano alla produzione di un’opera di valore. Bisognariconsiderare attentamente il ruolo del docente nei confronti deglistudenti: “Noi sediamo in cattedra solo in qualità di insegnanti.”34
Ma qual è allora il senso della scienza come professione? Una“funzione etica ed intellettuale nell’insegnare a riconoscere i fattiscomodi”35 per essere all’altezza della complessa “realtà quotidiana” epoter guardare quindi con dignità al “volto severo del destino deltempo”36. L’insegnante deve offrire agli studenti la scienza comeinsieme di mezzi e metodi del pensiero al servizio del conseguimentodella “chiarezza”37. Perché lo “scopo” ultimo dell’attività intellettualedeve farci “rendere conto del senso ultimo del nostro operare”38. Circolimistici e sette religiose non sono la risposta alle domande a cui lascienza non riesce a rispondere, come le “profezie dalla cattedra”39 nonsono le risposte alle necessità dei giovani studenti che devonoaffrontare la società moderna: sono anzi atti deleteri, inutili e financhedannosi quando danno luogo a sette fanatiche. Alla fine:
gli studenti possono apprendere, ma allo stesso tempo li blocchi e dici “Nonprovare a fare questo”. Dici loro di farlo, e di non farlo.” [traduzione mia]32 WEBER, La scienza come professione, p. 8.33 Op. cit., p. 12.34 Op. cit., p. 35.35 Op. cit., p. 32.36 Op. cit., p. 34.37 Op. cit., p. 37.38 Op. cit., p. 38.39 Op. cit., p. 44.
La critica come vocazione 89
entro l’aula di lezione nessun’altra virtù ha valore al di fuori dellasemplice onestà intellettuale. […] L’insegnamento è che anelare eattendere non basta: ci metteremo al nostro lavoro e adempiremo alla“richiesta di ogni giorno” – come uomini e nella nostra attivitàprofessionale.40
La scienza come professione significa il lavoro duro e rigorosodell’intellettuale, la cui vocazione critica guida la prospettivad’indagine e il cui senso di responsabilità bilancia la passione el’interesse personale. Un rapporto sofferto e difficile che peròrestituisce la natura tragica della conoscenza umana: intrinsecamentefallace e contraddittoria, eppure tesa al futuro e alla continuazione dellastoria. In Humanism and Democratic Criticism Edward Said declina lavocazione alla critica secondo un eroismo filologico di matrice vichianaper contrastare le pratiche egemoniche dei poteri dominanti. Unavocazione doppiamente difficile però, perché è il risvolto drammaticodelle esperienze biografiche dell’intellettuale e perché funge daAnsatzpunkt41 dell’impegno militante per un rinnovamentodell’umanesimo sclerotizzato dalle istanze reazionarie. Un umanesimointeso “come una sconvolgente avventura nei territori delladifferenza.”42
Per una vocazione filologica contro l’egemonia culturale
Le difficoltà del ruolo dell’intellettuale e della sfera umanisticanella società contemporanea, dunque, sono da ricondurre ad una serie diquestioni metodologiche, ideologiche e personali che riguardano lapratica critica ed il suo relativo rapporto con il potere. Per far fronte aqueste istanze problematiche che la situazione storica contingenteoppone ad una attività umanistica ‘solidale’ è necessario che
40 Ibid.41 Questo Lieblingswort di Erich Auerbach è un termine di notevoleimportanza nel pensiero di Edward Said sin dagli inizi della sua carriera. Cfr.la traduzione in inglese a cura di M. JAANUS ed E. W. SAID del saggio di E.AUERBACH, Philologie der Weltliteratur del 1952: Philology and“Weltliteratur”, “The Centennial Review” 13, 1969, pp. 1-17.42 SAID, Umanesimo e critica democratica, p. 81.
90 Vincenzo Salvatore
l’intellettuale riconsideri i propri metodi di indagine e produzionescientifica, prima di questionare su che tipo di ruolo socio-politicopossa egli svolgere fuori dall’accademia. Per Said la critica è l’attivitàpiù importante che l’intellettuale possa praticare per rapportarsi con larealtà. In maniera sintetica il terzo ed il quarto capitolo di Humanismand Democratic Criticism spiegano attraverso quale metodo rinnovarela critica, specificatamente letteraria, riassumendo l’intero sforzo che ilcritico palestinese ha profuso a tali riguardi nel corso di quart’anni diattività. Le premesse di base, la terminologia, la prospettiva e i punti diriferimento sono ripresi direttamente dalla tradizione filologica europeaed araba: ed è infatti un “ritorno alla filologia”43 che viene auspicatodall’autore quale effettiva possibilità di rinnovamento.
Said, come per gli studi orientali in Orientalism, non vuolesminuire il valore del lavoro degli specialisti, ma è altresì ovvio chepropone una filologia radicalmente diversa dalla codificazioneaccademica. Il critico palestinese si riferisce sostanzialmente a quellagrandiosa educazione culturale grazie a cui eccezionali intellettualifilologi come Friedrich Nietzsche hanno radicalmente cambiato lastoria del pensiero, dimostrando indubbiamente come la filologia nonsia esclusivamente asservita ad un sapere retrogrado, ma al contrario:
La filologia è il dettagliato e paziente esame delle parole el’esercizio di una costante ricognizione delle parole stesse e dellestrutture retoriche con le quali gli esseri umani usano il linguaggio,esseri umani che vivono nella storia.44
Said è fermamente convinto che il linguaggio sia portatore diconoscenza e coscienza umana, sia ovvero espressione vitale dellaagency umana nel momento in cui, e cita Richard Poirier, “nellinguaggio si possono trovare le tracce dell’originario potere tramite ilquale inventiamo noi stessi in quanto unica forma della natura”45. Laletteratura è la dimostrazione più alta di cosa sia possibile ‘fare con illinguaggio’ a livello artistico ed espressivo. Ma se, come disseNietzsche “la verità della storia umana è un esercito di metafore e
43 Op. cit., p. 83.44 Op. cit., p. 87.45 Op. cit., p. 84.
La critica come vocazione 91
metonimie e antropomorfismi in continuo movimento”46, allora ènecessario ritrovare attraverso Vico un “eroismo filologico”47 perché:
il significato di questi tropi deve essere continuamente decifratotramite letture e interpretazioni a partire dalla forma delle parole. Leparole sono portatrici di realtà, una realtà nascosta, ingannevole,difficile e che oppone resistenza. La scienza delle parole è il puntoculminante della conoscenza umanistica.48
Bisogna avere coscienza delle basi mutevoli della praticaumanistica49 rispetto ai valori della vita umana per poter far fronteconcretamente alle istanze problematiche della situazione storica e almodo in cui quelle “strutture di atteggiamento e riferimento”interagiscono con la realtà: la filologia si deve declinare essenzialmentecome ‘interpretazione filologica’.
Said riprende da Vico ed Erich Auerbach la consapevolezza che larealtà sia interpretabile filologicamente come un testo, perché è unacondensazione immaginativa del mondo dell’uomo. Per questo motivoSaid usa con insistenza i termini ‘secolare’ e ‘mondano’ in riferimentoa tutti i campi di azione dell’attività intellettuale. Non è possibileancorarsi a valori trascendentali, totalistici, sistemici: una prospettivasub specie aeternitatis è assolutamente contraria all’attività intellettualeperché non permette di relazionarsi tanto col contingente momentostorico personale, quanto col contesto relativo del testo che si è preso inesame. Said caratterizza epistemologicamente la filologia come unadisciplina vasta e ambiziosa che ha come riferimento l’intero complessointerculturale che trasuda dai testi letterari e dai fatti del mondo.Delinea un particolare impianto di base che segue una sostanzialeinterconnessione tra storia, letteratura e geografia, intese non comeindici settoriali, ma come grandi categorie umanistiche le cuicorrispondenze diacroniche e sincroniche possono permettere unacomprensione sintetica della realtà su scala generale e opporsi al bieco
46 Ibid.47 Ibid.48 Ibid.49 “Le mutevoli basi dello studio e della pratica umanistici” è il titolo delsecondo capitolo di Humanism and Democratic Criticism. Op. cit., p. 59.
92 Vincenzo Salvatore
specialismo auto-referenziale che affossa l’influenza socio-politicadelle accademie.
Prima di arrivare all’atto ‘creativo’, è necessario anteporre un atto‘meditativo’: ovvero la lettura del testo. Una azione attiva, intima,finanche sfacciata, che riveli ciò che è nascosto nel testo, nell’uso delleparole e dello stile, ciò che manca o che è distorto. Perché, parafrasandoun’altra citazione di Poirier, la letteratura non è altro che una relazionedialettica tra le parole e il lettore.50 Ed è proprio a partire da quelleparole e da quel rapporto sempre più stretto che il critico può iniziarel’atto interpretativo. Said distingue due momenti fondamentali efondanti della lettura e interpretazione filologica: la “ricezione” e la“resistenza”51, rispettivamente atto meditativo ed atto creativo. La“ricezione” è un punto zero, dove il soggetto lettore si ‘abbandona’ alleparole, e potrà quindi, come si diceva:
spostare l’attenzione sulla situazione storica e sul modo in cui laretorica e certe strutture comportamentali e psicologiche interagisconocon date circostanze storiche e sociali. Solo disponendosi a<<ricevere>> il testo in tutta la sua complessità […] la lettura attenta diun testo letterario calerà gradualmente il testo nel suo tempo vedendolocome parte di un’ampia rete di relazioni la cui struttura e influenzagiocano un ruolo essenziale nel testo stesso.52
Bisogna prima comprendere l’identità dell’autore del testo, entrarein sintonia con il suo linguaggio, con le sue strutture e con il suomondo: è il momento fondamentale per capire le ragioni delle singolescelte stilistiche e letterarie. Si pone allora l’accento sulla ‘qualità’ dellalettura, per rivelare tanto la componente secolare e mondana delleparole quanto quella psicologica e personale delle scelte operate.Successivamente si pone un momento di ‘confronto’ con le parole,ovvero la lettura vera e propria in quanto comprensione del testo. Ilprimo momento anticipa ed è necessario al successivo, perché solograzie alla loro combinazione si può giungere alla fase di “resistenza” –cioè, come si è detto, di interpretazione vera e propria. Il testo non èqualcosa di metafisicamente isolato dall’esperienza che può essere
50 Op. cit., p. 86.51 Op. cit., pp. 87 e 96.52 Op. cit., p. 87.
La critica come vocazione 93
esperito nella sua totalità tramite una contemplazione trascendente. E’impossibile impedire alla percezione della realtà fattuale che cicirconda, ovvero dove si trova il proprio punto di vista, di influire sullacomprensione della realtà storica e letteraria del testo in lettura. Ma nonbisogna neanche identificare il proprio pensiero con la verità assoluta.
Said usa ampie citazioni dal saggio Linguistica e storia letteraria diLeo Spitzer per spiegare come l’“interiore centro vitale”53 dell’operad’arte, il suo principio compositivo, sia raggiungibile solo attraverso unprocesso di continue letture e riletture, di fiducia nella capacità esensibilità della mente umana di raggiungerlo tramite una correlazionedipendente da numerosi tentativi e fattori che si ramificano, siintrecciano e si referenziano tra loro, con il mondo, il testo e il criticomedesimo. Questo processo filologico di lettura delineerà infine –ovviamente senza alcun risultato certo o scientifico – una sorta dietimologia dello scritto, data appunto da uno scandaglio profondo e‘vero’. Il critico palestinese cerca di ridare dignità alla lettura personalepresentandola come un atto di per sé secolare, mondano e umano diemancipazione ed edificazione. Riprendendo da Vico la:
scoperta rivoluzionaria di straordinaria importanza e acutezza […],in totale solitudine e in contrapposizione alle astrazioni cartesiane, chegli esseri umani sono creature storiche in quanto fanno la storia, <<ilmondo delle nazioni>>54
Said restituisce all’atto della lettura tutto il suo valore fondamentaleper l’educazione dell’uomo e, soprattutto, per la pratica degli studiumanistici. Perché l’uomo è l’artefice della realtà, attraverso il suocomportamento, la sua agency e le sue scelte influisce e crea la realtà.L’importanza irrinunciabile dell’arte per lo sviluppo della civiltà umanaè giustificata da una radicale intuizione estetica:
Concordo con Adorno nel sostenere che c’è una fondamentaleincompatibilità tra il piano estetico e quello non estetico, e che taleincompatibilità va ribadita perché è la condizione necessaria del nostrolavoro. L’arte non è qualcosa di dato una volta per sempre: la suaesistenza si nutre dell’irriducibile opposizione a tutte le devastazioni
53 Op. cit., p. 90. Cfr. L. SPITZER, Critica stilistica e storia del linguaggio, acura di A. Schiaffini, Laterza, Bari 1954, p. 130.54 Op. cit., p. 114.
94 Vincenzo Salvatore
della vita quotidiana e dell’<<incontrollabile mistero sul pianoanimale>>.55
Questa irriducibilità è la necessaria caratteristica dei grandicapolavori artistici. E’ la resistenza agli sforzi di comprensione einterpretazione che permette ad un’opera di ‘diventare’ arte quando sioppone alla “pressione livellante dell’esperienza quotidiana da cuiparadossalmente trae origine”56.
Solo nella matrice delle parole si rivela all’attento lettore quella“rete di notazioni culturali spesso tra loro contraddittorie”57, secondo ladefinizione che Said trae da Raymond Williams: ovvero la possibilità dicomprendere quel rapporto dialettico tra l’autore, il testo stesso e quelle“strutture di atteggiamento e riferimento” di cui si è detto più sopra.Ecco perché Said pone fortemente l’accento sulla pratica umanisticacome attività libera e democratica, tesa all’inclusione e nonall’esclusione, alla rivelazione e non alla mistificazione. Un processo diricezione così complesso e stratificato non può avere esito ‘felice’ ameno che chi lo compia non si ponga nella e con la giusta vocazioneintellettuale al compito:
la realtà concreta della lettura è, fondamentalmente, un atto diemancipazione ed edificazione umana che, per quanto modesto,trasforma e accresce il sapere di una persona per ragioni diverse dalcinismo o da infruttuose divagazioni. […] In questo risiede laspecificità dell’impresa umanistica: il senso dello sforzo eroicocompiuto dall’autore è qualcosa da emulare, ammirare e a cui aspirarecome lettori, oltre che come poeti, romanzieri e drammaturghi. […]Non siamo scribacchini o umili copisti, ma menti le cui azionidiventano parte della collettiva storia umana che prende forma intorno anoi.58
La fase della “resistenza”, a differenza di quella di “ricezione”, sicaratterizza in senso intellettuale riguardo all’interpretazione di untesto. Si rende necessario tradurre la propria induzione ermeneutica,faticosamente raccolta, in un lessico che sia al contempo adatto a
55 Op. cit., p. 89.56 Ibid.57 Ibid.58 Op. cit., pp. 92-93.
La critica come vocazione 95
rappresentare l’opera d’arte, a trasmettere un determinato messaggio e,soprattutto, possa sottrarsi alla pressante omologazione della culturamediatica commerciale che ci bombarda con “rappresentazionipreconfezionate e reificate del mondo che usurpano la coscienza eostacolano il sorgere di una critica democratica.”59 Che tipo dilinguaggio può usare un intellettuale che vuole ‘fare resistenza’operando nell’università e/o fuori da essa? Si ritorna quindi alleuniversità, in opposizione allo spazio pubblico, come unico luogorelativamente libero da questioni prosaicamente economiche dovepotersi dedicare alla resistenza militante contro questi “oggettialienanti”60 che tentano di prendere il controllo del libero pensiero, cheasserviscono la pratica umanistica alla cultura egemonica e all’interesseimperialistico. Said si scaglia, pertanto, contro l’uso di un idiomaastruso, incomprensibile e gergale: avverte che “chi usa un linguaggioinvoluto non è necessariamente un Adorno”61. Chiarisce nuovamentecome il vero dovere degli intellettuali sia quello di rendere piùtrasparente e maggiormente fruibile “l’opera di demistificazione eindagine propria dell’interpretazione umanistica”62:
L’educazione implica un ampliamento della consapevolezza percerchi concentrici, ognuno analiticamente distinto ancorché connesso atutti gli altri perché appartenente alla stessa realtà mondana. Un lettoresi trova in un luogo determinato e in un dato periodo. […] Ma non sitratta di contesti passivi. […] In questo, appunto, consiste l’atto diresistenza: nella capacità di distinguere tra quello che può essere coltodirettamente e quello che risulta nascosto [oltre gli orizzonti e lerestrizioni dominanti]. […] Bisogna discutere l’universo conflittuale emorale incarnato in un dramma o in un romanzo e cogliere in questaesperienza estetica una bruciante incarnazione di conflitto e scelta.63
Le parole e le strutture dei testi sono l’autentico oggetto del nostrostudio. Non possiamo prescindere da loro allo stesso modo nel qualenon si può prescindere dal contesto contingente. La fase di “resistenza”
59 Op. cit., p. 96.60 Ibid.61 Op. cit., p. 97.62 Op. cit., p. 98.63 Op. cit., pp. 100-101.
96 Vincenzo Salvatore
nell’interpretazione filologica è il vero momento ‘creativo’ dell’attivitàintellettuale, ma è anche il momento più drammatico. E’ una resistenzadi tipo intellettuale al testo, ma anche di tipo personale, sentimentale epsicologico. Se, appunto, nella fase di ricezione “si tratta solo distabilire dei nessi!”64, in questa seconda fase si tratta di “contribuireattivamente all’emancipazione all’ampliamento della conoscenza”65.L’esigenza di trovare un significato a ciò che si legge, cioè si interpreta,e di renderlo fruibile ad un pubblico è la vera missione dell’umanesimocome critica democratica.
Le manifestazioni istituzionali della società di massa agisconotrasversalmente da amorfi tentacoli del potere egemonico, costringendola coscienza critica del singolo individuo ad una pressione livellantecontinua e senza sosta, il cui senso ultimo non è altro che instillare unapassività e un’accondiscendenza politica tali da garantire la“governabilità della cittadinanza”66. La critica non può asservirsi aldiscorso omogeneizzante dell’interesse egemonico trasformandosi inuna “arte creativa”67 reificata e massificata dal mercato commerciale alpari dei format mediatici. E’ necessario riappropriarsi della critica,specificatamente di quella letteraria, per renderla una forma indefessadi resistenza a questi attacchi livellanti: tramite i testi bisogna capire lastoria e dalla situazione presente bisogna progettare il futuro persfuggire all’immanenza, all’indifferenza e all’autoreferenzialità cuicostringe l’interesse politico-economico. Per Edward Said la criticadiventa così il reale risvolto pratico dell’intima vocazionedell’intellettuale deciso a influire sulla realtà sociale e politica delproprio tempo avendo a cuore la chiarezza e l’onestà professionalesopra ogni interesse particolare. Quello contro cui lotta Said è latensione sistematica per una progettualità finita e conchiusa. Il progettoumanistico deve seguire il ragionamento abduttivo proposto da Peirce:“generalizzare da fatti noti per fornire ipotesi di una nuova situazione e
64 Op. cit., p. 91.65 Op. cit., p. 95.66 SAID, Nel segno dell’esilio, p. 213.67 Op. cit., p. 214.
La critica come vocazione 97
proiettarsi verso il futuro”68. Un futuro radicalmente e umanamentediverso.
68 “What is the word that Peirce uses? Some notion of abduction, generalizingfrom the known facts. A hypothesis of the new situation, projecting forward”.In SAID, Power, Politics and Culture, p. 163.