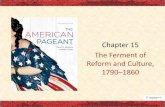imperial ufficio provinciale di polizia 1829 – 1860 - ARCHIVIO ...
La città dei vinti. Le trame della cospirazione borbonica (1860-1870)
Transcript of La città dei vinti. Le trame della cospirazione borbonica (1860-1870)
STUDI RISORGIMENTALI
VITTORIO FROSINI, Breve storia della critica al marxismo in ItaliaMARIO CONDORELLI, Stato e Chiesa nella rivoluzione siciliana del 1848ROSARIO ROMEO, Il giudizio storico sul RisorgimentoENzO SCIACCA, Riflessi del Costituzionalismo Europeo in SiciliaRUGGERO MOSCATI, Risorgimento LiberaleDENIS MACk SMITh, Da Cavour a MussoliniVITTORIO FROSINI, Il Risorgimento e l’EuropaFERNANDO MANzOTTI, Esperienze risorgimentaliGAETANO MOSCA, Il tramonto dello stato liberaleVITTORIO FROSINI, Intellettuali e politici del RisorgimentoNOEL BLAkISTON, Italiani e Inglesi nel RisorgimentoVLADIRNIR NEVLER, La Russia e il RisorgimentoALBERTO M. GhISALBERTI, Uomini e cose del Risorgimento e dopoMARIO CONDORELLI, La Cultura Giuridica in SiciliaGIUSEppE ASTUTO, Garibaldi e la rivoluzione del 1860GIUSEppE ASTUTO, Cavour con la rivoluzione e la diplomaziaGIUSEppE BARONE (a cura di), Catania e l’Unità d’Italia
Catania e l’unità d’italia
EVENTI E pROTAGONISTI DEL LUNGO RISORGIMENTO
a cura diGiuseppe Barone
BONANNO EDITORE
Volume pubblicato con il contributo della Facoltà di Scienze politichedell’Università degli studi di Catania e dell’Unitre
ISBN 978-88-7796-702-2
Proprietà artistiche e letterarie riservateCopyright © 2011 - Gruppo Editoriale s.r.l.
ACIREALE - ROMA
Facoltà di Scienze politiche
INDICE
INTRODUZIONEdi Pina Guccione Lisi pag. 7
PREMESSAdi Giuseppe Barone ,, 9
GIUSEPPE BARONEIl “risorgimento” di Catania prima dell’Unità(1815-1860) ,, 11
SEBASTIANO ANGELO GRANATAL’Intendente e la CittàPietro Settimo tra borbonici e liberali ,, 37
CHIARA MARIA PULVIRENTIIl Risorgimento all’UniversitàProfessori e studenti tra cattedre e barricate ,, 65
MARIA GRAZIA PANEBIANCOPatrioti in rete nell’area ionico-etneaDalla rivoluzione verso l’unificazione ,, 89
GIUSEPPE BARONEBorbonici e garibaldini nel 1860La “battaglia” di Catania nelle carte del generale Clary ,, 135
MARGHERITA BONOMODonne fuori dall’ombra: la Sicilia del 1860nel carteggio fra la marchesina di San Giulianoe il principe di Cassaro ,, 159
5
GIANCARLO POIDOMANIIl governo della città: assistenza, istruzione,infrastrutture (1861-1866) pag. 191
ALESSIA FACINEROSOLa città dei “vinti”Le trame della cospirazione borbonica (1861-1867) ,, 235
GIUSEPPE ASTUTOI sindaci di Catania dall’Unità alle riforme crispine ,, 265
6
ALESSIA FACINEROSO
LA CITTÀ DEI “VINTI”LE TRAME DELLA COSPIRAZIONE BORBONICA (1861-1867)
15 gennaio 1865. Lo scalpitio dei cavalli rompe la quiete della nottedi Catania, propagando per le strade della città l’eco di una corsaforsennata, il presagio di una minaccia che incombe. È un corteoanimato quello che parte dalla caserma di Polizia, in piazza Stesico-rea, per poi dissolversi in mille rivoli diversi, fino a interrompere lamarcia dinanzi alle dimore del sospetto. Le targhe di fianco alle porte raccontano storie diverse: accanto
ai volti celebri della vita politica catanese ci sono quelli, per il mo-mento meno noti, di chi fino ad allora ha agito nell’ombra, protettoda un anonimato che sta per essere infranto. La lista dei colpevoli èfin troppo lunga1, e insolitamente “varia”, un fitto elenco di nomisu cui spiccano quelli di Gaetano Ajello, ex guardia sanitaria; dei ba-roni Bonanno e Ventimiglia; del vecchio funzionario d’IntendenzaGuglielmino e del suo amico Francesco Marletta. Insieme a loro,banchieri, proprietari, artigiani, uomini di scienza o di legge, e per-sino qualche sacerdote, come Antonino Cesareo, noto in città peressere uno strenuo pastore di anime e non certo un malvivente.Gli agenti scendono giù dalle selle, poi il rumore dei loro passi cede
il posto a quello di colpi secchi sulle porte serrate, che di lì a poco sispalancano, a forza, per svelare parole e fatti fino a quel momento na-scosti, costrette a violare i segreti di una calma apparente. I modi bru-schi tradiscono una certa impazienza: pochi minuti per mostrare imandati ai loro attoniti interlocutori – in osservanza a quelle garanzielegali che la propaganda antisabauda vuole ormai in disuso2 – poi nonc’è più posto per le formalità. È il ritmo di una frenetica ricerca a scan-dire il tempo della notte: si va avanti sino a quando l’alba rischiara icontorni di un nuovo giorno, fino a che anche l’ultimo anfratto è stato
235
1 Cfr. Archivio di Stato di Catania (d’ora in avanti ASCt), Corte d’Assisee d’Appello, b. 5, Processo per cospirazione politica del 1866, Elenco nominativodegli indagati.
2 Cfr. «Il Precursore», anno VI, n. 18, 24 gennaio 1864.
perquisito, trasformando in certezza quello che, fino a quel momento,era stato solo un sospetto. Le tracce della «congiura anti Italiana»3 ven-gono immediatamente sequestrate: lettere, manifesti, bandiere in cuiil bianco dei borbonici si avvince al rosso dei repubblicani, fotografiedell’Eroe dei due Mondi insieme a quelle del vile Franceschiello, armida fuoco e polvere da sparo, qualche moneta e troppi dubbi4. A lasciaresbalorditi gli inquirenti è soprattutto l’identità dei criminali: se la pre-senza di volti noti della reazione è per certi versi una prevedibile con-ferma, l’amara sorpresa è il coinvolgimento di democratici di provatafede, garibaldini impetuosi, azionisti e liberali, in un circuito contortoche valica i confini di Catania e si estende alla provincia, all’isola, atutta l’Italia, toccando persino Malta e Corfù.I militari capiscono immediatamente che quello appena aperto è
un vaso di Pandora: occorreranno giorni perché tutta la corrispon-denza venga esaminata, dipanando pienamente i legami della cospi-razione, la sua reale portata, i progetti e le idee di cui essa è foriera.Intanto, però, con in mano solo le prove più scoperte, possono pro-cedere ai primi arresti: in casa di Guglielmino hanno scovato, oltre almateriale sedizioso, quattro borbonici di Adrano, i fratelli Alongi eVincenzo Russo, che adesso viaggiano, con le manette ai polsi, versoil carcere provinciale. A condividere la loro sorte ci sono poi altri in-dagati, tra cui il famigerato Raffaele Greco5.L’unico rammarico delle autorità riguarda i fuggiaschi: Gugliel-
mino e Ajello, infatti, sono riusciti a scappare appena prima che i po-liziotti entrassero in casa, perdendosi nel fitto dedalo di strade catanesisenza lasciare traccia. La Procura teme un loro imbarco clandestino,ma neppure la stretta sorveglianza sui padroni di barca di Aci Trezzaha dato esito positivo6: i due uomini sembrano dissolti nel nulla. Neigiorni seguenti, mentre le loro ricerche continuano, altre perquisizioni
236
3 Così le autorità definiscono la cospirazione catanese, cfr. ASCt, Questura,Elenco I, b. 3.
4 Cfr. Archivio di Stato di Napoli (d’ora in avanti ASNa), fondo Borbone,b. 1146, Copia del verbale della perquisizione e del sequestro di materiale sediziosoin casa di G. A., Catania, 16 gennaio 1865.
5 Greco era un noto borbonico, nonché genero di Ajello, noto alle autoritàanche per le sue amicizie in ambito democratico; cfr. ASCt, Questura, ElencoI, b. 8.
6 Ibidem.
e nuovi arresti scuotono la vita di Catania: un blitz nella tipografiaGalàtola permette di rinvenire caratteri identici a quelli usati nellestampe di Ajello7, e una seconda spedizione in casa del latitante con-sente il sequestro di 40.000 onze8, da utilizzare come «Fondo Propa-ganda». Nonostante la mediazione del console britannico, non sfuggeall’arresto nemmeno il maltese Felice Attard: a incastrarlo è la scopertadi armi clandestine nella sua abitazione, e le autorità catanesi preten-dono di conoscere quali rapporti lo leghino alla sua terra d’origine, esoprattutto al Comitato borbonico che lì risiede e opera, a pochimetri d’acqua dalla Sicilia. Intanto, la rete di congiurati si allarga adismisura: nelle indagini vengono inclusi ex militari, come GaetanoAfan De Rivera9 e Tommaso Clary10; alcuni funzionari del passatoregime, tra cui il conte di San Secondo11; i democratici GiuseppeBadia12 e Carlo La Fata13. La lunga serie di interrogatori non basta
237
7 Ibidem.8 Ibidem.9 Afan de Rivera (Palermo, 25 luglio 1816-Trieste, 7 giugno 1870), era un
ufficiale dell’esercito borbonico, figlio del Maresciallo Carlo. Dopo la vittoriosaspedizione a Catania, a giugno del 1860, alcuni tentennamenti durante la cam-pagna militare sul Volturno gli erano costati il comando del suo battaglione:nonostante ciò, il generale aveva scelto di seguire il sovrano a Gaeta e, dopo ildefinitivo abbandono della piazzaforte, aveva scelto l’esilio a Trieste, da dovesi teneva in contatto con i Comitati borbonici in Sicilia e con la corte di Roma,e reclutava militari e volontari in vista di una riconquista del Regno. Cfr. R.Selvaggi, Nomi e volti di un esercito dimenticato. Gli ufficiali dell’esercito napo-letano del 1860-61, Napoli 1990, pp. 57-58; sull’attività in esilio cfr. ASNa,fondo Borbone, b. 1143.
10 Si tratta dell’ultimo comandante della piazza di Catania, giunto in città agiugno del 1859. Sulla sua esperienza da esule cfr. ASNa, fondo Borbone, b. 1252.
11 Enrico Rosso di San Secondo, ex Intendente di Trapani, rifugiatosi aMalta dopo il 1860.
12 Ex ufficiale garibaldino, e deluso dall’assetto politico e istituzionale ita-liano, Badia dopo il 1860 era passato alla cospirazione, insieme al compagnodi fede e di battaglie Giovanni Corrao, con cui condivideva l’idea della necessitàdi un’insurrezione popolare per provocare la caduta del governo piemontese.Cfr. P. Alatri, Lotte politiche in Sicilia sotto il governo della Destra (1866-1874),Torino 1954, p. 158; L. Riall, La Sicilia e l’unificazione italiana. Politica liberalee potere locale (1815-1866), pp. 192-251.
13 Carlo Gaetano La Fata, intellettuale di sentimenti liberali e aspirazioni“italiane”, era nato a Palermo ma risiedeva da 23 anni in esilio volontario negli
tuttavia a fare chiarezza sull’effettiva portata della cospirazione, comese una nebbia sottile ma insistente ne coprisse i meccanismi e le di-namiche: i sospettati alternano bugie e reticenze, e rafforzano la loroinclinazione al silenzio quando scoprono che Gaetano Ajello è riuscitoa far perdere le sue tracce14. L’unica certezza delle autorità, a duegiorni dalla prima retata, è proprio il ruolo del fuggitivo, punto dicontatto tra tutti gli indagati e perno centrale della congiura: trovarlodiviene ancora di più un obiettivo prioritario, necessario a gettareuno squarcio di luce sull’intera questione.Tra le asfittiche mura di una cantina, a pochi passi dalla sua abi-
tazione, Gaetano sente che la sua libertà volge al termine. Immaginache la Polizia stia scandagliando tutta la città in cerca di lui, soffreper la sorte dei suoi familiari, portati a forza in carcere nella speranzadi indurli a rivelare il suo nascondiglio. Le notizie gli arrivano permezzo della principessa di Cassaro15, che ha accettato di nasconderlofino a che non deciderà cosa fare della sua vita. Le scelte, comunque,non sono poi molte: la via del mare ormai è preclusa, a causa dellenavi armate che presidiano le coste catanesi; molti “compagni” sonotenuti sotto torchio, e prima o poi finiranno per cedere alle insistenzedei poliziotti, rivelando tutto ciò di cui sono a conoscenza: a quelpunto, sarà fin troppo semplice arrivare a lui. Senz’altra possibilitàche quella di attendere lo sviluppo degli eventi, Gaetano ripercorreidealmente la strada che lo ha condotto fino a lì, rivivendo la storiadella sua città, della sua isola e di una promessa, l’Italia, presto tra-sformata in delusione. Come in un sogno a occhi aperti, si lasciatrasportare dai ricordi…
14 gennaio 1861. A pochi mesi dal plebiscito che ha legato lesorti della Sicilia a quelle dello Stato italiano, per qualcuno l’ottimi-smo nazionale, ammesso che ci sia mai stato, è già finito. Tra i delusi
238
Stati Uniti, dove aveva combattuto nel 1860 contro gli schiavisti. Rientratoin Sicilia nel 1864, era stato il fondatore della loggia massonica Washington, dichiara ispirazione antigovernativa. Cfr. E. Floritta, Rivoluzione e tirannide. Fattistorici contemporanei, Palermo 1863, p. 166; L. Polo Friz, La Massoneria ita-liana nel decennio postunitario. Lodovico Frapolli, Milano 1998, p. 149.
14 Cfr. ASCt, Questura, Elenco I, b. 3, Prospetto dei risultati delle visite do-miciliari, Catania 28 gennaio 1865.
15 Eleonora Statella, figlia di Antonio.
c’è Gaetano Ajello, impiegato solerte della monarchia borbonica,“declassato” dal nuovo governo a una mansione inferiore a quellaricoperta fino ad allora16. L’uomo non riesce a condividere la gioiadei suoi concittadini per il mutato regime: conosce poco la politica,ma il suo istinto lo rende ostile agli invadenti controlli di Polizia,alle tasse, ai nuovi doveri imposti dall’Italia. Si chiede spesso se siapoi tanto cambiata, la situazione, rispetto a quando il re non si chia-mava Vittorio Emanuele ma Francesco; si chiede cosa è veramentemigliorato, nella sua vita, da quando è diventato italiano. Le sue do-mande, tuttavia, se le tiene in testa; ha provato a farne cenno allamoglie, e lei lo ha redarguito: visto il sospetto che già li circonda,non è il caso di rincarare la dose con interrogativi insolenti17. Presto, Gaetano prende l’abitudine di recarsi in piazza, a sera,
quando i poliziotti sono un po’ meno zelanti: incontra i suoi amicidi sempre – Francesco Guglielmino, Felice Attard, don Antonio Ce-sareo – e con loro discute fino a tarda notte degli inconvenienti delnuovo Stato. Da quello che sente, sono in molti a condividere le sueidee: tutta la città è percorsa da malumori e sotterranei fremiti di in-sofferenza verso la corte di Torino e i suoi inviati locali.Se ne accorge anche Vincenzo Tedeschi, focoso garibaldino “della
prima ora”, scelto dal Generale come Governatore di Catania dopoil trionfo delle camicie rosse e adesso sorpreso di doversi confrontarecon una realtà a tratti ostile. Proprio quel giorno, scrivendo al nuovoLuogotenente dell’isola, Massimo di Montezemolo, Tedeschi riba-disce l’inclinazione «eminentemente annessionista ed unitaria» delcapoluogo, ma non può non far cenno alla riorganizzazione dei bor-bonici etnei:
Ciò però non esclude l’esistenza, tanto qui che in altri Comuni, di unpugno di affezionati al passato Governo, che sia per imprudenza o altromotivo qualunque, spacciando delle voci allarmanti, prestano da unaparte occasione ai caldi liberali di assalirli, e dall’altro danno campo a’speculanti agitatori di disturbare l’ordine e la tranquillità. Io non pocafatica ho durato per prevenire qualunque inconveniente […] ma colgofrattanto questa occasione per rinnovare all’E.V. la preghiera […] diordinare che una frazione di truppa stanziata in Messina, o anche un
239
16 Cfr. ASCt, Corte d’Assise e d’Appello, Processo per cospirazione politicadel 1866, Interrogatorio di Gaetano Ajello.
17 Ibidem.
Battaglione incompleto di Truppa regolare, fosse destinato in questacome mezzo efficacissimo per […] tenere in freno i tristi18.
La richiesta di forze armate non è un capriccio: a Catania si respiraun clima teso19, soprattutto dopo che l’estensione della legislazionesabauda ha iniziato a produrre i primi effetti perversi sull’opinionepubblica, contraria alla nuova e più esosa tassazione, nemica della co-scrizione obbligatoria, avversa a «tutto quello che sa di piemontese»20.Così, nemmeno l’arrivo dei soldati riesce a sedare i fermenti dellacittà, percorsa in quel momento da una crescente insoddisfazione an-tigovernativa che spesso si traduce in una velata compiacenza per lebattaglie ideologiche dei borbonici: ad agosto di quell’anno, la diffu-sione di un volantino proveniente dal Comitato di Marsiglia, in cuisi invita la popolazione a boicottare il «ladrocinio Piemontese»21 e la«nefanda speculazione sui beni di prima necessità»22, si trasforma inun tentativo di tumulto popolare che solo grazie all’uso della forzapuò essere sedato. Il governatore è costretto a procedere a diversi ar-resti, a mettere sotto stretta sorveglianza il contenuto dei bastimentiprovenienti dall’estero, a insistere perché Torino accetti di inviare an-cora truppe sul territorio. L’arrivo di altri militari, che percorrono incessantemente le strade
della città con i fucili in spalla, conferma la brusca interruzione diquel “sogno patriottico” che aveva visto la luce insieme allo Stato ita-liano. Catania non serba più nulla di quell’euforia nazionale: è, piut-tosto, il ritratto di una città “arrabbiata”, contraria ai metodi duri delgoverno e poco disposta alla benevolenza nei confronti dei suoi rap-presentanti locali, incline più ai complotti che alla partecipazione po-litica, quanto mai ostile alla leva.All’alba di una fredda giornata di inizio novembre, due soldati
240
18 Archivio di Stato di Palermo (d’ora in avanti ASPa), Real Segreteriapresso il Luogotenente del Re in Sicilia, b. 4176, Confidenziale sullo spiritopubblico della provincia, Catania 14 gennaio 1861.
19 Cfr. A. Carrà, La Sicilia orientale dall’Unità all’impresa libica, Catania1968; G. Giarrizzo, Catania, Bari 1986.
20 ASPa, Prefettura – Gabinetto, b. 1, Il Luogotenente del Re in Sicilia alMinistro dell’Interno, Palermo 20 gennaio 1861.
21 ASCt, Questura, Elenco I, b. 8, Copia di manifesto borbonico provenienteda Marsiglia, 25 agosto 1861.
22 Ibidem.
in perlustrazione scovano, in via San Berillo, un manifesto che invocaalla renitenza. La scoperta scatena una vera e propria “caccia alle stre-ghe” che si conclude appena qualche giorno più tardi, nella cella car-ceraria di un detenuto eccellente, padre Cirillo da Biscari, trovato inpossesso di un manifesto identico a quello stracciato a forza dai muridella città23. L’episodio conferma quello che le autorità cittadine ave-vano già intuito: sul terreno della protesta contro la leva obbligato-ria24 si incontrano i malumori popolari, le mene dei borbonici e leistanze del clero, anch’esso “oltraggiato” dall’Italia e deciso a imbrac-ciare le armi della cospirazione25. La sinistra convergenza suscita na-turalmente i timori del Prefetto Tholosano, nonché i suoi furorirepressivi, subito comunicati al Ministro dell’Interno:
241
23 Cfr. ASCt, Corte d’Assise e d’Appello, b. 15, Diffusione di “scritti allar-manti e notizie false” contro l’attuale Governo a carico di padre Cirillo da Biscari.
24 Questo sentimento di ostilità alla leva si riscontra anche in un branodella Storia di Catania a opera di Benedetto Cristoadoro del 2 gennaio 1864:«Molti soldati di buon mattino recaronsi fuori porta del Fortino, e come an-davano a fatigare i giovani alla Piana, li arrestarono tutti e li condussero inCasa Comunale: ve ne erano di anni 16, di 18, sino anco giovani al di là dei30 anni e più, sul frivolo motivo di essere renitenti di leva; abusi immensi, efino a quando si giustifica colla fede di nascita di non essere in leva, ci vuoletempo ed essi restano colà; e degli altri la sera si vanno arrestando e si portanoalla questura, e passano ivi la notte fino a quando poi, al far del giorno, si estrael’atto di nascita e si giustifica l’età. Quei giovani poi che sono assenti: si piaz-zano dei piantoni in casa del padre, ed ancorchè giustificano i parenti che illoro figlio è in Malta, in Alessandria o altrove, non importa, di giorno in giornosi aumentano i piantoni. […] La più bella cosa poi è che, se si trova uno del-l’istesso cognome, non importa […] E se non si trova il padre o la madre, sipiazzano i piantoni nei parenti i più lontani». B. Cristoadoro, Storia di Catania(1807-1894), esemplare depositato presso la Biblioteca Universitaria Regionaledi Catania, con segnatura Mss Arm. 4.186-213.
25 L’atteggiamento di gran parte del clero siciliano e napoletano fu di pro-fonda ostilità nei confronti del nuovo Stato, specialmente dopo l’emanazionedei Decreti luogotenenziali del 17 febbraio 1861, su relazione di Pasquale Sta-nislao Mancini, che abolivano il Concordato, ed applicavano alle provinciemeridionali le riforme ecclesiastiche vigenti in Piemonte. Cfr. ASNa, fondoBorbone, b. 1147, Indirizzo dei Vescovi di Sicilia a S.M. Francesco II, 26 febbraio1864; B. Pellegrino, Vescovi borbonici e Stato liberale 1860-1861, Roma-Bari1992; R. De Lorenzo, Clero, legittimismo, ordine pubblico e organizzazione delloStato nel Mezzogiorno dopo il 1860, in «Archivio Storico per le Province Na-poletane», a. XXI (1982), pp. 335-348.
Non sono mancati dei tristi in vari Comuni, come Catania, Caltagirone,Nicosia, Mirabella e qualche altro, a far comparire dei cartelli sediziosi,per rappresentarle questa leva come un atto abusivo del potere e nocivoad un popolo che ne è stato sempre esentato, ma ciò in quanto a Catania[…] è attribuibile alle mene di qualche Monaco, che la S.P. ha saputorintracciare, arrestando un Padre Damiano, cappuccino, e rinvenendoin camera di un Padre Cirillo carmelitano, detenuto per precedenti im-putazioni politiche in queste Prigioni Centrali, l’originale di un cartellostrappato pochi giorni prima dalle pubbliche cantonate della città26.
Il rinvio a giudizio dei due frati – e l’arresto, poco successivo, diFrancesco Chines, trovato in possesso di un proclama di Francesco II27
– inducono il Prefetto a cercare una mediazione con il fronte borbonico.Alla fine di novembre Ajello e molti altri compagni si vedono recapitareuna convocazione urgente28, e ascoltano con scarso interesse una lungaorazione sulla necessità, per loro, di abbandonare la «pazza e vana lusinga[…] di vedere realizzare un avvenire divenuto oramai impossibile»29. Quello che Tholosano non riesce a comprendere, tuttavia, è che
la lotta dei legittimisti ha ormai subìto una netta inversione di rotta,lasciando il terreno della pura e semplice restaurazione per approdarea quello, certo più fertile, dell’attacco frontale alle lacune del nuovoStato: l’opposizione alla leva rappresenta, così, l’occasione più propiziaper recuperare il consenso del popolo catanese, che già all’inizio digennaio del nuovo anno annovera al suo interno più di 950 renitenti30. La situazione, del resto, è comune a tutta la Sicilia, travagliata da
un profondo scollamento tra classi dirigenti e masse popolari, frustratanelle sue richieste di autonomia, soggiogata da un governo, quelloLuogotenenziale, che riunisce in sé i poteri civili e quelli militari, con-fondendo il dissenso con la criminalità. Le parole di una relazione sullecondizioni dell’isola, recapitata da un anonimo mittente all’indirizzodel Presidente del Consiglio Ricasoli, restituiscono l’immagine di unarealtà tormentata, afflitta da mali profondi quanto antichi, per i qualinon si riesce a trovare una cura:
242
26 ASPa, Prefettura – Gabinetto, b. 2, Copia del rapporto del Prefetto di Ca-tania a S. E. il Ministero dell’Interno in Torino, Catania 20 novembre 1861.
27 Cfr. Ivi, Sullo spirito pubblico della Provincia, Catania 2 dicembre 1861.28 Ibidem.29 Ibidem.30 Ivi, Sulle condizioni della leva in Provincia, Catania 11 gennaio 1862.
Il malcontento è generale, e si accresce ogni giorno, perché le leggi di leva,d’imposte ecc. sono in ogni stato odiose, e devono maggiormente esserlein un paese che faceva la rivoluzione piuttosto per non pagare dazi, cheper un sentito principio politico. Ond’è che il malcontento non è controil Ministero B o C, ma contro l’Unità, lo Stato, il Governo in astratto31.
Unico antidoto a quel malcontento sembra essere, per il momento,l’uso della forza, con la ferma intenzione di estirpare le minacce piùinsidiose alla vita nazionale: la risposta del governo alle proteste del-l’isola si tramuta allora in una forsennata ricerca di nemici interni, col-pevoli di esternare dissenso, a prescindere dal colore politico di cui lorivestono. L’esordio del 1862 vede così la Sicilia stretta in una morsadi repressione che colpisce, nella stessa misura, democratici e borbo-nici, accomunati, nelle rappresentazioni delle autorità, da un’avver-sione al nuovo Stato che, pur muovendo da sponde opposte, finiscecon l’approdare alla dimensione condivisa della cospirazione. Comein una strana profezia che si auto-avvera, le storie di quei “delusi” fi-niranno con l’incontrarsi davvero, nel giro di qualche anno: in quelmomento, tuttavia, si muovono ancora su strade parallele. I democratici vivono con rammarico il nuovo ruolo da antago-
nisti: «depressi, avviliti, trattati con ingiurie e confinati nei bagni enegli ergastoli»32, dopo aver indossato gli abiti da vincitori, dopoaver condotto e sostenuto la rivoluzione nazionale con tutte le forzedi cui erano capaci, sperimentano adesso l’oltraggio ed il sospetto,in ragione delle loro idee radicali, a causa dell’incapacità di «rompereintieramente con gente che sogna la repubblica»33. La spedizione ga-ribaldina del 1862, fermata sull’Aspromonte34, getta su di loro nuova
243
31 Archivio Centrale dello Stato (d’ora in avanti ACS), Carte Ricasoli, b.2, Relazione sulla situazione in Malta e in Sicilia, gennaio 1862.
32 P. Oliveri, Episodi della Rivoluzione Siciliana. Rivelazioni segrete sulla vitapolitica di Giuseppe La Farina e suoi seguaci, Losanna 1865, p. 5.
33 D. Pantaleoni a B. Ricasoli, Rapporto a S. E. il Signor Ministro dell’Internosulle condizioni della Sicilia, citato in G. Scichilone, Documenti sulle condizionidella Sicilia dal 1860 al 1870, Roma 1952, p. 100.
34 Dopo che il tentativo del Generale di marciare dalla Sicilia al continented’Italia per sottrarre Roma al Papa fu stroncato, il 29 agosto 1862, il governodichiarò lo stato d’assedio in tutto il Mezzogiorno e sull’isola. Venne anche so-spesa la libertà di stampa e ridotta quella d’associazione; cfr. L. Riall, La Siciliacit., pp. 179-204.
ondata di discredito, a cui non possono reagire se non per mezzo diestenuanti polemiche, condotte – dagli scranni del Parlamento cosìcome dalle colonne dei giornali che riescono a eludere la censura –allo scopo di denunciare al popolo il dispotismo e le vessazioni delgoverno torinese35. Così, le parole prendono il posto dei fatti, la-sciando i democratici in balia di un’opposizione “legale” che smorzal’efficacia delle loro battaglie.Come in un remake a parti invertite, sono i borbonici a combattere,
adesso, sul fronte della cospirazione, servendosi dei propri esuli disse-minati per l’Europa non meno che dei fedeli sostenitori rimasti in pa-tria, e abbandonando le parole – versate a fiumi nella prima fase delloro “calvario” politico, all’indomani del crollo della monarchia – perfare posto alle azioni. La fuga del sovrano a Roma36, infatti, se ha mo-strato chiaramente che l’Italia non è un incubo destinato a svanire infretta, è stata anche l’occasione per una profonda riorganizzazione dellastrategia di riconquista, con l’ideazione di un nuovo, grande progettoche prova a legare i centri dell’esilio, la corte romana e le province del-l’ex Regno. Comitati borbonici nascono a Parigi, Lione, Bruxelles eLondra, poi si spingono ancora più oltre: Corfù37, Barcellona38, Civi-tavecchia39, Marsiglia40 spalancano le loro porte agli emigrati napoletani
244
35Cfr. Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Discussioni, 25 novembre 1862.36 Avvenuta il 14 febbraio 1861, dopo la resa di Gaeta, che aveva fino a
quel momento ospitato la Corte, sin da quando essa aveva lasciato Napoli, il6 settembre 1860.
37 La centrale d’azione corfiotta è presieduta da Engelbert von Brackel, eopera come centro di raccolta di aiuti e di uomini; cfr. Archivio Storico delMinistero degli Affari Esteri (d’ora in avanti ASMAE), bb. 235-236, Rapportidel Consolato in Corfù, 1861-1869.
38 La Spagna si dimostra uno dei paesi più “fertili” per la reazione, fornendoospitalità a molti esuli borbonici e assoldando numerosi volontari alla causa le-gittimista; cfr. ASMAE, bb. 220-221, Rapporti del Consolato in Barcellona,1861-1869; Museo Centrale del Risorgimento di Roma (d’ora in avantiMCRR), fondo Archivio, b. 105, fasc. 27, Lettere del Console d’Italia in Barcel-lona al Ministro dell’Interno; A. Albonico, La mobilitazione legittimista contro ilRegno d’Italia. La Spagna e il brigantaggio meridionale postunitario, Milano 1979.
39 Il Comitato agisce sotto la direzione di monsignor Lorenzo Randi e, perun breve periodo, anche del generale siciliano Ferdinando Beneventano del Bosco.
40 Marsiglia è di certo la sede più dinamica dell’emigrazione borbonica: ilgenerale Afan de Rivera e il vescovo di Sorrento vi lavorano alacremente in qua-lità di Presidenti, avvalendosi della collaborazione dell’ex direttore della Polizia
e siciliani, offrendo una dimora al loro tempo sospeso e una protezionealle loro azioni. Il rifugio più caldo rimane però Malta, la “patria” degliesuli italiani, che raccoglie adesso le storie e le vite dei nuovi vinti41: viprendono stanza nobili, funzionari delle Intendenze e della burocrazia,poliziotti, e un nutrito numero di esponenti del clero, che accettanodi trasformarsi in pedine del legittimismo, sperando in un rivolgimentopolitico che possa restituire quanto l’Italia ha sottratto loro42. L’isolasembra divenire l’avamposto strategico del progetto borbonico: la suaposizione al centro del Mediterraneo la trasforma in una fucina di uo-mini e armi da sbarcare in Sicilia, per spargerli poi in tutte le altre pro-vince del Regno. Poco più a nord, intanto, la corte romana prova aimprimere un indirizzo unitario a quel vibrare di iniziative, avvalendosidell’opera del nuovo governo Ulloa43 e di un nutrito gruppo di consi-glieri che attorniano il sovrano. Proprio nel cuore d’Italia si dipana inquel momento un serrato dibattito tra le due anime del movimento44:una incline al rinnovamento, l’altra orientata alla restaurazione. La di-sputa diventa, talvolta, vero e proprio scontro: la guerriglia che si staconducendo nel Mezzogiorno pone il problema, spinoso, di come as-servire alla causa di re Francesco la carica eversiva dei briganti, arruolatisolo a sé stessi, recalcitranti, ostili ai tentativi di “normalizzazione” at-tuati dagli ufficiali. La violenza sperimentata nelle province continentali
245
siciliana, Salvatore Maniscalco. Sull’attività del Comitato cfr. ASMAE, bb. 250-251, Rapporti del consolato in Marsiglia, 1861-1867; ASNa, fondo Borbone, b.1146. Sulla vita da esule di Maniscalco cfr. T. Mirabella, Salvatore Maniscalco,Direttore della Polizia borbonica ed esule dopo il ’60 a Marsiglia, Milano 1980.
41 Sulla cospirazione borbonica maltese; cfr. ASNa, fondo Borbone, b. 1607,in particolare Elenco degli individui componenti l’emigrazione siculo-napoletanain Malta; ASMAE, b. 248, Rapporti del Consolato in Malta, 1861-1869.
42 Per una ricognizione di borbonici e clericali dimoranti sull’isola cfr.MCRR, fondo Archivio, b. 105, fasc. 26, Lettere del Console d’Italia in Maltaal Ministro dell’Interno, con allegato l’elenco dei borbonici e dei Padri gesuiti e li-guorini lì dimoranti.
43 Il nuovo governo era presieduto da Pietro Ulloa, e annoverava al suo in-terno anche Salvatore Carbonelli, Ministro delle Finanze; Leopoldo Del Re,agli Affari Esteri; Antonio Ulloa, Direttore della Guerra; cfr. F. Leoni, Il governoborbonico in esilio (1861-1866), Napoli 1984; Id., L’attività diplomatica delgoverno borbonico in esilio (1861-1866), Napoli 1969.
44 Nell’ambito del Gabinetto Ulloa si era realizzata da subito una spaccaturatra la fazione “costituzionale”, che faceva capo al Presidente del Consiglio, e lafazione “assolutista”, capeggiata da Del Re.
del Regno dissolto eccita le nostalgie sanfediste di una parte dei bor-bonici: nell’altra, tuttavia, suscita sgomento, soprattutto dinanzi alleproteste dell’opinione pubblica europea. I due volti del dispatrio sifronteggiano allora in un duro faccia a faccia, che prende le mosse dallemodalità della “riconquista” e poi si allarga, impetuoso, alla scelta degliobiettivi strategici della cospirazione. Presto, l’oggetto del contenderediviene la Sicilia: i più non le perdonano i tradimenti del passato, le ri-volte, l’indocile fremito di indipendenza; così, vorrebbero tagliarla fuoridalle attenzioni del governo in esilio, lasciandola in balia della sua “di-versità”, di quella tanto invocata, e ostinata, autonomia; gli altri, Pre-sidente del Consiglio in testa, pensano invece che proprio dall’isola sianecessario ripartire per riprendere in mano le redini del trono: in Siciliail Regno è stato perduto, e in Sicilia si potrà riconquistare, trasfor-mando i suoi abitanti in “nemici” dello Stato italiano e piegando laloro naturale alterità alle ragioni della monarchia di Francesco. Quella che si consuma a Roma è una vera e propria guerra fra-
tricida tra due opposte visioni politiche, e il giovane sovrano, forseancora troppo “figlio” per poter essere un padre autorevole, non rie-sce a dirimere la contesa, se non oscillando dubbiosamente tra ledue opzioni in gioco. Il brigantaggio gli sembra a tratti una minaccia,a tratti un’ancora di salvataggio: così gli si avvicina e poi se ne di-scosta, senza saper bene come maneggiarlo. Solo in merito alla Siciliale sue idee si fanno progressivamente più chiare: le ripesca dal baga-glio dei ricordi, dalle parole del padre, da quelle, ancora più decise,pronunciate dal fidato Filangieri nel momento della sua nomina aPrimo Ministro. Francesco ne è sicuro: è sull’isola che bisogna pun-tare. A gennaio del 1862 scrive al Principe di Cassaro45, a Napoli:
Gli avvenimenti che di giorno in giorno àn luogo, massime nella Sicilia,portano a credere […] con qualche probabilità che la loro continuazione
246
45 Antonio Statella, nato nel 1785, apparteneva a una famiglia aristocraticasiciliana. Dopo aver ricoperto diversi incarichi diplomatici dal 1815 al 1830, funominato Ministro degli Esteri del Regno delle Due Sicilie, mantenendo la suacarica fino al 1840. Allontanato dalla vita politica a causa di beghe con il sovranointorno alla nazionalizzazione del commercio dello zolfo siciliano, fu richiamatoda Francesco II alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 13 marzo 1860, efino alla svolta costituzionale del 25 giugno resse le sorti del governo. Dopo l’uni-ficazione rimase a Napoli, fungendo da punto di raccordo tra la corte in esilio ela città partenopea. Cfr. infra il saggio di Margherita Bonomo.
dovrà sempre più interessare me, e quanto à rapporto alla buona causa.Se finora ò potuto rimanere qui privo di un abile esperto siciliano che[…] fosse a giorno delle leggi, degli affari e dei bisogni dell’isola, orapiù non è possibile46.
La pronta risposta di Statella porta alla designazione di un inca-ricato per la Sicilia, Antonio Invidiato: l’uomo viene convocato aRoma da Firenze, dove ha scelto di riparare, e resta lì per diversi giorniprima di mettersi in marcia in direzione dell’isola, con la testa pienadelle istruzioni che il governo ha stilato per lui. Il re ne è entusiasta:
Invidiato è stato qua, ed à avuto con me lunghe conferenze. Ò trovatoin lui l’uomo onesto, zelante, istruito e capacissimo in ciò che riguardale cose di Sicilia47.
Dopo qualche mese, però, è chiaro a tutti che la missione è stataabiurata: Invidiato non ha più fatto avere sue notizie, e il fatto cheinsieme a lui sia sparito anche tutto il denaro che gli era stato affidatosembra la prova inconfutabile dell’ennesimo “tradimento”48. È a quel punto che a Roma prende corpo un progetto ancora
più ambizioso: la creazione di una Commissione per gli Affari diSicilia, un intero organismo governativo immaginato e concepitoal solo scopo di dedicarsi alle questioni dell’isola. Del consesso sonochiamati a far parte diversi esponenti di spicco dell’emigrazione ro-mana, cooptati per tessere una nuova rete di rapporti con i comi-tati dell’esilio, e soprattutto con le province siciliane. I loro nomisembrano una garanzia di riuscita dell’impresa: Ignazio Pilo49, Conte
247
46 ASNa, fondo Borbone, b. 1146, Lettera di S.M. Francesco II al Principedi Cassaro, Roma 29 gennaio 1862.
47 Ivi, Lettera di S.M. Francesco II al Principe di Cassaro, Roma 11 maggio 1862.48 Cfr. ASNa, fondo Borbone, b. 1146.49 Nato a Palermo nel 1807, Pilo aveva intrapreso, sin dal 1833, una bril-
lante carriera all’interno dell’amministrazione borbonica: Senatore aggiuntodi Palermo e Consigliere di Intendenza a Siracusa, era divenuto Sottointen-dente del distretto di Sciacca il 31 dicembre 1837. Nel 1845 era stato nomi-nato Segretario Generale dell’Intendenza di Palermo, per poi essere messo acapo di quella di Girgenti il 7 luglio del 1855. Infine, il 27 febbraio 1857 erastato trasferito a Trapani. Dopo il crollo del Regno aveva seguito Francesco IIa Roma. Cfr. ASNa, fondo Borbone, b. 1010, Stato di servizio degl’IntendentiMarchese Artale, e Conte di Capaci, 4 agosto 1858.
di Capaci e fratello del più noto Rosolino; Emanuele Raeli50; il ba-rone Ferdinando Malvica51; il sacerdote Giuseppe Carnemolla52 el’avvocato Gioacchino Grassi53; nonché Pietro54 e Girolamo55 Ulloa
248
50 Fratello del patriota Matteo, Emanuele aveva ricoperto diversi incarichinell’amministrazione siciliana e dopo il 1860 si era trasferito a Roma.
51 Nato a Palermo nel 1802, era il figlio cadetto della famiglia dei Baroni diVillanova. Aveva partecipato ai moti siciliani del 1820, e per questo era statoallontanato dall’isola. Nel 1830 era rientrato a Palermo e due anni più tardiaveva dato il via, insieme a Vincenzo Mortillaro, al periodico trimestrale «Effe-meridi Scientifiche e Letterarie per la Sicilia». La rivista, molto critica nei con-fronti della politica economica del governo borbonico, si era attirata da subitoi sospetti delle autorità. Entrato in contatto con Vieusseux, aveva dato sfogoalle sue tendenze “antinapoletane” pubblicando la Memoria sul cabotaggio traNapoli e Sicilia, scritta nel 1836 ma pubblicata nel 1838. Nonostante le sueidee “eversive”, dal 1840 aveva intrapreso la carriera nell’amministrazione bor-bonica, ed era divenuto Intendente del Molise, dove era rimasto per due anni,lottando contro gli eccessi polizieschi. Nella rivoluzione del 1848 aveva tenutoun atteggiamento ambiguo, e la sua tendenza a oscillare tra repubblicanesimoe borbonismo gli aveva provocato le accuse di entrambi gli schieramenti. Re-staurata la monarchia borbonica, Filangieri lo aveva voluto al suo fianco comeDirettore degli Interni in Sicilia, dove si era distinto per una politica riformatricee per la sua inclinazione verso un governo temperato. Lasciato l’incarico agliInterni, era stato destinato alla Consulta e nel 1860 era fuggito a Roma, dovesi era dedicato alla stesura di diversi opuscoli sull’idea confederativa, fino ad ap-prodare a posizioni di estremo liberalismo e anticlericalismo. Cfr. G. Fiume,Ferdinando Malvica (Appunti), in «Nuovi Quaderni del Meridione», XVIII(1980), 1, pp. 79-102; Id., La crisi sociale del ’48 in Sicilia, Messina 1982.
52 Arciprete di Scicli, Carnemolla era passato da posizioni apertamente an-tiborboniche – che nel 1860 lo avevano portato a prendere parte ai moti netinidell’8 aprile e a subire l’arresto per opera dell’Intendente Mezzasalma – a unarinnovata adesione alla causa di Francesco II in esilio.
53Nativo di Monreale, era stato reclutato in funzione della sua parentela conRosario Miceli, reclutatore di bande e seguace del democratico Giuseppe Badia.
54 Nato a Napoli il 12 febbraio del 1802, e presto entrato nell’esercito, Pie-tro aveva partecipato, sotto gli ordini di Guglielmo Pepe, alla difesa del Regnodalle truppe austriache. Per questioni sentimentali, aveva abbandonato la car-riera militare e intrapreso quella legale, divenendo un avvocato di fama e poiMagistrato, con prima sede ad Avellino. Nel 1838 era passato alla Procura Ge-nerale di Trapani. Dopo diverse peregrinazioni, era stato affidato alla CorteSuprema di Napoli, dov’era rimasto in servizio fino al 1860. Destituito peropera del governo dittatoriale, aveva seguito il re a Gaeta e poi a Roma, doveera divenuto Presidente del Consiglio. Cfr. ASNa, fondo Borbone, b. 1134.
55 Nato nel 1810, aveva compiuto gli studi alla Nunziatella. Aveva parte-
e il ministro spagnolo Bermudez56, intimo consigliere di Francesco. Il loro primo impegno è quello di fornire una coperta ideologica
alle aspirazioni dell’isola: mesi di lavoro portano alla redazione di unprogetto costituzionale che le regala lo status di regno indipendente,anche se sotto il governo di un membro della famiglia reale; le ga-rantisce le libertà d’opinione e di stampa, un esercito separato, unParlamento stabilmente collocato a Palermo. Subito dopo, viene la necessità di individuare una strategia con-
creta per la riconquista, con l’elezione di tre inviati speciali: uno perla rotta Marsiglia-Genova-Torino; il secondo responsabile dei rap-porti con la Sicilia; l’ultimo addetto alle relazioni con Malta: l’ideaè quella di trasfondere la linfa rivoluzionaria dal centro romano alleperiferie dell’isola. È un progetto ambizioso, quello, che si muovesul “doppio binario” della cospirazione militare e della convergenzapolitica con i deputati che, in Parlamento, protestano contro il go-verno italiano:
Il Sig. Emmanuele Raeli muoverà direttamente per Marsiglia. Ivi siprocurerà un passaporto Italiano, onde allontanare ogni sospetto, e sirecherà a Genova e poscia in Torino. Egli va munito di lettere […] peri signori D. Matteo Raeli, Emerico Amari, B.ne Ondes Reggio e qual-che altro Deputato siciliano […]. Più dovrà trovar modo di conoscerele operazioni tutte de’ Rivoluzionari, ed indagare pure le operazioni
249
cipato, nel 1848, alla guerra in Lombardia con i volontari guidati da GuglielmoPepe. Nel maggio dello stesso anno era stato eletto Deputato della provinciadi Napoli e nel gennaio dell’anno successivo membro dell’Assemblea di Vene-zia. Dopo la capitolazione di quest’ultima, aveva seguito Manin nell’esilio pa-rigino, dove era rimasto fino al 1859. Solo allora aveva fatto ritorno: contattatoda Cavour, era entrato infatti nei reparti dell’esercito sardo. Ad agosto di quel-l’anno era stato allontanato dal Piemonte e aveva fatto ritorno a Napoli, dovesi era riavvicinato ai Borboni, che aveva poi seguito in esilio.
56 Salvatore Bermudez de Castro, marchese di Lerma, era il Ministro diSpagna a Napoli, Gaeta e Roma. Strenuo sostenitore della restaurazione diFrancesco II, si era fatto portavoce di questa idea a Madrid, anche a costo diinimicarsi una parte del governo, progressivamente divenuto indifferente – senon apertamente ostile – alla causa borbonica. Richiamato in patria, si era co-munque rifiutato di abbandonare definitivamente Roma, sia per i suoi legamiaffettivi con la corte in esilio, che a causa delle numerose relazioni che avevaintrecciato con alcune nobildonne napoletane. Come ricompensa per la sualealtà, Francesco gli aveva fatto dono del palazzo della Farnesina.
del partito d’azione […]. Il commissionato per Palermo […] dovràusare tutti i mezzi di buona insinuazione per assicurare a tutti dell’ec-cellenti intenzioni di S.M. e mostrare che il ritorno dell’ordine nonpuò mancare, tanto per le violenze e malgoverno attuale, quanto pervolere dei Potentati di Europa […]. Il sig. Gioacchino Grassi, com-missionato in Malta, appena sarà ivi arrivato stabilirà due Comitati,uno di direzione e l’altro di azione57.
La corte di Roma non può certo immaginare, in quel momento,che proprio Raeli, l’uomo di punta del progetto, si rivelerà in breveuna spia al soldo del Ministero dell’Interno, disposto a vendere i det-tagli della sua missione in cambio di un posto in prima fila nell’altaburocrazia del nuovo Stato, capace di determinare il fallimento diuna parte consistente dei piani dell’esilio: ignari di tutto ciò, i bor-bonici procedono, spediti, all’allestimento della propria rete. Tra lafine del 1862 e l’inizio dell’anno successivo vengono progettati nu-merosi sbarchi clandestini sulle coste siciliane, e intanto si procedea una riorganizzazione dei comitati nei capoluoghi interni: alla pro-paganda – e alla raccolta di munizioni e denaro – si affianca prestola realizzazione di un complesso sistema di reclutamento dei reni-tenti, spediti in grandi quantità a Malta, e lì addestrati a far ritornoin Sicilia, muniti delle armi e del coraggio necessari per provocareun’insurrezione armata58. La «tratta dei disertori» è particolarmente intensa nella parte orien-
tale dell’isola, e trova proprio a Catania il suo centro nevralgico: trail capoluogo etneo e l’emigrazione melitense si realizza da subito unapesante osmosi, che trova nel fronte Ajello-Guglielmino-Attard il suoperno centrale. Gaetano e i suoi compagni hanno accettato già daqualche mese di compiere il «gran salto»: la loro opposizione al nuovoStato non si serve più solo di astratte parole, ma poggia sui fatti. Laprogettualità della Commissione li ha definitivamente convertiti allacausa borbonica, e alle linee generali formulate a Roma hanno ag-giunto, d’accordo con gli altri membri del Comitato, dei piani det-tagliati che riguardano la città, e che uniscono il legale all’illecito: la
250
57 ASNa, fondo Borbone, b. 1134, Istruzioni per i Commissionati, Roma12 settembre 1862.
58 Cfr. ASNa, fondo Borbone, b. 1607, Notamento degl’individui sbarcaticlandestinamente in Malta, fuggiti dalla Sicilia per causa della leva militare, aprile1862.
“conquista” dei seggi elettorali – una sorta di occupazione pacificadei nuovi spazi della politica – e insieme a questo, naturalmente, ilcomplotto militare. Mentre cercano nomi “puliti” da presentare alleprossime elezioni, con un programma che sfida lo Stato su infrastrut-ture e politica fiscale59, i catanesi si occupano anche di coordinarel’import-export cospirativo, soprattutto grazie alla dimestichezza diGaetano con tutto quello che riguarda il mare: il suo passato da guar-dia sanitaria addetta alle dogane torna, improvvisamente, molto utile.Quegli intrighi, tuttavia, per quanto abilmente nascosti, non man-
cano di suscitare l’apprensione delle autorità. Così, a gennaio del 1863il Prefetto stabilisce una sorveglianza speciale sull’attività di FilippoBurgio, ex percettore a Monterosso, che si sposta incessantementeda Catania a Noto, passando per Giarre, insieme a una compagniadi altri borbonici. Le ricerche danno i risultati attesi: l’uomo si oc-cupa dell’arruolamento di renitenti e del loro invio a Malta. La «cri-minosa attività» viene subito stroncata mediante il suo arresto60, maa turbare la tranquillità di Tholosano c’è la certezza che oltre 100giovani soldati sono già stati sottratti all’Italia per andare a nutrire lelinee della reazione61. Ad appena un mese, le notizie maltesi si fannoancora più allarmanti; l’isola è sempre stata il centro di smistamentodella corrispondenza introdotta in Sicilia, ma quello che turba dipiù le autorità, in quel momento, è il contenuto dei fogli clandestini,densi di pericolose promesse politiche del governo di Francesco II:
Questa nuova manifestazione del Borbone […] cerca di commuovere glianimi colla esposizione delle miserie del suo esiglio, colla esaltazione dellanazionalità Napolitana e Siciliana e colle promesse di un governo rappre-sentativo per come potesse essere dai suoi amati sudditi desiderato62.
La reazione si avvale insomma di un discorso nazionale, usato però
251
59 Cfr. ASCt, Questura, Elenco I, b. 6, Progetti borbonici per una ferroviada Catania a Castiglione; ASNa, fondo Borbone, b. 1606, Prospetto per un si-stema fiscale siciliano in vista di un rientro, Catania maggio, 1862.
60 ASCt, Questura, Elenco I, b. 3, Riservatissima del Sottoprefetto di Acirealeal Sig. Questore della provincia di Catania, 26 febbraio 1863.
61 Cfr. ASPa, Prefettura – Gabinetto, b. 2, Copia del rapporto del Prefetto diCatania a S. E. il Ministero dell’Interno in Torino, Catania 28 febbraio 1863.
62 ASCt, Questura, Elenco I, b. 3, Riservata del Questore di Catania al Sig.Prefetto della città e provincia, Catania 2 marzo 1863.
in chiave anti-italiana, e la sua propaganda si incentra sui temi delgoverno rappresentativo, dell’autonomia siciliana, della tutela delleidentità preunitarie, utilizzate adesso come antidoto al pesante ac-centramento piemontese. I pericoli, però, sono ancora più profondi:oltre alla loro carica “naturalmente eversiva”, questi punti program-matici si portano dietro una singolare affinità con quelli diffusi dal-l’opposizione di matrice garibaldina e repubblicana, che proprioin quel momento vive una calda stagione progettuale. È soprattuttoil fronte Badia-Corrao a destare i timori del governo siciliano: i duehanno fomentato per mesi il malcontento dell’isola, fino quasi aprovocare una sollevazione popolare, a Partinico, con l’insperato ap-poggio del Comitato borbonico della città. Adesso, dopo essere mi-racolosamente scampati all’arresto, operano da latitanti, su e giù perle campagne siciliane, provando a stringere ancora di più i legamicon la reazione. L’eco di quel connubio si sparge per tutta l’Italia:persino il Prefetto di Genova si sente in dovere di inoltrare a Palermola lettera di un suo informatore, densa di notizie “scottanti” sulla Si-cilia. Per una singolare coincidenza, lo scrupoloso mittente rispondeal nome di Filippo Gualterio, che in capo a due anni sarà inviato asvolgere il suo incarico proprio nel capoluogo palermitano, dandovita a una cruda repressione all’indirizzo di criminali comuni e op-positori politici. La missiva che inoltra sull’isola sembra insomma ilprologo della sua attività:
In Sicilia ancora si cospira […]. Mi assicurano che Corrao sarebbe allatesta del moto […]. Parlano di un 500 associazioni principali a Palermoe dintorni; Caltanissetta si offrirebbe spontanea; Messina si rifiuterebbe[…]; a Catania vi sarebbe del marcio nella Guardia Nazionale, nellaquale vi sarebbero una cinquantina de’ più ardenti63.
Ancora una volta, è proprio Catania a emergere come epicentrodella cospirazione. Oltre alla Guardia Nazionale, sono i borbonici arappresentare un pericolo: Ajello e soci agiscono sotterraneamente,reclutando cospiratori e fomentando il malcontento della popola-zione; così, la città è preda di sinistri sommovimenti, talvolta veri epropri furori.
252
63 ASPa, Prefettura – Gabinetto, b. 6, categoria 15, Rapporto di un infor-matore, s.d.
I timori delle autorità di un’occulta alleanza tra le due ali dellaprotesta si fanno sempre più forti, specie in un momento così com-plesso per l’intera isola: l’applicazione della legge Pica64 suscita infattiuna nuova ondata di violenze e di arresti, e nemmeno la morte diCorrao, ad agosto, serve a sedare l’allarme per i complotti borbo-nico-garibaldini. Anche Francesco II, del resto, appare estremamenteconvinto che la strada della convergenza sia quella da percorrere:
Passiamo per una terribile epoca, ma gli avvenimenti incalzano, la crisisi avvicina, ed è a sperarsi che qualunque sia il risultato degli avveni-menti di Sicilia, il divorzio del partito d’Azione italiano col Governopiemontese aprirà la strada ad una reazione salutare65.
La lettera porta la data di agosto del 1863: l’esperimento dellaCommissione Siciliana si è rivelato fallimentare, specie dopo la sco-perta del doppio gioco di Raeli, e le azioni dei borbonici sono lasciate,in quel momento, alle iniziative dei singoli Comitati dell’isola. Tra ipiù attivi, c’è come sempre quello di Catania: la città è coinvolta nelpropagarsi di intrighi e attività clandestine, costringendo la Polizia aun’intensa e incessante sorveglianza. A impensierire le autorità sonosoprattutto tre borbonici, presunte sentinelle della reazione etnea. I loro nomi, ormai noti, evocano immediatamente il pericolo di
una restaurazione: Gaetano Ajello, Francesco Guglielmino, FeliceAttard; i loro movimenti, poi, sono circospetti quanto basta per su-scitare allarme: quello che emerge, dai pedinamenti, è un intreccio
253
64 Promulgata dal governo Minghetti il 15 agosto del 1863, la legge erastata presentata come un mezzo eccezionale e temporaneo per la difesa delloStato. Il provvedimento legislativo seguiva di circa un anno la proclamazionedello stato d’assedio nelle province meridionali. La legge sospendeva le garanziecostituzionali dello Statuto albertino, delegando le competenze per i reati dibrigantaggio ai tribunali militari. Si prevedeva inoltre la condanna al domiciliocoatto per vagabondi, disoccupati, sospetti manutengoli, camorristi e fian-cheggiatori. Era stata estesa alla Sicilia, nonostante nell’isola fosse assente ilgrande brigantaggio, per combattere il fenomeno della renitenza alla leva, eaveva subito una torsione in senso autoritario, con l’introduzione del concettodi responsabilità collettiva. Cfr. R. Martucci, Emergenza e tutela dell’ordinepubblico nell’Italia liberale, Bologna 1980.
65 ASNa, fondo Borbone, b. 1146, Lettera di S.M. Francesco II al Principedi Cassaro, Albano 23 agosto 1863.
di segreti e complotti, in cui i peccati della carne si confondono aquelli della politica. A dicembre del 1864, il Questore redige ad Alessandro Bossini,
neo-Prefetto, un dettagliato resoconto di quello strano affare:
Attard […] suddito Inglese perché nato a Malta […] sotto la veste dicommerciante di fili-grane, chincaglie ed altre minuterie, tiene attiva cor-rispondenza con segnalati retrograti residenti in Malta […]. Il medesimoè in stretta relazione con certo Ajello […] e con certo Francesco Gugliel-mino, ambedue notissimi borbonici […]. La sera del 7 corrente ad oramolto tarda tutti e tre convenivano in casa di certa Rosa Greco, indiziatacome manutengola alla prostituzione, perché coabitando con certa DonnaMicia, facilita le relazioni amorose di costei col suo antico padrone e drudoDon Francesco Guglielmino. Invece però di scandali morali nella casadella Greco si commettono forse degli scandali politici66.
L’irruzione dei poliziotti in casa Greco non è stata abbastanzatempestiva da cogliere gli uomini in flagranza di reato, ma l’appun-tamento con la legge, per i tre, è solo rimandato. Da quel momento,sono entrati nel mirino delle autorità, e la retata del 15 gennaio hafinito per coronare i mesi di sorveglianza, giusto in tempo per scon-giurare una nuova impresa: da più parti, in città, si mormora che illoro Comitato avesse fissato un’insurrezione armata per giorno 16,la prima alba dopo gli arresti…
19 gennaio 1865. Il lungo flashback di Ajello si interrompe bru-scamente: sono ricordi troppo vicini, quelli, per poter far parte delpassato. L’arresto dei compagni e le indagini che non vogliono tro-vare tregua sono come un cerchio che gli si stringe intorno: anche ilsuo nascondiglio appare ormai troppo scoperto. Non si sorprende,Gaetano, quando le voci e i passi sempre più vicini gli annuncianoche la sua fuga è terminata. Non prova nemmeno a opporre resi-stenza: accetta di seguire gli agenti, ovunque lo condurranno. Laprima meta è il commissariato, e subito dopo gli si spalancano leporte del carcere. Lo attendono giorni di interrogatori: nonostanteil tentativo di trincerarsi nel silenzio, il suo ruolo nella cospirazionediventa pian piano più chiaro, permettendo l’arresto di altri affiliati
254
66 ASCt, Questura, Elenco I, b. 3, Rapporto del Questore di Catania al Sig.Prefetto della provincia, Catania 15 dicembre 1864.
alla setta: alcuni catanesi, come l’ultimo patrizio della città, EnricoPisani Ciancio67, gli altri disseminati per l’isola. Il tentativo di esten-dere le indagini all’area intorno a Palermo trova nel nuovo Prefettodella città, Gualterio, un pronto esecutore. È così che Bossini gli in-dica la strada da seguire:
Io procedei molto all’azzardo. Credo che se i tuoi borbonici ti dannofastidio non esiterai a fare come ho fatto io. Con questa canaglia si puòtirare un po’ via: sin quando si è d’accordo col Ministero pubblico èben facile legalizzare il provvedimento. Se non si riesce a chiapparenulla, si è certi di metterli paura e di scongiurare le trame per cui nondanno più noia da un pezzo68.
In effetti, in quel frangente le autorità catanesi non esitano a ser-virsi di delazioni ed esposti anonimi per procedere ad accuse e catturesu tutto il territorio: molto spesso si tratta di notizie infondate, talvoltafiglie di una brama di vendetta personale che poco ha a che fare conil desiderio di giustizia. Quel clamore desta l’attenzione dell’opinionepubblica di ogni parte d’Italia, e serve ai borbonici per gridare alloscandalo: oltre agli innocenti finiti nella tempesta, a indignarli è lalentezza del processo, di cui ancora non è stata fissata la data. «L’Ecodi Sicilia» strumentalizza quelle notizie per una dolente requisitoria:
Sono già trascorsi due mesi da quella malaugurata notte in cui venivanotradotti alle grandi prigioni diversi ragguardevoli cittadini del nostroPaese. Noi sogguardando gli atti della precedente lor vita, ed una in-temerata condotta […] nell’intimo del cuore, li appellammo innocenti:ma non per tanto intendemmo menomamente pregiudicare le saviedisposizioni della giustizia, la quale spesso vien costretta a procedere,su di una denunzia, che poi bendata al vivo, non lascia dietro di sé,che abominevoli vestigia della più nera ed impudente calunnia. Or-
255
67 Pisani Ciancio aveva alle spalle una storia “travagliata”: arrestato nel 1835insieme a Placido De Luca per cospirazione antiborbonica, era fuggito in esilioa Malta subito dopo il rilascio; ritornato in patria, nel 1859 aveva ricevuto lanomina a Consigliere d’Intendenza e quindi Patrizio di Catania. Inizialmenteconfermato da Vincenzo Tedeschi in questa carica, era stato successivamenterimosso in seguito al decreto dittatoriale che escludeva dagli incarichi gli ex im-piegati dell’amministrazione borbonica. Cfr. infra il saggio di Angelo Granata.
68 ASPa, Prefettura – Gabinetto, b. 7, categoria 35, Il Prefetto di Catania aFilippo Gualterio, Catania 4 maggio 1865.
dunque diciamo al magistrato cui spetta: voi ne avete di già restituitouna parte in libertà, li avete dunque riconosciuti innocenti; eppurenon potreste raccogliere una polve seminata al vento, parola detta esasso lanciato non tornano mai indietro – ne più compensare […] lesofferenze per ben due mesi ingiustamente durate in un penosissimocarcere. Con sì deplorevole esempio, vi preghiamo in nome dell’uma-nità e del decoro della giustizia, perché vogliate sollecitare ulteriormenteil pendente processo69.
L’autore dell’articolo è anche il fondatore del giornale: PietroOliveri, membro rampante dell’aristocrazia palermitana, volonta-riamente arruolato alla causa di Francesco II70. I continui viaggi aRoma lo hanno reso un affezionato interlocutore del sovrano – a di-spetto della diffidenza di Ulloa nei suoi confronti – tuttavia la suavera base operativa è la Sicilia, dove sembra essere il più strenuo fau-tore dell’avvicinamento ai “rossi” del partito repubblicano. Ad apriledel ’65, il programma dettagliato di quella convergenza l’ha presen-tato al “suo” re:
Il convegno tenuto in casa Badia ove intervennero i capi della masso-neria decise rispondere concordemente al lavoro dei comitati italianiper un movimento in senso repubblicano […]. Impertanto presentaiun piano d’esecuzione ed analogo un programma. Il piano, fusionedel partito rosso col partito legittimista. Il programma, la reazione con-tro l’attuale monarchia con il ritorno ad un governo provvisorio. Que-sto ordine di idee […] venne generalmente plaudito ed abbracciatodal partito rosso […]. Il movimento in senso legittimista è radical-mente impossibile come impossibile tornerebbe abbattere l’attuale or-
256
69 «L’Eco di Sicilia», Palermo 1 aprile 1865, p. 7.70 Nato a Palermo nel 1836, proveniva da una famiglia molto legata ai Bor-
bone. Il padre Francesco, nel 1848, era stato l’unico membro della Camera deiPari a non firmare l’atto di decadenza della monarchia. Pietro aveva partecipatoai moti del 1860, divenendo intimo amico di Giuseppe La Farina. Subito dopol’estensione delle leggi piemontesi alla Sicilia, deluso dalla frustrazione delle ri-chieste autonomistiche dell’isola, aveva abbandonato la vita politica italiana –nonostante avesse ottenuto un posto nella nuova amministrazione statale – pre-ferendo arruolarsi alla causa borbonica, nell’ambito della quale era divenuto, apartire dal 1865, il principale anello di congiunzione tra Palermo e Roma: lì siera distinto per la costante difesa dei suoi compatrioti dinanzi a Francesco. Cfr.ASNa, fondo Borbone, b. 1146, Lettera di Pietro Oliveri a S.M. Francesco II,Roma 17 settembre 1865.
dine di cose col programma repubblicano. In quanto avere il ritornoal governo provvisorio implicherebbe politicamente la quistione e contal programma la rivoluzione verrebbe a superarsi con l’appoggio certodi tutti i partiti […]. L’idea della maggioranza è per il ritorno al passato,io credo che la restaurazione ne seguirebbe come fatto compiuto. Com-prendo che questa verrà diplomaticamente perseguita, ma la politicaha le sue fasi, e credo non doversi omettere quelle pratiche71.
A maggio, dinanzi alla perplessità di una parte del governo in-torno alla natura del legame con i democratici, Oliveri è tornato conurgenza sulla necessità dell’alleanza tattica:
Sire,tra legittimisti e democratici regna un accordo completo – sfrattarel’attuale governo. Se il partito legittimista non avesse spiegato questaenergica attitudine, il democratico sarebbe insorto solo, e pel suo nu-mero, e pel poco numero, richiamato il governo avrebbe sempre reagitosul borbonico. Fu dunque necessaria la riscossa per agglomerare e nondividere le forze72.
A corte, quelle parole portano scompiglio: Francesco le accogliecome preziosi suggerimenti – probabilmente i più concreti, fino aquel momento – sulla strada da percorrere; Ulloa le interpreta come“fumo negli occhi”, utili solo a distogliere il re dagli intrighi di Oli-veri73; la fazione più retriva della camarilla reale freme all’idea di farcausa comune con i nemici di sempre.
257
71 ASNa, fondo Borbone, b. 1146, Lettera di Pietro Oliveri a S.M. FrancescoII, Palermo 4 aprile 1865. Dopo questo incontro, si era dato il via a una dif-fusione capillare dei proclami stilati in occasione della riunione.
72 Ivi, Lettera di Pietro Oliveri a S.M. Francesco II, Roma 17 maggio 1865.73 Le proposte del duchino d’Acquaviva avevano creato diversi attriti all’in-
terno della corte romana: soprattutto Ulloa si era scagliato contro Oliveri, perchériteneva i suoi progetti esosi e velleitari. Probabilmente, tuttavia, nelle accusedel Primo Ministro trovava sfogo anche la “gelosia” nei confronti di un referenteprivilegiato del sovrano. Lo scontro fra i due si era spostato dalle stanze del pa-lazzo Farnese alla stampa italiana e internazionale, e si era concluso con un di-stillato di discredito nei confronti di Ulloa e di molti altri emigrati della suacerchia, pubblicato da Oliveri sotto il falso nome di David Gizzio. Cfr. ASNa,fondo Borbone, b. 1146, in particolare l’opuscolo ivi contenuto: D. Gizzio, Imisteri di Roma. Lettera agli elettori del Regno d’Italia, Torino 1865 (dai docu-menti nella busta si evince che il luogo di pubblicazione era in realtà Roma).
Mentre a Roma si dibatte, a Catania si indaga. All’inizio di maggio la cospirazione annovera più di 20 individui,
e i suoi legami con i gruppi palermitani guidati da Badia divengonocertezza: una circolare del Ministero dell’Interno ordina l’immediatosequestro della corrispondenza tra l’ex garibaldino e Biscari74, e intantoa Palermo vengono fermati Felice Giacoppo e Antonio Zappalà-Bar-bagallo, inviati di raccordo tra l’Etna e le Madonie. Due mesi dopo èla volta del loro “capo”, scovato in mezzo a una piantagione di tabaccoe portato in carcere dall’ex compagno Carlo Trasselli75. Infine, toccaall’avvocato Correnti, messinese di nascita e catanese d’adozione, in-caricato di stilare liste di borbonici da presentare alle prossime ele-zioni76: si tratta, nel suo caso, del tentativo di colpire un potenzialeavversario politico, prima ancora che un reale cospiratore. La sua cat-tura sembra essere il tassello mancate, l’ultimo per la conclusione delleindagini: a quel punto è possibile dar finalmente avvio al processo…
15 febbraio 1866. L’aula è gremita di gente, una folla di giorna-listi, vecchi nemici e nuovi amici, esperti politici o semplici curiosi,accorsi da tutta la provincia per assistere all’udienza. Ajello ha il postod’onore nel banco degli imputati: è probabilmente il più calmo deicompagni, di certo il più fiducioso nell’esito degli eventi. Lo rassicurasoprattutto la presenza del loro legale, il cui nome desta già di per séla certezza di una tenace difesa: Gabriele Carnazza ha accettato dirappresentarli dopo essere stato rimosso dalla carica di Procuratore,e adesso è in cerca di una vetrina d’eccezione per mostrare all’Italiala sua abilità come giurista e i soprusi di cui è stato vittima. Il suoallontanamento dalla carica di Procuratore Generale – richiesto in-cessantemente dal governo a partire dal 1861 e ottenuto l’anno suc-cessivo – è stato solo l’ultimo passo di una violenta campagna dibiasimi e sospetti a suo carico, dovuti al suo passato da ardito dellarivoluzione e soprattutto alla verve polemica esplosa in seguito ai ple-bisciti del 1860 e culminata nella pubblicazione del pamphlet “L’An-nessione”, in cui le idee di Carnazza sono emerse con chiarezza:
258
74 Cfr. ASCt, Questura, Elenco I, b. 3, Riservatissima di S. E. il Ministrodell’Interno in Torino al Prefetto di Catania, Torino 23 maggio 1865.
75 Dopo un tentativo di evasione, Badia sarà infine processato nel 1867.76 Cfr. ASNa, fondo Borbone, b. 1146.
Noi abbiamo fatto la rivoluzione per essere governati come uomini, enon trattati come bruti colle bastonate sul dorso nelle pubbliche piazze77.
Dopo la “gogna” della rimozione, Gabriele ha deciso di passaredall’altra parte, difendendo gli imputati di cospirazione e reati poli-tici, coi quali condivide la delusione nei confronti del nuovo Stato:il processo dei catanesi si trasforma, così, in una crociata dell’ex ma-gistrato, impegnato a dimostrare che la presunta congiura altro nonè se non il convergere di uomini che hanno deciso di intrecciare leproprie vite per ragionare di una possibile alternativa alla «miseriaattuale»78. Lo dimostra proprio la corrispondenza sequestrata:
Queste lettere mostrano tutto il loro malcontento del Governo attuale,ma non contengono una sola parola che potesse dar sospetto di cospi-razione79.
Sono le garanzie costituzionali sancite dallo Statuto a impedire chela loro azione possa essere considerata un crimine, quel brandello diCarta che le autorità hanno accettato di vilipendere lo dichiara aper-tamente:
La cospirazione è cosa distinta dalla setta. Sotto le vecchie leggi […]erano entrambe punite; ma sotto le nuove è punita la cospirazione enon la setta80.
La conclusione dell’arringa difensiva è l’affermazione della scarsarilevanza dei progetti di Ajello e compagni, colpevoli solo di avercoltivato la velleità di un’impossibile restaurazione, ma incapaci –nelle parole di Carnazza – di tramare concretamente:
Tutto è opera di una mano d’intrigati e d’intriganti, di ingannati ed’ingannatori, di scrocconi e di scroccati, d’illusi, d’imbecilli, di timo-rati, di uomini senza fede; ma nel fondo, in realtà, risoluzione, mezzi,cospirazione: nulla, assolutamente nulla!81.
259
77 G. Carnazza, L’annessione. Risposta agli autonomisti, Catania 1860, p. 10. 78 G. Carnazza, Difesa degli imputati di cospirazione per la ristaurazione de’
Borboni avanti la Corte di Assisie di Catania, Catania 1866, p. 1.79 Ivi, p. 14.80 Ivi, p. 5.81 Ivi, p. 53.
L’impeto indagatore della Polizia catanese, chiosa il legale, nonè riuscito a entrare in possesso di qualcosa di più che alcune lettere,poche armi e qualche sbiadita foto: non è abbastanza per provare lareale minaccia dei “criminali” all’ordine costituito. La sentenza, aquel punto, non può che essere un’assoluzione. L’aula esplode in unsordo boato: è un coro eterogeneo, in cui trovano posto l’esultanzadegli imputati, la rivincita di Carnazza, la protesta dei patrioti. Il loro disappunto, unito a quello delle autorità, si trasforma in
un nuovo allarme qualche giorno più tardi, quando le mura di Ca-tania vengono ricoperte da un infuocato proclama:
Fratelli,All’armi eroi Siciliani – L’ora della riscossa è suonata di poter combat-tere accanto ai figli del Vespro una battaglia che deve infrangere l’ul-timo anello di Catena, con cui fu avvinta questa terra del genio edell’eroismo.Coraggio e Unione! La Sicilia mostrerà al mondo intero che non è de-generata. La Provvidenza benedirà i nostri sforzi, poiché santa agl’occhidi Dio la causa che si appoggia sulla giustizia, sull’umanità, sull’amoredella patria e sulla civiltà.La tirannide Torinese può avere schiavi rinnegati che proni adorinotutti gli orrori di un’ebrietà sanguinaria, ma null’altro fuorché un im-pudente vigliacco può unir la sua voce, fuorché sotto l’incubo del ter-rore, a quella dell’empia congrega…All’armi dunque – Il servaggio deve cessare, e chi è capace d’impugnareun’arma e non l’impugni è un codardo od un traditore della Patria. Ilnostro grido di guerra sarà sempre:Viva Francesco II!Viva la Sicilia!Fratelli! Il nemico cede perché debole – è questo l’ultimo sforzo chesarà vano al par degli altri. Noi vinceremo… Vinceremo82.
La città dei vinti è di nuovo in fermento, ed è lo sguardo agliequilibri internazionali a fomentare nuove speranze. L’alleanza mi-litare tra Italia e Prussia, siglata qualche giorno prima, avvicina laprospettiva di un conflitto antiaustriaco, e quella sembra l’occasionepiù propizia per un tentativo di insurrezione armata: le truppe regiesaranno impegnate sul fronte di guerra, così sarà molto più semplice
260
82 ASCt, Questura, Elenco I, b. 3, Copia di proclama sedizioso redatto a Pa-lermo e diffuso in provincia di Catania, Catania 23 aprile 1866.
sobillare l’incendio siciliano senza che l’intervento governativo riescaa spegnerlo. In quel momento, esercito regolare e armata della co-spirazione sono entrambi in movimento: il primo si sposta versoNord, gli altri reclutano soldati a Malta, coinvolta in un’internazio-nale della controrivoluzione che vede nobili e ufficiali di tutta l’Eu-ropa trasformarsi in volontari della causa legittimista. L’idea è di farconvergere tutte le forze su Palermo, per poi propagare il moto allealtre città dell’isola. La costa intorno a Catania si rivela ancora unavolta una zona strategica, scelta come punto di sbarco degli uominie delle armi, che da lì saranno spostati verso l’antica capitale di Sicilia. In città, l’allarme delle autorità raggiunge il culmine, e il Prefetto
dirama immediatamente una circolare a tutti gli amministratori dellaProvincia:
Provate corrispondenze da Malta avvisano che alquanti Borbonici ten-terebbero uno sbarco intorno a Catania, onde aiutare il movimento diPalermo. Essi sono in quattro piccoli legni carichi di uomini e muni-zioni. L’interesse da farsi è che sia disposta la massima sorveglianza nelcircondario83.
Intanto, l’euforia dei cospiratori si fa tangibile, e al momentodello scoppio del conflitto lo diventa ancora di più: il momento dellariscossa è davvero vicino. Quando scoppia, il 15 settembre, la rivolta di Palermo scatena
le fantasie dei borbonici: il popolo in armi, le barricate, il cerchiodella rivoluzione che lentamente si estende ai paesi limitrofi, tuttosembra il preludio a una grande sollevazione, capace di stravolgerele sorti dell’isola, e da lì quelle della Nazione intera. Anche quelsogno, tuttavia, è destinato a svanire in fretta, determinando la finedella speranza e regalando a quel tumulto un nuovo nome, «che isiciliani, con l’ironia con la quale spesso salano le loro storie piùtragiche, chiamarono la rivolta del “sette e mezzo”, ché tanti giornidurò quella sollevazione»84. Mentre il generale Cadorna procede alla repressione armata, la
conclusione della guerra, con la vittoria dell’Italia, sancisce il defini-
261
83 Ivi, Riservatissima del Prefetto di Catania agli amministratori della provin-cia, Catania 24 agosto 1866.
84 A. Camilleri, Biografia del figlio cambiato, Milano 2000, p. 3.
tivo arenarsi dei progetti borbonici: di lì a poco, anche il governo diRoma sarà sciolto, privando il movimento legittimista di un poterecentrale che, per quanto labile, era pur sempre stato il baluardo dellareazione.Le conseguenze della disfatta sono ben visibili anche a Catania:
dopo anni di inquietudini, la città vive una stasi rassegnata. PersinoGaetano Ajello può ritornare a passeggiare per le vie del centro,senza che la sua presenza desti sospetti: le preoccupazioni delle au-torità per gli intrighi borbonici sono ormai solo un ricordo, nes-suno sembra avere più voglia di dar fiato a polemiche sullo Statoitaliano…
18 aprile 1867. Mentre percorre le stradine intorno a piazzaDuomo, un giovane militare in perlustrazione strappa con foga, dalmuro adiacente l’Arcidiocesi, un manifesto anonimo che infanga ilnome del nuovo vescovo, monsignor Giuseppe Dusmet, col pretestodi rispondere alla sua pastorale del marzo precedente. Il contenutodel volantino evoca vecchi fantasmi:
Monsignore,[…] vi è piaciuto d’incolpare di viltà quei sommi e rispettabili Prelatiche umiliati nel sentimento del proprio nulla, si sono confessati inca-paci di sostenere il gravissimo peso dell’Episcopato; e non già per man-canza di apostolico zelo […] ma sibbene per non essere animati daquello spirito italiano, atto a saper transiggere con i settarii85.
A destare rabbia è la richiesta che l’ecclesiastico rivolge al suo futurogregge: serbare come un bene prezioso il funzionamento dell’ammi-nistrazione catanese, e tutelare con tutti i mezzi l’ordine pubblico. Larisposta è furente:
Monsignore voi scherzate! Chiamare buon andamento, ed ordine l’at-tuale regime di cose, ed il mostruoso, miserando, orribile, scandaloso,rovinoso ed esecrando disordine, che deplora la bella nostra Catanianon solo, ma tutta intera l’Italia governata dalla setta infernale, e chea faccia scoperta, e mano armata distrugge quanto evvi di più sacro evenerando, e fede, e religione, e sagramenti, e morale, e Dio? […]
262
85 ASNa, fondo Borbone, b. 1602, Risposta alla Lettera Pastorale di Monsig.Dusmet Arcivescovo di Catania diretta ai suoi diocesani, Catania 18 aprile 1867.
Chiamate buon stare sotto un Governo, che non tutela l’innocenza,che non esiegue la giustizia, che toglie la libertà agli onesti; ed ove lavirtù si chiama vizio ed il vizio virtù? Monsignore voi sognate vera-mente? Vi piace lo stato quò86?
Le righe finali sono un pesante attacco alla legittimità della fa-miglia regnate e – tramite loro – a quella della stessa Italia:
Dobbiamo credere, che il Cesare, di cui parlate apertamente di volerglirendere quello che gli appartiene non è Francesco II. Chi sarà dunque?Vittorio Emmanuele, sento rispondermi, colui che in atto governa.Ma perdonate Monsignore. Ragionate un po’ meglio. Ascoltateci. Seun capo di una forte banda di assassini occupasse e governasse dei paesimal difesi dal legittimo governo, sarebbe egli per voi un tale assassinoil Cesare di quelle contrade? Credo che no. Ma Vittorio Emmanuele(galantuomo per quanto lo vogliate) per la vostra Diocesi non è cheun forte assassino, che con la forza bruta si sostiene, e scorrazza bal-danzoso le vostre contrade87.
Quei concetti sono un materiale abbastanza scottante per scate-nare l’immediata caccia agli autori. Tuttavia, le indagini non portanoa nulla. I caratteri dello stampato sono stranamente simili a quellidei foglietti scovati – più di due anni prima, oramai – in casa diAjello: eppure la tipografia Galàtola risulta estranea alla vicenda, ela minaccia di Gaetano sembra ormai molto distante, tanto quantola consistenza della cospirazione politica. Il rimedio delle autorità, allora, non può che essere quello di
stracciare tutte le copie della lettera, ogni volta che compaiono affisseal muro di qualche edificio. Quelle parole, però, restano a lungo neiloro pensieri, quasi una prova della latente ostilità dei catanesi per ilgoverno italiano, destinata – almeno per qualche anno ancora – atravagliare la vita della città.
263
86 Ibidem.87 Ibidem.










































![Lucian GIURA, Despărţământul Sebeş al Astrei în documente inedite (1870-1900) [The Sebeş Division of ASTRA in Inedited Documents (1870-1900)]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63221f4a64690856e10903cd/lucian-giura-despartamantul-sebes-al-astrei-in-documente-inedite-1870-1900.jpg)







![[Leavenworth, KS] Daily Times, June 12, 1860-October 8, 1861](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631c4e39b8a98572c10cd7d2/leavenworth-ks-daily-times-june-12-1860-october-8-1861.jpg)