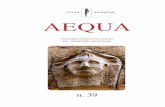“Colonizar é civilizar”: o cinema e a Exposição Colonial Internacional (Vincennes, 1931)
La casa a Cappadocia nel 1931, in Aequa, (IX) 31, ottobre 2007, pp. 27-30
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of La casa a Cappadocia nel 1931, in Aequa, (IX) 31, ottobre 2007, pp. 27-30
AEQUA
Rivista di studi e ricerche sul territorio degli Equi
Anno IX, n. 31, ottobre 2007
DirettoreGiuseppe Aldo ROSSI
Direttore responsabile
Fabrizio Lollobrigida
Condirettori
Artemio Tacchia, Luca Verzulli
Collaboratori
Gabriele Alessandri, Nicola Cariello, Pietro Carrozzoni,
Giuseppe Cicolini, Bernardino Ciocari, Alberto Crielesi,
Andrea Del Vescovo, Ivo Di Matteo, Alessandro Fiorillo,
Terenzio Flamini, Annita Garibaldi Jallet, Maria Teresa
Giovannoni, Giovambattista Grifoni, Aldo Innocenzi,
Sergio Maialetti, Vincenzo Marchionne, Zaccaria Mari,
Micaela Merlino, Giuseppe Panimolle, Antonio Proietti,
Carmine Proietti, Walter Pulcini, Gianfranco Ricci,
Claudio Rossi Massimi, Piero Sebastiani Del Grande,
Beatrice Sforza, Paola Elisabetta Simeoni, Maria
Sperandio, Boris Tacchia, Antonio Tantari.
Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 390/99 del 20/08/99
Costo copia € 5,00 Numeri arretrati € 8,00
Contributo editoriale: euro 20 da versare sul C.C.P. n.17250036
intestato a Associazione “Aequa”, via Valeria, 62 - 00020
Riofreddo (Rm).
Indirizzo web: www.aequa.orge-mail: [email protected] - [email protected]
Redazione: A. Tacchia, via D. Alighieri 11, 00027 Roviano (RM)
Segreteria: L. Verzulli, via del Colle 1, 00020 Riofreddo (RM)
Stampa: Tipografia Fabreschi in Subiaco.
La collaborazione alla rivista è assolutamente volontaria e gratuita. Gli
articoli e le foto ricevute, anche se non pubblicati, non vengono restitui-
ti. Di quanto scritto sono direttamente responsabili i singoli autori.
AEQUA
Associazione Culturale
Sede: c/o G. Roberti, Via Valeria 62, 00020 Riofreddo (Rm)
Segreteria romana: c/o G. A. Rossi, Via degli Scolopi 19,
00136 Roma.
Quote associative annuali: soci ordinari euro 30, soci sostenitori
euro 50, da versare sul C.C.P. n. 17250036 intestato
all’Associazione “AEQUA”, via Valeria 62, Riofreddo (Rm).
Codice Fiscale: 94029830588 - Partita IVA: 05908741001
In copertina:
Una coppa di granturco nella
mola di Vivaro Romano
(1991)
SOMMARIO
Artemio Tacchia
I Catasti o le Assegne della metà
del XVII secolo a Roviano pag. 3
Nicola Cariello
Il culto di Santa Anatolia nel Cicolano pag. 12
Beatrice Sforza
Il tormentato Monte Frumentario
di Vivaro Romano pag. 16
Antonio Tantari
Le reliquie di Santa Felicita ad Affile pag. 20
Giuseppe Cicolini
Le piogge a Subiaco e nella valle dell’Aniene pag. 24
Alessandro Fiorillo
La casa a Cappadocia nel 1931 pag. 27
Gianfranco Ricci
I martiri della strage del 1944 a Capistrello pag. 31
Stefano Rinaldi
Il palio di Castel Madama,
un “fatto sociale globale” pag. 36
Andrea Del Vescovo
Gli imperatori di Roma venuti dalla Sabina pag. 38
Marina Cimato
Il restauro della chiesa di San Nicola
a Riofreddo pag. 40
Vincenzo Marchionne
Una ipotesi sull’origine del nome
Scotonico a Roviano pag. 45
Fabio Pillonca
I danni dell’alluvione del 1813
a Paganico e Collalto pag. 47
Referenze fotografiche:
A. Tacchia, copertina, pp. 3, 6, 10, 17, 34; M. Cimato, pp.
41, 42, 43; N. Cariello, pp. 13, 14; A. Tantari, p. 20; G.
Ricci, pp. 31, 33; Archivio Aequa; Associazione Culturale
Nuovo Mondo; Associazione Rione Castelluccio.
2
LA CASA A CAPPADOCIA NEL 1931
di Alessandro Fiorillo
Dopo la pubblicazione della Storia di Cappadocia, Petrella, Verrecchie (1), risultato di
una ricerca storica sui tre paesi della Valle di Nerfa (Marsica) dal periodo che precedette
la loro comparsa alla prima metà del Novecento, sto ora portando avanti una serie di
studi incentrati su alcuni aspetti della vita sociale del paese di Cappadocia (Aq) negli
anni compresi tra i primi del Novecento e la fine degli anni Quaranta.
Tale ricerca vuole approfondire alcune realtà del vissuto sociale delle genti di questo
paese, simile nella sostanza alla realtà delle genti dei tanti paesi e località limitrofe, sia
della Marsica che della vicina Valle dell’Aniene, caratterizzata da attività economiche
per lo più incentrate sull’agricoltura e la pastorizia, e nello specifico di Cappadocia (e
della vicina Petrella Liri) da una intensa attività legata al mestiere di mulattiere, che
portava le genti locali a frequenti e lunghi periodi vissuti al di fuori dei rispettivi paesi,
fuori dalle loro case (2).
La casa
Questo primo articolo vuole focalizzare l’attenzione su quella che, allora come oggi,
rappresentava il bene per antonomasia, e che garantiva prima di ogni altro la sopravvi-
venza, il riparo primario e il luogo della vita e del focolare domestico: la casa.
In quegli anni il paese di Cappadocia non era ancora esteso come oggi (sebbene molto
più abitato!), o meglio stava appena cominciando a colonizzare la zona dell’odierno
“piazzale” (3), con le prime abitazioni private costruite dai mastri muratori locali, e con
la nuova Chiesa di Santa Margherita, che proprio in quegli anni veniva ricostruita nel
nuovo sito, rispetto all’antica chiesa che si trovava in
località Vallefredda (4), irrimediabilmente danneggia-
ta dal terremoto del gennaio 1915 (5).
La vita nel paese trascorreva tranquilla e laboriosa,
rispettando quei ritmi segnati fin dai tempi più remo-
ti, una vita che nel corso dell’anno, come abbiamo
accennato, vedeva diverse famiglie passare la mag-
gior parte del tempo fuori dal paese, dalla propria
casa, nei posti dove c’era il lavoro, quel lavoro garan-
tito soprattutto dal possesso dei muli, il principale
“mezzo” di trasporto di quegli anni, soprattutto laddo-
ve c’era bisogno di disboscare e trasportare il legna-
me, il carbone e le merci in genere.
Molto spesso capitava, specialmente lungo il freddo
periodo invernale, che in paese restavano soprattutto
donne, anziani e bambini. La casa era, soprattutto
d’inverno, il “riparo” all’interno del quale trascorre-
27
Casa tipica di Cappadocia
28
vano, lente e spesso monotone, le giornate. Scrive Vincenzo Massotti, riferendosi alle
case (6):
“ (…) si trattava di case costruite con i sassi, con quella pietra che le montagne circo-
stanti hanno sempre fornito. Sicuramente erano case assai grandi, fino ai primi di que-
sto secolo, infatti la gente di Cappadocia ha trascorso la propria esistenza in un grande
stanzone, posto al piano superiore di una modesta abitazione, poiché il piano inferiore
veniva adibito a stalla, a pollaio e cantina. In quella sala si mangiava, si dormiva, lì le
donne si radunavano per trascorrere le lunghe giornate invernali, quando il freddo e la
neve non permettevano di uscire. Per secoli in quelle case si sono consumate storie di
miseria, ma anche piacevoli intrattenimenti. Non c’è da stupirsi del fatto che tanta
gente anche pastori e contadini, conoscessero i grandi poemi del Rinascimento:
“l’Orlando furioso”, “La Gerusalemme liberata”, “La canzone d’Orlando”, o tutti i
racconti biblici. Intorno al fuoco, infatti, la sera quando si poteva godere un po’ di ripo-
so, si radunava l’intera famiglia allora assai numerosa, e il capo famiglia, o chi per lui,
leggeva questi racconti. Quella era la televisione di allora, e i bambini chissà quali
mondi immaginavano sentendo quelle storie (…)”.
I temi di “Francesco Lilli”
Ma niente meglio di una testimonianza diretta di quegli anni riesce ad esprimere il
significato più intenso in riferimento a ciò che la casa rappresentava allora, soprattutto
se a raccontarlo in un tema dal titolo “Le lunghe serate d’inverno” è un bambino:
“Il possedere una casa è una bellissima proprietà e misero potrà dirsi colui che è privo
anche di un piccolo tugurio. La casa è il luogo più utile e più atto per il genere umano,
perché la maggior parte della vita si svolge principalmente dentro di essa. O come si
sta bene dentro la casa nella rigida e brutta stagione d’inverno! Che lunghi giorni e che
belle serate si trascorrono dentro di essa. Quando il cielo è di colore nerognolo, venti
settentrionali si innalzano impetuosi nell’immensità dell’aria, la neve densa cade a lar-
ghe tese, tutta la gente sta rinchiusa nelle sue abitazioni a godere la bella pace delle
loro famiglie. Si raccontano fiabe, si cantano stornelli, canzoni, poesie, si balla, si lavo-
rano cose famigliari. Ma guastano queste
belle felicità tristi pensieri, i quali alcune
volte eccitano anche il pianto. Ma anche
dentro le abitazioni il gran freddo inverna-
le si fa sentire, poiché nelle porte e nelle
fessure delle finestre il freddo e il vento
inevitabili entrano impetuosamente. Come
soffrono i nullatenenti in questa stagione,
molto nemica per loro! Saranno stretta-
mente spinti a girare il mondo in cerca di
cibo e di ricovero in tutti i tempi, sia buoni
che cattivi. Anelano quindi di possedere al
minimo una piccola e brutta abitazione, e
un poco di cibo per il sostentamento neces- Gruppo di Cappadociani
29
sario. Ecco quei pensieri che turbano le belle e lunghe serate d’inverno.
Cappadocia, 20-8-1931, Lilli”.
A Cappadocia, molto spesso nel corso dell’anno, i capi famiglia si trovavano fuori paese
impegnati nei vari lavori e attività che consentivano di sostenere economicamente la
famiglia. A volte si tornava però in occasione delle festività, come ci testimonia in un
altro delizioso tema, “Il ceppo di Natale”, sempre lo stesso bambino:
“Non ho provato più mai una grande gioia come la provai l’anno scorso. Erano già tra-
scorsi tre anni che mio padre si era allontanato dalla sua famiglia per andare a lavora-
re in altri paesi affinché mantenesse onestamente i suoi figliuoli. Quindi avvicinandosi
la grande, solennità del S. Natale, colse l’occasione di ritornare verso il sospirato tetto.
Noi tutti di famiglia aspettavamo con ansia il desiato giorno in cui doveva ritornare il
nostro genitore. Finalmente venne il giorno tanto bramato, e ritornò il nostro padre.
Oh! come mi palpitò il cuore per l’allegria quando lo vidi! Lui piangeva per tenerezza e
io ridevo per gioia. Quindi la nostra madre preparata nel giorno della vigilia di Natale
una grande cena, tutti quanti noi ci sedemmo a tavola, riccamente apparecchiata.
Finito di mangiare e passati i dolci natalizi, ci sedemmo attorno al focolare che manda-
va un caldo eccessivo. Ma essendosi quasi consumato, mia madre uscì fuori per prende-
re un gran ceppo e fare il fuoco. Fattosi un gran fuoco, io e le mie sorelle ci mettemmo
attorno a nostro padre affinché ci raccontasse qualche fatto o qualche novella. Allora
vinto dalle nostre preghiere incominciò a raccontare delle avventure che erano avvenu-
te proprio a lui là in quei paesi di barbari e rozzi e delle tavolette piacevoli e ridicole.
Oh! come era contento vedendo tutti i suoi figliuoli stretti intorno a sé! Oh! come sop-
portava a malapena il pianto! Ed esclamava! Ah! che gioia proverebbe se potesse vive-
re sempre nella mia casa insieme colla mia famiglia! Essendo già trascorso molto
tempo in divertimento e in risi, lasciammo i giuochi e andammo a riposare.
Cappadocia 26-1-1931, Francesco Lilli” (7).
La casa, allora come oggi, era il luogo che riuniva all’interno dello stesso spazio tutti i
componenti della famiglia, ed era spesso in occasioni come quelle narrate nei temi, le
Cappadocia, la piazza con la scuola, (1935 circa)
30
festività o il ritorno a casa dei capi famiglia, che al suo interno si vivevano momenti di
generale allegria, dinanzi al camino, scaldati dal fuoco e dal calore delle relazioni fami-
gliari. I temi scritti dal bambino di Cappadocia, F. Lilli, nel lontano 1931, esprimono in
maniera esemplare questo rapporto indissolubile tra le genti del paese e le loro case,
spesso piccole, scomode, fredde, inadeguate, ma pur sempre la “ricchezza” maggiore
d’ogni nucleo famigliare.❖
__________
1- A questa mia opera, pubblicata nel 2005 con il patrocinio del Comune di Cappadocia, hanno collaborato
con le loro ricerche la dott.ssa Micaela Merlino e i ricercatori locali dott. Bruno Tocci, Mario Cosciotti,
Gerardo Rosci, Margherita Addari.
2- Con notevole arricchimento di esperienze date dal contatto con una realtà più vasta e più variegata rispet-
to al microcosmo rappresentato dal paese. I mulattieri di Cappadocia e Petrella Liri hanno lavorato molto
in Toscana, in Emilia Romagna, nel Lazio e anche in altre regioni italiane, e in molti casi hanno finito per
stabilirsi nelle medesime. Ad esempio, a tutt’oggi c’è un nucleo piuttosto numeroso di cappadociani resi-
denti in Toscana, ma ancora molto legato al paese d’origine; infatti nel corso dell’estate non è infrequente
sentire il dialetto toscano per le vie del paese di Cappadocia, quando i “cappadociani” della Toscana torna-
no in paese. Ad ogni modo non erano soltanto i mulattiere ad “emigrare” dal paese, soprattutto l’inverno.
Scrive MARGHERITA ADDARI in Storia di Cappadocia, Petrella, Verrecchie di A. Fiorillo, Roma 2005, pp.
130-131: “Negli anni che seguirono la fine della seconda guerra mondiale ci fu un po’ di lavoro in più
anche in inverno perché si dovevano ristrutturare molte costruzioni. Così un anno molti degli artisti murato-
ri partirono per un paesino che si trovava a circa 15 chilometri da Nettuno, Torre del Padiglione, dove c’e-
rano da rimettere a posto alcuni casali. Per primi partivano gli uomini (i nonni, i padri e i figli) e una volta
che si erano sistemati, arrangiandosi come potevano in piccole case in affitto, nei casali abbandonati, nelle
capanne, li raggiungevano anche le mogli, ma senza i figli più piccoli che restavano al paese e continuava-
no ad andare a scuola. In inverno si lavorava molto nella zona che va da Ladispoli a Civitavecchia. Molti
dei muratori poi, invece di lavorare alla ristrutturazione degli immobili, andavano tra le rovine in cerca di
proiettili inesplosi o casse di bombe a mano abbandonate che poi rivendevano, guadagnando più di quanto
avrebbero guadagnato lavorando un giorno da muratori. Comunque se a causa di qualche lavoro, gli artisti
lasciavano Cappadocia, ma questo succedeva di rado, tornavano a casa prima degli altri, sempre e comun-
que per Pasqua”.
3- M. ADDARI, op. cit., p. 126: “Tornando alla nostra storia, i figli di Mastrangelo, temendo di perdere tutto
(…), decisero di investire immediatamente i risparmi prima che fosse troppo tardi e costruirono a
Cappadocia in un luogo che, oggi è il Piazzale, ma all’epoca era improponibile per la costruzione di un
palazzo, perché c’era un immondezzaio. Nessuno credeva che i miei avi riuscissero ad erigere un palazzo lì
e invece nel 1929 portarono a termine l’opera.”
4- Il primo nucleo abitativo del paese, il più antico. Vedi V. MASSOTTI, Historia Cappadociae, Tagliacozzo
1996, Ente Provinciale Turismo L’Aquila – Associazione Pro-Cappadocia. p. 14: “(…) Febonio Marso
nomina solo la chiesa di S. Biagio, come sede parrocchiale. Da ciò si desume che gli antichi consideravano
il borgo di Vallefredda come parrocchia a sé, intitolata a S. Margherita. Tale distacco tra i due luoghi abitati
si riscontra anche in un interessante fatto: gli uomini del piccolo borgo erano soliti alla domenica riunirsi a
gruppetti nelle piazze del paese, separati da coloro che vivevano nella parrocchia di S. Biagio. Inoltre esi-
steva un detto, vanto degli abitanti di Vallefredda, che diceva: “Se vuoi veder la gioventù fiorita vieni a
Vallefredda a S. Margherita”.
5- Quasi contemporaneamente veniva costruito anche il Palazzo del Municipio.
6- V. MASSOTTI, op. cit., pp. 4-5.
7- I temi sono stati scritti da un bambino, Francesco Lilli, della scuola elementare di Cappadocia. Li ho
ritrovati tra le carte e i documenti conservati da don Giovanni Ferrazza, parroco di Cappadocia durante i
primi 50 anni del Novecento.