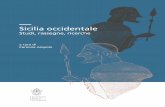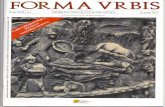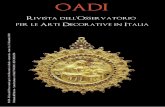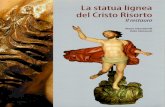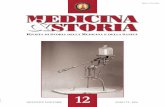Il restauro della Rocca Albornoziana di Costantino Dardi a Spoleto
Il restauro del disegno Sul fienile di Giuseppe Pellizza da Volpedo
-
Upload
opificiodellepietredure -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Il restauro del disegno Sul fienile di Giuseppe Pellizza da Volpedo
Rivista dell’Opificio delle Pietre Duree Laboratori di Restauro di Firenze
Centro Di
R E S T A U R O 21 2009
SoprintendenteIsabella Lapi Ballerini
DirezioneMarco Ciatti, Giancarlo Lanterna,Patrizia Riitano
Comitato di redazioneAlfredo Aldrovandi, Fabio Bertelli,Marco Ciatti, Cecilia Frosinini,Alessandra Griffo, Clarice Innocenti,Giancarlo Lanterna, Isabella Lapi, MariaDonata Mazzoni, Anna Mieli, LetiziaMontalbano, Daniela Pinna, SimonePorcinai, Patrizia Riitano, Chiara RossiScarzanella, Laura Speranza, Isetta Tosini,Maria Alberta Zuffanelli
Direttore responsabileCristina Acidini Luchinat
RedazioneFabio Bertellicon la collaborazione di Alice Turchetti
Archivio restauriPerla Roselli, Rebecca Giulietti, GiulianaInnocenti
Gabinetto fotograficoMarco Brancatelli, Fabrizio Cinotti, SergioCipriani
Hanno inoltre prestato la loro operaLoriana Campestrelli, Stefania Mariotti,Angela Verdiani
Direzione e Redazione Opificio delle Pietre Dure Via Alfani 78, 50121 Firenze Tel. 0552651347 Fax 055287123
www. opificiodellepietredure.itopd.promozioneculturale@beniculturali.it
Autorizzazione del Tribunale di Firenzen. 3914 del 16.12.1989Iscrizione al Registro Operatori di Comunicazione n. 7257
Associato all’Unione StampaPeriodica Italiana
OPD RestauroRivista dell’Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro di Firenze21 2009
Hanno collaborato a questo numero
Opificio delle Pietre DureAndreina Andreoni, Fabrizio Bandini,Roberto Bellucci, Giancarlo Buzzanca,Ezio Buzzegoli, Simona Calza, CiroCastelli, Isidoro Castello, MariateresaCianfanelli, Marco Ciatti, SusannaConti, Alberto Felici, Cecilia Frosinini,Monica Galeotti, Alessandra Griffo, CarloLalli, Mariarosa Lanfranchi, Isabella LapiBallerini, Paola Ilaria Mariotti, MariaDonata Mazzoni, Letizia Montalbano,Rosanna Moradei, Mauro Parri, AlessandraRamat, Perla Roselli, Andrea Santacesaria,Oriana Sartiani, Luciano Sostegni, LauraSperanza, Peter Stiberc, Isetta Tosini
Collaboratori esterni
Accademia di Belle Arti di BreraFrancesca Valli
Agenzia nazionale per le nuovetecnologie, l’energia e lo svilupposostenibile, ENEA, RomaDonatella Biagi Maino, Giuseppe Maino,Pietro Moioli, Claudio Seccaroni,Agostino Tartari
Archivio di Stato di SienaRaffaella De Grammatica, Carla Zarrilli
Comune di Ascoli PicenoConservatore delle raccolte comunali Stefano Papetti
Culturanuova srlMassimo Chimenti
Istituto Nazionale di Ottica ApplicataINO-CNR, FirenzeClaudia Daffara, Raffaella Fontana, MariaChiara Gambino, Enrico Pampaloni
Pinacoteca Comunale, FaenzaClaudio Casadio
Società di San Giovanni Battista, FirenzeAnita Valentini
Soprintendenza per i Beni Storici,Artistici ed Etnoantropologici di Milano -Pinacoteca di BreraEmanuela Daffra
Soprintendenza per i Beni Storici,Artistici ed Etnoantropologici di Siena e GrossetoLaura Martini
Soprintendenza per i Beni Storici,Artistici ed Etnoantropologici per leProvince di Modena e Reggio EmiliaMario Scalini
Soprintendenza per i Beni e le Attivitàculturali della Regione autonoma dellaVal d’Aosta - Laboratorio di analisiscientifiche
Copyright 1989 Centro Didella Edifimi srl, FirenzeOpificio delle Pietre Dure, Firenze
Stampa Alpi Lito, Firenze marzo 2010
Pubblicazione annuale con supplementoin lingua ingleseISSN 1120-2513
Prezzo di copertina € 110,00Abbonamenti€ 80,00 (Italia) € 100,00 (estero)Distribuzione e abbonamentiCentro DiLungarno Serristori 35, 50125 Firenzetel. 055 2342666 / fax 055 [email protected]
Lorenzo Appolonia, Nicole Seris, Dario Vaudan
Soprintendenza per il PatrimonioStorico, Artistico ed Etnoantropologicoper le province di Bologna, Ferrara, Forlì,Cesena, Ravenna e RiminiAnna Colombi Ferretti
Soprintendenza Speciale per il PatrimonioStorico, Artistico ed Etnoantropologico eper il Polo Museale della città di Firenze -Galleria d’Arte ModernaAnnamaria Giusti
The Edelstein Center for the Analysis of Ancient ArtifactsDepartment of Chemical Engineering -Shenkar College of Engineering andDesign - Ramat-Gan, IsraelZvi C. KorenE-mail: [email protected]
Università degli Studi della TusciaFacoltà di Conservazione dei Beni CulturaliSimona Rinaldi
Università degli Studi di FirenzeFacoltà di Medicina e Chirurgia - Dipartimento di Patologia Umana eOncologiaGabriella Nesi, Raffaella Santi
Annette Keller, Grafica digitale
Federica Innocenti, Diagnosta per i BeniCulturali
Ilaria Ciseri, Alessandra Malquori,Nicoletta Matteuzzi, Storiche dell’arte
Francesca Bettini, Lorenzo Conti, MariaGrazia Cordua, Chiara Gabbriellini,Antonio Iaccarino Idelson, Lisa Lombardi,Sara Micheli, Chiara Mignani, DanieleRossi, Francesca Rossi, Carlo Serino,Valentina Paola Tonini, Restauratori
Un diario lungo un annoIsabella Lapi Ballerini
Il restauro del Polittico di Palma il Vecchio di PegheraCiro Castelli, Mariateresa Cianfanelli, Marco Ciatti, Emanuela Daffra,Federica Innocenti, Carlo Lalli, Giancarlo Lanterna, Pietro Moioli, Mauro Parri,Alessandra Ramat, Andrea Santacesaria, Claudio Seccaroni
La collezione di cere del Museo di Anatomia Patologica di Firenze.Note sulle vicende storiche, sulla tecnica esecutiva e sui restauriChiara Gabbriellini, Gabriella Nesi, Francesca Rossi, Raffaella Santi, Laura Speranza
Mirabili orrori. Cere inedite di Gaetano Zumbo dopo il restauroMaria Grazia Cordua, Giancarlo Lanterna, Lisa Lombardi, Rosanna Moradei,Mario Scalini, Laura Speranza
La necessità delle analisi micro-distruttive nello studio dei coloranti organiciSusanna Conti, Zvi C. Koren, Isetta Tosini
La ‘Sacra Famiglia’ della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, una recenteattribuzione a Giulio Romano Roberto Bellucci, Cecilia Frosinini, Stefano Papetti
Il metodo di lavoro di Francesco Hayez: Sansone e il leone, dagli schizzi, dagli studi, al cartone e al dipintoSimona Calza, Cecilia Frosinini, Francesca Valli
Ancora un restauro “impossibile”: la Madonna del Rosario del SodomaMarco Ciatti, Lorenzo Conti, Susanna Conti, Antonio Iaccarino Idelson, Laura Martini, Daniele Rossi, Carlo Serino, Luciano Sostegni
La Scuola d’Alta Formazione dell’Opificio delle Pietre Dure. Passato e futuro a confrontoLetizia Montalbano
Il restauro dei soffitti delle tre Sale dei Pianeti in Palazzo Pitti a FirenzeFabrizio Bandini, Alberto Felici, Mariarosa Lanfranchi, Paola Ilaria Mariotti
Il restauro della Madonna del Parto della pieve di MontefiesoleCiro Castelli, Marco Ciatti, Chiara Mignani, Mauro Parri, Andrea Santacesaria, Oriana Sartiani, Luciano Sostegni
‘Tensionamento controllato’: un contributo per risolvere la contrazione dei dipinti (senza stressarsi troppo)Francesca Ciani Passeri, Chiara Rossi Scarzanella, Valentina Paola Tonini
Si restaurano i byte? Dal restauro virtuale al restauro del virtuale ovvero dagli “smanettoni” all’applicazione della critica del restauro nella conservazione del digitale (seconda parte)Giancarlo Buzzanca
La documentazione informatica nel restauro: la cartografia tematica nel casoapplicativo della cappella maggiore della basilica di Santa Croce a FirenzeMassimo Chimenti, Mariarosa Lanfranchi, Paola Ilaria Mariotti
Editoriale
Contributi
Note di restauro
7
13
51
71
88
97
109
123
139
145
161
177
183
193
Sommario
Un contributo allo studio della tecnica esecutiva delle pitture murali della cappella di San Giorgio nel Priorato di Sant’Orso ad AostaLorenzo Appolonia, Ezio Buzzegoli, Alberto Felici, Annette Keller, Mariarosa Lanfranchi, Nicole Seris, Dario Vaudan
Indagini sulla Madonna del CardellinoMarco Ciatti, Donatella Biagi Maino, Claudia Daffara, Raffaella Fontana, Maria Chiara Gambino, Giuseppe Maino, Enrico Pampaloni, Agostino Tartari
Il restauro della miniatura del Caleffo dell’Assunta dell’Archivio di Stato di SienaRaffaella De Grammatica, Letizia Montalbano, Carla Zarrilli
Il crocifisso di Giovanni Pisano del Museo dell’Opera del Duomo di SienaLaura Speranza, Peter Stiberc
Il restauro del disegno Sul fienile di Giuseppe Pellizza da VolpedoMelissa Gianferrari, Sara Micheli, Letizia Montalbano
Il restauro della Madonna col Bambino, attribuita a Cimabue, del Museo Santa Verdiana di CastelfiorentinoFrancesca Bettini, Ciro Castelli, Ilaria Ciseri
I Due carabinieri (la ronda) di Antonio Berti. Il restauro di un bozzetto in terra crudaAndreina Andreoni, Laura Speranza
Il San Giovannino della Pinacoteca Comunale di Faenza: storia, ipotesi attributive, restauroClaudio Casadio, Isidoro Castello, Anna Colombi Ferretti, Alessandra Griffo, Anita Valentini
Le tecniche di realizzazione degli occhi di vetro nel XVIII secolo. Considerazionisulla tecnica costruttiva e decorativa di sculture lignee napoletane tra Sei eSettecentoMaria Donata Mazzoni
La tempera dei Primitivi nella pittura americana degli anni 1930-1950Marco Ciatti, Simona Rinaldi
Paradisi a confronto: la Porta del Paradiso degli orafi AccarisiAlessandra Malquori
Restauri eseguiti dal II semestre 2008 al I semestre 2009a cura di Rebecca Giulietti e Perla Roselli
Un questionario di gradimento del museo dell’Opificio delle Pietre Dure a FirenzeNicoletta Matteuzzi
Il restauro della pala di San Zeno di Andrea MantegnaMarco Ciatti
Aggiornamento sul cantiere di restauro di Agnolo Gaddi in Santa CroceMariarosa Lanfranchi
Presentazione del volume Scientific Examination for the Investigation of PaintingsMonica Galeotti
Schede di restauro
Tecniche artistiche
Archivio storico
Attività dell’Opificio2008-2009
Notiziario
213
225
239
245
253
259
270
279
288
301
311
332
341
344
350
351
Schede di restauro
253
Il restauro del disegno Sul fienile di Giuseppe Pellizza da Volpedo
Melissa Gianferrari, Sara Micheli, Letizia Montalbano
re gran parte del modo di operare del pittore nellaprogettazione dell’omonimo dipinto, è stato possibilepresentare al pubblico un disegno di grande impor-tanza, poco noto anche agli studiosi. Sono molti gli aspetti che rendono quest’opera inte-ressante: la tipologia grafica, il formato e soprattuttola tecnica, che descrive un modo di lavorare in studio,tipico per alcuni versi dei pittori ottocenteschi, manello stesso tempo ancora poco analizzato. L’intervento su questo disegno è stato anche il prete-sto per riprendere lo studio sulle carte trasparenti del-la fine del XIX secolo, iniziata qualche anno fa con latesi di Melissa Gianferrari su alcuni disegni di Fran-cesco Hayez, facenti parte del corpus grafico del pitto-re, di proprietà dell’Accademia di Brera, di cui da po-co è stato completato il restauro.3
Il disegno,4 inizialmente denominato Carità cristiana,risulta sommariamente eseguito: i tratti sono lineari,semplici e lasciano immaginare solo a grandi lineel’atmosfera di luci e ombre che caratterizzano inveceil dipinto. Il fienile in primissimo piano è il luogo do-
Inchiostro nero su carta trasparente (GR 12015)Dimensioni: altezza 1094 mm; lunghezza 2483 mmAutore: Giuseppe Pellizza da Volpedo (Volpedo 1868-1907)Volpedo, Studio Pellizza, Associazione Pellizza da VolpedoTempi di restauro: maggio 2007 – luglio 2009Direzione del restauro: Cecilia Frosinini, LetiziaMontalbanoRestauratori: Melissa Gianferrari, Sara Micheli
Il restauro del grande disegno su carta trasparente diGiovanni Pellizza da Volpedo completa una serie diinterventi eseguiti dal settore Restauro Disegni eStampe dell’Opificio su alcune opere grafiche del pit-tore, conservate nella sua casa studio di Volpedo, oramuseo e fondazione.1 Grazie alla collaborazione conAurora Scotti, che ha recentemente curato l’esposi-zione della grande velina relativa al dipinto Sul fieni-le 2 (fig. 1) e che con i suoi studi è riuscita a ricostrui-
1. Sul fienile, olio sutela (133x243,5 cm),1883, collezioneprivata.
254
Schede di restauro
ve si svolge la triste scena; qui viene raffigurata la mor-te di un contadino attorniato da alcune figure caritate-voli, fra le quali un prete che, accompagnato dai chie-richetti, giunge a somministrare il viatico (figg. 2-3). Inlontananza si scorge la casa del pittore, così come sipresenta ancora oggi. Il dipinto, eseguito fra il 1893 eil 1894, fu per Pellizza occasione di riflessione sul temadella morte, come testimoniano anche i numerosi di-segni e i bozzetti ad esso collegati.5 Quest’opera si inse-risce in una tipologia particolare di disegni: sono glistudi su carta lucida, spesso eseguiti in formato 1:1, tal-volta usati per la progettazione delle opere e dunquepreparatori al trasferimento su tela, altre volte impiega-ti come d’après da dipinti già eseguiti, testimonianzedestinate a vari usi, che non possiamo però definire car-toni nel senso più stretto del termine. Giuseppe Pelliz-za utilizzò la stessa tipologia di carte anche durante larealizzazione del celebre dipinto Il Quarto Stato 6 di cuiuno studio per alcune figure in primo piano, prove-niente dalla stessa collezione, è appena giunto all’Opi-ficio per il restauro. Purtroppo, non essendo stato pos-sibile esaminare il dipinto Sul Fenile – di proprietà pri-vata – restano delle incognite sull’effettivo scopo del re-lativo studio su carta trasparente, che ipotizziamo, aquesto punto della ricerca, essere un calco eseguito du-rante una fase intermedia di realizzazione dell’opera.[Letizia Montalbano]
Lo stato di conservazione
Lo stato di conservazione del disegno si mostrava par-ticolarmente problematico: il grande foglio, conserva-to in uno stretto rotolo, appariva tanto fragile e de-formato da risultare quasi impossibile da maneggiaree distendere (fig. 4). Il tipo di carta impiegata, l’usoche ne era stato fatto nel tempo, la conservazione pro-lungata in ambienti non idonei e soprattutto l’arroto-lamento su un’anima cilindrica di diametro molto li-mitato, avevano creato un insieme di fattori di degra-do fra i più negativi. Così, se da un lato questo tipodi conservazione aveva in parte salvaguardato il ma-nufatto fino ad oggi, dall’altro – come accade spessoper i disegni – aveva però innescato altre tipologie didanni. È plausibile pensare che la scelta di arrotolare il foglioe conservarlo nello studio del pittore, all’interno diuna cassettiera, sia derivato proprio dalla necessità dilimitare l’aggravarsi di problematiche già esistenti,che ormai ne impedivano anche l’esposizione. Treprofondi strappi orizzontali lungo il lato destro dellacarta – dei quali il più esteso giungeva fin quasi allametà dell’opera – tre grandi lacune (angolo sinistrosuperiore e destro inferiore, margine destro al centro),piccole rotture lungo i bordi e numerose pieghe sec-che, rendevano infatti precario lo stato dell’intero fo-glio. La carta trasparente mostrava inoltre ingialli-
2. Studio di testa per Sul fienile. Carboncino e gesso su carta beige(333x380 mm), Milano, Civico Gabinetto dei Disegni presso il CastelloSforzesco.
3. Sul fienile, particolare con testa del contadino morente. Inchiostronero su carta trasparente (1094x2483 mm), Volpedo, Studio Pellizza.
255
Schede di restauro
menti più o meno disomogenei su tutta la superficie,particolarmente evidenti, soprattutto lungo i bordidegli strappi e delle lacune, a causa di un consistentedeposito di polvere. Diversamente dal lato sinistro, tagliato nettamente eperpendicolarmente agli adiacenti lati lunghi, il bor-do del margine destro risultava irregolare e tagliatomalamente, mentre alcuni piccoli fori negli angoli su-periori della carta indicavano l’uso di chiodi per fissareil disegno su un supporto permanente o provvisorio. In corrispondenza del margine sinistro del foglio èstata individuata la dicitura “a 9”, scritta a pastelloverde molto sbiadito, probabilmente appartenente alprimo inventario dei beni, eseguito immediatamentedopo la morte del pittore.7
Le indagini preliminariL’opera è stata sottoposta a una serie di indagini scien-tifiche, necessarie a ottenere informazioni sia sui ma-teriali costituenti che sulle cause di degrado.8
Analisi al SEM/EDS e FTIR (in ATR e in trasmissionesu pasticca di cloruro di sodio) sono state effettuate suun piccolo frammento, proveniente dal margineesterno dell’opera, per stimare la composizione elet-tronica, morfologica e la presenza dei gruppi funzio-nali della carta, così da comprenderne il tipo di ma-nifattura. L’analisi al SEM ha messo in evidenza un
forte segnale di zinco, la presenza di bario associato azolfo (solfato di bario) e tracce di silicio, alluminio,potassio e ferro che potrebbero essere correlabili a si-licoalluminati derivati dal deposito atmosferico, men-tre lo FTIR non ha evidenziato alcuna presenza di ma-teriali organici aggiunti alla cellulosa. Tali risultati la-sciano verosimilmente ipotizzare che la carta traspa-rente in esame sia stata fabbricata senza aggiunta dipatinanti o impregnati e che quindi debba essere clas-sificata come carta pergamena vegetale, generalmenteottenuta a macchina, per battitura leggera di pastachimica di legno e resa trasparente da brevi bagni agradazione calante di acido (acido solforico per cartesottili o cloruro di zinco per carte più spesse).Per misurare il pH della carta sono state eseguite al-cune misurazioni con cartine indicatrici9 applicate sutre zone diverse della superficie. La media dei valoririlevati ha indicato un pH 5,5-6, limite consideratoaccettabile per la conservazione di questo genere dicarte, molto delicate e difficili da trattare con le solu-zioni deacidificanti attualmente in uso.
L’intervento di restauro
Pulitura superficialeÈ ormai noto come oggi il restauro dei supporti car-tacei trasparenti si indirizzi sempre più verso la scelta
4. Sul fienile, inchiostro nero su carta trasparente. Stato di conservazioneprecedente al restauro.
256
Schede di restauro
di trattamenti a ridotto impiego di solventi a base ac-quosa, considerati, a ragion veduta, una delle causedell’insorgenza di deformazioni e dilatazioni dimen-sionali, a volte permanenti.In considerazione di ciò e del fatto che l’inchiostro abase di nerofumo, pur rivelatosi stabile ai test di solu-bilità10 si configura come un medium delicato e sen-sibile all’umidità, la pulitura superficiale dell’opera èstata condotta quasi interamente a secco, tramite pol-vere di gomma e matite in gomma morbida; soltantosul bordo inferiore dell’opera è stato eseguito un trat-tamento umido, a tampone, con una soluzione al50% di alcool etilico e acqua deionizzata, in modo daattenuare gli imbrunimenti e ridurre l’eccessiva rigi-dità della carta.
Recupero della planarità e delle dimensioni originali del foglio Il lungo mantenimento in rotolo del foglio trasparen-te aveva provocato nel tempo notevoli deformazionidella carta distribuite principalmente lungo le tregrandi fratture orizzontali. I margini degli strappi,non più combacianti tra loro e divergenti verso l’e-sterno, rendevano inoltre qualsiasi manipolazioneparticolarmente difficile e rischiosa e non permette-vano di procedere con un normale intervento di sal-datura dei lembi. Per ridurre tali deformazioni e iniziare a riconnetterele parti lacerate dell’opera, è stato necessario procede-re in due fasi successive, destinate a ridare gradualemorbidezza e planarità alla carta, in modo da recupe-rare successivamente le originali dimensioni e poter
intervenire sull’intero foglio. Durante la prima fased’intervento le zone compromesse sono state umidifi-cate impiegando grandi membrane in Goretex posi-zionate al di sotto delle parti da trattare: una voltaammorbidita la carta è stata effettuata una tempora-nea ricongiunzione dei lembi degli strappi con striscedi carta giapponese applicate dal verso (fig. 5). Inquesta fase, anche le rotture più piccole e le lacune pe-rimetrali sono state rinforzate temporaneamente invista dell’intervento successivo che ha consentito il re-stauro definitivo del foglio, nonché il recupero dellasua planarità.Nel caso dei supporti trasparenti, le tradizionali tec-niche di spianatura11 non appaiono idonee. Per farriacquistare alle carte deformate nuova planarità èquindi necessario apportare umidità in modo capilla-re, tramite l’impiego di membrane in Goretex, a cui
5. Fermaturatemporanea deglistrappi tramitestrisce di velinagiapponeseapplicate sul versodell’opera.
6. Sistema di umidificazione dell’opera tramite l’impiego di hard-softsandwich.
257
Schede di restauro
segue un leggero tensionamento perimetrale dei mar-gini dei fogli. Considerate le grandi dimensioni della carta in anali-si, è stato necessario provvedere a un’umidificazione esuccessiva spianatura “a mosaico”, procedendo cioèper zone adiacenti, in modo da rendere più controlla-bile l’operazione e limitare l’immissione di umidità.La carta è quindi stata posta, con il verso a vista, di-rettamente sopra un piano indeformabile e la parte datrattare è stata coperta con una membrana in Gore-tex, a sua volta foderata da un velo di Melinex®. Sul-l’intera struttura sono stati adagiati strati di feltrimorbidi, cartoni e pesi leggeri che hanno assicuratoun contatto omogeneo tra la carta e la membrana (fig.6). Una volta rimosso il sandwich – dal momento chei fogli trasparenti iniziano a perdere rapidamente l’u-midità in eccesso – è stato necessario eseguirne subi-to il tensionamento. Tale procedura ha previsto l’im-piego di pesi posizionati in modo da tenere in trazio-ne solo i bordi, mentre la zona centrale umida è ri-masta libera di muoversi e asciugarsi naturalmente(fig. 7). Questo stato di blando tensionamento è sta-to mantenuto per qualche giorno in modo da stabi-lizzare le fibre di cellulosa, eliminando quasi comple-tamente le pieghe secche e le vecchie deformazioni.
Mending e risarcimento delle lacune con velina giapponese montata a SAl termine del tensionamento il sistema di fermatura,utilizzato temporaneamente per saldare gli strappi, èstato rimosso per essere sostituito con un metodo piùidoneo. Lo strato di carta giapponese e adesivo posti
solo sul verso, possono infatti appesantire e irrigidirele zone trattate, provocando sul recto un lieve affossa-mento dei lembi ricongiunti, e comportare la perditadi trasparenza del supporto, così che spesso il risultatofinale risulta piuttosto antiestetico e invasivo.Per tale motivo, gli strappi sono stati uniti con striscedi carta giapponese più sottile, poste non completa-mente sul verso, bensì a S lungo i margini. Con que-sto metodo, la velina giapponese viene incollata sfal-sata tra i due bordi dello strappo, per poi essere assot-tigliata con speciali lame piatte fino a lasciare piccolee corte barbe che la ancorano lungo la linea di frattu-ra. Come per gli strappi, anche per le mancanze si è
7. Spianatura etensionamento dell’operaper zone.
8. Saldatura degli strappi e chiusura delle lacune. Velina giapponeseposizionata a S tra i margini delle fratture e degli inserti.
Schede di restauro
deciso di intervenire con lo stesso sistema. È stata co-sì scelta una velina giapponese a texture compatta, ilcui recto mostra caratteristiche di lucentezza simili aquelle possedute dalla carta dell’opera. Ogni inserto,tinto con pigmenti acrilici diluiti in acqua, in mododa ottenere la medesima tonalità della carta, è quindistato incollato in due strati sagomati sulla forma del-le lacune e ancorato lungo i margini delle mancanze,mediante la medesima tecnica a S, già utilizzata nelmending (fig. 8).
Montaggio finale dell’operaPer il montaggio permanente dell’opera è stato sceltoil sistema dei “falsi margini”, tradizionalmente consi-derato idoneo in tutti quei casi in cui si necessita diuniformità di tensione, e di un blando tiraggio in gra-do di evitare deformazioni e, nei casi peggiori, rottu-re superficiali. I falsi margini di carta giapponese, lar-ghi circa 10 cm, sono stati incollati dal verso lungo ibordi dell’opera per poi essere fermati su di un pan-nello in cartone alveolare Canson, scelto come sup-porto definitivo (fig. 9). Per proteggere l’opera e crea-re un’ intercapedine d’aria tra il recto e il plexiglassdella cornice, è stato infine introdotto un passe-par-tout in cartone Durevole per la conservazione, fode-rato con carta giapponese color avorio.
1) L’Associazione “Pellizza da Volpedo” nasce nel 1994 grazie a ungruppo di volontari, coordinati da Ida Bassi e Igino Imelio, chequotidianamente si impegna a garantire l’apertura al pubblicodello Studio Pellizza, in via Rosano, e del Museo didattico, inpiazza Quarto Stato. Per le opere restaurate dall’OPD vedi: A.Cagnini, N. Cavalca, M. Galeotti, M. L. Nussio, La Spannoc-chiatura di Pellizza da Volpedo. La tavolozza dei Divisionisti,‘OPD Restauro’, 18, Firenze 2006, pp.177-184.2) Vedi in proposito, I migranti di Pellizza, catalogo della mostra,a cura di A. Scotti Tosini, Volpedo, 29 agosto-18 ottobre 2009.3) Cfr. M. Gianferrari, Nascita ed evoluzione di un supporto origi-nale. La carta trasparente, ‘OPD Restauro’, 15, Firenze 2003, pp.245-254.4) Opera catalogata presso lo Studio Pellizza come: Studio prepa-ratorio per il dipinto su tela “Sul Fienile”.5) Cfr.: A. Scotti, Pellizza da Volpedo. Catalogo generale, Milano1986, pp. 24-26; schede nn. 772-799, pp. 304-316. 6) Il Quarto Stato, olio su tela, 1901 (293x545 cm), Milano, Gal-leria d’Arte Moderna.7) Tale numerazione viene ripetuta tre volte lungo la fascia late-rale sinistra: sul verso, nella zona superiore; sul recto, nelle zonecentrale e inferiore del foglio.8) Le analisi scientifiche sono state effettuate da M. Rizzi, A. Ca-gnini e M. Galeotti del Laboratorio Scientifico dell’Opificio del-le Pietre Dure.9) Cartine indicatrici Macherey-Nagel, intervallo 0,5-5,5.10) I test sono stati condotti con acqua deionizzata, alcool etilicoe miscele a varie concentrazioni degli stessi.11) In genere le opere grafiche, laddove non presentino tecnichea corpo, vengono spianate sotto peso, fra cartoni o feltri morbidi,dopo avere apportato l’umidità necessaria all’ammorbidimentodelle fibre di cellulosa. Tale procedura, mediante l’asciugatura sot-to peso, consente di restituire planarità al foglio trattato.
9. L’opera a restauro ultimato. Montaggio su pannello in cartonealveolare tramite “falsi margini” in carta giapponese.
258