Il δέχεσϑαι τὰ σκόλια in Aristoph. Vesp. 1208-1250, SemRom 2, 1999, 243-262
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Il δέχεσϑαι τὰ σκόλια in Aristoph. Vesp. 1208-1250, SemRom 2, 1999, 243-262
© Roma 2000, Edizioni Quasar di Severino Tognon srl, via Ajaccio 43,I-00198 Roma, tel. 0684241993, fax 0685833591, email: [email protected]
ISSN 1129-5953
Registrazione Tribunale di Roma n. 146/2000 del 24 marzo 2000
copia autore
GIULIO COLESANTI
Il devcesqai ta; skovlia in Aristoph. Vesp. 1208-1250
* Desidero ringraziare Emanuele Dettori per l’interessante discussione che ho avuto con luisu vari punti di questo lavoro.
1 La scena ha destato l’interesse di alcuni studiosi di scolî attici e poesia simposiale: vd.Engelbrecht 1882, p. 65 s., Reitzenstein 1893, pp. 24-29, van der Valk 1973, pp. 7 s., 11, 19, masoprattutto il fondamentale contributo di Vetta 1983; Ehrenberg 1956, p. 60, Bowra 1973, p. 579,Lambin 1992, p. 274, e Fabbro 1995, pp. XIX n. 38, XXVIII s., 144, si interessano di v. 1226.
2 Vd. ad es. Clearch. Sol. fr. 63 I Wehrli tw'/ prwvtw/ e[po" kai; ijambei'on eijpovnti to; ejcovmenone{kaston levgein kai; tw'/ kefavlaion eijpovnti ajnteipei'n to; eJtevrou poihtou' tino", Plut. Quaest.conv. 1. 1 deuvteron d∆ ejfexh'" eJkavstw/ mursivnh" paradidomevnh", h}n ai[sakon oi\mai dia; to; a[/deinto;n dexamevnou ejkavloun. Mi riferisco all’esecuzione di scolî di secondo tipo, che secondoAristosseno-Dicearco sono quelli cantati da tutti i convitati in successione (distinti da quelli diprimo tipo, cioè i peani, cantati da tutti all’unisono, e da quelli di terzo tipo, appannaggio deipiù esperti; per tutto questo vd. Severyns 1934, p. 836 s.).
3 Seguo RVG, come già altri (ad es. Brunck 1783, Bekker 1829), nell’attribuire kalw'" di v. 1222a Bdelicleone e a[lhqe"… di v. 1223 a Filocleone. Alcuni studiosi (Meineke 1860, Bergk 1877,Engelbrecht 1882, p. 65, van Leeuwen 1909, Coulon 1928) assegnano kalw'" a Filocleone e conse-
Nella scena dei vv. 1208-1250 delle Vespe aristofanee, ultimo atto di unapiù ampia scena di paidei'a (vv. 1174-1250), viene presentato Bdelicleone in -ten to a saggiare le competenze poetiche del padre, perché questi non corra ilri schio di far brutta figura quando dovrà prendere parte a un simposio1.Bde licleone simula addirittura una riunione in atto, immaginando una auj lh -triv" già all’opera (v. 1219), e annoverando tra i convitati (v. 1220 s.) niente -me no che Cleone con alcuni dei suoi più importanti accoliti (Teoro, Eschine,Fa no); egli stesso, intonando qualcosa, fingerà di essere ora l’uno ora l’altrodi questi simposiasti, mentre Filocleone dovrà replicare all’Armodio (v. 1225),al l’Admeto (v. 1238) e al Clitagora (vv. 1245-1247), cioè a tre dei più noti e dif -fu si scolî attici, dando così prova di saper opportunamente selezionare un’i-donea risposta. Naturalmente le repliche di Filocleone si rivelano le più ina-datte possibili all’immaginaria compagnia, il che da una parte appare un fal-limento degli sforzi paideutici di Bdelicleone, ma dall’altra sancisce il suc-cesso presso Filocleone dell’anticleonismo del figlio, buon maestro almenoin politica. La scena, dunque, riveste grande interesse, perché costituisce,no nostante sia formalizzata e esplicitamente simulata, l’unico caso effettivodi quella recitazione poetica simposiale che ricostruiamo dalle fonti2.
L’esercizio cui Bdelicleone sottopone il padre è quello del devcesqai ta;skov lia, come si desume dall’ammonimento ta; skovli∆ o{pw" devxei kalw'" div. 12223 (e cf. anche v. 1225 devxei e v. 1243 devxetai). Lo schol. ad v. 1222 preci-
copia autore
sa che il devcesqai consiste nel proseguimento, da parte di un simposiasta, diun da to canto accennato con il verso d’inizio da un altro simposiasta4; e que-sta in terpretazione sembra adattarsi perfettamente ai tre casi di vv. 1226 e1227, 1238 e 1240-1242, 1245-1247 e 1248, dove ad un esame non approfondi-to in ef fetti può apparire, soprattutto nel primo caso, che i versi eseguiti daFi lo cleo ne siano una prosecuzione di quelli cantati da Bdelicleone. Gli stu-diosi han no accettato questa spiegazione, riconoscendo nella continuazioneuna pro va di cultura poetica, e cioè una dimostrazione, da parte del convita-to, di co noscenza mnemonica dei testi recitati usualmente a simposio5.
È merito di Vetta aver dimostrato senza ombra di dubbio che invece lapra tica cui fa riferimento Aristofane è un’altra: non la prosecuzione di un datoinizio, che è un costume inusuale per le riunioni simposiali, ma al contrariol’esecuzione, da parte di un convitato, di un intero scolio che possa in qualchemodo collegarsi ad un altro scolio cantato subito prima da un precedente con-vitato, secondo la pratica comune degli interventi poetici dei simposiasti6.Questa interpretazione non ha bisogno di riscontri, ma, come lo stesso Vettaha fatto notare, trova comunque un’inoppugnabile conferma pro prio nellascena aristofanea, dove a v. 1239 Bdelicleone chiede al padre non quale verso,ma quale “scolio” pensi di eseguire (tiv levxei" skovlion), dopo che nella finzio-ne simposiale lo stesso Bdelicleone ha cantato un unico verso si mulando diessere Teoro. Vetta, comunque, ha mantenuto la vecchia interpretazione, inqualità di eccezione, per i soli versi 1226-1227, parlando non tanto di una con-tinuazione dell’Armodio da parte di Filocleone, quanto di un’interruzione diuna reale versione del canto, una sorta di comico cattivo inizio dell’apprendi-stato di paidei'a simposiale7. Anche questa interruzione, tuttavia, si configuracome una continuazione, perché Filocleone non farebbe altro che interrompe-re Bdelicleone per impedirgli di eseguire il previsto, e a noi ignoto, secondoverso di quella redazione dell’Armodio, continuando lui il carme con un secon-do verso di sua invenzione8 appartenente allo stesso schema strofico (la cosid-detta “strofetta attica” phal I phal I gg2cho I 2dodrans II i).
244 G. Colesanti
guentemente a[lhqe"… a Bdelicleone, ma il kalw'" sembra proprio pronunciato dal figlio: dai suoistrilli in vv. 1228-1230 è chiaro che egli rimprovera il padre non per aver mancato di recitare, maper averlo fatto male, in modo, cioè, da suscitare le ire di Cleone per l’attacco troppo scopertodi v. 1227; kalw'" sembra dunque un buon complemento dell’invito a devcesqai ta; skovlia.
4 Schol. vet. ad Aristoph. Vesp. 1222 ajrcai'on h\n e[qo" eJstiwmevnou" a[/dein ajkolouvqw" tw'/ prwvtw/,eij pauvsaito th'" wj/dh'", ta; eJxh'": kai; ga;r oJ ejx ajrch'" davfnhn h] murrivnhn katevcwn h/\de Simwnivdoukai; Sthsicovrou mevlh a[cri" ou| h[qele, kai; meta; tau'ta w/| ejbouvleto ejdivdou oujc wJ" hJ tavxi"ajph/vtei: kai; e[legen oJ dexavmeno" para; tou' prwvtou ta; eJxh'" tou' mevlou" kajkei'no" ejpedivdou pav-lin w/| ejbouvleto. dia; to; pavnta" ou\n ajprosdokhvtw" a[/dein kai; levgein ta; mevlh skovlia ei[rhtai dia;th;n duskolivan.
5 Vd. ad es. MacDowell 1971, p. 290, Mastromarco 1983, p. 538, Sommerstein 1983, p. 228.6 Vetta 1983, pp. 128-130.7 Vetta 1983, p. 129.8 Sempre Vetta 1983, pp. 122, 128 e 130, ha evidenziato l’indubbio carattere di improvvisazio-
ne di tre delle quattro repliche di Filocleone (vv. 1227, 1241 s., 1248).
copia autore
L’espressione devcesqai ta; skovlia di v. 1222, d’uso corrente a quantosembra ai tempi della rappresentazione delle Vespe, probabilmente derivaper me tafora da modi di dire come devcesqai vel lambavnein th;n murrivnhn /kuvlika / luvran, poiché nei simposî dell’Atene del V secolo ricevere/prende-re il ra mo di mirto, la coppa o la lira costituiva, come una sorta di passaggiodel te sti mone, il prodromo all’esibizione poetica di ogni convitato9.Estremamente vi cino alla formulazione aristofanea appare, del resto, il devce-sqai th;n poivhsin di Dionys. Chalc. 1 W.2 = 1 Gent.-Pr.
devcou thvnde propinomevnhnth;n ajp∆ ejmou' poivhsin: ejgw; d∆ ejpidevxia pevmpw
soi; prwvtw/, Carivtwn ejgkeravsa" cavrita".kai; su; labw;n tovde dw'ron ajoida;" ajntiprovpiqi,
sumpovsion kosmw'n kai; to; so;n eu\ qevmeno" 5
dove l’invito alla replica poetica (vv. 1 s., 4) è reso con metafore simpoti-che10.
I commentatori delle Vespe non hanno comunque notato che la situazio-ne prospettata nella scena di vv. 1222-1248 è un po’ particolare; nei simposî,infatti, al suono dell’aulo i convitati recitavano l’uno dopo l’altro in sequen-za11, mentre in questo caso Filocleone, invece di esibirsi in un’unica occasio-ne, si trova a dover rispondere ogni volta agli scolî proposti ora da Cleone(v. 1224), ora da Teoro (v. 1236), ora da Eschine (v. 1243).
Per risolvere quest’aporia è bene considerare quanti siano gli ipoteticisim posiasti, e soprattutto in che modo, approssimativamente, si immaginache si trovino disposti. Oltre a Filocleone, ovviamente presente all’immagi -na ria riunione, in v. 1220 se ne enumerano quattro (Qevwro", Aijscivnh",Fa'no", Klevwn), mentre invece c’è incertezza tra gli studiosi sull’indicazionedi v. 1221, dove Bdelicleone potrebbe riferirsi a due persone (un secondostraniero e Acestore) se si legge xevno" ti" e{tero" pro;" kefalh'" ∆Akevsto -ro"12, oppure a una sola (il figlio di Acestore) nel caso si intenda xevno" ti"
Il devcesqai ta; skovlia in Aristoph. Vesp. 1208-1250 245
9 Vd. ad es. Aristoph. Nub. 1355 s. aujto;n th;n luvran labovnt∆ ejgw; ∆kevleusa / a\/sai Simwnivdoumevlo" e 1365 s. ejkevleus∆ aujto;n ajlla; murrivnhn labovnta / tw'n Aijscuvlou levxai tiv moi, Eup. fr.395. 1 K.-A. dexavmeno" de; Swkravth" th;n ejpidevxi∆ ãa[/dwnÃ, Amips. fr. 21. 1-3 K.-A. (A.) au[lei moimevlo" / su; d∆ a\/de pro;" thvnd∆: ejkpivomai d∆ ejgw; tevw". / (B.) au[lei suv, kai; ãsu;Ã th;n a[mustin lavm-bane, Antiphan. fr. 85. 2 K.-A. to;n wj/do;n lavmbane. Il riferimento è agli scolî di secondo e terzotipo, secondo la distinzione di Aristosseno-Dicearco (per cui vd. supra).
10 Si può notare, inoltre, a ulteriore conferma dell’interpretazione di Vetta, che anche in que-sto frammento ciò che viene ricevuto o re-inviato è una composizione poetica in sé conclusa(poivhsi", il pl. pro sing. ajoidaiv), e non un incipit da proseguire né un verso o più a completa-mento di un dato inizio. Per le metafore simpotiche relative all’esecuzione poetica cf. lo stessoDionisio Calco in fr. 4. 1 W.2 = 3. 1 Gent.-Pr. u{mnou" oijnocoei'n ejpidevxia soiv te kai; hJmi'n.
11 Vd. ad es. Dicaearch. fr. 88 Wehrli kaq∆ e{na eJxh'".12 Ad es. Dindorf 1877, Reitzenstein 1893, p. 25, Rogers 1916, Sommerstein 1983.
copia autore
e{tero" pro;" kefalh'", ÔAkev sto ro" (scil. oJ ∆Ak.)13; la seconda soluzione, tutta-via, appare di gran lunga la migliore, perché sembra molto difficile l’omis-sione del nome di un convitato, o comunque di una sua precisa identifica-zione, proprio nel momento in cui Bdelicleone effettua una rassegna deisimposiasti14. L’espressione xevno" ti" e{tero" non indicherà, dunque, «unsecondo straniero» rispetto a quel l’Ace store, straniero, nominato stranamen-te alla fine15, ma al contrario «un al tro simposiasta, straniero», «uno stranie-ro»: il figlio di Acestore. Il solo Ro gers, infine, ha supposto una presenza trai convitati anche di Bde li cleo ne16, ma si può ben vedere che costui non siautoinclude tra i supposti eJtai' roi, e dun que una sua partecipazione sembrada escludersi.
Assodato che verosimilmente i simposiasti si immaginano in numero di sei,possiamo notare che Bdelicleone fornisce anche alcune indicazioni sulla lo rodisposizione: uno di essi si trova pro;" kefalh'" (v. 1221), mentre in v. 1236 s.
tiv d∆, o{tan Qevwro" pro;" podw'n katakeivmeno"a/[dh/ Klevwno" labovmeno" th'" dexia'"...…
Teoro viene presentato sdraiato pro;" podw'n (v. 1236). È chiaro, come del restogli studiosi hanno ben evidenziato, che queste due precisazioni sono localiz-zazioni relative di un simposiasta nei confronti di un altro: nei simposî in ge -nere, come vediamo dalle rappresentazioni vascolari, i convitati si sdraia va -no ognuno su una klivnh17, adagiandosi con il fianco sinistro e lasciando liberala mano destra; le kli'nai venivano disposte in circolo intorno al cratere, eogni convitato era preceduto e seguito da altri due, uno situato prima di lui,cioè dalla parte del capo, e un altro collocato dopo di lui, ovvero dalla par tedei piedi. Quel che non è apparso evidente è invece al capo e ai piedi di qualesimposiasta si faccia riferimento. Se escludiamo in v. 1221 la lettura pro;"
246 G. Colesanti
13 Ad es. Starkie 1897, van Leeuwen 1909, MacDowell 1971, Mastromarco 1983. Inoltre, comegiustamente sottolinea MacDowell 1971, p. 289, anche lo schol. ad loc. attesta quest’interpreta-zione (ejpei; kai; aujto;n to;n ∆Akevstora wJ" xevnon kwmw/dou'si to;n tragikovn).
14 Così già Starkie 1897, p. 345.15 Reitzenstein 1893, p. 24 s., segna lacuna prima di v. 1220; Sommerstein 1983, p. 228, risolve
invece la difficoltà in modo arguto, asserendo che la ritardata menzione di Acestore dovevaingenerare per un attimo nel pubblico l’impressione che il primo straniero in questione fosseCleone, citato subito prima dello xevno" e{tero".
16 Rogers 1916, p. 190.17 Su una klivnh potevano distendersi due persone (vd. ad es. Herodot. 9. 16. 1 o il Simposio
platonico), ma sovente, come si vede in molte rappresentazioni vascolari di scene di banchettoo simposio, era un solo convitato a collocarvisi: l’altro possibile posto era riservato eventual-mente all’etera. Questo è il caso, mea quidem sententia, anche della scena delle Vespe: il numerolimitato dei convitati lo suggerisce. Una disposizione di due convitati per letto per la scenadelle Vespe è stata sostenuta da Rogers 1916, p. 190, che calcolava i simposiasti in numero diotto su quattro letti (Cleone e Teoro, straniero non nominato e Acestore, Eschine e Fano,Filocleone e Bdelicleone).
copia autore
kefalh'" ∆Akevstoro", secondo la quale un secondo straniero si colloche reb bedalla parte del capo di Acestore (cioè prima di lui), allora sembra ra gio nevolepensare che il simposiasta rispetto al quale il figlio di Acestore gia ce pro;"kefalh'" e Teoro pro;" podw'n debba essere in entrambi i casi o Filo cleo ne18
oppure Cleone19: il primo perché è appunto a lui che Bdelicleone par la, edunque potrebbe già indicargli gli eJtai'roi a lui prossimi; e il secondo per chéè il convitato di cui Bdelicleone parla proprio quando fornisce le due lo -calizzazioni relative. MacDowell, inoltre, accogliendo la prima soluzione, haanche pensato che in v. 1219 Teoro, Eschine, Fano e Cleone vengano citatisecondo l’ordine che occuperebbero a simposio; dopo Cleone verrebbe il fi -glio di Acestore, pro;" kefalh'" rispetto a Filo cleo ne che quindi si sdraierebbenel l’ultimo posto; Teoro, da cui inizia il circolo dei simposiasti, verrebbe dun -que a trovarsi pro;" podw'n rispetto all’ultimo, appunto Filocleone.
Ma tutte le ricostruzioni dell’ipotetico ordine dei simposiasti non devo-no prescindere da due particolari, cui non si è prestata la dovuta attenzione:il fatto che i simposiasti cantassero in sequenza l’uno dopo l’altro, come si ègià detto, e che lo facessero sempre da sinistra verso destra20. Il simposiastaa destra di un altro era quello che si trovava dalla parte dei piedi di quest’ul -ti mo, come risulta palese da alcune espressioni del Simposio platonico comeejn th/' (scil. klivnh/) kavtw ... aujtou' ... katakei'sqai (185d 1-2), uJpokavtw ejmou'kata kliv nou (222e 4-5), oppure eja;n ... uJpo; soi; kataklinh'/ (222e 11-12), dovecolui che si sdraia “al di sotto” si trova sempre alla destra del precedentesimpo sia sta (cf. 222e 10-11); ed evidentemente sdraiarsi al di sotto di qualcu-no vuol dire posizionarsi dalla parte dei suoi piedi21.
Se dunque le due indicazioni pro;" kefalh'" e pro;" podw'n si riferisserodavvero a Filocleone, allora egli dovrebbe cantare soltanto dopo il figlio di
Il devcesqai ta; skovlia in Aristoph. Vesp. 1208-1250 247
18 Ad es. MacDowell 1971, pp. 289 e 292, Mastromarco 1983, p. 539, e per il solo v. 1236Dindorf 1877, p. 150. Poiché Klevwno" di v. 1237 potrebbe riferirsi sia a pro;" podw'n di v. 1236 (inbuon iperbato) sia a th'" dexia'" di v. 1237 sia a entrambi ajpo; koinou', solo il secondo di questicasi viene ritenuto possibile.
19 Ad es. Starkie 1897, pp. 345 e 348, van Leeuwen 1909, p. 189, e Coulon 1928, p. 70, e per ilsolo v. 1236 Rogers 1916, p. 194, Sommerstein 1983, p. 229.
20 Vd. Eup. fr. 395. 1 K.-A., Dionys. Chalc. frr. 1. 2 W.2 = 1. 2 Gent.-Pr., 4. 1 W.2 = 3. 1 Gent.-Pr.,Plat. Symp. 177d 3, 214b 10-c 1, 222e 10 s. (per una recitazione di discorsi, mimetica di quellapoetica). L’uso di cantare ejpi; dexiav deriva evidentemente dal senso antiorario in cui il vinoveniva versato ai simposiasti riuniti intorno al cratere: cf. Od. 21. 141 s., dove i pretendenti sicimentano nella prova dell’arco passandosi l’arma secondo un ordine esplicitamente ispirato alversamento del vino (un medesimo giro dei convitati, ad opera di Odisseo, si ritrova in Od. 17.365, senz’altro per lo stesso motivo); cf. anche Plat. Symp. 223c 5, dove in una sorta di simposioa tre tra Socrate, Agatone e Aristofane il turno di bevuta da un’unica coppa procede anch’essoda sinistra verso destra. Naturalmente la direzione destra era preferita alla sinistra perché rite-nuta favorevole e fausta.
21 Tutto ciò vale in genere per letti ognuno dei quali era occupato da due simposiasti, comedimostra Symp. 175c 6-8 (vd. Dover 1980, p. 11); ma la terminologia e i criteri di disposizionesono evidentemente analoghi al caso di kli'nai con singoli occupanti.
copia autore
Ace sto re, e Teoro soltanto dopo Filocleone; ma mentre la seconda eventualitàsi ve rifica realmente (vv. 1236-1238), anche se solo dopo la prima delle tre oc -ca sioni in cui Filocleone canta, la prima non si realizzerebbe mai: Filocleonerisponde a ben tre persone nessuna delle quali è il figlio di Acestore, violan-do dunque per tre volte l’ordine di esecuzione, e replicando addirittura aTeo ro, cui egli non dovrebbe mai succedere nel turno di canto. Inoltre dopo laseconda esibizione di Filocleone stranamente non interverrebbe più Teoro,ma Eschine, ancora in spregio all’ordine di canto. Se invece sup poniamo cheil simposiasta cui si riferiscono le due localizzazioni sia Cleo ne, allora dob -bia mo pensare che egli si trovi tra il figlio di Acestore e Teo ro; ma anche inquesto caso non si capisce, allora, perché sia Filocleone a re plicare a Cleone alposto di Teoro, che invece interviene dopo Filocleone. Inoltre Filocleone ri -sponde a tre convitati diversi, violando quindi almeno due volte il turno dicanto (posto che possa trovarsi o dopo Teoro o dopo Eschi ne).
Per quanto riguarda la seconda indicazione, tuttavia, tra Filocleone eCleone il riferimento è senz’altro a quest’ultimo, poiché solo in rapporto alui è interpretabile il labovmeno" th'" dexia'" di Teoro in v. 1237 (riferendoKlevw no" a th'" dexia'" o anche a pro;" podw'n di v. 1236): non si tratta di uneffettivo “da re la mano” di Teoro a Cleone, come si è creduto22, ma invece diun “ricevere la mano” (destra!), cioè dell’indicazione di un turno di recita-zione poetica (che procedeva appunto verso destra) per mezzo di unametafora simile a quella del devcesqai ta; skovlia. Teoro riceve la destra diCleone, ovvero gli suc cede nell’ordine di canto, perché evidentemente èdisteso alla destra di Cleo ne, cioè ai suoi piedi (pro;" podw'n).
Rimane sempre da spiegare, comunque, perché Filocleone intervenga trevol te, mentre Cleone, Teoro e Eschine cantano una volta soltanto. Riguardoa quest’ultimo fatto io credo che quel che prospetta Bdelicleone non rispec-chi una vera recitazione simposiale, nella quale a Filocleone sarebbe toccatodi intervenire poeticamente solo una volta a giro; si tratta invece di diversepro ve cui Bdelicleone sottopone il padre, per vedere che cosa questi saprà ri -spon dere nel caso che venga recitato o l’Armodio o l’Admeto oppure il Cli ta -go ra. Tuttavia le due indicazioni pro;" kefalh'" e pro;" podw'n non possonoessere prive di significato, e inoltre in v. 1243
meta; tou'ton Aijscivnh" oJ Sevllou devxetai
248 G. Colesanti
22 Vd. ad es. Dindorf 1877, p. 150, Coulon 1928, p. 71, Mastromarco 1983, p. 539, Sommerstein1983, p. 121. Rogers 1916, p. 194, afferma che il prendere la mano di Cleone implica necessaria-mente che Teoro gli sia sdraiato accanto, sul medesimo lettino; MacDowell 1971, p. 292, pensainvece che Teoro, posizionato nel circolo simposiale di fronte a Cleone, si alzi dal lettino, attra-versi il circolo e prenda la mano del demagogo. Il gesto del prendere la mano, comunque, èabbastanza singolare, e stranamente non si è sentito il bisogno di motivarlo in alcun modo (ades. come gesto di sottomissione, o come prova di relazione omoerotica).
copia autore
si può vedere che Bdelicleone si riferisce di nuovo ad un ordine di canto, poi -ché colloca Eschine di seguito ad un altro simposiasta e lo incarica di dev ce s -qai lo scolio appena eseguito da costui. L’unica soluzione possibile mi ap paredunque la seguente: l e d u e l o c a l i z z a z i o n i r e l a t i v e s ir i f e r i s c o n o e n t r a m b e a C l e o n e , m a n o n a d u n am e d e s i m a d i s p o s i z i o n e d e i s e i c o n v i t a t i .
Dobbiamo innanzitutto ricordare che nei banchetti e nei simposî, perlo -me no in quelli dell’Atene del V-IV secolo a. C., le kli'nai dove ci si sdraiavanon erano del tutto equivalenti, ma avevano un qualche ordine gerarchico: ilposto migliore, il primo, era quello considerato il più in alto a sinistra, cuivia via seguivano tutti gli altri verso destra; il peggiore, l’ultimo, era il più inbas so a destra, cioè la klivnh posta al di sopra del primo letto. Il primo postoera riservato ovviamente al convitato più importante; l’ultimo, il “posto del -la vergogna”23, poteva essere destinato a persone poco importanti24 o esserela sciato libero per un a[klhto" o un comasta25, quando non veniva cortese -men te occupato dal padrone di casa26.
Tra gli immaginari simposiasti nominati da Bdelicleone il più prestigio-so, ça va sans dire, è Cleone, ed è dunque a lui che tocca il primo posto, né al -cu no degli spettatori delle Vespe può aver pensato il contrario. Chi si trovaso pra Cleone, cioè dalla parte del capo di costui (pro;" kefalh'"), occupa l’ul-timo posto, quello peggiore; e fra i restanti cinque simposiasti è proprio aduno straniero come il figlio di Acestore che ben si adatta questa vergogna:Ari stofane lo sbeffeggia colpendolo con una sorta di ajtimiva simposiale chesi ac corda con il mancato possesso della cittadinanza. In v. 1219 s., dunque, a
Il devcesqai ta; skovlia in Aristoph. Vesp. 1208-1250 249
23 klisiva a[timo" viene definito in Plut. Septem sapient. conviv. 148f. In Plut. Quaest. conviv. 1. 2si trova una disquisizione sul diverso valore dei posti a convito e sui criteri di assegnazione,anche se in relazione all’uso di epoca imperiale.
24 In Stob. 3. 13. 56 si racconta che Platone viene umiliato da Dionisio di Siracusa appuntocon l’assegnazione di tale posto. Presumibilmente l’ultima piazza doveva essere il classicoposto del kovlax o paravsito".
25 L’ a[klhto" era colui che si presentava non invitato a un banchetto, come ad es. il Menelaodi Il. 2. 408, assurto a esempio paradigmatico; vd. inoltre Cratin. frr. 46 e 47 K.-A., Xen. Symp. 1.11-16 (con un Filippo gelwtopoiov" assimilabile a un kovlax, e le due categorie del resto potevanocoincidere per Asius Sam. fr. 14 W.2), Lucian. Symp. 12; in Plat. Symp. 174a 9-d 1, invece,Aristodemo rifiuta questo ruolo per rivestire quello di ospite invitato da un altro ospite (cioè diejpivklhto" o skiav, per cui vd. Plut. Quaest. conv. 7. 6). Il comasta era uno dei partecipanti alkw'mo" successivo al simposio, e poteva irrompere in un altro simposio in corso: vd. ad es. ilcaso famoso di Alcibiade in Plat. Symp. 212d 3-213b 1. È lecito supporre che, se i partecipanti aun convito erano in numero anche solo inferiore di uno alle kli'nai, nessuno volesse occuparespontaneamente l’ultimo posto, che dunque rimaneva libero; in caso di arrivo di un a[klhto" odi un comasta, era proprio a costui che doveva essere assegnato quel posto, senza tema dioltraggio (l’arrivo era inaspettato, e il sopraggiunto, se voleva unirsi alla compagnia, dovevaaccettare qualsiasi collocazione). In Plat. Symp. 213a 6-b 1 il comasta Alcibiade, in effetti, si siededi sua iniziativa accanto ad Agatone, cioè nell’ultimo posto.
26 In tal modo si comporta Agatone nel Simposio platonico, sedendo da solo ultimo tra tutti(175c 7 e[scaton katakeivmenon movnon).
copia autore
mio avviso Bdelicleone enumera in ordine sparso gli ipotetici cittadini sum -pov tai, ma culmina con il personaggio più importante, Cleone, ricordandoso lo dopo questi, e collocandolo naturalmente nel posto peggiore, lo xevno"ÔAkev sto ro".
L’ovvia deduzione che il primo posto non può che essere di Cleone, e lapre cisazione che il posto prima di lui, cioè l’ultimo, è occupato dallo stranie-ro, non sono particolari privi di importanza: fondandosi su di essi, infatti,Ari stofane esclude subito, e silentio, che sia proprio Filocleone ad occupare lapri ma o l’ultima klivnh, e al contempo lascia indeterminate le posizioni di Fi -lo cleone stesso e dei tre scherani di Cleone (Teoro, Eschine, Fano). Tutto ciò èfon damentale per la riuscita della scena di paidei'a simposiale, poiché l’ordi-ne di recitazione poetica rispecchiava esattamente quello dei posti: il primo in tervento spettava a chi occupava il primo posto, e poi si proseguiva versode stra fino a giro concluso27.
Nell’immaginario simposio supposto da Bdelicleone il primo a eseguireuno scolio, in effetti, è proprio Cleone (v. 1224 s.), a conferma di quanto ab -bia mo detto; Bdelicleone chiede allora al padre di replicare al carme di co -stui (v. 1225), e ciò automaticamente vuol dire che egli ipotizza che sia Fi lo -cleo ne il simposiasta disteso subito dopo Cleone, ovvero ai piedi di questi,poi ché solo e soltanto a quel simposiasta spetta di replicare al capopopolo.L’or dine di successione che si prospetta è dunque questo: Cleone-Filocleone-Teo ro, Eschine e Fano in sequenza non precisata-figlio di Acestore.
Ma subito dopo (v. 1236 s.) Bdelicleone chiede al padre che cosa faràquan do interverrà con l’Admeto Teoro, il quale, viene precisato, si trova di -steso ai piedi (pro;" podw'n) di Cleone e alla sua destra. Evidentemente Bde li -cleo ne non segue più l’ordine di esecuzione da lui prima supposto, ma ipo-tizza un nuovo scenario con la successione Cleone-Teoro-Filocleone-Eschinee Fano in sequenza non precisata-figlio di Acestore: una successione in cui aFi locleone non spetti più di replicare a Cleone, ma al secondo simposiasta,iden tificato in Teoro. Si tratta dunque di una seconda prova cui Filocleonevie ne sottoposto, dopo quella della risposta all’Armodio di Cleone.
Infine, Bdelicleone dice chiaramente (v. 1243) che dopo Teoro deve prati -ca re il devcesqai Eschine, il quale eseguirà il Clitagora; e la questione è orache co sa potrà rispondere Filocleone a questo scolio. L’ordine degli interven-
250 G. Colesanti
27 Vd. ad es. il Simposio platonico, dove, in base ad un ordine degli interventi ejpi; dexiav, Fedroparla per primo perché prw'to" katavkeitai (177d 3 s.); per ultimi parlano invece Agatone eSocrate, occupanti dell’ultimo posto. In Aristoph. Vesp. 1225, inoltre, Bdelicleone, che ha appenaaffermato (v. 1224) di impersonare Cleone, dice effettivamente a[/dw de; prw'to", e potrebbe dav-vero alludere al naturale diritto di Cleone di esibirsi per primo; ma il riferimento può essereanche al fatto che Cleone canterà per primo semplicemente rispetto a Filocleone. GiàReitzenstein 1893, p. 26, aveva osservato che Cleone canta per primo in virtù della sua maggio-re importanza rispetto agli altri convitati.
copia autore
ti mu ta di nuovo, e questa volta si prospetta la sequenza Cleone-Teoro-Eschi ne-Filocleone-Fano-figlio di Acestore.
Si tratta, insomma, di tre ipotesi diverse: che cosa potrebbe rispondereFi lo cleone all’Armodio di Cleone? Ma se dopo Cleone è disteso Teoro checan ta l’Admeto, quale sarà la replica più idonea? E se, ancora, dopo Teoro sitro va invece Eschine che canta il Clitagora, che cosa opporrà Filocleone aque sto scolio? Non dobbiamo quindi immaginare una sequenza recitativanel la quale intervengono sia Cleone con l’Armodio sia Teoro con l’Admeto siaEschine con il Clitagora, e con Filocleone che replica di volta in volta a tutti etre; ma dobbiamo pensare, invece, a tre possibili situazioni di recitazione, al -ter native l’una all’altra, che prevedono sempre e soltanto la successione sim -posiasta-Filocleone. Il gioco, anzi, poteva continuare ancora una volta con lase quenza Cleone-Teoro-Eschine-Fano-Filocleone-figlio di Acestore, ma Ari -sto fane ha ritenuto opportuno interromperlo.
Quella attuata nella scena delle Vespe è una costruzione solo apparente-mente complicata, ma in realtà perfettamente aderente alle consuetudinisim posiali dell’epoca, e che soprattutto si rivela come l’unica funzionale nel-l’ottica comica. Bdelicleone, in effetti, avrebbe potuto semplicemente richie-dere al padre una risposta ai tre scolî, senza indicare ipotetici esecutori. As -se gnando invece ad ogni carme un diverso simposiasta, Aristofane ha attua-to in primo luogo una variatio, e poi, con buona riuscita comica, ha potutoper seguire l’ ojnomasti; kwmw/dei'n tramite le mordaci risposte di Filocleone re -la tive ai tre personaggi; ma tutto ciò era possibile, in base alle regole simpo-siali, solo non fissando a priori la collocazione di Filocleone.
Vorrei ora analizzare la prima prova di vv. 1224-1227, e in generale lasezione dei vv. 1224-1235, che riporto secondo il testo di Sommerstein 1983:
(Bd.) kai; dh; gavr eijm∆ ejgw; Klevwn,a[/dw de; prw'to" ÔArmodivou, devxei de; suv. 1225«oujdei;" pwvpot∆ ajnh;r e[gent∆ ∆Aqhvnai"–»
Fi. – oujc ou{tw ge panou'rgo" ãoujde;Ã klevpth".Bd. touti; su; dravsei"… parapolei' bowvmeno":
fhvsei ga;r ejxolei'n se kai; diafqerei'nkajk th'sde th'" gh'" ejxela'n.
Fi. ejgw; dev ge, 1230eja;n ajpeilh'/, nh; Div∆, eJtevran a[/somai:«w\nqrwf∆, ou|to" oJ maiovmeno" to; mevga kravto", 1232/3ajntrevyei" e[ti ta;n povlin: aJ d∆ e[cetai rJopa'"». 1234/5
Secondo l’ipotesi interpretativa ancora oggi accolta dagli studiosi, laqua le però, premetto subito, non è a mio avviso la più probabile, il meccani-smo operante nei vv. 1226 e 1227 sarebbe quello dell’interruzione-continua -zio ne di un dato inizio; ma è possibile svolgere ancora alcune considerazioni
Il devcesqai ta; skovlia in Aristoph. Vesp. 1208-1250 251
copia autore
nel l’ambito di questa linea esegetica. Innanzitutto, se noi accettiamo taleipo tesi, allora la supposizione che v. 1226 sia l’incipit di una redazione a noiigno ta dell’Armodio appare probabile (Page lo rubricava come fr. 911);Athen. 15. 695a-b, in effetti, ci attesta ben quattro versioni dell’Armodio (893-896 P. = 10-13 Fabbro), che di certo erano molto tipiche e note, ma che pote -va no anche non essere le uniche circolanti ad Atene nel lasso di tempo 514-422 a. C. Sappiamo, tra l’altro, che nel V secolo il governo ateniese proibì l’a/\sai ejpi; ta; kakivona dell’Armodio, divenuto ormai una sorta di inno nazio-nale (Hyperid. 4. 3); questa proibizione indica la circolazione di versionischerzose del carme, e indirettamente conferma, se ve n’è bisogno, la possi-bilità che in Atene venissero create versioni serie dell’Armodio alternativealle quattro a noi note28. L’ ajprosdovkhton costituito dal v. 1227, inoltre, cipotrebbe far im ma ginare, con buon grado di probabilità, il secondo versopiù adatto all’incipit oujdei;" pwvpot∆ ajnh;r e[gent∆ ∆Aqhvnai" di v. 1226, che amio avviso sarebbe il ben noto w{sper ÔArmovdio" kai; ∆Aristogeivtwn, secondoverso di due redazioni del l’Armodio (893 e 895 P. = 10 e 12 Fabbro), e compa-tibile con l’andamento sin tattico di v. 1226. È comunque necessario ipotizza-re un secondo verso che men zionasse in modo comparativo almeno il soloArmodio (w{sper ÔArmovdio" x h g h W), dato che in un Armodio questa cita-zione è inevitabile, mentre invece quella di Aristogitone potrebbe ancheessere taciuta (cf. 894 P. = 11 Fabbro). In seguito si dovrebbe pensare ad unaspiegazione dell’eccezionalità di Ar mo dio (e forse anche di Aristogitone),ovviamente in riferimento al tiran nici dio; e al tal scopo, se Aristogitoneveniva menzionato, andrebbero beni i due versi finali di 896 P. = 13 Fabbroo{ti to;n tuvrannon ktanevthn / ijsonovmou" tæ ∆Aqhvna" ejpoihsavthn. Ma natu-ralmente si tratta di una ricostruzione del tutto ipo tetica.
Un’interruzione-continuazione simile a quella ipotizzata per i vv. 1226 e1227 viene messa in scena da Aristofane l’anno dopo la rappresentazionedelle Vespe, in Pax 1298-1301:
paid. b v ajspivdi me;n Sai?wn ti" ajgavlletai, h}n para; qavmnw/,e[nto" ajmwvmhton, kavllipon oujk ejqevlwn –
Tr. eijpev moi, w\ povsqwn: eij" to;n sautou' patevr∆ a[/dei"… 1300paid. b v yuch;n d∆ ejxesavwsa –Tr. kath/vscuna" de; tokh'a".
Ci troviamo all’interno della scena (vv. 1265-1310) in cui Trigeo valuta l’oppor-tunità di ciò che due fanciulli, il figlio del prode Lamaco e il figlio del di ser toree rJivyaspi" Cleonimo, eseguiranno di lì a poco nel simposio succes si vo al
252 G. Colesanti
28 Giustamente già Vetta 1980, p. XXXI, notava che le deformazioni dell’Armodio non eranoaltro che un esercizio di metapoiesis del canto ufficiale.
copia autore
gavmo": una situazione di paidei'a che, come si vede, appare molto vicina aquella di Vesp. 1222-1248. Il paidivon b v, che è il figlio di Cleonimo (v. 1295), suinvito di Trigeo (v. 1296) comincia a eseguire il suo pezzo, che si rivela es se rel’elegia dello scudo di Archiloco (5 W.2), notissima e famigerata nel mon dogreco (la commedia è dionisiaca). Trigeo interrompe subito il fanciullo dopo ilprimo distico, chiedendogli se stia parlando del padre, e possiamo no tare cheegli continua lo schema epodico eseguendo l’atteso esametro29, mentre inveceavrebbe potuto effettuare l’interruzione con un trimetro recitato30. Il bimbo,imperterrito, tenta di continuare, e si mette ad eseguire il ter zo verso, sostituen-do così l’esametro di Trigeo con il vero verso archilocheo31; riesce però ad arri-vare solo alla trocaica, perché viene di nuovo inter rot to, e questa volta definiti-vamente, da Trigeo, che gli completa a suo modo l’esa metro. Entrambe le inter-ruzioni, dunque, si configurano come continuazioni del canto del fanciullo.
Tuttavia, tornando alla scena delle Vespe, quanto detto finora sul v. 1226è valido, come ho precisato, solo nell’ipotesi che il meccanismo di vv. 1226-1227 sia realmente quello della recitazione di un verso da parte di Bdeli cleo -ne e dell’interruzione-continuazione di Filocleone, in ajprosdovkhton, con unsecondo verso appartenente allo stesso schema strofico. Ma rispetto a questain terpretazione, che anch’io a suo tempo ho condiviso32, penso ora che sipos sa presentare una lettura più valida. Voglio ancora ricordare che, com’è
Il devcesqai ta; skovlia in Aristoph. Vesp. 1208-1250 253
29 Proprio per questo fatto ritengo che sulla scena la resa di questo verso possa essere la stessadei vv. 1298 e 1299. Pretagostini 1995, p. 170, propone questa interpretazione: 1298-1299 distico liri-co in quanto cantato (cf. v. 1296), 1300 esametro recitato, 1301 esametro lirico. Penso sia possibile,for se, anche questa spiegazione: vv. 1298-1301 tutti in parakataloghv, i primi due e il quarto (1301a+ il completamento) in quanto versi elegiaci, e il terzo perché continuazione epodica di un distico;sul fatto che il fanciullo “canti” questi versi cf. ad es. Theogn. 939, 943 (uso di ajeivdw per versi elegia-ci).
30 Come avviene in Pax 1284 s. e 1288 s., dopo che però Trigeo ha varie volte “duettato” asuon di esametri con il figlio di Lamaco.
31 Aristofane quale primo termine di questo verso presenta yuchvn, mentre Plut. Inst. Lac. 34 atte-sta aujtovn, confermato da altre fonti, e difficilior. Per spiegare la genesi della variante aristofaneaOlson 1998, p. 310 s., nota che dopo l’interruzione di Trigeo il pubblico avrebbe inteso aujtovn comeriferimento a patevr(a) di v. 1300 piuttosto che come ejmautovn, e quindi crede che per evitare ambi-guità Aristofane lo abbia accortamente sostituito con yuchvn. Ma si può obiettare che il morceauarchilocheo doveva essere fin troppo noto al pubblico pangreco perché qualcuno incorresse inquell’errore, e che una sostituzione poteva frustrare le attese del pubblico, indisponendolo; inoltreil modo migliore e più economico per evitare ogni fraintendimento era senz’altro sostituire aujtovncon auJtovn (o ej‿autovn). Olson si rifà alla vecchia ipotesi di Platnauer 1964, p. 171 s., che addebita ilcambio ad Aristofane stesso, «to suit the Attic usage»; per West 1974, p. 118, invece, si tratta di una«variante orale», di origine popolare, per incomprensione del riflessivo aujtovn. Seguendo in partequesta linea, credo si possa avanzare l’ipotesi che yuchvn, più che una “variante popolare”, sia una“variante di recitazione” prodottasi in ambito simposiale, per motivi di difficile comprensione oancora meglio per difetto di memoria (come deve essere per le due varianti equivalenti fivlei/sev-bou del primo verso dell’Admeto, per cui vd. Vetta 1983, p. 122 e n. 17 a p. 151); la variante dovevaessere nota ad Aristofane, forse quale unica lezione, per via orale. L’unica altra possibilità è unerrore di Aristofane per citazione mnemonica. Non ritengo probabile, invece, l’ipotesi di Loscalzo1997, pp. 10 e 14, per il quale la variante è una parodia aristofanea di Archiloco.
32 Colesanti 1997, p. 440.
copia autore
sta to dimostrato, il devcesqai ta; skovlia cui Aristofane allude (v. 1222) consi-ste so lo e soltanto nell’alternare scolio a scolio; se tutta la scena è imperniatasu que sto, non mi pare allora probabile che proprio la prima delle tre proveche si avranno costituisca un’eccezione rispetto a tale pratica. Questa ecce-zione, inol tre, risulta ancora più strana se si tiene presente che Bdelicleone fadi nuo vo esplicito riferimento alla pratica del devcesqai, con le parole devxeide; suv (v. 1225), proprio immediatamente prima che i due faleci di v. 1226 s.vengano eseguiti. Si deve notare, poi, che in v. 1231 Filocleone afferma checanterà “un’altra” wj/dhv (eJtevran [scil. wj/dh;n] a[/somai), un’altra, cioè, rispettoall’ wj/dhv eseguita in precedenza, ed è evidente che non è definibile come talela semplice aggiunta di un secondo verso 1227 a un primo verso 1226 recita-to da altri. Infine, l’ wj/dhv di vv. 1232-1235 viene presentata come alternativaalla prima esecuzione di Filocleone, e ciò costituisce l’argomento definitivocontro l’ipotesi dell’interruzione-continuazione: infatti, mentre v. 1227 puòeffettivamente essere una continuazione di v. 1226 in base allo schema della“strofetta attica”, altrettanto non può dirsi per i due alcmani di vv. 1232-1235.
Penso pertanto che si possa affermare che i l d ev c e s q a i t a;s k ov l i a d e v e n e c e s s a r i a m e n t e v a l e r e a n c h e p e ri v v . 1 2 2 6 e 1 2 2 7 , e dunque per tutte le recitazioni dei vv. 1226-1248. Ma così com’è normalmente edito il testo non funziona in questosenso; avanzo allora la proposta di assegnare a Filocleone, oltre a v. 1227,anche v. 122633, per arrivare al seguente testo (vv. 1224-1230):
(Bd.) kai; dh; gavr eijm∆ ejgw; Klevwn,a[/dw de; prw'to" ÔArmodivou: devxai de; suv. 1225
Fi. oujdei;" pwvpot∆ ajnh;r e[gent∆ ∆Aqhvnai"oujc ou{tw ge panou'rgo" ãoujde;Ã klevpth" –
Bd. touti; su; dravsei"… parapolei' bowvmeno":fhvsei ga;r ejxolei'n se kai; diafqerei'nkajk th'sde th'" gh'" ejxela'n. 1230
Non vi è dubbio che ciò che viene spontaneo fare, nel leggere i vv. 1225-1227, sia appunto attribuire 1226 e 1227 a due personaggi diversi, poichéqual cuno in v. 1225 afferma di cantare per primo, invitando un altro a conti-nuare: niente di più immediato e conseguente che tradurre queste parole inuna distinta esecuzione di 1226 e 1227, con il primo verso assegnato a chipar la in v. 1225, e il secondo all’altro personaggio34. Ma questa ricostruzione,
254 G. Colesanti
33 La medesima proposta è stata avanzata da Dobree 1833, p. 203, ma senza alcuna motiva-zione: «1221-2 [scil. = 1226-1227]. Ambo versus sunt Philocleonis». Questo stringato interventoè stato pressoché ignorato da tutti (vi accenna diligentemente Blaydes 1893, p. 149).
34 È lo stesso ragionamento che si ritrova nello schol. ad Vesp. 1222, la cui autoschediasticità è evi-dente (Vetta 1983, p. 128, con n. 47 a p. 155). Lo scoliasta, inoltre, si riferisce agli scolî di terzo tipo
copia autore
del tutto naturale, è come si è detto in contrasto con l’uso del devcesqai, edun que si rivela falsa. L’unica altra strada percorribile, allora, è proprioquel la di riconoscere nel solo Filocleone l’esecutore sia di 1227 sia anche di1226, e la situazione che si prospetta appare la seguente.
Bdelicleone, nel saggiare la cultura poetico-simposiale del padre, lo sot-topone ad una prima prova: afferma di essere Cleone e di cantare l’Armodio,e subito invita il padre a replicare (v. 1225): devxei de; suv (R), o ancora megliodev xai de; suv (V)35. Bdelicleone dice semplicemente: «io canto l’Armodio», main realtà non lo esegue; non ve n’era bisogno, del resto, perché si può imma-ginare che quasi nessuno, nel pubblico, non ne conoscesse almeno una ver-sione36. Si potrebbe osservare che dell’Armodio esistevano varie redazioni (al -me no quattro), e che in tal modo rimane incerto a quale precisamente inten-da riferirsi Bdelicleone; ma a questa obiezione si può rispondere che non do -ve va importare troppo di quale redazione si trattasse: il punto fondamentaleera la capacità di devcesqai l’Armodio, in qualunque versione venisse esegui-to (e quest’ultima eventualità, anzi, poteva rendere la prova ancora piùinteres san te)37. Il compito di Filocleone, allora, è quello di replicareall’Armodio con un altro scolio, e la cosa più ovvia che si possa fare è quelladi recitare un car me metricamente speculare, cioè organizzato anch’essosulla cosiddetta “stro fetta attica”38; i versi 1226 e 1227, infatti, sono due fale-ci, e corrispondono ai primi due versi della “strofetta”.
Il devcesqai ta; skovlia in Aristoph. Vesp. 1208-1250 255
(eseguiti solo dai più esperti, in spregio all’ordine di disposizione dei letti); ma tale ricostruzione èfalsa, innanzitutto perché non spiega comunque il triplice intervento di Filocleone rispetto a quellisingoli degli altri, e poi perché i simposiasti nella scena delle Vespe cantano al suono dell’aulo, suo-nato da altra persona (vd. v. 1219), come avveniva per gli scolî di secondo tipo (per gli scolî di terzotipo i simposiasti suonavano da sé, e usavano la lira: vd. ad es. Plut. Quaest. conv. 1. 1. 5).
35 Così già Meineke 1860 e Vetta 1983, p. 150.36 E del resto lo stesso Aristofane negli Acarnesi, commedia lenaica come le Vespe, e nella Li si -
stra ta, probabilmente lenaica, dà per scontata presso il pubblico la conoscenza di almeno duedi verse redazioni dell’Armodio: quella di 894 P. = 11 Fabbro, quando in Ach. 1093 ne cita il primoco lon, e quella di 893 oppure 895 P. = 10 e 12 Fabbro (se non di tutte e due), quando in Lys. 632ne traspone l’incipit. Ciò che è noto, secondo un ovvio principio, può essere accennato o anchedel tutto taciuto; cf. il v. 914 delle Ecclesianti (altra commedia lenaica), dove una ragazza con untrimetro recitato interrompe al terzo verso una canzonetta, dicendo kai; ta\lla ãm∆à oujde;n ãta;Ãmeta; tau'ta dei' levgein: Vetta 1989, p. 240, ha spiegato quest’interruzione supponendo che ilcarme che la ragazza sta eseguendo sia parte di un repertorio popolare ben noto a tutto il pub-blico.
37 Anche in Ach. 980 (to;n ÔArmovdion a/[setai) e fr. 444. 2 K.-A. (ÔArmodivou mevlo"), d’altra parte,Aristofane si riferisce genericamente all’Armodio, e non ad una specifica redazione, come pureAntiphan. fr. 85. 5 K.-A.; cf. inoltre in Aristoph. Lys. 1237 e Antiphan. fr. 85. 4 K.-A. i genericiaccenni al Telamone, scolio di cui ad Atene circolavano almeno due versioni (898-899 P. = 15-16Fabbro), come mostra Theopomp. fr. 65. 3 K.-A. Telamw'no" ... mevlh.
38 Cf. il caso di Aristoph. Eccl. 938-941 e 942-945, dove a una “strofetta attica” cantata da uncomasta viene risposto con un’altra “strofetta”, con agganci tematici e verbali (per questi versivd. Vetta 1984, p. 114, e Vetta 1989, pp. 243-245). L’ovvia specularità metrica si trova anche in900/901 P. = 17-18 Fabbro, una coppia simposiale sicura per via di precisi riscontri tematico-verbali (vd. Vetta 1980, p. XXX s.), e in 904/905 P. = 21-22 Fabbro (vd. Cannatà 1999, p. 23 s., cheanzi, oltre a riconoscere questa coppia, la collega in “catena simposiale” a 903 P. = 20 Fabbro).
copia autore
La risposta appare improvvisata, come due delle altre tre repliche. Maper ché Filocleone canterebbe soltanto i primi due versi, omettendo di ese-guire anche gli ultimi due e non presentando, in tal modo, uno scolio inte-gro perfettamente associabile a quell’Armodio ben presente nella mente ditut ti gli spettatori? È evidente che, giunto alla fine dell’esecuzione di v. 1227,egli viene impedito dal continuare da un’interruzione del figlio, il quale,sor preso per quanto ha sentito (si parla di un uomo panou'rgo" e klevpth"evidentemente riconoscibile in Cleone), non riesce a trattenersi, e zittisce ilpa dre erompendo con touti; su; dravsei"… ktl. L’intenzione di Filocleone,però, do veva essere quella di cantare uno scolio intero, e questo può appari-re con fer mato dai due alcmani di 1232-1235, presentati come una vera w/jdhv(cioè uno scolio completo), e recitati in sostituzione dello scolio attico noneseguito integralmente, come nuovo contraltare dell’Armodio: «se mi minac-cia io gliene canto un altro di scolio, in risposta al suo Armodio», sembra direin v. 1230 s. Filocleone. I due alcmani, come segnala anche lo scolio ad loc.,sono ver si di Alceo (141. 3 s. V.), estrapolati da un più ampio carme alcaico,e usa ti, con alcune varianti39, come scolio integro, esattamente secondo lostesso pro cedimento per cui una strofetta alcaica (249. 6-9 V.), parte di unapiù ampia composizione, fungeva da carme autonomo nei simposî attici(891 P. = 8 Fabbro)40.
Ma analizziamo ora l’ultima parte della scena, ai vv. 1236-1250, che ri -por to secondo il testo di Vetta 1983 (p. 150 s.):
Bd. tiv d∆, o{tan Qevwro" pro;" podw'n katakeivmeno"a/[dh/ Klevwno" labovmeno" th'" dexia'":∆Admhvtou lovgon w\tai're maqw;n tou;" ajgaqou;" fivlei, 1238/9touvtw/ tiv levxei" skovlion…
Fi. wJdiv pw" ejgwv: 1240oujk e[stin ajlwpekivzein,oujd∆ ajmfotevroisi givgnesqai fivlon.
Bd. meta; tou'ton Aijscivnh" oJ Sevllou devxetai,ajnh;r sofo;" kai; mousikov", kajnta/vsetaicrhvmata kai; bivon Kleitagovra/ te kajmoi; meta; Qettavlwn. 1245/7
Fi. polla; dh; diekovmpasa" su; kajgwv.
256 G. Colesanti
39 Certamente intenzionali ad opera di Aristofane, com’è ovvio, sono il passaggio dal nom.w[nhr al voc. w\nqrwf∆, e il cambio della terza persona ojntrevyei con la seconda ajntrevyei" (forsecon il mantenimento del timbro eolico); questi cambiamenti sono mimetici di quanto dovevaavvenire correntemente nei simposi, quando carmi di celebri autori venivano modificati appo-sta per adattamento al contesto di recitazione (vd. ad es. in Theogn. 153 s. il caso di Solon. fr. 6.3 s. W.2 = 8. 3 s. Gent.-Pr., con la spiegazione di Ferrari 1989, p. 23 s.). Per la sostituzione dell’al-caico tavca con e[ti, del tutto ininfluente, penso o ad un errore di memoria dello stessoAristofane (così già MacDowell 1971, p. 291), o ad una variante recitativa simposiale, prodottasisempre per difetto mnemonico, e recepita da Aristofane.
40 Per le questioni inerenti al confronto tra l’originale alcaico e lo scolio attico vd. Rossi 1993.
copia autore
Bd. touti; me;n ejpieikw'" suv g∆ ejxepivstasai.o{pw" d∆ ejpi; dei'pnon eij" Filokthvmono" i[men. 1250
La pratica cui si fa riferimento è sempre quella dell’alternare scolio asco lio, come è stato dimostrato e come chiariscono gli evidenti accenni di vv.1240 e 1243; ma il meccanismo che la attua è parzialmente diverso. Nel casodel la prima prova Bdelicleone non ha recitato l’Armodio, mentre Filocleonesi è di fatto esibito fornendo una replica, interrotta, e quindi una seconda re -pli ca, alternativa alla prima. Ora, invece, sia il figlio sia il padre eseguonodei carmi, in un vero “botta e risposta” mimetico della realtà simposiale.
Nelle sue due esecuzioni, tuttavia, Bdelicleone non canta mai un interosco lio, ma un solo verso; si deve però osservare che questi micro-interventiso no tutti definiti skovlia proprio da Aristofane41, e che uno dei versi esegui-ti (v. 1238) ci è noto da altre fonti come incipit dell’Admeto (897 P. = 14Fabbro). Se ne può concludere, allora, che Aristofane ha voluto in entrambi icasi rife rir si a degli scolî interi con la citazione del solo inizio42 (che comun-que con te neva il nome “Admeto” o “Clitagora”), il quale inizio, in conside-razione del la notorietà dei due scolî presso il pubblico, doveva essere perce-pito co me un’abbreviazione sufficiente per l’intero carme43, alla stregua diun ti to lo44. Tale uso, peraltro, è del tutto analogo a quello della prima prova,dove l’Ar modio, non eseguito, era solo evocato con la citazione del nome, chefun ge va appunto da titolo. Il tipo di presentazione è quindi sostanzialmenteil me desimo in tutti e tre le proposte, ed è comunque del tutto sufficiente,anzi van taggioso, all’azione comica, in quanto una reale esecuzione integra-le de gli scolî in questione, oltre a essere inutile, avrebbe inopportunamentedila ta to il tempo scenico.
Agli scolî di proposta abbreviati all’incipit corrispondono due risposteche non si configurano, come si è detto, come continuazione dei due inizi,ma come vere repliche, secondo la prassi del devcesqai. Tali risposte, inparal le lismo con le proposte, potrebbero essere anch’esse scolî abbreviati alverso d’ini zio45; ma mi sembra più plausibile che si tratti di scolî interi, dimisura mi nima, i quali dovevano fornire una buona risposta ai due scolî di
Il devcesqai ta; skovlia in Aristoph. Vesp. 1208-1250 257
41 Sono preventivamente considerati tali in v. 1222.42 Per il Clitagora (912b P.), comunque, non è improbabile che quanto attestato da Vesp. 1245-
1247 sia uno scolio integro.43 Così già Vetta 1983, p. 129.44 È noto che l’incipit può assolvere alle funzioni del titolo. Cf. del resto Ach. 1093, dove
l’Armodio viene citato in una delle sue versioni (894 P. = 11 Fabbro) neppure con l’incipit, ma conla sola sezione iniziale del primo verso (fivltaq∆ ÔArmovdi∆ ouj), ovvero con le prime tre parole,sintatticamente non collegate ma costituenti un preciso colon (hemiascl I), adattabile al trimetro.
45 Tale deduzione deriva dal fatto che la risposta al secondo intervento di Bdelicleone è unfalecio (v. 1248), il quale verso, come già si è detto, può costituire l’incipit di uno scolio struttu-rato secondo la “strofetta attica”.
copia autore
proposta intesi nella loro interezza46, e forse, proprio per la scarsa estensio-ne, ri sul tavano ancora più efficaci come repliche dei due incipit.
Il meccanismo comico è lo stesso in tutti e tre i casi, ma a mio avviso lapoin te non è determinata solo dall’ ojnomasti; kwmw/dei'n. Consideriamo, adesem pio, le due risposte di Filocleone nella prima prova, le quali sono deipa lesi attacchi nominali a Cleone, gratificato dei peggiori epiteti e identifica-to nella rovina della città. Tali risposte, però, sono comunque delle replicheal l’Armodio, e proprio il loro riferimento a Cleone suggerisce, a posteriori, chean che lo scolio di proposta debba riferirsi al medesimo personaggio. Il teno-re delle risposte, denigratorio di Cleone, suggerisce cioè che la (mancata) re -ci tazione dell’Armodio sottintendesse una presenza nell’esecutore Cleonedel le stesse eroiche attitudini di Armodio (Cleone è come Armodio); ma Fi -lo cleone chiarisce subito, con due diversi carmi, che le attitudini del dema -go go sono ben altre. Il gioco comico, dunque, non risiederebbe soltanto nel -l’at tacco ad personam, ma anche nel capovolgimento di quanto implicitamen-te suggerito dalla proposta.
Lo stesso meccanismo vale anche per la seguente prova di vv. 1236-1241.Bde licleone suppone che Teoro canti (v. 1238)
∆Admhvtou lovgon, wjtai're, maqw;n tou;" ajgaqou;" fivlei,
cioè il celebre scolio chiamato Admeto, che come noi sappiamo bene si com -po neva di due versi e aveva appunto quell’inizio47. Filocleone in rispostaese guirà un altro scolio (v. 1240 s.)
oujk e[stin ajlwpekivzein,oujd∆ ajmfotevroisi givgnesqai fivlon,
de terminando un attacco a Teoro, ma anche un rovesciamento dello scolio diproposta: alla conoscenza di qualcosa di tessalico che deve garantire l’amici-zia degli ajgaqoiv, oggetto dell’incipit eseguito da Teoro, e in generale del l’Ad -me to, viene opposto un carme che invita a non far troppo la volpe e ad ac -con tentarsi dell’amicizia dei kakoiv48.
258 G. Colesanti
46 Così, per i soli vv. 1238 s. e 1241 s., già Engelbrecht 1882, p. 66 («Theorus totum scoliumcantans fingitur, ad quod Philocleo alio scolio respondet») con n. 34 («Quamquam enim pri-mum tantum versum [Theorus] recitat, tamen totum scolium cantasse fingas oportet, quod nonad primum versum, sed ad totius scolii sententiam respondet Philocleo»).
47 897 P. = 14 Fabbro ∆Admhvtou lovgon, w\‿eJtai're, maqw;n tou;" ajgaqou;" fivlei, /tw'n deilw'n d∆ajpevcou, gnou;" o{ti deiloi'" ojlivgh cavri".
48 Tenendo presente che nell’Admeto si parla di ajgaqoiv e kakoiv, gli ajmfovteroi di v. 1241 nonpossono essere che queste due categorie polari. Poiché chi recita l’Admeto, secondo uno dei topoidella precettistica simposiale, invita a frequentare solo gli ajgaqoiv, lo scolio di risposta, con l’ac-cenno all’ ajlwpekivzein e l’invito a non essere amico dei buoni e dei cattivi, lascia sottintendere
copia autore
Nella terza prova, infine, Bdelicleone dichiara che Eschine eseguirà (vv.1245-1247)
crhvmata kai; bivon Kleitagovra/ te kajmoi; meta; Qettavlwn
cioè il ben noto scolio chiamato Clitagora che presumibilmente iniziava conquel verso (3hemiascl II); Filocleone mostra allora che in risposta reciterà unaltro scolio
polla; dh; diekovmpasa" su; kajgwv
limitato ad un falecio. Ma così facendo si attua automaticamente una corri-spondenza tra i due carmi, poiché con il suo verso («le hai dette grosse, tu, ean ch’io») Filocleone non solo attacca Eschine49, ma suggerisce anche la se -guen te interpretazione dell’innocente inizio del Clitagora: «ricchezze e beniper Clitagora e per me (= Eschine), insieme ai Tessali».
Nel caso della disposizione dei convitati e dell’assegnazione di v. 1226 èsta ta la conoscenza delle usanze simposiali che ci ha permesso di megliocom prendere la scena aristofanea; ma anche il testo delle Vespe può, a suavol ta, illuminarci su una particolarità delle recitazioni simposiali della finedel V secolo. È stato già evidenziato50 che i vv. 1222-1248 confermano piena -men te quanto possiamo ricostruire delle performances simposiali, come ilriuso, con conseguenti varianti involontarie o volute, di brani di celebri au -to ri (nel nostro caso i due alcmani di Alceo), e il ricorso all’improvvisazione(nel le nostre tre prove per tre delle quattro risposte51, le quali palesemente sifin gono improvvisate in quanto perfettamente aderenti al contesto); a questedue caratteristiche, anzi, possiamo unire il rapporto tematico tra proposta eri sposta (di opposizione e non di consenso nella scena delle Vespe, poiché leri sposte correggono le proposte).
Ma c’è ancora un elemento che possiamo considerare: la specularità me -tri ca. Nella prima risposta di Filocleone questo fatto viene rispettato, perchéi vv. 1226-1227 accennano ad una risposta metricamente parallela allo sche-ma strofico dell’Armodio che Bdelicleone afferma di cantare in persona Cleo -nis. Ma già con la replica alternativa di vv. 1232-1237 la contiguità metrica èin franta, poiché i due alcmani dello scolio di derivazione alcaica non sonocom patibili, dal punto di vista metrico, con la “strofetta attica” dell’Armodio.
Il devcesqai ta; skovlia in Aristoph. Vesp. 1208-1250 259
nello scolio di proposta un’assimilazione di Teoro agli ajgaqoiv, e al contempo sottolinea checostui, al contrario, non è altro che un kakov".
49 Lo schol. ad loc. giustifica l’attacco osservando che Eschine era kompasthv"; ma la notiziaappare autoschediastica.
50 Vetta 1983, p. 122.51 Vv. 1226 s., 1241 s., 1248. Nelle reali esecuzioni, naturalmente, era anche possibile che si
improvvisassero le proposte, e che per le risposte ci si ispirasse a celebri pezzi di lirica.
copia autore
Lo stesso avviene anche negli altri due casi, di “botta e risposta”, dove ladif formità metrica è evidente (Ascl e 2^hipp + cr, 3hemiascl II e phal).
Ma questa particolarità si può osservare anche in altri casi. Quando Bde -li cleone, per la seconda prova cui sottopone il padre, ipotizza la successioneCleo ne-Teoro-Filocleone etc., conseguentemente dà per scontato che l’Ad me -to di Teoro risponda all’Armodio di Cleone, il che è del tutto plausibile dalpun to di vista tematico52, ma doveva comportare, nelle reali esecuzioni sim -po siali, un passaggio metrico-musicale ben percepibile53. Analogamente nel -la terza prova, con la successione Cleone-Teoro-Eschine-Filocleone etc., Ari -sto fane afferma esplicitamente che Eschine, posizionato dopo Teoro, riceve(cf. v. 1243 devxetai) lo scolio di costui, cioè l’Admeto, e gli risponde con il Cli -ta gora, tematicamente affine54 ma diverso dal punto di vista metrico-musica-le55. E in tutti i casi di “rispondenza”, tra le singole proposte di Bdelicleonema soprattutto tra le proposte di Bdelicleone e le risposte di Filocleone, nonera impossibile che il pubblico avvertisse, oltre alla differenza metrica, an -che la diversità di esecuzione musicale tra scolio e scolio, se la aujlhtriv" cuisi accenna in v. 1219 era effettivamente presente e operante sulla scena56.
Nelle recitazioni simposiali in cui vari carmi, eseguiti ognuno da un di ver -so convitato, si succedevano l’un l’altro, l’effetto migliore si doveva averequan do un carme si collegava al precedente, in particolare a livello tematico(per opposizione o consenso), ma poi anche per ripresa di termini o espressionisignificative, per specularità metrica e per simmetria d’ampiezza. Sen non chérispettare tutte queste condizioni, per quanto non fosse certo di estre ma dif -ficoltà, non doveva essere neppure troppo semplice, e possiamo pen sare, an zi,che nell’estemporaneità dell’esecuzione una certa libertà fosse am messa e tolle-rata nelle risposte. Il punto fondamentale, nel caso di coppie o catene sim -posiali, era senza dubbio la vicinanza di argomento, cioè il rap por to tematico,cui poteva unirsi, ma non necessariamente, la ripresa di ter mi ni; ma già si ènotato, ad esempio, che la simmetria d’ampiezza tra proposta e risposta po te vaessere, almeno parzialmente, non vincolante per la riu sci ta del gioco poe ti co57.
260 G. Colesanti
52 Proprio la scena delle Vespe suggerisce che entrambi gli scolî, come anche il Clitagora, dovesse-ro essere cantati, intorno al 422 a. C., nei simposi democratico-radicali, perché potevano alludere aisuc cessi politici della fazione cleoniana (vd. per tutto questo Vetta 1983, pp. 124-128). L’Admeto diTeo ro fornirebbe dunque una risposta di consenso, a livello tematico, rispetto all’Armodio di Cleo ne.
53 Cf. al riguardo Aristoph. fr. 444 K.-A. oJ me;n h\/den ∆Admhvtou lovgon pro;" murrivnhn / oJ d∆aujto;n hjnagkavzen ÔArmodivou mevlo", dove l’opposizione tra i due scolî non è di tipo politico, mamusicale (Vetta 1983, p. 155 n. 46).
54 Oltre a una connotazione politica democratico-radicale, che, come già detto, avevano incomune all’epoca delle Vespe, l’Admeto e il Clitagora sono apparentati da un medesimo riferi-mento tessalico (il lovgo" di Admeto, mitico re della Tessaglia; i Tessali).
55 Cf. Cratin. fr. 254 K.-A. Kleitagovra" a[/dein, o{tan ∆Admhvtou mevlo" aujlh'/.56 Era già una buona idea di MacDowell 1971, p. 292.57 Vd. Colesanti 1998, p. 220, con le nn. 52 e 53.
copia autore
Come la coincidenza d’ampiezza, anche l’identità metrica doveva essereun forte elemento di contiguità tra i diversi interventi, e poteva risultarescon tata se in una riunione si decideva di recitare solo e soltanto esametri odi s tici o giambi o trochei; ma nel caso dei cosiddetti “scolî attici” (come ades. quelli di 888-908 P. = 5-25 Fabbro), in metri eolici diversi, la scena delleVe spe ci mostra chiaramente che, almeno nei simposî ateniesi intorno al 422a. C., t r a d u e o p i ù c a r m i i n r a p p o r t o t r a l o r o l as p e c u l a r i t à m e t r i c a p o t e v a a n c h e n o n e s s e r eo s s e r v a t a58. Non è certo casuale che con la prima risposta di Filocleone(v. 1226 s.) Aristofane abbia opposto all’Armodio taciuto di Cleone un carmeche si annunciava metricamente coincidente: all’inizio del finto simposio havoluto presentare la situazione più classica, e di migliore effetto, ma già conla seconda risposta all’Armodio ha pensato di poter fare a meno dell’identitàme trica, seguendo quella che, nei simposî ateniesi di quel periodo, pur nonpo tendo essere la regola non doveva essere però neppure l’eccezione. E que-sto è forse il contributo simposiale più interessante che oggi la scena delleVe spe ci può offrire.
BIBLIOGRAFIA
I. Bekker, Aristophanis comoediae, I-II, Londinii 1829Th. Bergk, Aristophanis comoediae, I, Lipsiae 18772
F. H. M. Blaydes, Aristophanis Vespae, Halis Saxonum 1893C. M. Bowra, La lirica greca da Alcmane a Simonide, tr. it. Firenze 1973 (Oxford 19612)R. P. Ph. Brunck, Aristophanis comoediae, II, Argentorati 1783F. Cannatà, Problemi di mistione dialettale nei Carmina convivalia. A proposito dei carmi
903, 904, 905 Page, «SemRom» 2, 1999, pp. 1-27G. Colesanti, Rec. E. Fabbro, Carmina convivalia Attica, «RFIC» 125, 1997, pp. 439-445G. Colesanti, Un agone simposiale in Theogn. 1003-1022, «SemRom» 1, 1998, pp. 207-229V. Coulon, Aristophane, II, Les Guêpes - La Paix, trad. par H. van Daele, Paris 1928W. Dindorf, Aristophanis comoediae et deperditarum fragmenta, Parisiis 1877P. P. Dobree, Adversaria. Edente Jacobo Scholefield, Cantabrigiae, I, 1831; II, 1833K. J. Dover, Plato. Symposium, Cambridge 1980
Il devcesqai ta; skovlia in Aristoph. Vesp. 1208-1250 261
58 Nella raccolta degli scolî attici tràdita da Athen. 15. 694c-695f un caso del genere può essere907/908 P. = 24/25 Fabbro (“strofetta attica”/2AscI). Il primo carme è il celebre Lipsidrio, edesordisce nel primo verso con il lamento aijai' Leiyuvdrion prodwsevtairon, mentre il secondo,sempre nel primo verso, elogia chi mh; prodivdwsin l’amico; 908 P. può dunque collegarsi inmodo accettabile a 907 in virtù dell’accenno al “tradimento”. I due carmi sono al di fuori dellestrisce di scolî metricamente uguali (884-890 e i quattro Armodi di 893-896 in “strofetta”, 902-905in 2Ascl), e la loro vicinanza nella raccolta sembrerebbe dipendere proprio da quel collegamen-to; in un primo momento ho imputato tale contiguità al compilatore del Kommersbuch(Colesanti 1997, p. 442), ma ora penso che possa anche trattarsi della registrazione di un’effetti-va coppia simposiale, in spregio all’identità metrica.
copia autore
V. Ehrenberg, Das Harmodioslied, «WS» 69, 1956, pp. 57-69 (= Polis und Imperium,Zürich - Stuttgart 1965, pp. 253-264)
A. G. Engelbrecht, De scoliorum poesi, Diss. Vindobonae 1882E. Fabbro, Carmina convivalia Attica, Romae 1995F. Ferrari, Teognide. Elegie, Milano 1989G. Lambin, La chanson grecque dans l’antiquité, Paris 1992J. van Leeuwen, Aristophanis Vespae, Lugduni Batavorum 19092
D. Loscalzo, Lo scudo di Archiloco (fr. 5 West = 8 Tarditi), «RCCM» 39, 1997, pp. 7-18D. M. MacDowell, Aristophanes. Wasps, Oxford 1971G. Mastromarco, Commedie di Aristofane, I, Torino 1983A. Meineke, Aristophanis comoediae, I, Lipsiae 1860S. D. Olson, Aristophanes. Peace, Oxford 1998M. Platnauer, Aristophanes. Peace, Oxford 1964R. Pretagostini, L’esametro nel dramma attico del V secolo: problemi di ‘resa’ e di ‘riconosci-
mento’, in M. Fantuzzi - R. Pretagostini (curr.), Struttura e storia dell’esametro ome-rico, I, Roma 1995, pp. 163-191
R. Reitzenstein, Epigramm und Skolion, Giessen 1893B. B. Rogers, The Comedies of Aristophanes, II, III. The Clouds, IV. The Wasps, London
1916L. E. Rossi, Lirica arcaica e scoli simposiali (Alc. 249, 6-9 V. e carm. conv. 891 P.), in R.
Pretagostini (cur.), Tradizione e innovazione nella cultura greca. Da Omero all’età elle-nistica. Scritti in onore di Bruno Gentili, I, Roma 1993, pp. 237-246
A. Severyns, Proclos et la chanson de table, in AA.VV., Mélanges Bidez, II, Bruxelles1934, pp. 835-856
A. H. Sommerstein, The Comedies of Aristophanes, IV, Wasps, Warminster 1983 (repr.1996 with corr.)
W. J. M. Starkie, The Wasps of Aristophanes, London 1897M. van der Valk, On the Composition of the Attic Skolia, «Hermes» 102, 1974, pp. 1-20M. Vetta, Theognis. Elegiarum liber secundus, Romae 1980M. Vetta, Un capitolo di storia simposiale. (Per l’esegesi di Aristofane, «Vespe» 1222-1248),
in M. Vetta (cur.), Poesia e simposio nella Grecia antica, Roma - Bari 1983, pp. 117-131 (testo) e 149-155 (note)
M. Vetta, Identificazione di un caso di catena simposiale nel corpus teognideo, in AA.VV.,Lirica greca da Archiloco ad Elitis. Studi in onore di Filippo Maria Pontani, Padova1984, pp. 113-126
M. Vetta, Aristofane. Le Donne all’assemblea, tr. D. Del Corno, Milano 1989M. L. West, Studies in Greek Elegy and Iambus, Berlin - New York 1974
Roma
262 G. Colesanti
copia autore


























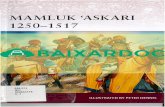

![[MI 611-262] Model 876PH Intelligent Transmitter for pH, ORP ...](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631f303d13819e2fbb0f9fb1/mi-611-262-model-876ph-intelligent-transmitter-for-ph-orp-.jpg)






![Hemjum Pty Ltd v Osachy [2019] QSC 262](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631be52eb8a98572c10ca7ee/hemjum-pty-ltd-v-osachy-2019-qsc-262.jpg)







