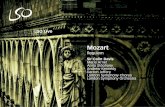Una Messa e l'Infinito. Appunti sul Requiem di Mozart e sulla concezione religiosa del suo autore
I viaggi in Italia di Mozart tra realtà e finzione, in Il personaggio di Mozart nella letteratura...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of I viaggi in Italia di Mozart tra realtà e finzione, in Il personaggio di Mozart nella letteratura...
Il personaggio di Mozart nella letteratura d’invenzione
Atti del convegno Verona, Accademia Filarmonica
4-5 dicembre 2007
a cura di Simona Cappellari Cristina Cappelletti
QuiEdit
Volume pubblicato con il contributo del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica
dell’Università di Verona
Copyright© by QuiEdit s.n.c.
Via S. Francesco, 7 - 37129 Verona, Italy www.quiedit.it
e-mail: [email protected] Edizione I Anno 2011
ISBN: 978-88-6464-140-9 Finito di stampare nel mese di dicembre 2011
da QuiEdit s.n.c. La riproduzione per uso personale, conformemente alla conven-zione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artisti-che, è consentita esclusivamente nei limiti del 15%.
147
CRISTINA CAPPELLETTI
I VIAGGI IN ITALIA DI MOZART TRA REALTÀ E FINZIONE
Certo l’andar qua e là peregrinando Ell’è piacevol molto ed util arte; Pur ch’a piè non si vada ed accattando. Vi s’impara più assai che in su le carte, Non dirò se a stimare o spregiar l’uomo. Ma a conoscer se stesso e gli altri in parte.1
Il personaggio di Mozart nella letteratura italiana d’invenzione ha una fortuna piuttosto tarda. Se escludiamo la pièce teatrale di Eugenio Checchi del 1879, Mozart fanciullo, la presenza del compositore salisbur-ghese in qualità di attante nelle opere romanzesche è quasi nulla sino agli anni ’90 del Novecento. Con l’approssimarsi del bicentenario della nasci-ta (1991), la letteratura d’invenzione ha scoperto le potenzialità di Mozart in qualità di persona della fabula narrativa, a partire dal racconto di Laura Mancinelli, Amadé. Mozart a Torino.2 Un notevole incremento di racconti e romanzi che vedono come protagonista il genio salisburghese si è poi verificato a partire dal 2004, con l’avvicinarsi di un altro anniversario, i 250 anni della nascita.
Questi scritti “d’occasione” sono, nella loro quasi totalità, testi lette-rari di consumo. Occupandomi di romanzi del Settecento, la più parte dei quali si può ascrivere appunto a questo genere di letteratura, mi piace spesso ricordare come il lettore moderno, analizzando le opere – per esempio – dell’abate bresciano Pietro Chiari, abbia l’impressione che un rilegatore maldestro abbia cucito insieme fascicoli diversi presi a caso dai
1 VITTORIO ALFIERI, Satira nona. I viaggi, in ID., Scritti politici e morali, vol. III, a cura di Cle-mente Mazzotta, Asti, Casa d’Alfieri, 1984 (Opere di VITTORIO ALFIERI da Asti, 5), p. 128. Nel licenziare il presente articolo, mi è caro ringraziare Gian Paolo Marchi, lettore pa-ziente e largo di consigli, e Carlo Annoni, con il quale ho il piacere di intavolare sovente conversazioni musical-letterarie. 2 In merito ai racconti mozartiani di Laura Mancinelli si veda in questo stesso volume il contributo di Corrado Viola, al quale sono riconoscente per gli utili confronti avuti sull’argomento.
CRISTINA CAPPELLETTI
148
romanzi più famosi di Richardson, Fielding, Prevost, Marivaux; e di con-seguenza ritrova episodi analoghi in quasi tutti i romanzi, che si ripetono di volta in volta con ordine diverso. In maniera non dissimile, analizzan-do molta della letteratura mozartiana d’invenzione più recente, si avverte spesso la sensazione di essere di fronte al già detto o al già noto, poiché il ricco epistolario, particolarmente dettagliato per quel che concerne i viaggi, è fonte primaria di tutte le narrazioni. Le lettere di Wolfgang o del padre Leopold entrano nella narrazione come citazione, come traduzio-ne, come parafrasi, imprimendo così una nota di serialità a molta lettera-tura mozartiana.
Non è infatti un caso che tra le opere con maggiori spunti di origi-nalità figuri il racconto, citato poco fa, di Laura Mancinelli, Amadè. Mo-zart a Torino. Sul soggiorno piemontese del giovane compositore e del padre, infatti, le notizie sono assai scarse; i due musicisti arrivarono nella capitale sabauda il 14 gennaio 1771 e ripartirono il 30 dello stesso mese. In una lettera scritta da Milano il 12 gennaio, Leopold dichiara come imminente la partenza: «andremo a Torino lunedì prossimo»;3 poi la cor-rispondenza si interrompe sino al 2 febbraio, quando padre e figlio sono già tornati a Milano. Nella missiva si legge: «tu per due giorni di posta non avrai visto nulla da parte mia, ma avrai anche immaginato che non abbiamo potuto scrivere a causa del viaggio a Torino. Il 31 gennaio sia-mo felicemente ritornati da questa bella città, dove abbiamo visto un’opera davvero magnifica».4 La mancanza di dettagli precisi sul soggior-no dei Mozart nella capitale sabauda ha permesso all’autrice moderna, e a quanti dopo di lei si sono dedicati al medesimo argomento, di lasciare largo spazio all’invenzione romanzesca; cosa che – per uno strano prin-cipio di verosimiglianza – spesso viene meno in scrittori che si occupano di viaggi e soggiorni corredati da una più fitta documentazione.
La presenza, anzi la citazione, di testimonianze reali quali sono le lettere dell’epistolario, potrebbe spingere il lettore a credere di trovarsi di
3 ALBERTO BASSO, I Mozart in Italia. Cronistoria dei viaggi, documenti, lettere, dizionario dei luoghi e delle persone, Roma, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, 2006, p. 241. 4 Ibi, p. 242. L’opera di cui si fa menzione è l’Annibale in Torino di Giovanni Paisiello, messa in scena per la prima volta al Teatro Regio di Torino il 16 gennaio. Sulla presenza di Mozart a Torino si vedano almeno i contributi di STEFANO AJANI, Presenze mozartiane a duecento anni dalla sua venuta a Torino, «Musicalbrandé», n. 49 (marzo 1971), pp. non nume-rate; RITA PEIRETTI, «Mitridate re del Ponto». Storia di un prestito, «Diastema rivista di cultura e informazione musicale», 7 (1994), pp. 55-56; ALBERTO RIZZUTI, I Mozart a Torino, in ID., «Annibale in Torino»: una storia spettacolare, Torino, EDT, [2006], pp. 23-26.
I viaggi in Italia di Mozart tra realtà e finzione
149
fronte a romanzi e racconti storici. Al riguardo, credo non sia fuori luogo cominciare da molto lontano, riprendendo in parte l’articolo polemico Del romanzo in generale, ed anche dei Promessi sposi, apparso sul numero di ottobre del 1827 della «Biblioteca italiana» in forma anonima, ma dovuto alla penna di Paride Zajotti. L’autore prendeva posizione sul primo ro-manzo storico della nostra letteratura e sul genere tout court.5 Secondo la definizione che in esso si profila, anche la narrativa che vede Mozart co-me protagonista potrebbe essere ascritta al genere del romanzo storico. Si legge infatti che: «Romanzo storico è propriamente quello in cui per-sonaggi già celebri nella storia sono argomento della narrazione, e questa va mischiando i privati avvenimenti ai pubblici casi».6 Il romanziere scozzese Walter Scott aveva dato e continuava a dare molti esempi di tal genere (Waverley, Woodstock, Puritani, l’Abate, e Quintino Durward), ma – nonostante la fortuna di detti romanzi – era da biasimare, secondo scrive il pubblicista milanese, la prassi di creare una mescidanza del vero e del falso, modus scribendi pericoloso, perché il riproporre in chiave romanzesca personaggi e avvenimenti storici, ingenerava confusione nel lettore, de-formando la stessa realtà storica. Infatti, scriveva lo Zajotti, «tutti i casi o pubblici o privati, quando vennero una volta alla cognizione universale degli uomini, debbono essere sottratti per sempre all’arbitrio della finzio-ne: la verità li raccolse per suoi».7 La critica mossa non era tanto contro il romanzo storico d’impianto manzoniano, anche perché la storia di «gen-te meccaniche e di piccol affare» veniva catalogata dall’articolista come «romanzo descrittivo»; il bersaglio polemico era piuttosto costituito dalle biografie romanzate, in cui la commistione di vero e verosimile era mag-giore.
Il rischio prospettato dallo Zajotti, quello cioè di restituire al lettore di romanzi storici una visione distorta dei personaggi celebri messi in 5 [PARIDE ZAJOTTI], Del romanzo in generale, ed anche dei Promessi sposi, romanzo di Alessan-dro Manzoni, «Biblioteca italiana», XLVII-XLVIII (settembre e ottobre 1827), pp. 322-372 e 32-81. Sull’intervento dello Zajotti, e sulle reazioni suscitate dalla pubblicazione della Ventisettana, si sofferma FABIO DANELON nel suo saggio Il dibattito sul romanzo storico in Italia. Tre documenti [Introduzione all’Appendice. Interventi sul romanzo storico di Zajotti, Tommaseo e Scalvini], in ALESSANDRO MANZONI, Del romanzo storico e, in genere, de’ componimenti misti di storia e d’invenzione, premessa di Giovanni Macchia, introduzione di Folco Portinari, testo a cura di Silvia De Laude, Edizione Nazionale ed Europea degli scritti di Alessandro Man-zoni, vol. XIV, Milano, Centro Nazionale di Studi Manzoniani, 2000, pp. 111-140 (da cui sono tratte le citazioni a testo). 6 Ibi, p. 167. 7 Ibi, p. 177.
CRISTINA CAPPELLETTI
150
scena, è esattamente quanto occorso a Mozart, almeno nel corpus di opere che sono state oggetto della presente indagine. Si assiste in questo senso a due diversi fenomeni: da un lato le pseudo-biografie romanzesche ten-dono ad assumere la morfologia del saggio documentario; e contrario, la saggistica mozartiana si abbandona sovente a digressioni aneddotiche che in parte sembrano inficiare lo statuto di scientificità del genere stesso. Caso emblematico in questo senso è il libretto di Armando Torno, Mo-zart a Milano. Un racconto, un saggio,8 dove la ricostruzione storica del sog-giorno milanese di Mozart, per ammissione dello stesso autore, non ha una documentazione rigorosamente scientifica; e quindi – accanto al rac-conto d’invenzione propriamente detto – abbiamo un saggio che raccon-ta artisticamente il soggiorno milanese di Mozart, appoggiandosi alla bi-bliografia esistente, non senza concedersi escursioni nel territorio del ve-rosimile.
Tali ibridi saggistico-letterari non sono però il principale oggetto dello studio qui presentato. Ciò che ci si è invece prefissi di fare, inizian-do le ricerche mozartiane, è stato di verificare che cosa avessero rappre-sentato dal punto di vista narrativo i viaggi in Italia del compositore. La bibliografia critica ad essi relativa è abbastanza cospicua, come dimostra l’enciclopedico volume – enciclopedico almeno per quanto concerne le dimensioni – di Alberto Basso, I Mozart in Italia;9 e non esiste città, in cui il salisburghese abbia soggiornato, che non dedichi contributi monografi-ci all’argomento.10 8 ARMANDO TORNO, Mozart a Milano. Un racconto, un saggio, Milano, La Vita Felice, 1996; il capitolo “saggistico” è poi stato riproposto nel volume Mozart a Milano, Milano, Monda-dori, 2004. 9 Alberto Basso è tra gli ultimi studiosi, almeno in ordine di tempo, a dedicare le proprie ricerche ai soggiorni italiani del compositore salisburghese. Senza voler qui richiamare tutta la bibliografia critica ad essi relativa, mi limito a ricordare, oltre al già citato studio di Basso, almeno i seguenti contributi: ANDREA OSTOJA, Mozart e l’Italia: contributo biografico nel bicentenario della nascita, Bologna, Tip. L. Parma, 1955; GUGLIELMO BARBLAN, Mozart in Italia: i viaggi, con Lettere, a cura di Andrea della Corte, Milano, Ricordi, 1956; Colloquium «Mozart und Italien», Roma 1974, Bericht herausgegeben von Friedrich Lippmann, Köln, Arno Volk, 1978; Delitiae Italiae. I viaggi di Mozart in Italia, a cura di Rudolph Anger-mueller, con la collaborazione di Geneviève Geffray, traduzione di Martha Canestrini, Verona, Associazione Mozart Italia, 1995; IWO ZALUSKI - PAMELA ZALUSKI, Mozart in Italy, London, Chester Springs, 1999. 10 Alle già menzionate monografie su Torino, e a quelle che andremo via via citando, si possono affiancare almeno i saggi sul soggiorno veneto di PAOLO CATTELAN, Mozart. Un mese a Venezia, Venezia, Marsilio, 2000, e quelli inclusi nel recente volume Sig.r Amadeo Wolfgango Mozart. A Verona con Mozart. Personaggi, luoghi, accadimenti, a cura di Giuseppe
I viaggi in Italia di Mozart tra realtà e finzione
151
È forse propedeutico a quanto si andrà dicendo ripercorrere in bre-ve la cronistoria dei viaggi italiani di Mozart. Cade il 13 dicembre del 1769, allorché il tredicenne Mozart intraprende con il padre un primo viaggio in Italia, durante il quale fa tappa nelle principali città della peni-sola (nell’ordine: Verona, Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli); il soggiorno si protrae per oltre un anno, sino al marzo 1771. Pochi mesi più tardi, in agosto, i due viaggiatori ripercorrono strade già note verso Milano, per sovrintendere all’allestimento dell’Ascanio in Alba, musicato dal giovane austriaco su libretto di Giuseppe Parini. Il rientro prevede soste a Brescia, e nelle già note città di Verona, Rovereto e Trento. Risale invece all’ottobre del 1772 l’ultimo soggiorno italiano dei Mozart, sempre padre e figlio, che riprendono la via di Milano in occasione dell’allesti-mento del Lucio Silla, su libretto di Giovanni de Gamerra, rivisto poi da Metastasio.
Mozart visita la nostra penisola tre volte, ma in realtà quasi solo il suo primo viaggio, risalente agli anni in cui era ormai al limitare della sua infanzia prodigiosa, ha ispirato la letteratura d’invenzione. Il musicologo Piero Rattalino è tra i pochi a cimentarsi nella ricostruzione del travel book in maniera organica e sistematica. Questo autore, infatti, si prodiga nella
Ferrari e Mario Ruffini, Venezia, Marsilio, 2007. Sulla presenza di Mozart a Napoli, si vedano invece: Mozart a Napoli nelle lettere di Wolfgang e Leopold, a cura di Pasquale Scialo, traduzioni di Valeria Bazzicalupo ed Enrico Zummo, Napoli, Guida, 1991, e DOMENICO
ANTONIO D’ALESSANDRO, I Mozart nella Napoli di Hamilton. Due quadri di Fabris per Lord Fortrose, presentazione di Marita Petzoldt McClymonds e Donatella Trotta, Napoli, Gri-maldi, 2006. Al soggiorno bolognese sono dedicati, tra gli altri, due recenti contributi: L’idillio di Amadeus: musica, arte e società a Bologna attorno alla luminosa permanenza di Mozart nel 1770, a cura di Piero Mioli, premesse di Virginiangelo Marabini e Carmine Carrisi, Bolo-gna, Forni, 2008, e Un anno per tre filarmonici di rango: Perti, Martini e Mozart. Un principe, un “definitore” e un fuoriclasse da celebrare nel 2006, Atti del convegno, Bologna, Accademia Fi-larmonica, 3-4 novembre 2006, a cura di Piero Mioli, Bologna, Pàtron, 2008. Ai soggiorni nelle singole città o regioni italiane del compositore salisburghese sono state dedicate an-che mostre, i cui cataloghi propongono saggi e documenti di indubbia utilità; si possono ricordare almeno i volumi: Mozart in Lombardia. Catalogo della mostra, Cremona, ridotto del teatro Ponchielli, 20 ottobre-18 novembre 1990, a cura di Elia Santoro, Laura Pietranto-ni, Roberto Fiorentini, Cremona, Pizzorni, 1990; Mozart a Firenze: …qui si dovrebbe vivere e morire, Mostra bibliografica e catalogo a cura di Paola Gibbin, Lucia Chimirri, Mariella Migliorini Mazzini, Firenze, Vallecchi, 2006; Mozart. Note di viaggio in chiave di violino, Cata-logo della mostra, Riva del Garda-Bolzano, 2006, a cura di Marina Botteri Ottaviani, An-tonio Carlini, Giacomo Fornari, Provincia autonoma di Trento, Soprintendenza per i Be-ni storico-artistici, Comune di Riva del Garda, 2006. Il novero, però, è ben lungi dall’essere esaustivo.
CRISTINA CAPPELLETTI
152
stesura di una Vita di Wolfango Amadeo Mozart scritta da lui medesimo, ri-prendendo la forma pseudo-autobiografica di impianto vagamente sette-centesco, che richiede una precisa, e cronologicamente ordinata, rievoca-zione dei fatti (non penso tanto alla felice stagione della memorialistica di Alfieri, Goldoni, Casanova e Da Ponte, quanto piuttosto ai molti roman-zi inglesi e francesi e solo più tardi anche italiani).11 L’importanza del soggiorno italiano di Amadé viene icasticamente riassunta nelle parole di Paisiello, che nel romanzo così sancisce: «è ancora troppo giovane», na-turalmente per dedicarsi all’opera, «vada in Italia e diventi celebre».12 Vengono poi rievocati e mescolati, come in quasi tutta la narrativa di viaggio mozartiana, aneddoti ed episodi reali, che costituiscono quasi un repertorio cui attinge sovente la narrativa d’invenzione che vede prota-gonista il compositore. Mi riferisco in particolare alla trascrizione del Mi-serere di Allegri a Roma, che per ordine papale nessuno, pena la scomuni-ca, doveva permettersi di stendere per iscritto; e all’episodio parimenti celebre dell’anello, sfoggiato da Mozart durante una esibizione a Napoli, che gli astanti vollero si togliesse, perché suggestionati dall’idea che pos-sedesse facoltà magiche, e fosse in realtà la causa della smisurata bravura del piccolo salisburghese.
Il vecchio Mozart che rievoca le vicende della propria vita pensa sempre con certo rammarico all’Italia, che rimane il miraggio di una po-sizione economicamente stabile e artisticamente appagante. Così sospira l’artista ritratto da Rattalino: «l’Italia contribuì in misura molto significa-tiva a farmi capire il teatro e i suoi segreti. […] A volte mi chiedo che co-sa sarebbe stato di me se fossi rimasto in Italia e se avessi poi avuto una vita come quella di Hasse».13
Condivide la scansione cronologica della biografia rattaliniana, ma con eccessivo schematismo, il volumetto In viaggio con Wolfi, di Angelo Corioni,14 già autore di romanzi per ragazzi, che – pur non volendo pub-
11 Non tutte le città, però, hanno il medesimo rilievo: Venezia, e il mese che Mozart vi trascorse nel periodo di carnevale del 1771, occupa larga parte della narrazione; del resto l’accuratissimo e ben documentato saggio di PAOLO CATTELAN, Mozart. Un mese a Vene-zia, cit., ricostruisce sia le vicende poco note del giovane salisburghese nella Serenissima, sia l’ambiente musicale con cui egli venne a contatto. 12 PIERO RATTALINO, Vita di Wolfango Amadeo Mozart scritta da lui medesimo, Milano, Il Sag-giatore, 2005, p. 55. 13 Ibi, p. 142-145. 14 ANGELO CORIONI, In viaggio con Wolfi. La meravigliosa avventura giovanile di Wolfgang Ama-deus Mozart, Firenze, Nicomp letture (Nicomp Laboratorio Editoriale), 2006.
I viaggi in Italia di Mozart tra realtà e finzione
153
blicare un’opera rivolta al pubblico dei soli adolescenti – finisce in realtà con il ricostruire, in maniera anche troppo scolastica ed elementare, il soggiorno italiano del quattordicenne Mozart.
Più originale è invece lo spunto narrativo di Italo Moscati, sceneg-giatore televisivo prestato alla narrativa, che usa il viaggio in Italia del giovane compositore come incipit del suo romanzo I piccoli Mozart.15 È il maggio del 1770, «Nannerl è alla finestra. In mano, ha la lettera del fratel-lo» che le scrive, come accade di solito, per narrare le proprie esperienze in un luogo nuovo, e per avere informazioni di chi è rimasto, ma «La let-tera le ha rovesciato addosso in poche righe i recenti ricordi che fanno male. A diciannove anni è rimasta lì, sola, tra quattro mura a sognare».16
La prima tournée, durante la quale i piccoli musicisti non possono esibirsi insieme, provoca – in effetti – una frattura nei loro rapporti. La partenza di Wolferl con il padre sancisce la sua consacrazione alla musi-ca, a scapito della carriera della sorella: il viaggio negato alla piccola don-na rappresenta al tempo stesso la fine di un sodalizio artistico e l’irrimediabile distruzione di un sogno, visitare un paese lungamente va-gheggiato, sì, ma soprattutto diventare una grande concertista:
Poi, all’improvviso, con l’effetto di una valanga, la partenza di Wolfi per l’Italia, mesi di lontananza, le lettere, il vuoto violento più di una cata-strofe. Nannerl se ne accorgeva ogni giorno che passava, e ogni lettera era una fitta atroce. Wolfi era lontano, troppo lontano per farsi voler be-ne e proteggere. Le mancava. Le mancavano quelle opportunità che le erano state tolte senza spiegazioni: il viaggio, la felicità di un’avventura da fare ancora una volta insieme, i concerti, gli umori e gli applausi del pub-blico, le feste. […] L’Italia, Napoli, quel paese e quel viaggio che faceva-no venire l’acquolina in bocca, restavano – a solo pensarli – parole e se-gni sui libri e sulle carte geografiche che Nannerl aveva consultato. Carte chiuse con rabbia, destinate a prendere polvere. Come la sua fantasia.17
Il viaggio negato, quindi, diventa lo spunto per la narrazione, un lunghissimo flashback che ripercorre dettagliatamente gli itinerari europei
15 ITALO MOSCATI, I piccoli Mozart. Wolfi e Nannerl una storia di bambini prodigio, Torino, Lindau, 2006. 16 Ibi, pp. 7-8. 17 Ibi, pp. 9-10. Per una trattazione sistematica della figura di Nannerl Mozart, anche in relazione a questo romanzo, rimando al contributo di SIMONA CAPPELLARI, edito in que-sto stesso volume, e al saggio di RITA CHARBONNIER, Donne, romanzi, fantasie. Divulgare la musica di Mozart attraverso un romanzo ‘femminile’, in Un anno per tre filarmonici di rango, cit., pp. 279-294.
CRISTINA CAPPELLETTI
154
dei due fanciulli prodigio; e – facendo ricorso a una struttura ad anello – si chiude con la partenza di padre e figlio per quella che viene definita «terra promessa», poiché nell’immaginario mozartiano l’Italia, va detto da subito, sarà sempre legata alla speranza di trovare un consono impiego nel mondo operistico. Infatti, in chiusura di racconto, si ricorda come
Leopold ave[sse] già da tempo maturato la decisione di andare in Italia, la terra promessa della nuova musica, dei nuovi compositori, dei talenti ambiti e ricercatissimi dalle corti, dai nobili, dagli impresari più astuti e lungimiranti. Voleva “italianizzarsi” e “italianizzare” Wolfi. E poi tornare
e cogliere i frutti dell’impero.18
Le ultime pagine del romanzo non sono strettamente necessarie alla struttura; da buon sceneggiatore Moscati mette a giorno il lettore sul fu-turo dei due protagonisti, con un brevissimo flash-forward: insomma, con-clude in copione.
Si è già accennato alla fortuna non tanto del viaggio nella sua totali-tà, ma in ordine alle varie avventure occorse al giovane Mozart nelle sin-gole città: Torino diventa centrale per Laura Mancinelli e Pierluigi Ber-botto, Milano per Armando Torno, Venezia per Eduardo Rescigno. Tra le città che maggiormente suggestionano i moderni narratori c’è sicura-mente Napoli, a cui Simone De Roberto dedica alcuni racconti e Vladi-miro Bottone consacra un romanzo. Il titolo, Mozart in viaggio per Napoli, denuncia da subito un omaggio a Mörike, che nel suo celeberrimo Mozart in viaggio verso Praga non manca di inserire una digressione sul soggiorno napoletano del compositore, e la minuta descrizione di una curiosa rivisi-tazione moderna delle antiche naumachie, tanto spettacolare e barocca-mente scenografica, da apparire poco realistica.
Napoli, nonostante il fascino dei suoi personaggi, è spesso indicata dai viaggiatori come città di truffe e imbrogli, specie a scapito di sprov-veduti stranieri. Vale forse la pena di ricordare, dal momento che stiamo parlando di letteratura, come nel Settecento la città partenopea potesse vantare una fiorente attività nelle contraffazioni librarie.19 Lo stesso Leo-
18 I. MOSCATI, I piccoli Mozart, cit., p. 221. 19 Al riguardo si possono vedere, almeno, i saggi di CLOTILDE BERTONI, Editoria e romanzo fra Venezia e Napoli nella seconda metà del Settecento, in Editoria e cultura a Napoli nel XVIII secolo, Atti del Convegno organizzato dall’Istituto Universitario Orientale, dalla Società Italiana di Studi sul Secolo XVIII e dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 5-7 dicem-bre 1996, a cura di Anna Maria Rao, Napoli, Liguori, 1998, pp. 697-722; e di ANNA
I viaggi in Italia di Mozart tra realtà e finzione
155
pold, nel romanzo, ripete spesso che «Napoli è la capitale dei veleni, e degli avvelenatori»,20 nonché la «mecca delle sordidezze, crocevia di tutti gli avvelenatori».21 In effetti la permanenza napoletana ha stretti legami con la leggenda, storicamente infondata, dell’avvelenamento di Mozart. Appoggiamoci alle suggestioni del romanzo di Bottone: è notte, in uno spiazzo ai margini del Prater un uomo barcollante si aggira senza meta. Si tratta naturalmente del musicista, che si imbatte, nella fredda notte vien-nese, in un italiano, «una canaglia d’italiano»,22 pensa lui. Lo sconosciuto si presenta come indovino ed offre a Mozart i suoi servigi. Tutto ciò che il maestro desidera sapere è se qualcuno l’ha avvelenato; il grande Ga-miani, questo è il nome del magicien, cercherà di trovare una risposta sot-toponendo il maestro a una seduta d’ipnosi per rintracciare le cause dell’avvelenamento. Sin qui, in realtà, non c’è nulla di nuovo: la diceria dell’avvelenamento di Mozart ha una certa fortuna letteraria a partire dal microdramma di Puškin; il coupe de scene consiste nella completa assenza – dopo che Mozart è caduto in stato d’ipnosi – del rivale Salieri, contra-riamente a quanto il salisburghese stesso si sarebbe aspettato:
Quante volte Mozart si sarà trasognato a immaginare il suo nemico men-tre, con pennellate lente, meticolose come il suo odio, spalmava dell’antimonio o dell’arsenico sui margini delle pagine. Il veleno sarebbe stato assorbito direttamente dai polpastrelli di chi lo sfogliava. Oppure avrebbe potuto permeare la lingua, così spugnosa di capillari, quando le dita di Mozart, asportata inconsapevolmente la patina di veleno, fossero state umettate fra le labbra (Wolfgang effettivamente usa così, per volare le pagine più facilmente).23
Al contrario, il quattordicenne Amadeus si trova in una scomoda carrozza che da Roma lo porta a Napoli. Giunto nella città partenopea, il musicista adolescente conosce lo splendore dei paesaggi, il fascino del
SCANNAPIECO, Un editore goldoniano nella Napoli del secondo Settecento, «Problemi di critica goldoniana», IV (1997), pp. 7-152. 20 VLADIMIRO BOTTONE, Mozart in viaggio per Napoli, Napoli, Avagliano, 2003, p. 94. 21 Ibi, p. 83. 22 Ibi, p. 12. 23 V. BOTTONE, Mozart in viaggio per Napoli, cit., pp. 199-200. È anche troppo facile rileva-re la contiguità del brano citato con il Nome della rosa di Umberto Eco: basta infatti sosti-tuire Salieri con fratello Jorge e Mozart con i vari monaci che vengono uccisi dalle pagine avvelenate del fantomatico secondo libro della Poetica di Aristotele, dedicato alla comme-dia e al comico in genere.
CRISTINA CAPPELLETTI
156
teatro, e l’emozione del primo amore.24 In una città popolata di malfattori e avvelenatori, i due stranieri tro-
vano ospitalità presso un abate con due nipoti, Carlo e Teresa Guarienti. Il ragazzo, di pochi anni più grande del salisburghese, è un promettente violoncellista e organista, le cui potenzialità artistiche verranno oscurate ben presto dal genio musicale dell’ospite. La bambina, undicenne, è irre-sistibilmente affascinante, metà angelo e metà strega. Come una novella Beatrice dantesca ella è in grado di infondere pace con la sua sola pre-senza; e della donna salvifica possiede anche la fenomenologia, con tanto di capelli d’oro, a dispetto dell’origine mediterranea, secondo il cliché di bellezza stilnovista. Il suo fascino è però perverso e, come inverato da Baudelaire, anche lei è una damnata Beatrix, destinata a portare alla rovina i suoi adoratori.25 A coronamento del lungo flashback sul viaggio napole-tano, un Mozart ancora sotto l’effetto dell’ipnosi trova la risposta al que-sito iniziale, «chi mi ha avvelenato?». È stata lei, Teresa. La fanciulla, ras-sicurata dallo stesso compositore che il suo allontanamento da Napoli sarebbe stato breve (in realtà non vi tornerà più), aveva percepito un nuovo soggiorno napoletano di Wolfgang come una seria minaccia alle aspirazioni musicali del fratello Carlo. Scissa tra l’amore domestico e quello esotico, sceglierà naturalmente il primo, sacrificando il pur ricam-biato amore per Amadè.26 Al momento della partenza, la ragazzina done-rà agli stranieri un’ampolla di rosolio tragicamente avvelenato. Si concre-tizza così quanto più volte ribadito da Leopold: «Napoli città di veleni, e di avvelenatori». Dimenticata in fondo a un baule da viaggio, la bevanda verrà riscoperta dal compositore dopo oltre vent’anni; il ritrovamento e la fruizione del lontano ricordo, diventeranno per Mozart una mortale madeleine.27
24 Mi sia permessa una brevissima digressione: anche l’educazione sentimentale e il primo amore del compositore poco più che quattordicenne costituiscono un Leitmotiv frequente della narrativa di consumo mozartiana; ogni città della nostra penisola si contende il pri-mo amore di Mozart, tanto che potremmo – noi pure – stilare un catalogo in stile lepo-rellesco. 25 Vedi, per altra prospettiva, il saggio di CARLO ANNONI, Onomastica sveviana: la funzione-Francesca, la funzione-Beatrice (e altro), «Otto/Novecento», 3 (2003), pp. 71-98 (con partico-lare riferimento alle pp. 75-76 ), cui rimando. 26 V. BOTTONE, Mozart in viaggio per Napoli, cit., p. 207: «Perciò Teresa aveva dovuto sce-gliere: o lui o Carlo. Non possono coesistere due soli, in una sola volta. Uno dei due do-vrà eclissarsi. Uno dei due dovrà perire, sacrificato in favore dell’altro». 27 Ibi, p. 209: «Quando è che veramente avevano cominciato a manifestarsi i primi distur-bi? A fine settembre. Subito dopo (eccoli finalmente attanagliati, causa ed effetto) aver
I viaggi in Italia di Mozart tra realtà e finzione
157
A metà fra il romanzo sentimentale e il giallo storico, l’opera di Bot-tone cerca di costruire una vicenda originale sulla logora leggenda dell’avvelenamento di Mozart, riunendo così il tradizionale binomio di eros e thanatos. Affascinante lo spunto narrativo, e – a tratti – non disprez-zabile nemmeno la prassi scrittoria, con una sola stonatura: l’avvelena-mento, giunto ad esecuzione dopo vent’anni, appare forse eccessivamen-te fiabesco.
Anche la recente raccolta di Novelle K 666, del musicista e musicolo-go Roberto de Simone, pur cambiando radicalmente le modalità narrati-ve, è legata al soggiorno partenopeo di Amadeus. Nel racconto L’anello di Mozart, infatti, il vero protagonista è un moderno professore di musica, che per caso ritrova presso un antiquario partenopeo un anello apparte-nuto a Mozart, quello stesso cui i napoletani avevano attribuito – più di due secoli prima – facoltà straordinarie. Impossibilitato ad acquistarlo, l’uomo non rinuncia però a condurre indagini sull’oggetto, che si rivelerà forgiato in ambienti massonici, e realmente dotato di poteri magici, capa-ce cioè di esaltare al massimo grado le potenzialità artistiche di chi lo possiede. Non solo. Per salvaguardare il cimelio è stato realizzato un uguale gioiello, che, però, sprigiona influssi negativi su chiunque lo in-dossi. Interessante, in questo caso, la scelta dell’autore di creare un rac-conto fantastico in senso strettamente todoroviano, di cui si rintracciano i principali elementi: un io narrante, che addirittura si identifica con lo scrittore (il protagonista si chiama Roberto), un antefatto più che veritie-ro, fortemente connotato da elementi autobiografici; la presenza di un oggetto medianico (l’anello, appunto); e il finale aperto, in cui il lettore ha la possibilità di trovare sia una spiegazione logica che una soprannaturale ai fatti narrati. In questo caso, si diceva, il soggiorno di Mozart è però da-to marginale alla narrazione.
Nel racconto Diario di Conservatorio e lettere segrete da Amadeus a Floria-no, la vicenda della nomina di De Simone a direttore del conservatorio di S. Pietro a Majella per chiara fama, racconto autobiografico reale e do-cumentato, è intercalato da lettere mozartiane, tutte rigorosamente false, la cui funzione risulta al lettore poco chiara sino all’explicit della novella. Si tratta della corrispondenza tra Wolfgang e un cantante napoletano, conosciuto ai tempi del famoso viaggio, e sembrano stare al racconto come gli intermezzi stanno alla messa in scena operistica. In realtà i due
ritrovato, per combinazione, quella vecchia fiasca dentro un bauletto. Un regalo dimenti-cato, vecchio di una ventina d’anni».
CRISTINA CAPPELLETTI
158
racconti, quello biografico e quello epistolare, trovano un punto di inter-sezione nel finale della novella: poco prima di lasciare la direzione del Conservatorio, De Simone viene chiamato da un nobile napoletano, che intende donare due dipinti all’istituzione, l’uno del cantante Caffariello e l’altro di un antenato. Il donativo è però quasi un pretesto per mostrare al musicista i propri mirabilia, cosa che fa assumendo toni che bene po-trebbero confarsi a una loggia massonica, come si può leggere:
Adesso voglio metterla a conoscenza di qualcosa che avrei difficoltà a confidare ad altri –. E da un cassetto tirò fuori una scatola di colore bru-no. – Caro maestro, – mi chiese, – nelle sue ricerche non s’è mai imbat-tuto in un tal Domenicantonio Bolognini, “detto Floriano”, un evirato cantore napoletano del Settecento? – [...] Egli lentamente aprì la scatola in cui giacevano una decina di lettere, e aggiunse: – Si tratta di una corri-spondenza fra tale cantante e Mozart –.28
La situazione, sempre in senso todoroviano, assume toni fantastici. Solo pochi giorni prima, infatti, il De Simone, intenzionato a congedarsi dal proprio incarico in Conservatorio con un concerto degli allievi più promettenti, secondo la tradizione settecentesca, aveva affidato a due di loro l’esecuzione di un Concerto in re minore, utilizzando le cadenze scritte da lui stesso, quando ero ancora studente di conservatorio in S. Pietro a Majella. Per questo motivo aveva a lungo rovistato tra le proprie carte. A questo punto le strane coincidenze mozartiane si complicano: la telefo-nata della figlia di un suo insegnante di composizione lo avverte del ri-trovamento, tra le carte paterne, di un suo autografo, appunto le giovenili cadenze. Tutto il racconto sembra voler istituire un provvidenziale lega-me tra Mozart e il maestro napoletano: il suo destino, artistico e non so-lo, pare doversi intrecciare sempre con quello del salisburghese.
La presenza a latere di Mozart ritorna anche nel romanzo breve, o racconto lungo, di Attilio Piovano, La stella amica. Percorsi musicali a Torino, tra presente e passato, dove un docente universitario e un’antiquaria indaga-no su personaggi e situazioni della Torino sabauda di fine Settecento. Va detto da subito che alcune situazioni ricordano da vicino il racconto della Mancinelli, Il fantasma di Mozart,29 e non solo per le ambientazioni torine-si. Viene rapidamente rievocato il plagio perpetrato da Amadeus nei con-
28 ROBERTO DE SIMONE, Diario di Conservatorio e lettere segrete da Amadeus a Floriano, in ID., Novelle K 666. Fra Mozart e Napoli, Torino, Einaudi, 2007, pp. 178-179. 29 LAURA MANCINELLI, Il fantasma di Mozart, in EAD., Il fantasma di Mozart e altri racconti, Torino, Einaudi, 2005.
I viaggi in Italia di Mozart tra realtà e finzione
159
fronti dell’abate Quirino Gasparini, autore, ben prima del saliburghese, delle musiche di un Mitridate re di Ponto, in cui un’aria, Vado incontro al fato estremo, come dimostra Rita Peiretti, è identica a quella della partitura mo-zartiana. Probabilmente la scelta era stata obbligata, perché il tenore Gu-glielmo d’Ettore, esecutore anche del primo Mitridate, aveva imposto al giovane compositore di mantenere intatta un’aria a lui già nota. La vicen-da, però, è veramente marginale alla trama narrativa, che ha come princi-pale soggetto l’avventurosa vita di una restauratrice e un musicologo, quest’ultimo impegnato nella riscrittura di un concerto del Gasparini in parte perduto.30
E sempre a Torino, una Torino magica e misteriosa,31 Pierluigi Ber-
botto ambienta il suo romanzo, I violini dell’autunno; in questo caso Mo-zart non è attore in scena, ma è presenza a latere in tutte le trame narrati-
30 Anche se a tratti il racconto risulta essere piuttosto intrigante, alcuni dei passaggi che riguardano Mozart sembrano ricordare più il tono del saggio che quello del romanzo: «Le aveva narrato infatti di come l’Adoremus di Gasparini era stato ricopiato, probabilmente per mano di Leopold: ritrovato tra le carte di Wolfgang, fino a ’900 inoltrato era stato attribuito a Mozart. Al punto che il Köchel l’aveva incluso nel suo catalogo delle opere del salisburghese dove per tempo figurò con il numero d’opera K 327. Solamente nelle più recenti edizioni del catalogo stesso il lavoro aveva cambiato numerazione ed era logi-camente finito nell’appendice, accorpato alle opere spurie, dopo la giusta attribuzione da parte d’uno studioso. Forse inglese o americano: non ricordava con esattezza quanto Ste-fano le aveva detto. In realtà Stefano le aveva citato entrambi i ricercatori responsabili del ritrovamento: Hermann Spies che nel 1922 aveva provato l’autenticità mozartiana del mottetto e Wolfgang Plath il quale esattamente quarant’anni dopo, nel 1962, aveva ag-giunto un’ulteriore tessera al mosaico, dimostrando come la copia fosse stata vergata per mano di Leopold». Cfr. ATTILIO PIOVANO, La stella amica. Percorsi musicali a Torino, tra pre-sente e passato, Torino, Daniela Piazza editore, p. 73. 31 Che Torino fosse una città carica di misteri è notizia ben nota, come ricorda anche Ma-rio Soldati, il quale spesso vi ambienta i suoi racconti: «la carica magica di una città è, normalmente, in proporzione inversa alla sua fama turistica, artistica, storica. Per esem-pio, Lione e Torino sono le città d’Europa più frequentate dai fantasmi» (MARIO SOLDA-
TI, 55 novelle per l’inverno, Milano, Mondadori, 1971, p. 14). Sull’elemento fantastico in Sol-dati mi permetto di rimandare al mio contributo «E adesso, racconterò un fatto vero». Proposte interpretative sugli “spettri” di Mario Soldati, «Resine», XXIX, 116 (2008), pp. 55-68. La lettera-tura scientifica, o presunta tale, sulla Torino fantastica è piuttosto cospicua, mi limito a menzionare il saggio dell’antropologo MASSIMO CENTINI, Il fantasma dell’occulto. Viaggio nel mito della Torino magica, Torino, Ananke, 1998.
CRISTINA CAPPELLETTI
160
ve. Una sua sonata, la K 488, conosciuta anche come la Siciliana,32 diviene per il protagonista, lo scrittore di chiara fama Dante Soldano, una sorta di colonna sonora: ascoltata in un locale newyorkese quale accompagna-mento di un sensuale balletto dell’affascinante Odette, fa riaffiorare alla sua memoria Delphine, il suo grande amore, l’unica donna che il dongio-vannesco romanziere abbia mai amato. Rientrato a Torino, il Soldano la ascolta nuovamente, eseguita con maestria da una fanciulla bella quanto misteriosa, già a partire dal nome, Ombra: il ricordo ancora una volta va a Delphine, di cui – si scoprirà solo in seguito – la ragazza è figlia. Affa-scinato da lei, come dalla madre molti anni prima, il romanziere si lascia coinvolgere in una folle impresa, folle almeno a suo avviso: ricostruire il soggiorno torinese di Mozart, capire chi abbia incontrato e cosa abbia fatto il giovane compositore salisburghese nella città piemontese, argo-mento sul quale poco o nulla traspare dalle lettere di Leopold e Wolfgang. Ombra è in possesso di uno zibaldone di testimonianze messe insieme dalla madre, la cui morte ha interrotto la stesura della biografia, ma nes-suno potrà portare a termine il lavoro, certo non uno storico, ma solo uno scrittore, il solo capace di ricostruire anche ciò che la storia non tramanda, visto che la situazione, come sottolinea ella stessa, è quasi di-sperata:
«Il vuoto, credo. Voglio dire quel vuoto che sembra dominare il paio di settimane, o poco più, che i due Mozart, padre e figlio, nel loro primo viaggio in Italia, trascorsero a Torino. Dal 14 al 31 gennaio, per la preci-sione». «Vuoto… di che cosa?» mormorò Dante. «Vuoto di eventi, soprattutto. Vuoto di testimonianze. E vuoto perfino di quelle coordinate ambientali, di riscontri indiretti e punti di riferimen-to, che costituiscono altrettanti appigli per il biografo, utili a colmare la-cune, e ricostruire una storia…» «Come dire che della presenza dei Mozart a Torino in pratica non si sa niente…» «È la verità. Tanto che qualcuno ha addirittura avanzato il sospetto che i due a Torino non ci siano mai stati».33
La mancanza pressoché totale di testimonianze rende necessario il
32 In realtà la sinfonia non è nota con il nome di Siciliana, come si dice nel romanzo, ma il primo tempo del concerto per pianoforte n. 23 (K 488) ha carattere di siciliana, cioè di movimento lento usato di solito nelle ‘suites’ o nelle sonate. 33 P. BERBOTTO, I violini dell’autunno, cit., p. 81.
I viaggi in Italia di Mozart tra realtà e finzione
161
coinvolgimento di chi non ha paura di «inventare là dove più non lo soc-corre la materia».
Non senza qualche riserva Soldano accetta l’incarico, più per l’attrazione che prova nei confronti di Ombra, che per il progetto in sé; anche Odette fa nuovamente il suo ingresso in scena e il romanziere, ariostescamente, va in cerca di entrambe, le confonde, le trova, e nuova-mente le perde di vista, in un concitato tourbillon di inseguimenti ed esplorazioni nei sotterranei di palazzi antichi e cadenti, in una Torino sempre più misteriosa.
Nella vita di Dante Soldano vi è, però, un’altra donna il cui nome inizia per O:34 si tratta di Olimpia Tomatis, anziana nobildonna rinchiusa nel suo palazzo settecentesco, dove, tutti i lunedì, in pieno clima di revival del XVIII secolo, tiene salotto con letterati e musicisti. Anch’essa è inte-ressata al soggiorno torinese di Mozart, e ai suoi legami con la ballerina Marie Blanche (o Blache), personaggio realmente esistito, che nel 1771 prese parte ai «balli obbligati con coro» per l’Ascanio in Alba dello stesso Mozart.35 La vicenda tende ad assumere contorni sempre più fantastici: la signora Olimpia decide di rievocare la serata torinese del 30 gennaio 1771, durante la quale Mozart partecipò a una festa a palazzo Tomatis. Nella messa in scena, Dante dovrà vestire i panni del padrone di casa, amante della ballerina francese, in odore di stregoneria.
La notte della fatidica festa, il romanziere riconosce tra gli ospiti Ombra, o forse, Odette, o forse entrambe le donne, ma durante la sua quête si rende conto che qualcosa di terrificante è accaduto: una sorta di transfert l’ha riportato al 1771 e le due fanciulle che insegue non sono al-tro che due manifestazioni di Marie Blanche, provetta occultista, che in-fine egli ritrova, tornata ad essere una persona sola, nei sotterranei del palazzo (gli stessi in cui si era perso inseguendo Ombra), mentre sta suo-nando a un giovanissimo Mozart spezzoni di quelle che diverranno le sue
34 L’insistenza sulla medesima iniziale del nome ricorda, ma forse è più suggestione del lettore che effetto ricercato dall’autore, il caso sveviano del matrimonio di Zeno: anche in quel caso il protagonista aveva fatto le sue profferte di matrimonio a tre delle quattro so-relle Malfenti, i cui nomi iniziavano tutti per A. 35 Cfr. A. BASSO, I Mozart in Italia, cit., pp. 499-500: Maria Blache (Mimi), ballerina, il cui nome compare nel cartellone del Teatro Regio di Torino, stagione 1767-1768, per i bal-letti creati da Antoine Pitrot come intermezzo a Il trionfo di Clelia di Josef Mysliveček e del Creso di Pasquale Caffaro. Nelle stagioni successive ricompare nel cartellone e, nella sta-gione 1770-71, danza nei balletti di Jean Dauberval uniti alla Berenice di Ignazio Platania e all’Annibale in Torino del Paisiello, a cui assiste anche Mozart.
CRISTINA CAPPELLETTI
162
più celebri sinfonie. E in tutto questo la signora Olimpia, che assume sempre più i contorni di una megera, si rivela come il burattinaio che ha mosso tutti i fili necessari a squarciare il velo di mistero che avvolge il soggiorno a Torino del salisburghese.
Il racconto termina con questo accumulo di elementi fantastici, con un certo sgomento da parte del lettore, e con una crisi di nervi del prota-gonista, sopraffatto dalle inquietanti, e oltremodo confuse, scoperte. Le ultime pagine, però, ce lo mostrano risanato, dopo aver portato a termine la sua biografia mozartiana; la signora Olimpia è misteriosamente scom-parsa dopo la notte fatale, e di Odette non vi è traccia. Solo Ombra do-vrebbe ritrovare il proscenio, nel suo debutto da solista al Regio: Dante vi prende parte, ma della ragazza non c’è traccia, la pianista che si esibi-sce non le somiglia affatto, eppure quel pezzo, la Siciliana, sembra pro-prio suonato da lei, come quella sera nella sua casa fuori Torino. Todo-rovianamente il protagonista, e il lettore con lui, resta incerto sulla soglia del fantastico: non riesce cioè a stabile se quello che ha visto è da attri-buirsi a pura suggestione, o se tutto è reale, e la nuova concertista altri non è che l’ennesima manifestazione di Marie Blanche.
Il romanzo di Berbotto viene presentato come capitolo conclusivo di una «ipotetica trilogia di misteri», insieme a Concerto Rosso (Milano, Mondadori, 1985) e L’ombra della cattedrale (Milano, Mondadori, 1989), a cui fa da comune sfondo «una Torino magica e suggestiva». Nel primo romanzo Mozart compare solo fugacemente, in una discussione tra me-lomani (p. 193); nel secondo, invece, il critico musicale Alessio Dotta, lo stesso che disserta di Mozart con partecipata competenza nei Violini, s’imbatte spesso nel salisburghese, durante le sue ricerche sul Concerto Rosso per organo e orchestra del musicista settecentesco Giovan Battista Rambaudi.
Abbiamo più volte fatto riferimento a testi letterari che falsificano o
inventano documenti. L’ultimo romanzo di cui vorrei dar conto, invece, prende le mosse da un documento d’archivio reale. Devo fare nuova-mente ricorso alla monografia di Paolo Cattelan, Mozart. Un mese a Vene-zia, in cui si trovano notizie, tutte rigorosamente desunte da documenti dell’Archivio della parrocchia di S. Cancian a Venezia, relative a una Pe-nelope Mozart, figlia di N.N., vissuta tra fine Sette e inizio Ottocento nella città lagunare. Un semplice caso di omonimia? Possibile, anche se dai registri dei battezzati e da quello dei morti, almeno stando alle ricer-
I viaggi in Italia di Mozart tra realtà e finzione
163
che dello studioso, il cognome non troverebbe altra attestazione a Vene-zia. Questo il dato storico, da cui il musicologo Edoardo Rescigno, già autore di una biografia abbastanza romanzata di Da Ponte,36 prende le mosse per la stesura del romanzo Alla ricerca di Penelope Mozart.37
L’opera ha una struttura tripartita, propone cioè tre diverse vicende. La prima, che funge in parte da cornice, presenta un annoiato ricercatore il quale – non avendo nessun lavoro scientifico cui dedicarsi (situazione accademicamente fantastica, in senso todoroviano) – decide di vagare per gli archivi veneziani, lasciandosi guidare un po’ dal caso, nella speranza di rinvenire qualche documento tanto prezioso, quanto sconosciuto, che possa fornire materiale ad eventuali suoi studi. Nel libro dei morti della parrocchia di San Cancian si imbatte nel certificato di morte di tre ragaz-zini, Giacomo Gasparo, Prosdocimo Domenico e Gioseffa, tutti figli di Penelope; dato assolutamente irrilevante, se non per la tragicità dell’evento. La Penelope in questione, però, ha un cognome illustre, Mo-zart, come il musicista che nel 1771 trascorse a Venezia gli ultimi giorni di carnevale. Il ricercatore, voce narrante del romanzo, inizia da questo punto in avanti a indagare due diversi filoni narrativi. Da un lato egli av-via la storia di Penelope, giovane senza genitori, che ha tre figli, nei certi-ficati di battesimo dei quali, però, non compare mai il nome del padre. Principia così la ricostruzione, sostenuta da una reale ricerca d’archivio, delle vicende di questa ragazza che, con un nome tanto illustre, si aggira-va negli stessi luoghi in cui, trent’anni prima, il giovane compositore sali-sburghese aveva soggiornato quasi un mese. In parallelo viene raccontato il viaggio nella Dominante di Mozart, cercando di rintracciare un qualche sottile fil rouge in grado di legarlo a Penelope.
Riassumo, brevemente, l’esito delle indagini del nostro annoiato ri-cercatore. Mozart soggiornò a Venezia in casa della famiglia Wider; a proposito della quale il giovane austriaco parla di “cinque perle”, indi-cando così le cinque figlie, due ancora piccole, ma le altre tre più o meno
36 EDUARDO RESCIGNO, Da Ponte poeta e libertino tra Mozart e il nuovo mondo, con una post-fazione di Giovanni Carli Ballola, Milano, Bompiani, 1989. 37 EDUARDO RESCIGNO, Alla ricerca di Penelope Mozart, Milano, Skira (Art Stories), 2006. Tra i primi saggi di Rescigno figura già una monografia dedicata al genio salisburghese (Mozart, con contributi di Alfredo Mandelli, Sergio Martinotti, Milano, Fabbri, 1979), nel-la quale al viaggio in Italia erano però dedicate solo poche pagine (19-22). A conferma dei suoi interessi mozartiani si può citare anche la monografia, curata insieme a Edgar Vallo-ra e Luigi Di Fronzo, pubblicata come supplemento al «Corriere della Sera», Wolfgang Amadeus Mozart, Milano, Skira, 2007.
CRISTINA CAPPELLETTI
164
coetanee del compositore. Da subito il giovane salisburghese dimostra una spiccata predilezione per la terzogenita Teresa, di poco più grande di lui. Rescigno ipotizza che Penelope potrebbe essere nata da una relazio-ne tra i due: il dato sembrerebbe confermato dall’allontanamento di Te-resa dalla famiglia e dal suo trasferimento in altra zona di Venezia. Meno stringente, mi pare, l’idea che a questa vicenda sia legato il giudizio di Leopold su Venezia, che in una lettera alla moglie descrive come il «luo-go più pericoloso di tutta l’Italia per la gente giovane»: l’arrivo nel perio-do di carnevale, tempo in cui i costumi nella città lagunare erano regolati dal «si placet, licet», può aver ingenerato nell’apprensivo, e opprimente, Leopold questa riflessione.
Rescigno, al di là della trama accattivante, ha la capacità di alternare con grande acutezza e opportunità le tre diverse vicende; inserendo, a beneficio della verosimiglianza, una lettera di Mozart alla sorella, lettera immaginaria, visto che poche pagine prima il narratore ha voluto ricorda-re al lettore come nel periodo veneziano Amadeus abbia dedicato a Nannerl solo poche frasi in chiusa delle lettere paterne. Molto efficaci appaiono anche le parti dialogate, due interi capitoli, in cui hanno voce le sorelle Wider, con stile e vivacità di goldoniana memoria. Credo di poter prendere a prestito, per descrivere questo romanzo, una metafora ario-stesca, che è certamente eccessiva per il prodotto letterario, ma che chiama in causa la musica, e quindi bene si adegua al contesto mozartia-no:
Signor, far mi convien come fa il buono sonator sopra il suo instrumento arguto, che spesso muta corda, e varia suono, ricercando ora il grave, ora l’acuto. (Orlando Furioso, VIII, XXIX, 1-4)
Il romanziere, infatti, interrompe una vicenda, per passare ad altro filone narrativo, mantenendo così sempre viva l’attenzione del lettore, come insegna, con ben più alti risultati, proprio Ariosto.
Romanzo storico a tutti gli effetti, Alla ricerca di Penelope Mozart, però, non corre il rischio – cui si accennava iniziando questo studio – di creare «confusione fra la precisione del documento (veritas), e la sfocatura dell’invenzione (amplificatio)».38 Rescigno offre, infatti, al suo lettore, in appendice, una minuziosa trascrizione di tutti i documenti reali cui fa ri-ferimento, tracciando così un preciso confine fra realtà storica e finzione;
38 E. RESCIGNO, Alla ricerca di Penelope Mozart, cit., p. 113.
I viaggi in Italia di Mozart tra realtà e finzione
165
riesce cioè ad ovviare al problema posto dallo Zajotti, indicando esatta-mente quel che è documento storico e quel che è inventio letteraria.
Molti dei romanzieri che si sono dedicati al viaggio italiano di Mo-
zart hanno voluto prefigurare in esso situazioni e personaggi che torne-ranno nella sua produzione artistica, in particolare operistica. Si è già ac-cennato al caso di Berbotto, e a come Dante Soldano, misteriosamente riportato all’anno del Signore 1771, avesse visto la maliarda Marie Blan-che suonare al quattordicenne Mozart spezzoni di quelle che sarebbero poi divenute le sue composizioni più famose.
In Vladimiro Bottone, invece, l’incontro – durante il viaggio in car-rozza da Roma a Napoli – con un mondanissimo chevalier, che suscita da subito le simpatie del giovane compositore, al quale descrive con dovizia di particolari suggestivi quello che l’Italia gli può offrire, potrebbe sem-brare una prefigurazione del Don Giovanni. Egli infatti lascerà ben pre-sto i due stranieri, attratto da lusinghe ben diverse da quelle che spingono padre e figlio a Napoli: «Sarà la prospettiva di scorrerie fra letti violati e disfatti a rubartelo [scil. a Mozart]».39 L’immagine è suggerita dal roman-ziere stesso poco dopo, quando rievoca nei discorsi dello chevalier un banchetto infernale, a cui manca solo la statua «gentilissima» del Com-mendatore, profetizzando a Mozart che con il tempo potrà capire a pie-no, e mettere a frutto, ciò che gli sta prospettando l’amico:
«L’inferno è un ininterrotto banchetto, per il quale si deve passare tutti. E, purtroppo, i convitati non siamo noi. I convitati del famoso banchetto sono i vermi». […] Ci vorrà tempo, dovrai fortificarti ancor, dovrai uscire dal tuo Paradiso e diventare un uomo, se mai ci riuscirai. Prima di poter sbirciare ciò che accade fra le quinte della mostruosa commedia.40
Molto più scoperta è Laura Mancinelli, che immagina Amadé, du-rante il soggiorno torinese, insieme a una ragazzina di cui è invaghito, una Rosina, con la quale si fa spettatore di un teatrino di burattini, in cui è messo in scena un battibecco tra fidanzati:
Ho contato, Susannetta, quanto spazio c’è qui dentro: qui ci sta la sedia, il letto, un armadio e una poltrona.
39 V. BOTTONE, Mozart in viaggio per Napoli, cit., p. 57. 40 Ibi, p. 58.
CRISTINA CAPPELLETTI
166
Questa stanza ce la dona il signore per le nozze.
A questo punto la sposa burattina interrompe bruscamente il com-pagno, redarguendolo e accusandolo di eccessiva ingenuità:
Sempre l’ultimo sarai, caro Figaro, a capire. Il sor conte ha certe mire che sepolte tien nel cuore. Ma io so perché vuol darci questa stanza a lui vicina...41
Si tratta, non è certo difficile intuire, di una riscrittura della scena iniziale delle Nozze di Figaro, e anche il nome dell’amica con cui il giovane Mozart assiste alla recita non è casuale: se nel libretto di Da Ponte la mo-glie del Conte d’Almaviva è genericamente designata come Contessa, sappiamo dalla trilogia di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (Le barbier de Séville, La folle journée ou Le mariage de Figaro, La mère coupable) che il suo nome era proprio Rosina. Sono poi numerosi, e nemmeno troppo degni di nota, i racconti in cui giovane Mozart, durante il suo Grand Tour italiano, in particolare quando si trova a passare nel Trentino, ha modo di decantare un «eccellente Marzemino», che riaffiorerà nella sua memoria al momento della stesura del Don Giovanni.
Le speranze riposte da Leopold e Amadeus Mozart nei viaggi italiani
e le lusinghe che indussero il genio salisburghese a credere di poter tro-vare nel nostro paese una giusta fortuna nel teatro d’opera, vennero disil-luse, come bene riassume Vladimiro Bottone, facendo storpiare a Leo-pold una filastrocca, cara a molte generazioni di studenti per mandare a memoria alcune regole della grammatica latina: «spero, promitto e iuro reggono l’infinito spergiuro».42
41 L. MANCINELLI, Il fantasma di Mozart, cit., p. 149. 42 V. BOTTONE, Mozart in viaggio per Napoli, cit., p. 30.