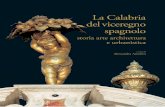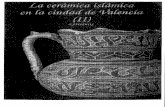Gli ordini mendicanti e la città: localizzazioni conventuali e urbanizzazione a Valencia (secoli...
Transcript of Gli ordini mendicanti e la città: localizzazioni conventuali e urbanizzazione a Valencia (secoli...
Storie di città e architettureScritti in onore di Enrico Guidoni
Edizioni KappaEdizioni Kappa
Storie di città e architettureScritti in onore di Enrico Guidoni
Storie di città e architettureScritti in onore di Enrico Guidoni
a cura di Guglielmo Villa
cop.Scritti_cop.ScrittiGuidoni 16/04/14 08.54 Pagina 1
Storie di città e architettureScritti in onore di Enrico Guidoni
001-008_Iniziali_001_Finelli 07/04/14 11.43 Pagina 1
Il volume è stato pubblicato con il contributo del Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura dellaSapienza – Università di Roma e del Centro Interdipartimentale Edilizia Restauro Ambiente dello stesso Ateneo.
Progetto grafico: Massimo Mariano - Roma
© Copyright 2014 by Edizioni KappaVia Silvio Benco, 2 - 00144 Roma - Tel. 06.273903www.edizionikappa.com
Tutti i diritti riservati
001-008_Iniziali_001_Finelli 07/04/14 11.43 Pagina 2
Storie di città e architettureScritti in onore di Enrico Guidoni
a cura di Guglielmo Villa
Edizioni Kappa
001-008_Iniziali_001_Finelli 07/04/14 11.43 Pagina 3
95
1 J. LE GOFF, Apostolat mendiant et fait urbain dans la France médiévale: L’implantation des ordres mendiants, «Annales», 22 (1968),pp. 335-352, ID. Ordres mendiants et urbanisation dans la France médiévale, «Annales», 25 (1970), pp. 924-946; E. GUIDONI,Città e ordini mendicanti. Il ruolo dei conventi nella crescita e nella progettazione urbana del XIII e XIV secolo, «Quaderni medievali»,4 (1977), pp. 69-106.
2 P. VOLTI, Les couvents des ordres mendiants et leur environment à la fin du Moyen Age. Le nord de la France et les anciens Pays-Basméridionaux, Paris 2003.
3 La bibliografia su questo tema è quasi inabbordabile nel presente e ha i suoi antecedenti nell’interesse della storio-grafia in lingua tedesca sul tema dal principio del secolo XX. Recentemente la questione tipologica è stata riconsideratada diversi angoli che mettono a fuoco l’esistenza di un modello concreto di chiesa mendicante con indipendenza di tem-po, spazio e intenzioni particolari. Si vedano tra gli altri i lavori di A. CADEI, Ar chi tettura mendicante: il problema di una defi-nizione tipologica, «Storia della Città», 26-27 (1983), pp. 21-32;C. BOZZONI, L’edilizia degli Ordini Mendicanti in Europa e nelbacino del Mediterraneo, in Lo spazio dell’umiltà, Atti del convegno di studi sull’edilizia dell’Or dine dei Minori (Fara Sabina,3-6 novembre 1982), Fara Sabina 1984, pp. 275-326; R. BO NELLI, Nuovi sviluppi di ricerca sull’edilizia mendicante, in Gli ordi-ni mendicanti e la città. Aspetti architettonici, sociali e politici, a cura di J. Raspi Serra, Milano 1990, pp. 15-26; W. SCHENKLUHN,Ordines studentes. Aspekte zur Kirchenarchitektur der Dominikaner und Franziskaner im 13. Jahrhundert, Berlin 1985, ID., Archi-tettura degli Ordini Mendi canti. Lo stile architettonico dei domenicani e dei francescani in Europa, Padova 2003 (traduzione italianadell’originale tedesca Architektur der Bettelorden. Die Baukunst der Dominikaner und Franziskaner in Europa, Darmstadt 2000);R.A. SUNDT, Mediocres do mos et humiles habeant fratres nostri: Dominican Legislation on Architecture and Architectural Decoration inthe 13th Century, «Journal of the Society of Architectural Historians», 46 (1987), pp. 394-407; D.M. GILLERMAN, San For-tunato in Todi: Why the Hall Church?, «Journal of the Society of Architectural Historians», 48 (1989), pp. 158-171; E. OR-TOLL, Algunas consideraciones sobre la iglesia de Santa Caterina de Barcelona, «Locus amoenus», 2 (1996), pp. 47-63. Nell’ambi-to spagnolo i francescani hanno ottenuto maggiore attenzione da parte della storiografia architettonica recente; M. CUA-DRADO SÁNCHEZ, Arquitectura franciscana en España (siglos XIII-XIV), «Archivo Ibero-Americano», 201-202 (1991), pp.15-70; 203-204 (1991), pp. 479-552; V. GARCÍA ROS, Los Franciscanos y la Arquitectura. De San Francisco a la Exclaustración,
Le relazioni articolate tra gli ordini mendicanti e le città risaltano tra i molti temi esplo-rati dal professore Enrico Guidoni nelle sue ricerche sulla città europea medievale e rina-scimentale. Sebbene già Le Goff aveva posto in relievo la connessione specifica tra l’ur-banizzazione e le sistemazioni degli ordini mendicanti in Europa nei secoli XIII e XIV, fuGuidoni che con più perspicacia e profondità segnalò le conseguenze che il carisma deifrancescani, domenicani e degli ordini simili a questi ebbero nella morfologia della città eu-ropea e specialmente in Italia1. A questi studi pioneri sono seguiti molti altri nei quali lastoria urbana e architettonica si intrecciano in un’analisi d’ambito territoriale più limitata2.Nonostante ciò, per la maggior parte degli studiosi la questione fondamentale ha conti-nuato ad essere per anni quella di indagare sulle origini della tipologia di chiesa mendican-te, basata sulla volontà di manifestare la fedeltà al voto di povertà e sulla necessità di di-sporre di grandi aule per la predicazione, e la configurazione di questo tipo di tempio co-me un modello per l’architettura gotica meridionale nei paesi del Mediterraneo3. Il pre-
GLI ORDINI MENDICANTI E LA CITTÀ: LOCALIZZAZIONI CONVENTUALI E URBANIZZAZIONE A VALENCIA
(SECOLI XIII-XV)
Amadeo Serra Desfilis
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/05/14 12.14 Pagina 95
AMADEO SERRA DESFILIS96
Valencia 2000; una sintesi in M. CUADRADO SÁNCHEZ, Arquitectura de las órdenes mendicantes (Cuadernos de Arte EspañolHistoria 16) Madrid 1993.
4 Questo articolo parte dai lavori realizzati nell’ambito del progetto di ricerca Arqui tectura en construcción en el ámbito va-lenciano de la Edad Media y Moderna finanziato dal Ministerio de Educación y Ciencia di Spagna (HUM 2004-5445/AR-TE) con fondi FEDER, e sviluppato presso il Departamento de Historia del Arte della Universitat de Va lència-EstudiGeneral.
5 M. FALOMIR, Arte en Valencia, 1472-1522, Valencia 1996, pp. 65-84; A. SERRA DESFILIS, La influencia de las órdenes men-dicantes en la evolución urbana de la Valencia medieval en IV Congreso de Arqueología Medieval Española: Sociedades en transición. Ac-tas. (Alicante, 4-9 octubre 1993), II, Alicante 1994, pp. 205-211.
6 FALOMIR, op. cit., pp. 73-74.7 SERRA DESFILIS, op. cit., pp. 206-207.8 J. TEIXIDOR, Antigüedades de Valencia, a cura di R. Chabás, II, Valencia 1895, p. 10; Libre del Repartiment de València, a
cura di A. Ferrando Francés, Valencia 1984, p. 22, n. 210.9 V. M. ROSSELLÓ, J. ESTEBAN, La fachada septentrional de la ciudad de Valencia, Valencia 2000, pp. 9-13.
sente studio si prefigge di esplorare la modalità di insediamento dei nuovi ordini mendi-canti nella città di Valencia, di analizzare l’intorno urbano di queste fondazioni e descri-vere i meccanismi di intervento dei frati nell’urbanistica valenciana dei secoli XIII, XIV eXV4. Negli anni ’90 del secolo passato due lavori si addentrarono nel problema da pro-spettive affini e ora tenteremo di approfondire quei risultati con apporti complementari5.
L’interesse di Valencia come osservatorio della installazione, espansione e proiezionedegli ordini mendicanti nello spazio urbano necessita appena di una giustificazione. Con-quistata ai musulmani nel 1238, la città fu oggetto di una distribuzione sistematica dellospazio urbano murato e del territorio circostante già prima della sua conquista effettiva, inun momento nel quale i nuovi ordini mendicanti avanzavano in tutta Europa al riparo del-la canonizzazione dei santi fondatori (San Francesco di Assisi nel 1228 e San Domenicodi Guzmán sei anni dopo). La conquista e la spartizione ebbero inoltre come attori prin-cipali un monarca come Jaime I d’Aragona (1208-1276), propenso alle forme di apostola-to che rappresentavano i domenicani, francescani e mercedari, istituzioni religiose che eglifavorì espressamente durante il suo regno. Così, non è strano che nel processo di cristia-nizzazione del paesaggio urbano intrapreso a partire dalla conquista, i conventi mendicantiassunsero un grande protagonismo del quale erano pienamente coscienti due figure intel-lettuali che riflettevano tra i secoli XIV e XV a Valencia a proposito dell’idea di una cittàcristiana, del suo regime di costumi e, fino a un certo punto, della sua costruzione mate-riale come furono Francesc Eiximenis e San Vincenzo Ferrer.
L’insediamento degli ordini mendicanti a Valencia ebbe luogo all’incirca tra il 1238 e il1310, sebbene si ebbe una seconda ondata di fondazioni nel secolo XV motivata dal mo-vimento di riforma mendicante e dalle nuove forme di pietà6. Jaime I incontró nei frati unappoggio decisivo per il suo proposito di organizzare la società urbana di un nuovo regnocristiano conquistato di recente ai musulmani e per questo li favorì risolutamente. Al prin-cipio, i mendicanti si installarono in case all’interno delle mura, donate dal re, mentre da-vano inizio le opere di nuove installazioni su terreni che gli venivano assegnati al ritmo del-le elemosine e dei lasciti7.
I domenicani furono beneficiati da Jaime I pocchi giorni prima della conquista della città:il 24 di aprile del 1238 il monarca concedeva “ad opus domus Predicatorum” un terreno(“realem”) prossimo al fiume, tra le porte della Xerea e del Temple. Il luogo rimaneva vi-cino al pulsante “arrabal” (quartiere fuori mura) della Xerea ed era irrigato dalle acque delfiume Turia e dal canale che muoveva i mulini di Beltrán de Teruel8. Tra il lotto del con-vento domenicano e il quartiere della Xerea esisteva una spianata che aveva dato il nomeal secondo e circondava il letto della più tardi conosciuta come “rambla de Predicadors”,coincidente in gran parte con l’ambito della attuale piazza di Tetuán, da dove scorreva an-che il canale9. Il toponimo Xerea deriva dall’arabo “sari’a”, come dire, un ampio oratorio
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 96
GLI ORDINI MENDICANTI E LA CITTÀ: LOCALIZZAZIONI CONVENTUALI E URBANIZZAZIONE A VALENCIA 97
10 J. RIBERA, La Xarea de la Valencia musulmana, «Almanaque Las Provincias», (1927), pp. 225-227.11 Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Jaime I, registro 21, f. 4v; R. I. BURNS, El Reino de Valencia en el siglo
XIII. Iglesia y sociedad, II, Valencia 1982, pp. 465, 474.12 F. DIAGO, Historia de la Provincia de Aragón de la Orden de Predicadores, Barcelona 1599, ff. 156-157r; TEIXIDOR, op. cit.,
II, pp. 11-14.13 DIAGO, op. cit., f. 159v; ROSSELLÓ, ESTEBAN, op. cit., pp. 98-99.14 Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Jaime I, registro 20. f. 274v.15 V. MARTÍNEZ COLOMER, Historia de la Provincia de Valencia de la regular Observancia de San Francisco, I, Valencia 1803,
pp. 31-32; A. HUICI, A. CABANES, Documentos de Jaime I de Aragón, II, Valencia 1976, p. 54; J. WEBSTER, Els Menorets: theFranciscans in the Realms of Aragon from Saint Francis to the Black Death, Toronto 1993 e la edizione catalana ID., Els franci-scans catalans a l’Edat Mitjana, Lleida 2000, pp. 39-41.
16 WEBSTER, op. cit., p. 126.17 A. HUICI, A. CABANES, op. cit., IV, p. 118-119.18 J. A. HEBRERA, Crónica Seráfica de la Provincia de Aragón de la Regular Observancia de Nuestro Padre San Francisco, I, Zara-
goza 1703, p. 176.
all’aria aperta, contiguo alle mura della città, dove si riunivano le comunità ispano-musul-mane in occasioni speciali e la cui esistenza nella Valencia islamica è attestata dal secoloXI10. In questo modo il convento disponeva fin dal principio di una piazza adiacente e ilre proibì nel 1271 che si edificasse in essa11. In seguito, la piazza della “rambla de predica-dors” e il convento formarono un insieme che l’autorità reale colmó di esenzioni e privi-legi tendenti a mantenere la tranquillità e il decoro urbano di questa zona in favore dei fra-ti12. D’altra parte, la decisione di Jaime I di convertire gli antichi orti o quinta islamica delReal nella nuova residenza dei monarchi cristiani, giusto all’altro lato del fiume, era favo-rita anche dalla vicinanza del palazzo al cenobio domenicano. L’inconveniente della man-canza di difesa del luogo davanti ad un alluvione del Turia entró in via di soluzione quan-do il vescovo di Valencia, il domenicano frate Andreu di Albalat, suffragó la costruzionedi una muraglia per la sua protezione che andava dalla torre “de l’Esperó”, isolata nell’estre-mo nord del recinto difensivo della città, fino alla torre della porta del Temple13. Nel 1275,senza dubbio, l’insediamento della comunità dei frati predicatori in quel luogo non era con-siderato definitivo dato che Jaime I arrivò a donare una piazza di fronte al convento a Ar-nau Esquerre affinché lì potesse edificare case e opifici se i domenicani abbandonavano illuogo14.
Il 3 di maggio del 1238, quando la conquista cristiana della città già era prossima, JaimeI donó ai francescani anche un terreno, ma il lotto scelto per la fondazione del conventofu meglio definito alcuni mesi dopo, in seguito alla presa di Valencia nell’ottobre diquell’anno: il re consegnò alla comunità un terreno di 85 braccia di lunghezza per 55 di lar-ghezza (come dire, una superficie di 175,95 per 113,85 metri equivalente a poco più di 2ettari) vicino al cammino di Ruzafa, non lontano dal cimitero vicino alla porta della Boa-tella15. Il vescovo di Valencia Ferrer di Pallarés cedette ai frati minori una moschea, il ci-mitero immediato e alcune case sulla strada che conduceva fino alla “torre cremada”, ter-reni che erano appartenuti prima a Ramona Torpina16. Così i francescani rimanevano lo-calizzati vicino al principale quartiere commerciale, dove si stabilirà anche il mercato, inun terreno prossimo al settore sudest delle mura del secolo XI, anche se di estensione ri-dotta. Per questo, quando la comunità venne a prosperare e vedi aumentare la sua in-fluenza, i frati minori ottennero dal re Jaime nel 1260 l’ampliamento della donazione ori-ginale con un esteso lotto, libero da edifici, che doveva servirgli da cimitero e piazza da-vanti alla chiesa del convento17. Il luogo era sacro per la comunità francescana perché erastato scenario del martirio di due frati, fra Giovanni da Perugia e fra Pietro da Sassoferra-to, arrivati nel 1228 nella Valencia musulmana per predicare il cristianesimo18. Fin dal prin-cipio, i frati minori si allontanarono della tendenza eremitica che avevano mostrato nei pri-mi insediamenti realizzati in altri luoghi e i domenicani guidati dal fondatore e confessore
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 97
AMADEO SERRA DESFILIS98
19 La licenza per insediarsi senza pagare tributi in qualsiasi dominio di Jaime I in Archivo de la Corona de Aragón,Cancillería, Jaime I, registro 21, f. 80. TEIXIDOR, op. cit., I, p. 34; BURNS, op. cit., II, pp. 466-467.
20 Sopra les “pueblas” come modalità d’insediamento nella espanzione urbana di Valen cia, J. RODRIGO PERTEGÁS,La urbe valenciana en el siglo XIV, en III Congreso de Historia de la Corona de Aragón, (Valencia, julio de 1923) I, Valencia 1923,pp. 290-298; J. TORRÓ, E. GUINOT, De la madina a la ciutat. Les pobles del sud i la urbanització dels extramurs de València (1270-1370), «Saitabi», 51-52 (2001-2002), pp. 51-103, en especial, pp. 85-92; F. QUEROL FAUS, La vida valenciana en el siglo XV.Un eco de Jaume Roig, Valencia 1963, p. 25, commenta l’allusione al “bovalar dels agustins”.
21 J. JORDÁN, Historia de la provincia de la Corona de Aragón de la Sagrada Orden de los Ermitaños de nuestro gran Padre San Agu-stín, I, Valencia 1704, p. 190. La hanegada equivale a 831 m2. A. SERRA DESFILIS, Iglesia parroquial de San Agustín (Valencia),en Monumentos de la Comunidad Valenciana: Valencia. Arquitectura religiosa, a cura di J. Bérchez, Valencia 1995, pp. 70-75.
22 J. GUIRAL HADZIIOSSIF, Le paysage urbain à Valencia du XIII au XVI siècle en La ciudad hispánica durante los siglos XIII alXVI, (La Rábida y Sevilla, 14-19 septiembre 1981) a cura di E. Sáez, C. Segura Graiño e M. Cantero Montenegro, II,Madrid 1985, pp. 1581-1610; R. NARBONA, Memorias de la Ciudad. Ceremonias, creencias y costumbres en la hi storia de Valencia,Valencia 2003, pp. 78-79.
23 R. GONZÁLEZ VILLAESCUSA, Análisis morfológico e historia urbana. El barrio del Carmen de Valencia, «Madrider Mittei-lungen», 41 (2000), pp. 410-435.
24 Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Pedro III, registro 44, f. 204v.
reale, frate Miquel Fabra, e in seguito dai prelati dell’ordine che ostentarono la mitra va-lentina si insediarono quasi sempre prima degli altri ordini. Gli agostiniani e carmelitani sistabilirono a Valencia poco più tardi, nell’ultimo quarto del secolo XIII, ma seguirono unaprocedura simile.
Gli agostiniani ottennero una licenza reale per stabilirsi a Valencia nel 1272, ma più pro-babilmente accadde che la fondazione non fosse effettiva prima del 128119. Il suolo rima-neva al sudovest della città, poco più lontano del recinto murato delle localizzazioni con-cesse a francescani, domenicani e mercedari, però poteva contare su una via di comuni-cazione diretta con il nucleo urbano attraverso la strada di San Vicente, tracciata sulla an-tica via Augusta. In questi paraggi esisteva anche un polo di urbanizzazione nella “poblad’en Mercer”, come dire, poteva contare su un riordinamento delle parcelle e del sistemaviario per favorire la sistemazione dei nuovi abitanti della città esterna alle mura, sebbenetuttavia nel secolo XV conservava qualcosa della sua funzione di luogo di pascolo e cosìJaume Roig lo denomina il “bovalar dels agustins”20. La chiesa esisteva già alla fine del se-colo XIII e nel 1300 il re Jaime II duplicó l’estensione del terreno disponibile conceden-do al convento di Sant’Agostino di Valencia un’altra estensione in più di terra, ossia 6 ha-negadas in più, equivalente a quasi mezzo ettaro. Con questo privilegio reale del 1300 si in-traprese un piano costruttivo che includeva oltre alla fabbrica del tempio, il primo chio-stro, il dormitorio e il refettorio, elementi tutti riconosciuti al principio del secolo XVIIIcome i più antichi del complesso conventuale21. Il culto all’icona mariana della Madonnadi Gracia fu il motivo della costruzione di una cappella nel chiostro sotto il patronato diEnrique II di Castiglia e conferì una speciale importanza al cammino che conduceva dalnucleo commerciale di Va lencia direttamente al convento di Sant’Agostino, percorso spes-so da processioni e preghiere in onore della veneranda immagine22. Il camino finì conver-tendosi nella via Virgen de Gracia, attualmente intitolata Músico Peydró in parte del suotracciato storico, e correva parallela alla strada di San Vicente, la quale si dirigeva a sud fi-no a Xàtiva, dopo aver attraversato la porta delle mura.
Il convento del Carmen fu fondato verso il 1281 vicino al suburbio di Roteros, un set-tore urbanizzato già in epoca musulmana e che fu colonizzato dopo la conquista cristianacon l’insediamento di una “puebla”23. Da quell’anno i frati avevano licenza reale per ac-quisire terreni fuori dalle mura di Valencia del valore di 3.000 soldi, dove poter edificareun convento24. I carmelitani andarono gradualmente acquisendo propietà nella zona, con-tando sempre sull’appoggio della corona e del governo municipale: nel 1283 ottennero ilpermesso del re per comprare case e orti e in questo stesso anno pagarono a Sancha Llo-
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 98
GLI ORDINI MENDICANTI E LA CITTÀ: LOCALIZZAZIONI CONVENTUALI E URBANIZZAZIONE A VALENCIA 99
1. La città di Valencia nel secolo XIV: situazione dei conventi nello spazio urbano della nuova muraglia (da Rosselló, Esteban, 2000).
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 99
AMADEO SERRA DESFILIS100
25 R. GALLOFRE GUINOVART, Documentos del reinado de Alfonso III relativos al Reino de Valencia y contenidos en los Registros delArchivo de la Corona de Aragón, Valencia 1968, p. 267 (licenza reale di 26 febbraio 1289); B. VELASCO BAYÓN, El conventodel Carmen de Valencia en los siglos XIII al XVI, «Carmelus», 35 (1988), pp. 94-137; J. WEBSTER, Per Déu o per diners. Els men-dicants i el clergat al País Valencià, València 1998, pp. 87-100.
26 D. GARCÍA HINAREJOS, La arquitectura del convento del Carmen de Valencia, Valencia 1989.27 Già in 1317 i carmelitani si lamentavano della presenza di prostitute e malfattori nel cammino che conduceva alla
chiesa e l’autorità reale prese misure nel 1340, però con esito limitato, WEBSTER, op. cit., p. 93. R. NARBONA, Pueblo, podery sexo. Valencia medieval (1306-1420), Valencia 1992.
28 J. CORTÉS, V. PONS, Geografia dels monestirs femenins valencians en la baixa Edat Mitjana, «Revista d’Història Medieval»,2 (1991), pp. 77-90.
29 BURNS, op. cit:, Mª. P. ANDRÉS ANTÓN, El Monasterio de la Puridad, Valencia 1991-1993; D. BENITO GOERLICH, ElReal Monasterio de la Santísima Trinidad, Valencia 1998.
pis 1.150 soldi per il terreno di sua propietà e nel 1289 tornarono a ottenere licenza del reAlfonso III per comprare lotti e un orto nel quale edificare il convento; nel 1309 Jaime IIli autorizzò a comprare terre in città per un valore di 5.000 soldi, come fecero vicino all’or-to che già possedevano, e ancora fu realizzato un altro ampliamento del convento nel 1321;nel 1348 la superficie occupata dal convento tornò a crescere, questa volta con l’appoggiodi Pedro IV il Ceremonioso, mediante l’acquisto di lotti e l’incorporamento di una stradavicina, il tutto per un ammontare di 15.000 soldi25. Difronte al cenobio carmelitano si de-finì anche una piazza conosciuta prima come piazza di Roteros e dopo del Carmen, di am-bito più ridotto della spianata della quale usufruivano i domenicani e i francescani26. Laporta di Roteros che sarà sostituita alla fine del secolo XIV da quella di Serranos era situa-ta anch’essa in prossimità e serviva da principale accesso al centro urbano dal nord, in-crociando il fiume attraverso il ponte di Serranos. Al principio, pertanto, la zona di loca-lizzazione dei carmelitani era propizia, però si deve contare anche sulla scomoda vicinan-za delle concerie e, con il tempo, del bordello pubblico o “pobla de les fembres pecadrius”dove si concentrava la prostituzione senza che rimanesse confinata del tutto nel recinto27.Invece, l’abilitazione di un nuovo accesso al recinto murato del secolo XIV attraverso ilportale Nuevo o di San José situava i carmelitani vicino ai cammini di entrata alla città da-gli orti della sponda sinistra del Turia.
Conventi di monache domenicane, francescane e agostiniane furono fondati anche aValencia, però i loro recinti furono più raccolti, il loro regime di clausura più stretto e le lo-ro chiese meno frequentate. Per le loro prime fondazioni scelsero lotti vicino a porte e stra-de, confidando nel sostegno che il patriziato e la nobiltà cittadina offrirono a queste co -munità tanto attraverso le elimosine come incamminando alcune delle loro figlie verso lavita religiosa di questi ordini28. A Valencia seguirono due modalità di insediamento bendifferenziate. Da una parte, le dominicane di Santa Maria Maddalena si stabilirono vicinoall’area commerciale del mercato e le clarisse di Santa Chiara e Santa Elisabetta d’Unghe-ria (poi chiamato de “la Puridad”) tra questa zona e la strada di Quart, nello spazio allorafuori mura ma già relativamente urbanizzato. D’altra parte, le religiose agostiniane di SanGiuliano si installarono nel quartiere del cammino di Sagunto, sulla sponda sinistra del Tu-ria, dove fu fondato nel 1445 un altro convento di clarisse intitolato alla Trinità, le quali so-stituirono appunto i frati trinitari, al margine della strada di Alboraida; quindi, le comunitàfeminili dovettero localizzarsi in spazi periferici e fuori dalle mura, anche se in essi già esi-steva un vicinato di case, case coloniche e cammini29.
Cosí i fondatori dei conventi mendicanti cercarono di unire il circuito delle mura con gliampi spazi fuori dalle mura, tenendo anche presente la vicinanza dei quartieri popolosi edelle vie di comunicazione che emergevano già nel siglo XIII come assi di espansione ur-bana. Più in là delle mura, gli orti apparivano come un’area disseminata di piccoli nucleiabitati e case coloniche che costituivano l’area naturale di influenza della città. I france-scani si situavano tra i cammini di Ruzafa e di San Vicente; questo e la via della Virgen de
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 100
GLI ORDINI MENDICANTI E LA CITTÀ: LOCALIZZAZIONI CONVENTUALI E URBANIZZAZIONE A VALENCIA 101
2. La città di Valencia nel piano di Vicente Tosca inciso da José Fortea (1738). Si indicano a colori i lotti dei principali conventi mendi-canti stabilitisi nella città tra i secoli XIII e XV.
3. Valencia. Il convento di San Francesco in una incisione della metà del secolo XIX.
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 101
AMADEO SERRA DESFILIS102
Gracia conducevano al convento di Sant’Agostino; i domenicani si beneficiavano della cir-colazione verso il palazzo reale (il “Real”) e soprattutto della vivacità della strade del Ma-re, che conduceva fino al porto del Grau; i carmelitani si trovavano tra l’uscita al nord dal-la porta di Serranos e il cammino di Campanar e Llíria con l’accesso del portal Nuevo. Inrealtà, il margine sinistro del Turia era popolato di suburbi a partire dalla spianata del Realfino a Campanar, i quali erano prossimi al convento del Carmen e di Santo Domenico, mache non furono mai inclusi nell’area murata e che dovevano superare l’ostacolo del fiumeattraverso i ponti, mentre la zona a sud dei terreni agricoli era orientata in prevalenza ver-so i conventi dei francescani e agostiniani.
Alla fine del siglo XIII il perimetro di Valencia era costellato dai conventi maggiori deiquattro ordini mendicanti principali in combinazione con quelli degli ordini femminili e isuburbi vicini. È probabile che si producesse una distribuzione delle aree di influenza trai diversi ordini per lo sviluppo del loro apostolato urbano e l’imprescindibile raccolta dielemosine, a volte in franca competizione con il clero parrocchiale, una disputa sostenutadall’epoca di fondazione fino al principio del secolo XV30. Così supponeva lo storico ago-stiniano Jaime Jordán al principio del secolo XVIII quando scriveva che Jaime I decise illuogo di collocazione di ciascuno dei quattro conventi maschili degli ordini mendicanti edell’ordine della Merced: “e para que éstos no estrecharan la vivienda a los ciudadanos esirvieran de baluartes para la defensa de la ciudad, les señaló los lugares fuera de los murosque entonces la cerraban, que son los mismos en que hoy están los cuatro conventos”31.Anche se questa tradizione serviva ad anticipare la data della fondazione del convento ago-stiniano fino al 1238, è cosa certa che alla fine del secolo XIII San Francesco occupava lazona meridionale, San Domenico, quella orientale; il Carmen restava al nordovest eSant’Agostino al sudest, in modo che i conventi definivano i vertici di un poligono imma-ginario il cui centro si troverebbe intorno al nucleo civico religioso di Valencia, dove si eri-gevano la cattedrale e la Curia comunale. Se questo poligono si definisce aprossimativa-mente come un triangolo con i conventi dei domenicani, i carmelitani e gli agostiniani neivertici, il baricentro coinciderebbe pressapoco con l’area della cattedrale e le piazze adia-centi, secondo un modello identificato da Enrico Guidoni nelle città dell’Italia centrale32.Per altri autori, in cambio, è la prossimità ai suburbi il fattore principale nel momento dispiegare la localizzazione delle nuove fondazioni nelle aree urbane in espansione, a partei condizionanti della topografia, le construzioni e le vie di comunicazione preesistenti, dal-le quali il convento deve rimanere separato da un’ area de rispetto33.
In effetti, l’intorno del convento doveva rimanere libero da edificazioni e da qualsiasiclasse di attività che risultasse inconveniente per la vita delle comunità mendicanti per ra-gioni morali, igieniche o qualsiasi altra classe di pregiudizio. Jaime I concesse nel 1274 alconvento di Santa Maria un privilegio affinchè si rispettasse una distanza minima di 10 pal-mi (equivalenti a 226,5 centimetri) tra le pareti del cenobio e le case che si costruirono in-torno a esso34. È probabile che il convento favorito con questa disposizione fosse quellodi Santa Maria della Merced, molto prossimo alla piazza del Mercato e al densamente po-polato quartiere della Boatella, però tenendo in conto l’appoggio della monarchia e delleautorità municipali si può supporre che misure analoghe si adottarono in favore di altrecomunità mendicanti, al fine di evitare che i conventi re stassero inghiottiti dai suburbi e
30 WEBSTER, op. cit., pp. 111-136.31 JORDÁN, op. cit., I, p. 189.32 E. GUIDONI, La città dal Medioevo al Rinascimiento, Roma-Bari 1981, pp. 138-152. FALOMIR, op. cit., p. 73.33 M. SANFILIPPO, Il Convento e la Città: nuova definizione di un tema, in Lo spazio dell’umiltà, op. cit., pp. 327-341, en especial
pp. 334-337.34 Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, Jaime I, registro 19, f. 108.
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 102
GLI ORDINI MENDICANTI E LA CITTÀ: LOCALIZZAZIONI CONVENTUALI E URBANIZZAZIONE A VALENCIA 103
4. Valencia. Il convento di San Domenico e la piazza della “Rambla de predicadors” nella pianta assonometrica di padre Vicente To-sca (1704).
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 103
AMADEO SERRA DESFILIS104
dalle “pueblas” in espansione. Le “pueblas” si possono caratterizzare come piani di urba-nizazione regolare, di iniziativa privata, per valorizzare i terreni con la costruzione di al-loggi e infrastrutture lo sfruttamento dei quali apportava diverse fonti di rendita. Per que-sto motivo, Paulino Iradiel ha interpretato che l’impatto dei cenobi mendicanti nel mer-cato immobiliare fu scarso e incluso costrinse la crescita delle “pueblas” come aree diespansione urbana35. Di fatto, sebbene i conventi avevano acquisito proprietà che per-mettevano il loro sviluppo, in alcune occasioni dovettero ricorrere ai poteri della città perampliare i loro terreni per motivi di riforma, miglioramenti e ampliamenti dei loro impianti.Nel 1347 il re Pedro IV il Ceremonioso e l’infante Pe dro, conte di Ribagorza, insistetterocon il municipio valenciano affinchè donasse alle monache dominicane di Santa Maria Mad-dalena un angolo della piazza vicina al convento e al mercato per ampliare la testata dellachiesa36. Si trattava di mantenere un suolo esteso dove elevare un’architettura ogni volta piùdecisamente monumentale in parti come la chiesa, il claustro e l’aula capitulare, e di preser-vare l’intorno urbano immediato in condizioni favorevoli di accessibilità, clausura e sicu-rezza. Per tale obiettivo servivano delle misure per mettere al bando la prostituzione e la de-linquenza, o la restrizione di altre attività come che si caricasse sabbia, si immagazzinasse illegno trasportato lungo il fiume, si gettasse lino e sterco o si fabbricassero corde nella piaz-za della rambla dei Predicadores37. Ancora più specifica è la proibizione che nelle case vici-ne del convento di San Domenico vi fossero finestre, terrazze o belvedere che affacciasse-ro all’interno del recinto di clausura dei frati38. Le lamentele per la vicinanza di prostitute,di commercianti o artigiani che molestavano con i loro comportamenti i frati predicatoridovettero essere ascoltate spesso nell’assemblea municipale come nell’udienza del re e deisuoi uf ficiali di corte. I domenicani ottennero che la corona proibisse la prostituzione inquei paraggi per ordine reale di Jaime II nel 1324 e Pedro IV il Ceremonioso nel 1338. Dueanni dopo i francescani, carmelitani e agostiniani protestarono davanti al re per la vicinan-za indesiderata delle me retrici e la delinquenza che si associava a quelle39.
Nel caso valenciano conta anche la situazione dei conventi rispetto al perimetro difen-sivo della città, aspetto già segnalato dallo storico agostiniano Jordán al principio del se-colo XVIII. Fondati fuori dalle mura, i conventi presto si circondarono di una cinta checomprendeva la chiesa e altre costruzioni con i loro orti al tempo che offriva una certa si-curezza alla comunità di frati. Oltre a definire l’ambito di loro proprietà, questi recinti con-figurarono una specie di bastioni difensivi tra i quartieri suburbani, le nuove “pueblas” eil circuito della muraglia tracciato a metà del secolo XIV40. Il tracciato delle nuove mura fuordinato da Pedro IV il Ceremonioso nel 1337, però il perimetro tornò a definirsi nel 1351con il proposito di includere i suburbi cresciuti più in là delle antiche mura e i lotti dei con-venti mendicanti che così rimanevano al riparo della fortificazione urbana41. Di conse-guenza, le mura si stirarono verso il sudest in forma di balestra in modo da cingere l’areadel convento di Sant’Agostino, la cui chiesa rimase quasi contigua al muro. Queste operedi difesa obbedivano alla necesità di proteggere lo spazio urbano da un attacco militare edalle inondazioni del Turia nel settore settentrionale, dove erano situati i conventi del Car-
35 P. IRADIEL, Mercado inmobiliario, crédito y crecimiento urbano medieval en Valencia, in Mercado inmobiliario y paisajes urbanos enel Occidente europeo (siglos XI-XV), «XXXIII Semana de Estudios Medievales» (Estella, 17-21 julio 2006), Pamplona, 2007,pp. 377-415, in particolare pp. 386-388.
36 Archivo Municipal de Valencia, Manual de Consells, A-6, f. 115.37 DIAGO, op. cit., ff. 156v-157r.38 TEIXIDOR, op. cit.,II, pp. 12-14.39 WEBSTER, op. cit., p. 93.40 FALOMIR, op. cit., pp. 70-72.41 A. SERRA DESFILIS, Ingeniería y construcción en las murallas de Valencia en el siglo XIV, en V Congreso Nacional de Historia
de la Construcción, (Burgos, 7-9 junio 2007), a cura di M. Arenillas, S. Huerta et alii, II, Burgos 2007, pp. 883-894.
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 104
GLI ORDINI MENDICANTI E LA CITTÀ: LOCALIZZAZIONI CONVENTUALI E URBANIZZAZIONE A VALENCIA 105
5. Valencia. Il convento di Sant’Agostino nella pianta assonometrica di padre Vicente Tosca (1704).
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 105
AMADEO SERRA DESFILIS106
men e di Santo Domenico, i più esposti a questo pericolo per la loro prossimità al letto delfiume. Quando l’esercito castigliano di Pedro I il Cruel assediò in due occasioni la città trail 1362 e 1364, i conventi e ospedali costruiti al margine sinistro del fiume, che rimaserofuori dal nuovo recinto murato, come lo stesso palazzo del Real, soffrirono gravi danniche obbligarono anni dopo a sostenere spese per la sua riparazione42. Anche nella città diXàtiva l’attacco delle truppe di Castiglia si accanì con il convento di San Francesco co-struito fuori dalle mura e per questo dopo la guerra si decise di ricostruirlo dentro al re -cinto difensivo. In alcune occasioni, i fondi municipali si investivano nella riparazione deirecinti murati dei conventi, come accadde nel 1372 nel convento di San Domenico dopol’assedio castigliano43.
Dal principio i conventi mendicanti sembra che avessero disposto di spazi pubblici con-tigui il cui uso cercarono di riservarsi o di controllare in misura della loro influenza sulle isti-tuzioni municipali. Di fatto, nella Valencia medievale questi spazi, vicini alla piazza del Mer-cato e quelli immediati alle tre porte della cattedrale, erano gli unici ambiti di una certa am-piezza all’interno del denso centro urbano ereditato dalla città islamica anteriore alla con-quista. Siccome il principale mezzo di azione sulla popolazione urbana erano le predica-zioni pubbliche, dentro e fuori dai templi degli ordini mendicanti, le grandi piazze vicine aiconventi funzionavano in determinate occasioni come autentici auditori di massa all’ariaaperta. In essi si tendevano teloni e si erigevano strutture di legno in modo che il predica-tore e suoi gesti potessero essere ben visibili e la loro voce tonante fosse ascoltata con chia-rezza in tutti gli angoli della piazza e anche nelle strade vicine44. Predicando in lingua vol-gare, i frati si rivolgevano a un pubblico eterogeneo e cercavano il contatto diretto con la re-ligiosità popolare. La grande influenza dei predicatori tra il po polo si accentuava nei mo-menti di esaltazione o ipersensibilità religiosa, in modo che il governo municipale cercò diindividuare le figure di maggiore spicco come il domenicano san Vincenzo Ferrer o il fran-cescano osservante fra Matteo da Agrigento. Nel 1414 il Consiglio municipale accettò diassumersi tutte le spese occorse per la visita e permanenza di san Vincenzo Ferrer a Valen-cia e, in primo luogo, “les despeses fetes en fer los cadafals e banchs al ort de preycadors perlo sermó de mestre Vicent Ferrer e fusta comprada a obrar aquells”45; nel 1428 fece allostesso modo con il francescano fra Matteo da Agrigento, pagando le spese e addirittura gliindennizzi per i danni causati ad alcune sepolture del “corral” del convento di San France-sco per montare i catafalchi per la predicazione di questo famoso francescano46.
Senza dubbio, non era infrequente che si creasse un conflitto di interesse tra le autoritàcittadine e le comunità di frati per l’uso di questi spazi pubblici. I mendicanti volevano la-sciare libero l’intorno dei loro conventi da qualsiasi attività morale o igienicamente perni-ciosa per la loro vita claustrale mentre il Comune tentava di salvaguardare il carattere pub-blico di queste piazze. La piazza del convento di San Francesco fu oggetto di controver-sia tra i frati minori e le autorità della città per motivi simili nel 1358 e 140847. Il cosiddet-to “corral” dei francescani, situato di fronte al convento, fu occupato da baracche nel 1377,quando poveri venuti dalla Castiglia non disponevano di case dove vivere48. Le condizio-
42 Archivo Municipal de Valencia, A-22, f. 33 y ff. 39v-40r, pagamenti di indennizzo nel 1400 agli intaccati dalle de-molizioni attuate sul margine sinistro del fiume durante la guerra con la Castilla e consegna di una torre delle antichemura come riparazione dei danni occorsi per la costruzione delle nuove.
43 Archivo Municipal de Valencia, Claveria de Censals, Albarans, I-5, f. 42r.44 Archivo Municipal de Valencia, Manual de Consells, A-24, f. 245v, 1410; Llibre de Certificacions del Racional, qq-
3, f. 70v, 1410; Claveria Comuna, Comptes, O-10, ff. 214v-215r, 1428.45 Archivo Municipal de Valencia, Manual de Consells, A-25, f. 128r.46 Archivo Municipal de Valencia, Manual de Consells, A-29, f. 26; Claveria Comuna, Comptes, O-10, f. 208v.47 Archivo Municipal de Valencia, Manual de Consells, A-13, f. 5v, 1358; A-24, ff. 29r-30v, 1408.48 Archivo Municipal de Valencia, Manual de Consells, A-17, f. 83v.
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 106
GLI ORDINI MENDICANTI E LA CITTÀ: LOCALIZZAZIONI CONVENTUALI E URBANIZZAZIONE A VALENCIA 107
6. Valencia. Il convento dei Carmelitani nella pianta assonometrica di padre Vicente Tosca (1704).
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 107
AMADEO SERRA DESFILIS108
ni topografiche della piazza di San Domenico indussero anche alla proibizione di levaresabbia per evitare che le acque del fiume la sommergessero in periodi di piena e in seguitosi ordinò che i tagliapietre lavorassero le pietre nei paraggi con il fine di riempire con i cal-cinacci questo antico braccio secondario del fiume fino a che nel 1598 si diede per rag-giunto l’obiettivo49. In cambio di questo uso degli spazi pubblici, i conventi men dicanti ac-coglievano assemblee civiche e riunioni delle corti del regno, rafforzando in questo modoi vincoli tra le elites governanti e le comunità dei frati. Se nel 1321 l’aula capitolare del con-vento di San Dome nico ospitò le corti del regno di Valencia, il convento di San Francescoserviva a volte da luoghi di riunione per i rappresentanti del potere cittadino50. Tuttavia,tali concessioni non furono disinteressate, poichè quando era necessario l’erario munici-pale sovvenzionava l’organizzazione dei capitoli generali e provinciali degli ordini nei con-venti della città, come fece nel 1454 a favore dei francescani e nel 1467 in aiuto dei dome-nicani51.
Per la maggior parte, le piazze servivano anche da cornice per ammirare l’architetturamonumentale delle chiese che si presentavano davanti ad esse con la facciata principale oda una visione laterale con l’abside poligonale come elemento di risalto. Per l’orientamentodella facciata so no esempi le chiese di San Domenico e del Carmen, che configuraronocon il tempo alcuni dei più solenni fronti monumentali della città, a maggior gloria dei fon-datori e della vocazione propria degli ordini. La visione d’angolo dell’esterno della testatae del profilo della chiesa con portate laterali come accesso principale fu la soluzione se-guita dai francescani e agostiniani, in gran parte condizionati dall’orientamento liturgicodei suoi templi e dalla disponibilità di terreno adiacente della piazza.
La piazza era l’ambito immediato della proiezione urbana dei conventi, ma non l’unico.Gli interessi urbanistici delle comunità dei frati mendicanti si estendevano all’idea interadella città cristiana nel pensiero di intellettuali come Francesc Eiximenis o san VincenzoFerrer52 e se portavano in pratica in operazioni di rettificazione dei tracciati di strade onell’ordinamento degli usi del suolo. I domenicani emersero in questo aspetto per la loroformidabile influenza nei confronti delle autorità co munali e davanti alla monarchia. Lapresenza del ghetto nel settore orientale del primitivo recinto murato dovette essere vistacome un inconveniente da parte dei frati predicatori. La chiusura della giudecca nel 1390aggravò la situazione obbligando i fedeli che s’indirizzavano verso il convento di San Do-menico a fare il giro oltre il quartiere della Xerea per raggiungere la piazza della “rambla depredicadors”. Di conseguenza, nel giugno del 1391 i domenicani e alcuni rappresentantidei vicini sollecitarono il Consiglio municipale ad aprire una nuova strada tra la piazza del-la Figuera e l’antica porta della Xerea53. L’assalto al ghetto, accaduto un mese più tardi, ela conseguente riduzione del recinto occupato dagli ebrei finirono per facilitare l’esecu-zione del progetto con vantaggio per l’intorno urbano del convento e il tracciato di unastrada rettilinea che in seguito sarà il principale asse di accesso alla piazza di San Domeni-co dalla città54. La nuova via dalla la piazza della Figuera fino alla porta della Xerea si con-vertirà nel primo tratto della attuale via del Mar e per il suo tracciato si adoperarono cor-
49 DIAGO, op. cit., ff. 156v-157r; L. ARCINIEGA GARCÍA, Arquitectura a gusto de Su Majestad en los monastérios de San Miguelde los Reyes y Santo Domingo (siglos XVI y XVII), en Historia de la ciudad II. Territorio, sociedad y patrimonio, a cura di S. Dauksisy F. Taberner, Valencia 2002, pp. 186-204, in particolare pp. 187-188.
50 Archivo Municipal de Valencia, Claveria Comuna, Albarans, J-3, f. 4v, 1357; Claveria Comuna, Comptes, O-1, f.6r per “una col·lació qu’es feu a frares menors per alguns fets necessaris de València” (11-IX-1365).
51 Archivo Municipal de Valencia, Claveria Comuna, Comptes, O-29, f. 121v, 1454; Claveria Comuna, Comptes, O-35, f. 117, 1467.
52 FALOMIR, op. cit., pp. 75-84.53 Archivo Municipal de Valencia, Manual de Consells, A-19, f. 231.54 Archivo Municipal de Valencia, Manual de Consells, A-24, ff. 163v-164r.
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 108
GLI ORDINI MENDICANTI E LA CITTÀ: LOCALIZZAZIONI CONVENTUALI E URBANIZZAZIONE A VALENCIA 109
7. Valencia. Il convento di San Francesco nella pianta assonometrica di padre Vicente Tosca (1704).
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 109
AMADEO SERRA DESFILIS110
8. Pianta del convento di San Domenico di Valencia nel 1842 realizzato dall’ingegnere Vicente Casanovas, prima della demolizione del1870 (Valencia, Archivio della Comandancia de Obras de la Región Militar di Valencia).
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 110
GLI ORDINI MENDICANTI E LA CITTÀ: LOCALIZZAZIONI CONVENTUALI E URBANIZZAZIONE A VALENCIA 111
de che definissero con precisione i nuovi allineamenti e permettessero di stimare gli in-dennizzi corrispondenti alle espropriazioni. Nel 1400 si costruì un canale per la bonificadella Xerea dal mulino delle cinque macine nell’attuale piazza di Alfonso il Magnanimo fi-no alla via del Mar, che servì anche per mettere in funzione le ruote del mulino, che era ri-masto senza somministrazione di acqua nel 139255. Non contenti di ciò, i domenicani ot-tennero che i privati che avevano comprato suoli nelle parcelle affettate da queste opera-zioni si privassero di essi, al fine di garantire che la comunità dei frati controllasse l’edifi-cazione e le attività di questa zona della città. In effetti, nel 1409, si decise di utilizzare il ter-reno dell’antico canale che scorreva tra la piazza della Figuera e la via del Mar per vender-lo come suolo e con il beneficio ottenuto di finanziare il tracciato di una nuova via in quellazona, ma i frati predicatori, adducendo il timore dell’insediamento di prostitute e delin-quenti nelle case che si sarebbero costruite conseguirono, per mediazione di san Vincen-zo Ferrer, che la amministrazione delle opere pubbliche della città devolvesse ai privatidanneggiati ciò che era stato investito nell’acquisto di quei terreni56.
L’occupazione di ampie superfici dell’area urbana e la costruzione di va sti complessi mo-numentali non sono che manifestazioni eloquenti del potere e del prestigio acquisiti dagliordini mendicanti nella Valencia me dievale. Da un loro inizio modesto, ma anche propi-zio, nella città recentemente conquistata da Jaime I, i frati andarono assumendo un prota-gonismo e una influenza decisivi nella storia urbana. Il loro precoce radicamento, l’ascen-dente che esercitavano tanto tra il patriziato come tra le classi popolari attraverso la devo-zione, le confraternite e le sepolture si possono paragonare con ciò che questi ordini con-seguirono nel resto d’Europa. Ebbene, le loro condizioni d’insediamento furono partico-larmente favorevoli grazie alla congiuntura della colonizzazione della città dopo la con-quista e il sostegno sostenuto dalla corona dai tempi di Jaime I sino alla fine del Medioevo,alla quale succedettero i poteri comunali e le elite del patriziato urbano, come si evidenzianella seconda ondata di fondazioni conventuali posteriori alla crisi della metà del Trecen-to: conventi di monache agostiniane San Cristoforo (1409), promosso da Martín I l’Uma-no, di Santa María de Jesús di francescani osservanti (1427), quello delle clarisse della Tri-nità (1445), entrambi promossi dalla regina María di Castiglia, sposa di Alfonso il Magna-nimo; quello delle monache domenicane di Santa Caterina da Siena nel 1491 nel suolodell’antico cimitero ebreo, con il patrocinio di Fernando II il Cattolico e le autorità comu-nali; e quello delle clarisse di Jerusalén nel 1496, fondato dalla famiglia Cabanilles57. I fra-ti poterono sviluppare lentamente un piano costruttivo prudente al principio che andòespandendo le sue ali nel secolo XIV, quando si alzarono grandi templi ad una navata, co-perti con tetti di legno o voltati e con cappelle tra i contrafforti, claustri, dormitori, aule ca-pitolari e celle individuali per i membri più importanti della comunità. Per le loro imprese,incontrarono quasi sempre l’appoggio del Comune, che sovvenzionava direttamente leopere, adducendo che oltre che per assistere la comunità che aveva fatto voto di povertà,la costruzione di grandi complessi conventuali contribuiva a imbellire la immagine pub-blica della città, proprio come teorizzava anche Francesc Eiximenis nelle sue opere: cosìle casse municipali finanziarono, tra le altre, le opere del dormitorio dei domenicani nel1371-1376, il chiostro dei francescani nel 1376, le chiese e conventi di Sant’Agostino e delCarmen questo stesso anno, i lavori del convento di Santa Chiara e Santa Elisabetta di Un-gheria nel 1376 e 1454, il convento di Santa María di Jesús en 1429, la cappella di San Vin-
55 Archivo Municipal de Valencia, Manual de Consells, A-19, f. 208; Sotsobreria de murs i valls, d3-12, ff. 159r-172r.TEIXIDOR, op. cit., II, p. 12.
56 TEIXIDOR, op. cit., II, pp. 13-14.57 M. D. CABANES PECOURT, Los monasterios valencianos. Su economía en el siglo XV, Valencia 1974; A. ROBLES SIERRA,
Real Monasterio de Santa Catalina de Siena, Valencia 1993; F. ALMELA Y VIVES, El Monastério de Jerusalén, Valencia 1941.
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 111
AMADEO SERRA DESFILIS
cenzo Ferrer nel convento dei domenicani nel 1460 e il sofitto ligneo del dormitorio delconvento della Trinità in tempi di sor Isabel di Villena (1468)58. I fondi comunali contri-buirono anche all’apparizione delle prime celle individuali nei conventi valenciani, desti-nati al principio ai membri più notevoli di questa comunità religiosa: così furono conse-gnati 800 soldi al convento di Sant’Agostino nel 1373 a favore di fra Miquel Cardener, pro-vinciale dell’ordine in Aragona, “per fer obrar en lo monestir dels frares agustins de la di-ta ciutat una cambra per son estatge, per ço que aquell haja major raó de estar en aquestaciutat”59.
I terreni che si andarono occupando dal secolo XIII e ampliando in seguito furono par-ti chiave del paesaggio urbano che condizionarono la costruzione delle nuove mura e laestensione del caseggiato nei suburbi e nello spazio interno alle mura. In realtà, il model-lo di sviluppo di Valen cia dalla conquista del 1238 fino alla metà del secolo XIV può ca-ratterizzarsi come frutto della combinazione delle “pueblas” e i grandi recinti conventua-li dei frati mendicanti, e in ambo i casi il ruolo della mo narchia nello sviluppo fu decisivonel momento di favorire queste modalità di colonizzazione, insediamento ed espansionedello spazio urbano. Quando si tentò di portare a compimento un ultimo piano di urba-nizzazione nell’antico cimitero ebreo, il “fossar dels jueus”, sul suolo della attuale piazzadi los Pinazo, i risultati per gli investitori furono poco allettanti poiché molti lotti (“patuadomorum”) rimasero senza essere edificati a metà del secolo XV e di nuovo si scelse peruna nuova fondazione conventuale per le suore domenicane di Santa Caterina da Siena: sichiudeva così il ciclo di un modello di espansione urbana nel quale i conventi andavano acolmare gli spazi di minor valore per il mercato immobiliare con impianti più modesti ri-spetto ai grandi conventi fondati nel secolo XIII e contando, come di solito, sull’appog-gio del Comune, che donò parte dei terreni, e della corona, che fece la sua parte con l’an-tico cimitero ebraico confiscato agli ebrei convertiti “per il crimine di heressia”60.
112
58 SERRA DESFILIS, op. cit., pp. 205-208; Archivo Municipal di Valencia, Claveria di Censals, Albarans, I-9, ff. 9r, 11v,13r y 17v (1376, fabbrica del convento di San Francesco, convento e chiesa del Carmen; convento di Santa Chiara e San-ta Elisabetta e convento e chiesa di Sant’Agostino rispettivamente) Claveria Comuna, Comptes, O-11, f. 172v (1429,convento di Santa Maria de Jesús), O-29, ff. 137v-138r (1454, convento di Santa Chiara e Santa Elisabetta); O-32, ff.107v-108r (1460, cappella di San Vincenzo Ferrer); O-36, f. 101 (1468, convento della Trinità).
59 Archivo Municipal de Valencia, Claveria de Censals, Albarans, I-6, ff. 36r y 40r.60 Il relativo fallimento dell’operazione urbanistica del “fossar dels jueus” nel IRADIEL, op. cit., pp. 399-400; sopra il
convento di Santa Catalina da Siena, fondato da Fernando II il Cattolico a instanza di fra Gaspar Fayol en 1491, e la con-figurazione del lotto dove si costruì negli anni succesivi, TEIXIDOR, op. cit., II, pp. 197-200.
095-112_Serra Desfilis_007_Serra Desfilis 07/04/14 12.02 Pagina 112