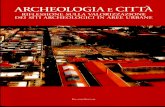Sensitive biosensors using Fano resonance in single gold nanoslit with periodic grooves
Fratarcangeli M., Salvagni I., Città e guerra: il caso di Ancona e Fano nelle fotografie del...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Fratarcangeli M., Salvagni I., Città e guerra: il caso di Ancona e Fano nelle fotografie del...
STUDI MACERATESI
47
TERRIToRIo, CITTà E SpAzI pUbblICIDAl MonDo AnTICo
All’ETà ConTEMpoRAnEA
II.lA forma urbis.
CITTà REAlE E CITTà IMMAgInATA
AbbADIA DI fIASTRA (Tolentino)
26-27 novEMbRE 2011
M A C E R A T A
CEnTRo DI STUDI SToRICI MACERATESI2013
Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
città e guerra: il caso di ancona e di Fano nelle FotograFie del colonnello
John bryan Ward-Perkins (*)
tra tutte le cause di trasformazione della città – eccezion fatta, naturalmente, per le calamità naturali – la guerra è sicura-mente la più violenta, repentina, traumatica e devastante, i cui esiti si traducono d’impatto in forma urbana, violando i primitivi topoi, annientando o compromettendo per sempre, in molteplici casi, vocazioni e potenzialità originarie dei luoghi, e deviandone irrimediabilmente, troppo spesso, il corso della storia.
occupato dai tedeschi in ritirata nell’autunno del 1943, parte integrante dall’anno successivo del fronte difensivo che avrebbe dovuto rallentare l’avanzata alleata, teso dal feldma-resciallo albert kesselring sui rilievi montuosi compresi fra il Mar tirreno e l’adriatico seguendo il tracciato continuo che da Massa carrara conduceva fino a Pesaro e che sarebbe rimasto tristemente noto come Linea Gotica, il territorio delle Marche ha pagato alla seconda guerra Mondiale un notevole tributo in termini di vite umane e di distruzione del proprio patrimonio artistico e architettonico, diventando, tra l’estate del 1944 e quella del 1945, teatro di violenti scontri e oggetto di ripetuti attacchi alleati.
la letteratura specialistica ha in parte affrontato dal
(*) il presente testo è esito del lavoro congiunto delle autrici, delle quali rispec-chia in maniera condivisa il parere scientifico sul tema; nel dettaglio i paragrafi i, iii sono da considerarsi a firma di isabella salvagni e il paragrafo ii a firma di Margheri-ta Fratarcangeli. si ringraziano la dott.ssa alessandra giovenco e la dott.ssa valerie scott della british school at rome per la disponibilità e il supporto al contributo.
726 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
punto di vista storico tali avvenimenti, con particolare attenzione all’impatto sociale (ed emotivo) provocato dalla catastrofe sulla regione e sulla popolazione, restituendone all’attenzione degli studiosi alcuni aspetti particolari (1) e cristallizzandone la memoria in appositi musei, quali il Museo della liberazione di ancona – che custodisce la remi-niscenza visiva del conflitto consumato nell’area delle Marche –, al quale fanno eco, sul territorio nazionale, analoghi alle-stimenti come, ad esempio, il Museo della seconda guerra Mondiale del Fiume Po di Felonica (Mantova), il Museo della guerra – linea gotica di castel del rio (bologna), o il Museo della liberazione di roma.
1. un osservatorio privilegiato: la monuments, fine arts and archives sub-commission
un osservatorio del tutto particolare e privilegiato delle città in tempo di guerra è costituito dalla Monuments, Fine Arts and Archives Sub-commission (nota con l’acronimo di
(1) si vedano ad esempio, M. Salvadori, La Resistenza nell’anconetano e nel Piceno, roma, opere nuove, 1962; Le donne raccontano: guerra e vita quotidiana. Ancona 1940-1945, a cura di M.g. Camilletti, ancona, istituto gramsci Mar-che, 1994; W. Caimmi, Al tempo della guerra, ancona, a.c. remel, 1996; La battaglia di Ancona del 17-19 luglio 1944 e il secondo Corpo d’Armata polacco, a cura di g. Campana, Falconara Marittima, errebi, 2001; Quando la morte venne dal cielo. Il bombardamento aereo di Falconara del 30 dicembre 1943, a cura di g. Campana e r. GiaComini, Falconara Marittima, errebi, 2003; Ancona 1944. Immagini dei fotografi di guerra inglesi e polacchi, a cura di G. Campana e r. orSetti, Falconara Marittima, istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche, 2004 (Quaderni di storia della fotografia); r. GiaComini, Ribelli e partigiani. La Resistenza nelle Marche 1943-1944, ancona, affinità elettive, 2005; K. de Souza, Fuga dalle Marche. Prigionia ed evasione di un ufficiale di aviazione inglese (1942-1944), ancona, affinità elettive, 2005; II secondo Corpo d’armata polacco nelle Marche. 1944/1946 fotografie, a cura di G. Campana, catalogo della mostra (loreto, 2005), s.l, s.e., 2005; La guerra nelle Marche (1943-1944), a cura di s. Sparapani, atti del convegno La liberazione di Ancona e la battaglia sul fronte Adriatico (ancona, 21 maggio 2004), ancona, il lavoro editoriale, 2005 (ricerche storiche, 12); Agosto 1944. Churchill nelle Marche. Dietro le immagini, a cura di G. Campana e r. orSetti, osimo, tipo-luce, 2006; 1943-1947. Il secondo Corpo d’Armata Polacco in Italia, a cura di G. Campana, Ancona, istituto regionale per la storia del movimento di liberazione delle Marche, 2009 (Quaderni del Museo della liberazione, 1).
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 727
MFaa), appositamente creata all’interno dell’esercito alleato per monitorare la «sorte» dell’intero patrimonio artistico e monumentale europeo. a tale organismo, nato in concomi-tanza con l’entrata in guerra degli stati uniti sulla spinta di organizzazioni private e istituito formalmente nell’ottobre 1943 a conflitto in corso, veniva affidato il compito di ese-guire una ricognizione a tappeto sulle maggiori città d’arte e sulle relative emergenze monumentali, preliminarmente ai previsti attacchi militari, mettendo in opera poi, a «libe-razione» avvenuta, in accordo con istituti e autorità locali preposti alla tutela del patrimonio artistico monumentale, tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per limitare i danni delle operazioni belliche, affiancando i medesimi organismi statali nell’organizzazione e nell’esecuzione degli interventi ritenuti urgenti su opere e monumenti colpiti e danneggiati, per scongiurarne l’ulteriore compromissione. Pur se subor-dinata alle priorità strategiche belliche ritenute ineluttabili dai vertici militari, che non riuscì in alcun modo a condizio-nare, il maggior merito della Sub-commission, soprattutto nel caso italiano, consistette proprio nelle «provvidenze» (come gli stessi alleati le definirono) messe in atto all’indomani dei bombardamenti, ovvero nell’allestimento degli interventi di «primo soccorso» e d’emergenza, nel supporto offerto agli organi di tutela nazionale per attivare l’erogazione dei fondi stranieri destinati allo scopo, come pure nella continua azione di sorveglianza svolta contro saccheggi e vandalismi, azioni tutte che permisero di traghettare cospicue porzioni di patrimonio artistico sottratte alle requisizioni degli eserciti dell’asse oltre il periodo di interregno seguito alla fine del conflitto, e di riconsegnarlo formalmente nelle mani delle preposte autorità nazionali.
nell’arco di tempo compreso tra lo sbarco in sicilia (luglio 1943), la definitiva resa tedesca (2 maggio 1945) e il passaggio di consegne al Ministero e alle soprintendenze statali (dicembre 1945), l’italia costituì il banco di prova della grandiosa macchina operativa messa in atto dalla Sub-commission, la cui immane attività svolta sul territorio nazio-nale è testimoniata anche dall’ingente corpus documentario versato presso i national archives di Washington, disponibile
728 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
in copia microfilmata presso il nostro archivio centrale dello stato (2), e da tempo noto agli studiosi (3).
tale corposa documentazione ci restituisce l’azione di monitoraggio delle principali città italiane, dei loro monu-menti e opere d’arte allestita precedentemente alle azioni militari, esplicita i piani di intervento, individua le emergenze
(2) Per l’area delle Marche si vedano in particolare i seguenti documenti: ar-chivio centrale dello stato, roma (acs), Allied Commission Control, bob. 149d, scat. 55, scaff. 55, fasc. 55 (insieme ad abruzzi, umbria e Molise, giugno 1945 - giugno 1946, per le Marche vedi records 4955, 3933, 4907-4896, 4893-4888), ibidem, bob. 150d, scaff. 49, fasc. 56 (abruzzi, Marche, regione generale, novembre 1944-maggio 1945, per le Marche vedi records 5168-5159, 5113-5663, 5658-5656, 5654-4991), fasc. 57 (abruzzi, Marche, regione generale, gennaio 1943-novembre 1944, records 5384-5383, 5378-5370, 5357-5354, 5347-5336, 5332-5324, 5316-5296, 5290-5289, 5272), fasc. 58 (abruzzi, Marche, Mappe, novembre-dicembre 1943); ibidem, bob. 204b, scaff. 50, fasc. 217 (Final report Marche, novembre 1945, records 698-690).
(3) al riguardo si vedano gli indispensabili studi di C. CoCColi, Repertorio dei fondi dell’Archivio centrale dello Stato relativi alla tutela dei monumenti italiani dalle offese belliche nella seconda guerra mondiale, in Monumenti alla guerra. Città, danni bellici e ricostruzione nel secondo dopoguerra, a cura di G.p. treCCani, Milano, Franco angeli, 2008, pp. 303-329; eadem, «First aid and repairs». Il ruolo degli alleati nella salvaguardia dei monumenti italiani, in «anagke−», n.s., lXii (2011), pp. 13-23, e, da ultimo, Guerra, monumenti, ricostruzione. Architetture e centri storici italiani nel secondo conflitto mondiale, a cura di l. de Stefani e la col-laborazione di C. CoCColi, venezia, Marsilio, 2011, C. CoCColi, Die Denkmäler Italiens und der Krieg, präventiver Schutz, Erste Hilfe und Instandsetzungen: die Rol-le der «Monuments, Fine Arts and Archives Subcommission» in Italien während des Zweiten Weltkriegs, in Kunsthistoriker im Krieg. Deutscher Militärischer Kunstschutz in Italien 1943–1945, a cura di C. fuhrmeiSter, J. Griebel, S. KlinGen, r. pe-terS, köln, böhlau, 2012, pp. 75-92. cfr. inoltre i. baldriGa, Contributo alla storia dei danni di guerra: l’opera della Allied Commission for Monuments Fine Arts anc Archives, in «ricerche di storia dell’arte», 68 (1999), pp. 87-93; e i saggi di r. ranieri, La tutela del patrimonio culturale in Italia durante la Seconda guerra mondiale, e di S. rinaldi, I monumenti italiani e la guerra, in Protezione e recupero del patrimonio culturale durante i conflitti, a cura di m.G. fadiGa, atti della conferenza I lunedì della crociera (roma, 23 novembre 2009), [s.l.], uguccione ranieri di sorbello Foundation, 2011, pp. 53-67, 69-87. a questi vanno affiancati testi di più ampio respiro europeo: citiamo unicamente i volumi di r. m. edSel, b. Witter, The monuments men. Allied heros, Nazi thieves, and the greatest treasure hunt in history, london, Preface, 2009, i più divulgativi i. daGnini brey, Salvate Ve-nere! La storia sconosciuta dei soldati alleati che salvarono le opere d’arte italiane nella Seconda guerra mondiale, Milano, Mondadori, 2010 (i° ed. new york 2009) e r. M. edsel, Saving Italy: The Race to Rescue a Nation’s Treasures from the Nazis, new york, norton & company, 2013.
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 729
storico-artistiche e architettoniche, e, ad azione compiuta, rendiconta attraverso diversi reports gli esiti dei sopralluoghi effettuati, illustrando le ricostruzioni e gli interventi in corso. il gruppo degli ufficiali preposti all’operazione – che, deve essere ribadito, non ha precedenti sia per estensione del ter-ritorio interessato, sia per il sincronismo delle azioni, sia per il brevissimo lasso di tempo nel quale l’impresa venne messa in atto – fu composto dai maggiori studiosi ed esperti del set-tore storico-artistico (prevalentemente archeologi e architetti, ma anche storici dell’arte) reclutati appositamente allo scopo nei paesi alleati del regno unito e degli stati uniti d’ame-rica (4), capeggiati dallo statunitense ernest theodore de Walde (1891-1968), in qualità di direttore, e dall’archeologo inglese John bryan Ward-Perkins (1912-1981) nelle vesti di vice direttore.
la consapevolezza da parte degli alleati che l’italia fosse un territorio particolare dal punto di vista artistico e culturale, da monitorare quindi con maggior riguardo, è confermata dall’incarico affidato dal primo ministro inglese Winston churchill alla British Committee on the Preservation and Restitution of Works of Art, Archives and Other Material in Enemy Hands per la valutazione dello stato di città, monumenti, chiese, biblio-teche e opere d’arte alla fine della seconda guerra Mondiale, rendicontazione interna alla molteplice attività della MFaa nota come Works of Art in Italy (5), avviata in concomitanza con le prime «liberazioni» e con l’avanzata verso nord delle truppe alleate. la volontà (spesso disattesa) di voler limitare le distruzioni ai soli casi considerati inevitabili dal punto di vista militare è espressa anche nelle Istruzioni del comandante del Quartier generale della Mediterranean Allied Air Force redatte il 7 aprile 1944, nelle quali le principali città italiane
(4) daGnini brey, Salvate Venere!…, cit. nella nota precedente.(5) Works of Art in Italy. Losses and Survivals in the War, london, h. M. sta-
tionery off., 1945; vedi anche The Age of Mars, Introduzione al volume curata da a. banfi, G. bordiGnon, m. Centenni. il volume edito nel 1945 costituisce la prima parte della relazione e descrive lo stato in cui versano le città dell’italia centro-meridionale; la seconda parte, datata 1946, riguarda le città settentrio-nali, con un’appendice su alcune città a sud di bologna, al fine di completare il quadro che nel 1945 non era ancora definitivo.
730 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
furono divise in tre categorie sia in base all’ordine d’impor-tanza (deciso secondo criteri altrettanto spesso confusi e non sempre condivisibili) sia per ineluttabilità della necessità del bombardamento ai fini militari.
tragicamente, ancona rientrò nella terza categoria, rela-tiva alle città nelle quali «vi sono importanti obiettivi militari […]. Questi devono essere bombardati e ogni danno che ne derivi è accettato» (6).
degli esiti dello studio sulla documentazione della Monu-ments, Fine Arts and Archives Sub-commission, per evidenti motivi di «spazio» si presentano in questa sede solo alcuni aspetti fondamentali, concentrando l’attenzione sui due emblematici «casi» urbani costituiti da ancona e da Fano, e cercando di portare all’attenzione dell’osservatore il particolare punto di vista per così dire «documentale» e «catalografico» offerto dalle quarantasei fotografie che il colonnello Ward-Perkins scattò nelle due città, uniche ad essere rappresentate di tutto il territorio delle Marche, fatta eccezione per le tre istantanee riservate al castello di gradara.
2. fotografia e guerra: john bryan ward-perkins
Figura centrale della MFaa, in particolare nel caso italiano, fu John bryan Ward-Perkins (7), che si occupò personalmente anche della campagna fotografica relativa alle principali loca-lità bombardate, scattandovi parte delle foto che costituiscono il prezioso materiale figurativo a corredo della monumentale documentazione prodotta dalla Sub-commission. storico dell’ar-chitettura classica e archeologo, direttore della british school at rome per 28 anni, la sua statura di studioso è riconosciuta a livello internazionale e la sua biografia in tempo di guerra si
(6) cfr. a. banfi, G. bordiGnon, m. Centenni, The Age of Mars, Introduzio-ne, in Works of Art in Italy…, cit. alla nota precedente.
(7) una breve biografia di Ward-Perkins (ma anche di Wheeler e de Walde) è in r.m. edSel, b. Witter, The monuments men. Allied heros, Nazi thieves, and the greatest treasure hunt in history, london, Preface, 2009; per un profilo metodolo-gico, J. reynoldS, John Bryan Ward-Perkins, CMG, CBE, FBA, in «Papers of the british school at rome», 48 (1980), pp. Xiii-Xvii.
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 731
sovrappone con la storia dei bombardamenti alleati e l’azione di monitoraggio e salvaguardia dei monumenti (Fig. 1). dopo la laurea nel 1934, tra il 1936 ed il 1938, Ward-Perkins è assistente conservatore al london Museum, sotto la direzione dell’archeologo sir robert eric Mortimer Wheeler; insieme i due si ritrovano in piena guerra come ufficiali nel 1941 in nord africa, nell’area di leptis Magna, dove riescono a otte-nere l’approvazione per la messa in atto di una serie di misure di salvaguardia del sito archeologico. nel 1939 accetta la cattedra di archeologia all’università di Malta, dove rimane solo sei mesi, arruolandosi nella british royal artillery. con il grado di maggiore è assegnato dapprima al nord africa; qui, grazie alla sua preparazione, con l’intervento di ernest de Wald, già allora professore di arte e archeologia a Princeton, e di Wheeler, è incaricato di organizzare un dipartimento deputato alle antichità per la cirenaica e per la tripolitania. divenuto tenente colonnello, viene spostato in italia dove, tra i circa ventisette ufficiali addetti, è nominato vice direttore della sottocommissione alleata per il territorio nazionale, della quale è direttore de Wald. a conflitto terminato, dal 1945 al 1946 si occuperà personalmente della chiusura dell’archi-vio e conclusa l’esperienza, accetterà la posizione di direttore della british school at rome, rimanendovi sino al 1974. i suoi campi principali di studio hanno riguardato soprattutto l’arte antica e la topografia della città. le sue ricognizioni ter-ritoriali, in particolare dell’etruria meridionale, restituiscono uno studioso innovativo che, parafrasando il grande topografo italiano Ferdinando castagnoli «fu uno dei pochi archeologi a rendersi conto come le trasformazioni sul territorio che erano scattate negli anni cinquanta […] segnavano l’ultima occasione per una documentazione delle antichità esistenti sul territorio» (8). Forse anche relativamente ai successivi studi, i danni e le cancellazioni perpetrate dalla guerra gli avevano insegnato molto. le sue metodiche ricognizioni sul territorio rimangono a tutt’oggi un modello di analisi topografica atta
(8) F. CaStaGnoli, John Brian Ward-Perkins [necrologio], in «studi romani», 30 (1982), pp. 87-88.
732 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
ad una concreta comprensione di fenomeni quali l’economia fondiaria, la demografia, l’organizzazione territoriale in un arco temporale che dalla protostoria giunge al medioevo, e che possono qualificare Ward-Perkins soprattutto come uno storico che, utilizzando trasversalmente l’archeologia assieme ad altre discipline, riuscì a rileggere intere aree neglette e marginali, indicando un nuovo e proficuo metodo di studio. Per le ricognizioni topografiche, quale probabile retaggio del lavoro svolto in tempo di guerra, fece uso costantemente della fotografia aerea e delle mappe dell’esercito militare, che utiliz-zava anche durante le sue passeggiate nella campagna romana e durante i meeting svolti con gli studenti, subordinando per lo più l’attività di scavo alla soluzione di specifici problemi topografici (9).
Ward-Perkins è oggi forse maggiormente noto per i suoi studi sull’architettura romana (in italia, e nelle Province dell’impero), sulle influenze che legarono reciprocamente roma, la grecia e le province, studi nei quali l’architettura è letta e interpretata quale esito della circolazione di idee e dei rapporti dialettici instauratisi fra persone e luoghi. i suoi Etru-scan and Roman Architecture e l’Architettura Romana (10), editi entro la prima metà degli anni settanta del novecento, sono ancor oggi usati come manuali di riferimento nelle facoltà d’architettura, così come rimangono fondamentali alcune sue ricerche su singoli edifici. egli diede nuovo impulso anche al progetto Tabula Imperii Romani, iniziato nel 1928 da osbert crawford, divenendone dal 1967 al 1981 il direttore, confer-mando così il suo estremo interesse per l’uso e l’interpretazione delle immagini aeree in campo archeologico.
le fotografie che Ward-Perkins e i suoi aiuti scattarono in tempo di guerra, che coprono la maggior parte delle regioni
(9) va segnalato l’interessante saggio scritto da J.b. Ward-perKinS, utiliz-zando la tecnica della fotointerpretazione, Landscaper and history in Central Italy, oxford, b.h. blackwell, 1964 (J.l. Myres Memorial lecture, 2).
(10) a. boethiuS, J.b. Ward-perKinS, Etruscan and Roman architecture, har-mondsworth, Penguin, 1970 (the Pelican history of art, 32); J.b. Ward-per-KinS, Architettura Romana, Milano, electa, 1974 (storia universale dell’architet-tura, 2).
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 733
italiane, restituiscono molto dell’‘occhio’ che le realizzò: vi tra-spare in maniera evidente la volontà di documentare la ferita subita dall’edificio rappresentato, ma vi si coglie soprattutto la modalità «severa» e calibrata con la quale si avvicinava all’archi-tettura, sia che questa fosse monumentale o fosse seriale. l’obiet-tivo fotografico attraverso il quale egli traduceva in immagine la realtà e l’obiettivo scientifico che si proponeva erano guidati da un comune intento, e rispondevano evidentemente ad una stessa irrinunciabile esigenza: quella, centralissima, di documentare rigorosamente l’oggetto architettonico e/o archeologico (Fig. 2).
in tal modo, anche in uno scenario come quello della guerra, secondo un procedimento di acquisizione dei dati quasi impersonale, tutta la realtà viene proiettata in una dimensione a-temporale e in una sorta di rarefatta «quiete», oltre il cla-more e lo shock emotivo provocato dalla vista delle rovine. i suoi scatti sono esenti da qualunque implicazione di tipo retorico, evocativo, o di spettacolarizzazione delle macerie, si focaliz-zano solo sulle architetture, come semplice ‘dato’ inerte, che tuttavia riprende vita se accostato ai reports stilati dall’ufficiale addetto ai sopralluoghi, e che restituisce la quarta dimensione alla visione bidimensionale delle fotografie. le immagini rac-contano gli edifici, o quello che ne rimane, analizzandoli per brani o mettendo a fuoco dettagli, ma soprattutto certificano, nel loro nitido bianco e nero – come forse solo lo sguardo di un archeologo avrebbe potuto fare –, le ferite di un tessuto edilizio, divenendo uno strumento irrinunciabile per catalogare, archi-viare e divulgare un brandello di storia. l’immobile solennità dei lacerti delle città devastate è ritratta quasi sempre in assenza di figure umane; le poche volte che esse appaiono, per lo più di spalle, sembrano quasi dei fantasmi, che tuttavia alludono al lavoro svolto dagli alleati per il monitoraggio e la salvaguardia dei beni danneggiati: sono infatti gli ufficiali Maxse o Marriott o lo stesso Wark-Perkins che compivano cadenzati sopralluoghi nelle città colpite (di media una volta al mese), affiancati dal sovrintendente o dal funzionario del Ministero italiani (Fig. 3). È altresì vero che le persone in quei luoghi, spesso irreparabil-mente danneggiati, non possono più stare.
le fotografie non restituiscono gli stati d’animo con cui si guardava ciò che restava dopo la devastazione, ma certamente
734 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
passeggiare sulle macerie di un edificio, di cui tutti conosce-vano il valore storico (le dettagliate e gerarchiche Harvard Lists (11) compilate erano esplicite al riguardo) doveva tra-smettere un non so che di spettrale. le immagini uscite dalla kodak di Ward-Perkins possono rappresentare in tal senso, forse, anche l’esorcizzazione di una perdita.
se è vero che gli scatti eseguiti dal maggiore inglese e dai suoi collaboratori costituivano l’indispensabile documenta-zione visiva di supporto alla ricognizione documentario-archi-vistica espletata dalla Sub-commission, è anche vero che erano un modo per presidiare l’area, e dunque per resistere e poter veri-ficare quanto del patrimonio monumentale originariamente in sito era ancora, nonostante tutto, rimasto in piedi. Fu proba-bilmente la sua ‘vocazione’ archeologica, la consuetudine con lo studio dell’antico, a portare Ward-Perkins a conservare in copia nel proprio archivio l’intero corpus delle foto scattate in italia (e non solo). Foto che diventano testimoni di un passato che tra-mandano ai libri e alle persone che li fruiscono, re-indirizzando la memoria sui luoghi, e costringendoci a fare i conti con la storia.
Molte delle fotografie realizzate dalla Allied Commission Control si trovano, mescolate con altre immagini, anche presso gli archivi fotografici delle soprintendenze italiane, a conferma di una collaborazione e cooperazione che è facile riscoprire e seguire attraverso le raccolte documentali dei singoli istituti. tuttavia, se le fotografie conservate presso gli archivi delle soprintendenze, commissionate ad hoc per documentare lo stato dell’oggetto artistico, sono caratterizzate dalla «trasparenza» o dalla scomparsa del fotografo, o ancora dalla sottesa ricerca di produrre un’immagine denotata e oggettiva, quelle raccolte da Ward-Perkins, a ben vedere, lasciano cogliere l’uomo che le ha volute fissare indelebilmente sulla pellicola.
(11) tali elenchi di edifici di importanza storica e artistica furono allesti-ti a cura del comitato dell’american defense-harvard group per individuare monumenti e opere d’arte nei paesi coinvolti nella seconda guerra Mondiale, con lo scopo di prevenire e tutelare ulteriori distruzioni (al riguardo rinviamo unicamente a c. CoCColi, «First aid and repairs»…cit., p. 14).
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 735
la fotografia che documenta i danni della seconda guerra Mondiale non ha al suo attivo molti studi critici che l’abbiano valutata con l’intento di inserirla in un processo evolutivo della storia di questa disciplina e della percezione visiva del fotografo. essa è stimata per lo più per il portato semantico e storico che mostra di possedere: è memento storiae, documenta-zione del danno e del perduto, e in tal senso è usata soprattutto nelle ricerche storico-architettoniche che si occupano del con-servato e del restauro storico.
vent’anni dopo gli scatti di Ward-Perkins viene pub-blicato un saggio fondante sulla ‘retorica dell’immagine’ del semiologo francese roland barthes, che ci appare quanto mai utile e ascrivibile al caso fotografico in esame (12). certo può apparire audace retro-applicare la teoria barthesiana a quanto fin qui esposto – non vi sono soprattutto i presupposti storici – ma di certo la Rhétorique de l’image può essere d’aiuto per una nuova disamina e una più significante valutazione della fotografia in tempo di guerra, la quale non è forse così affa-scinante come quella prodotta subito dopo gli eventi bellici, ed etichettata come ‘neorealista’, ma di sicuro può diventare foriera di letture alternative.
Per barthes
«la fotografia possiede il potere di trasmettere l’informazione (letterale) senza formarla con l’aiuto di segni continui e regole di trasformazione. bisogna dunque opporre la fotografia, messaggio senza codice, al disegno, che, quand’anche denotato, è un messaggio codificato. […] la fotografia, se può scegliere il proprio soggetto, l’inquadratura e l’angolazione, non può intervenire all’interno dell’oggetto (se non mediante il trucco)».
e ancora, nella fotografia «il rapporto tra i significati e i significanti non è di «trasfor-
mazione» ma di «registrazione», e l’assenza del codice rafforza evi-dentemente il mito del «naturale» fotografico: la scena c’è, captata meccanicamente, ma non umanamente (il meccanico è qui pegno di oggettività). gli interventi dell’uomo sulla fotografia (inquadra-
(12) Per le implicazioni tra semiologia e fotografia si rinvia a C. marra, Le idee della fotografia. La riflessione teorica dagli anni Sessanta a oggi, Milano, Mon-dadori, 2001.
736 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
tura, distanza, luce, flou, «filato», ecc.) appartengono effettivamente tutti al piano della connotazione; tutto avviene come se ci fosse all’inizio (anche in senso utopico) una fotografia brutta (frontale e netta), sulla quale l’uomo disporrebbe, grazie a certe tecniche, i segni appartenenti al codice naturale. soltanto l’opposizione tra il codice culturale e il non-codice culturale può, a quanto sembra, rendere conto del carattere specifico della fotografia e permettere di misurare la rivoluzione antropologica che essa rappresenta nella storia dell’uomo, poiché il tipo di coscienza che essa implica è in verità senza precedenti. la fotografia installa non una coscienza dell’esserci della cosa (che ogni copia potrebbe suscitare), ma una coscienza dell’esserci-stato. si tratta dunque di una nuova categoria dello spazio-tempo: locale immediato e temporale anteriore; nella fotografia si produce una congiunzione illogica tra qui e un tempo. È dunque a livello di questo messaggio denotato o messaggio senza codice che si può comprendere pienamente l’irrealtà reale della foto-grafia; la sua irrealtà è quella del qui, perché la fotografia non è mai vissuta come un’illusione […]; e la sua realtà è quella dell’esserci-stato, perché in ogni fotografia vi è l’evidenza sempre sorprendente del: è accaduto così: noi possediamo allora, prezioso miracolo, una realtà di cui siamo sicuri» (13).
Partiamo dunque dall’’esserci-stato e dall’è accaduto così, sui quali ci instradava barthes per provare a leggere e vedere una «realtà di cui siamo sicuri». nel nostro caso i danni al patri-monio artistico marchigiano.
3. città, guerra, ricostruzione: ancona e fano
diverse e diversamente colpite dalla guerra sono ancona e Fano. la prima (14), capoluogo della regione, ha legato for-temente la sua identità al mare, distendendosi intorno all’in-
(13) r. bartheS, L’ovvio e l’ottuso, torino, einaudi, 1985 (traduzione italiana di Rhétorique de l’image, in «communications», 4, 1964).
(14) tra gli studi più recenti sulla storia urbana di ancona si citano per tutti: r. pavia, e. Sori, Ancona, roma, laterza, 1990; s. SebaStiani, Ancona: forma e urbanistica, roma, l’erma di bretshneider, 2004; F. mariano, I piani e le trasformazioni urbanistiche in Ancona dall’Unità alla Seconda Guerra Mondiale. 1860-1943, in Territorio, città e spazi pubblici dal mondo antico all’età contemporanea, 1. Il paesaggio costruito. Trasformazioni territoriali e rinnovo urbano, atti del Xlvi convegno di studi Maceratesi (tolentino, 20-21 novembre 2010), Macerata, centro di studi storici Maceratesi, 2012 (studi Maceratesi, 46), pp. 535-580.
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 737
senatura naturale dominata dal monte guasco – il «gomito», ’Aγκων, appunto, da cui aveva mutuato il nome la primitiva colonia greca sulla quale si strutturava la città successiva –, facendo sì che la sua importante funzione portuale all’interno dell’adriatico, caratterizzata dalla duplice connotazione mer-cantile e militare, divenisse l’elemento propulsore della forma urbana, condizionandone inesorabilmente l’intero corso della storia. dall’epoca romana, con il rinnovamento e l’espansione del porto traianeo, alla decadenza post-imperiale, allo svi-luppo in epoca pontificia – quando, tra quattro e settecento, i migliori architetti dello stato della chiesa consolidavano l’immagine di cittadella militare cinta da mura (Fig. 4), che in alcuni momenti arrivava a contendere addirittura a genova e a venezia il ruolo di più importante porto del Mediterraneo – tale identità veniva traghettata oltre la metà dell’ottocento fino all’unità d’italia, compromettendosi infine solo parzial-mente quando, dopo l’annessione al nuovo stato di venezia e il passaggio di testimone a questa della supremazia per così dire «marinara», si consumava la frattura tra porto e città, dando il via all’espansione urbana verso l’entroterra. Pur nella dicotomia tra «città vecchia» e «città nuova», la prima conti-nuava ad avere un rapporto privilegiato con il mare; carattere – quello di strategico avamposto militare – che ne avrebbe decretato di lì a poco la distruzione.
la seconda (15) affonda le radici della sua storia nella colonia romana che ottaviano augusto volle fosse dedotta sull’ultimo tratto della via consolare Flaminia, nei pressi dell’antico santuario dedicato alla dea Fortuna – Fanum Fortu-nae, appunto, dal quale la città tradusse il nome –, nel punto
(15) a fronte di numerosi studi archeologici e storico-artistici dedicati a opere d’arte e monumenti fanesi, decisamente scarsa è la letteratura scientifica sulla sua storia urbana. tra le più recenti descrizioni si citano s. tomani amiani, F. battiStelli, Guida storico artistica di Fano, Pesaro, belli, 1981; Fano nel Seicento, a cura di a. deli, urbino, arti grafiche editoriali, 1989; Fano medievale, a cura di F. mileSi, Fano, editrice grapho 5, 1997, e le ormai datate guide di c. Sel-velli, Fano romana, medievale e moderna, Milano, sonzogno, [s.d.] (le cento città d’italia illustrate, 42); ideM, Fanum Fortunae. Guida di Fano, Fano, società operaia di Mutuo soccorso, 1909, ideM, Fano e Senigallia, bergamo, istituto ital. arti grafiche, 1931.
738 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
di sbocco del tracciato viario sul mare, che da qui costeggiava fino a giungere a rimini, ultima sua destinazione. Fu la fon-dazione augustea ad imprimere a Fano il duplice carattere di rilevante snodo territoriale affacciato sull’adriatico, e di «città» romana, la cui maglia reticolare veniva ad essere generata dalla croce stradale costituita dal cardo e dal decumano, moltiplicati parallelamente e perpendicolarmente a se stessi nella viabilità minore, interamente contenuta dalla cortina muraria continua che circondava l’abitato, disegnando una spezzata poligonale ad andamento pseudo-quadrato. né le devastazioni barbariche, né le sovrapposizioni medievali, né l’addizione al tessuto che, tra la fine del trecento e il primo quattrocento, sotto il governo dei Malatesta dilatava verso meridione l’area della città, allar-gando il perimetro delle mura, né i continui rimaneggiamenti successivi, avrebbero snaturato l’identità urbana della primitiva colonia romana, cresciuta su se stessa e sull’ampliamento mala-testiano, saturando la maglia stradale precostituita, all’interno della quale, nei palazzi, nelle case, nelle chiese e nei monumenti, si sedimentavano secoli di storia (Fig. 5).
Fissate così per ancona l’identità di porto strategico, e per Fano l’immagine di città murata, i cui rispettivi «strati» erano ben leggibili e rappresentati attraverso i lacerti di età antica e le numerose emergenze monumentali di epoca medievale e moderna, passate quasi indenni attraverso le molteplici aggres-sioni della natura e dell’uomo, entrambe venivano consegnate agli anni quaranta del novecento e all’ultimissimo scorcio del secondo conflitto mondiale.
la cronaca della guerra nelle Marche e la sorte di ancona e Fano sono amaramente note: tra il 16 ottobre 1943, giorno della prima incursione aerea sulla città, e il 18 luglio 1944, giorno della sua liberazione da parte delle forze alleate polac-che, ancona subiva circa 180 bombardamenti dal cielo e dal mare (16) mirati ad annientare quello che era il maggior porto
(16) sull’argomento: Bombardamenti su Ancona e Provincia 1943/1944, a cura di c. CaGlini, ancona, c.r. di ancona, 1983; Via Saffi dov’era come era, catalogo della mostra (ancona, 29 maggio-4 luglio 1993), ancona, aniballi, 1993.
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 739
dell’adriatico tra brindisi e venezia. agghiacciante era il con-teggio finale, che riscontrava alcune migliaia di morti e feriti tra i civili, la distruzione dei due terzi del tessuto abitativo, la devastazione del porto e della zona ferroviaria, la rovina della gran parte del patrimonio monumentale, e dunque l’irrepara-bile cancellazione di pezzi di città e della sua identità urbana originaria (Fig. 6).
diversa fu la sorte di Fano, in parte risparmiata dai bom-bardamenti alleati che, nell’aprile del 1944, interessavano una porzione del tessuto e alcuni monumenti, concentrandosi sugli strategici gangli viari, ovvero sui ponti sul Metauro e sulla linea ferroviaria. lo «sfregio» – come fu definito dagli stessi fanesi, considerandolo del tutto superfluo ai fini stra-tegici o militari – fu compiuto il 20 e il 21 agosto successivi dalle truppe tedesche in ritirata, che minavano alla base quasi tutte le torri e i campanili, il maschio malatestiano, il faro. l’azzeramento di tutte le emergenze verticali, che rovinavano sugli edifici vicini, mutilava definitivamente e appiattiva il profilo dell’abitato stagliato contro il cielo e ben visibile da chi veniva dal mare; carattere, questo, fino a quel momento colto e moltiplicato nelle numerose rappresentazioni storiche di Fano, che le aveva fatto guadagnare l’epiteto di «città dei campanili» (Fig. 7).
dall’estate del 1944, subito dopo la liberazione, iniziava l’azione congiunta delle tre soprintendenze – alle antichità di umbria e Marche, alle gallerie e ai Monumenti delle Mar-che – e della sottocommissione alleata. di questa era direttore deputato il colonnello John bryan Ward-Perkins, affiancato nell’operazione dai capitani, anch’essi inglesi, Fred Maxse e basil Marriot (che sappiamo essere un architetto), advisors nominati per le Marche e gli abruzzi. Per parte italiana diri-gevano le operazioni il soprintendente alle antichità edoardo galli (per le Marche, l’umbria e la riva del tevere, con uffici ad urbino), il soprintendente ai Monumenti riccardo Pacini (per le Marche, con uffici ad ancona), il soprintendente alle gallerie Pasquale rotondi (per le Marche, con uffici ad ancona) – il cui impegno e il considerevole contributo nel salvataggio di molte opere d’arte appartenenti a musei e chiese
740 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
di roma, venezia, Milano e delle Marche è ormai ben noto –, affiancati dai loro collaboratori, insieme alle autorità comunali e ai funzionari del genio civile.
come gli stessi protagonisti avrebbero scritto alla fine del 1945 nel libro edito nel 1946 che illustrava i Danni di guerra nell’area delle Marche (17), la situazione che si preparavano a fronteggiare lavorando fianco a fianco ininterrottamente per nove mesi interi era estremamente grave: le città, devastate, erano deserte, mancava la manodopera per qualsiasi opera-zione, impiegata in gran parte nelle emergenze militari, era difficile ogni forma di comunicazione.
già a guerra in corso e anche durante l’occupazione nazi-sta, i soprintendenti avevano tentato in diversi modi di sal-vaguardare opere d’arte e monumenti sottoposti alla propria giurisdizione. in via preventiva nel 1940, come ripetutamente disposto per altre località della regione, la soprintendenza alle gallerie aveva operato lo «sfollamento» delle opere d’arte delle chiese di ancona ritenute di primaria importanza, e lo stesso soprintendente ai Monumenti Pacini aveva organizzato il trasporto della maggior parte dei quadri e delle sculture nei palazzi apostolici di loreto. analogamente a quanto deciso per altri luoghi ritenuti più sicuri all’interno del territorio delle Marche, il Museo nazionale archeologico anconetano era stato adibito a ricovero delle opere d’arte cittadine prove-nienti dal tesoro del duomo, dal duomo e dalla chiesa di san domenico, e ancora, degli arazzi della chiesa del sacramento, delle sculture romaniche e del rinascimento appartenenti al medesimo museo, tutti custoditi in un ricetto segreto situato all’ingresso.
se si poteva sperare di aver messo faticosamente al sicuro le opere mobili di maggior valore, più difficile era mettere in atto azioni preventive per salvaguardare il patrimonio monu-
(17) Danni di guerra e provvidenze per l’Antichità i Monumenti e l’Arte, anco-na - urbino, [s.e.], 1946; il volume, che reca sul frontespizio «soprintendenza per le antichità delle Marche e dell’umbria, per le gallerie delle Marche, per i Monumenti delle Marche» reca i saggi dei tre soprintendenti e l’Introduzione del capitano Maxse. a tale testo si rimanda per un elenco e una descrizione puntuali delle opere e dei monumenti danneggiati o distrutti ad ancona e Fano.
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 741
mentale, rispetto al quale e analogamente a quanto avvenuto per le opere d’arte, sarebbe stata ancora ancona a pagare il prezzo più alto.
l’azione della soprintendenza ai Monumenti, che aveva già provveduto a proteggere le facciate con triplici strati di populit (salvando opere insigni, tra le quali, ad esempio, l’arco di traiano), aveva avuto inizio immediatamente all’indomani dei bombardamenti aerei. il 16 ottobre 1943, in concomitanza con il primo raid, riccardo Pacini avviava la redazione di un diario (18) nel quale registrava, dal 1° novembre successivo, ovvero a partire dalla seconda devastante incursione (ne sareb-bero seguite oltre un centinaio), lo status quo dei monumenti di ancona, che aggiornava via via fino al 18 settembre 1944 (poco dopo l’abbandono da parte delle truppe tedesche dell’in-tera regione) e il cui racconto si sovrapponeva con le cronache più note: la popolazione del capoluogo era scesa da 90.000 a 8.000 abitanti, gli uffici erano stati spostati; al termine delle azioni militari la città storica era distrutta, i principali monumenti devastati. gravissimi, continuava il soprinten-dente, erano i danni subiti anche da Fano (che con ancona e Pesaro componeva la triade delle città più colpite): tutti i campanili erano stati minati e fatti esplodere dai tedeschi che avevano preannunciato l’azione con una lettera indirizzata al vescovo – poi disattesa nei fatti –, nella quale garantivano di limitare le esplosioni alle sole celle campanarie. Ma molto rimaneva in piedi. erano state già avviate le azioni di ‘pronto soccorso’, ma bisognava fare presto, esortava Pacini, e partire da quei luoghi come il guasco con il duomo anconetano, o il duomo e il Palazzo della ragione di Fano da considerare emblemi dell’identità cittadina, la cui distruzione aveva avuto un forte impatto emotivo sulla popolazione civile. la scelta delle priorità della ricostruzione doveva essere guidata dunque da ragioni simboliche, e i monumenti superstiti assumevano ora la funzione di vere e proprie «reliquie» urbane sulle quali si coagulava il sentimento popolare.
(18) acs, ACC, bob. 150d, scaff. 49, fasc. 57, records 5347-5338. la lunga relazione si chiude il 18 settembre 1944, data dell’invio.
742 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
le parole di Pacini non fanno che confermare quanto già messo in evidenza dagli storici (19), che nella logica dei bom-bardamenti a tappeto hanno riscontrato la ferma volontà di colpire quello che churchill aveva definito il «ventre molle» dell’asse – ovvero l’italia – spingendola fuori dal conflitto: colpire pesantemente i centri abitati per annichilire la popo-lazione civile, congenitamente debole e incapace di sostenere tale contraccolpo psicologico, e portarla a negare il consenso alla guerra fascista. crollata la fiducia alimentata dalla pro-paganda del duce nell’’infallibile’ difesa dell’aeronautica nazionale, ben presto il morale degli italiani veniva sopraffatto dalle bombe alleate, rendendo inevitabile lo scollamento del consenso dal partito di governo.
tornando alle Marche e all’estate del 1944, dopo un primo contatto avvenuto tra gli ufficiali della Sub-commission Ward-Perkins e Maxse e i soprintendenti delle Marche, veniva concertato un programma di primo intervento relativo alle urgenze e al contenimento dei danni subiti da opere d’arte e monumenti della regione. Quanto ad ancona e Fano, si avvia-vano immediatamente le operazioni volte al ripristino del porto di ancona e della viabilità, allo scavo e al recupero dei frammenti architettonici sepolti tra le macerie, si richiedevano i finanziamenti alleati destinati alle ricostruzioni, alle ripa-razioni e ai restauri, si vigilava sui monumenti danneggiati, scegliendo di privilegiare soprattutto le iniziative che avessero un carattere definitivo e non provvisorio. istantaneamente si poneva il problema della scelta di quale tipo di «restauro» eseguire – «ricostruzioni, ripristino, completamento», come lo stesso Pacini scriveva – su edifici che di colpo avevano perso la propria forma e la funzione originarie, e che erano spesso ridotti allo stato di rudere. scelta che sarebbe stata operata poi di volta in volta, caso per caso, ma che in alcuni casi poneva maggiori interrogativi, ad esempio rispetto ai campanili di Fano che avrebbero dovuto comunque essere ricostruiti se,
(19) cfr. M. Gioannini, g. maSSobrio, Bombardate l’Italia. Storia della guerra di distruzione aerea 1940-1945, Milano, rizzoli, 2007.
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 743
per ragioni liturgiche e simboliche, le chiese non potevano rimanere prive delle loro campane e, di conseguenza, dei cam-panili (20).
in entrambi i casi qui presi in esame, le urgenze e le ragioni simboliche che richiedevano la ricomposizione immediata dei monumenti emblematici dell’identità cittadina denunciate da Pacini sarebbero state fatte proprie dagli ufficiali della Sub-commission e utilizzati come filo conduttore delle prime rico-struzioni.
nella mappa di ancona – scelta tra le sedici città delle Marche e degli abruzzi ritenute più importanti dal punto di vista artistico e culturale – redatta dalla Sub-commission antece-dentemente ai primi bombardamenti, tra le chiese, i palazzi, i monumenti, le istituzioni culturali puntualmente annotate, molti asterischi evidenziavano altrettante rilevanze storico-artistiche (21). tra queste spiccavano il duomo e il Museo nazionale archeologico delle Marche, che, tuttavia, a causa della contiguità con la caserma Fanti e l’indicazione del carat-tere militare esteso per errore dalla caserma fino al complesso del san Francesco sulle piante in possesso degli alleati (22), sarebbero stati ripetutamente colpiti dalle bombe, devastando irreparabilmente con ben quattro incursioni il museo e col-pendo il monumento simbolo della città: il san ciriaco, sorto sul guasco sul luogo del primitivo tempio di venere che in origine dominava il porto e la città romana.
il 20 e il 21 agosto 1944, alla presenza degli ufficiali della Sub-commission e dei referenti nazionali veniva aperto il ricovero sotto il campanile della chiesa di san Francesco, dove erano state riposte le opere del Museo nazionale e del duomo, mira-
(20) Danni di guerra…, cit., pp. 86-91.(21) acs, ACC, bob. 150d, scaff. 49, fasc. 58, record 5400. nella map-
pa – sulla quale campeggia la scritta «Protection of cultural treasures in War areas» – si prende nota delle emergenze rilevanti con sintetica descrizione dei tesori d’arte contenuti al loro interno e relativa datazione, indirizzi di ciascuna e nominativi dei referenti delle istituzioni culturali cittadine. le città di Marche, abruzzi e umbria ritenute di maggior rilievo sono: ancona, ascoli Piceno, assisi, città di castello, Fabriano, Foligno, gubbio, loreto, Macerata, orvieto, Perugia, Pesaro, spoleto, terni, todi, urbino.
(22) Danni di guerra…, op. cit., ancona - urbino, [s.e.], 1946, p. 14.
744 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
colosamente intatto (Fig. 8). lo stesso Ward-Perkins scattava le foto dei rinvenimenti. il 29 agosto successivo il colonnello stilava un documento di primo intervento nel quale elencava gli interventi da attuarsi per ordine di priorità (23).
cominciava quindi una sistematica ricognizione dei monumenti, alla quale Ward-Perkins partecipava ancora il 16 ottobre 1944 insieme ai referenti della soprintendenza (24). il 23 novembre successivo era il capitano Maxse a firmare il lungo resoconto, monumento per monumento puntualmente analiz-zato, delle distruzioni e dei lavori necessari. a metà dicembre era la volta degli ispettori Ministeriali della Pubblica istru-zione, lavagnino, romanelli e castelfranco, che compivano sopralluoghi, tra le altre località, ad ancona e Fano (25).
il 15 febbraio 1945 Ward Perkins scriveva all’ufficio della Sub-commission per ottenere il permesso di scattare foto nelle Marche portando con sé l’equipaggiamento completo (26), e avviando dopo questa data la campagna fotografica che sarebbe confluita parzialmente nel citato volume dedicato ai Danni di guerra.
il 27 gennaio 1945 l’architetto riccardo Pacini inviava la propria relazione agli uffici di riferimento (27), nella quale veniva messa in evidenza la fiducia riposta nella ricostruzione in atto concertata con la Sub-commission alleata, denunciando però i pericoli derivanti dall’uso indiscriminato della mano-
(23) in seguito all’ispezione di Ward-Perkins datata 29 agosto 1944, sono raccomandati interventi immediati nel Museo nazionale, in santa Maria della Piazza, nel Palazzo del senato, sono ritenuti di una certa opportunità interventi nel Palazzo degli anziani, in san domenico, nella cattedrale; è ritenuto impos-sibile il restauro di sant’anna, santa Maria della Misericordia, san Pietro, casa stracca, si consiglia la ricostruzione ma non immediata del santissimo sacra-mento, del gesù, del Palazzo del comune, della loggia dei Mercanti, si deve rimandare a più lungo termine come procedere per san Francesco della scala (acs, acc, bob. 150d, scat. 49, fasc. 57, records 5316-5306).
(24) acs, ACC, bob. 150d, scaff. 49, fasc. 57, records 5378-5376.(25) acs, ACC, bob. 150d, scaff. 49, fasc. 56, records 50049, 5043-5039.(26) acs, ACC, bob. 150d, scaff. 49, fasc. 56, record 5078. alcune foto
scattate ad ancona recano sul retro la data 27 marzo 1945, data del verbale dell’apertura del ricovero delle opere del Museo nazionale di ancona. alcune foto scattate ad ancona recano sul retro la data 27 marzo 1945.
(27) acs, ACC, bob. 150d, scaff. 49, fasc. 56, records 5077-5076.
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 745
dopera non specializzata largamente impiegata nei cantieri, e il fatto che i crolli avevano messo in luce i resti delle antiche costruzioni delle quali si era perduta la traccia fino ad allora. l’entusiasmo con il quale venivano accolti i nuovi rinveni-menti, considerati testimonianze dell’antica identità citta-dina, faceva sì che spesso si decidesse di privilegiare il reperto isolato dal tessuto rispetto al ripristino o alla riedificazione. analogamente a quanto accaduto in altri luoghi d’italia, il lacerto archeologico-reliquia diventava dunque uno dei temi centrali della ricostruzione. il pericolo maggiore, continuava Pacini nella sua relazione, era la de-contestualizzazione dei monumenti superstiti, privati del tessuto connettivo circo-stante, distrutto o in demolizione, perché pericolante. cam-biava dunque la forma della città, che durante la ricostruzione andava pian piano assumendo un’identità nuova ed estranea alla propria storia secolare.
il 31 maggio 1945 si stilava la rendicontazione puntuale di interventi, stanziamenti e lavori in corso d’opera e già com-piuti, firmata dal capitano Maxse (28).
il Final Report per le Marche è datato 10 novembre 1945. nell’ultimo documento prodotto poco prima della fine della permanenza degli ufficiali della Sub-commission viene fatto «il punto» definitivo sulla situazione.
si ribadiva che la contiguità con la porzione orientale della linea gotica aveva causato i gravi danneggiamenti della regione, dai quali era parzialmente esclusa solo la provincia di Macerata. confermando quanto contempora-neamente sarebbe stato riscontrato nei rapporti della Works of Art (29), secondo il Final Report ancona era devastata; la
(28) acs, ACC, bob. 150d, scaff. 49, fasc. 56, records 5163-5155.(29) ancona: a really lamentable loss to art was involved by the bombing
and shelling of this town, where stubborn fighting was longdrawn-out and a city rich in architectural monuments was obstinately held and had to be captured at all costs. of the fifteen buildings listed as being of the first importance, the following escaped damage: S. Agostino, Palazzo Benincasa, Palazzo Ferretti, and Arch of Trajan. S. Maria della Piazza, the most important monument in the city, with its elaborate early thirteenth-century facade adorned with sculptures by Master Philippus (which had been carefully protected), suffered only slight blast damage to the roof. the Cathedral (S. Ciriaco) lost its roof, and the end wall of the chapel of the crocifisso in
746 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
limitata compromissione di Fano era stata invece vanificata dalle mine tedesche.
the south transept collapsed and fell through the floor into the crypt. Fortunately the two inner arcades are for the most part intact. restoration can undertake with little loss of character. S. Domenico. the false vaulting of the nave has collapsed, but the internal decoration below cornice level has suffered relatively little. S. Francesco delle scale. the campanile was destroyed, leaving a gap in the south wall of die church, but for the rest there was only minor blast damage, and the facade, with the gothic portal by Giorgio da Sebenico, was unharmed. the cast wing of tile cloisters was destroyed, together with the whole of the west range of the convent attached. S. Maria della Misericordia was destroyed beyond possibility of restoration. Palazzo Comunale. the interior was badly smashed, but the façade is preserved. Palazzo degli Anziani (Prefettura). the west wing was destroyed, but the rest of the building was undamaged. Palazzo del Senato. Part of the important facade is in danger of collapse. the Loggia dei Mercanti is a wreck internally, but the lower part of Giorgio da Sebenico’s facade still stands, saved by protective masonry, Vanvitelli’s «Lazaretto» has suffered a good deal of superficial damage, but is perhaps not seriously ruined. the Museum and Picture Gallery sustained several direct hits, but most of the pictures had been removed. of the archaeological collections one-half was stored in the cellars and the rest left in situ. the Communal Library is buried under a mass of fallen masonry. the-se are only the more important of ancones’ monuments. a number of lesser works have perished or been seriously damaged. the Roman Amphitheatre, Arco Clementino, Porta Pia and the Fontana del Calamo have escaped injury; as also the church of S. Maria in Porto Novo, six miles from the city.
Fano: the town suffered most severely, and the damage is so senseless that it can be called wanton. under the pretext of creating roadblocks the germans mined and destroyed the bell-towers of no less than five churches and of the Palazzo della Ragione; in only two cases could a real obstruction have been caused, and the mining was, in fact, so clumsily done that, even in these two cases, most of the masonry of the towers fell inwards on to the churches and did not effectively block the roads. Cathedral. the campanile («belisarius’ cower»), crossing and north transept were destroyed and the eastern most chapel on the north side was filled with rubble; its thirteenth-century facade, the nolfi chapel with Domenichino’s frescoes, Carracci’s altar-piece and the stone pulpit by Maestro Rainerio are all undamaged. S. Agostino. the apse and south chapel were destroyed by the fall of the tower. S. Domenico. a fourteenth-century church had its dome, apse and high altar destroyed. S. Maria Nuova. the collapse of the campanile tore away the entire apse and badly shook the rest of the building. S. Paterniano. the apse was destroyed by the fall of Sansovino’s tower. S. Michele, having no campanile, is undamaged. S. Francesco is undamaged. Palazzo della Ragione Vanvitelli’s Tower now lying in a heap in the Piazza tore away the whole fourth bay of the arcaded facade; the interior is badly damaged. Works of art. Many important pictures such as the Guercino from S. Agostino, the Palma il Giovane painting from S. Domenico, and three Perugino panels from S. Maria Nuova had been stored in safety. in S. Agostino the painted ceiling by Ferdinando Bibiena was destroyed, but the collapse of the eighteenth-century investment of the nave walls has brought to light important early frescoes. in S. Domenico the frescoes, one of the fourteenth century, others by Ottaviano Belli of Gubbio (a «st. agnes») and
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 747
Quanto alla prima (30), la città vecchia, pittoresca, era interamente distrutta, avendo subito danni comparabili con civitavecchia o livorno, anch’essi strategici avamposti sul mare. i maggiori monumenti erano fortunatamente scampati
by Ragazzini, have suffered damage, the first being entirely buried beneath fallen masonry. in S. Paterniano the fall of the tower ruined the cast end of the church: the paintings (by Viviani and Ceccarini) and the ceiling (by Ragazzini) were not of great importance and most of them survive. in S. Maria Nuova the paintings left /’/; situ, the «visitation» of Giovanni Santi and others, are all safe; in the Chiesa del Suffragio the fifteenth-century fresco of the crucifixion is smoke-stained in places, but intact (da Works of Art in Italy, london, op. cit. alla nota 5).
(30) acs, ACC, bob. 204b, scat. 50, fasc. 217, records 695-690. segue la sintesi di quanto riportato nel record: Cattedrale: molto danneggiata dai ripetuti bombardamenti, ma è possibile restaurarla senza la perdita del carattere ori-ginario. il danno è più spettacolare che irreparabile. nel transetto sud i muri sono collassati interamente nella cripta, altri sono pericolanti. danneggiati altri muri e il tetto. le sculture antiche scavate dalla cripta, i muri e il tetto del transetto sud sono in ricostruzione, il resto del tetto è completato. stanziate £ 3.144.972; Museo Nazionale delle Marche (ex convento san Francesco): ripetuta-mente danneggiato. solo una piccola parte della collezione archeologica è stata messa in salvo in una stanza rinforzata sotto il campanile, 2/3 della costruzione è ora demolita insieme al campanile. la Collezione residua è stata ricoverata in altri luoghi. Quasi tutti i materiali della sala della Preistoria sono ora perduti. stanziate £ 600.000; Chiesa di San Francesco della Scala: il campanile è distrutto, la facciata che è stata protetta è salva; Chiesa del Gesù: danni minori al tetto e alla facciata del vanvitelli, che sono stati riparati. stanziate £ 323.000; Chiesa di San Domenico: la bomba diretta sulla navata ha distrutto la volta a crociera, il resto è intatto. È stata ripulita dalle macerie, i muri consolidati, il tetto ricostruito. stanziate £ 545.550. il Ministero dei lavori Pubblici ha stimato necessarie £ 2000.000 per riparare la volta; Chiesa di Santa Maria della Piazza: poco danneg-giato il tetto, danneggiata la facciata anche sotto la copertura protettiva, la ripa-razione è stata completata. stanziate £ 280.000; Chiesa del Santissimo Sacramento: tetto danneggiato, riparato a spese del parroco e del genio civile; Chiesa di Sant’Anna: distrutta; Chiesa di Santa Maria della Misericordia: distrutta. il pulpi-to medievale è ora ricoverato al Museo nazionale; Chiesa di San Pietro: distrutta, ricoverati i frammenti del portale; Palazzo del Comune: la facciata è quasi intatta, l’interno è crollato. riparazione di primo «impatto» completata. stanziate £ 1.589.661; Palazzo del Senato: importante solo la facciata, un angolo è in peri-colo di crollo. le operazioni di consolidamento sono state completate. stanziate £ 27.665; Palazzo degli Anziani (del Governo): lato ovest molto danneggiato, il resto intatto. l’angolo ha bisogno di essere smantellato. Primi restauri finiti tranne il tetto per £ 1.822.873; Loggia dei Mercanti: parte alta della facciata dan-neggiata, interno crollato. restauri finiti per £ 199.910; Lazzaretto di Vanvitelli: danno esteso superficiale; Sant’Agostino, Palazzo Giovannelli Benincasa, Palazzo Ferretti: non danneggiati; Pinacoteca comunale: Poco danneggiata. i dipinti più importanti sono ricoverati a urbino e loreto. seriamente danneggiata l’enorme
748 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
alle distruzioni, ma molti erano perduti. grazie alle protezioni messe in atto dalla soprintendenza alcuni di essi erano intatti e il danno al san ciriaco era più spettacolare che irreparabile (Fig. 9). la perdita significativa da registrarsi era quella del tessuto secolare della città medievale. grazie allo stanziamento di fondi ingenti, moltissimi erano i restauri e le ricostruzioni in corso di realizzazione, a partire dal duomo (Fig. 10).
Quanto a Fano (31), tutti i campanili erano stati minati, ma la città era sostanzialmente illesa, come pure i suoi monu-menti principali; alcuni monumenti erano stati riparati, i materiali più preziosi della biblioteca Federiciana collocati al riparo, erano ora tornati in sede. non si era ricevuto l’inventa-rio finale. anche in questo caso erano in stato di avanzamento restauri e ricostruzioni, a partire proprio dalla cattedrale e dal Palazzo della ragione il cui campanile vanvitelliano sarebbe stato ricostruito secondo la forma originaria (Fig. 11).
Quando, alla fine del 1945, gli ufficiali della Sub-commission lasciarono le Marche, non solo i monumenti erano stati «riparati», ma anche l’immagine degli alleati che di quella distruzione erano stati gli artefici aveva subito una mutazione. il lavoro di ricostru-
assunzione di lorenzo lotto; Biblioteca comunale: riunita al museo, i materiali sono bruciati sotto le macerie. Molti altri sono stati trasportati al riparo. non si conosce ancora l’entità dei danni; È apparso l’anfiteatro romano sotto le rovine del distrutto penitenziario; Arco di Traiano: illeso.
(31) acs, ACC, bob. 204b, scat. 50, fasc. 217, records 695-690. segue la sintesi di quanto riportato nel record: Cattedrale: campanile minato dai tedeschi e crollato sul lato sinistro del transetto. sono intatti la facciata, il pulpito e la cappella nolfi (affreschi del domenichino). restauri: parzialmente completati. stanziate £ 768.962, altri fondi per il tetto da parte del genio civile; Palazzo della Ragione: minata dai tedeschi la torre del vanvitelli, crollata, distruggendo l’angolo del palazzo, danneggiandone il tetto e la sala verdi. i frammenti sono stati tra-sportati al sicuro, gli archi tamponati, puntellati il tetto e la sala verdi. restauri in stato di avanzamento, stanziate £ 95.230. sarà restaurato eventualmente nella forma originaria; Chiesa di Sant’Agostino: campanile minato dai tedeschi insieme all’abside e alla cappella destra. le opere del guercino sono state rimosse in prece-denza. completato il tetto. stanziate £ 511.540; Chiesa di San Domenico: campanile minato dai tedeschi, crollato in parte sul coro. rimossa la pala d’altare di Palma il giovane. Pulito dalle macerie, tetto riparato, aperta la fine del coro chiusa da un muro; stanziate £ 342.973; Chiesa di San Paterniano: campanile minato dai tede-schi, crollato distruggendo il coro, l’abside e la cappella di tutti i santi. ricostru-ito il coro. stanziate £ 198.123; Chiesa di Santa Maria Nuova: campanile minato dai tedeschi. ricostruiti muri, volta e tetto. stanziate £ 332.108.
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 749
zione compiuto fianco a fianco con i funzionari italiani e con la popo-lazione civile, i finanziamenti ingenti dei primi interventi di restauro, avrebbero contribuito evidentemente, oltre che a raf forzare l’idea della ineludibilità dei bombardamenti per aprire la strada ai «liberatori», a far sì che all’immagine di «carnefici» si sovrapponesse quella di veri e propri «salvatori», contrastando la propaganda fascista che esaltava la barbarie nemica manifestata nella distruzione delle opere d’arte da parte alleata. alla costruzione di tale immagine positiva avrebbero teso la pubblicazione contemporanea nel 1946 dei due già sopra citati volumi Works of Art e Danni di guerra, che cele-brando il comune lavoro di tutela, salvaguardia e ricostruzione da parte alleata e italiana, ribadiva la barbarie tedesca espressa nelle tante azioni di distruzione gratuita del patrimonio artistico com-piute degli ex alleati dell’asse, emblematicamente rappresentate dal caso di Fano, esempio sebbene non isolato, tuttavia rilevante.
tuttavia, al di là della propaganda precostituita, la colla-borazione con gli ufficiali della Sub-commission – che abbiamo visto essere tutti per così dire «addetti al mestiere» – fu estre-mamente importante per i funzionari italiani, che con Ward-Perkins, Maxse, Marriot condividevano gli interessi scientifici e la particolare disposizione d’animo nei confronti di monumenti e opere d’arte, che ne aveva determinato il personale coinvolgi-mento emotivo nell’operazione. l’empatia reciproca, enfatizzata dall’emergenza, dalla fretta di constatare i danni subiti, sanare presto le ferite e recuperare quanto possibile, dalle precaris-sime condizioni, dal lavoro serrato durato nove mesi, sono ben espressi nelle parole d’encomio con le quali il capitano Maxse illustrò l’impegno e il lavoro dei tre soprintendenti marchigiani nell’Introduzione al volume Danni di guerra edito a cura della soprintendenza, che egli stesso definì «buoni amici». stima evidentemente ricambiata dagli italiani se Pasquale rotondi chiese di scrivere la presentazione del suo volume Vade mecum del visitatore di Urbino pubblicato nel 1946 (32) allo stesso capitano inglese con il quale aveva lavorato gomito a gomito in quella controversa situazione che fu determinata dalla guerra.
(32) p. rotondi, Vade mecum del visitatore di Urbino, con prefazione di F.h.J. Maxse, urbino, regio istituto d’arte, 1946.
750 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
Fig. 1 - John Bryn Ward-Perkins ad Ancona, estate 1944 (british school at rome, Ward-Perkins collection)
Fig. 2 - J.b. Ward-Perkins, Fano, Santa Maria Nuova dopo la caduta del campanile sul coro (da Danni di guerra e provvidenze per l’Antichità i Monumenti e l’Arte, ancona - urbino, [s.e.], 1946, fig. 11)
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 751
Fig. 3 - J.b. Ward-Perkins, Ancona, San Francesco. Recupero delle opere d’arte dal ricovero segreto alla presenza del capitano Marriot (da Danni di guerra e provvidenze per l’Antichità i Monumenti e l’Arte, ancona - urbino, [s.e.], 1946, fig. 1)
Fig. 4 - g. braun, F. hogenberg, Pianta prospettica di Ancona, 1569 (da Civitates Orbis Terrarum …, coloniae agrippinae, apud bertramum bochholtz, sumptibus auctorum, 1599)
752 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
Fig. 7 - Fano, Profilo della città vista dal mare (da c. selvelli, Fano romana, medievale e moderna, Milano, sonzogno, [s.d.] [le cento città d’italia illustrate, 42], p. 16)
Fig. 5 - e. alessandri, Fano, Pianta e profilo della città, 1924 (da c. selvelli, Fanum For-tunae. Guida di Fano, Fano, società operaia di Mutuo soccorso, 1909, tav. i)
Fig. 6 - Rilievo aero-fotogrammetrico delle devastazioni belliche, 1945 (da r. Pavia, e. sori, Ancona, roma, laterza, 1990 [le città nella storia d’italia], fig. 152)
città e guerra: il caso di ancona e di Fano 753
Fig. 8 - J.b. Ward-Perkins, Ancona, San Francesco. Recupero delle opere d’arte dal ricovero segreto alla presenza del capitano Maxse e del soprintendente Galli (da Danni di guerra e provvidenze per l’Antichità i Monumenti e l’Arte, ancona - urbino, [s.e.], 1946, fig. 2)
Fig. 9 - J.b. Ward-Perkins, Ancona, San Ciriaco. Il braccio del transetto dopo il bombardamento del 7 novembre 1943 (british school at rome, Ward-Perkins collection)
754 Margherita Fratarcangeli - isabella salvagni
Fig. 11 - J.b. Ward-Perkins, Fano, Il Palazzo della Ragione dopo il crollo della torre vanvitelliana (da Danni di guerra e provvidenze per l’Antichità i Monumenti e l’Arte, ancona - urbino, [s.e.], 1946, fig. 12)
Fig. 10 - J.b. Ward-Perkins, Ancona, Palazzo del Senato con lo sperone di sostegno (da Danni di guerra e provvidenze per l’Antichità i Monumenti e l’Arte, ancona - urbino, [s.e.], 1946, fig. 13)