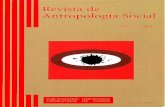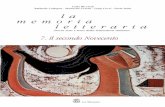La eterna ironía de la comunidad Porno-estéreo Seducción/producción
Eterna Melancolia - Analisi della parte VII de \"Il Gattopardo\" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Transcript of Eterna Melancolia - Analisi della parte VII de \"Il Gattopardo\" di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
1
ETERNA MELANCOLIA
ANALISI DELLA PARTE VII DE “IL GATTOPARDO” DI GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA
a cura di Leonardo CANOVA
In seguito al clamoroso successo editoriale de Il Gattopardo, pubblicato sul finire del 1958 da
Feltrinelli, la critica – tradizionalmente ostile ad ogni “best seller” – ha cercato di ritagliarsi il suo
cantuccio sicuro all’interno di un’opera che lascia al lettore più domande che risposte. A farne le
spese furono in particolare le parti V, VII e VIII, spesso considerate appendici accessorie
assolutamente non necessarie alla compiutezza del romanzo, vere e proprie mine a quei solidi pilastri
che sono le unità aristoteliche; e certo chi ha voluto catalogare l’opera sotto l’angusta etichetta di
“romanzo storico” doveva trovarsi profondamente a disagio nel leggere la parte relativa alla morte
del Principe di Salina, dove sembrano venir meno molte delle caratteristiche che avevano riguardato
il resto del romanzo: in particolar modo quel realismo che, perlomeno superficialmente, cede il passo
all’introspezione psicologica. Tuttavia, come Auerbach ha tentato di mostrare nella sua monumentale
opera1, la nozione di realismo dipende totalmente dal concetto di realtà che un’epoca, una società, un
individuo, hanno; nel sistema di pensiero lampedusiano, che, come vedremo, poggia costantemente
su due piani, questa sezione doveva essere realistica perlomeno quanto lo furono le bolge infernali
per Dante o il paesino di Aci Trezza per Verga. Non si può poi prescindere dal fatto che la parte che
ci accingiamo ad analizzare fosse presente nel cantiere del romanzo fin da quando l’autore pensava
ancora ad un “ciclo di novelle” (maggio 1956): una dimostrazione fin troppo evidente che per lui non
doveva certo essere una mera appendice, ma piuttosto una componente essenziale della sua incessante
ricerca sul “dopo”, sui destini storici ed individuali.
Perciò è con la lente, piuttosto che col rasoio, che cercheremo di interpretare questo complesso primo
epilogo del romanzo.
1 AUERBACH E., Mimesis, il realismo nella letteratura occidentale, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi, 2013
2
1. MELANCOLIA, MORTE.
Il tema della morte, introdotto fin dalle prime parole del romanzo (“Nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.” p. 312), percorre come un filo sottile tutto lo svolgimento della vicenda, tanto che c’è chi ha
sostenuto che Il Gattopardo sia un’opera “soprattutto sulla morte”3. In realtà esso contiene istanze
molteplici e variegate e volerne isolare una sola significa necessariamente trascurare le altre, anche
se è indubbio che la morte ed il personaggio ad essa più legato, Don Fabrizio, siano i veri protagonisti
di questa parte, intitolata per l’appunto “La morte del Principe”. Qui l’autore tenta il difficile – ed
innovativo – esperimento di narrare gli ultimi istanti di una vita dal punto di vista del moribondo:
esperimento certo non realistico in senso tradizionale ma sicuramente compatibile con ciò che Tomasi
di Lampedusa considerava realtà; del resto poi nessuno ha mai potuto descrivere gli istanti precedenti
la propria morte.
Durante questo processo Don Fabrizio porta a compimento quei tratti che durante tutta la vicenda si
erano intravisti ma che non si erano mai apertamente rivelati, resi opachi da un’ironia, spesso
derivante dallo sfasamento tra il punto di vista del narratore e quello del protagonista, che in queste
pagine si assottiglia fin quasi a scomparire.
Del Principe di Salina la critica ha messo in evidenza di volta in volta i caratteri di intellettuale, di
reazionario (forse proprio trascurando ciò che accade nelle pagine che stiamo analizzando), di
machiavellico qualunquista. A noi, in questo contesto, interessa parlare di quella che potremmo
definire “melancolia” di Don Fabrizio.
Usiamo il termine “melancolia”, in luogo del più comune “malinconia”, non per vuoto nozionismo,
ma in quanto è nostra precisa intenzione far riferimento non tanto alla tradizione di eroi e protagonisti
romantici, quanto piuttosto a quella presente nel panorama letterario del Novecento europeo (in primo
luogo l’Hans Castorp manniano), ma risalente fino alla teoria umorale di Ippocrate ed ai principi della
2 L’edizione di riferimento per il testo de Il Gattopardo è: TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, edizione conforme al
manoscritto del 1957 a cura di Gioacchino Lanza Tomasi, Milano, Feltrinelli, 2013 3 CAPECCHI G., Il Gattopardo, tra storia ed eternità, ma anche Javier Mariàs.
3
medicina medievale. Secondo questa teoria, del melancolico sarebbero tipici il pallore, la tristezza e
la riservatezza, la tendenza all’introspezione e al pessimismo, alla nostalgia e alla passività, il
sentimento di morte.
E infatti vediamo che il Principe di Salina viene descritto con “la pelle bianchissima e i capelli biondi”
(p.33) , è spesso portato alla riflessione ed alla tristezza anche in situazioni normalmente “felici” per
gli altri personaggi (“Per il Principe, però, il giardino profumato fu causa di cupe associazioni
d’idee” p.35 e la famosa battuta di Tancredi “Corteggi la morte?” p.224) ed è passivo di fronte ad
avvenimenti storici che pure lo riguardano da vicino; riconosce la presenza della morte in tutte le cose
come “l’unico filo rosso rasserenante durante buona parte della propria esistenza”4 e talvolta è
descritto esplicitamente come malinconico: “Si alzò; la malinconia si era mutata in umor nero
autentico” (p.220). Un vero “riottoso figlio della vita” (così Settembrini definisce Hans Castorp nella
traduzione di Der Zauberberg a cura di Renata Colorni5).
Analizzando poi una delle raffigurazioni più esemplari della
melancolia, Melancholia I di Albrecht Dürer (Figura 1), le analogie
si fanno ancora più evidenti. In questa incisione, come in molte
altre opere figurative sullo stesso tema, compare il cielo stellato (in
particolar modo una sorta di astro presago dell’Apocalisse) ed un
quadrato numerico, simbolo di ordine, le cui colonne e righe danno
sempre la stessa somma; la figura femminile giace passiva col volto
abbandonato sul dorso della sua mano.
A questi veri e propri simboli della melancolia corrispondono la
passione di Don Fabrizio per l’astronomia così come per i calcoli, grazie ai quali egli crede di
dominare un mondo ordinato ed eterno, opposto a quello caotico e in continuo decadimento in cui
4 G.P. SAMONÀ, Il Gattopardo, i racconti, Lampedusa, Firenze, La Nuova Italia, 1974 5 T. MANN, La montagna magica, a cura e con introduzione di Luca Crescenzi, traduzione di Renata Colorni, Milano,
Mondadori, 2010.
Figura 1
4
(fortuitamente, verrebbe da dire) si trova a vivere. “Il Principe, che ha i piedi nella storia, ha la testa
nell’eternità […] Il Principe sa che esiste la morte, fa i conti con questa, la corteggia, la contempla
quotidianamente osservando il cielo stellato”6; la realtà, per Tomasi di Lampedusa come per Don
Fabrizio, nasce dalla coesistenza di questi due piani: un piano storico, della vita, soggetto a
decadimento e legato alla terra, ed un piano eterno, della morte, sede di esseri immortali, legato al
cielo e al mare.
Il Principe è l’unico personaggio ad essere consapevole di questa duplice realtà e la sua melancolia
nasce proprio dallo sfasamento tra la volontà di mantenere integre le apparenze, dovendo
forzatamente vivere nel mondo storico, e la consapevolezza della sua caducità e pochezza rispetto a
ciò che viene dopo; dalla prospettiva del suo empireo stellare egli osserva e (raramente) agisce nel
mondo dei “vivi”, consapevole del fatto che l’unica eternità che agli uomini sia concesso conoscere
è quel “palliativo che promette di durare cento anni” (p.59) chiamato tradizione.
Di particolare interesse è poi il fatto che, alla stregua delle teorie medievali, la melancolia del Principe
porti con sé una sorta di pessimistica chiaroveggenza, come dimostrano le tante piccole profezie e
massime che spesso sono affidate alla voce, o perlomeno al punto di vista, di Don Fabrizio:
“Andava chiedendosi chi fosse destinato a succedere a questa monarchia che aveva i segni della morte sul volto. Il
Piemontese, il cosiddetto Galantuomo che faceva tanto chiasso nella sua piccola capitale fuor di mano? Non sarebbe
stato lo stesso? Dialetto torinese invece che napoletano, e basta.” (p.39)
“In quanto a questo giovane Crispi, non io certamente, ma Lei potrà forse vedere se da vecchio non ricadrà nel nostro
voluttuoso vaneggiare: lo fanno tutti.” (p. 179)
“Tutto questo non dovrebbe poter durare; però durerà, sempre; il sempre umano, beninteso, un secolo, due secoli...; e
dopo sarà diverso, ma peggiore” (p.185)
Al temperamento melancolico sono dunque direttamente associabili molti dei tratti caratteriali di Don
Fabrizio e, sebbene non si abbiano elementi sufficienti per poter palare della Montagna Magica e del
suo protagonista come di un modello7, forse proprio alla luce di questi potrebbe essere più semplice
comprendere la settima parte del romanzo.
6 CAPECCHI G., Il Gattopardo, tra storia ed eternità 7 Di Mann abbiamo un solo riferimento indiretto a La Morte a Venezia nelle lezioni di Letteratura Inglese. Cfr. TOMASI
DI LAMPEDUSA, Opere, I Meridiani, Milano, Mondadori, 1997, p.753
5
2. TEMPO, ETERNITÀ.
In questa parte, infatti, si getta una luce più intensa sul personaggio di Don Fabrizio. Qui, il diaframma
che l’autore aveva posto tra il suo protagonista e il narratore viene quasi del tutto meno, e i punti di
vista di quelli che potremmo definire i due personaggi principali (appunto, il Principe ed il narratore)
si trovano quasi sempre a coincidere. L’ironia cede il passo alla rappresentazione diretta dei pensieri
del Principe, che scorrono sulla pagina in un vero e proprio stream of consciousness, segnalato anche
dall’assenza degli spazi tipografici che distinguono i vari “capitoletti” nelle altre parti. Flusso di
coscienza che echeggia forse maggiormente quello della Woolf – vengono in mente i passi di To the
Lighthouse analizzati magistralmente da Auerbach8 – che non quello di Joyce, dal momento che la
figura del narratore, per quanto marginalizzata ed insolitamente silenziosa, è comunque presente nelle
pause descrittive e in altri brevi, ma significativi, interventi.
In primo piano vi sono quindi i pensieri, il punto di vista non mediato (o quantomeno mediato il meno
possibile) del Principe di Salina, e ciò agisce sul trattamento particolare che viene riservato al tempo
in questa sezione; tempo che, se fino ad ora era stato rappresentato come sostanzialmente immobile
– il “tempo congelato” (p.244) di Donnafugata (ma anche di San Cono) – adesso si distende nel
passato e nel futuro seguendo i movimenti della mente del Principe durante i suoi ultimi istanti di
vita. La narrazione segue il pensiero del protagonista senza alcun tentativo di mettervi ordine: le
analessi non hanno un ordine cronologico ma appaiono come flashes memoriali che non hanno alcuna
funzione se non quella di scavare nella memoria del Principe, di rendere quell’ “esperienza umana
del tempo” che Lungani, trattando di Gadda, ha definito esprimersi “attraverso questi raccostamenti
repentini e folgoranti e questi urti, anche violenti, fra tempi ed eventi tra loro separati e, nel
contempo, attraverso la relazione che il discorso, con il suo presente, instaura tra quei tempi non più
8 AUERBACH E., Il Calzerotto Marrone, in Mimesis, il realismo nella letteratura occidentale, Torino, Piccola Biblioteca
Einaudi, 2013
6
presenti”9. Qui, diversamente rispetto a quanto accade in Gadda, tra i diversi tempi non c’è un urto
violento: essi coesistono all’interno della mente del moribondo senza alcun particolare attrito tra loro
e il tutto si amalgama perfettamente sulla pagina.
La sezione, infatti, dopo il riferimento temporale “statico” fornito dalla data “Luglio 1883”, si apre
con un flashback:
“Don Fabrizio quella sensazione la conosceva da sempre. Erano decenni che sentiva come il fluido vitale, la facoltà di
esistere, la vita insomma, e forse anche la volontà di continuare a vivere andassero uscendo da lui lentamente…” (p.235)
Dopo poco più di una pagina, nella quale il Principe medita sulla natura della morte (e della vita), si
torna repentinamente al presente
“Perché adesso la faccenda era differente, del tutto diversa. […] Era il mezzogiorno di un Lunedì di fine Luglio” (p.236)
dove il narratore riporta la data ed il luogo, come una sorta di ancora legato alla quale il protagonista
può spingere la mente indietro o in avanti. Il deittico “adesso” incalza in maniera quasi anaforica,
forse echeggiando quel “Nunc” con il quale si era aperto il romanzo; adesso però, lo spazio tra “Nunc”
e “in hora mortis nostrae” si è colmato.
Nelle pagine successive continuano ad alternarsi presente e passato con un ritmo incalzante, come
possiamo notare nel periodo che segue e in molti altri simili ad esso:
“Nella stanza bassa si soffocava: il caldo faceva lievitare gli odori, esaltava il tanfo delle peluches mal spolverate; le
ombre di decine di scarafaggi che vi erano stati calpestati apparivano nel loro odore medicamentoso; fuori dal tavolino
di notte i ricordi tenaci delle orine vecchi e diverse incupivano la camera” (p.240).
Il passato del ricordo si avvicenda con un presente puntuale dove gli eventi narrati sono
prevalentemente subiti dal protagonista, svuotato della sua erculea forza fisica e ridotto ad uno stato
larvale. L’erompere della vita fuori da Don Fabrizio viene reso grazie a metafore e similitudini, legate
perlopiù alla sfera dell’acqua, quali: “come delle particelle di vapor acqueo che esalassero da uno
stagno ristretto” (p.236) o “Era solo, un naufrago alla deriva su una zattera, in preda a correnti
indomabili” (p.241). E indomabile, del resto, è proprio quel presente al quale, come per tutto lo
svolgimento della vicenda, il protagonista non riesce a opporre una resistenza attiva, conformandosi,
9 LUGNANI L., Racconto ed esperienza umana del tempo, in “The Edinburgh Journal of Gadda Studies” , Issue no. 1,
EJGS 1/2001, p.3
7
anche in punto di morte, a dover morire come Principe di Salina, con tutta la mole di convenzioni e
rituali che ne conseguono:
“Perché a tutti succede così: si muore con una maschera sul volto” (p.239)
“Era il principe di Salina e come principe di Salina doveva morire, con tanto di prete accanto.” (p.242)
Stupirebbe, se già non avessimo analizzato la forma mentis del Principe, qui posta in primo piano,
trovare accanto al passato ed al presente anche insistiti riferimenti ad un futuro più o meno prossimo,
quelle piccole profezie, costantemente presenti nell’opera, che qui subiscono un’intensificazione. E
infatti Don Fabrizio presagisce in qualche modo ciò che accadrà nella parte successiva, 27 anni dopo:
“Il cuore gli si strinse, dimenticò la propria agonia pensando all’imminente fine di queste povere cose care” (p.241)
Intrecciando memoria e futuro fa poi previsioni su quelli che sarebbero stati i ricordi del piccolo
Fabrizietto e sul destino del proprio casato:
“Fabrizietto avrebbe avuto dei ricordi banali, eguali a quelli dei suoi compagni di ginnasio, ricordi di merende
economiche […] ed il senso del nome si sarebbe mutato in vuota pompa sempre amareggiata dall’assillo che altri
potessero pompeggiare più di lui”. (p.241)
Fino alle magistrali righe in cui si fondono assieme presente, passato e futuro, in una chiusa tipica
dello stile lampedusiano:
“Lui stesso aveva detto che i Salina sarebbero sempre rimasti i Salina. Aveva avuto torto. L’ultimo era lui. Quel
Garibaldi, quel barbuto Vulcano aveva dopo tutto vinto”. (p.242)
Questo andamento ondivago, quasi sinusoidale, del tempo segue quindi il flusso di pensiero del nostro
melancolico protagonista che, eternamente sospeso tra un passato di ricordi ed un futuro in cui ha il
potere di scrutare, si trova inerte di fronte ad un presente che sente estraneo e che, pur trovandosi
molto spesso ad odiarlo, subisce passivamente. L’immobilità, l’ordine che egli percepisce nel piano
eterno delle sue fredde stelle e che egli ambirebbe a proiettare anche nella vita di ogni giorno, non
appartengono a questo mondo. Emblematico, in questo senso, l’amuleto raffigurante “la testina di
Medusa con gli occhi di rubino” (p.50) che il Principe porta alla cravatta forse proprio come simbolo
della sua volontà di immobilizzare e che aggiunge un altro tassello a conferma della nostra
8
interpretazione; il rubino, infatti, compare anche nell’ode On Melancholy10 di John Keats
accompagnato alla dea degli inferi Proserpina, entità sospesa tra due mondi, che peraltro si riteneva
fosse in possesso proprio della testa di Medusa.
Viene dunque a configurarsi la figura di una sorta di dannato dantesco, cieco ed inerte di fronte al
presente ma costantemente consapevole del passato e del futuro: Don Fabrizio osserva la storia dalla
prospettiva dell’eternità, rimanendo sospeso tra di esse. Ma se da un lato, come egli stesso ammette
nella sesta parte del romanzo (“Non era lecito odiare altro che l’eternità” p.222), odia
quell’irraggiungibile eternità, dall’altro sembra anche in una certa misura parteciparvi.
3. IMMORTALITÀ, APOTEOSI.
Un dannato, dunque, ma certo un personaggio che aspira ad un’immortalità che non sia semplice
illusione, Don Fabrizio tende ad un mondo che egli considera più suo di quello in cui si è trovato a
vivere, il mondo del cielo e del mare che, nel romanzo, assumono tratti particolari. Ma Don Fabrizio
è anche indissolubilmente legato alla terra (elemento per tradizione legato al temperamento
melancolico) e da essa, in quanto Principe di Salina, non può e non riesce a staccarsi, rimanendo
sospeso, alla stregua di una mitologica Proserpina, tra i due mondi.
Complementarmente, però, al protagonista sono affidati tratti che lo accomunano, pur quasi sempre
sotto una luce ironica, alla stirpe divina. E dunque, oltre alle sue erculee dimensioni (“l’urto del suo
peso da gigante” p.32) ne viene sottolineato il “cipiglio zeusiano” (p.34) e il suo “signoreggiare su
uomini e fabbricati” (p.32); Don Fabrizio stesso afferma: “Vengono per insegnarci le buone creanze
ma non lo potranno fare, perché noi siamo déi” (p.182) mentre Padre Pirrone nel suo dialogo con
don Pietrino si premurerà di sottolineare che i signori
“vivono in un universo particolare che è stato creato non direttamente da Dio ma da loro stessi durante secoli di
esperienze specialissime, di affanni e di gioie loro; essi posseggono una memoria collettiva quanto mai robusta, e quindi
si turbano o si allietano per cose delle quali a voi ed a me non importa un bel nulla, ma che per loro sono vitali perché
poste in rapporto con questo loro patrimonio di ricordi, di speranze, di timori di classe.” (p.194)
10 Che l’autore cita direttamente nelle sue lezioni di Letteratura Inglese. Cfr, TOMASI DI LAMPEDUSA, Opere, I
Meridiani, Milano, Mondadori, 1997, p.972
9
che altro non è che un ulteriore attributo di divinità. Nel Principe
“orgoglio e analisi matematica si erano a tal punto associati da dargli l'illusione che gli astri obbedissero ai suoi calcoli
(come, di fatto, sembravano fare) e che i due pianetini che aveva scoperto (Salina e Svelto li aveva chiamati, come il suo
feudo e un suo bracco indimenticato) propagassero la fama della sua casa nelle sterili plaghe fra Marte e Giove e che
quindi gli affreschi della villa fossero stati piú una profezia che un’adulazione.” (p.34)
e, sebbene infine giunga a riconoscervisi (“sono della medesima risma” p.222), tuttavia, in un primo
momento, al ballo dei Ponteleone sono gli altri ad essere “effimeri esseri che cercavano di godere
dell’esiguo raggio di luce fra le due tenebre” (p.222) e “la reciproca stretta di quei corpi destinati a
morire” (p.222) è quella tra Angelica e Tancredi.
Don Fabrizio aspira a diventar “puro intelletto” (p.96), a separarsi dalla componente storica e
corruttibile alla ricerca di una vera immortalità. E qui, nella settima parte del romanzo, l’ultima a
vederlo protagonista, se ne descrive il processo.
Dopo l’analessi iniziale e la contestualizzazione temporale viene subito introdotto il motivo del mare
“compatto, oleoso, inerte, si stendeva di fronte a lui, inverosimilmente immobile” (p.236); immobile
proprio come le stelle fisse, teatro, come i cieli, dell’azione delle divinità: una sorta di pelagus
virgiliano. Don Fabrizio “aveva preteso di ritornare per via di terra” (p.237) – forse perché anche il
voler tornare via mare sarebbe stato “assurdo quanto mangiare una fetta di torta subito prima di un
desiderato banchetto” (p.240) – e di lui è messa costantemente in evidenza la debolezza fisica, in
contrasto con la possanza erculea che sempre lo aveva contraddistinto fino a questo momento: quel
corpo, che pur nella sua veste semidivina lo aveva tenuto incollato a questo mondo, sta lentamente
dissolvendosi. E qui, come ha giustamente notato Samonà, la tradizionale duplicità instaurata
dall’ironia viene sostituita dall’opposizione tra la “laidezza e dolorosità del concreto morire”11, così
lontana dall’impeccabilità della Morte del Giusto di Greuze, che viene a più riprese sottolineata:
“Nella stanza bassa si soffocava: il caldo faceva lievitare gli odori, esaltava il tanfo delle peluches mal spolverate”
(p.240)
“Il gigante sparuto che adesso agonizzava sul balcone di un albergo” (p.241)
11 G.P. SAMONÀ, Il Gattopardo, i racconti, Lampedusa, p.179
10
e la dolce sensazione di esser giunto, ormai, al tanto atteso banchetto; opposizione sottolineata anche
dal contrasto tra il silenzio esterno ed il fragore di acque che la vita produce nel suo impetuoso
fuoriuscire:
“fu allora che si fece sentire il fragore della cascata” (p.238)
Questo, contrariamente a quanto afferma Samonà, è un contrasto che tende a conciliarsi: non per
fusione, ma per prevalenza di uno dei due elementi. Con l’ingigantirsi del fragore nella mente del
Principe cessano proporzionalmente le preoccupazioni per il corpo e tutto ciò che è sensibile; Don
Fabrizio, con matematica precisione, comincia a fare il conto di ciò che della sua vita ha realmente
vissuto:
“Faceva il bilancio consuntivo della sua vita, voleva raggranellare fuori dall’immenso mucchio di cenere delle passività
le pagliuzze d’oro dei momenti felici: eccoli” (p.243)
In corrispondenza “Il silenzio fuori si richiuse, il fragore dentro ingigantì” (p.244) mentre il
moribondo porta a termine il suo calcolo:
“Nell'ombra che saliva si provò a contare per quanto tempo avesse in realtà vissuto. Il suo cervello non dipanava più il
semplice calcolo: tre mesi, venti giorni, un totale di sei mesi, sei per otto ottantaquattro... quarantottomila... √840.000.
Si riprese. Ho settantatré anni, all'ingrosso ne avrò vissuto, veramente vissuto, un totale di due... tre al massimo. E i
dolori, la noia, quanti erano stati? Inutile sforzarsi a contare: tutto il resto: settant'anni.” (p.245)
A quel punto “non era più un fiume che erompeva da lui, ma un oceano, tempestoso, irto di spume e
di cavalloni sfrenati” (p.245): il narratore, in uno dei suoi pochi interventi diretti, ci ricorda le
sofferenze fisiche ma da un punto di vista esterno, con espressioni come “Doveva aver avuto un’altra
sincope”, “era il su rantolo ma non lo sapeva”, “credette di sorridere” (p.245). Esse non sono più
una preoccupazione per Don Fabrizio che, finalmente, ha raggiunto quelle gelide distese che per tutta
la vita aveva agognato, divenendo “puro intelletto armato di un taccuino per calcoli” (p.96).
“La familiarità col pensiero della morte, da lui (Il Principe) coltivata tanto a lungo, è stata come un
tentativo di non subirla, di non riceverla dall’esterno, dalla natura, ma di appropriarsela” 12 afferma
Derla, comprendendo che per Don Fabrizio la morte non è un qualcosa di subito ma di conquistato:
soltanto adesso ella potrà mostrarsi sotto le sembianze di una
12 DERLA L., Quel “povero principe”. Rilettura del “Gattopardo”, in “Aevum”, LXXXII, 2008, pp.802-816
11
“giovane signora; snella, con un vestito marrone da viaggio ad ampia tournure, con un cappello di paglia ornato da un
velo a pallottoline che non riusciva a nascondere la maliziosa avvenenza del volto. Insinuava una manina guantata di
camoscio fra un gomito e l'altro dei piangenti, si scusava, si avvicinava. Era lei, la creatura bramata da sempre che
veniva a prenderlo: strano che così giovane com'era si fosse arresa a lui: l'orario di partenza del treno doveva essere
vicino. Giunta faccia a faccia con lui sollevò il velo, e cosí, pudica, ma pronta ad esser posseduta, gli apparve più bella
di come mai l'avesse intravista negli spazi stellari.” (p.246)
È la Venere che tanto aveva osservato nelle sue notti trascorse a scrutare le stelle e che finalmente si
è decisa a concedergli “un appuntamento meno effimero, lontano dai torsoli e dal sangue, nella
propria regione di perenne certezza” (p.232); ma è anche La Sirena che, qualche anno dopo, Tomasi
di Lampedusa renderà protagonista di uno dei suoi racconti più emozionanti. Il Principe di Salina, in
quel mare pagano il cui fragore si è ormai del tutto placato, trova infine un’immortalità vera, della
quale finora non aveva sperimentato che un mero palliativo: un’immortalità “fisica” (Nigro) e
sensuale come quella di Rosario La Ciura, donata dal definitivo congiungersi con un essere divino.
Proprio come nel racconto La Sirena, il mare “dà la morte insieme all’immortalità”13: Don Fabrizio,
morendo, ascende al suo personale pantheon.
13 TOMASI DI LAMPEDUSA, La Sirena, in Opere, I Meridiani, Milano, Mondadori, 1997, p.408
12
BIBLIOGRAFIA
OPERE
TOMASI DI LAMPEDUSA, Il Gattopardo, edizione conforme al manoscritto del 1957 a cura di
Gioacchino Lanza Tomasi, Milano, Feltrinelli, 2013
TOMASI DI LAMPEDUSA, Opere, I Meridiani, Milano, Mondadori, 1997
SAGGI E STUDI CRITICI
AUERBACH E., Mimesis, il realismo nella letteratura occidentale, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi,
2013
DERLA L., Quel “povero principe”. Rilettura del “Gattopardo”, in “Aevum”, LXXXII, 2008,
pp.802-816
LUGNANI L., Racconto ed esperienza umana del tempo, in “The Edinburgh Journal of Gadda Studies”
, Issue no. 1, EJGS 1/2001, p. 3
MACCHIA G., Le stelle fredde del Gattopardo, in Saggi Italiani, Milano, Mondadori, 1983, pp.348-
353
MUSARRA-SCHRØDER U., Leopardi nella memoria letteraria di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, in
AA. VV., Studi d’italianistica per Paolo Maria Sipala, a cura di S. Zappulla Muscarà, in “Siculorum
Gymnasium”, LV, 2002, pp.419-433
NIGRO S.S., Il Principe Fulvo, Palermo, Sellerio, 2012
ORLANDO F., L’intimità e la storia. Lettura del “Gattopardo”, Torino, Einaudi, 1998
SAMONÀ G.P., Il Gattopardo, I Racconti, Lampedusa, Firenze, La Nuova Italia, 1974
ZAGO N., Realtà e desiderio nel Gattopardo, in “Siculorum Gymnasium”, XXXI, 1, 1978, pp.102-
137