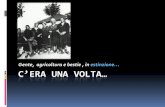Declinazioni degli spazi di frontiera fra agricoltura, archeologia e mito” (Atti del Convegno...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Declinazioni degli spazi di frontiera fra agricoltura, archeologia e mito” (Atti del Convegno...
La nota tecnica di coltivazione della “vite maritata”, eredità etrusca archeologicamente ben documentata e sopravvissuta in molte campagne della Penisola almeno fino alla metà dello scorso secolo, rappresenta - in virtù della sua collocazione spaziale spesso a segnare il passaggio fra i luoghi deputati all’agricoltura e i luoghi del pascolo e/o del bosco - un confine “colturale” e fisico che, in modo metaforico, può suggerire varie decli-nazioni dell’idea di frontiera, mediante i soggetti e gli elementi “culturali” che alla vite si affiliano. Partendo dai dati sul paesaggio agrario dell’antica Etruria a suo tempo valorizzati da Emilio Sereni, in questo contributo si intende dunque operare una riflessione su alcune espressioni del concetto di limite e liminarità nel mondo antico, attraverso il fil rouge costituito dalla vite e dal mondo culturale che ruota attorno a questo elemento.
Agli esordi della pratica di coltivazione della vite, verosimilmente per l’agricoltore fu una soluzione del tutto naturale scegliere degli alberi come sostegni per i tralci dell’arbusto, notando la capacità che questo possiede, grazie ai viticci, di aggrapparsi salendo sui tronchi e rami.La tecnica di coltivazione su tutori vivi, conosciuta come “vite maritata”, è storicamente associata ai paesaggi e al nomen degli Etruschi, che, domesticata la vitis vinifera sylvestris, divennero nel tempo concorrenti dei Greci nell’uso e nell’esportazione di vino, distribuendo i prodotti enologici dell’area tosco-laziale e campana fino alla Gallia e alla Penisola Iberica1.Nell’ottica di questo contributo è particolarmente interessante evidenziare il sistema di coltivazione della vite maritata chiamato da Plinio il Vecchio arbustum italicum, e del quale parla ampiamente E. Sereni riferendo ad esso il termine “piantata”2.
1 Dal punto di vista paleobotanico, tra gli altri, si ha attestazione di un rinvenimento di vitis vinifera e di vinaccioli al Gran Carro di Bolsena, risalente, in base al contesto all’VIII sec. a.C., per cui esso documenterebbe un primo tentativo di sfruttamento indigeno della vite. Del resto, attraverso le tipologie ceramiche e metalliche documentate, i corredi funerari parlano esplicitamente, fin da quell’epoca di un consumo di vino in cui si osserva il contatto delle tradizioni locali con i valori più propriamente ellenici che ruotavano intorno all’ideale omerico. E’ interessante la notizia dell’esistenza di un vino «italico» (latino ed etrusco) – il temetum – che le fonti antiche ci tramandano, forse da intendere come prodotto di tecniche di vinificazione primitive, a cui Torelli rapporta, acutamente, delle forme vascolari specifiche, come le capeduncole e le anforette a spirali, che costituirebbero, in accordo con la loro estraneità alle forme del simposio greco, il «retaggio della maniera “nazionale” di bere, perfettamente giustapposta alla maniera “greca” e con quella convivente» (riferimenti in: M. TORELLI, Primi appunti per un’antropologia del vino degli Etruschi, in D. TOMASI, C. CREMONESI (a cura di), L’avventura del vino nel bacino del Me-diterraneo: itinerari storici ed archeologici prima e dopo Roma, Simposio Internazionale, Conegliano 30 settembre-2 ottobre 1998, Conegliano 2000, pp. 89-100; M. TORELLI (a cura di), Gli Etruschi, Catalogo della mostra, Milano 2000, pp. 147-149). Le fonti storiche e letterarie sono abbastanza prodighe di notizie (e lodi) circa i prodotti dei vigneti della regione etrusca. Celebre la testimonianza sulla qualità del vino di Chiusi, che Arrunte potè usare come arma impropria per convincere i Galli a calare in Etruria: «Arrunte di Chiusi … avendo riposto molti recipienti di vino e di olio sui carri, e molte ceste di fichi, si diresse verso la regione dei Celti» (D.H., Ant. Rom. XIII, 10-11. Cfr. anche Liv. Ab Urb. V, 33). Anche Plinio (Plin. Nat. Hist. XIV, 38 e 35) menziona l’uva di Chiusi, che era stata impiantata a Pompei e nell’area del Ve-suvio (da cui il nome di Pompeiana). Lo scrittore ricorda poi anche altri vitigni eccellenti, appartenenti ad aree di produzione probabilmente già famose in precedenza: l’uva di Todi, con due varietà piantate nel territorio di Arezzo e di Firenze (Plin., Nat. Hist., 14, 36); i vitigni del perugino, con uva dai chicchi neri, che dopo quattro anni dava vino bianco, impiantati anche nell’area di Modena (Plin., Nat. Hist. XIV, 39). Nota era la qualità dei vini ceretani (Mart., Ep. XIII,124), ma erano apprezzati nel mercato anche quelli di Pisa (Plin. Nat. Hist., XIV, 39), di Adria, Gravisca, Statonia, Luni (Plin., Nat.Hist. XIV, 67-68).
2 Differenza rispetto all’arbustum gallicum, cui si riferisce invece il sistema dell’“alberata”. Sul tema si veda E. SERENI, Storia del paesaggio agrario italiano, Roma-Bari 1985, pp. 40-43. Cfr. già G. NEGRI, Come si possa ricostruire la fisonomia della vegetazione della Toscana durante il periodo etrusco, «Studi Etruschi» I, 1927, pp. 363-373, per alcune importanti annotazioni sulla ricostruzione dell’ambiente e del paesaggio dell’antica Etruria. Per la diffusione della vite e dell’olivo nell’area del Mediterraneo nel periodo dalla preistoria all’epoca ellenistica, cfr. in particolare J.P. BRUN, Archéologie du vin et de l’huile. De la prehistoire à l’époque hellénistique, Paris 2004. Da ultimo, sull’argomento vinum, i contributi raccolti negli atti del Convegno di Scansano 2005, A. CIACCI, P. RENDINI, A. ZIFFERERO (a cura di), Archeologia della vite e del vino in Etruria, Atti del Convegno Internazionale di Studi (Scansano, 9-10 settembre 2005), Siena 2007.
Declinazioni degli spazi di frontiera fra agricoltura, mito e archeologia
Sabrina Batino
372
In tale caso la vite cresceva addossata all’albero di supporto (fig. 1), come accadeva per l’arbustum gallicum, ma a differenza di quest’ultimo, i tralci venivano fatti passare tra un albero e l’altro, creando delle effettive sequenze di filari di viti intrecciate tra loro e dispiegate in senso prevalentemente orizzontale, talora anche a diverse altezze.Come risulta sia dai dati archeologici che da alcuni apprestamenti ancora esistenti tra area padana e Campa-nia, specialmente nella vasta pianura tra Capua e Aversa, la “piantata”, per una serie di motivazioni di tipo economico ed utilitaristico trova generalmente allocazione ai confini tra appezzamenti di diversa proprietà o tra appezzamenti destinati a diversa coltura, oppure ancora ai bordi delle strade o ai margini dei fossati per la raccolta e lo scolo delle acque piovane, distinguendo così gli spazi dedicati all’agricoltura da quelli del bosco, e i luoghi della cultura da quelli della natura. L’aspetto semantico del confine, che la vite - e in particolare, la vite maritata - porta in sè, ci permette però di far scivolare il focus dell’attenzione dal limite “colturale” fisico alla sfera della liminarità metaforica, per indagare accezioni differenziate dello stesso concetto di frontiera. E infatti, ci vengono incontro a facilitare questo ampliamento di prospettiva proprio alcune note a margine rispetto alla pianta, che qui di seguito cercheremo di puntualizzare.In prima battuta, alla luce delle considerazioni brevemente espresse sopra, sembra del tutto pertinente sot-tolineare la contiguità tra Fufluns, il Dioniso etrusco originariamente associato ai cicli stagionali e al vigore della vegetazione primaverile, e Selvans, nume tutelare della caccia e delle selve, che si riscontra nell’area assegnata alle divinità terrestri nel famoso modello in bronzo di fegato ovino conosciuto come «Fegato di Piacenza» (fig. 2)3. Un ulteriore spunto di riflessione è prospettato dalla doppia natura, selvatica e domestica dell’arbusto: essa anticipa, per così dire, l’altrettanto duplice carattere del suo corollario frutticolo, il vino, che, esito paradigma-tico di una metamorfosi e dunque di un passaggio da una condizione all’altra, nei suoi impieghi, tanto sociali che rituali, pone costantemente in risalto queste peculiarità, sottolineando l’intensa dialettica tra dimensione della barbaritas e dimensione della civilitas, tra esterno e interno, tra normalità e alterità, che trovano spazio comune nel prezioso liquor4.Soltanto un uso proprio dell’inebriante bevanda, all’interno di un quadro ben preciso di regole, come queste si instaurano nel simposio e nel sacrificio, consente infatti di apprezzarne i benefici effetti, collegati ad un armo-nico ordine sociale; l’allontanamento da tali norme, vale a dire un utilizzo non misurato del vino, comporta per colui che abbia intrapreso questo pericoloso percorso un cambio d’identità, che se non ritualmente gestito, lo proietta in una situazione di animalità ferina estranea al raziocinio, escludendolo dalla comunità degli uomini e dal mondo della polis (fig. 3). Soggetto divino che, come la «sua» vite, si destreggia tra le due condizioni antitetiche della physis e del nomos, padroneggiandole entrambe come figura paradigmatica di demarcazione e mediazione, è il greco Dioniso: tramite tra la città e ciò che le è «altro», vale a dire i luoghi dell’incolto come il bosco o il mare; viaggiatore in pellegrinaggio per le vie di mondi inesplorati fra popoli sconosciuti, dalle remote regioni indiane alle oscure plaghe catactonie; divinità di initia, che per loro definizione presuppongono il varco di una soglia, superata la quale si accede ad una realtà diversa da quella precedente (fig. 4)5.L’accoglienza del culto di Dioniso in Etruria, transitato verosimilmente attraverso Cuma, si colloca cronologi-camente nella fase di passaggio dall’arcaismo alla classicità – periodo di intensi contatti con il mondo greco per ciò che concerne la religione -, e risulta chiaramente attestata almeno dalla prima metà del V secolo a.C. grazie ad un piccolo repertorio di dediche inscritte su ceramiche attiche a figure rosse provenienti da contesti funerari della necropoli vulcente, rinvenute durante gli scavi condotti dal fratello archeologo di Napoleone, il
3 Il reperto bronzeo, interpretabile come strumento di esercitazioni didattiche oppure quale attributo di una statua di aruspice, ci forni-sce importanti indicazioni epigrafiche in merito alle divinità pertinenti ad ogni settore celeste, sulla scorta di magici parallelismi stabiliti tra le superfici superiore ed inferiore dell’organo animale e la suddivisione degli spazi urani ed inferi del mondo secondo la concezione etrusca. Un primo studio organico di questo importante monumento epigrafico in L.B. VAN DER MEER, The Bronze Liver of Piacenza. Analysis of a. Polytheistic Structure, Amsterdam 1987.
4 Per una serie di riflessioni complessive su questi aspetti, tra mondo ellenico, italico e romano, cfr. la raccolta di contributi in O. MUR-RAY, Sympotika: A Symposium on the Symposium, Oxford 1990.
5 Vastissima la bibliografia prodotta da antropologi, storici, archeologi intorno alla figura di Dioniso. Per un excursus completo sulle diverse fisionomie del dio dal mondo minoico alla tarda antichità romana, sottolineandone l’impatto fondamentale nella storia di molti aspetti rappresentativi della cultura europea, si vedano, oltre ai saggi ancora validi degli esperti di mitologia e storia delle religioni H. Jeanmaire e K. Kerenyi (H. JEANMAIRE, Dioniso: religione e cultura in Grecia, Torino, 1972; K. KERENYI, Dionysos: Archetypal Image of Indestructible Life, Princeton 1996), i contributi a firma di Frontisi-Ducroux, Graf e Isler-Kerenyi 2001, pubblicati nella collana curata da S. SETTIS, I Greci: storia, cultura, arte, società (cfr. F. FRONTISI-DUCROUX, Dioniso e il suo culto, in S. SETTIS (a cura di), I Greci: storia, cultura, arte, società, II, 2, Torino 1997, pp. 275-307; F. GRAF, I culti misterici in S. SETTIS (a cura di), I Greci: storia, cultura, arte, società, II, 2, Torino 1997, pp. 309-343; C. ISLER-KERENYI, Mitologie del moderno: «apollineo» e «dionisiaco» in S. SETTIS (a cura di), I Greci: storia, cultura, arte, società, III, Torino 2001, pp. 1397- 1417.
Nell’universo tematico sereniano. Studi di caso e metodi di analisi 50 anni dopo
373
principe Luciano Bonaparte6. In esse si legge il nome di Fufluns Pachie, termine, quest’ultimo, da intendersi come corrispettivo dell’epiklesis ellenica di Dioniso Bakcheios.Certamente queste epigrafi costituiscono un rilevante dossier a testimonianza di una delle valenze più spiccate della religione dionisiaca in area tirrenica, peraltro in completa assonanza con il comparto cumano, vale a dire l’accezione escatologica del culto, con la garanzia di salvazione riservata agli iniziati, che l’adesione ai Misteri del dio libera dai vincoli della morte7.Ecco dunque che il rito altamente socializzante del simposio e l’uso collettivo, ma al tempo stesso selettivo, del vino, svolti sotto l’egida del dio che insegnò agli uomini a trarre dalla pianta di vite il prodigioso succo, assumono nella cultura etrusca una connotazione non solo «civile» e «terrena» – come simbolo aristocratico di appartenenza ad una cerchia di privilegiati che governa l’ordine urbano -, ma si permeano di una specifica funzione oltremondana, come viatico verso quella salvezza che solo Dioniso può garantire e conferire (fig. 5). E in tal senso si mostrano particolarmente eloquenti alcune testimonianze archeologiche che denunciano il completo assorbimento del mondo del vino nella dimensione della morte: il riferimento è in questa sede alla nota categoria delle kelebai volterrane, crateri monumentali di produzione locale riccamente effigiati con sce-ne per lo più afferenti al mondo dionisiaco o al viaggio del mystes verso l’Ade, usati esclusivamente (almeno a quanto ci è permesso di arguire dai riscontri ad oggi disponibili) per scopi funerari, come contenitori delle ceneri dei defunti8. Tra le decorazioni ricorrenti, l’arrivo dell’iniziato - il tirso in mano – alle soglie dell’Oltre-tomba, dove i cavalli si arrestano di fronte alle colonne d’ingresso, a simboleggiare che l’ultima meta, senza ritorno, è ormai raggiunta.Questa classe di materiali, che a partire da poco dopo la metà del IV secolo a.C. metabolizza e sistematizza in chiave indigena un’abitudine già precedentemente riscontrata in Etruria con la quale si ricorreva alle pre-stigiose importazioni attiche, trova a sua volta seguito nella florida e rinomata produzione di urne lapidee che ebbe luogo nella stessa Volterra tra II e I secolo a.C.Come è stato opportunamente osservato, i rilievi di queste teche funebri propongono con frequenza la rappre-sentazione di crateri ed anfore, e secondo una verosimile ipotesi in tali riproduzioni si può leggere la risposta alla precisa volontà da parte di produttori e acquirenti di collocarsi idealmente sulla scia di una tradizione rituale più antica legata all’estremo passaggio, di cui si intendeva conservare salda la memoria, nonostante l’adozione di una diversa forma di sepoltura9.
6 M. CRISTOFANI, M. MARTELLI, Fufluns Paχies. Sugli aspetti del culto di Bacco in Etruria, «Studi Etruschi» XLVI, 1978, pp. 119-133; M. CRISTOFANI, Fufluns, Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) III, Basel 1986, pp. 531-540; G. COLONNA, Riflessioni sul dionisismo in Etruria, in F. BERTI (a cura di), Dionysos. Mito e mistero (Atti del Convegno, Comacchio 1989), Ferrara 1991, pp. 117-155; G. COLONNA, Il dokanon, il culto dei Dioscuri e gli aspetti ellenizzanti della religione dei morti nell’Etruria tardo-arcaica, in L. BACCHIELLI, M. BONANNO ARAVANTINOS (a cura di), Scritti di antichità in memoria di Sandro Stucchi, “Studi Miscellanei” XXIX, 1996, pp. 165-184.
7 Non a caso, del resto, una delle più antiche raffigurazioni etrusche del dio lo mostra nell’atto di assistere al rapimento mortale di Arian-na da parte di Artemide, premessa mitica della rinascita come dea sposa di Dioniso: G. COLONNA, Note di mitologia e lessico etrusco, «Studi Etruschi» LI, 1985, pp. 143-158, in part. pp. 154-155. Sul tema del banchetto e del simposio in ambito funerario etrusco, si vedano, fra gli altri, i contributi di L. CERCHIAI, Sulle tombe Del tuffatore e Della caccia e pesca. Proposta di lettura iconologica, «Dialoghi di Archeologia» 5 n. 2, 1987, pp. 113-123; L. CERCHIAI, Riflessioni sull’immaginario dionisiaco nella pittura tombale etrusca di età arcaica, in S. ESTIEN-NE, D. JAILLARD, N. LUBTCHANSKY, CL. POUZADOUX (a cura di), Image et religion dans l’Antiquité Gréco-romaine (Atti del Convegno, Roma 2003), L’Erma di Bretschneider, Roma 2008, pp. 439-447; L. CERCHIAI, B. D’AGOSTINO, Il banchetto e il simposio nel mondo etrusco, Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum, II, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, pp. 254-267. La Tomba del Tuffatore di Paestum costituisce un caso significativo di osmosi culturale tra mondo greco e mondo etrusco per quanto concerne la convivialità in senso funebre.
8 M. CRISTOFANI, Mistai kai bacchoi. Riti di passaggio nei crateri volterrani, «Prospettiva» LXXX 1995, pp. 2-14.9 R. ROTH, From Clay to Stone: Monumentality and Tradition in Volterran Urns, «American Journal of Archaeology» n. 113, 2009, pp.
35-56, con bibliografia e cenni sulle numerose collezioni esistenti in Europa oltre a quella del locale Museo Guarnacci.
Sabrina Batino
374
Figg. 1, 2 Fusto d’albero intorno al quale si avvolge una pianta di vite, rigogliosa di grappoli parzialmente ricoperti dai pampini. Parti-colare di una statua di Dioniso (II sec.d.C.). Centro di Documentazione, Carsulae (Tr); Il cd Fegato di Piacenza (II secolo a.C.). Museo Civico, Piacenza
Fig. 3 Il rapimento di Ippodamia. Particolare da un cratere apulo a figure rosse (350-340 a.C. circa). British Museum, Londra
Il mito racconta che in occasione del matrimonio tra il re dei Lapiti Piritoo e la principessa Ippodamia, i Centauri, che erano tra gli invitati a banchetto, in preda ai fumi dell’alcool infransero le sacre regole della xenia, tentando ubriachi di rapire la sposa e di molestare le altre donne. Si scatenò così una violenza fra le parti che degenerò nella guerra mitica chiamata Centauromachia. L’episodio è da considerare una narrazione esemplare delle conseguenze nefaste di uno scorretto uso del vino, e della spietata barbarie che esso scatena.
Nell’universo tematico sereniano. Studi di caso e metodi di analisi 50 anni dopo
375
Fig. 4 Dioniso e due satiri. Tondo di una kylix del Pittore di Brygos (480 a.C. circa). Cabinet des Médailles, Parigi
Nel mito, queste creature dall’aspetto ibrido umano e caprino, che vivono nei boschi simboleggiando la potenza generatrice della natura, sono, con le menadi, tra i consueti componenti del thiasos dionisiaco, ed incarnano compiutamente il concetto di alterità e di limite tra la sfera delle regole stabilite dal vivere civile, propria dell’uomo, e quella selva-tica della barbaritas, in cui si colloca idealmente l’animalità, governata dal solo istinto.
Fig. 5 Scena di banchetto. Particolare dalla Tomba dei Leopardi nella necropoli di Monterozzi, Tarquinia (480 a.C. circa)
E’ possibile osservare come tutta l’attenzione della rappresentazione sembri convergere visivamente verso la figura del primo commensale a destra della sequenza di banchettanti, da identificare verosimilmente con il defunto, colto nel gesto di alzare con enfasi il braccio per mostrare alla consorte e agli altri compagni un uovo, simbolo universale di vita e rigenerazione, auspicio della sua rinascita dopo la morte.
Sabrina Batino
376
Title
Nell’universo tematico sereniano. Studi di caso e metodi di analisi 50 anni dopo
The well-known technique of cultivation of grapevine named vite maritata is an etruscan heritage, archaeologically surviving in many rural landscapes of the Penisola until the last century.Thanks its location often marking a transition between sites designated for agriculture and areas of pasture or forest, it can be undestood as a physical boundary, but, metaphorically, it may suggest some different variations of the word “frontier”, across the subjects and the cultural elements semantically related to the Vitis vinifera.The product of the vine, wine, is the effect par excellence of a transformation (a passage, ultimately). Its uses, both public and ritual ones, always emphasize this peculiarity, together with the strong relationship between the sphere of barbaritas and that one of civilitas, vividly “cohabiting” in the precious liquor of Dionysus.Observing data about agricultural scenaries of ancient Etruria valued by E. Sereni, this paper will focus on some expressions concerning concept of limit and liminarity in ancient mediterranean world, through a common thread consisting of grapevine, wine and the cultural world built around these themes.