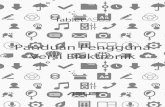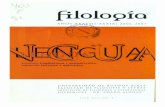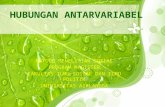Da Gallerio a Driulini, sul filo dei versi
Transcript of Da Gallerio a Driulini, sul filo dei versi
DA GALLERIO A DRIULINI, SUL FILO DEI VERSI 657
Quando, verso l ’ autunno del 1880, don Giuseppe Driu-
lini viene scelto quale cappellano di Vendoglio, parroco
del paese collinare è un altro prete originario di Tricesi-
mo, don Giovanni Battista Gallerio. Il cooperatore, che
aveva ricevuto l ’ ordine presbiterale il primo agosto di
quell ’ anno, passerà soltanto alcuni mesi accanto al più
anziano sacerdote: nella notte tra il 16 e il 17 gennaio
1881, questi sarà improvvisamente stroncato da un
colpo apoplettico.
Quello che ha fatto incrociare le strade dei due poeti
di cui si parla in questo contributo è stato dunque un
tratto di tempo molto breve: quasi trascurabile nella
lunga carriera vissuta da Gallerio in larghissima parte
a Vendoglio, e invece collocato all ’ inizio di una intermi-
nabile serie di peregrinazioni nel caso di Driulini, di ben
quarantadue anni più giovane. Tuttavia quei pochi mesi
costituiscono, forse non soltanto idealmente, una sorta
di passaggio di consegne tra due sacerdoti che in modi
molto diversi hanno arricchito la letteratura friulana con
contributi poetici originali e densi di motivi di interesse.
Due vite, non sempre parallele
Per quanto collocate su archi temporali soltanto in parte
coincidenti, le vicende biografiche di pre Tite Galeri e di
GABRIELE ZANELLO
DA GALLERIO A DRIULINI, SUL FILO DEI VERSI
Il paesaggio dei nostri poeti: il Çuc di San Pieri.
GABRIELE ZANELLO658
il giovane manifesta apprezzamento per la fisica e la
matematica, che continuerà a studiare per tutta la vita,
ma ottiene risultati eccellenti in tutte le materie e ri-
sulta particolarmente versato nello studio delle lingue,
tanto che il vescovo di Udine, mons. Emmanuele Lodi,
lo invita ad apprendere anche l ’ ebraico, oltre al latino
e al greco. Un percorso senza traumi, dunque, assai
distante da quello di Driulini, il quale da chierico deve
affrontare tre anni di servizio militare a Trapani, in una
Sicilia ancora oppressa dal brigantaggio. In seminario,
peraltro, si distingue “ per la sua intelligenza aperta,
per prontezza, acume, serenità e versatilità di mente
penetrativa, per il suo ingegno semplice e per la sua fede
tenace ” (Gatti 1951, 19). Infine, ricevuti gli ordini sacri,
inizia ad associare al ministero l ’ attività di insegnante,
secondo una formula abituale per il clero dell ’ Ottocento
e oltre: jò ’ ne salût di fiâr / e plen di bon volê, / alegri ’ o
scombatevi / in scuèle a plui podè (Melchior 1999, 141);
un servizio svolto con energia, entusiasmo e risultati
proficui ad Amaro, a Vendoglio, ad Artegna e a Lusevera
(e ancora, negli incarichi successivi, nella scuola serale
per i giovani; cfr. Gatti 1951). Ma nei versi la passio-
ne pedagogica affiora insieme con un vero e proprio
affetto per gli alunni, un affetto analogo a quello che
il parroco di Vendoglio dimostrava nello svolgere il
proprio servizio pastorale con i più giovani, come scrive
Biasutti: “ Era maestro nel tenere la dottrina cristiana,
in friulano, ai fanciulli; coi quali sapeva parlare da pari
a pari, suscitando in essi un affetto filiale, che li faceva
accorrere in festa al suo passaggio per le vie ” (Biasutti
, ). D ’ altra parte molte delle opere di Gallerio
sono concepite proprio in ottica educativa, e non è
fortuito il fatto che la sua copiosa produzione poetica
nasca sempre all ’ insegna della cantabilità, della varietà
Siôr Barbe presentano diverse analogie. Sono comuni,
innanzitutto, le origini contadine. La famiglia in cui
Gallerio vede la luce, a Monastetto il 24 giugno 1812,
è di piccoli possidenti benestanti, ma il 1817, anno di
fame, lascerà i suoi segni anche sul fisico del piccolo Gio-
batta, apparso ben presto inidoneo al lavoro dei campi
(Brusini 1988, 65). L ’ inizio degli studi nel seminario di
Udine – un destino piuttosto consueto in quegli anni per
coloro che, nelle famiglie rurali più abbienti, mostravano
una certa propensione allo studio – è peraltro alquanto
tardivo, e il sacerdote stesso ricorderà anche da adulto
le notti di carnevale trascorse a ballare con la fidanzata
(Brusini 1988, 65). Il 29 marzo 1854 – Gallerio è già da
quasi quattordici anni parroco di Vendoglio – Driulini
nasce a Fraelacco “ da una famiglia di poveri agricoltori ”,
come sottolinea lui stesso in una breve autobiografia
(Giuseppe Driulini 1949, 116; Pascolo 1963, 3); la sua
infanzia attraversa gli eventi convulsi della seconda guerra
di indipendenza, ma di quegli anni i suoi versi ricorde-
ranno soprattutto la quotidianità di una vita familiare
vissuta all ’ insegna di una umile e onesta operosità, di
un ‘ ora et labora ’ fondato sul timor di Dio, sul rispetto
delle istituzioni, sulla pacifica convivenza: si lavore e si
pree, / si trate ben il puar e il siôr, / si pae l ’ esatôr, / si
cîr di fà ce che al Signôr i plâs (Floreanade XIX, 17-24;
Melchior 1997-1998, 111). In un ambiente così pro-
fondamente cristiano, sul quale aleggia la presenza di
almeno quattro sacerdoti (tre fratelli della madre e un
prozio, Pietro Driulini, che lo battezza), la scelta della
carriera ecclesiastica non stupisce, ma lascia intendere
motivazioni alquanto diverse da quelle che verosimil-
mente stavano alla base della vicenda di Gallerio.
In quest ’ ultimo, tuttavia, non si può riscontrare qual-
che forma di renitenza: sin dagli anni del seminario
DA GALLERIO A DRIULINI, SUL FILO DEI VERSI 659
anche dal carteggio, conservato presso l ’ archivio parroc-
chiale di Vendoglio, fra Gallerio e il vescovo di Udine;
tuttavia l ’ appoggio e la stima del presule sono costanti,
come dimostra la pronta accoglienza della rinuncia al
vicariato, nell ’ ottobre del 1840, e la successiva nomina
a parroco di Vendoglio, giunta già il 19 novembre. Nel
1892, invece, la popolazione di Lusevera elegge Driu-
lini quale proprio vicario curato; in realtà egli, che era
giunto in quella località nel 1886 quale cappellano
curato, è l ’ unico concorrente per la sede. Anche lui, nel
1893, rinuncia all ’ incarico, ma nel suo caso i toni della
metrica, di un ’ indole intimista garantita efficacemente
anche dall ’ (ab)uso dei diminutivi. Che una tale scelta
debba essere riconosciuta come consapevole lo si deduce
da una lettera del dicembre del 1878, scritta da Gallerio
a Vincenzo Joppi per ringraziarlo di avergli inviato
una “ pregevole memoria ” (non meglio identificata) e
per invitarlo a studiare, con competenza di filologo,
le parole con cui i bambini friulani si rivolgono ai loro
genitori nei primi anni di vita (Gallerio 1891a; ma cfr.
Chiurlo 1907, 23). Non è accessoria a questa sensibilità
neppure la simpatia con cui Gallerio guarda all ’ Opera
della Santa Infanzia, a beneficio della quale escono, fra
1861 e 1863, due (e forse tre) opuscoli di preghiere la cui
paternità va assegnata al parroco di Vendoglio (anche
Il furlan a messe o meditazions e prejeris par assisti cun
devozion al sant Sacrifizi de l ’ altar, del 1862, con tutta
probabilità non è di don Pietro Benedetti, come invece
sostiene Toller 1962, 16-19).
Un ’ altra delle esperienze comuni ai personaggi di cui
ci occupiamo va riconosciuta nel ministero pastorale
prestato presso le “ Ville Schiave ”, ossia le dieci filiali
della pieve di Tarcento che ormai da secoli compone-
vano il vicariatus sclaborum: Ciseriis, Zomeais, Stella e
Malmaseria, Coja, Sammardenchia, Sedilis, Cesariis,
Pradielis, Villanova, Lusevera. Inviato nel 1835, subito
dopo l ’ ordinazione, quale cooperatore domestico presso
il pievano di Tarcento mons. Pisolini, Gallerio riceve nel
1838 l ’ incarico di vicario di tali paesi, ma a differenza dei
suoi predecessori è tenuto a risiedere a Ciseriis. Nel tem-
po le vicissitudini delle “ Ville Schiave ” e le tensioni con
la pieve di Tarcento, percepita in loco come antagonista,
hanno sollevato preoccupazioni sempre maggiori nelle
autorità diocesane e nei pastori d ’ anime a esse assegnati.
Dissapori con la deputazione comunale si intuiscono
Don Giuseppe Driulini in un bel ritratto dello Studio Fotografico L. Pignat
di Udine.
GABRIELE ZANELLO660
ra, che tradisce subito una conflittualità accesa con le
gerarchie ” (Melchior 1999, 142). Dopo il paese della
Stradalta, l ’ itinerario comprende il santuario della Ma-
donna delle Grazie a Udine e le cappellanie di Leonacco,
Collerumiz, Farla di Majano, Cerneglons (poi elevata a
vicaria) e Bonzicco, fino ai quindici anni di quiescenza
trascorsi a Fraelacco nella completa cecità (Ermacora
1944): quanto di più lontano si possa immaginare dalla
tranquilla sedentarietà vissuta da Gallerio a Vendoglio
per quattro decenni scanditi soltanto da brevissimi
viaggi, dalla pubblicazione delle poesie religiose, dalla
stesura dei discorsi e dei versi composti nelle più diverse
occasioni, in particolare negli ingressi dei parroci, negli
anniversari, nelle cerimonie funebri e nelle inaugura-
zioni. In pieno consenso alle direttive dei superiori,
Gallerio dimostra tutta la propria sollecitudine pastorale
in una predicazione vivace, nella catechesi in friulano
e nell ’ approfondimento della teologia, della filosofia e
della storia moderna per conciliare le nuove scoperte
scientifiche con la fede; sui giornali cattolici “ Il Cittadino
Italiano ” e “ L ’ Eco del Litorale ” ha modo di esprimere,
ma senza sterile sdegno, la propria passione di vigoroso
apologeta e polemista (Biasutti 1958, 43). Apprezzato
dalle autorità diocesane e amato dalla gente del paese, in
virtù della sua oratoria semplice e chiara viene chiamato
in numerose località del Friuli a predicare le missioni
al popolo, che per lui diventano occasione preziosa per
esortare i fedeli a una fede impavida e granitica.
D ’ altronde anche la notorietà di Siôr Barbe travalica,
grazie ai versi, i confini angusti delle cappellanie. La
cerchia dei lettori che lo ammirano allarga ampiamente
quella dei fedeli, che spesso si trovano ad avere a che fare
con un carattere spigoloso, con un ’ indole poco disposta
ad accettare una religione vissuta superficialmente,
richiesta non sottacciono una situazione tesa: “ Dopo
un settennio di immediato contatto con Lusevera e le
annesse borgate della Vicaria, attentis adiunctis, il sac.
Giuseppe Driulini ne ha quanto basta sia per l ’ anima
quanto per il corpo ” (ACAU, Serie “ Presbiteri dioce-
sani defunti nel secolo XX ”, fasc. pers. del sacerdote
Driulini Giuseppe, lettera del 15.3.1893); pochi giorni
dopo il sacerdote rinnova al vicario generale la supplica
( “ prego quindi Vostra Signoria Rev.ma a degnarsi di
tener parola in proposito con Sua Eccellenza, affine di
liberarmi da questo mio letto di Procuste ”) e chiede
che gli sia affidato “ un posto di cappellano-maestro,
preferibilmente nell ’ Alta di Udine, non però inter Slavos ”
(ivi, lettera del 7.4.1893). Un anno prima, nel 1892, su
suggerimento di persone devote aveva fatto giungere
a Lusevera l ’ immagine della Madonna di Pompei e
aveva chiesto il permesso di poterla benedire; essen-
dogli stato risposto che l ’ incombenza era prerogativa
del pievano, protestava ancora col vicario generale: “ A
che obbligare il parroco di Tarcento a recarsi in questa
bella stagione quassù a perdere una giornata intiera? Io
credo che tutti i Cappellani di montagna possano dirsi
Rectores Ecclesiarum o tanto o più del famoso ab. Conte
Romano di costà. Ma io sono un asino, come tutto il
clero della Diocesi. Lo ha detto Berengo [l ’ arcivescovo,
n.d.r.] e basta ” (ivi, lettera del 4.2.1891). Dopo questi
scambi, tutt ’ altro che sereni, con le autorità diocesane,
il 12 ottobre 1893 Driulini diventa parroco a Castions
di Strada.
La trafila di parrocchie che Driulini attraverserà, sem-
pre come cooperatore o cappellano dopo la parentesi
di Castions, non può non far sorgere il sospetto della
strategia punitiva, o almeno di “ un nomadismo certo
non volontario, non dovuto a una vocazione zinga-
DA GALLERIO A DRIULINI, SUL FILO DEI VERSI 661
1997-1998, 103); principi antitetici non soltanto alla
violenza, ma anche alla religione vissuta in modo for-
male o ipocrita dai fascisti e da coloro che a ’ jan cjolt il
Crist dai cûrs / par picjâlu su pai mûrs (Floreanade XVI,
apparato; Melchior 1997-1998, 93; Driulini 1955, 24).
I versi corrono di bocca in bocca, sussurrati tra amici
e confidenti; le minacce di provvedimenti da parte dei
superiori diocesani non tardano, ma la voce non si lascia
intimorire, e continua a denunciare soprusi e connivenze.
La critica più benevola ha apprezzato, in questi due
autori, anche i riferimenti ai modelli in lingua, cono-
sciuti sulla base di una cultura solida e ampia. Le carte
conservate a Vendoglio restituiscono per Gallerio nomi
e citazioni di poeti religiosi del Seicento e del Settecento
(Carlo Maria Maggi, Francesco De Lemene, Tommaso
Ceva), e naturalmente di quelli dell ’ Ottocento (Tomma-
so Grossi, Giovanni Prati, Aleardo Aleardi, Giuseppe
Giusti, Giacomo Zanella e Alessandro Manzoni), a
confermare un debito che già le grazie settecentesche e
l ’ ispirazione romantica della scrittura letteraria avevano
denunciato. Driulini si rivolge invece al poeta civile e
satirico ottocentesco per antonomasia, dedicandogli
anche una breve poesia: “ Risorgi, caro Giusti, / poeta
dei miei gusti, / e in una man la lira, / nell ’ altra lo
staffile, / a flagellar ti ispira / codesta età servile / che
canta libertà / e cosa sia non sa ” (Driulini 1955, 119;
Melchior 1999, 162).
Avvicinare e confrontare questi poeti accomunati dal-
la provenienza tricesimana spinge a soffermarsi sugli
aspetti più insoliti della produzione dell ’ uno e dell ’ altro,
non tanto con l ’ intenzione di esaminare qualche inedito,
quanto con quella di contribuire a un ritratto a tutto
tondo, di sottrarre il loro ricordo agli stereotipi entro
cui la critica talora li ha costretti o per una eccessiva
con un temperamento che, pur intriso di generosità
e disinteresse, non esita a far presente la situazione
di difficoltà economica del clero e a far valere i propri
diritti. E questo carattere insofferente alle regole e agli
ordini non condivisi è anche alla base degli attriti con
la curia udinese e con le gerarchie fasciste, contro le
quali Driulini si scaglia sia nelle poesie che circolavano
manoscritte, sia nei ventuno testi aspramente satirici
conosciuti come Floreanadis e scritti, tra il 1921 e il
1925, per “ Il Lavoratore Friulano ”, settimanale socialista
diffuso in tutta la regione. Tuttavia la fortuna di Siôr
Barbe ha respiro breve: dopo la morte, che il 6 gennaio
1949 lo coglie novantacinquenne, è scarso il successo
postumo delle poesie raccolte da Chino Ermacora nel
1955 (Comelli 1982, 318); conseguenza non soltanto
del carattere necessariamente occasionale della scrittu-
ra satirica, ma forse anche della volontà, presente nel
potenziale pubblico del dopoguerra, di voltare pagina
rispetto a ciò di cui quei versi parlavano.
In modi assai disparati, dunque, e a partire dalle ri-
spettive (e assai diverse) situazioni sociali, politiche
e religiose in cui si sono trovati a operare, Gallerio e
Driulini non si astengono dal dire la propria, a porre
la parola del Vangelo in stretto contatto con la realtà; e
se il primo preferisce i canali della predicazione e della
stampa cattolica per difendere la Chiesa e contrastare
il “ paganesimo socialista ” e l ’ anticlericalismo liberale,
riservando la poesia per l ’ ispirazione spirituale e con-
templativa, l ’ anticonformista e combattivo Driulini si
serve proprio dei versi satirici per una battaglia civile
profondamente ispirata ai principi evangelici: Jo, Ven-
turin, da bon cristian, / ’ o stoi de bande dal capelan, /
che mi à insegnât che, essint duc ’ fradis, / no vin di fâsi
mai baronadis (Floreanade XVIII, 37-40; Melchior
GABRIELE ZANELLO662
Per gioco
Nel maggio del 1875, durante una delle rare occasioni
in cui lascia Vendoglio, Gallerio si trova a Pontafel, in
Austria, subito al di là del confine di Pontebba, e in
quella località coglie l ’ occasione per scrivere a un inti-
mo amico un sonetto giocoso in italiano e in tedesco
(APV, busta “ Memorie e scritti del parroco e poeta don
G. B. Gallerio ”); protagonisti sono l ’ autore stesso e il
compagno di viaggio don Angelo Noacco (1832-1904),
nato a Rizzolo, professore nel Seminario di Udine,
appassionato progettista di numerosi luoghi di culto
edificati in tutto il Friuli secondo quel neomedievalismo
così in voga all ’ epoca, nonché parroco del vicino paese
di Cassacco; il destinatario, invece, è don Domenico
Pancini, il quale pochi anni dopo riceverà il compito di
pronunciare, nella parrocchiale di Vendoglio, l ’ orazione
funebre nel trigesimo della morte di Gallerio (Pancini
1881):
Al R.mo Parroco di S. Giorgio di Nogaro
Sonetto
D ’ oltre il confine ove suona il sì,
mando un saluto a Voi, caro Monsieur;
ve ’ l dice anche Noacco, anch ’ egli è qui,
un lebe wohl, e non sa dir di più.
Mangiam Speknedel, Schinken tutto il dì, 5
e gutes Bier beviam di soprapiù:
Noacco molto, ed io così così,
reuchen i bon cigarren di quassù.
Ich bitte, herr Pfarrer, vollen trinken Wein,
una sehr schöne Kelnerin a me 10
dimanda. Io le rispondo: Ich denke, nein.
severità o per una indulgenza dettata dall ’ affetto e dai
toni celebrativi. Rileggere certe pagine satiriche di Gal-
lerio, per esempio, permette di prescindere da quello
sguardo oleografico che ci ha consegnato il ritratto di
un prete in qualche misura avulso dalla realtà concreta,
immerso nel proprio otium letterario, “ passeggiante fra
roncs e tavielis, un dito dentro il Breviario socchiuso,
un distico affiorante sopra i pensieri, il sereno cuore
di contadino spalancato alla contemplazione delle nu-
vole e degli orizzonti ” (Comini 1955, 13). Gallerio è
anche altro, come hanno segnalato in modo piuttosto
episodico anche i critici e come rivelano alcuni inediti
presenti fra le sue carte.
Don Giovanni Battista Gallerio nell’unico ritratto che ci è pervenuto.
DA GALLERIO A DRIULINI, SUL FILO DEI VERSI 663
intermedia fra la gravità del più giovane destinatario
Monsieur Pancini e le intemperanze di Noacco, incline
a gutes Bier e al goloso del succo della vite. A rincalzo,
la corposa sonorità di Speckknödel (gnocchi di pane al
lardo) e Schinken (prosciutto) completa anche sul piano
fonico la caratterizzazione della scenetta.
Dalla corrispondenza con il parroco di San Giorgio
intuiamo, oltre al grande attaccamento di quest ’ ultimo,
anche il fatto che la composizione di una breve poesia
era una delle consuetudini – quasi piccole ritualità – che
accompagnavano le uscite; così, infatti, Pancini scrive
a Gallerio il 29 settembre 1876 (e si osservi la data):
“ Appena tornato da Qualso trovai il sonetto, che giunse
col timbro di Pontebba. Lo rilessi con piacere e dissi
fra me e me: le trenta miglia che mi separano da chi ha
fatto questo sonetto con trenta miglia di gran seccatura.
Se invece di trenta fossero tre, sovente godrei qualche
ora di vero sollievo ” (APV, “ Memorie e scritti ”, lettera
di D. Pancini a G. B. Gallerio, 29.9.1876). L ’ amicizia
e la comune passione letteraria (associata a quella per
l ’ enigmistica, in particolare per rompicapi come i so-
netti logogrifi e le sciarade in versi) costituiscono un
importante diversivo per quell ’ indole malinconica che
il sacerdote adombra nella stessa missiva: “ Io quì me la
passo come sempre. Poco contento e poco addolorato ”.
Immancabili, nelle lettere, gli inviti a venire in visita a
San Giorgio e i saluti per la piccola cerchia degli amici
che vivevano o si incontravano nella canonica di Ven-
doglio: “ Mi saluti don Bastiano, Noacco, don Antonio
suo cappellano e Maria di lui sorella ” (APV, “ Memorie e
scritti ”, lettera di D. Pancini a G. B. Gallerio, 23.3.1876).
Le sollecitazioni disattese, in particolare da don Bazzara,
provocano vive proteste: “ Il bericchino di Capellanut
non volle portarsi a Carlino per S. Rocco, invece mi
Ma Noacco, goloso, che si sa,
del succo che la vite ognor ci diè,
le mostra il Krigel e le dice: Ja!
Pontafel, maggio 1875
All ’ apparenza, il foglietto volante che restituisce il com-
ponimento sembra non proporre nulla di più di uno
scherzo poetico, destinato a scorrere con leggerezza dalle
mani del suo autore a quelle del destinatario, per consu-
marsi fugacemente in un sorriso, in un attimo di svago.
Ma l ’ abile Gallerio mantiene una scrittura sorvegliata
e addirittura ricorre, certamente con consapevolezza,
a qualche espediente retorico di facile effetto. La scelta
del plurilinguismo può apparire scontata e funziona-
le alla situazione, ma al di là delle incertezze grafiche
(Speknedel per Speckknödel, vollen per wollen, Kelnerin
per Kellnerin, Krigel per Krügel, forse anche denke per
danke) conferma la consistenza di quel gusto per le
lingue straniere di cui già si è detto; un gusto sui cui
sembra giocare il contenuto stesso del sonetto, contrap-
ponendo alla relativa scioltezza linguistica e alle garbate
risposte dell ’ autore (Ich denke, nein) le esclamazioni
essenziali ma efficaci del Noacco: un lebe wohl ( ‘ stammi
bene ’ ) e soprattutto quello Ja!, esposto in punta di verso,
di strofa e di componimento, e accompagnato, a ogni
buon conto, dal gesto risoluto di mostrare il boccale
alla cameriera. Ma conta anche l ’ atmosfera disegnata
dagli endecasillabi tronchi del sonetto: una spontaneità
amicale un po ’ arruffata, goduta all ’ insegna di Bacco,
del tabacco e di una Venere che assume le sembianze
seduttrici della sehr schöne Kelnerin ( ‘ una cameriera
molto bella ’ ); una franchezza scomposta e incontrollata
nella quale Herr Pfarrer Gallerio, con i suoi dinieghi e i
suoi “ così così ”, sembra volersi garantire una posizione
GABRIELE ZANELLO664
A mal partito son così ridotto
che lis braghessis plui no mi stan su; 10
langue il mio corpo e tutto il capo ho rotto:
’ o soi propri il ritratt de la penurie;
e non potendo aver pazienza più,
’ o mandi là che ’ o sai plevàn e curie!
Se il risvolto formale lascia percepire la scrittura a quat-
tro mani, cosicché gli artifici risultano meno significativi,
è peraltro vivace il contrasto dei codici, che in qualche
caso si potenzia diventando anche frizione di registri
(nonostante le censure e gli eufemismi: par bio, là che ’ o
sai). Nell ’ interpretazione del componimento, invece, ci
vengono in aiuto le note di Costantini, il quale ha avuto
modo di ricostruirne allusioni e sottintesi: la misteriosa
“ carta ” di cui si parla, ricetta di veleno e bisturi insan-
guinato, è il documento che don Tita Miotti, prete
originario di Conoglano (classe 1818), doveva presentare
ogni sabato alla firma del parroco di Cassacco onde evi-
tare la sospensione a divinis; si trattava insomma di un
espediente escogitato dalla curia udinese per impedire
quelle che Costantini si limita a definire semplicemente
“ scappatelle ”, evitando, “ per carità di prossimo ”, di svelare
la vita del sacerdote e “ dire di lui tante cose buffe ed
alcune seriamente umoristiche ” (Costantini 1900-1901,
145). I versi ci presentano un uomo costretto a digiuni e
privazioni: ridotto “ a mal partito ”, illanguidito nel corpo,
smagrito al punto da perdere i pantaloni e da sembrare
un ritratto della miseria, Miotti perde la pazienza e
manda al diavolo parroco e curia. Sul carattere delle
“ scappatelle ”, benignamente sottaciuto anche dai versi
Gallerio e Pancini, non è affatto renitente Chiurlo quan-
do commenta il componimento friulano che da Pietro
Zorutti si fece destinare don Miotti in persona, prete
scrive che andrà non so con quale compagno a Zara.
Gli dica che […] strada facendo per Zara si poteva
combinare d ’ arrivare anche un giorno da queste parti,
giacchè sarebbe stato tutto preparato per il trasporto.
Insomma ora è fatta, ma se me ne fa delle altre Perbacco!
sentirà il mio poetico furore ” (APV, “ Memorie e scritti ”,
lettera di D. Pancini a G. B. Gallerio, 5.8.1876). “ Non
ha torto ”, annota Gallerio.
Per scherzo
Agli attimi di svago concessi dall ’ amicizia con il parroco
di San Giorgio si deve un altro sonetto, che Giuseppe
Costantini, curatore dell ’ edizione più completa delle po-
esie friulane di Gallerio, ha ritenuto opportuno escludere
dalla silloge del 1900 (Gallerio 1900) preferendo darlo
alle stampe su “ Pagine friulane ” (Costantini 1900-1901).
Costantini, riconoscendo il valore di alcuni degli scherzi
poetici conservati presso il successore don Bazzara,
spiega anche che questo sonetto è stato improvvisato
nella canonica di Vendoglio da Pancini e da Gallerio,
che si sono alternati componendo rispettivamente i
versi in italiano e quelli in friulano:
La carta di don Tita
(soliloquio)
Questa carta, a dir vero, è maledetta!
È son sîs àins che l ’ ai culì cun me!
Di veleno mi sembra una ricetta
e plui no sai, par bio, ce fâ di jé.
Il giorno di bruciarla invan s ’ aspetta; 5
il plevàn mi ten dùr senze un parcè,
sangue mi cava come una lancetta:
l ’ è afàr di disperâssi, sì la fè!
DA GALLERIO A DRIULINI, SUL FILO DEI VERSI 665
No l ’ è po ’ stàd clamàd da la nature / par la letterature;
/ di politiche an sa màncul dai siei stivàij; / al à scienze
e criteri / in abondanze pa ’ l so ministeri; / valent nel
funzionâ, / passionàd pa ’ l çhantâ, / l ’ ame la glesie cun
grande devoziòn (Zorutti 1990, 564). Dopo una breve
carriera vissuta come cappellano in vari paesi del Friuli,
Miotti si ritira nella natìa Conoglano: Cumò di pôc in cà
/ ritiràd dal servizi, / al vîv a çhase so / occupansi di cûr
in ce ’ ch ’ al pô. Ma ritorniamo alla nostra poesia: anche
in questo caso la vicenda invita a restringere lo sguardo
sull ’ occasione della composizione: verosimilmente un
ritrovo di amici sacerdoti, con la presenza, oltre che di
Pancini e di Gallerio, anche del suo cooperatore Baz-
zara, di Noacco e di Miotti stesso (e questa presenza
può giustificare il riserbo). È peraltro singolare anche
la sorte riservata a don Noacco: proprio lui, che nel
sonetto precedente veniva benevolmente preso di mira
per i suoi eccessi, viene ora individuato quale garante
della buona e irreprensibile condotta del confratello.
Per sdegno
Mai largo di elogi nei confronti della poesia di Gallerio,
sovente criticata per “ quel vezzo diminutivo-vezzeg-
giativo ” che conferisce ai versi un sapore dolciastro e
un carattere infantile (Chiurlo 1940), Bindo Chiurlo
segnala la sottile vena di umorismo che anima le poesiole
profane dedicate ai piccoli animali (Gallerio 1881),
rilevando come tale vena abbondi invece nelle poesie
inedite che don Antonio Bazzara conservava con cura
gelosa tra le proprie carte (Chiurlo 1907). Lo studioso
cita il racconto giocoso di una gita di preti in Austria
(e potrebbe trattarsi del sonetto qui esaminato, o forse
di un altro analogo, come la consuetudine lascia pre-
sumere) e una umoristica Marchettade che finora non è
“ corto di cervello e di coltura, ma, in compenso, molto
soggetto alle tentazioni della carne, e pronto a fermarsi a
scherzare colle ragazze del paese, per cui teneva sempre
in tasca un involtino di mandulis ambrusinis ”. Insomma
“ un tipo di prete sui generis tra balordo e sensuale, non
discaro alle compagnie liete, che si divertivano alle sue
spalle, specialmente quando prendeva sul serio i compli-
menti ironici che gli rivolgevano ” (Zorutti 1990, 564).
Il ritratto di Zorutti sembra essere più clemente, ma
in realtà disegna una persona insulsa (al punto che la
poesia stessa, secondo Chiurlo, è insipida e stupida):
Don Giuseppe Driulini, Sior Barbe, in età avanzata.
GABRIELE ZANELLO666
buttait i Peress
in muel come i pess.
Su su a Racolane
chel çhioch di Lauzane 25
che al torni in preson
so fradi spion.
Chel porch di Osovan
nassut tal ledan
mandailu a fa foti. 30
E intant scampanoti
pur Rivis d ’ Arçhian
un uè e un doman:
din don e din dan.
No stait a sei frez 35
su su Colorez,
no no che in esili
no l ’ è pre Basili;
al ’ è capelan
a Rivis d ’ Arçhian. 40
Al va a spas pe vile,
al çhiante, al sivile,
e Pin e il speziar
al manda all ’ infiar;
e il sior di Rizzul 45
lu à la dal cul,
cu la so p…..,
cul çhioch di Lauzzane,
e so fradi lari,
spion, incendiari. 50
Peres rufian
cun dut l ’ Osovan
ju mande a fa foti.
E intant scampanoti
pur Rivis d ’ Arçhian; 55
stato possibile rintracciare. Decide, invece, di pubblicare,
sulla base della copia autografa in suo possesso, la po-
esia ferocemente satirica che qui si riproduce secondo
l ’ edizione comparsa su “ Le nuove pagine ”:
La partenza
del cappellano don Basilio Benedetti da Colloredo di
Mont ’ Albano nell ’ anno 1862 per Rive d ’ Arcano, dopo
discordie suscitatesi tra lui, il cappellano di Lauzzana
don Pietro Zuliani, Del Pino don Giovanni parroco
quiescente, il medico condotto di Colloredo Bertani e
alcuni signori del castello.
Din din e dan dan
un uè e un doman:
sintit lis çhiampanis
che sunin lontanis
di Rivis d ’ Arçhian. 5
No stait a sei frez;
su, su Colorez;
dait fuch al canon.
Mandait sior Berton
bricon e purcit, 10
a fa il çhialzumit,
a çhioli la zappe
a tignì su la grappe
lajù par Rizzul.
Mandait fur dal cul 15
chel bech di speziar:
netait chel seglar!
Fur fur di ché cove
Teresie chè scrove;
fur fur dal confin 20
chel bestie di Pin;
DA GALLERIO A DRIULINI, SUL FILO DEI VERSI 667
seglar!, più insolite rispetto alla pur prolungata litania di
epiteti zoologici: purcit (v. 10), bech (v. 16), scrove (v. 19),
bestie (v. 21), porch (v. 28, e con i pess del v. 23); questi
appaiono concentrati nella prima parte dell ’ invettiva,
e precedono la ripresa dei versi iniziali di esortazione:
No stait a sei frez; / su, su Colorez. La seconda parte,
anch ’ essa racchiusa fra la ripresa centrale e quella finale
del tema delle campane, ritorna su tutti i bersagli della
din din e din dan
un uè e un doman.
Afferma Chiurlo che “ Artisticamente la poesiola ha un
solo merito: che vi si sente solo lo sdegno. Del resto
questo si è espresso in modi troppo volgari, perché
possa piacere ” (Chiurlo 1907, 25); il critico segnala
altresì la plastica efficacia di espressioni come netait chel
Il paesaggio dei nostri poeti: la Cjassanìe.
GABRIELE ZANELLO668
Bruneti che al ven a Colored di Montalban laureat in Me-
disine (Zanello 2005, 139-43); i versi sembrano risalire
alla fine del 1880, mentre è di alcuni anni precedente
il brindisi per Capodanno inviato All ’ illustrissimo ca-
valiere professore medagliato signor Antonio Clocchiatti a
Gemona il 27 dicembre 1876 (Gallerio 1891b). In ogni
caso si tratta di testi che si avvicinano a quelle poesie
d ’ occasione di cui l ’ edizione del 1885 aveva dato ampio
saggio (Gallerio 1885, 257-93).
In omaggio
Per manifestare il proprio affetto filiale nei confronti
di Gallerio, a fianco del quale è vissuto per alcuni mesi
durante il proprio servizio pastorale a Vendoglio, Driu-
lini sceglie l ’ immagine della rondine, tanto cara al poeta
tricesimano da comparire non soltanto nelle due ben
note poesie a essa intitolate, La viarte o il salut alla cisile e
La siarade o l ’ adio a la cisile, ma anche nella produzione
religiosa, come attesta L ’ amor di Dio, dallo Svearìn ne
l ’ occasion del S. Giubileo 1865 del Plevan di Vendoi (Gal-
lerio 1865). Roberta Melchior, che nella tesi di laurea si
è occupata con puntualità e diligenza dell ’ edizione di
gran parte degli scritti friulani di Driulini, così descrive
il tono di questo componimento: “ Un ’ atmosfera dolce
e rarefatta, richiamata nel componimento dedicato a
Giovanni Battista Gallerio, poeta della natura e della
bontà cristiana, imitato da Driulini in Cisilute di Ven-
doi, e rinnovata nei versi stesi in occasione della morte
dell ’ amico Ellero ” (Melchior 1999, 159). È il versante
più intimo e personale della scrittura di Siôr Barbe, un
versante colmo non soltanto di ispirazione evangelica,
ma anche di partecipazione umana e intima fraternità.
La tesi della Melchior (Melchior 1997-1998, 192-94)
recupera il testo dalle Floreanadis di Siôr Barbe del 1955
prima, ma in modo più fulmineo e mettendoli in rela-
zione con don Benedetti.
Versi di questo genere solitamente si trasmettevano
manoscritti entro una piccola e riservata cerchia di amici,
ma nel caso in questione la scorrevolezza dei cinquan-
tasette senari in rima baciata (con eccezioni nelle tre
riprese) deve averne favorito l ’ apprendimento mnemo-
nico; e infatti veniamo a sapere ancora da Chiurlo che le
copie della satira ebbero insolita diffusione a Colloredo:
i preti e i laici che in essa venivano biasimati e svergo-
gnati probabilmente ritennero opportuno rivolgersi
alle autorità diocesane perché punissero il responsabile
della loro umiliazione, cosicché l ’ autore delle rime ven-
ne ‘ condannato ’ a una settimana di esercizi spirituali. Se
si riflette sulla vicinanza tra Vendoglio e Colloredo di
Monte Albano e soprattutto sulla familiarità di Gallerio
con l ’ amico Pietro di Colloredo Mels, si può facilmente
comprendere come la critica potesse avere un oggettivo
fondamento di verità e forse rispondesse anche alla
giusta indignazione del sacerdote per gli scandali di
cui era venuto a conoscenza.
Tra le carte di Gallerio sono state ritrovate altre due (e
più innocue) poesie friulane di argomento profano: si
tratta di una Vilote e di un Sonet offerti Al dotor Faustin
DA GALLERIO A DRIULINI, SUL FILO DEI VERSI 669
che la Viarte ’ e cjape pît.
Quan ’ che a jugn sarìn rivâz
e i biei tènars cisilins 30
a ’ saran dispatussâz,
mèniju, mèniju chêi ninins,
sot chê linde, a chel balcon,
e in chel mût che amôr al sa,
fàur cognossi il to paron 35
che lu devin rispietâ.
Prin di dîti: “ Mandi, mandi,
cisilute dal cûr gno! ”
une grazie ti domandi
e no stâmi a dî di no: 40
cheste sere, su chel len,
va là, pòiti par cjantâ
e al paron che ti ûl tant ben
tù tu mi âs di ricuardâ.
Chi ha avuto modo di leggere o ascoltare la coppia di po-
esie di Gallerio sulla cisile si renderà conto senza indugi
di come i versi di Driulini si assestino su un ’ imitazione
consapevole ed esplicita del modello, non soltanto per
la scelta delle quartine di ottonari tronchi nelle sedi pari
e in rima alternata, ma anche nella ripresa di alcuni dei
motivi che hanno fatto sì che esse siano, tra le poesie
non religiose, le più fortunate e le meglio conosciute.
Oltre al riuso di formule ben identificabili come Benvi-
gnude, cisilute (cfr. il v. 3 del modello), benvignude ancje
chest an (cfr. i vv. 4, 16 e 52), Mandi, mandi (cfr. il v. 5),
ritorna l ’ immagine del volatile impegnato a costruire
il nido, a nutrire sot chê linde i suoi cisilins fino ad averli
dispatussâz, a posarsi e cantare sul pujûl e sul balcon per
(Driulini 1955, 106-7):
Cisilute di Vendoi
(a pre ’ Zuanbatiste Galerio, plevan di Vendoi)
Benvignude, cisilute,
che tu svolis par Vendoi,
jo ’ o uei dîti une cjossute,
sin tan ’ ben a quatri voi.
Cisilute inamorade, 5
benvignude ancje chest an,
sestu tù chê furtunade
che tu stâs là dal Plevan?
Cisilute tù tu cjantis…
Baste, baste, ’ o ài za capît, 10
nissun ’ altre in dutis quantis
no à cjatât un plui biel sît.
Ce tant cjare che tu j sês,
ce tant ben ch ’ al dîs di te,
ti à spietade mês e mês 15
dal setembar fin a uè.
Cisilute sta sigure,
sta contente, tenti in bon;
use dute la primure,
vê bon cûr cul to paron. 20
Tenlu simpri in aligrie,
pòiti e cjante sul pujûl,
fâsij buine compagnie,
chest al brame, chest al ûl.
Sù prepare, sù lavore 25
tôr la fabriche dal nît:
sù prepare ch ’ e je l ’ ore,
GABRIELE ZANELLO670
fluidità della vena poetica e la gentilezza dei sentimenti
denotano la piena e convinta continuità tra le prove dei
due autori, anche se una datazione precisa tornerebbe
utile per raggiungere conclusioni più puntuali. Afferma
Corrado Gatti che questa “ graziosa e delicata lirica ” era
stata scritta da Driulini “ in risposta a la Viarte o il salût a
la cisile del Gallerio medesimo, comparsa sul “ Cittadino
Italiano ” nella primavera del 1878 ”, e deduce che essa
“ ci è del tutto preziosa perchè è una fra le assai rare che
ci sono pervenute della musa giovanile di Siôr Barbe ”,
allora ventiquattrenne (Gatti 1949, 5; cfr. anche Gatti
1951, 19). La lacunosa consistenza delle raccolte del
periodico in questione non permette di verificare la
data precisa in cui è comparsa prima delle due poesie
di Gallerio (poi inclusa, nel 1885, nella prima silloge
ampia: Gallerio 1885, 249-51), ma in ogni caso anche
questo dato non offrirebbe certezze di datazione al di
là di un vago termine a quo. Gatti – purtroppo senza
esplicitare un fondamento documentario – si spin-
ge oltre, e scrive senza indugi che “ Il pio sacerdote di
Vendoglio, che aveva preso ad ammirare e ad amare il
chierico Driulini, fino da allora aveva preconizzato in
lui il futuro cantore della friulanità ” (Gatti 1951, 19).
In memoria
Ma Driulini non ama proporsi come vate e neppure
esibire patenti di ispirazione poetica; anzi, ha perfino
l ’ umiltà di manifestare pubblicamente, senza pose o
atteggiamenti di elitaria complicità, la propria ammi-
razione verso mons. Giuseppe Ellero (1866-1925), al
quale lo univa un ’ amicizia arricchita da reciproca stima.
Originario pure lui di Tricesimo, ma di una dozzina
d ’ anni più giovane di Driulini, Ellero muore a Udine il
31 gennaio 1925; il grande concorso di popolo trasforma
fare compagnia al padrone presso il quale è ritornato;
ed è presente anche qui, nelle ultime due quartine, la
nota elegiaca finale, che corrisponde, nelle poesie di
Gallerio, all ’ invito a condividere pene, amore e dolori
(La viarte) e alla raccomandazione di andare a cercare
nel cimitero una croce e una sepoltura presso le quali
pregare al momento del ritorno primaverile (La siarade).
Benché da un lato le zeppe e le ridondanze denuncino
una certa immaturità della prova, dall ’ altro la sponta-
neità del verso, l ’ immediatezza della lingua popolare, la
Copertina delle Floreanadis di Siôr Barbe, edizioni “La Panarie”, uscito in timp di
vendeme dal 1955 con postfazione di Chino Ermacora.
DA GALLERIO A DRIULINI, SUL FILO DEI VERSI 671
Il paesaggio di Siôr Barbe:
da Fraelacco verso Nanarià.
GABRIELE ZANELLO672
sorridente, Driulini accantona per un attimo l ’ ispira-
zione satirica per concentrarsi sull ’ illustre schema del
sonetto e ricreare un clima elegiaco, velato di innocenza,
beatitudine e rimpianto:
In memorie di mons. Ellero
’ O m ’ impensi di te, nobil figure
di predi, di poete e leterât;
ma plui m ’ impensi de la tô bontât,
de la tô gran bontât, anime pure.
Inzenoglât ai pîs de sepulture 5
che il to cuarp vergjnâl ’ e ten siarât,
a Dio Signôr, che vive al à stampât
in te l ’ imagjn de la sô nature,
’ o fâs ùmil preiere e vôz insieme
ch ’ al mandi chì in Friûl animis buinis, 10
che di lôr ’ o sintìn bisugne estreme:
animis che cul ben vìnzin il mâl,
animis santis che ancje tra lis spinis
’ ne lûs a ’ spandin clare e celestiâl.
Una figura complessa, quella di Giuseppe Ellero, che
Driulini ha saputo delineare con tratti essenziali ma
decisi, mettendone in luce prima di tutto la nobiltà in-
teriore; la terna di sostantivi (nella redazione originaria
avevamo: “ di predi, di furlan, di leterât ”, cfr. Melchior
1997-1998, 124) compendia con efficacia l ’ opera di
una personalità versatile: innanzitutto prete, ricordato
principalmente quale poeta, ma anche letterato meri-
tevole, scrittore di prosa e di teatro, ricercato oratore e
saggista, studioso e insegnante di grammatica, filologia
classica, storia ecclesiastica ed eloquenza in seminario.
il suo funerale in un imponente e corale tributo di affetto
e di ammirazione, quasi un risarcimento postumo per le
sofferenze ingiustamente patite nel momento più deli-
cato della repressione del modernismo, quando l ’ ansia
per la verità e per la libertà della ricerca scientifica gli era
costata il temporaneo allontanamento dalla docenza nel
Seminario di Udine (Marchetti 1979, 840-50; Comelli
1982, 319-22; Ellero 2008, 279-82).
Ai giorni delle solenni celebrazioni esequiali dell ’ amico
risale il sonetto che qui si riporta nella versione delle
Floreanadis (Driulini 1955, 105), più scorrevole dal
punto di vista metrico rispetto alla prima stesura; “ Il
Lavoratore Friulano ” l ’ aveva pubblicata il 7 febbraio
1925 a corredo di un articolo che, con parole di com-
mossa partecipazione, ricordava lo scomparso come
un uomo “ evangelicamente francescano ”, “ al di sopra
dei partiti e degli stessi uomini ”, che “ viveva in una sua
purezza compiuta, “ indiandosi ” quasi verso quel cielo a
cui credeva, e verso cui si protendeva la sua anima eletta
in uno sforzo costante di perfezionamento ”; il giornale
socialista continuava ricordando che “ Ellero non fu sol-
tanto un sacerdote buono ”, ma anche “ poeta, nel senso
più alto della parola, e poeta di questo nostro Friuli,
di cui conosceva la storia come un erudito, ed i luoghi
come un pellegrino, e di cui seppe cogliere gli aspetti
in versi pieni di musicale dolcezza, con il candore di un
fanciullo e con la forza di un adulto ”. Parole che, sulla
pagina del settimanale socialista, si pongono in piena
sintonia con i versi di Driulini, mentre questi ultimi
(naturalmente non firmati) entrano in dialogo con
quelli che su un altro settimanale, “ La Vita Cattolica ”,
firmava pre Zaneto; non deve passare inosservato il
fatto che, mentre Schiff si avvale delle solite quartine di
settenari e non rinuncia a osservare Ellero con sguardo
DA GALLERIO A DRIULINI, SUL FILO DEI VERSI 673
carme CI: Multas per gentes et multa per aequora vectus):
la pietra tombale, le preghiere e i voti, il corpo definito
“ verginale ” (e, nella prima stesura, anche le lacrime:
Cun lagrimis o fâs umil preiere, v. 9) costituiscono una
sorta di rinvio obbligato in un epicedio per un culto-
re della classicità. Ma l ’ orizzonte classico accoglie fin
dalla seconda quartina la consapevolezza cristiana, e
in particolare l ’ idea, ricca di echi biblici e patristici, di
un Dio che ha impresso nell ’ uomo l ’ immagine vivente
della propria natura divina. Così anche preghiere e voti
prescindono dalla sfera del dolore personale e perfino
dall ’ omaggio al defunto; ricevono invece un respiro ben
più ampio, allargandosi a un bisogno non generico: lo
sguardo disincantato di Driulini coglie nel Friuli di
inizio Ventennio, in una realtà che continuava a essere
sempre più drammaticamente segnata dal male storico,
la necessità estrema di “ anime buone ” come quella di
Ellero (e ancora una volta la ripetizione, anaforica nei
vv. 12 e 13, mette in evidenza un altro aggettivo: santis).
Varianti significative coinvolgono anche l ’ ultimo verso,
nel quale, rispetto al motivo della luce chiara e celestiale
di questa stesura, appariva più felice quella precedente,
più aperta a molteplici legami semantici: animis santis
che ance fra lis spinis / spandin intôr l ’ arome spirituâl
(cfr. Melchior 1997-1998, 124; e spàndin intôr l ’ arome
celestiâl in Ermacora 1949, 119).
Come ricordava anche la Melchior nel proprio stu-
dio, non mancano, nella produzione di Driulini, altri
versi dedicati a figure sacerdotali: un Ritràt è riservato
al parroco delle Grazie mons. Pietro Dell ’ Oste, altro
esponente del clero udinese legato da antica amicizia a
Siôr Barbe (cfr. Dell ’ Oste 1932, e l ’ edizione commentata
in Melchior 1997-1998, 223-38). Si tratta peraltro di
componimenti nei quali affiora in varia misura, oltre alla
Le testimonianze di chi lo ha conosciuto ne ricordano
quella bontà che il quarto verso (quasi una anadiplosi,
amplificata da gran) associa alla purezza d ’ animo, ma
ne mettono in risalto soprattutto il candore di fanciullo.
Così lo ricordava il collega mons. Ivan Trinko: “ È questa
la sua santa infantilità, congiunta alla limpida freschezza
della sua vena che ci ingannò tutti: tutti sentendoci
invecchiare guardavamo a lui come ad una giovinezza
perenne. […] Morì povero perché visse povero nello
spirito. Aveva studiato le beatitudini per praticarle ”
(citato in Ellero 2008, 280); e l ’ allievo mons. Guglielmo
Biasutti: “ Povero sant ’ uomo! Non conobbe furberia e
men che meno cattiveria. E se lo sfioravano malignità
e discordia, più che aborrirne, ne piangeva. Talora let-
teralmente ” (Biasutti 1981, 12). Eppure anche Ellero
dovette soffrire molto in quel decennio trascorso fra
la fine della Grande Guerra e la morte; l ’ introduzione
della sua antologia postuma, curata nel 1950 da Pietro
Bertolla, Pietro Londero e Giovanni Zanier, ne colloca
la figura in quel difficile contesto adombrato anche da
Driulini nei propri versi: “ in virtù di quella profonda
coscienza religiosa […] quell ’ anima restò fanciulla e
trasmigrò dietro il richiamo delle cose belle, all ’ infan-
zia libera di dissidi, alla sua terra amata e sventurata;
trasmigrò dietro il sogno di rifare buoni gli uomini
richiamandoli dall ’ orrore dell ’ odio alla serenità d ’ una
nuova primavera ” (Ellero 1950, 16).
Anche Driulini, pur insistendo sul motivo della bontà,
si mantiene a distanza sia dalle visioni unilaterali che
dalle semplificazioni stilistiche o di maniera; anzi, va alla
ricerca di una tessitura composita e – in certa misura –
perfino dotta. Dopo la quartina di apertura, infatti, il
sonetto sembra voler cogliere suggestioni foscoliane (In
morte del fratello Giovanni) e dunque anche catulliane (il
GABRIELE ZANELLO674
Gallerio 1885 = Giovanni Battista Gallerio, Poesie dedicate a S. Ecc. Ill. e
Rev. Mons. G. Maria Berengo Arcivescovo di Udine, Patronato, Udine.
Gallerio 1891a = Giovanni Battista Gallerio, Il linguaggio dei bambini
in Friuli. Lettera al dott. Vincenzo Joppi (inedita), “ Pagine friulane ”, 4
(1891-1892), 4, pagg. 63-64.
Gallerio 1891b = Giovanni Battista Gallerio, Un brindisi del sacerdote Gallerio
(inedito). Capo d ’ anno, “ Pagine friulane ”, 4 (1891-1892), 6, pag. 84.
Gallerio 1900 = Giovanni Battista Gallerio, Poesie friulane, raccolte e trascritte
da G. Costantini, Patronato, Udine.
Gallerio 1955 = Giovanni Battista Gallerio, Poesiis, scelte e presentate da
Leone Comini, Edizioni Nord Est, Udine.
Gatti 1949 = Corrado Gatti, Giuseppe Driulini maestro, “ Risveglio magistrale ”,
1 (1949), 2, pag. 5.
Gatti 1951 = Corrado Gatti, Giuseppe Driulini, poeta satirico e maestro, “ Sot
la Nape ”, 3 (1951), 1, pagg. 16-23.
Giuseppe Driulini 1949 = Giuseppe Driulini figlio e poeta del popolo, “ La
Panarie ”, 17 (1949), 6, pagg. 116-20.
Marchetti 1979 = Giuseppe Marchetti, Il Friuli, uomini e tempi, Del Bianco,
Udine.
Melchior 1997-1998 = Roberta Melchior, Giuseppe Driulini tra piega satirica
e autobiografia, tesi di laurea in lingua e letteratura friulana, Università
degli Studi di Trieste, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. Rienzo Pellegrini.
Melchior 1999 = Roberta Melchior, Giuseppe Driulini, “ Metodi & Ricerche ”,
n.s., 18 (1999), 1, pagg. 139-69.
Pancini 1881 = Domenico Pancini, Parole sulla vita di Don Giovanni Battista
Gallerio parroco di Vendoglio lette in quella chiesa parrocchiale nel trigesimo
della sua morte, Patronato, Udine.
Pascolo 1963 = Etelredo Pascolo, Ricuart di Driulin, “ Int Furlane ”, 1 (1963),
pag. 3.
Toller 1962 = Mario Toller, Don Pietro Benedetti nella sua vita e nelle sue
opere, Arti grafiche friulane, Udine.
Vigevani-Mirmina 1953 = Alessandro Vigevani, Emilia Mirmina, Giuseppe
Driulini: il suo “ clima ” e il suo Friuli, “ Ce fastu? ”, 29 (1953), pagg. 72-79.
Zanello 2005 = Gabriele Zanello, Giovanni Battista Gallerio (1812-1881).
Gli autografi delle poesie e delle prediche friulane, Glesie furlane, Villanova
di San Daniele.
Zorutti 1990 = Pietro Zorutti, Le poesie friulane di Pietro Zorutti, ristampa
completa dell ’ edizione Bosetti curata da Bindo Chiurlo integrata dal
corpus iconografico dell ’ edizione Delle Vedove e con una premessa di
Rienzo Pellegrini, Del Bianco, Udine.
confidenza e all ’ ammirazione per il compagno di studi
in seminario, anche quella lepida (altrove graffiante)
leggerezza di Driulini che ci è già familiare.
BIBLIOGRAFIA
ACAU = Archivio della Curia arcivescovile di Udine.
APV = Archivio parrocchiale di Vendoglio.
Biasutti 1958 = Guglielmo Biasutti, Sacerdoti distinti dell ’ arcidiocesi di Udine
defunti dal 1863 al 1884 (episcopato di mons. Casasola), Arti grafiche
friulane, Udine, pagg. 42-44.
Biasutti 1981 = Guglielmo Biasutti, Salustris, Arti grafiche friulane, Udine.
Brusini 1988 = Alan Brusini, Pre Tite Galeri, treseman, “ Sot la Nape ”, 40
(1988), 1, pagg. 65-69.
Chiurlo 1907 = Bindo Chiurlo, G. B. Galerio e una sua poesia inedita, “ Le
nuove pagine ”, 1 (1907), 2, pagg. 22-25.
Chiurlo 1940 = Bindo Chiurlo, La poesia di Giovanni Battista Gallerio, “ Ce
fastu? ”, 16 (1940), 1, pagg. 3-29.
Comelli 1982 = Giovanni Comelli, Tricesimani illustri, in Andreina Ciceri
e Tito Miotti (a cura di), Tresésin, Società filologica friulana, Udine,
pagg. 306-38.
Costantini 1900-1901 = Giuseppe C. Costantini (a cura di), Un sonetto
inedito di Giovanni Battista Gallerio [La carta di don Tita (Soliloquio)],
“ Pagine friulane ”, 13 (1900-1901), 9, pag. 145.
Dell ’ Oste 1932 = Pietro Dell ’ Oste, Preziosi e cari ricordi spirituali della mia
S. Messa d ’ oro, Ciani, Udine.
Driulini 1955 = Giuseppe Driulini, Floreanadis di siôr Barbe, La Panarie,
Udine.
Ellero 1950 = Giuseppe Ellero, Pagine scelte, La Panarie, Udine.
Ellero 2008 = Elpidio Ellero, Il Seminario di Udine. 1900-1928, Seminario
arcivescovile, Udine.
Ermacora 1944 = Chino Ermacora, La messa di «sior barbe», “ Ce fastu? ”,
20 (1944), 3-4, pagg. 208-12.
Ermacora 1949 = Chino Ermacora, Verso i cent ’ anni un poeta morale, “ La
Panarie ”, 17 (1949), 1, pagg. 42-43.
Gallerio 1865 = Giovanni Battista Gallerio, Svearìn ne l ’ occasion del S.
Giubileo 1865 del Plevan di Vendoi, Zavagna, Udine.
Gallerio 1881 = Giovanni Battista Gallerio, Poesie friulane. Per il solenne
ingresso del Molto Reverendo D. Antonio Bazzara da Gemona alla par-
rocchia di S. Michele Arcangelo di Vendoglio, Patronato, Udine.