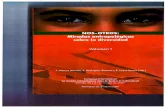“Las canteras de granito de Augusta Emerita: localización y sistemas de explotación”
Conclusioni, in Arqueología de la construcción, 4. Las canteras en el mundo antiguo: sistemas de...
Transcript of Conclusioni, in Arqueología de la construcción, 4. Las canteras en el mundo antiguo: sistemas de...
Jacopo BonettoStefano camporeale
antonio pizzo(eds.)
ARQUEOLOGíA DE LA CONSTRUCCIÓNIV
laS canteraS en el mundo antiguo:SiStemaS de explotación y proceSoS productivoS
Actas del congreso de Padova, 22-24 de noviembre de 2012
Consejo superior de investigaCiones CientífiCasinstituto de arqueología de Mérida
università degli studi di padovadipartimento dei Beni Culturali:
archeologia, storia dell’arte, del Cinema e della Musica
ÉCole norMale supÉrieuredépartement des sciences de l’antiquité
MÉrida, 2014
Catálogo general de publicaciones oficiales:http://publicacionesoficiales.boe.es
Editorial csic: http://editorial.csic.es (correo: [email protected])
Reservados todos los derechos por la legislación en materia de Propiedad inte-lectual. Ni la totalidad ni parte de este libro, incluido el diseño de la cubierta, puede reproducirse, almacenarse o transmitirse en manera alguna por medio ya sea electrónico, químico, óptico, informático, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito de la editorial.
Las noticias, los asertos y las opiniones contenidos en esta obra son de la exclu-siva responsabilidad del autor o autores. La editorial, por su parte, solo se hace responsable del interés científico de sus publicaciones.
imagen de cubierta: M. Korres, From Pentelicon to the Parthenon: the ancient quarries and the story of a half-worked column capital of the first marble Parthenon, London, 1995.imagen de contracubierta: detalle de la anterior.
© csic© Jacopo Bonetto, stefano camporeale, Antonio Pizzo (eds.) y de cada texto, su autorNiPO: 723-14-096-8e-NiPO: 723-14-097-3isBN: 978-84-00-09832-2e-isBN: 978-84-00-09833-9Depósito Legal: M-19082-2014
Maquetación: Matteo Annibalettoimpresión y encuadernación: imprenta Taravilla, s.L.impreso en España. Printed in Spain
En esta edición se ha utilizado papel ecológico sometido a un proceso de blanqueado TcF, cuya fibra procede de bosques gestionados de forma sostenible.
Esta publicación se ha beneficiado de la investigación asociada al proyecto “Análisis de soluciones técnico-constructivas, modelos arquitectónicos y urbanísticos de la arquitectura romana de la Lusitania: orígenes y trasformación de una cultura arquitectónica”, HAR2012-36963-C05-05, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. VI Plan de Investigación Científica (investigador principal: Antonio Pizzo).
Cave nel mondo antico.indd 6 08/07/14 09:43
I ventiquattro contributi raccolti in questo vo-lume, con differenti finalità e metodologie e in re-
lazione a diversi territori, illustrano in vario modo le potenzialità della ricerca archeologica sulle cave
CONCLUSIONI
STEFANO CAMPOREALE
UMR 8546, École normale supérieure, Paris
RIASSUNTO: Questo lavoro compendia i risultati del convegno in relazione ai metodi, ai temi e alle prospettive dell’archeologia delle cave di pietra. Quanto ai metodi si discute sugli apporti degli scavi stratigrafici, sulle analisi archeometriche dei materiali lapidei e sulle prospezioni di superficie per il censimento delle cave. Dopo aver accennato ai problemi inerenti alla cronologia di sfruttamento del-le cave, vengono individuati i diversi aspetti delle cave antiche che possono essere oggetto dell’inda-gine archeologica, riassumibili in nove temi di ricerca: geologia e caratteristiche degli affioramenti; tipologia delle cave e tecniche estrattive; produttività e tipologia dei manufatti; organizzazione inter-na della cava; accessibilità, infrastrutture e rete insediativa del territorio; diffusione e commercio dei manufatti; proprietà, amministrazione e gestione; committenti, intermediari e funzionari, forza lavoro; trasformazioni e riutilizzi delle cave. Quanto alle prospettive della ricerca si sottolinea l’importanza degli studi regionali allo scopo di indagare, in riferimento a specifici contesti territoriali, quale fos-se il ruolo delle attività di cavatura rispetto alle economie locali. In questo modo il panorama offerto dalla produzione e dal commercio delle comuni pietre da costruzione può integrare i più tradizionali studi sui marmi e le ricostruzioni dei fenomeni macroeconomici connessi. Infine si rileva come l’ar-cheologia della costruzione, considerando la relazione fra le cave e i processi costruttivi, possa contri-buire a ricostruire più compiutamente l’ambito storico, sociale ed economico delle attività estrattive.
SUMMARY: This article summarises the results of the conference with reference to the methodology, main themes and future of the archaeology of stone quarries. Discussion of methodology covers con-tributions on archaeological excavations, archaeometry of the stone material, and field survey to record the presence of quarries. The inherent problems of the chronology of exploitation are then touched on, followed by classification of the different aspects of ancient quarries which can be the subject of archae-ological investigation. These aspects are set out under nine research headings, as follows: geology and characteristics of the rock formations; typology of the quarries and quarrying techniques; productivity, and typology of the products; internal organisation of the quarries; accessibility, infrastructure and set-tlement patterns of the surrounding territory; trade and distribution of the quarry products; ownership, administration and management; patrons, middlemen and officials, labour force; development and re-use of the quarries. With regard to future research the importance is stressed of regional studies with the scope to investigate, for specific territories, the role of quarrying in the local economy. In doing so, the picture of production and trade in common types of building stone can be integrated with more traditional studies of marble and its associated macroeconomics. Finally, this article considers how the archaeology of construction, taking account of the relationship between quarries and construction pro-cesses, can better reconstruct the history, society and economy of stone quarrying.
PAROLE CHIAVE: scavo, archeometria, prospezioni di superficie, cave, processi costruttivi, studi regionali, economia antica.KEYWORDS: excavation, archaeometry, field survey, quarries, construction process, regional studies, ancient economy.
430 STEFANO CAMPOREALE Anejos de AEspA LXIX
antiche. Rispetto a un passato non troppo lontano appare in maniera oramai evidente l’onnipresen-za dei resti di attività estrattive, a dimostrazione che queste erano parte integrante della vita degli insediamenti, sia urbani sia secondari, che spesso sfruttavano un’ampia varietà di litotipi, soprattutto se disponibili nelle vicinanze. L’estrazione riguar-dava principalmente la pietra per la costruzione e la decorazione degli edifici e dipendeva quindi dalle esigenze dei cantieri, ma poteva anche essere fina-lizzata a ottenere manufatti come le epigrafi, le ma-cine, le pavimentazioni stradali, i sarcofagi, le scul-ture oltre a un’ampia gamma di altri oggetti (bacini, mortai, ecc.). Il ventaglio dei possibili prodotti non fa che confermare la specializzazione dell’artigia-nato e il livello della tecnologia coinvolti, nonché la complessità dei sistemi di approvvigionamento e commercio delle pietre, che si possono oggi più compiutamente osservare sia a livello globale sia in riferimento a singole realtà locali.
Esaminando le metodologie impiegate nelle di-verse ricerche e i temi affrontati, si può compren-dere come gli atti del convegno di Padova si inseri-scano nel panorama odierno degli studi sulle cave, che proprio negli ultimi anni hanno dimostrato una rinnovata vitalità1, e contribuiscano ad arricchire la nostra conoscenza dei processi produttivi legati all’edilizia e ai cantieri dell’antichità.
METODI
Nonostante la diversa impostazione delle ricer-che presentate, che ne rende difficoltosa una sin-tesi esaustiva, si possono enucleare gli apporti più significativi rispetto alle principali metodologie impiegate nello studio delle cave: lo scavo strati-grafico, le indagini archeometriche e le prospezioni di superficie.
Scavi stratigrafici
Gli scavi hanno il merito di chiarire i processi formativi della stratigrafia all’interno delle cave2, che presenta peculiarità dovute principalmente alle modalità di gestione degli scarti di lavorazione e
1 Si vedano in particolare le edizioni del progetto QuarryScapes da parte del Geological Service of Norway (Abu-Jaber et al. 2009), della monografia di A.M Hirt (2010) sulle cave e le miniere di proprietà imperiale e, da ultimo, del volume di B. Russell (2013) sul commercio della pietra in epoca romana.
2 Bessac 1986.
all’organizzazione interna del sito estrattivo. Si possono infatti trovare aree riservate a determinate attività, come l’estrazione, la prima lavorazione dei materiali e la riparazione degli strumenti da lavoro, oltre ai passaggi per lo spostamento dei materiali, le aree di deposito e di organizzazione dei trasporti al di fuori della cava. Le tracce leggibili sulle pa-reti e sui piani coltivati della roccia sono relative all’uso di strumenti quali il piccone, i cunei, le leve e la sega, e i procedimenti tecnici dell’estrazione sono oramai ben conosciuti con un terminologia abbastanza normalizzata, soprattutto in francese3. Anche le modalità più generali dell’estrazione e la tipologia delle cave (a cielo aperto, in galleria, ecc.) sono note4. Rispetto a questo panorama, i contributi del convegno non hanno apportato no-vità sostanziali, anche se alcuni esempi di analisi più dettagliata delle tracce di estrazione rivestono una particolare importanza rispetto al contesto in cui sono state osservate. In questo senso, le tracce di un piccone terminante con tagliente diritto usato per incidere il banco di tufo del Palatino (Rossi) rappresentano ad oggi la più antica testimonianza della coltivazione di blocchi squadrati in quest’a-rea (inizi vi secolo a.C.). Nei comprensori ter-ritoriali dove sono state effettuate indagini su un ampio numero di cave, com’è l’esempio del con-ventus Tarraconensis (Gutiérrez García-Moreno), si è notato che la tipologia degli strumenti utilizza-ti – in questo caso picconi a punta o con tagliente diritto – può variare all’interno della stessa cava a seconda delle squadre al lavoro o della cronolo-gia dello sfruttamento. In questi casi si documenta perciò l’adattabilità delle tecniche estrattive e del relativo strumentario, a seconda anche delle carat-teristiche geolitologiche dell’affioramento, nonché della richiesta da parte della committenza di speci-fici prodotti e qualità della pietra (vedi anche Soler et al.). Man mano che le ricerche proseguono, la cronologia di utilizzo degli strumenti sembra dun-que valida soprattutto a livello locale5.
3 Bessac 2002b; 2004, 19-25; Abdul Massih – Bessac 2009.4 Bessac 2004, 31-9.5 Nelle cave di calcare di Bois de Lens presso Nîmes il
piccone a tagliente diritto è utilizzato in epoca ellenistica – prima del piccone con tagliente a doppia punta (escoude) e di quello a punta – e nel basso impero (Bessac 2002a, 35, fig. 21). Anche nelle cave di calcarenite di Populonia, sfruttate nel iii a.C., queste tracce precedono l’uso del piccone a punta, ma la cronologia di utilizzo dei due strumenti non è definibile con maggiore precisione (Camporeale – Mascione 2010, 165-6). La misura del tagliente attestato sul Palatino (2-2,5 cm), è simile a quello di Populonia (2 cm) e maggiore rispetto allo strumento più antico usato a Bois de Lens (tagliente di 1,2-1,5 cm: Bessac 1996, 208, tab. 8).
Anejos de AEspA LXIX 431CONCLUSIONI
Altre tracce frequentemente riscontrate all’in-terno delle cave sono relative al funzionamento dei macchinari per il sollevamento dei blocchi e il loro caricamento sui carri: si documentano ad esempio
alloggiamenti di forma circolare e canalette nelle cave di Siracusa (Mastelloni et al.) e del suburbio di Roma (Buccellato – Coletti). La specializzazione ne-cessaria alla costruzione delle machinae è maggiore
Fig. 1. Tabella sintetica degli argomenti dei contributi.
AUTORE SITO/TERRITORIO LITOTIPI PRODOTTI CRONOLOGIA ANALISI
ARCHEOM.Bessac Vari Rocce sedimentarie Pietra da taglio Età romanaPensabene Vari Marmo Pietra da taglio Età imperialeVolpe Roma Tufo Pietra da taglio Primo quarto del iv sec. a.C.
Lazzarini Thera Marmo Pietra da taglio Età greco-romana – età bizantina X
Rossi Roma Tufo Pietra da taglio Inizi vi sec. a.C.Serlorenzi Roma Pozzolana Aggregato per malta Età tardo-repubblicana
Buccellato – Coletti Suburbio di Roma PozzolanaTufo
Pietra da taglioAggregato per malta
iv sec. a.C. – età medio-imperiale
Pensabene – Domingo Vari Marmo Pietra da taglio Età imperialePensabene – Gasparini Cottanello Breccia Pietra da taglio ii sec. a.C. – i sec. d.C.
Previato et al. Aquileia e regioni alto-adriatiche
Trachiteeuganea
Pavimentazioni stradaliPietra da taglioMacine
Età repubblicana e impe-riale X
Cagnana Luni Marmo Pietra da taglioIscrizioni Età imperiale e tardoantica
Bugini – Folli Lombardia
ArenariaCalcareDioriteDolomiaGneissGranitoMarmo
Pietra da taglioEpigrafiStatuaria
Età romana X
Bonetto et al. Nora Arenaria Pietra da taglio vi sec. a.C. – v sec. d.C.?
Del Vais et al. Sinis di CabrasTharros Arenaria Pietra da taglio Età fenicio-punica – età
romana X
Mastelloni et al. Siracusa Calcarenite Pietra da taglio Età greca – età medievale X
Giglio SelinunteMarsala Calcarenite Pietra da taglio iv secolo a.C. – età
moderna
Auriemma et al. Italia meridionale
ArenariaAreniteBeachrockConglomerato
Macine Età antica – età moderna X
Soler Huertas et al. Carthago Nova
ArenariaAndesiteBasaltoCalcareMarmoTravertino
Pietra da taglioPavimentazioni stradaliEpigrafiMacine
iii sec. a.C. – iv/v sec. d.C.
Gutiérrez García-Moreno
ConventusTarraconensis
ArenariaBroccatello CalcareLumachella
Pietra da taglio Età imperiale
Pizzo – Cordero Mérida Granito Pietra da taglio Età imperialeGaillard Saintonge Calcare Pietra da taglio Età imperiale X
De Simone – Tomasello Leptis Magna CalcareCalcarenite Pietra da taglio Età imperiale
Vitti Eubea Marmo cipollino Pietra da taglio Età imperiale
Arce Vicino Oriente
ArenariaBasaltoCalcareGranitoMarmo
Pietra da taglio Età imperiale – alto Medioevo
Marano ProconnesoThasos Marmo Pietra da taglio
Mortai Età tardoantica
432 STEFANO CAMPOREALE Anejos de AEspA LXIX
quanto più aumenta la dimensione dei blocchi da tra-sportare (Pensabene – Domingo). Inoltre, in tutti quei casi in cui l’indagine archeologica è stata condotta in maniera più dettagliata – v. soprattutto i contributi già citati –, sono state notate ulteriori testimonianze, come gli allestimenti utili alle riparazioni degli uten-sili metallici, riconoscibili per le tracce di forge e la presenza di bacini per l’acqua (v. anche Vitti).
Analisi archeometriche
L’analisi delle rocce è stata condotta secondo due metodi differenti. Il primo ne ha preso in consi-derazione le caratteristiche tecniche con particolare riguardo alle rocce sedimentarie (Bessac), suddivi-dendole in tenere, semi-dure e dure, secondo una classificazione che considera questo fattore come inscindibile dal tipo di cavatura adottata così come dalla tecnica edilizia risultante e dall’estetica del monumento6. Il secondo metodo ne considera la composizione, analizzata microscopicamente, allo scopo precipuo di caratterizzare i diversi litotipi, individuarne i bacini di estrazione fino a legare la costruzione di singoli edifici allo sfruttamento di precise cave, o addirittura di singoli lotti di esse, e di ricostruire così modelli di circolazione, diffusio-ne e commercio delle pietre (Lazzarini)7.
Nella tabella alla figura 1, in cui vengono sinte-tizzati i diversi litotipi citati nei contributi, la cro-nologia delle cave, i relativi luoghi di estrazione e i prodotti, sono evidenziati i casi in cui sono state effettuate le analisi archeometriche. È notevole la preponderanza delle rocce sedimentarie, le più dif-fuse e accessibili e dunque anche quelle maggior-mente utilizzate nell’edilizia antica.
Prospezioni di superficie
Un cospicuo numero di contributi presenta i ri-sultati di nuove prospezioni di superficie. Le inda-gini riguardano cave comprese in ambiti territoriali di diversa ampiezza8:
6 Per un maggiore dettaglio sulla caratterizzazione tecnica e archeologica delle pietre da taglio proposta dallo stesso autore, v. Bessac 2004, 11-6 e in particolare la tabella a fig. 7.
7 Nell’intervento non pubblicato di O. Rodríguez Gutiérrez e J. Beltrán Fortes si proponeva un aggiornamento delle indagini sulle cave della Baetica, per le quali v. già Rodríguez Gutiérrez – Beltrán Fortes 2010.
8 Nella raccolta di studi sulle cave antiche della Francia in Bessac – Sablayrolles 2002a, se da un lato i risultati degli scavi archeologici sono di maggiore importanza, nelle conclusioni
a) gli insediamenti urbani e le loro immediate vicinanze: Roma, Nora, Tharros, Siracusa, Marsala;
b) più ampi comprensori di rifornimento degli in-sediamenti urbani: Roma, Mérida, Carthago Nova, Aquileia;
c) comprensori politico-amministrativi: conven-tus Tarraconensis;
d) comprensori regionali e bacini geologici: Lombardia, Italia meridionale, Saintonge, Vi-cino Oriente.
L’utilizzo delle prospezioni di superficie per-mette di considerare le cave insieme con il loro contesto, rappresentato dalla loro relazione con gli edifici in cui il materiale fu impiegato, ma inteso anche in senso più ampio come ambito geografico, geologico, economico e socio-culturale che può es-sere esaminato tramite l’indagine delle vie di colle-gamento e dell’accessibilità, della rete insediativa del territorio, della varietà tipologica dei prodotti e della loro diffusione.
I risultati ottenuti nel suburbio di Roma (Buc-cellato – Coletti) permettono di integrare il quadro tradizionalmente noto degli approvvigionamenti di materiali lapidei per l’Urbe9, restituendo un panora-ma variegato delle attività edilizie e di cavatura che si svolgevano negli immediati dintorni della città. Nel territorio in esame le cave si intrecciano, in ma-niera diacronica e sincronica, con una serie di altre realtà, quali le coltivazioni dei terreni, le aree di necropoli, la viabilità secondaria. Questi risultati si sommano agli scavi di nuove cave di pozzolana “in Urbe”, ovvero all’interno del perimetro delle Mura Aureliane (Serlorenzi), e al nuovo esame del cantie-re repubblicano delle mura Serviane per le quali ci si servì del tufo giallo della Via Tiberina, prelevato quindi a notevole distanza, lungo il Tevere (Volpe).
Anche le ricerche facenti capo alle Soprintenden-ze siciliane di Siracusa (Mastelloni et al.) e Trapani (Giglio) hanno permesso di riassumere le evidenze riferibili alle cave attive per un lungo periodo di tempo (dall’età greca a quella medievale) e anche in relazione alla costruzione di specifici monumenti. Esempi di ricerche che ricostruiscono le diverse fonti di approvvigionamento di uno stesso insediamento sono quelli di Aquileia (Previato et al.), Tharros (Del Vais et al.), di Nora (Bonetto et al.), Carthago Nova (Soler et al.), Tarragona (Gutiérrez García-Moreno).
i curatori segnalano invece la carenza delle prospezioni di superficie (Bessac – Sablayrolles 2002b).
9 Ad esempio DeLaine 1995; Lancaster 2005, 12-8.
Anejos de AEspA LXIX 433CONCLUSIONI
Questo tipo di indagini si dimostrano tanto più complete ed efficaci nella ricostruzione storica quanto più fanno uso di strumenti propri dell’ar-cheologia dei paesaggi (v. ad es. Pizzo – Corde-ro sull’analisi del territorio e delle cave intorno a Mérida) e quanto maggiori sono l’ampiezza dell’arco cronologico e del territorio considerati (v. Arce sulla Giordania, il Libano e la Siria fino all’alto Medioevo).
La cronologia delle cave
La cronologia del periodo di utilizzo delle cave è problematica, come sottolineato in molti con-tributi, e di difficile definizione, quando ci si può basare unicamente sulle tracce di estrazione, vista la continuità delle tecniche tradizionali fino all’età moderna e contemporanea (v. Del Vais et al.).
Oltre alle attribuzioni cronologiche fondate sui reperti rinvenuti negli scavi, dai contributi del con-vegno emergono nuovi metodi di datazione. Nel caso di alcune cave costiere di pietre da macina dell’Italia meridionale (Auriemma et al.) come in-dicatore cronologico è stata utilizzata la variazio-ne del livello marino. Il metodo è da considerarsi valido solo per quei casi per in cui le formazioni rocciose non hanno subito movimenti tettonici suc-cessivamente alla cavatura antica e viene da chie-dersi non si potrebbe utilizzare anche per le cave costiere di blocchi da costruzione molto diffuse in tutto il Mediterraneo.
Un diverso metodo viene adottato per datare le cave nella regione francese della Saintonge (Gail-lard). Partendo dalla cronologia dei monumenti e poi considerando i materiali utilizzati per la loro co-struzione, sulla base dell’analisi microscopica delle particelle terrigene intrappolate nel calcare al mo-mento della sua formazione è possibile distinguere – e così datare – le singole cave di provenienza dei materiali, anche in un ristretto ambito territoriale.
TEMI
Temi comuni a ogni indagine sulle cave antiche sono dunque:
a) la geologia e le caratteristiche degli affioramenti;b) la tipologia delle cave e le tecniche estrattive;c) la produttività e la tipologia dei manufatti;d) l’organizzazione interna della cava;
e) l’accessibilità, le infrastrutture e la rete inse-diativa del territorio;
f) la diffusione e il commercio dei manufatti;g) la proprietà, l’amministrazione e la gestione
delle cave;h) i committenti, gli intermediari e funzionari, la
forza lavoro;i) le trasformazioni e i riutilizzi delle cave.
Il sito estrattivo in senso stretto è preso in conside-razione dai temi di ricerca ai punti a-d. I temi ai punti e-f considerano la rete di collegamenti fra la cava e i luoghi di destinazione dei prodotti, mentre i temi ai punti g-h l’ambito politico, sociale ed economico delle attività di cavatura. L’ultimo tema (punto i) inte-ressa la storia delle cave successiva alla loro dismis-sione e del loro possibile riutilizzo con altre funzioni.
Nei paragrafi seguenti prenderemo in conside-razione l’apporto dei diversi contributi relativa-mente agli ultimi dei temi di ricerca sopra indivi-duati (punti g, h, i).
Aspetti giuridici, organizzativi e gestionali: il ruolo degli autori coinvolti
Per la ricostruzione del generale panorama del-la proprietà, dell’amministrazione e della gestio-ne delle cave tra la tarda età repubblicana e l’età imperiale (v. Marano per le cave di marmo tardo antiche) vengono utilizzate le fonti epigrafiche, e soprattutto le cosiddette notae lapicidinarum che si ritrovano incise sui blocchi di marmo ritrovati abbandonati in cava, nei luoghi intermedi di stoc-caggio oppure in opera.
Grazie anche a queste testimonianze il commer-cio dei marmi, in particolar modo di quelli cosid-detti “imperiali” – utilizzati cioè nell’architettura e nella scultura dei monumenti pubblici e imperiali di Roma –, ha occupato maggiormente l’attenzio-ne degli studiosi, soprattutto in seguito all’opera di J.B. Ward-Perkins10.
Più di recente il quadro ricostruttivo offerto dal-lo studio sui marmi viene completato consideran-do anche la produzione e il commercio delle altre pietre da costruzione. Lo scopo è di giungere a una ricostruzione dei commerci di manufatti lapidei che integri i fenomeni di larga scala – il commercio dei marmi – con le dinamiche che caratterizzano le economie locali, e dunque con maggiore atten-
10 Dodge – Ward-Perkins 1992.
434 STEFANO CAMPOREALE Anejos de AEspA LXIX
zione verso le diversità regionali11. Proprio questo approfondimento si può considerare fra i risultati più rilevanti del convegno.
Più nello specifico, sono state nuovamente ri-considerate le notae lapicidinarum sui marmi im-periali (Pensabene)12 per valutare, tramite il ruolo dei diversi funzionari implicati e il sistema degli appalti (procuratores, curatores e redemptores), il grado di coinvolgimento dell’amministrazione im-periale negli approvvigionamenti destinati all’Ur-be. Un più rigido controllo sembra fosse esercita-to sui marmi colorati e in particolare su blocchi e fusti di migliore qualità, su cui si trovano le sigle più complesse. Indipendentemente dalla proprietà pubblica o imperiale delle cave, una parte dei mar-mi era destinata al mercato, com’è testimoniato dal diffuso utilizzo delle lastre di rivestimento marmo-ree negli edifici residenziali privati.
Nell’approvvigionamento dei marmi pregiati per le città provinciali un ruolo fondamentale era svolto da personaggi che ricoprivano specifiche cariche, come i procuratores marmorum13. La loro posizione, oltre a eventuali legami personali con l’imperatore e la sua famiglia, permetteva a costo-ro di disporre di una certa quantità di marmi che talora donavano per l’edilizia pubblica delle loro città e regioni di origine.
In un’ottica simile (Pensabene – Domingo) vengono analizzati i blocchi di dimensioni colossa-li. Per il loro approvvigionamento e la loro lavora-zione erano necessarie una manodopera qualificata e una complessa organizzazione, possibili sola-mente grazie alla partecipazione diretta dell’ammi-nistrazione imperiale. L’utilizzo di blocchi gigante-schi nell’architettura provinciale di imitazione dei modelli urbani, soprattutto negli edifici per il culto imperiale, per lo più dipendeva dunque da un atto di munificenza dell’imperatore nei confronti delle comunità locali, che probabilmente riguardava la fornitura della manodopera per l’estrazione, la la-vorazione e il trasporto del materiale.
Questa ricerca può essere utile anche per com-prendere, quali siano i vettori e le modalità della trasmissione non solo dei materiali, ma anche di mode e stili, di tradizioni lavorative, di maestran-ze e tecniche edilizie. Un altro esempio del rilievo
11 V. in particolare Russel 2013.12 Già Fant (1993) aveva distinto le sigle per uso esterno alla
cava (contrassegni di controllo apposti dai vari intermediari e funzionari lungo il tragitto verso la destinazione a Roma) o per uso interno (contrassegni di controllo sulla produzione che avvenivano prima del trasporto).
13 Hirt 2010, 113-9.
dell’intervento imperiale per la diffusione di ma-teriali e tecniche edilizie è quello dell’opera reti-colata14, il cui utilizzo può spiegarsi con un atto di evergetismo dell’imperatore.
Anche nel caso del laterizio vediamo all’opera reti di rapporti clientelari: i bolli attestati a Roma, Ostia e Portus indicano che in molti casi i proprietari dei fundi in cui si trovavano le cave e le infrastrutture produttive erano membri della famiglia imperiale e dell’aristocrazia urbana o ad esse più o meno stretta-mente collegati15. Questi legami sociali, unitamente alla presenza di una via di comunicazione come il Tevere, permettevano l’arrivo dei materiali da note-vole distanza nonostante i costi del trasporto16.
Un esempio di piccola cava di marmo “impe-riale”, ma probabilmente gestita da privati, è quel-la di cipollino ad Aghii in Eubea (Vitti), dove si estraevano colonne di dimensioni medio-piccole e lastre di rivestimento. Le tracce di utilizzo di una sega rinvenute su un blocco in questa cava indica-no che le lastre erano prodotte in situ e da qui im-messe direttamente sul mercato. Sempre in Eubea si conserva un’epigrafe datata intorno al 134 d.C. che nomina il centurione Tiberius Sergius Longus, amministratore del distretto di Karystos. La pre-senza di questo personaggio ci ricorda che un altro mezzo di controllo delle cave da parte dell’impe-ratore era l’esercito, come era anche il caso delle cave del Mons Claudianus e Porphyrites, e di Si-mitthus dove probabilmente lavoravano i condan-nati ad metalla17. D’altra parte i militari, distaccati tramite vexillationes quando la loro perizia tecnica era richiesta, sono un altro dei vettori di diffusione della tecnologia di più alto livello, soprattutto nelle opere di ingegneria sia civile sia militare18.
Per quanto riguarda le cave di Luna (Cagnana), oltre alle notae lapicidinarum si trovano iscrizioni votive e funerarie, che restituiscono molti particolari della vita dei cavatori. Si traggono così informazioni di una loro organizzazione gerarchica e articolata in squadre, testimoniata anche dalla cosiddetta “epi-
14 Esempi sono la ricostruzione augustea della collina di Byrsa a Cartagine o il Palazzo di Erode a Gerico (casi già citati in Medri 2001, 30-6).
15 DeLaine 2002, in particolare 49-52.16 Anche in questo caso, come in quello dei marmi, è
testimoniata la presenza di luoghi di immagazzinamento dei materiali: Bukowiecki 2012.
17 V. in generale Hirt 2010 con bibliografia precedente per le singole cave.
18 V. ad esempio Greene 1992. Per la conduzione da parte di personale militare di cave di pietra locale, probabilmente da usare per le opere difensive lungo il limes germanico, v. ad esempio Lukas 2002.
Anejos de AEspA LXIX 435CONCLUSIONI
grafe Salvioni” (CIL XI 1356) che riporta le liste dei nominativi di un collegium, forse funeraticium19, di schiavi marmorarii (22 d.C.). Oltre ai cavatori troviamo anche scalpellini che dovevano occuparsi della prima lavorazione dei materiali in cava. Dalla documentazione lunense emerge lo status sociale dei cavatori, per la maggior parte schiavi o liberti, e la loro origine e appartenenza etnica: si trovano nomi grecanici, italici, celtici, germanici, armeni.
Meno frequenti sono le iscrizioni sulle pietre da costruzione locali. Nel caso di Leptis Magna (To-masello – De Simone) i contrassegni di cava visibi-li sui blocchi in opera rivelano la presenza di squa-dre di maestranze specializzate nella lavorazione della calcarenite o del calcare locali, impiegati per diverse tipologie edilizie, dimostrando la stretta re-lazione e la contestualità fra il progetto edilizio e l’approvvigionamento della pietra.
Nel caso del conventus Tarraconensis (Gutiér-rez García-Moreno) le notae sono poste sui fronti di taglio e, come in molti casi già noti, sono rela-tive all’organizzazione interna della cava e al con-trollo sulla produzione.
Per le cave di pietra locale bisogna ipotizzare una filiera produttiva che differisce da quella dei marmi. Spesso queste cave si trovano all’interno di fundi privati o di proprietà delle comunità urbane (v. Pensabene – Gasparini per le cave di Cottanel-lo). L’estrazione iniziava solo in seguito all’ordine di un certo numero di pezzi da parte di singole im-prese edilizie e la fornitura avveniva parallelamen-te all’avanzamento della costruzione proprio per evitare l’inutile accumulo di materiali che rischia-vano di soffocare il cantiere, soprattutto in ambito urbano. Solo raramente, per alcuni grandi cantieri di edilizia pubblica, si può cautamente ipotizzare la presenza di aree di immagazzinamento20.
Nel caso del marmo, invece, in ragione del suo particolare pregio, l’estrazione e il commercio del materiale potevano essere indipendenti dal suo im-mediato utilizzo nei cantieri e dunque si trovano inter-mediari commerciali e zone di immagazzinamento.
Trasformazioni e riutilizzi
Alcuni contributi hanno evidenziato i cambia-menti di utilizzo delle aree di cava. Se da un lato di-
19 Hirt 2010, 314-5.20 A questo proposito v. l’intervento di Soler et al. su
Carthago Nova e Mar – Pensabene 2010, 511-5 per il cantiere del Foro superiore di Tarraco.
stinguiamo le tracce dell’estrazione da quelle lasciate dalle diverse attività succedutesi nel tempo, dall’al-tro, considerando tutte le fasi di utilizzo delle cave, possiamo restituirne il pieno valore di documento storico. Troviamo così cave riutilizzate come cister-ne, peschiere, saline, impianti produttivi, luoghi di culto, necropoli, aree coltivate e altro ancora (v. Buc-cellato – Coletti per il caso del suburbio di Roma; Mastelloni per Siracusa; Arce per il Vicino Oriente).
A questo proposito possiamo aggiungere qual-che osservazione sui nessi fra l’estrazione della pie-tra e l’architettura rupestre, realizzata cioè scavando il banco roccioso. In questi casi il sito di costruzio-ne, un cantiere in negativo, può coincidere con la cava, quando il lavoro di escavazione sia stato or-ganizzato razionalmente in vista della contestuale estrazione di materiale per le strutture in elevato, di quello stesso o di altri progetti edilizi. Questa prospettiva è stata finora considerata in pochi casi, in particolare quando le tracce della cavatura siano ben evidenti, come nell’esempio delle tombe mo-numentali di Petra e di Hergla21. Ma non è escluso che un esame delle tante testimonianze, presenti in molti territori, di architettura rupestre monumentale non possano aprire una nuova prospettiva su questa particolare tipologia di cave-cantiere.
PROSPETTIVE
Studi regionali
Ritornando alle precedenti osservazioni sui metodi e sui temi delle ricerche, gli studi regio-nali sulle attività di cavatura sembrano rappre-sentare uno degli orizzonti più promettenti. È in-fatti in questa prospettiva che si può comprendere compiutamente come si organizzarono le attività estrattive, l’assetto territoriale e le infrastrutture e quali ordinamenti socio-politici – e investimenti di risorse economiche – fossero implicati in questa organizzazione. Gli studi regionali possono essere implementati considerando anche l’interazione di altri fattori quali: la geologia locale insieme con la qualità “tecnica” delle diverse rocce; la qualità del-le rocce in relazione alla tipologia dei prodotti, alla loro diffusione e utilizzo (ad esempio per miglio-rare le proprietà statiche degli elementi strutturali); le percentuali dei prodotti locali e importati attesta-ti nei vari contesti.
21 Bessac 2008.
436 STEFANO CAMPOREALE Anejos de AEspA LXIX
La presenza nel territorio delle cave e dei loro prodotti potrebbe poi essere confrontata con gli atlanti regionali delle tecniche edilizie. In questo modo vedremmo le relazioni fra le attività di ca-vatura e le sequenze locali delle tecniche – mentre la cronotipologia di queste ultime potrebbe essere chiarita da una migliore conoscenza delle rocce e delle loro caratteristiche deposizionali.
Nonostante gli studi regionali, sia delle cave sia delle tecniche, debbano ancora essere piena-mente sviluppati, esistono casi in cui le ricerche sono più avanzate e di più lunga tradizione, come quello della Francia, rappresentata in questo con-vegno da un unico intervento (Gaillard)22. Proprio in questi atti la Penisola Iberica, con più contributi su diverse zone, appare invece in un quadro nuovo e organico (Gutiérrez García-Moreno, Soler et al., Pizzo – Cordero)23. Per l’Italia segnaliamo il valore di lavori di sintesi come quello presentato per la Lombardia (Bugini – Folli).
Queste riflessioni ci riportano ancora una volta al campo dell’archeologia dei paesaggi (v. supra). Infatti, i “paesaggi delle cave” dimostrano la loro importanza sia come ricostruzione socio-economi-ca, in quanto l’industria dell’edilizia – in cui inclu-diamo l’estrazione della pietra – ha da sempre rap-presentato una fondamentale attività economica, sia come risorsa culturale, che merita azioni di tutela e valorizzazione. Il rilevamento delle cave all’interno di comprensori regionali, difatti, oltre a rappresen-tare un campo di applicazione per la ricerca archeo-logica, si colloca anche in quest’ultima direzione24.
Cave e cantieri
Infine consideriamo l’ambito della nostra ricer-ca, quello dell’archeologia della costruzione, e lo scopo di questo convegno: esplorare l’approvvi-gionamento dei materiali lapidei come parte inte-grante dei cantieri edili e dei processi costruttivi.
La pietra veniva cavata in seguito a una do-manda di materiali per il “mercato” dell’edilizia e i meccanismi dell’approvvigionamento obbedivano a generali regole di economia dei lavori, intesa qui in senso ampio come organizzazione razionale al
22 Oltre ai lavori di Bessac già citati, v. Bedon 1984; Lorenz 1991; 1993; 1996; Lorenz – Géry 2004; Blary et al. 2008.
23 V. anche Gutiérrez García-Moreno 2009.24 V. Bloxam 2009 per la proposta di nuova metodologia
di studio delle cave in vista della loro conservazione e valorizzazione in quanto patrimonio culturale.
minor costo possibile25. Diversamente, come già sottolineato da precedenti studi, nel caso del mar-mo si seguivano logiche dipendenti più dal valore simbolico e dal prestigio del materiale che dall’ef-fettivo costo dell’estrazione e trasporto.
Ad ogni modo, era in primo luogo il commit-tente a imporre il tipo di risorsa da utilizzare, te-nendo comunque in considerazione la tipologia dei materiali disponibili nelle vicinanze del cantiere.
Ma scopo dell’archeologia della costruzione è l’individuazione di tutte le fasi del lavoro e delle persone coinvolte nell’intero processo, fino ai più umili cavatori. Come abbiamo già cercato di evi-denziare, queste figure sono alla base della com-prensione del funzionamento delle cave e dell’uti-lizzo delle diverse tecniche estrattive. Il loro lavoro, non meno del ruolo svolto dai committenti, fornisce informazioni essenziali sul livello della tecnologia impiegata, sulle dinamiche delle economie locali, sulla diffusione delle tradizioni di lavoro, non solo in relazione alla cavatura ma anche alle tecniche co-struttive. Per conoscere meglio i cavatori, oltre alle fonti epigrafiche e all’analisi delle tracce di estra-zione, di cui abbiamo prima detto, un’altra via è an-cora da sfruttare appieno, e cioè l’indagine – tramite prospezioni e scavi – degli insediamenti di uso tem-poraneo o prolungato in cui essi risiedevano.
Molte aree del mondo greco-romano sono ri-maste escluse dalla trattazione dei contributi e mol-ti argomenti trarranno beneficio da successivi ap-profondimenti delle ricerche. Per quanto riguarda la pietra da costruzione, ad esempio, ci si è concen-trati sulle cave di grandi blocchi destinati a essere squadrati e utilizzati soprattutto nell’architettura pubblica. Queste cave sono più facilmente rico-noscibili grazie alle inconfondibili tracce lasciate sui banchi rocciosi. E d’altra parte la lavorazione della pietra da taglio era la più complessa ed esige analisi di maggiore dettaglio. Ma altri tipi di ma-teriali, come il pietrame per le opere con tecnica irregolare, la pozzolana per le malte e le lastre di rivestimento, a cui si è pure accennato, non sono meno importanti per la ricostruzione dei cantieri.
Tutti questi rimangono altrettanti aspetti da ap-profondire e successive valutazioni generali saranno possibili solo grazie a nuovi studi che considerino i progetti edilizi in tutte le loro fasi, a partire dalle fonti di approvvigionamento dei materiali. In ogni caso, la pluralità degli argomenti trattati nei con-
25 V. l’introduzione a Camporeale et al. 2012.
Anejos de AEspA LXIX 437CONCLUSIONI
tributi qui raccolti, così come le prospettive per la ricerca che ne scaturiscono, dimostrano la vitalità della disciplina e l’utilità dello studio dei cantieri per la ricostruzione storica delle società antiche. E d’al-tra parte, la varietà dei prodotti estratti in cava, che comprende le macine, le epigrafi e un’ampia gam-ma di altri oggetti, grandi e piccoli, ci ricorda che “l’economia della pietra” riguarda aspetti di queste società che non si limitavano ai soli lavori edilizi.
BIBLIOGRAFIA
ABdul mAssih, j., BessAc, J.-Cl. 2009. Glossaire tech-nique trilingue de la pierre. L’exploitation en car-rière, Guides archéologiques de l’Institut français du Proche-Orient 7, Amman-Beyrouth-Damas.
ABu-jABer, n., BloxAm, e.g., degryse, p., heldAl, t. (a cura di) 2009. QuarryScapes: ancient stone quarry landscapes in the Eastern Mediterranean, Geologi-cal service of Norway. Special publication 12, s.l.
Bedon, R. 1984. Les carrières et les carriers de la Gaule romaine, Paris.
BessAc, J.-Cl. 1986. La prospection archéologique des carrières de pierre de taille: approche méthodolo-gique, Aquitania, 4: 151-71.
BessAc, J.-Cl. 1996. La pierre en Gaule Narbonnaise et les carrières du Bois des Lens (Nîmes). Histoire, ar-chéologie, ethnographie et techniques, JRA suppl. 16, Ann Arbor, MI.
BessAc, J.-Cl. 2002a. Les carrières du Bois de Lens (Gard), Gallia, 59: 29-51.
BessAc, J.-Cl. 2002b. Glossaire des termes techniques, Gallia, 59: 189-94.
BessAc, J.-Cl. 2004. L’archéologie de la pierre de taille. In: Bessac. J.-Cl., Chapelot, O., De Filippo, R., Fer-dière, A., Journot, F., Prigent, D., Sapin, Ch., Seigne, J., La construction. Le matériaux durs: pierre et terre cuite, Collection Archéologiques, Paris: 7-49.
BessAc, J.-Cl. 2008. Le travail de la pierre à Petra. Tech-nique et économie de la taille rupestre, Paris.
BessAc, j.-cl., sABlAyrolles, R. (a cura di) 2002a. Car-rières antiques de la Gaule, Gallia, 59: 1-204.
BessAc, j.-cl., sABlAyrolles, R. 2002b. Recherches ré-centes sur les carrières antiques de la Gaule. Bilan et perspectives, Gallia, 59: 175-88.
BlAry, f., gèly, j.-p., lorenz, J. (a cura di) 2008. Pierres du patrimoine européen. Économie de la pierre de l’antiquité à la fin des temps modernes, Archéologie et histoire de l’art 28, Paris.
BloxAm, E.G. 2009. New directions in identifying the significance of ancient quarry landscapes: four con-
cepts of landscape. In: Abu-Jaber, N., Bloxam, E.G., Degryse, P., Heldal, T. (a cura di), QuarryScapes: an-cient stone quarry landscapes in the Eastern Med-iterranean, Geological service of Norway. Special publication 12, s.l.: 165-83.
BukoWiecki, E. 2012. Le stockage des briques à Rome. In: Camporeale, S., Dessales, H., Pizzo, A. (a cura di), Arqueología de la construcción, 3. La economía de las obras (Paris, 9-11/12/2009), Anejos de AespA 64, Madrid-Mérida: 161-78.
cAmporeAle, s., dessAles, h., pizzo, A. (a cura di) 2012. Arqueología de la construcción, 3. Los procesos constructivos en el mundo romano: la economía de las obras (Paris, 10-11/12/2009), Anejos de AEspA 64, Madrid-Mérida.
cAmporeAle, s., mAscione, C. 2010. Dalle cave ai cantie-ri: estrazione e impiego della calcarenite a Populonia tra periodo etrusco e romano. In: Camporeale, S., Dessales, H., Pizzo, A. (a cura di), Arqueología de la construcción, 2. Los procesos constructivos en el mundo romano: Ita-lia y provincias orientales (Siena, 13-15/11/2008), Ane-jos de AespA 57, Madrid-Mérida: 153-72.
fAnt, J.C. 1993. Ideology, gift, and trade: a distribution model for the Roman imperial marbles. In: Harris, W.V. (a cura di), The inscribed economy. Production and dis-tribution in the Roman empire in the light of the instru-mentum domesticum. The proceedings of a Conference held at the American Academy in Rome on 10-11 Janu-ary, 1992, JRA suppl. 6, Ann Arbor, MI: 145-70.
delAine, J. 1995. The supply of building materials to the city of Rome. In: Christie, N. (a cura di), Set-tlement and economy in Italy 1500 BC - AD 1500. Papers of the fifth conference in Italian archaeolo-gy (Oxford, 11-13/12/1992), Oxbow monograph 41, Oxford: 555-62.
delAine, J. 2002. Building activity in Ostia in the second century AD. In: Bruun, C., Gallina Zevi, A. (a cura di), Ostia e Portus nelle loro relazioni con Roma. Atti del Convegno all’Institutum Romanum Finlandiae (Roma, 3-4/12/1999), ActaIRF 27, Roma: 41-101.
dodge, h., WArd-perkins, B. (a cura di) 1992. Marble in antiquity. Collected papers of J.B. Ward-Perkins, Archaeological monographs of the British School at Rome 6, London.
greene, K. 1992. How was technology transferred in the western provinces? In: Wood, M., Queiroga, F. (a cura di), Current research on the romanization of western provinces, BAR international series 575, Oxford: 101-5.
gutiérrez gArcíA-moreno, A. 2009. Roman quarries in the northeast of Hispania (modern Catalonia), Docu-menta 10, Tarragona.
438 STEFANO CAMPOREALE Anejos de AEspA LXIX
hirt, A.M. 2010. Imperial mines and quarries in the Ro-man world. Organizational aspects 27 BC – AD 235, Oxford.
lAncAster, L. 2005. Concrete vaulted construction in im-perial Rome. Innovations in context, Cambridge, NY.
lorenz, J. (a cura di) 1991. Carrières et constructions en France et dans les pays limitrophes, 1, Paris.
lorenz, J. (a cura di) 1993. Carrières et constructions en France et dans les pays limitrophes, 2, Paris.
lorenz, J. (a cura di) 1996. Carrières et constructions en France et dans les pays limitrophes, 3, Paris.
lorenz, j., gély, J.-P. (a cura di) 2004. Carrières et constru-ctions en France et dans les pays limitrophes, 4, Paris.
lukAs, D. 2002. Carrières et extraction romaines dans le nord-est de la Gaule et en Rhénanie, Gallia, 59: 155-74.
mAr, r., pensABene, P. 2010. Finanziamento dell’edili-zia pubblica e calcolo dei costi dei materiali lapidei: il caso del Foro superiore di Tarraco. In: Camporea-le, S., Dessales, H., Pizzo, A. (a cura di), Arqueología de la construcción, 2. Los procesos constructivos en
el mundo romano: Italia y provincias orientales (Sie-na, 13-15/11/2008), Anejos de AEspA 57, Madrid-Mérida: 509-37.
medri, M. 2001. La diffusione dell’opera reticola-ta: considerazioni a partire dal caso di Olimpia. In: Constructions publiques et programmes édilitaires en Grèce entre le IIe siècle av. J.C. et Ier siècle ap. J.-C. Actes du Colloque organisé par L’Ecole française d’Athènes et le CNRS (Athènes, 14-17/5/1995), BCH suppl. 39, Paris: 15-36.
rodríguez gutiérrez, o., BeltrÁn fortes, L. 2010. Los materiales lapídeos de la provincia Baetica. Estado de la cuestión y líneas actuales de investigación. In: Camporeale, S., Dessales, H., Pizzo, A. (a cura di), Arqueología de la construcción, 2. Los procesos con-structivos en el mundo romano: Italia y provincias orientales (Siena, 13-15/11/2008), Anejos de AespA 57, Madrid-Mérida: 555-70.
russell, B. 2013. The economics of the Roman stone trade, Oxford.
ARCHIVO ESPAÑOL DE ARQUEOLOGÍA(AEspA)
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE MANUSCRITOS
Normas de redacción
Dirección.— Redacción de la revista: Calle Albasanz 26-28, E-28037 Madrid, Teléfono: +34 91 6022300; Fax: +34913045710, correo electrónico: [email protected]
Contenido.— Archivo Español de Arqueología es una revista científica de periodicidad anual que publica trabajos deArqueología, con atención a sus fuentes materiales, literarias, epigráficas o numismáticas. Tiene como campo deinterés las culturas del ámbito mediterráneo y europeo desde la Protohistoria a la Alta Edad Media, flexiblementeabierto a realidades culturales próximas y tiempos fronterizos. Se divide en dos secciones: Artículos, dentro de losque tendrán cabida tanto reflexiones de carácter general sobre temas concretos como contribuciones más brevessobre novedades en la investigación arqueológica; y Recensiones. Además, edita la serie Anejos de ArchivoEspañol de Arqueología, que publica de forma monográfica libros concernientes a las materias mencionadas. Lostrabajos serán originales e inéditos y no estarán aprobados para su edición en otra publicación o revista.
Formulario de autoría.— Al enviar el artículo, los autores deben incluir una declaración específica de que el artículo no seha sometido a presentación para su evaluación y publicación en otras revistas simultáneamente o con anterioridad.En el momento en que el artículo sea aceptado, al enviar el texto y figuras definitivas, deberán rellenar unformulario específico donde constarán las condiciones de copyright de las publicaciones del CSIC.
Normas editoriales1. El texto estará precedido de una hoja con el título del trabajo y los datos del autor o autores (nombre y apellidos,
institución, dirección postal, teléfono, correo electrónico, situación académica) y fecha de entrega. Cada originaldeberá venir acompañado por la traducción del Titulo al inglés, acompañado de un Resumen y Palabras Claves enespañol, con los respectivos Summary y Key Words en inglés. De no estar escrito el texto en español, los brevesresúmenes y palabras clave vendrán traducidos al español e inglés. Las palabras clave no deben incluir lostérminos empleados en el título, pues ambos se publican siempre conjuntamente.
2. Se entregará una copia impresa y completa, incluyendo toda la parte gráfica. Se adjuntará asimismo una versiónen soporte informático, preferentemente en MS Word para Windows o Mac y en PDF, con imágenes incluidas.
3. El texto no deberá exceder las 11000 palabras. Solo en casos excepcionales se admitirán textos más extensos. Losmárgenes del trabajo serán los habituales (superior e inferior de 2 cm; izquierdo y derecho de 2.5 cm). El tipo deletra empleado será Times New Roman de 12 puntos a un espacio, con la caja de texto justificada. Aparecerá lapaginación correlativa en el ángulo inferior derecho. Se empleará a comienzo de párrafo el sangrado estándar (1,25). Salvo la separación lógica entre diferentes apartados, no se dejarán líneas en blanco entre párrafos. En ningúncaso se utilizarán negritas.
4. Se cuidará la exacta ordenación jerárquica de los distintos epígrafes, numerándolos indistintamente medianteguarismos romanos y árabes, e incluso sin numeración.
5. Cuando se empleen citas textuales en el texto o en notas a pie de página se entrecomillarán, evitando la letracursiva. Dicha letra se acepta para topónimos o nombres en latín. En estos casos, se preferirán las grafías con “v”en lugar de “u”, tanto para mayúsculas como para minúsculas (conventus mejor que conuentus).
6. Por lo que se refiere al sistema de cita, deberá emplearse el sistema “americano” de citas en el texto, con nombrede autor en minúscula y no se pondrá coma entre autor y año (apellido o apellidos del autor año: páginas). Si losautores son dos se incluirá la conjunción “y” entre ambos. Si los autores fueran más de dos se indicará el apellidodel primero seguido por la locución et alii. Se incluirá una bibliografía completa al final del trabajo. En la bibliografía final, los títulos de monografías irán encursiva, mientras que en los artículos el título se colocará entrecomillado. Los nombres de los autores, ordenadosalfabéticamente por apellidos, en la bibliografía final irán en letra redonda, seguidos por el año de publicaciónentre paréntesis y dos puntos. Si los autores son dos, irán unidos por la conjunción “y”. Si son varios los autores,sus nombres vendrán separados por comas, introduciendo la conjunción “y” entre los dos últimos. En el caso deque un mismo autor tenga varias obras, la ordenación se hará por la fecha de publicación, de la más antigua a lamás reciente. Si en el mismo año coinciden dos o más obras de un mismo autor o autores, serán distinguidas conletras minúsculas (a, b, c...). En el caso de las monografías se indicará el lugar de edición tal y como aparececitado en la edición original (p. e. London, en lugar de Londres), separado del título de la obra por una coma. Enel caso de artículos o contribuciones a obras conjuntas, se indicarán al final las páginas correspondientes, tambiénseparadas por comas. Los nombres de revistas se incluirán sin abreviar. Las referencia a las consultas realizadas enlínea (Internet), deberán indicar la dirección Web y entre paréntesis la fecha en la que se ha realizado la consulta.Las notas a pie de página, siempre en letra Times New Roman de 10 puntos, se emplearán únicamente paraaclaraciones o referencias generales.
La Sede de los Ordines:M 14/1/14 10:43 Página 363