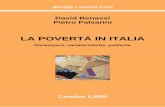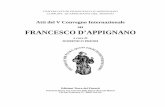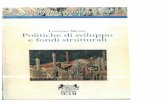Politiche di conciliazione e partecipazione delle donne al mercato del lavoro
atti della conferenza - le politiche dell'ue per l'immigrazione ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of atti della conferenza - le politiche dell'ue per l'immigrazione ...
DOCUMENTI
ATTI DELLA CONFERENZA
LE POLITICHE DELL’UEPER L’IMMIGRAZIONE,DIRITTI FONDAMENTALI,INTEGRAZIONE SOCIALE,COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
ROMA, 6-7 OTTOBRE 2003
3 0
INDICE
Presentazione ........................................................................... pag. 9
INTERVENTO DI APERTURAPIETRO LARIZZA - Presidente del CNEL ..................................” 13
RELAZIONE INTRODUTTIVAUNA STRATEGIA DI RIEQUILIBRIO E SVILUPPO DELLE POLITICHE
COMUNITARIE PER L’ IMMIGRAZIONE
GIORGIO ALESSANDRINI - Presidente Vicario dell’ONC - CNEL.. ” 16
COMUNICAZIONEL’ OPINIONE PUBBLICA EUROPEA DI FRONTE ALL’ IMMIGRAZIONE
ILVO DIAMANTI - Docente di Sociologia all’Università di Urbino.... ” 30
INTERVENTIJOAQUIM NUÑES DE ALMEIDA - Gabinetto del CommissarioEuropeo per la Giustizia e gli Affari Interni della CommissioneEuropea ................................................................................... ” 36
LIVIA TURCO - Deputata dei Democratici di Sinistra .............. ” 41
I SESSIONE - LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE SOCIALE DEGLI STRANIERI................................................ ” 47SILVIA COSTA - Consigliere del CNEL ..................................... ” 49
RODOLFOGUTIERREZPALACIOS - Direttore Area Studi e Analisidel Consiglio Economico e Sociale della Spagna ................... ” 53
3
BERNARD BEDAS - Direttore del Servizio Internazionale delConsiglio Economico e Sociale della Francia ........................pag. 57
ANDRESGARCIA PRADO - Direttore Generale Immigrazione,Assessorato Servizi Sociali della Regione di Madrid ..............” 61
RITA SÜSSMUTH- Presidente del Consiglio Indipendente di espertisu migrazione ed integrazione nominato dal Governo tedesco. ” 65
ABDERAZAK FETNAN - Membro del Consiglio Economico eSociale della Regione Provenza e Costa Azzurra ...................” 69
GIANLUCA BORGHI - Assessore alle politiche sociali dellaRegione Emilia-Romagna ........................................................” 73
RAFFAELLA MILANO - Assessore ai servizi sociali del Comunedi Roma ....................................................................................” 78
MAURIZIO SILVERI - Direttore Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ........................” 81
GIUSEPPINA COPPO- Delegata dell’Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia .........................” 84
ENRICA SARDEI - Assessorato alle politiche della sicurezzae dei flussi migratori della Regione Veneto .............................” 92
MALIKA HORCHANI - Coordinatrice della Maison des femmes
di Tunisi ...................................................................................” 96
GRAZIANO BATTISTELLA - Rettore dello Scalabrini InternationalMigration Institute ...................................................................” 113
MOHAMED SAADY - Copresidente della Associazione NazionaleOltre le Frontiere (ANOLF) ....................................................” 121
GIOVANNA ZALDINI - Presidente della Cooperativa “La Talea”(Alma Terra) ............................................................................” 123
MARIA JOSÉMENDEZ EVORA - Presidente della AssociazioneNostri Diritti (No.Di) ...............................................................” 127
RODRIGO JAIMES HIDALGO - Membro della Consulta Immi-grazione-Emigrazione della Regione Lazio ............................” 130
EDMOND AGBETTOR - Presidente della Consulta Immigrati delComune di Modena .................................................................” 133
4
VALENTINA LESKAJ - Ministro del Lavoro e degli Affari Socialidella Repubblica di Albania ....................................................pag. 136
MAURIZIO SACCONI - Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ...............................................” 140
II SESSIONE - QUADRO GIURIDICO COMUNITARIO ECONTROLLO DELLE FRONTIERE ESTERNE .....................” 145
FRANCESCASANTORO - Vice Presidente del CNEL ..................” 147
ANDREASKINTIS - Presidente del Consiglio Economico e Socialedella Grecia (OKE) .................................................................” 152
DERMOT MCCARTHY - Presidente del Consiglio NazionaleEconomico e Sociale dell’Irlanda (NESC) ..............................” 160
JURGEN HUMBURG - Alto Commissario per i Rifugiati delleNazioni Unite (UNHCR) .........................................................” 163
CHRISTOPHERHEIN - Direttore del Consiglio italiano per rifugiati ....................................................................................” 166
VITTORIO NOZZA - Direttore della Caritas italiana .................” 169
ANNEMARIE DUPRÉ- Consulente della Presidenza della Federazione delle Chiese Evangeliche ....................................” 174
PADRE FRANCESCODE LUCCIA SJ - Presidente dell’AssociazioneCentro Astalli ............................................................................” 177
SALVATORE GERACI - Presidente della Società Italiana diMedicina delle Migrazioni ......................................................” 180MARIA PAOLA COLOMBO SVEVO - Responsabile dell’European Network Against Trafficking in Women (ENATW) ..................” 185
REMIGIO MUSARAGNO - Presidente dell’UCSEI ......................” 191
MICHELE LEPRIGALLERANO - Prefetto - Vice Capo DipartimentoLibertà Civili e Immigrazione del Ministero dell’Interno .......” 193
III SESSIONE - IMMIGRAZIONE E POLITICHE DI COO-PERAZIONE ALLO SVILUPPO: ACCORDI BILATERALI ... ” 199ANGELO GENNARI - Presidente della Commissione Internazionaledel CNEL .................................................................................” 201
5
RADU COLCEAG - Segretario Generale del Consiglio Economicoe Sociale della Romania ..........................................................pag. 206
KAMIL EDDINE BENHABIB - Responsabile Studi Sociali del Consiglio Economico e Sociale dell’Algeria (CNES) .............” 210
TAHAR FELLOUS - Membro della Commissione Lavoro e Salutedel Consiglio Economico e Sociale della Tunisia ...................” 216
SAID IHRAI - Presidente del Consiglio Economico e Socialedel Marocco (CNJA) ................................................................” 220
UGO MELCHIONDA - Organizzazione Internazionale per leMigrazioni (OIM) ....................................................................” 226
ADELA ROS- Istituto Europeo del Mediterraneo di Barcellona ” 229
GILDO BARALDI - Direttore Generale dell’Osservatorio Interre-gionale Cooperazione allo Sviluppo .......................................” 231
IV SESSIONE - RUOLO DELLE PARTI SOCIALI PER UNACOMUNE POLITICA DI IMMIGRAZIONE ...........................” 235
ROGERBRIESCH- Presidente del CESE ...................................” 237
STEFANO CETICA - Segretario Generale dell’UGL ..................” 248
MASSIMO VIVOLI - Vicepresidente Vicario della Confesercenti .. ” 252
EDOARDO PATRIARCA - Forum Nazionale del Terzo Settore ..... ” 257
GUGLIELMO LOY - Segretario Confederale della UIL ..............” 261
TULLIO UEZ - Vice Presidente Vicario della Confartigianato ... ” 266
TITTI DI SALVO - Segretario Confederale della CGIL .............” 271
STEFANO PARISI - Direttore Generale di Confindustria ...........” 275
SAVINO PEZZOTTA - Segretario Generale della CISL ...............” 279
CONCLUSIONI
GIANFRANCO FINI - Vice Presidente del Consiglio dei Ministri.. ” 286
APPENDICE 1CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PERLA II SESSIONE
DI LAVORO - “Quadro giuridico e comunitario e controllo dellefrontiere esterne” .....................................................................” 298
6
SCHEMA DI PROPOSTA DI DIRETTIVA RELATIVA ALL’ASTENSIONE
DELL’ASSISTENZASANITARIA PERTUTTI GLI STRANIERI.Elaborato dal Naga di Milano, dalla Caritas di Roma,dall’Oikos di Bergamo, con il patrocinio della Società Italianadi Medicina delle Migrazioni e delCNEL ..............................pag. 306
APPENDICE 2- RASSEGNA STAMPA .........................................” 311
APPENDICE 3 - ELENCO DEI PARTECIPANTI ..............................” 322
7
Presentazione
Uno degli obiettivi prioritari del programma di Presidenza Italianadel Consiglio dell’Ue è stato quello “una gestione comune dei flussimigratori che rispetti un giusto equilibrio tra la politica di integrazionedegli stranieri legalmente residenti dell’Unione Europea, anche favo-rendo il dialogo a livello sociale, culturale e religioso, ed una lotta con-tro l’immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani”.
In questa ottica, il CNEL ha deciso di organizzare una Conferenzaeuropea su “Le politiche dell’Ue per l’immigrazione: diritti fondamen-tali, integrazione sociale, cooperazione allo sviluppo”.
L’organizzazione della Conferenza è stata affidata al Comitato diPresidenza dell’Organismo Nazionale di Coordinamento per le politi-che di integrazione sociale degli stranieri (ONC) del CNEL.
La Conferenza ha rappresentato l’espressione di un metodo dilavoro, fatto di dibattito e di partecipazione, di confronto con le forzepolitiche e sociali italiane ed europee, le istituzioni, il volontariato, lecomunità e le associazioni di stranieri.
La Conferenza ha avuto lo scopo di impegnare la Presidenza ita-liana dell’U.E. nel secondo semestre del 2003 su tre obiettivi della poli-tica comunitaria sull’immigrazione:
• una forte saldatura tra politiche immigratorie e politiche di coopera-zione per lo sviluppo con la promozione di accordi tra U.E. e Paesi diorigine degli immigrati;
9
• il completamento, già fissato per entro il 2004, del quadro giuridicocomunitario in tema di immigrazione ed asilo;
• la promozione del metodo aperto di coordinamento delle politiche diintegrazione sociale, che sono di competenza dei singoli Stati.
Una caratterizzazione specifica della Conferenza ha riguardato dueaspetti:
1. l’attenzione all’area mediterranea oggettivamente critica ancherispetto al fenomeno immigratorio, per migliorare il dialogo e la coo-perazione, i legami con l’Europa e per promuovere particolarmente lecondizioni della creazione dell’area di libero scambio, decisa nel ‘95a Barcellona (a fronte dell’allargamento ad Est), che sola in termini disviluppo può riequilibrare i Paesi delle due sponde con reciproci van-taggi e ridurre una pressione migratoria diversamente incontenibile;
2. la centralità delle politiche di integrazione sociale dei milioni di cit-tadini stranieri regolarmente e stabilmente soggiornanti nei Paesicomunitari, e delle politiche di collaborazione allo sviluppo dei Paesid’origine per ridurre la pressione migratoria, per governare in modoefficiente la programmazione dei flussi, per favorire i rimpatri.
Durante la Conferenza sono state avanzate due proposte di diretti-va, da sottoporre all’attenzione della Presidenza italiana, concernentil’estensione di una piena assistenza sanitaria a tutti i cittadini stranieripresenti nel territorio dell’Ue e la previsione di un permesso di soggior-no temporaneo, umanitario, rinnovabile a persone che si trovano in con-dizioni di riduzione in schiavitù e che intendono accettare un percorsodi reinserimento e protezione sociale.
Sono stati ribaditi, inoltre: - l’obiettivo già auspicato dal ComitatoEconomico e Sociale Europeo, rispetto alla estensione della CartaCostituzionale, di concedere la cittadinanza dell’Unione ai cittadini deiPaesi Terzi solo con status di residenti di lungo periodo, come base giu-ridico costituzionale di un trattamento equo e quindi di un’efficace inte-grazione sociale, civile e politica; - la sollecitazione, infine, a rafforzareil contributo della Ue al quadro giuridico internazionale, attraverso laratifica della Convenzione Onu sui diritti degli immigrati e delle lorofamiglie, del dicembre 1990, entrata in vigore il 1° luglio di quest’anno,
10
e di quella contro il crimine internazionale, con i relativi protocolli,operativa dal 29 settembre 2003.
I lavori della Conferenza, i cui atti sono raccolti in questa pubbli-cazione, si sono articolati in quattro sessioni, nell’arco di una giornata emezza, con la partecipazione di oltre cinquecento persone - fra italianee straniere - in rappresentanza di organismi internazionali, di Governieuropei, diComitati economici e sociali europei e dell’area mediterra-nea.
Sono intervenuti rappresentanti del Governo, dell’opposizioneparlamentare, i massimi esponenti dei sindacati confederali e delleassociazioni imprenditoriali, i responsabili dell’associazionismo socia-le, del volontariato e delle associazioni dei cittadini stranieri.
11
INTERVENTO DI APERTURA
PIETRO LARIZZA
Presidente del CNEL
Buongiorno a tutti!
Vorrei innanzi tutto esprimere il mio ringraziamento ai rappresen-tanti dei Governi dei Paesi esteri, dei Comitati economici e sociali, del-le Autonomie locali, delle Forze sociali e a tutti partecipanti per la loropresenza. Un saluto ed un ringraziamento particolare a Roger Briesch,Presidente del Comitato Economico e Sociale di Bruxelles che nellasessione di domani illustrerà il punto di vista del Comitato Economico eSociale Europeo sulle politiche immigratorie.
I lavori della odierna Conferenza inizieranno con la relazione in-troduttiva del Presidente dell’Organismo nazionale di coordinamentoper le politiche di integrazione sociale degli stranieri, Giorgio Alessan-drini.
Nel corso dei lavori interverranno, fra gli altri, ovviamente, anchei rappresentanti del Governo italiano che in questo semestre è titolaredella presidenza dell’Unione Europea e che ringrazio sentitamente.
Ciò che emergerà da questa Conferenza sarà, quindi, inviato alGoverno e al Parlamento italiano come contributo allo sviluppo dellepolitiche sul problema dell’immigrazione.
Ho detto “problema dell’immigrazione” perché, nell’affrontarequesta materia, bisogna tener conto di una parte dell’opinione pubblica
13
europea che, pur avendo verso i cittadini immigrati sentimenti di com-prensione umana e di solidarietà, ha anche sentimenti di preoccupazio-ne per il loro inserimento nel tessuto economico e sociale del proprioPaese. Il timore che tale inserimento possa condizionare il proprio be-nessere, la propria organizzazione sociale, la propria sicurezza è moltoforte. Poiché questo problema è un problema che riguarda tutta l’Euro-pa esso deve essere, a nostro avviso, guidato attraverso uno stretto edefficace coordinamento delle politiche di cooperazione, sociali e di si-curezza tra i vari Stati dell’Unione. Una politica europea pertanto chedeve muoversi su diversi fronti, il primo dei quali è quello di un rappor-to di assoluta collaborazione con i Paesi da cui proviene l’immigrazio-ne.
Deve essere un rapporto di sostegno, di massimo aiuto per lo svi-luppo di questi Paesi, per far sì che ci sia la possibilità del riscatto deicittadini più bisognosi attraverso il lavoro nel proprio Paese e senza ilbisogno di attraversare frontiere. Una politica di collaborazione anchenella prevenzione della forma peggiore di immigrazione, quella illegalee quindi clandestina. Bisogna cioè rafforzare il controllo delle frontiere,non certamente quelle che sono molto estese e facili da attraversare, maquelle dei Paesi di origine. Ovviamente tutto questo dopo aver scelto lastrada della collaborazione certa e del sostegno allo sviluppo.
Nei singoli Stati dovremo inoltre individuare la soluzione dei pro-blemi connessi all’immigrazione regolare. I problemi a riguardo sonomoltissimi, non solo quello dell’accoglienza, ma quello della completaintegrazione che deve essere programmata per renderla possibile neglianni. Perciò i modelli di organizzazione sociale, i problemi abitativi, sa-nitari, scolastici, i problemi appunto della partecipazione attiva alla vitacivile del Paese devono essere affrontati con pari dignità con i residentidel Paese.
Noi abbiamo organizzato questo convegno durante il Semestre diPresidenza italiana perché, essendo certi che c’è una grande responsabi-lità ed anche un grande compito che attende l’Europa, anche noi, assie-me a voi, intendiamo far giungere la nostra voce ai Paesi europei, allaCommissione Europea ed in particolare al Governo italiano che ha laresponsabilità della Presidenza in questo Semestre. Dovremo cercare di
14
indicare con precisione e senza allarmismi o emozioni quali sono i pro-blemi veri dell’immigrazione e quali sono le responsabilità che, a no-stro parere, l’Europa, tutta l’Europa in forma unitaria, si deve assumere.Non vogliamo chiedere un impossibile blocco delle frontiere ma voglia-mo fornire indicazioni utili per un intervento preventivo e amichevolein collaborazione con i Paesi da cui l’immigrazione proviene. Occorreinfatti stabilire le condizioni necessarie per assicurare una gestione e-quilibrata e a lungo periodo del fenomeno migratorio. Una gestionecioè che tenga conto di tutti gli aspetti per una equilibrata integrazionesocio-economica.
Questo è l’obiettivo della discussione di oggi e sono certo che essosarà realizzato.
Vi ringrazio e dichiaro aperta la Conferenza.
15
RELAZIONE INTRODUTTIVA
UNA STRATEGIA DI RIEQUILIBRIO E SVILUPPO DELLE POLITICHE COMUNITA-RIE PERL’ IMMIGRAZIONE
GIORGIO ALESSANDRINI
Presidente Vicario dell’ONC - CNEL
Gentili Signore e gentili Signori,
l’obiettivo di questa Conferenza, con la partecipazione dei diversiorganismi istituzionali che negli Stati dell’Unione, in quelli europei nonancora comunitari e in quelli del Mediterraneo meridionale rappresentanole forze imprenditoriali, sindacali e sociali, è quello di contribuire all’im-pegno della Presidenza italiana dell’U.E., in questo secondo semestre del2003, su tre obiettivi della politica comunitaria sull’immigrazione:
- il quadro giuridico comunitario, da completare entro il maggio 2004,con particolare riferimento ai requisiti per lo status di rifugiato e alleprocedure di asilo;
- la promozione del metodo aperto di coordinamentodelle politiche diintegrazione sociale, che sono di competenza dei singoli Stati;
- una forte integrazione tra politiche immigratorie e politiche di coope-razione allo sviluppo nei confronti dei Paesi di origine.
La partecipazione dei rappresentanti degli organismi degli Statidel Mediterraneo meridionale ha un particolare valore.
16
La Presidenza italiana dovrebbe offrire l’opportunità per rafforzarel’attenzione a questa area, oltretutto particolarmente critica rispetto alfenomeno immigratorio, per migliorare il dialogo e la cooperazione, ilegami con l’Europa allargata e per promuovere con più sollecitudinequell’area di libero scambio, decisa nella Conferenza euromediterraneadi Barcellonanel 1995, che sola, in termini di sviluppo, può riequilibra-re i Paesi delle due sponde con reciproci vantaggi e ridurre una pressio-ne migratoria diversamente incontenibile.
Dopo il Trattato di Amsterdam del 1999, che ha reso comunitariala competenza in materia di asilo ed immigrazione, nell’ottobre dellostesso anno il Consiglio Europeo di Tampere, per ricondurre in un am-bito comunitario queste politiche, prefigurò una strategia molto ambi-ziosa, integrata nella politica interna ed esterna; l’ha considerata un’au-tentica sfida per affermare una Unione di libertà, sicurezza e giustizianon solo per i cittadini europei, ma anche per quelli dei Paesi Terzi chevi soggiornano legalmente.
Una comune politica migratoria non si giustificava più soltanto intermini difensivi per la caduta dei controlli delle frontiere interne, maperché era riconosciuta più efficace, secondo il principio di sussidiarie-tà, per governare, in modo integrato, un fenomeno complesso ed inelu-dibile come l’immigrazione, interessante tutti i Paesi dell’Unione.
E’ appena il caso di ricordare che l’Europa è il più rilevante polomigratorio nel mondo e l’Europa occidentale con circa 20 milioni dipersone che hanno conservato la cittadinanza estera, viene subito dopol’America del Nord.
In questi anni la Commissioneha portato a compimento il suo lavo-ro di proposta programmatica e normativa, ma le difficoltà dei meccani-smi istituzionali del Trattato di Amsterdam, la rigidità del metodo deci-sionale intergovernativo, le diverse storie migratorie e i diversi interessidei Paesi, soprattutto il più recente impatto sociale del fenomeno immi-gratorio sulle opinioni pubbliche, provate da più generali e profonde in-quietudini, e i cambiamenti politici intervenuti nei governi hanno forte-mente compromesso, su alcune scelte decisive, lo spirito di Tampere.
Lo dimostrano i ritardi sul regime comune in materia di asilo ed ilmodesto profilo del consenso politico raggiunto su direttive importanti
17
come quelle più recenti sui ricongiungimenti familiari e sullo status deiresidenti regolari di lungo periodo, i limiti delle politiche di partenariatocon i Paesi di origine, addirittura il sostanziale abbandono della questionecruciale della promozione comunitaria delle politiche di integrazione so-ciale, come la stessa Commissione riconosce nella recente Comunicazio-ne ... su immigrazione, integrazione e occupazione del 3 giugno 2003.
E’ stato il Consiglio Europeo di Siviglia del giugno 2002 ad aprireuna fase nuova.
Esso ha determinato uno squilibrio, rivolgendo una prevalente at-tenzione alle politiche della sicurezza, cioè ai problemi della lotta al-l’immigrazione clandestina ed ai fenomeni criminali ad essa collegati,al controllo integrato delle frontiere esterne, ad una politica di partena-riato con i Paesi di origine soprattutto finalizzata alla cooperazione percontrastare l’immigrazione clandestina e per favorire riammissioni erimpatri.
Sono questioni certamente importanti, che, congiuntamente all’ob-biettivo di una regolamentazione comunitaria dei flussi, la Presidenza i-taliana, specificatamente il Ministro degli Interni, stanno affrontandocon grande determinazione.
Ma non si vince la lotta alla immigrazione clandestina soltanto conuna politica poliziesca e repressiva, pur necessaria se chiaramente fina-lizzata a combattere non i clandestini ma la criminalità organizzata,senza una congrua e certa programmazione delle entrate e con un im-pervio percorso per la presenza legale.
Occorre ritrovare l’equilibrio della strategia di Tampere innanzi-tutto con una integrazione di alto profilo tra politiche migratorie e azio-ne esterna dell’Unione (cooperazione e politica estera), ad iniziare dalperseguimento di relazioni inclusive con i Paesi vicini dell’Est e delMediterraneo meridionale.
La titolarità della politica estera da parte dell’Unione prevista dallanuova Costituzione dovrà dare un forte impulso a questo riequilibrio.
“L’Unione Europea - hanno affermato le Conclusioni di Tampere -ha bisogno di un approccio generale al fenomeno della migrazione cheabbracci le questioni connesse alla politica, ai diritti umani e allo svi-luppo dei Paesi e delle regioni di origine e transito. Ciò significa che bi-
18
sogna combattere la povertà, migliorare le condizioni di vita e le oppor-tunità di lavoro, prevenire i conflitti e stabilizzare gli Stati democratici,garantendo il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle mino-ranze, delle donne e dei bambini.”
Come d’altro canto non si assicurano condizioni di una ordinataconvivenza civile tra i cittadini europei e i milioni di cittadini dei PaesiTerzi immigrati regolarmente negli Stati dell’Unione, rendendo difficilee precaria la loro cittadinanza legale e senza un impegno forte nelle po-litiche di integrazione sociale, che è l’altro pilastro della strategia diTampere, per il quale pur si prevedeva la necessità di un approccio co-mune, del tutto disatteso.
“L’Unione Europea - hanno affermato ancora le Conclusioni diTampere - deve garantire l’equo trattamento dei cittadini dei Paesi Terziche soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri. Una politi-ca di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti eobblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’UE. Essa dovrebbe inoltre raf-forzare la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale eprevedere l’elaborazione di misure contro il razzismo e la xenofobia”.
Siamo al giorno dopo della Conferenza intergovernativa di Romasul Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa:nella primavera del 2004 si formalizzerà l’adesione dei nuovi dieci Statimembri ed entrerà in vigore la Costituzione dell’Unione Europea dei 25con 455 milioni di cittadini. Un terzo evento sarà l’elezione del nuovoParlamento europeo.
Con la nuova Costituzione, comprensiva della Carta di Nizza suidiritti fondamentali,applicabili a tutti i cittadini a prescindere dalla na-zionalità, l’Unione diventa titolare delle politiche relative al controllodelle frontiere, all’asilo e all’immigrazione ed anche della possibilità di“stabilire misure volte a incentivare e sostenere l’azione degli Statimembri al fine di favorire l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi re-golarmente soggiornanti nel loro territorio”, pur escludendo l’armoniz-zazione di leggi e regolamenti nazionali.
Non è quel mandato costituzionale forte, che auspicavamo con ilComitato Economico e Sociale Europeo nel suo Parere d’iniziativa delmaggio 2003 sul tema Integrazione nella cittadinanza dell’Unione Eu-
19
ropea, cioè la concessione della cittadinanza dell’Unioneai cittadinidei Paesi Terzi soltanto con status di residenti di lungo periodo, comebase giuridico costituzionale del trattamento equoe quindi di una effi -cace integrazione sociale, civile e politica.
Ed è un obiettivo che ribadiamo in questa Conferenza. In ogni ca-so riteniamo che vada posta al livello di coordinamento comunitario laquestione, già positivamente affrontata da alcuni Stati, di come sempli-ficare, per l’ottenimento della cittadinanza degli Stati membri, requisitie procedure nazionali, che non dovrebbero eccessivamente divaricare,essendo condizione della comune cittadinanza europea, in base all’at-tuale proposta di testo costituzionale.
Tuttavia quelle indicate sono condizioni straordinarie per dare unforte impulso a quel riequilibrio delle politiche immigratorie, nello spi-rito di Tampere, necessario perché l’UE non le impronti ad una logicaegoistica e repressiva, in gran parte appiattita sull’emergenza e oltretut-to di dubbia efficacia al contenimento del fenomeno, ma le indirizzi ascelte di sviluppo, cogliendo tutte le potenzialità economiche e socialiper sé e per i Paesi in via di sviluppo.
Certo non si deve sottovalutare che l’immigrazione pone una “que-stione” sociale, che riguarda non solo i diritti e la condizione degli immi-grati, ma anche l’impatto con l’opinione pubblica di accoglienza rispettoai processi di integrazione, alle preoccupazioni sul piano dell’identità,dell’occupazione, dell’ordine pubblico, della sicurezza personale.
In Italia, come negli altri Paesi europei, l’opinione pubblica vive il fe-nomeno immigratorio con inquietudine; oltretutto è “un sentire” facilmentestrumentalizzabile per determinare orientamenti politici ed elettorali.
Questa inquietudine tuttavia è la punta dell’iceberg di un malesse-re più profondo.
Esso chiama in causa in realtà le incertezze, le preoccupazioni, lediffidenze, le paure, una condizione di estraneità rispetto ai processi diglobalizzazione, di cui la nuova immigrazione è un fenomeno di impat-to forte e diretto sul lavoro e nella vita di tutti i giorni, al deficit di de-mocrazia e di politica nel processo di integrazione europea, al trauma ealle conseguenze del dopo 11 settembre, ai terrorismi di diversa origine,alla guerra.
20
Le inquietudini profonde che percorrono le nostre società, riguar-dano le prospettive economiche, ma ancora più la pace, la convivenzacivile, i comportamenti sociali, l’identità, la sicurezza personale.
Sono questi gli ambiti anche dell’impatto sociale dell’immigrazio-ne, pur avendo i Paesi membri dell’Unione situazioni migratorie moltodiverse: rispetto all’esperienza dell’emigrazione, alle storie più antichee recenti del fenomeno immigratorio, all’esposizione diretta o menodelle frontiere ai flussi, alla collocazione geopolitica, al fabbisognoquantitativo e qualitativo di manodopera straniera, alla maggiore o mi-nore capacità inclusiva del sistema delle tutele sociali, ecc.
E anche questo spiega le difficoltà di questi anni per una politicamigratoria comune con il consenso intergovernativo unanime.
Pur attraverso queste difficoltà, è sempre più forte la consapevo-lezza dell’interdipendenza e di un interesse comune molto rilevante, co-me dimostra la recente comune assunzione di oneri e di responsabilitàdirette nel processo in atto relativo al controllo delle frontiere esterne.
In Italia solo negli ultimi anni si stanno consolidando, nelle analisidel fenomeno della nuova immigrazione, alcune convinzioni condivise- altra cosa purtroppo è la condivisione di politiche coerenti per affron-tarne i problemi:
il suo carattere strutturale per una molteplicità di fattori ben noti,demografici, economici, geopolitici, pertanto destinato a diventare unasfida di lungo periodo per l’Italia e per tutta l’Europa;
la sua dimensione, appunto, europea, per cui è obbligato il riferi-mento al ruolo dell’UE;
l’alto tasso di stabilizzazione, come indicato dalla ripetitività deipermessi di soggiorno, dalla percentuale di residenti di lunga durata,dalla elevata presenza di permessi per motivi familiari, dalla domandacrescente di ricongiungimenti familiari, dal numero crescente di matri-moni e di minori, questi ultimi con alte percentuali di inserimenti nel si-stema di istruzione e di formazione;
la sua necessità economica per lo sviluppo produttivo e per il man-tenimento dei livelli di protezione sociale in ragione del deficit e dellosquilibrio demografici, del rifiuto di certi lavori, che spesso riduce losviluppo anche dell’occupazione qualificata, delle difficoltà di reperire
21
mano d’opera nelle aree ad elevata espansione della domanda, ancheper la scarsa propensione dei giovani di aree con alti tassi di disoccupa-zione, ad una mobilità con rilevanti costi sociali.
Sono ormai constatazioni condivise nel dibattito delle opinionipubbliche europee, al di là dei diversi orientamenti sulle politiche da as-sumere; è comune la valutazione del contributo dell’immigrazione perconseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona.
Come, d’altro canto, nella valutazione del fenomeno immigratorio,è molto ampia la coscienza che non è esaustiva la considerazione dellaconvenienza economica.
Con esso si misurano valori solidaristici e di civiltà profondi neiconfronti di persone che chiedono accoglienza per trovare un lavoro,per riunire la famiglia, per sfuggire alla miseria, alla persecuzione, allaguerra e che comunque esercitano un diritto fondamentale, quello di e-migrare, riconosciuto nella Dichiarazione dei diritti umani dell’ONUdel 1948 (art. 13).
Il fenomeno immigratorio è inoltre avvertito - ma occorre un impe-gno straordinario perché cresca questa consapevolezza - come una grandeopportunità per la prospettiva di una nuova società interculturale all’altez-za delle sfide della globalizzazione e della stessa integrazione europea.
Questi sono gli aspetti da tenere assieme nell’ispirazione delle po-litiche migratorie per coniugare immigrazione e sviluppo.
Per tenere assieme esigenze economiche, valori civili e solidaristi-ci, prospettive di una società interculturale l’opinione pubblica non vaassecondata nelle paure e nei pregiudizi, nelle percezioni di una sindro-me di invasioneo di pericolo della sicurezza personale,in realtà prive,entrambe, di un riscontro oggettivo.
Occorre certo rassicurarla con una lotta efficace alla criminalitàche organizza e sfrutta la clandestinità, e con una ordinata programma-zione dei flussi coerente con le esigenze ma anche le prospettive delmercato del lavoro, ma non disgiuntamente da un forte impegno di poli-tiche di accoglienza dignitosa, da nuovi cittadini, con cui dialogare,confrontarsi, conoscersi, per assicurare le condizioni di una convivenzaordinata e civile.
A questo fine, a livello UE, oltre la comunitarizzazione in atto del
22
controllo integrato delle frontiere, lo sviluppo degli accordi UE di associa-zione per la cooperazione con i Paesi Terzi, di origine e di transito, la pro-spettiva di una gestione comunitaria dei flussi migratori, sono necessari:
- una politica estera fortemente orientata, con l’affermazione dei dirittiumani e democratici, al riequilibrio dello sviluppo dei Paesi vicini,nel Mediterraneo e ad Est, e dei Paesi del Sud del mondo,
- un quadro giuridico comune che tenga conto dei caratteri strutturalidella nuova immigrazione, escludendo precarietà di diritti e di status eassicurando una cittadinanza legale, rigorosamente fondata sui valorie principi della Costituzione Europea,
- un sostegno forte di orientamenti, di risorse, di coordinamento alle po-litiche nazionali di integrazione sociale e culturale.
Con riferimento al completamento del quadro giuridico, occorre u-na correzione dei più recenti orientamenti nazionali e comunitari, che,assumendo le inquietudini della opinione pubblica, non tengono contodei caratteri strutturali del fenomeno immigrazione, anzi presuppongo-no una “immigrazione corta”, cioè a tempo limitato, in pieno contrastocon la domanda del mondo dell’impresa e con le aspettative e i compor-tamenti di stabilizzazione degli immigrati.
La conseguenza è che le norme ispirate da questi orientamenti, su-bordinando rigidamente lo status dell’immigrato al rapporto di lavoro enegando, ad esempio, il permesso per la ricerca di lavoro, auspicatodallo stesso Parere del CESE del luglio 2001 in merito alla Comunica-zione della Commissione su una politica comunitaria in materia di im-migrazionedel novembre 2000:
- tendono ad affermare una concezione mercantile dell’immigrato (in I-talia il “permesso” di soggiorno è diventato “contratto” di soggiorno),
- indeboliscono il principio dell’equo trattamento,
- restringono e rendono più difficili le vie legali all’immigrazione,
- precarizzano la permanenza, nonché le condizioni di vita, anche nelladimensione familiare.
In questo modo è rilevante il rischio di aggravare clandestinità edirregolarità, rispetto al quale l’esasperazione della disciplina delle e-
23
spulsioni non è un antitodo efficace e soprattutto può comportare ungrave arretramento sul piano dei diritti umani, civili e costituzionali.
Lo sviluppo di un regime europeo comune in materia di asilo im-pegna in modo particolare la Presidenza italiana dell’UE sulla defini-zione di due proposte di direttiva, quella sulle condizioni da soddisfareper ottenere la qualifica di rifugiatoo di persona comunque con la ne-cessità di protezione internazionale e quella sulle procedure di ricono-scimento e revoca dello status di rifugiato.
Anch’esso deve essere liberato da quegli stessi orientamenti re-strittivi, nazionali e comunitari, che caratterizzano le più recenti norma-tive sull’immigrazione, compresa la direttiva del febbraio scorso suglistandard minimi per l’accoglienza dei richiedenti asilo.
Tanto più il diritto di asilo, diritto fondamentale di rilevanza costi-tuzionale ai livelli nazionali e dell’Unione, non deve essere trattato conle stesse riserve politiche e culturali denunciate rispetto all’immigrazio-ne, cioè con la preoccupazione dominante della lotta alla immigrazioneclandestina e all’infiltrazione terroristica, in ogni caso con la prevalentepreoccupazione, per motivi di sicurezza, di rendere il più difficile possi-bile l’accesso allo stesso diritto di asilo.
Occorre dunque un cambiamento profondo di indirizzo politico,che recuperi un giusto equilibrio tra politiche di accoglienza civile e po-litiche di sicurezza.
Sarebbe un segnale importante in questa direzione l’attenzionedella Presidenza italiana a due proposte di direttiva che saranno avanza-te nel dibattito della seconda sessione del pomeriggio, tese a comunita-rizzare tutele consolidate nell’ordinamento italiano: l’estensione dellaassistenza sanitaria a tutti i cittadini stranieri comunque presenti nel ter-ritorio dell’Unione e la previsione di un permesso di soggiorno tempo-raneo, umanitario, rinnovabile a persone che si trovano in condizioni diriduzione in schiavitù e che intendono accettare un percorso di reinseri-mento e protezione sociale.
E’ un cambiamento che esige anche un adeguato investimento dirisorse finanziarie. Esso fino ad ora, per asilo, immigrazione e frontiereesterne, pur con un forte incremento dopo il Trattato di Amsterdam, èstato decisamente insufficiente, tra lo 0,8 e lo 0,9 delle spese per le poli-
24
tiche interne dell’Unione, e per oltre il 40% destinato al Fondo Europeoper i rifugiati (FER per 2000-2004, 216 milioni), istituito nel 2000 equasi totalmente gestito dagli Stati membri, da alcuni dei quali preva-lentemente speso per il rimpatrio dei richiedenti asilo!
Non cambia questo giudizio di insufficienza, anche se si tiene pre-sente l’utilizzo degli altri strumenti comunitari di intervento come quellirelativi alla Strategia per l’occupazione, al processo di inclusione sociale,ai programmi di azione contro l’esclusione sociale e la discriminazione.
I nuovi stanziamenti già annunciati per il 2004 - 2006, come quellia sostegno delle politiche di integrazione (12 milioni di euro per il nuo-vo programma INTI), per il controllo integrato delle frontiere (140 mi-lioni), per gli accordi di cooperazione con i Paesi di origine e di transitodell’emigrazione (250 milioni) sono un passo avanti, ma ancora decisa-mente incongrui rispetto al rilievo del fenomeno immigratorio per losviluppo economico, la coesione sociale, la politica di cooperazionedell’Unione.
Infine, il riequilibrio politico dell’iniziativa dell’Unione ha il suoterreno decisivo nel promuovere con misure comunitarie - “incentivaree sostenere” recita la Costituzione Europea - le politiche di integrazionesociale di competenza degli Stati membri.
Come si è già detto, esse sono la vera priorità per ridurre i fenome-ni indesiderati, in una certa misura ineludibili, evitare le tensioni e iconflitti sociali.
Occorre aggiornare e rafforzare il programma contenuto nella Co-municazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeodel luglio 2001 la quale prevedeva, con decorrenza 2002 purtroppo di-sattesa, la pratica di un “metodo aperto di coordinamento” della politi-ca comunitaria in materia di immigrazione (coordinamento delle politi-che nazionali, - scambio delle migliori prassi, - controllo e valutazionedell’impatto della politica comunitaria) sulla base di orientamenti plu-riennali dell’Unione con obiettivi a breve, medio, lungo termine, da re-cepire nei piani nazionali in modo da tenere presente le diversità deisingoli Paesi.
E’ l’obiettivo riproposto con forza dalla Commissione con la Co-municazione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Econo-
25
mico e Sociale e al Comitato delle Regioni su Immigrazione, Integra-zione e Occupazione, del 3 giugno 2003, prima del Consiglio di Salo-nicco con la conclusione della Presidenza greca.
E’ un percorso difficile che può avere un punto di forza nel riferi-mento al quadro giuridico comunitario quanto più esso attua l’equotrattamento,ma deve comunque misurarsi con concezioni diverse di so-cietà, con modelli differenti di integrazione sociale come si sono venutideterminando storicamente nelle diverse esperienze nazionali.
Nell’Unione si misurano diversi modelli di accoglienza, agli estre-mi quella con assimilazione e quella senza integrazione; la via italiana èforse la più complessa. Nella prima sessione dei nostri lavori vi sarà unconfronto tra i protagonisti di queste politiche certamente importanteper chiarire le prospettive.
L’ordinamento italiano che disciplina l’immigrazione ha, a questoriguardo, due punti forti: il riconoscimento della parità dei diritti civili esociali al cittadino immigrato regolarmente residente e la centralità del-la promozione territoriale delle politiche di integrazione da parte di Re-gioni ed Enti locali.
Il modello di integrazioneè individuato come un processo conti-nuo di confronto e di reciproca contaminazione culturale nel rispettodelle diversità, compatibili con i principi fondamentali della nostra Co-stituzione. Certo è un processo difficile che oltretutto in questo momen-to, come si diceva, si colloca per gli italiani dentro grandi tensioni sullaquestione dell’identità tra globalizzazione, integrazione europea, Statonazionale, realtà locale.
Da anni in Italia vi è una ricca esperienza di iniziative a favoredell’integrazione, grazie alla sensibilità solidaristica di istituzioni, asso-ciazioni, popolazioni, che è poi quella che ha fatto maturare molte scel-te avanzate, contenute nell’ordinamento del ‘98. Il passaggio dalle pra-tiche solidaristiche ad una politica organica di integrazione nel territorio- il salto di qualità richiesto dall’ordinamento - è un processo difficilesia per le incertezze dei nuovi interventi legislativi sia per il venire me-no della spinta di una politica nazionale.
Una “politica organica”, nel quadro dell’ordinamento italiano, si-gnifica la assunzione dei problemi dei cittadini stranieri regolarmente
26
residenti, alla pari di quelli di tutti gli altri cittadini, nelle politiche loca-li generali e settoriali: abitazione, sanità, scuola, politiche del lavoro,assistenza socio - economica, attività culturali.
Le maggiori difficoltà che il cittadino straniero deve affrontare perl’accesso ai diritti e per l’inserimento sociale, richiedono inoltre politi-che attive di compensazione.
Per una politica organica, pertanto, sono necessari, oltre un servi-zio di osservazione, quantitativa e qualitativa, del fenomeno immigrato-rio nel territorio, anche con indici di inserimento sociale condivisi, unaprogrammazione regionale, provinciale, comunale, annuale e plurienna-le, di interventi mirati,con congrui investimenti finanziari, da monito-rare e verificare nei risultati, per assicurare ai cittadini immigrati pariopportunità con i cittadini italiani in eguale condizione sociale, una par-ticolare valorizzazione a questo fine dell’apporto dell’associazionismosociale, non autoreferenziale ma nel quadro della programmazione pub-blica, secondo il principio di sussidiarietà.
Gli interventi mirati sono quelli relativi al sistema di informazione edi comunicazione, alle misure che facilitino l’accesso ai servizi pubblici edel privato sociale, con un loro riposizionamento organizzativo (dalla for-mazione degli operatori all’impiego dei mediatori culturali, all’integra-zione degli sportelli e alla semplificazione amministrativa), alla promo-zione della conoscenza delle lingue e delle culture dei Paesi di origine.
Negli interventi mirati una particolare attenzione è da rivolgere al-le donne che sono ormai quasi la metà delle persone immigrate e posso-no subire una doppia discriminazione, legata al genere e all’origine e-tnica. Oltretutto la qualità della loro integrazione ha una grande impor-tanza per il ruolo che esse rivestono nella famiglia rispetto alla media-zione tra le culture tradizionali e ospitanti e all’influenza sulle genera-zioni future.
Là dove ritarda questo passaggio dalle iniziative di solidarietà allapolitica di integrazione il rischio è che l’azione pubblica e privata restifrantumata, appiattita sull’emergenza - assistenza e ad una visione pau-peristica che non risponde ai nuovi dati reali del fenomeno immigrazio-ne, con una crescita continua, soprattutto nel centro e nel nord, di inse-rimenti lavorativi, di insediamenti familiari, di stabilizzazione.
27
Le realtà locali che avanzano con maggiore efficacia in una politi-ca organica di integrazione sociale, sono quelle impegnate dalla concer-tazione socialesu obiettivi condivisi (Patti sociali e Tavoli permanenti)e che si avvalgono, nella programmazione e nella progettazione, dellacollaborazione interistituzionaleper realizzare interventi che si integra-no: l’immigrato dalla frantumazione delle diverse istanze sociali diven-ta una persona, una persona con una famiglia, un cittadino da accompa-gnare e sostenere in un percorso di inserimento sociale e di partecipa-zione alla vita pubblica.
Ma una terza condizione di efficacia, la più importante, è la parte-cipazione dei cittadini stranieri.Le politiche di integrazione per loronatura non possono essere progettate unilateralmente.
E’ il problema della loro rappresentanza, della sua natura, delle se-di in cui si esplica, del modo in cui bisogni, interessi, opinioni dei citta-dini stranieri regolarmente soggiornanti trovano espressione e possibili-tà di risposta.
E’ innanzitutto la questione irrisolta della rappresentanza politica:il riconoscimento ai residenti di lunga durata almeno del diritto al votoamministrativo, come già avvenuto in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi,Svezia e Finlandia, dovrebbe essere un punto prioritario su cui mobili-tare l’attenzione politica, per quello che abbiamo indicato come il rie-quilibrio delle politiche migratorie.
D’altro canto solo in alcune realtà territoriali esemplari, le istitu-zioni hanno attivato sperimentazioni di rappresentanze elettive collega-te alle Assemblee locali e vi è un impegno adeguato di promozione esostegno dell’associazionismo degli stranieri, con messa a disposizionedi sedi, contributi finanziari, assistenza tecnica.
A queste associazioni viene affidata la gestione di progetti di inte-grazione, quando riguardano le iniziative culturali, educative e sociali,che rispondono all’obiettivo del mantenimento dell’identità culturale edel processo interculturale, e che, prima ancora, sono la condizione diaccesso reale, attraverso la mediazione linguistico culturale, ai serviziamministrativi e a quelli sociali, come la scuola e la sanità.
Sono dunque le Autonomie e le Comunità locali i protagonisti del-le sfide dell’integrazione, la risorsa strategica, per una risposta efficace
28
alla nuova complessità della coesione sociale nell’impatto difficile conl’immigrazione.
Certo ogni Paese ha un suo modello di integrazione sociale, le po-litiche di integrazione sono pertanto di competenza degli Stati, il coor-dinamento aperto da parte dell’Unione socializzerà le buone pratiche,rafforzerà la loro promozione, ne sosterrà lo sviluppo, segnando, in unaesperienza così incisiva sulla vita personale e collettiva di tutti i cittadi-ni dell’Unione, il più complessivo processo di integrazione europea.
Sulle politiche di integrazione sociale e culturale degli immigratisi giocano dunque diverse sfide:
- la creazione di condizioni per una convivenza civile ordinata, senzaintolleranze e discriminazioni, fondata sui valori fondamentali, demo-cratici e costituzionali, e rispettosa delle diversità culturali che sonouna ricchezza dell’immigrazione;
- un processo che contribuisce a quello più generale, nello sviluppo del-l’Unione, dell’integrazione tra le molteplici società degli Stati nazio-nali europei;
- la credibilità di una idea di Europa, come ora è scritta nella Costitu-zione, della libertà, della giustizia, della solidarietà, della democrazia,che diventa realtà anche per milioni di immigrati che vi hanno trovatoun lavoro, vi crescono i loro figli, ne rispettano le leggi.
Riteniamo che la credibilità di questa Europa deve avere un ri-scontro anche nel contributo dell’Unione al consolidamento e al raffor-zamento del quadro giuridico internazionale, finalmente con la ratifica
- sia della Convenzione ONU del dicembre 1990 sui diritti degli immi-grati e delle loro famiglieentrata in vigore il 1° luglio di quest’anno,
- sia, come dalla recente proposta della Commissione Europea al Consi-glio, della Convenzione ONU contro il crimine internazionale con ilprotocollo sulla prevenzione, la soppressione e la repressione deltraffico di persone, in particolare donne e bambini, e il protocollocontro il traffico di migranti, entrata in vigore il 29 settembre scorso.
29
COMUNICAZIONE
L’OPINIONE PUBBLICA EUROPEA DI FRONTE ALL’ IMMIGRAZIONE
ILVIO DIAMANTI
Docente di Sociologia all’Università di Urbino
1. Le principali indagini sugli orientamenti dei cittadini sui temidell’immigrazione e della cittadinanza, condotte negli ultimi anni sotto-lineano come sia in atto una tendenza all’europeizzazione degli atteggia-menti sociali su questo argomento. L’opinione pubblica dei principaliStati europei, cioè, delinea orientamenti sempre più simili, fra un Paese el’altro, in merito al fenomeno migratorio. Si tratta di un processo ali-mentato dalla paura, in quanto si assiste a un peggioramento generaliz-zato del clima sociale, che risulta dovunque più ostile. L’immigrazione,infatti, si presenta sempre più come un problema, piuttosto che come unfenomeno sociale da integrare; inoltre, la preoccupazione dei cittadininei confronti degli immigrati risulta tanto più cresciuta nei Paesi dove inprecedenza risultava meno forte e diffusa. Possiamo, per questo parlaredi una sorta di “integrazione europea” nel segno della paura, utile a sot-tolineare i rischi prodotti da un processo, come l’immigrazione, non go-vernato in modo coerente, oppure affrontato in modo frammentario,Paese per Paese. Mentre l’apertura delle frontiere, la convergenza delmercato del lavoro e delle economie nazionali, la prospettiva dell’allar-gamento rendono sempre più difficile e contraddittorio il disegno di “na-zionalizzare” le politiche e le normative dell’immigrazione.
30
2. Se questa è la tendenza che si osserva negli ultimi anni, si deveaggiungere che nella fase più recente assistiamo a una ulteriore accele-razione. Si osserva, cioè, l’accentuarsi sensibile dei timori sollevati dal-l’immigrazione, soprattutto nei Paesi in cui il fenomeno suscitava, qual-che anno fa, reazioni meno accese.
Nel complesso (indagine Fondazione Nord-Est, 2002), più di uncittadino su quattro, in Europa, vede nell’immigrazione una minacciaalla cultura e all’identità nazionale, e circa il 36% come una minacciasia all’occupazione che all’ordine pubblico. Peraltro, le preoccupazionicirca la sicurezza personale costituiscono l’orientamento che ha regi-strato il maggiore incremento, nell’ultimo periodo.
La Germania, la Francia e soprattutto la Spagna sono i paesi in cuiqueste tendenze si sono manifestate con maggiore intensità. Al contra-rio, l’Italia è l’unico paese che ha fatto osservare un ridimensionamentodelle paure. In tutte le direzioni. Non è più la “penisola delle paure”.Anche se, ovviamente, le inquietudini permangono.
E’ difficile individuare un’unica, specifica linea interpretativa difronte a tendenze tanto differenziate, su base nazionale. L’unico indiriz-zo comune a questi fenomeni, infatti, appare l’avvicinamento reciprocodelle opinioni pubbliche nazionali, sollecitato dalla pressione emotivanei paesi in cui il rapporto con l’immigrazione poneva meno problemi.
3. Tuttavia, vi sono almeno tre ordini di avvenimenti fatti che con-corrono a chiarire, almeno in parte, questa evoluzione dei sentimenti.
a. Gli effetti psicologici e sociali dell’emergenza internazionale inne-scata dall’attacco alle Torri Gemelle e ai conseguenti intervento mili-tari prima in Afghanistan poi, nei mesi scorsi, in Iraq.
b. La prospettiva, prossima, dell’allargamento dell’Unione ad altri Paesi.
c. Il percorso della costruzione europea, che vive una fase cruciale: dopol’avvio dell’euro, grazie alla definizione di una Costituzione Europea.
L’emergenza internazionale, in particolare, ha alimentato fra i cit-tadini una domanda di sicurezza e di “chiusura” nei confronti dell’ester-no, alimentando, in particolare, il sospetto nei confronti delle popola-zioni arabe e da quelle provenienti dal Medio-Oriente. Al contempo,l’incertezza internazionale ha depresso l’andamento dei mercati e com-
31
plicato i problemi dell’occupazione, contribuendo a far percepire comeuna “minaccia”, per le componenti di lavoratori più marginali, l’arrivodi nuovi immigrati.
La prospettiva dell’allargamento, a sua volta, ha accentuato il ti-more che i flussi migratori aumentino, ma ha anche alimentato, soprat-tutto in alcuni paesi, la preoccupazione di vedere ridotte le risorse ac-quisite in sede comunitaria (un atteggiamento che appare particolar-mente diffuso da reazioni registrate in Spagna, che ha ampiamente edefficacemente utilizzato i fondi strutturali della UE).
Infine, i passi che sono stati mossi verso l’integrazione europeahanno aumentato l’attenzione verso l’obiettivo di affermare valori e i-stituzioni comuni.
La diversa natura di questi fattori spiega la trama contrastante delclima d’opinione che osserviamo nei diversi Paesi della UE. In partico-lare, chiarisce, almeno in parte, il contrappunto fra l’inquietudine, cre-scente, suscitata dall’immigrazione; e il favore, cresciuto, seppure inmodo moderato, nei confronti dell’allargamento della UE e della cresci-ta dei poteri comunitari, anche su questa materia.
Tuttavia, più degli altri anni appare chiaro come la convergenzadei processi in atto in Europa sia la risultante di percorsi specifici e di-versi nei diversi paesi.
4. L’emergenza internazionale, comunque, spiega forse meglio dialtri fattori il mutamento del clima d’opinione verso gli “stranieri”, de-finiti in base alla provenienza geografica. La sfiducia, infatti, tende aconcentrarsi in una direzione specifica: gli “arabi”. Mentre, in parallelo,l’atteggiamento verso le altre popolazioni europee, i Balcani, l’Europacentro-orientale, appare più favorevole rispetto agli anni scorsi, quandol’impatto dei conflitti nell’ex Yugoslavia era ancora molto significativo.D’altronde, a distendere il clima d’opinione in questa direzione ha con-tribuito anche il processo di allargamento.
L’incombere della crisi internazionale, l’integrazione monetariaeuropea, peraltro, contribuiscono alle preoccupazioni di ordine econo-mico e occupazionale che turbano, soprattutto, il Paese che si pone alcentro della UE: la Germania. Mentre le difficoltà e le critiche che e-mergono nei confronti della Costituzione Europea e della costruzione di
32
un’Europa politica spiegano il raffreddarsi ulteriore degli atteggiamentiin paesi che attribuiscono un significato particolarmente forte all’identi-tà e alla sovranità nazionale, come la Francia.
L’unico Paese a fare registrare un peggioramento sensibile del cli-ma d’opinione, in modo generalizzato è, comunque, la Spagna. Che,probabilmente, cumula diversi motivi di tensione. Oltre al timore deglisvantaggi che le potrebbero derivare dall’allargamento, anche una cre-scita elevata dei flussi migratori, provenienti dal Nord Africa.
L’apertura sul tema dei diritti di cittadinanza politica, segnalata dallaconcessione del diritto di voto alle amministrative, conferma un atteggia-mento di grande disponibilità. I due terzi dei cittadini esprimono, a questoproposito, un accordo senza pregiudizi e senza limitazioni. Tuttavia, que-sta posizione universalista registra un lieve arretramento, a favore diquella di chi pensa opportuno circoscrivere questo diritto ai soli stranieriche provengono dalla UE (un diritto, peraltro, già previsto).
Anche questo, tuttavia, è un segnale interessante, che testimonia u-na crescente domanda di integrazione europea. Una crescente fiducianel processo di unificazione in atto in Europa.
L’indagine ne fornisce una significativa conferma, attraverso ilmaggiore appoggio all’allargamento che si registra rispetto l’anno scorso.Tuttavia, nell’assieme dei Paesi, il sostegno incondizionato e convinto al-l’allargamento resta circoscritto a meno di un terzo degli intervistati subase europea (cui si deve associare un altro 18% che considera l’ipotesinecessaria, ma svantaggiosa). Non solo per le note riserve della Germa-nia, ma per il ridotto consenso che si registra in un paese-chiave dellaUE, la Francia; e per il crollo, già segnalato, che si osserva in Spagna.
5. E’, quindi, evidente che l’immigrazione mette in luce le diffe-renze nazionali e i diversi modi di concepire il processo di integrazione.
Così, l’ipotesi di rafforzare i poteri della UE in materia di immi-grazione incontra il consenso di un terzo dei cittadini; una quota nontroppo superiore a quella di coloro che vorrebbero ridotte le competen-ze della UE.
Luci e ombre. Che sottolineano come l’immigrazione venga perce-pita dai cittadini seguendo diverse logiche, diversi approcci a un feno-
33
meno comune a tutti.
Oggi, in particolare, registriamo tre tipi di atteggiamenti verso gliimmigrati, la cittadinanza, l’Europa.
In Italia e in Spagna si associano atteggiamenti di timore sostan-zialmente “moderato”, verso gli immigrati, a un’apertura elevata in ma-teria di cittadinanza politica e a una domanda rilevante che i poteri dellaUE in materia crescano.
Francia e Germania, l’asse del processo di integrazione, hanno vi-sto crescere i timori nei confronti degli immigrati, mantengono un ap-proccio alla concessione della cittadinanza politica che privilegia le po-polazioni che vivono nei confini dell’Unione e valutano con una certadiffidenza l’accentuarsi ulteriore dei poteri dell’Unione in proposito.
La Gran Bretagna, infine, conferma il modello che ne definisce lasocietà - al pari della classe dirigente - tradizionalmente più esterna eprudente rispetto agli orientamenti espressi nella UE. In particolare,nell’opinione pubblica il timore verso gli immigrati resta alto (soprat-tutto per la preoccupazione sui temi dell’occupazione e dell’identità re-ligiosa), mentre l’atteggiamento verso la cittadinanza politica e versol’aumento dei poteri della UE è inferiore alla media europea, ma nontroppo.
Si tratta di uno schema che può apparire perfino prevedibile. Ri-calca il diverso ruolo giocato in Europa, il diverso peso dell’immigra-zione. Il modello mediterraneo (Italia e Spagna), il nocciolo duro dellaUE (Francia e Germania), il battitore libero, ponte fra fedeltà europea eatlantica (la Gran Bretagna).
Ma, peraltro, si tratta di un modello fluido, in ulteriore evoluzione.Che potrebbe cambiare profondamente nei prossimi anni.
Un discorso a parte meritano i Paesi che verranno coinvoltinell’allargamento.
Le indagini condotte in questi Paesi sottolineano come si tratti dicontesti le cui società percepiscono l’immigrazione con tensione epreoccupazione superiori rispetto a ciò che si registra nei Paesi membridella UE, anche se il fenomeno migratorio appare, per loro, ancora di li-mitata entità. Ciò avviene perché si tratta di sistemi istituzionali ancoranon consolidati, che vivono, per questo, con incertezza la questione dei
34
rapporti con i paesi confinanti e, più in generale, il problema del gover-no della società e del territorio. Il che conferma come l’atteggiamentoverso gli immigrati più che riflettere la dinamica e la dimensione ogget-tiva della realtà, riassume molti altri problemi, che attengono al rappor-to fra i cittadini, la politica e le istituzioni.
6. Possiamo trarre da questa sintetica lettura alcune indicazioni difondo.
La prima di segno generale. L’immigrazione è uno dei test più im-portanti per l’Europa. Ne mette alla prova i sistemi di integrazione na-zionali, a livello socioculturale e istituzionale; ma, ancor di più, ne sfidala capacità riaffermare un modello comune e unitario. Negli ultimi anni,comunque, ha influenzato con forza i sentimenti della società, gli orien-tamenti politici, i riferimenti istituzionali dei diversi Paesi e dell’Unio-ne. Continuerà così anche nei prossimi anni.
La seconda, riguarda il prossimo futuro. Collega la questione del-l’immigrazione a quella dell’allargamento. Destinate a influenzarsi reci-procamente. Nel senso che l’allargamento, se governato adeguatamen-te, può normalizzare il rapporto delle società nazionali con il fenomenomigratorio. Ma può avvenire l’inverso; che agisca da detonatore. Cosìcome può avvenire che un clima di opinione drammatizzato costituiscaun fattore di freno nei confronti dell’allargamento e della costruzioneeuropea.
Infine, c’è il problema della costruzione politica dell’Europa. Leprincipali indagini condotte dimostrano come ci sia un rapporto strettotra la fiducia nell’Unione Europea e nel rafforzamento delle istituzionicomunitarie, da un lato, e la percezione dell’immigrazione, dall’altro.Tanto più è forte la preoccupazione, tanto più è ostile l’atteggiamentoverso gli immigrati, tanto più è elevato il distacco dall’Unione, tantopiù è estesa la diffidenza verso l’allargamento.
Il che accentua la convinzione che affrontare gli obiettivi della co-struzione e dell’integrazione europea non è cosa diversa dall’affrontareil fenomeno migratorio; si tratta di facce del medesimo problema.
35
INTERVENTI
JOAQUIM NUÑES DE ALMEIDA
Gabinetto del Commissario Europeo per la Giustizia e gli Affari Internidella Commissione Europea
Ringrazio per l’invito il CNEL. È sempre difficile stabilire da do-ve cominciare a parlare in materia di immigrazione, cominciare dal-l’immigrazione illegale, da quella legale, o cominciare dalle politiche dilotta alla criminalità.
Dal 2000 la Commissione Europea ha cercato di avere una politica diimmigrazione legale, cioè di non parlare solo di chiusura delle frontiereperché non abbiamo bisogno di migranti e accettiamo solo quelli che ven-gono per l’asilo, per motivi umanitari, ma chiudere con questo discorso del-l’Europa che non ha bisogno di migranti. Noi, al contrario, crediamo chel’evoluzione demografica ed economica dimostri che c’è un bisogno di im-migrazione legale, dunque una politica di contrasto totale all’immigrazioneè, non solo disumana, ma anche o soprattutto contraria ai nostri interessi.
Spesso si stabilisce un legame tra immigrazione e disoccupazione,dicendo che non ci può essere più immigrazione perché c’è tanta disoccu-pazione, ma gli studi che abbiamo a nostra disposizione dimostrano chenon c’è praticamente nessun legame fra l’una e l’altra cosa, in quanto gliimmigrati vengono a fare quello che, o gli europei non sanno fare, o quelloche gli europei non vogliono fare, sia perché hanno una famiglia ed un si-
36
stema di sicurezza sociale che permette loro di non scegliere lavori checonsiderano come troppo sgradevoli, o perché semplicemente non si puòtrasformare un disoccupato in un esperto informatico, in un ingegnere o inun medico. Per questo l’Europa ha tanto bisogno di immigrazione di altolivello, come di immigrazione non qualificata.
Con tutto questo non voglio sostenere che la Commissione Europeadifenda il diritto “all’immigrazione economica”, c’è sicuramente un dirittoall’asilo, per motivi di persecuzione, riconosciuto dalla Convenzione diGinevra ed è quella la politica che la Commissione persegue nel cercare diarmonizzare gli ordinamenti giuridici europei, ma non siamo ancora al li-vello del riconoscimento di un diritto “all’immigrazione economica”.
Crediamo che l’immigrazione sia un’opportunità, che ci debbanoessere vie legali, che l’Europa debba vedersi un po’ come si vedono gliStati Uniti, l’Australia o il Canada, Paesi in cui le persone che lì voglio-no recarsi per lavorare devono andare al Consolato, devono dire cosaintendono fare, quali esperienze hanno, eccetera, piuttosto che mettersinelle mani di trafficanti per arrivare in Europa pagando cifre di 2000euro o più, per assicurarsi anni e anni di lavoro clandestino.
E nemmeno però voglio sostenere che l’immigrazione sia una pa-nacea. Il Commissario Vitorino dice spesso che l’immigrazione non èné un problema, né una panacea, ma una realtà che bisogna gestire.
Si dice, ad esempio, che sarà l’immigrazione a frenare l’evoluzionedemografica. Io penso che forse la ritarderà, ma l’inversione della piramidedemografica succederà anche con l’immigrazione, perché i migranti, primao poi, adottano i comportamenti di fertilità degli europei e per questo, almassimo, l’immigrazione aiuterà solo a ritardare il calo demografico.
Inoltre bisogna considerare il fatto che l’immigrazione, ai nostri tem-pi, significa accedere a delle società in cui la cittadinanza e l’esistenza diuna persona comportano anche tutta una serie di costi. Ciò vuol dire che a-vremo più persone che studieranno nelle nostre scuole, che utilizzeranno inostri ospedali, che usufruiranno dei servizi sociali, perché abbiamo dei li-velli di diritti socioeconomici sicuramente molto più alti di tutto il restodel mondo, perciò l’accoglienza di più persone significherà anche affron-tare questo aspetto da mettere nel computo globale.
Spesso crediamo anche che i politici perdano delle opportunità di
37
parlare dell’immigrazione come di un arricchimento culturale e anchecome una dimostrazione del successo delle nostre società, per cui lepersone emigrano in posti in cui le cose vanno bene, perché nessunopensa oggi di migrare in Argentina, in Congo o in Angola e dunque, sele persone vengono in Europa, è perché forse c’è qualcosa di buono inEuropa, perciò è anche una misura del nostro successo. Questo aspettoè spesso poco messo in evidenza mentre ho parlato con canadesi che sipreoccupano del fatto che l’immigrazione in Canada vada tutta a Toron-to, Montreal, Vancouver, e sarò contento il giorno in cui vedrò sindacieuropei preoccupati per il fatto che le loro città hanno pochi migranti.
Gli studi economici a nostra disposizione dimostrano che gli effet-ti sui salari e sull’occupazione dell’immigrazione è, nella peggiore delleipotesi, anodino, cioè non fa né abbassare i salari, né abbassare l’occu-pazione. Non sarà forse una panacea, né sarà lo strumento che ci porte-rà alla crescita, ma non è sicuramente negativo.
Dal punto di vista culturale, il Commissario Vitorino mette spessoin evidenza che da parte nostra, da parte delle nostre classi politiche, bi-sognerebbe fare più opera di pedagogia nell’accettare una maggiore di-versità nelle nostre società. È chiaro che le nostre società saranno menoomogenee e compatte nel futuro di quanto non siano state sino ad ora.Ma anche, dobbiamo dirlo, occorre chiedere da parte delle popolazionimigranti un rispetto per i nostri principi e valori costituzionali fonda-mentali. In altri termini serve un contratto: noi dobbiamo accettare lediversità, loro devono accettare i nostri valori fondamentali.
Devo dire, in proposito, e non lo faccio perché sono davanti ad unpubblico italiano, che in Italia comunque c’è sempre stato un discorsoabbastanza lodevole sull’inevitabilità e la necessità di una corrente diimmigrazione legale. Nel vostro Paese si accetta l’idea dell’immigra-zione legale con molti meno tabù - potete esserne sicuri - di quello chesuccede in altri Paesi dell’Unione Europea.
Siamo preoccupati per lo stato di negoziato di alcuni dei nostristrumenti legislativi. Sull’asilo c’è effettivamente un ritardo sul pro-gramma e ci aspettiamo molto dalla Presidenza italiana, soprattutto dal-la direttiva per uniformare le procedure di asilo e il concetto di asilo.
In più ci convinciamo, alla Commissione Europea, che l’immigra-zione sia anche un discorso che deve rientrare nel quadro normale deinostri rapporti internazionali con il resto del mondo. È difficile, cioè,
38
gestire l’immigrazione in modo unilaterale. In questo senso ci è sem-brata particolarmente interessante l’idea, posta in discussione dal Go-verno italiano, di parlare di quote di immigrazione da offrire ai paesiterzi in cambio della firma di accordi di riammissione degli immigratiillegali, perché, come vi ho detto prima, noi vediamo “l’immigrazioneeconomica” come un diritto, come un’opportunità, come una strada chedeve essere aperta, il che non vuol dire la porta aperta a tutti. Perciò ef-fettivamente crediamo di dover avere il controllo sulle persone che en-trano nel nostro territorio, quelle che ci sono illegalmente devono esseremandate via se non hanno diritto alla protezione internazionale secondola Convenzione di Ginevra o altri strumenti di diritto internazionale.
In questo senso sembra un’idea interessante, quella ammessa dalGoverno italiano, di firmare accordi di riammissione con Paesi Terzi incambio di quote di immigrazione legale. Dobbiamo entrare in un di-scorso bilaterale con i Paesi partner che ci aiuteranno a combattere i fe-nomeni della criminalità e dell’immigrazione clandestina di fronte allaquale spesso chiudono gli occhi, in cambio di, o quote di immigrazionelegale, o di facilitazioni dei visti per i visitatori legali.
Noi in Europa non possiamo renderci conto dell’importanza cultu-rale che ha per i paesi terzi la difficoltà, di questi tempi, di procurarsi unvisto Shengen per venire in Europa, le code che si devono fare, le do-mande! Anche professori universitari che devono venire per una Confe-renza, devono programmare una visita con due tre settimane di anticipoe tutto questo ha un effetto psicologico grandissimo sui Paesi con cuivogliamo avere un partenariato.
E anche un aiuto al rimpatrio degli illegali per aiutarli a reintegrar-si nelle società di provenienza o anche di rinvio al Paese da dove pro-vengono, perché spesso i Paesi con cui dialoghiamo con l’immigrazio-ne illegale sono soprattutto Paesi di transito, specie quelli intorno alMediterraneo. È una falsa idea pensare che continuino a venire così tan-te persone originarie, ad esempio, del Marocco o della Turchia, in Euro-pa. Questi Paesi sono diventati soprattutto Paesi di transito di personeche vengono da altre parti del mondo.
E’ necessario aiutare, anche nel nostro interesse, i paesi più poverinell’accoglienza dei rifugiati, perché, anche se in Europa si parla tantissi-mo dei problemi posti dall’asilo, la maggior parte della popolazione rifu-giata al mondo rimane nelle regioni di origine, vicina alle aree di conflitto.
39
Sulla futura Costituzione Europea. È vero che, in materia di inte-grazione, crediamo debba rimanere competenza nazionale e, a mio av-viso, più che nazionale quasi locale - la vedo piuttosto come una politi-ca che funziona a livello di municipio, di regione - ma sicuramente nonè a Bruxelles che si può decidere quale sia la politica di integrazioneche funziona bene nelle tanto diverse società europee.
Noi possiamo indicare, come abbiamo fatto, qualche strumento dicarattere costituzionale, come la direttiva sul ricongiungimento familia-re o sui diritti e gli obblighi dei cittadini di Paesi Terzi. Promuoveremo,a livello europeo, lo scambio di esperienze sull’integrazione perchéspesso c’è questa idea che l’integrazione degli immigrati in Europa fun-zioni malissimo. Da un lato, la stampa parla sempre più di quello che vamale e non di quello che va bene, ma spesso sento parlare di progetti edi situazioni in cui, se vogliamo vedere le cose da un certo punto di vi-sta, l’integrazione degli immigrati nelle società europee negli ultimiventi o trenta anni è stata piuttosto un successo. Forse alcuni, che inve-ce la vedono come un insuccesso, hanno semplicemente difficoltà adaccettare il fatto che le loro società siano diventate più diverse.
Una parola finale sul controllo della frontiera comune. Anche quisono stati fatti passi avanti sotto la Presidenza italiana. Sin qui il princi-pio Shengen per cui ogni Paese controllava il suo pezzo di frontiera e-sterna per tutti gli altri, adesso si sviluppa il concetto, che verrà anchepromosso dalla futura Costituzione, del controllo comune della frontie-ra comune. Il che non vuol dire che ci sarà una polizia comune di fron-tiera - l’idea sarebbe ancora troppo avveniristica - ma la CommissioneEuropea avanzerà l’idea di una Agenzia per il controllo della frontieraesterna. C’è un consenso fra i quindici attuali Stati membri e un grandeappoggio del Governo italiano che farà la formazione delle guardie difrontiera, l’analisi dei rischi e la messa a disposizione di materiale cheaiuta a controllare la frontiera e che potrà anche utilizzare mezzi persorvegliare i punti più deboli o per promuovere operazioni di rimpatrio.
Ho cercato di fare una panoramica delle politiche che promuovia-mo a livello europeo, sperando di darvi l’idea di una politica bilanciatache tratta di immigrazione legale, di asilo, ma anche di immigrazione il-legale, di questioni di sicurezza e di protezione delle frontiere.
40
LIVIA TURCO
Deputata dei Democratici di Sinistra
Il nostro Paese, l’Italia, ha una particolare e grande responsabilitàche deriva dalla sua storia e dalla sua collocazione geografica: far vive-re in questo Terzo Millennio la tensione universalistica della culturaMediterranea. Il Mediterraneo è stato ed è luogo centrale dell’umanitàponte tra Oriente ed Occidente, tra Nord e Sud.
Il carattere distintivo della cultura Mediterranea resta la vocazioneuniversalistica, la capacità di fondere e far convivere tradizioni di pen-siero e pratiche quotidiane di vite diverse, originariamente eterogeneeed anche contrapposte.
Far vivere in questo nostro tempo la tensione universalistica dellacultura Mediterranea significa collocare in modo preciso il ruolo del-l’Europa: aperta ad Oriente, costruttrice di cooperazione, di dialogo, dipace.
Il modo con cui l’Italia e l’Europa governano i flussi migratori ènon solo parte integrante ma banco di prova delle loro capacità e volon-tà di costruire un’effettiva politica di pace e cooperazione.
Perché, se vogliamo rendere concrete queste promesse di pace e dicooperazione dell’Europa, molto dipende dalla cultura e dall’approcciocon cui vengono gestiti i flussi migratori. Perché flussi migratori vuoldire non solo mercato ma persone, Paesi, culture, società.
41
Ed allora un Europa fortezza, preoccupata solo di difendersi daiflussi migratori non sarà un attore reale di politiche di pace e di coope-razione.
Per questo abbiamo salutato con grande favore le conclusioni delConsiglio Europeo di Salonicco, che correggendo Siviglia, rilancia gliorientamenti definiti a Tampere, cui molto fattivamente avevano colla-borato i governi dell’Ulivo.
E’ importante che il vertice di Salonicco abbia rilanciato comepriorità l’attenzione del programma approvato a Tampere. In particolareabbia collocato la politica dell’immigrazione nell’ambito delle relazionicon i Paesi Terzi, e dunque all’interno della politica estera. E’ impor-tante inoltre che abbia rilanciato e reso operativo il concetto della coo-perazione rafforzata tra i Paesi dell’Unione nel Governo dei flussi mi-gratori, soprattutto nella lotta alla criminalità e nel contrasto dell’immi-grazione clandestina.
Punto focale del Vertice di Tampere fu, appunto, la definizione diun approccio delle politiche di controllo basato sulla cooperazione con iPaesi d’origine e di transito e sulla concessione di contropartite specifi-che sotto forma di: sostegno tecnico e finanziario agli interventi di con-trollo di tali paesi e di un trattamento privilegiato in materia di ammis-sione (quote riservate all’interno dei decreti flussi).
Con il Consiglio di Salonicco scompare del tutto l’idea di “coope-razione condizionata” avanzata a Siviglia, riconducendo il partenariatocon i Paesi Terzi a una logica di collaborazione integrata e le politichedi integrazione vengono ricollocate allo stesso livello di priorità dellepolitiche di controllo.
Inoltre, dopo la ormai consueta, quasi rituale, “riaffermazione deiprincipi di Tampere”, il Consiglio definisce le direttive in materia di ri-congiungimento familiare e di status dei soggiornanti di lungo periodo“str umenti essenziali per l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi” e“sottolinea l’esigenza di ricercare mezzi legali per l’ingresso di cittadi-ni di Paesi Terzi nell’Unione”, aggiungendo che “Il successo di talepolitica di integrazione dipende dal coinvolgimento efficace di tutti gliattori possibili. Gli organi competenti dell’Unione Europea, le autoritànazionali e locali, i sindacati, le associazioni dei datori di lavoro, le or-
42
ganizzazioni non governative, le organizzazioni di migranti e le orga-nizzazioni che perseguono scopi culturali, sociali e sportivi dovrebberoessere incoraggiati a partecipare allo sforzo comune a livello di Unio-ne e a livello nazionale”.
Si ripropone, insomma, in coerenza con le priorità pronunciatedalla Presidenza Greca, quell’approccio integrato e aperto da un lato al-l’integrazione con le relazioni esterne dell’Unione e dall’altro al dialo-go sociale e civile auspicato dalla Commissione, dal Parlamento e dallaSocietà civile.
Dopo 4 mesi di Presidenza italiana abbiamo il dovere, soprattuttoin questa sede, di verificare se si stanno attuando questo indirizzo equeste priorità.
Per quanto riguarda le politiche di controllo e di ammissione noisosteniamo l’azione del Governo italiano finalizzata ad ottenere formedi condivisione dei costi connessi al controllo delle frontiere comuni,perché conforme al nostro interesse nazionale e perché coerente con lalinea avviata dagli esecutivi precedenti.
Qualche frutto comincia a vedersi soprattutto sul terreno dei prin-cipi condivisi. La vera partita politica ed economica si giocherà, tutta-via, al momento di negoziare le “prospettive finanziarie” per il periodosuccessivo al 2007.
Siamo disponibili, anzi auspichiamo, una politica bipartisan dell’I-talia su questa materia, possibilmente concordata con i Paesi membri difrontiera come Spagna e Grecia.
Deve essere chiaro, però, che se chiediamo agli altri Paesi Europeidi assumersi una responsabilità comune nel controllo delle frontiere,per contrastare la criminalità, questo comporta che l’Italia sia essa stes-sa coerente verso l’Europa ed essere coerente significa farsi carico di u-na giusta politica di asilo, promuovere le politiche di integrazione e cit-tadinanza degli immigrati, fare la propria parte nella lotta contro il raz-zismo, la xenofobia.
A Salonicco si è parlato della elaborazione di una politica globalee pluridimensionale per l’integrazione dei cittadini terzi.
Dopo 4 mesi di Presidenza italiana, viva è la preoccupazione, allaluce dei fatti, che tale indirizzo relativo alle politiche di integrazione re-
43
sti disatteso.
Le proposte di direttiva sui residenti di lungo termine segna il pas-so così come la comunicazione della Commissione in materia di inte-grazione e metodo aperto di coordinamento.
Nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale si so-no letteralmente perse le tracce della proposta di Decisione-quadro con-tro il razzismo e la xenofobia bloccate dalla resistenza degli Stati mem-bri ed, in particolare dall’Italia, che non l’ha neppure messa in agenda.
Esprimiamo viva preoccupazione per questa disattenzione nei con-fronti delle politiche di integrazione che però non è casuale ma è e-spressione dell’indirizzo sulle politiche migratorie del Governo italianoche ha messo l’accento solo sugli aspetti securatari e di contrasto dellaimmigrazione clandestina riducendo drasticamente l’ingresso legale perlavoro e relegando le politiche di integrazione alla esclusiva competen-za e responsabilità degli Enti locali e delle Regioni.
Scelta tanto più grave a fronte di una sanatoria di 700.000 personeche aumenterà in modo significativo i problemi connessi alla cittadi-nanza ed alla coesione sociale: casa, scuola, servizi per l’infanzia. Taliquestioni devono essere parte di un programma nazionale ed Europeoper l’integrazione e la cittadinanza.
Il Governo ha una opportunità per correggere il suo atteggiamentoe svolgere una funzione positiva: a dicembre scade il 2° ProgrammaTriennale sulle politiche migratorie con al centro un programma nazio-nale per l’integrazione.
Crediamo sia indispensabile che il governo adotti un nuovo Pro-gramma sulle politiche migratorie e di integrazione e lo presenti al Par-lamento. Sollecitiamo il Governo ad assumersi tale impegno durantequesto semestre.
L’Europa ha un compito fondamentale per costruire la pace, la si-curezza, la cooperazione nel mondo.
Per questo deve vincere la sfida di una politica dell’immigrazionerealistica e dunque aperta. Perché l’immigrazione clandestina si contra-sta rendendo accessibile l’ingresso regolare. Questo comporta indivi-duare meccanismi che favoriscono l’incontro tra domanda ed offerta dilavoro, favorendo anche l’ingresso per ricerca di lavoro. Alcuni assi e-
44
rano e restano essenziali nella costruzione di una politica comune che,pur tenendo nel necessario conto le differenze tra “vecchia” e “nuova”immigrazione, possa essere coerentemente adottata e applicata dall’U-nione nel suo insieme. Di questi assi fanno parte la definizione di nor-me minime comuni in materia di rispetto del diritto di asilo, di canaliefficaci e certi di ingresso legale, di un “pacchetto” uniforme di diritticivili, sociali e politici riconosciuti ai residenti legali di lungo termine;l’istituzione di meccanismi permanenti che consentano, ogni volta chesia possibile, il passaggio dalla condizione di irregolarità a quella di re-sidenza riducendo invece il ricorso ai rimpatri forzati; l’integrazione ef-fettiva e compiuta delle politiche migratorie nell’insieme delle politichedell’Unione, innanzitutto le politiche dell’occupazione e della coesionesociale e nelle relazioni esterne; la rivitalizzazione - e l’applicazione ef-fettiva ed efficace - delle norme contro le discriminazioni, il razzismo ela xenofobia, incluso un controllo rigoroso sulla messa in opera da partedegli Stati membri, un forte impegno nella lotta alla tratta. Su questebasi, infine, la costruzione di un sistema comune di controllo e gestionedelle frontiere esterne, capovolgendo il rapporto di stabilità stabilitosiin questi ultimi anni. Inoltre, è giunta l’ora, a mio parere, di promuove-re un grande Movimento in tutta Europa per l’integrazione e le cittadi-nanze. L’obiettivo della “cittadinanza civica europea” indicato nella re-lazione di Anna Terron e votato al Parlamento Europeo costituisce untraguardo realistico ma anche umano e civile molto coinvolgente. Per-ché sollecita ciascuno di noi, nella sua quotidianità e nella sua respon-sabilità di cittadino, a costruire legami, relazioni positive, convivenze.
45
SILVIA COSTA
Consigliere del CNEL
Con il Trattato di Amsterdam, ma soprattutto con il Consiglio Eu-ropeo di Tampere dell’ottobre ‘99, si sono gettate le basi per l’avvio diuna politica comunitaria sull’immigrazione e l’asilo, fondata - oltre chesul partenariato e sulla gestione dei flussi - sul “l’equo trattamento deicittadini dei Paesi Terzi”, “legalmente residenti”, cui vanno garantiti“diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini della UE”. Un indirizzoche raccoglie lo spirito e la lettera dell’art. 63 del Trattato di Amster-dam, laddove prefigura un quadro giuridico comune sullo status dei cit-tadini non comunitari, peraltro recepito dalla Carta dei diritti fondamen-tali nell’UE, che sarà parte costitutiva della Costituzione Europea.
La Commissione Europea ha dato seguito e forte impulso a questiobiettivi con la comunicazione del giugno 2003 su “Immigrazione,Integrazione e Occupazione”- predisposta in vista del Consiglio di Sa-lonicco - che offre una valutazione delle esperienze di integrazione ne-gli Stati membri e nella UE; individua il ruolo dell’immigrazione nelcontesto dell’invecchiamento della popolazione e delinea orientamentie priorità politiche per promuovere l’integrazione degli immigrati. Undocumento di ampio respiro, che affronta il tema delle migrazioni allaluce dei mutamenti demografici, ma anche delle sfide economiche e oc-cupazionali dell’Unione - emersi dalla Conferenza di Lisbona del mar-zo 2000 - come risorsa positiva per le dinamiche sociali ed economiche,come verifica delle politiche di inclusione e coesione sociale, di lottaalla povertà, alle discriminazioni e allo sfruttamento.
50
In questo quadro - afferma la CE - il concetto di integrazione assu-me il significato di un processo in due direzioni, basato su diritti e ob-blighi reciproci tra cittadini della UE e dei Paesi Terzi, diritti e doveriche devono essere proporzionali alla durata del loro soggiorno in unoStato membro. Quindi i cittadini stranieri devono poter accedere a mi-sure di integrazione il prima possibile dopo il loro arrivo, ma vanno de-dicate misure specifiche anche ai migranti di seconda e terza generazio-ne, pur nella prospettiva di un loro accesso ai servizi e alle opportunitàgenerali.
Di qui le iniziative avviate dalla CE di armonizzazione giuridica,di scambio di informazioni (rete EURES) e di esperienze, di avvio delmetodo aperto di coordinamento delle politiche di integrazione, con ungruppo ad hoc di lavoro e di collegamento.
Vanno in questa direzione le proposte di direttiva avanzate dallaCE al Consiglio in questi tre anni: dal diritto al ricongiungimento fami-liare, strumento indispensabile ai fini dell’integrazione (su cui nel feb-braio 2003 si è raggiunto il consenso politico del Consiglio), alla propo-sta di uno status dei cittadini dei Paesi Terzi residenti da lungo periodo;alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi Terzi cheintendono svolgere lavoro subordinato o autonomo oppure attività distudio o volontariato, piuttosto che di ricerca. Come la direttiva del gen-naio 2003 sui richiedenti asilo o la proposta di direttiva per la qualificadi rifugiato o di persona bisognosa di protezione internazionale. Da par-te degli Stati membri va data attuazione entro il 2003 alla direttiva fon-data sull’art. 13 per la parità di trattamento. Inoltre è stato garantito aicittadini di Paesi Terzi lo stesso livello di sicurezza sociale che si appli-ca ai lavoratori della UE. Infine vanno ricordati gli strumenti finanziaridella UE che possono promuovere - direttamente o indirettamente - lepolitiche di integrazione: Equal, Urban, Socrates, Leonardo, Youth,Culture 2000, nonché il FER per i rifugiati.
I capitoli principali di una politica complessiva di integrazione -individuati dalla CE - vanno dall’accesso al mercato del lavoro - dove iltasso di occupazione dei migranti è di 12 punti percentuali più bassodella media UE, specialmente tra le donne -; all’istruzione e la lingua,con il riconoscimento dei titoli di studio e professionali; agli alloggi, ai
51
servizi socio-sanitari - con le relative opportunità di informazione e me-diazione culturale -; alle occasioni di partecipazione culturale e sociale;all’acquisizione della cittadinanza, con meccanismi certi, il più possibi-le automatici o semiautomatici. In tal senso va sottolineato l’orienta-mento introdotto nel 2000 dalla CE di “cittadinanza civile”, come nu-cleo di diritti e doveri fondamentali che il migrante acquisisce gradual-mente nel tempo (compreso quello del voto amministrativo), per rende-re omogeneo il trattamento con i cittadini del Paese ospitante, anche senon naturalizzati. Un orientamento coerente con il fatto che la Carta deidiritti fondamentali prevede già diritti applicabili in quanto universali ealtri derivanti da quelli conferiti ai cittadini della UE.
Le condizioni indispensabili per una efficace attuazione dell’ap-proccio multisettoriale alla questione dell’immigrazione sono l’integra-zione tra le politiche, il coordinamento tra i diversi governi territoriali,il diretto coinvolgimento delle parti sociali, delle associazioni, dei sog-getti della società civile, il riconoscimento del ruolo della famiglia. Vainoltre ricordato che quasi la metà dei migranti è costituita da donne,che possono subire la doppia discriminazione, per genere e per origineetnica, ma che sono soggetti strategici di integrazione e di mediazioneinterculturale e intergenerazionale.
E’ molto importante che il Consiglio Europeo di Salonicco delgiugno 2003 abbia condiviso le valutazioni e gli orientamenti della CE,invitandola a presentare una relazione annuale sulle attività di integra-zione e individuando l’esigenza di un quadro coerente di principi comu-nitari.
Da queste premesse possiamo avviare il confronto tra i diversi, si-gnificativi interlocutori del nostro affollato panel, che vedono da un latola CES, l’istituzione rappresentativa delle parti sociali e della società ci-vile comunitaria, due Governi - Italia e Germania - una rappresentanzadella Tunisia, alcune Regioni (Italia, Francia, Spagna), l’Unione delleProvince e due Comuni italiani (Roma e Modena), alcune significativerappresentanze sociali (SIMI, ANOLF, Alma Terra, NO.DI).
Con loro vorremmo fare il punto sulle politiche di integrazione alivello comunitario, nazionale e locale, partendo da quegli ambiti primasottolineati e ricordando che:
52
dall’esame delle politiche nazionali di integrazione degli Statimembri emerge una forte iniziativa legislativa dal 98/99, con piani na-zionali d’integrazione - talora obbligatori in tutti gli Stati membri i sog-getti istituzionali competenti per le politiche di integrazione sono le au-torità locali e regionali, mentre il finanziamento di misure e programmiproviene da fonti nazionali o locali (con entità molto differenziate traStati) per il mercato del lavoro, emergono molte differenze nelle politi-che di integrazione: dalle quote ai programmi per diminuire la disoccu-pazione degli immigrati.
È molto diverso il ruolo riconosciuto alle parti sociali per favorirel’inserimento lavorativo. La partecipazione degli immigrati all’associa-zionismo o ai partiti e sindacati è libera. Metà degli Stati membri hannoconcesso alcuni diritti politici, come il voto amministrativo dopo un pe-riodo di soggiorno legale.
Esistono quasi ovunque Organi consultivi degli immigrati (ONCin Italia, composito).
In conclusione, sembrerebbe che per politica efficace di integra-zione gli Stati membri intendano quella che promuove i diritti fonda-mentali della persona; il suo diritto a mantenere la propria identità cul-turale; che contempli diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadiniUE; che consenta una partecipazione attiva e paritaria in tutti gli aspettidella vita.
Alla luce di questo, a che punto sono le politiche di integrazione equali sono le priorità?
53
RODOLFO GUTIERREZ PALACIOS*Direttore Area Studi e Analisi del Consiglio Economico e Sociale dellaSpagna
Innanzitutto vorrei ringraziare il CNEL per averci invitato a questaimportante conferenza e porgere le scuse a nome del Presidente delConsiglio Economico e Sociale Spagnolo per non essere qui oggi. Citeneva molto a partecipare a questa conferenza ma oggi è anche unadelle giornate più importanti per la funzione consultiva del ConsiglioSpagnolo, che deve concludere e presentare il parere relativamente allalegge di accompagno del bilancio 2004 ed è per questo che non è qui.
Per sfruttare al meglio il poco tempo a disposizione, vorrei accennaresoltanto a tre punti, per illustrarvi in maniera rapida le preoccupazioni delConsiglio Spagnolo che, di sua iniziativa, si è recentemente impegnato afornire entro la fine dell’anno un rapporto in cui si definisca una posizionecomune sull’immigrazione e sulle politiche per l’immigrazione. Come vidicevo, accennerò soltanto a tre punti: innanzitutto, vorrei farvi un quadrodella composizione e dell’intensità del fenomeno dell’immigrazione inSpagna, che è piuttosto singolare sia in termini di intensità che di ritmo. Se-condo, accennare all’integrazione dei lavoratori - perché credo sia un puntosostanziale - e, infine, fare qualche riflessione sulle politiche, soprattuttosulle politiche che favoriscono l’immigrazione regolare e le politiche d’in-tegrazione scolastica, che hanno una grande importanza nel nostro caso.
In primo luogo, per quanto riguarda il peso, il ritmo e la composi-zione dell’immigrazione nel nostro Paese, i dati ufficiali sull’immigra-__________* Intervento non rivisto dall’autore
54
zione pubblicati ogni anno in Spagna ci costringono a ritoccare la fotogra-fia ufficiale del Paese; infatti, negli ultimi anni il fenomeno ha conosciutouno sviluppo tale che i dati ufficiali più recenti, che risalgono all’inizio del-l’anno 2000, parlano di 2 milioni di stranieri in Spagna, il che vuol dire607.000 stranieri in più rispetto all’anno precedente. Per farvi capire qualeè stata l’accelerazione subita da questo fenomeno negli ultimi anni, basti ci-tare che mentre nei primi anni ‘90 in Spagna c’erano circa 300.000 stranie-ri, già nel 1996 ce n’erano 500.000, la maggioranza dei quali provenientidai Paesi dell’Unione Europea. In soli 5 anni c’è stato un aumento fortissi-mo, che in questi ultimi anni si attesta su circa 300-350.000 immigrati inpiù ogni anno. In Spagna la via dell’asilo politico ha avuto un ruolo moltopiù limitato rispetto ad altri paesi, perché gli immigrati che giungono nelnostro Paese sono soprattutto i cosiddetti “immigrati economici”; allo stes-so modo, anche l’acquisizione della nazionalità ha avuto un ruolo limitato,anche se è un fenomeno che si sta intensificando da qualche tempo. Perdarvi qualche cifra, vi dico che negli anni ‘90 ci sono state soltanto 130.000nazionalizzazioni, vale a dire acquisizioni della nazionalità spagnola.
In ogni caso, la composizione della popolazione immigrata sta cam-biando sensibilmente. Mentre fino a qualche anno fa gli immigrati eranoessenzialmente africani e soprattutto magrebini, negli ultimi 2 o 3 anni ilpeso dell’immigrazione dai Paesi dell’America Latina di lingua spagnola ècresciuto moltissimo. Negli ultimi anni, il numero di immigrati provenien-ti da Ecuador, Colombia e Argentina è cresciuto moltissimo, raddoppiandoda un anno all’altro, al punto che oggi gli immigrati di lingua spagnolapresenti in Spagna rappresentano quasi il 40% della popolazione stranieratotale. Questo è forse il risultato di una preferenza sociale diffusa, ma an-che di una azione politica più o meno esplicita che favorisce l’ingresso dipersone provenienti da questi paesi piuttosto che dal Nord Africa.
La popolazione immigrata rappresenta solo il 4% della popolazio-ne spagnola totale, e quindi ha ancora uno scarso peso demografico, mal’intensità di alcuni comportamenti fa sì che il suo peso e la sua impor-tanza in alcuni settori siano molto più sentiti. La popolazione immigrataè molto concentrata territorialmente; basti pensare che i tre quarti degliimmigrati si concentrano a Madrid e dintorni e in quelle che noi defi-niamo le Regioni o Comunità Autonome dell’Area Mediterranea, men-tre solo un quarto vive nel resto del territorio spagnolo, vale a dire lacornice cantabrica, l’interno e la valle dell’Ebro. Quindi c’è una forte
55
concentrazione regionale e anche una forte concentrazione in terminiurbani. Si tratta anche di una popolazione che è molto simile alla popo-lazione spagnola in termini di composizione demografica. La maggiorparte degli immigrati ha tra i 30 e i 50 anni. Anche la popolazione spa-gnola è piuttosto squilibrata dal punto di vista demografico e questo èun dato importante per il futuro, perché tutti i nostri problemi relativialla previdenza sociale e alle pensioni si aggraveranno a causa dellacomposizione demografica simile della popolazione immigrata. E’ unapopolazione che ha un tasso di natalità molto più alto, pari circa al dop-pio di quello della popolazione spagnola e questo è un fenomeno nor-male. Oggi, per esempio, sebbene la popolazione immigrata rappresentisolo il 4% dell’intera popolazione del Paese, essa vanta comunque il10% dei nuovi nati, arrivando in alcune zone addirittura al 20%. Ciò a-vrà delle ripercussioni molto particolari sul sistema scolastico. Cito unsolo dato: nell’anno scolastico 2000-2001, si è registrato un aumentodel 42% dei posti scolastici occupati dagli immigrati.
Questo è un ritratto piuttosto rapido della situazione spagnola, mache serve a spiegarvi che, pur essendo un fenomeno ancora relativamenteridotto, l’intensità e il ritmo gli conferiscono una grande importanza.
E ora parlerò della situazione lavorativa, altro nodo importante daaffrontare. Gli immigrati hanno una partecipazione lavorativa molto al-ta. Il tasso di attività degli stranieri è 20 punti più alto rispetto al tassodella popolazione spagnola. Anche il tasso di inattività è leggermentepiù alto, ma di soli 3 punti rispetto alla popolazione spagnola e credoche questo sia imputabile soprattutto agli immigrati giovani che hannoun livello d’istruzione più basso, e cioè abbandonano gli studi primadegli spagnoli. Gli immigrati svolgono nella maggior parte dei casi la-vori di livello inferiore e sono impiegati soprattutto nel settore dell’edi-lizia, dell’agricoltura e dell’industria alberghiera. Tuttavia, e questo èun dato molto importante, i percorsi di inserimento lavorativo sonomolto simili a quelli dei loro omologhi spagnoli, e parlo della rotazione,della mobilità, degli episodi di sospensione dell’attività lavorativa. Tut-tavia, l’alto peso della popolazione immigrata in posizione di irregolari-tà va associato alla presenza di situazioni che definiremo genericamente“di abuso” e che, pur non essendo ancora abbastanza conosciute, esisto-no ed hanno un peso sociale importante che riguarda oggi all’incirca
56
500.000 irregolari, vale a dire immigrati senza permesso, che nellamaggior parte dei casi lavorano in condizioni di abuso.
E, infine, due considerazioni politiche. Una sulla politica che cerca didisincentivare o meglio di combattere l’immigrazione clandestina e il traf-fico di persone che ha svolto un ruolo importante in Spagna. Chiaramenteuna delle priorità del nostro Paese è la regolarizzazione all’origine, vale adire che il cittadino straniero deve avere un permesso di lavoro e di sog-giorno prima di lasciare il Paese di origine e questo deve essere regola-mentato dal meccanismo delle quote o dei posti. Sebbene sia stato perfe-zionato di recente, sappiamo però che questo meccanismo è riuscito a ca-nalizzare solo un quarto degli immigrati. Tuttavia è una delle priorità dellapolitica spagnola, che recentemente ha trovato molti consensi. Di recente èstata apportata una riforma alla legge sugli stranieri, concordata tra gover-no e opposizione, ma bisogna riconoscere che, nonostante i recenti miglio-ramenti apportati, questo meccanismo è riuscito a convogliare soltanto unquarto degli immigrati che sono arrivati nel nostro Paese. Nonostante iprocessi di regolarizzazione straordinaria degli anni 2000-2001, ci sonoancora circa 500-600 mila immigrati stranieri in condizione irregolare, co-me dicevo prima. Questo ci porta necessariamente a fare una riflessionemolto approfondita sulle politiche di controllo dell’illegalità e sull’impor-tante ruolo svolto dalle reti nell’introdurre gli immigrati in Spagna. Questoè un problema che richiede sicuramente una maggiore efficacia delle poli-tiche interne e anche e soprattutto - e questo è il punto al quale volevo arri-vare e sul quale credo ci sia un consenso ampio - richiede una presenza euna maggiore efficacia delle politiche europee nel settore.
Crediamo che la sfida più importante a breve termine nell’ambitodella politica d’integrazione del nostro Paese riguardi soprattutto il si-stema scolastico. Il ritmo e l’intensità di crescita dell’immigrazione e-sercitano una pressione molto forte sul sistema scolastico, soprattutto suquello pubblico. Nel caso della Spagna, l’80% dei bambini che vanno ascuola frequentano le scuole pubbliche. Il sistema privato, o parificatocome lo chiamiamo in Spagna (che gode di finanziamenti pubblici), èriuscito ad evitare la presenza dei figli degli immigrati. La concentra-zione di situazioni critiche e difficili riguarda il sistema scolastico e cre-do che questo sarà uno dei settori più toccati dalle problematiche del-l’immigrazione nei prossimi anni.
57
BERNARD BEDAS*Direttore del Servizio Internazionale del Consiglio Economico e Socia-le della Francia
Grazie signora presidente e grazie al CNEL per aver organizzatoquesta interessante conferenza. Il Presidente del Consiglio Economico eSociale Francese, Dermagne, è stato purtroppo trattenuto a Parigi. Vichiede di scusarlo per la sua assenza e mi ha chiesto di rappresentarloqui oggi, cosa che io faccio naturalmente con immenso piacere. Perquanto riguarda il problema che ci vede qui riuniti, vorrei darvi qualcheesempio sulla situazione predominante in Francia e poi sulle politiche ele tendenze.
Per quanto riguarda la storia, comincio col dire che la Francia è unPaese con una lunga tradizione di accoglienza di immigrati.
Nel XIX secolo l’immigrazione era legata soprattutto al calo de-mografico del nostro Paese; fino alla metà del XX secolo, gli immigratiarrivavano soprattutto da Paesi europei, nella fattispecie la Polonia, ilBelgio e l’Italia. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, il fenomeno si è e-voluto diversamente, soprattutto per quanto riguarda il Paese di originedelle persone che emigravano in Francia in cerca di lavoro. All’iniziodegli anni ‘60, si trattava ancora e soprattutto di immigrati europei, mapoi le cose sono cambiate e il nostro Paese ha cominciato a ricevere unnumero crescente di immigrati provenienti in gran parte dai Paesi delMagreb e poi, con il passare degli anni anche dai Paesi dell’Africa sub-sahariana e dell’Asia, che hanno contribuito ad arricchire ed a diversifi-__________* Intervento non rivisto dall’autore
58
care la nostra popolazione. Oggi in Francia abbiamo circa 4,3 milioni distranieri, di cui 1,62 milioni di effettivi e quindi il peso degli immigratisia in termini di occupazione che in termini sociali è molto importante.Negli ultimi decenni il fenomeno migratorio si è evoluto e possiamo di-re che a partire dal 1974 abbiamo assistito ad una sorta di stabilizzazio-ne dell’immigrazione in Francia, dopo diversi anni di crescita. Forse haavuto a che fare con la fine di quello che è stato definito il “TrentennioGlorioso” (e cioè trent’anni di crescita economica), perché, come bensappiamo, c’è sempre un legame molto stretto tra i fenomeni migratorie la crescita economica e, per contro, nei periodi di disoccupazione lacrescita dell’immigrazione è meno forte, perché in quei casi il Paese di-venta meno attraente.
Possiamo dire che a partire degli anni ‘70 abbiamo assistito ad unacerta stabilizzazione dei flussi e ad un aumento dei ricongiungimenti fa-miliari. Infatti, negli ultimi anni, i tre quarti degli immigrati in Francia so-no arrivati per motivi familiari, il che vuol dire che la presenza straniera èpiù o meno stabile da circa 25 anni. Naturalmente continuiamo ad acco-gliere immigrati ad un ritmo di circa 100.000 persone l’anno, ma è in attoanche un fenomeno di acquisizione della nazionalità francese, che fa sìche la massa globale di stranieri che vivono e risiedono regolarmente inFrancia rappresenti sempre più o meno la stessa percentuale. In realtà, laFrancia è un Paese piuttosto multi-culturale perché, se consideriamo ilnumero di persone che hanno un nonno, una nonna, un bisnonno o un an-tenato di origine straniera, potremmo arrivare facilmente ad un francesesu tre che ha uno o più stranieri tra i suoi antenati.
Per quanto riguarda i luoghi di residenza degli immigrati, gli stra-nieri si concentrano essenzialmente in tre regioni: la regione dell’Ile deFrance, intorno a Parigi, la regione Rodano-Alpi e poi il Sud, con laProvenza e la Costa Azzurra. Questa concentrazione è legata a fenome-ni chiaramente economici, perché in quelle zone è più facile trovare la-voro e le persone che emigrano cercano innanzitutto un lavoro.
Per quanto riguarda l’aspetto politico dell’integrazione, a volte biso-gna diffidare un po’ delle parole. L’idea tradizionale d’integrazione inFrancia s’ispira direttamente alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo eall’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge indipendentemente dalla
59
loro origine, razza e religione. Questo approccio - che mira all’integrazio-ne totale - è sicuramente ammirevole, ma a volte presenta dei limiti. Sa-rebbe quindi interessante che la Francia facesse tesoro dei concetti adotta-ti da altri Paesi, soprattutto di quelli del mondo anglosassone che ha unapproccio concettuale al multiculturalismo un po’ diverso dal nostro. In-fatti, se analizziamo la situazione a livello locale, seguendo le attività de-gli enti locali, dei comuni, delle associazioni, le differenze che concet-tualmente e intellettualmente esistono in partenza, non esistono poi sulterreno. Tuttavia, il concetto d’integrazione e di uguaglianza assoluta deicittadini può a volte creare problemi. Per esempio, in Gran Bretagna at-traverso il concetto di minoranza etnica si possono avere delle statistichemolto precise, che permettono di agire in favore dei più deboli, mentre inFrancia, dove prevale l’idea di uguaglianza, nonostante le statistiche sul-l’origine, non abbiamo le cosiddette statistiche “etniche”.
E’ un problema difficile ed è solo un spunto per una riflessione al-largata agli altri Paesi europei. I maggiori vettori di integrazione inFrancia sono le scuole, le scuole pubbliche per i figli degli immigrati eper i giovani. Le scuole sono un potente fattore d’integrazione linguisti-ca, di formazione, di competenza. Tuttavia ci rendiamo conto che mol-tissimi immigrati o figli di immigrati vivono in zone socialmente sfavo-rite e si scontrano con le stesse difficoltà dei piccoli francesi delle classisociali più povere. Si tratta di giovani che generalmente vivono in quel-le che chiamiamo le “zone d’istruzione prioritaria”. Si tratta di un van-taggio da un lato, perché le zone d’istruzione prioritaria beneficiano dimezzi ulteriori per aiutare le persone in difficoltà, ma purtroppo sono altempo stesso le zone nelle quali i risultati scolastici sono sicuramentepeggiori. I giovani che vivono in ambienti degradati non hanno le stesseopportunità e le stesse possibilità di successo degli altri. In Francia, su11.800.000 alunni, 700.000 sono di origine straniera.
Lo stesso dicasi per il secondo grande fattore d’integrazione, che èanche il motivo essenziale per il quale gli immigrati vengono o veniva-no in Francia, vale a dire il lavoro. Il tasso di occupazione degli immi-grati in Francia è piuttosto elevato ed è quasi uguale a quello dei france-si. Purtroppo però il tasso di disoccupazione è quasi il doppio. Gli im-migrati spesso lavorano nei settori più difficili e il tasso di disoccupa-zione giovanile è il triplo rispetto a quello dei giovani francesi o a quel-
60
lo dei cittadini dell’Unione Europea che vivono in Francia. Si tratta so-prattutto di problemi sociali che non sono legati necessariamente a osta-coli linguistici, ma a problemi di competenza e di formazione profes-sionale. Il problema degli immigrati è soprattutto un problema sociale.Come hanno detto i relatori che mi hanno preceduto, l’immigrazionenon è più lo strumento per aumentare il tasso di natalità, come succede-va forse nel XIX secolo, perché ormai da una decina di anni a questaparte non c’è più nessuna relazione in Francia tra l’aumento dell’emi-grazione e il calo delle nascite. E anche se la maggiore natalità degliimmigrati continua a contribuire alla ricchezza del nostro Paese in ter-mini di diversità e di manodopera, non possiamo più contare sugli im-migrati per pagarci la pensione, per dirla brutalmente.
Direi, per concludere, che l’integrazione passa attraverso la scuola,il lavoro, la formazione sociale e professionale, la previdenza sociale,l’uguaglianza e l’assistenza medica. Parlo di uguaglianza rispetto ai cit-tadini di origine francese.
E il fatto che alcuni immigrati dispongano di competenze forti e didiplomi di istruzione superiore non basta ad eliminare totalmente le dif-ferenze. È per questo che dobbiamo continuare a lottare anche controquesta forma di discriminazione. In Francia abbiamo leggi che servonoa combattere la discriminazione in tutte le sue forme, comprese quelleindirette.
E infine per concludere, il Presidente della Repubblica ha chiestoal mediatore, il signor Stasi, di preparare una riflessione per creare l’an-no prossimo una commissione contro la discriminazione basata sullarazza, il sesso, l’handicap e via dicendo. Credo che sarà uno strumentomolto importante e che dovrà anche essere legato all’attività e alle ri-chieste europee. Credo che si tratti di una sfida ma al tempo stesso di u-na ricchezza importante sia a livello nazionale che Europeo.
61
ANDRESGARCIA PRADO
Direttore Generale Immigrazione, Assessorato Servizi Sociali della Re-gione di Madrid
Innanzitutto vorrei ringraziare il CNEL per averci dato l’opportu-nità di partecipare a questo evento importante.
Vorrei spiegarvi a grandi linee quello sta facendo la Comunità diMadrid in tema di immigrazione. Per Comunità di Madrid intendiamola regione che ospita la Capitale, e nella quale, come diceva GutierrezPalacios, si concentra il maggior numero di immigrati del Paese. Nellaregione di Madrid fino all’anno 2000 c’erano 166.000 immigrati censi-ti, contro i 610.000 al 1° gennaio 2003. Questo vuol dire che in tre anniil numero degli immigrati è cresciuto moltissimo e che l’intero fenome-no, che porta con sé problemi sociali, ricerca di case e di posti di lavo-ro, ha assunto dimensioni più vaste.
Nel 2001 il Governo Regionale ha lanciato il Piano Triennale Re-gionale per l’Immigrazione nella Comunità di Madrid, valido per glianni 2001-2003. E’ stato il primo piano di questo tipo in Spagna e ilsuo obiettivo è cercare di attuare in maniera congiunta quelle politicheche non sono di competenza prettamente regionale, ma che vengono di-vise tra lo Stato e la Regione. Lo Stato ha la competenza esclusiva inmateria di frontiere, mentre la Regione partecipa alle politiche relativeall’istruzione, alla sanità, alla casa e ai servizi sociali. L’amministrazio-ne pubblica spagnola insieme a tante associazioni ha fatto un grandesforzo nelle politiche d’integrazione, anche se è chiaro che bisogna con-tinuare a lavorare verso un modello d’integrazione più efficace.
62
Il Piano Regionale per l’immigrazione della Comunità di Madrid,che riprende e definisce le politiche generali del Governo Regionaledella Comunità di Madrid in materia di immigrazione, è stato approvatodall’Assemblea di Madrid il 7 dicembre del 2000 ed ha una validità ditre anni. Con questo piano abbiamo inteso razionalizzare e potenziareuna serie di misure e politiche sociali, tese all’integrazione degli immi-grati che vivono nella zona di Madrid, ricorrendo ad una serie di misurecoordinate e complementari per ottenere l’uguaglianza dei diritti, deidoveri e delle opportunità. Il Governo Regionale ha affrontato il PianoRegionale per l’Immigrazione mettendo a disposizione mezzi ambiziosiper l’integrazione, in connessione con le politiche di cooperazione allosviluppo con i Paesi di origine e come contributo ad altre iniziative delGoverno centrale dello Stato e in altre regioni del territorio nazionale.Per sua stessa natura, possiamo parlare di un piano dal contenuto emi-nentemente trasversale, che contiene programmi sulle varie materie cheriguardano l’immigrazione e sulle quali la comunità di Madrid ha com-petenza. Come dicevamo prima, si tratta di servizi sociali, assistenza sa-nitaria, istruzione, casa, formazione, lavoro e cultura. La sua applica-zione coinvolge 21 direzioni generali di 8 assessorati, il che presupponela quasi totalità del Governo della Comunità di Madrid. Vorrei, se me loconsentite, fare una sintesi dei punti più importanti di questo Piano chesta per concludersi e che sarà seguito da un periodo di dibattito e rifles-sione per valutarne i risultati, che a nostro avviso sono stati moltobuoni.
Da un lato, il programma ha rafforzato e migliorato i centri addettiai servizi sociali a livello municipale, in quanto primi responsabili del-l’accoglienza degli immigrati, inserendo la figura del mediatore cultura-le il cui compito principale è semplificare a tutti gli immigrati l’accessoai mezzi e ai servizi a loro disposizione nella Comunità di Madrid. Inquesti tre anni sono stati formati e assunti 48 mediatori culturali chenon sono solo spagnoli ma soprattutto immigrati e che per questo moti-vo possono interagire più facilmente con i loro concittadini.
Una delle sfide maggiori del piano era la costituzione dei Centri diAssistenza Sociale per gli Immigrati, i CASI. Si tratta di dispositivi disecondo livello, complementari ai Centri per i servizi sociali municipa-li, che offrono servizi specializzati e qualificati in materia di assistenza
63
sociale, psicologica, legale, lavorativa. Tutti questi servizi vengono of-ferti contemporaneamente all’immigrato, in maniera che possa seguireun percorso integrativo completo all’interno della comunità di Madrid.In tre anni, sono stati aperti 16 centri distribuiti in tutta la Comunità. Lacosa importante è che si tratta di centri pubblici gestiti dalle ONG com-petenti. Inoltre, questi Centri di Assistenza Sociale per gli Immigraticomprendono anche luoghi di accoglienza di emergenza per situazionidi particolare difficoltà. Quando è stato formulato il Piano, avevamopensato che 240 posti di accoglienza di emergenza sarebbero stati suffi -cienti ma, considerato l’aumento spettacolare dell’immigrazione versola comunità di Madrid negli ultimi 3 anni, è stato necessario aumentareil numero di posti disponibili che oggi sono circa 300.
Riteniamo anche che sia importante che gli immigrati godano diun accesso semplificato all’alloggio. A questo scopo è stato avviato unprogramma d’intermediazione per l’accesso all’alloggio, attraverso ilquale sono state alloggiate circa 1.000 persone e sono stati affittati circa300 appartamenti. Alla fine del 1997, la presenza di immigrati di etniagitana provenienti dall’Europa dell’Est nella regione di Madrid ha ri-chiesto il lancio di un progetto di inserimento concreto e specifico perquesto gruppo, la cui caratteristica principale è quella di essere itineran-te, composto da famiglie numerose con un basso livello di istruzione esenza alcuna qualifica professionale.
Inoltre, il Piano Regionale per l’Immigrazione aveva tra i suoi o-biettivi principali la creazione, attraverso l’Ufficio regionale per l’Im-migrazione, di un Osservatorio Regionale per l’Immigrazione incarica-to di una sorta di analisi continua della realtà dell’immigrazione nellacomunità di Madrid, proponendo e collaborando quando era necessarioper il lancio di programmi e progetti di integrazione. All’interno del-l’Uf ficio Regionale dell’Immigrazione c’è la scuola per i mediatori cul-turali dove non soltanto si formano i mediatori ai quali ho accennatoprima, ma vengono organizzati corsi di formazione diretti ad entità ecollettivi sia autoctoni e che d’immigrati, nei quali s’insegnano i valoridell’integrazione, l’importanza di offrire opportunità a chi arriva e cheservono anche a noi per conoscere, imparare e fare tesoro dei contributiche vengono dalle 600.000 persone straniere che vivono con noi.
64
Quello che vi ho appena descritto è uno dei primi e più ampi PianiRegionali per l’Immigrazione in Spagna. Siamo soddisfatti dei risultatiottenuti, anche se i piani successivi dovranno sicuramente imparare dal-le esperienze fatte, ampliare le attività e svilupparne altre che abbianouna maggiore efficacia politica in vista dell’integrazione. Per questo ipiani che prepareremo per il futuro devono poter contare su un ampioconsenso politico e sociale.
La pubblica amministrazione deve indubbiamente stimolare e so-stenere l’elaborazione di piani chiari che abbiano una prospettiva globa-le e coordinata, che rispettino i diritti umani, e prevedano una politicadi assistenza alla popolazione immigrata. Questi piani devono prevede-re diverse attività per il raggiungimento dell’integrazione e al tempostesso devono garantire la pianificazione, il coordinamento ed evitare lesovrapposizioni, per assicurare l’efficacia e la qualità dei programmi.La politica d’integrazione deve indubbiamente essere ispirata a politi-che globali che garantiscano un’immigrazione ordinata e che assicurinol’uguaglianza di diritti e doveri di tutti, di chi arriva e di chi li riceve,per promuovere l’integrazione sociale e culturale e le pari opportunità.
65
RITA SÜMMUTH*Presidente del Consiglio Indipendente di esperti su migrazione ed inte-grazione nominato dal Governo tedesco
Come presidente di un consiglio indipendente incaricato di tenereaggiornato il Governo tedesco in materia di migrazioni ed integrazione,desidero innanzitutto descrivervi la realtà attuale a livello federale e na-zionale in Germania. Forse sapete che la Germania è un Paese con unnumero elevato di stranieri, di immigrati: l’8% della popolazione per unnumero complessivo di 7,3 milioni di persone. Fino al 2000, la versioneufficiale in tema di migrazione era che non fossimo un Paese di immi-grazione. In realtà lo eravamo. Fino al 1973, moltissime persone veni-vano in Germania in cerca di occupazione, e finivano per non tornare ailoro Paesi di origine, fermandosi in Germania. Nel 2000, dopo aver alungo negato questa realtà, è stato ufficialmente riconosciuto il fatto diessere un Paese di immigrazione, non di tipo classico, ma comunque unPaese di immigrazione.
In questi giorni, stiamo cercando di riunificare le politiche in mate-ria di rifugiati, di immigrati per lavoro e di integrazione, in un’unica leg-ge quadro. Stiamo riscontrando molte difficoltà, ma questo è l’obiettivo.
Il tema dell’integrazione riveste al momento un’altissima priorità atutti i livelli: quello locale, quello regionale e quello nazionale. Deside-ro ribadire l’affermazione già fatta questa mattina sul fatto che nessuno__________* Intervento non rivisto dall’autore
66
dei Paesi membri dell’Unione Europea può permettersi una politica sul-l’immigrazione isolata dal resto dell’Unione. Abbiamo bisogno di unacondivisione degli approcci e delle regole. In tutti i nostri Paesi esistonoquei timori che sono già stati citati. Tuttavia, dobbiamo fare molta at-tenzione e lo dico soprattutto a quegli esponenti politici che alimentanoquesti timori invece di gestire le migrazioni e l’integrazione. Lo ripeto:molti di questi timori sono creati dagli stessi uomini politici e dallecampagne di partito.
Altri dati sulla Germania. Durante il periodo in cui negavamo diessere un Paese di immigrazione, dopo il 1973 quando fu interrotta l’as-sunzione di lavoratori dall’estero, gli immigrati non sono tornati nei lo-ro Paesi di origine. Quello è stato il periodo delle riunificazioni familia-ri. I dati che abbiamo oggi sono quindi il frutto prevalente delle riunifi-cazioni familiari e dell’arrivo dei rifugiati. Ufficialmente non esistonopiù assunzioni: si tratta solamente di casi eccezionali. Ciononostante, o-gni anno effettivamente assumiamo oltre mezzo milione di lavoratoristagionali: nel settore alberghiero, nella ristorazione e in agricoltura.Ma soprattutto aumenta il numero degli infermieri e delle persone dedi-te alla cura delle persone e degli anziani. E qui presentiamo una fortecontraddizione: abbiamo bisogno di immigrati, ma li ignoriamo e ne-ghiamo questo bisogno. Se guardo all’indietro alla storia del mio Paese,posso tranquillamente affermare che la pratica concreta è stata di granlunga migliore della politica ufficiale.
Berlino, una città con 180 nazioni rappresentate - la minoranza dimaggiore rilievo, quella turca, vanta 180.000 abitanti -, ha sviluppatonegli anni una pratica positiva per la convivenza pacifica e produttiva.Come ha fatto? Nel 1978 è stata introdotta la figura del commissariospeciale per gli stranieri. A livello municipale, il commissario è statoinsediato nel 1981. Il commissario di Berlino aveva un ruolo ecceziona-le - anche rispetto alla politica nazionale perseguita negli anni successi-vi - in tema di integrazione. Il suo ufficio era aperto a tutti gli immigratinella città e con questo ufficio si è riusciti ad inserirli tutti nel sistemasociale tedesco. Questa è la situazione oggi in Germania: tutti gli immi-grati regolari, con permesso di soggiorno a tempo indeterminato, hannoaccesso a tutti i settori del sistema sociale. In questo senso, siamo persi-no più avanti che non sul tema della cittadinanza civile. Infatti, vista la
67
nostra concezione del tema della naturalizzazione, la riforma della citta-dinanza risale solamente al 1999.
Un altro aspetto rilevante è che, soprattutto nelle grandi città, dovevive il 40% degli immigrati, esistono moltissime associazioni ed inizia-tive multiculturali. L’associazionismo ha rivestito e riveste un ruolofondamentale per l’integrazione, perché riesce a fare da ponte con la so-cietà locale, offrendo corsi di lingua, incontri ed eventi culturali, dovegli immigrati possono praticare la propria cultura del Paese di origineed anche avere l’opportunità di incontrare gruppi tedeschi. Esistonogruppi di tutte le etnie: russi, coreani, vietnamiti, etc. E funziona vera-mente.
La presenza di una commissione speciale, molto attiva in tema dirapporti personali con i migranti, e la presenza di gruppi ed associazioni(a Berlino ne esistono più di 1.000) sono elementi di estrema importan-za per l’integrazione e (questo è ora il nuovo paradigma) per portare gliimmigrati il prima possibile ad un’educazione prescolare e scolare, of-frendo loro la possibilità di parlare la lingua del Paese, non solo nel-l’ambito di corsi specifici, ma fuori dalle aule scolastiche. Più occasionisi hanno di parlare la lingua, più la si internalizza.
Ancora sulle iniziative di Berlino: il ruolo importante delle madri.Portare le madri verso una istruzione prescolare e scolare, dando lorol’opportunità di parlare la lingua. A volte è difficile nella cultura turcafar partecipare una donna ai corsi ufficiali. La rilevanza del ruolo dellemadri nel processo d’integrazione è stata promossa da Berlino ed è oradiffusa in tutto il Paese. Penso che fino ad ora sia stato fortemente tra-scurato il ruolo delle donne e delle madri nel processo di integrazione.
Infine, fatemi dire che abbiamo molto da imparare sui migranti esui loro talenti. Spesso li classifichiamo come degli “svantaggiati”, masiamo noi a renderli tali. È molto importante promuovere i loro talential di fuori della scuola, per poi proseguire con la formazione professio-nale ed il lavoro. A Berlino, gli immigranti che hanno un lavoro auto-nomo sono sempre più numerosi. In anni passati non attribuivamo loroparticolare attenzione, ma oggi abbiamo imparato che oltre a “toglierciposti di lavoro”, li stanno anche creando. In entrambi i casi, svolgonolavori che noi non vogliamo svolgere.
68
Attualmente la situazione è la seguente. Visto l’alto tasso di disoc-cupazione, è chiaro che i lavoratori non specializzati hanno minori op-portunità d’integrazione. Quindi la politica d’integrazione non rappre-senta la massima priorità per la stragrande maggioranza di immigratiben integrati, quanto per il 25-30% di immigrati poco integrati. Vi è unadomanda di programmi speciali mirati ai tedeschi più svantaggiati ed aimigranti, finalizzati a ravvicinarli, quando possibile: a non dividere igruppi familiari e non mettere un contro l’altro gruppi etnici diversi.
Credo che Berlino rappresenti la dimostrazione eclatante che non èla quantità di migranti - di per sé - a creare le principali difficoltà, mapiuttosto come viene affrontata la questione.
69
ABDERAZAK FETNAN*Membro del Consiglio Economico e Sociale della Regione Provenza eCosta Azzurra
Ho avuto la fortuna di essere stato preceduto da un componentedel Consiglio Economico e Sociale Francese che ha introdotto il mio di-scorso e quindi mi limiterò a raccontarvi qualche storia d’integrazione.Il processo d’integrazione è un processo lungo e io cercherò di raccon-tarvi 30 anni d’integrazione attraverso tante piccole storie.
Innanzitutto, comincerei col dire che se oggi gli europei comincia-no ad avere paura, gli immigrati e i figli degli immigrati hannopaura edubitano a loro volta, cosa che fino ad oggi non accadeva. Per quantomi riguarda, sono arrivato in Francia negli anni ‘70 (per la precisione,nel 1969). Avevo 12 anni. Mio padre viveva in Francia dal 1957 e face-va avanti e indietro come tanti altri. Io sono arrivato con mia madre equalche fratello e sorella. Appena arrivati, siamo andati ad abitare in unquartiere in cui c’erano quattro edifici praticamente distrutti, perché ilproprietario non li aveva mai terminati. La prima lotta è stata quella peril restauro dell’immobile per avere una vita un po’ più decente. All’e-poca avevo solo 12 anni, ma mi sono dovuto dare da fare subito perchéi miei genitori non parlavano bene francese e sono stato costretto a tra-durre per loro. Non c’era acqua potabile; c’era fango ovunque e, perspiegarvi il degrado di quegli edifici, vi dico solo che i bagni scaricava-no direttamente sulla strada. Vi lascio immaginare la sporcizia e soprat-tutto il cattivo odore. I genitori hanno creato un’associazione per lottare __________* Intervento non rivisto dall’autore
70
contro il proprietario affinché aggiustasse gli edifici. La lotta è durata 4anni e, in quel periodo, molti degli abitanti hanno abbandonato perché ilproprietario sembrava molto potente. A quell’epoca, però, mio padre miha detto una cosa che ricorderò per sempre: “Se c’è una cosa certa inFrancia, è che c’è una giustizia e quindi vedrai che, alla fine, vincere-mo”. Potete bene immaginare che a 12 anni avevo più voglia di giocarea biglie che di appurare se in Francia esistesse una giustizia. Ebbene,mio padre aveva ragione, perché la lotta è stata lunga ma alla fine ab-biamo vinto. E questa è stata la prima lezione che ho imparato in Fran-cia.
La seconda lezione mi riguarda più da vicino perché ero adole-scente. C’era un bar nel Paese e il Paese era praticamente vietato agli a-rabi. La vecchia generazione, gli adulti, avevano accettato questa condi-zione, mentre noi ci eravamo opposti. Per noi era inconcepibile che unluogo fosse inaccessibile. E quindi un sabato pomeriggio, quando il barera affollato, ci siamo andati tutti insieme. Abbiamo fatto uscire il pro-prietario e gli abbiamo detto: “noi oggi entreremo nel tuo bar, con lebuone o con le cattive”. Gli avventori del bar sono usciti e ci siamo tro-vati faccia a faccia. Potete immaginare la situazione, noi eravamo unadecina, loro venti. Immaginate la paura che potevamo avere. I toni delladiscussione sono saliti, è volato qualche schiaffo, ma davanti alla nostradeterminazione abbiamo firmato la pace e il barista ci ha invitato a bereun bicchiere tutti insieme. Questa è stata la seconda lezione che ho im-parato: l’integrazione è una lotta, e l’integrazione si deve conquistareperché non ti viene semplicemente data.
E poi c’è la terza lezione, che all’epoca non avevo capito. Uno deipalazzi rischiava di crollare per problemi strutturali ed allora abbiamochiamato il sindaco. Era una domenica mattina alle ore 10. Il sindaco èentrato nell’edificio, ha visto effettivamente diverse crepe e noi aspetta-vamo la sua decisione. Ad un certo punto lo abbiamo sentito biascicarequalche cosa al suo vice sindaco e tutto quello che ha osato dire, nonsapendo di essere ascoltato, è stato: “Ma che ci facciamo qui? E’ dome-nica mattina e non c’è neanche un elettore!” Ed aveva ragione, perchétutti gli abitanti di quel quartiere, 42 famiglie, erano tutti immigrati.
Negli anni 80, i giovani hanno cominciato a rifiutare una serie di
71
cose. In quel periodo ci sono stati diversi problemi e forse vi ricordereteanche qualche omicidio. Allora, ad un certo punto, i giovani, i ragazzinati in Francia da genitori magrebini hanno cominciato a dire: “Bastaal razzismo”.E hanno deciso di fare una Marcia della Pace, della qualequest’anno si festeggia il ventesimo anniversario. Sono partiti da Marsi-glia e sono arrivati fino a Parigi a piedi. Hanno marciato per 45 giorni.Hanno attraversato tutti i Paesi, tutte le cittadine dicendo: in Francianon c’è un problema di razzismo, ma un problema di uguaglianza. Sitratta di un problema sociale e non etnico. A partire da quel periodo, pa-recchie persone si sono messe a lavorare seriamente nelle scuole e acredere nella Repubblica al punto che alcuni di loro hanno anche fre-quentato e si sono diplomati all’ENA. Ve ne parlerò dopo relativamenteai problemi di discriminazione sul lavoro. Dagli anni ‘90 al 2000 c’èstato un grosso movimento nei quartieri che ha visto nascere tante atti-vità e mobilitazioni, lotte per l’uguaglianza e il raggiungimento di unaperfetta coesione sociale.
Tuttavia devo dirvi che oggi, nel 2000, anche se globalmente cisono numerosi esempi d’integrazione riuscita, la maggioranza degli im-migrati e dei loro figli dubitano. E dubitano perché, per esempio, alcunidi loro hanno seguito un percorso educativo esemplare, ma questo nonè bastato. Qualcuno si è addirittura diplomato all’ENA. Nel Sud c’è unVice Prefetto che è un prodotto dell’immigrazione. Non vi dirò il nome,ma lo chiamerò Mohammed Mohammed. Un giorno il Prefetto lo hachiamato nel suo ufficio e gli ha fatto vedere una scatola di cartone pie-na di passaporti. Il Vice Prefetto ha chiesto cosa volesse dire e il Prefet-to gli ha risposto che quei passaporti erano di cittadini che li avevano ri-mandati indietro perché erano stati firmati da Mohammed Mohammed.E questo è solo un esempio di discriminazione sul lavoro. Alcuni di lo-ro ce l’hanno fatta, sono diventati dirigenti o almeno hanno studiato perfarlo e alcuni lo sono. Altri invece, pur di ottenere un lavoro, sono staticostretti a cambiare nome e cognome.
Vi citerò un caso che è finito anche su tutti i giornali in Francia.C’era una donna che, nonostante avesse frequentato un’ottima scuola dispecializzazione per lavorare in banca e nonostante la grande disponibi-lità di posti adatti a lei, non riusciva a trovare lavoro. Alla fine ha deci-so di cambiare nome e poco dopo è stata chiamata per un colloquio di
72
lavoro. Poiché era alta, bionda e aveva gli occhi chiari e non sembravaprovenire dal Sud del Mediteranno, il datore di lavoro ha letto con inte-resse il curriculum, le ha detto che sarebbe stata perfetta per quel posto,le ha comunicato quale sarebbe stato il suo stipendio e via dicendo e,alla fine, le ha proposto di cominciare la settimana successiva. A quelpunto la donna è intervenuta dicendo: “Lei deve sapere che il mio nomenon è quello che c’è sul curriculum, ma il mio vero nome è MohammedMohammed.”E lui ha replicato che in una banca la fiducia è una cosafondamentale e che lei cambiando nome per potere avere un colloquiodi lavoro aveva violato il patto di fiducia e che quindi lui non potevaassumerla.
Vi racconto un altro esempio. Ho un amico che ha fatto la stessacosa ma il suo datore di lavoro gli ha detto “Lei è stato sfacciato, ma laprendo lo stesso perché ho bisogno di persone come lei”.
Per riassumere, l’integrazione totale è possibile anche se è un pro-cesso lungo. La cosa certa è che si tratta innanzitutto di un desiderio.Bisogna averne voglia: bisogna aver voglia d’integrare e di essere inte-grati. Ma bisogna lottare perché si tratta di negoziati permanenti e nonbasta la semplice volontà o il desiderio. L’integrazione può richiedereparecchio tempo perché, come avete visto, abbiamo cominciato neglianni ‘70 e siamo arrivati al 2000. E ci sono state fasi alterne. In alcunimomenti abbiamo avuto fiducia e in altri meno.
Per concludere: per arrivare all’integrazione dobbiamo ispirarci atre motti e mi riferisco alle regole repubblicane che in Francia o altrovedevono essere sempre applicate. Sto parlando di Libertà, Fratellanza eUguaglianza.
73
GIANLUCA BORGHI
Assessore alle politiche sociali della Regione Emilia-Romagna
Già nell’autunno del 2000 la Giunta regionale si è dotata di unprogramma organico sulla immigrazione che si svilupperà nell’arco ditutta questa legislatura.
Il programma è imperniato su quattro punti principali: osservazio-ne del fenomeno, concertazione con le parti sociali, programmazionedelle politiche di integrazione sociale, nuova legislazione regionale.
L’Osservatorio regionale
Nella nostra Regione il fenomeno dell’immigrazione si è impostoall’attenzione generale negli ultimi anni: gli immigrati stranieri che era-no 30.000 dieci anni fa, si avvicinano oggi ai duecentomila, gli stranierisono stati il 16% dei nuovi assunti nel corso del 2002; tra il 1999 ed il2001 i titolari di impresa stranieri sono passati da 7.500 a 15.000.
Con tutto ciò, gli stranieri ammontano oggi a circa il 5% della po-polazione residente e quindi siamo ben lontani dalla cosiddetta “inva-sione” che taluno ha paventato.
Ma non è difficile prevedere che nei prossimi anni, l’immigrazio-ne straniera continuerà ad aumentare, mentre quella dalle regioni meri-dionali si ridurrà.
Ecco quindi la necessità di governare un fenomeno complesso,impedendo che si crei uno scarto tra i fabbisogni del tessuto produttivoemiliano romagnolo (che ormai fronteggiano una cronica carenza dimano d’opera) e la possibilità di accoglienza abitativa e sociale.
74
Nel corso del 2001, prima Regione in Italia, abbiamo redatto il pri-mo rapporto dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione e a marzo2004 prossimo presenteremo il terzo rapporto.
Ancora qualche considerazione, basata su dati.
Su base provinciale è individuabile una relazione inversamenteproporzionale tra presenze degli immigrati e tassi di disoccupazione.
Minore è la disoccupazione (Reggio e Modena) maggiore è la pre-senza di immigrati e viceversa (Ferrara e Romagna). Si fa veramentefatica a sostenere che non sia il mercato del lavoro il motore della im-migrazione.
Inoltre ci sono già oltre 22.000 bambini stranieri iscritti nelle scuo-le della Regione ed il loro numero è destinato a crescere rapidamente.
La concertazione sociale
Mentre a livello nazionale assistiamo ad un progressivo deteriorar-si del clima sociale e dei rapporti tra le parti sociali e di governo, in E-milia-Romagna è stato firmato il 18 dicembre 2001 un importante ac-cordo in materia di immigrazione straniera.
Sul tema forse in assoluto più controverso, che minaccia di divide-re l’opinione pubblica tra timori e necessità, in Emilia-Romagna il testosottoscritto è stato condiviso dalle istituzioni (Regione, Province e Co-muni), da tutte le parti sociali (CGIL, CISL, UIL ed organizzazioni da-toriali) e dalle organizzazioni del terzo settore.
Si è così realizzata una convergenza di idee che è culturale primaancora che programmatica, che vuole conciliare i fabbisogni delle im-prese con la coesione sociale, i diritti e i doveri dei cittadini immigrati.
Con questo accordo la Regione Emilia-Romagna ha confermato ilruolo imprescindibile della concertazione come strumento di confrontoprimario sia a livello istituzionale che sociale.
A questo proposito è importante sottolineare che tutte le Parti fir-matarie del Protocollo abbiano condiviso il principio che: “i problemidella determinazione dei flussi di ingresso a scopo di inserimento lavo-rativo, il reperimento degli alloggi necessari e le azioni di integrazionesociale, necessitano di una visione di insieme e di elementi di program-mazione integrati tra loro”.
75
Nel novembre 2002 sono stati siglati i nove protocolli provincialiche hanno confermato l’impostazione di quello regionale, articolandonei contenuti nei contesti locali.
La programmazione regionale
Abbiamo costituito un coordinamento interassessorile e monitora-to le attività della Regione, rilevando una programmazione di risorse sucasa, formazione professionale, cultura ed integrazione sociale.
Abbiamo dato la priorità a corsi di lingua italiana, mediatori cultu-rali, accesso ai servizi, corsi di formazione professionale. Ci sembra dipoter dire che l’Emilia-Romagna sia una Regione all’avanguardia intermini di integrazione sociale degli immigrati.
Dal monitoraggio svolto sulla totalità dei Comuni, risulta che lamaggioranza di essi svolge interventi diretti in materia di politiche di in-tegrazione in particolare su alcune macro aree: accoglienza informativa,abitativa, corsi di lingua, orientamento ai servizi del territorio e al lavoro.
La legge 189/2002
Un ostacolo di non poco rilievo alle attività della regione è costituitodalla nuova legge Bossi-Fini che, ad un anno della sua entrata in vigore,sta mostrando tutti i limiti di un’impostazione ideologica: la stessa gestio-ne delle pratiche di regolarizzazione costringerà oltre la metà di coloroche avevano fatto domanda a rientrare nella clandestinità. Sta crescendola consapevolezza, anche presso le imprese, che è necessario andare ad u-na modifica della normativa soprattutto sul punto che lascia agli immi-grati soltanto sei mesi di tempo per trovare un nuovo lavoro.
Questa legge che il centro-destra ha presentato sotto le vesti del ri-gore, dell’ordine, dell’efficienza nei fatti a creato: la chiusura degli ac-cessi legali di ingresso, l’ingolfamento dei tribunali, un utilizzo deiCentri di permanenza temporanea in una logica repressiva ed in molticasi senza garanzie e tutele verso gli ospiti, e la creazione di una massaenorme e disperata di migranti senza futuro.
La legge regionale per l’integrazione sociale dei cittadini stranieri
La Regione intende ora accelerare su una questione centrale quale
76
è la politica di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri avendol’obiettivo di approvare entro il 2003 una nuova legge regionale.
Sono numerose le innovazioni introdotte dalla legge, denominata“Norme per l’inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati” e de-stinata a superare la precedente Legge regionale 14/90. Qui di seguito ipunti principali:
un programma triennale di attività sull’immigrazione per rafforza-re l’integrazione delle politiche regionali, anche in raccordo con il Pia-no sociale regionale e i Piani di zona;
promozione dell’integrazione sociale attraverso la partecipazionedei cittadini stranieri alla vita pubblica, con strumenti di rappresentanzanell’ambito delle istituzioni locali;
consulenza legale contro le discriminazioni, razziale, etnica, na-zionale o religiosa, con l’introduzione di nuove tutele così come previ-sto da direttive europee;
la Consulta regionale sull’immigrazione avrà come vicepresidenteuno straniero e dedicherà particolare attenzione alla presenza femmini-le, con una forte valenza simbolica a fronte dei diritti negati alle donnein diversi Paesi africani e asiatici;
definizione di una chiara ripartizione di compiti tra Regione, Pro-vince e Comuni;
attivazione di una nuova funzione di osservazione del fenomenomigratorio, con l’obiettivo di indicare annualmente il fabbisogno lavo-rativo nella regione;
allargamento della platea dei destinatari dei servizi anche ai richie-denti asilo ed ai rifugiati;
contributi per spese alle Province ed al Terzo settore su interventidi integrazione sociale, quali ad esempio sportelli informativi, corsi dilingua, centri ed iniziative interculturali;
contributi in conto capitale al Terzo settore, fondazioni e privatiper la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi sociali;
interventi per le politiche abitative (promozione di agenzie per lacasa per favorire l’incontro tra domanda e offerta, alloggi sociali, centridi prima accoglienza).
77
La Regione intende anche promuovere forme sperimentali di inter-vento promosse dalle parti sociali (datori di lavoro, enti locali, sindaca-ti) per affrontare congiuntamente il tema dell’inserimento lavorativo edella casa;
sostegno a programmi di istruzione e di formazione professionalenei Paesi di origine dei flussi migratori;
in campo sanitario, oltre le pari garanzie, la nuova legge sanciscel’opportunità che nell’ambito degli interventi rivolti a cittadini stranierisi tenga conto delle culture dei Paesi d’origine e si sviluppino i centri diinformazione. Allo stesso tempo si sottolinea la necessità di interventivolti a rispondere alle problematiche nel campo della sessualità, pro-creazione e nascita, oltre che ad eliminare pratiche lesive della condi-zione umana e dell’integrità fisica delle donne, pratiche persistenti econnesse a culture originarie.
78
RAFFAELLA MILANO*Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Roma
Ringrazio il CNEL per questa occasione. Porto un paio di rifles-sioni dal punto di vista di un’Amministrazione locale di una grande cit-tà come Roma.
Una prima riflessione la riprendo da alcuni interventi che mi han-no preceduto: che posto hanno le politiche di integrazione nell’ambitodelle politiche urbane? Io mi occupo di politiche sociali, ma sono con-vinta, anche dall’esperienza, che le politiche di integrazione siano altrorispetto alle politiche sociali.
Le politiche di integrazione sono anzitutto il modo in cui una cittàlegge, dal punto di vista dell’integrazione, il suo sviluppo urbano, il suosviluppo locale. E quindi il destinatario di queste politiche di integra-zione non è il cittadino straniero, ma è la comunità cittadina nel suo in-sieme che si ridisegna e si ripensa alla luce dell’integrazione. Questoper una comunità locale significa attenzione ad una serie di aspetti, nonnecessariamente di welfare, ma che riguardano la vita della città. Faccioqualche esempio: gli accordi che con le comunità straniere abbiamopromosso a Roma per i tempi della città; gli accordi che abbiamo pro-mosso anche per valorizzare dei momenti importanti della vita come lanascita, ma anche come la morte, quindi l’organizzazione dei servizi fu-nebri e cimiteriali, solo per fare qualche esempio; o ancora la possibilitàdi leggere la stessa storia della città a partire dalla storia delle comunità__________* Intervento non rivisto dall’autore
79
straniere che la vivono e la abitano, cercando di fare riferimento anche ap-punto a quello spirito di curiosità e di voglia di conoscere che talvolta è ilvero antidoto anche alle paure urbane. Infine, un aspetto che la città di Ro-ma sta cercando di promuovere è anche quello di leggere i flussi migratorinell’ambito della interdipendenza. Noi abbiamo promosso a Roma già dueincontri tra le grandi metropoli del mondo che condividono problemi e re-sponsabilità riguardo allo sviluppo e alla lotta all’esclusione sociale. Quindiquesto ci aiuta anche a leggere il tema dell’inclusione, dell’immigrazione edell’integrazione, non come un tema separato dai destini della comunità lo-cale, non come qualcosa da tollerare o da accettare, ma come un elementoche fa parte dello sviluppo umano e civile dell’intera comunità cittadina.
Poi certamente ci sono le politiche di sostegno all’inclusione. Si fa-ceva riferimento alle scuole e davvero quella è solo una prima frontiera. Ibambini e le bambine sono spesso caricati anche delle fatiche di questoruolo di mediatori tra le famiglie di origine e la nuova comunità cittadinain cui si vengono a trovare. C’è poi il ruolo delle donne che sono sicura-mente un elemento spesso vittima di violenze, ma davvero uno dei fortielementi delle politiche di sviluppo. Del resto questo è vero in tutto ilmondo, è vero anche nei nostri Paesi, e, ad esempio, a Roma siamo allavigilia dell’avvio di una sperimentazione che riguarda l’assistenza fami-liare. D’intesa con i sindacati confederali abbiamo avviato un registro peraccreditare chi fa lavoro di cura, assistenza familiare. Questo significaporsi il problema dell’incertezza di persone che magari si professionaliz-zano, ma che poi, alla morte o all’entrata in istituto dell’anziano che cura-no, si trovano con sei mesi di tempo per ricostruire tutto il proprio futuro.Quindi dare percorsi di professionalità ed elementi di certezza alle fami-glie italiane, alle famiglie straniere che fanno attività di cura, ci sembraun ruolo importante anche per l’ente locale, così come sono tutti queiruoli per il tempo non continuo che riguardano comunque il superamentodi quegli ostacoli aggiuntivi che colpiscono le comunità straniere di fron-te a problemi di accesso ai diritti sociali che sono difficili per tutti.
C’è quindi un quadro di azioni positive che però non ci può ovvia-mente far distogliere lo sguardo dalle condizioni di emergenza che vivia-mo e dalle condizioni di violazione dei diritti umani elementari. Insomma,gli enti locali compiono degli sforzi, ed è proprio in corso la riunione al-l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in cui parliamo del pia-no nazionale asilo, ma parliamo di diritti che oggi non sono esigibili nem-
80
meno da parte di chi vedrebbe questa tutela garantita, come chi scappa dalproprio Paese per motivi di persecuzione o di guerra. Ma gli enti locali, leassociazioni, le comunità, troppo spesso sono davvero lasciate sole a fron-teggiare queste situazioni di emergenza e, talvolta, appunto la legislazionenazionale, la legge Bossi-Fini, adesso con questo regolamento attuativo,ma comunque con una politica di chiusura non solo non affronta, ma osta-cola grandemente anche l’utilizzo di quegli strumenti normativi che pure ilnostro Paese ha per far fronte ad alcune situazioni di rischio.
Faccio riferimento all’articolo 18 della precedente legge che riguar-dava la tutela delle donne vittime di tratta, con le difficoltà attuative chenoi ci troviamo oggi a fronteggiare di fronte ad una legge tuttora in vigo-re. E faccio riferimento a quella sfera di diritti sociali elementari che variconosciuta a prescindere dalla regolarità o meno dei titoli di soggiorno eche, per esempio, gli enti locali come il nostro garantiscono a prescinderedalla regolarità o meno dei titoli di soggiorno, ma che tuttavia sono og-getto, possono essere oggetto, di azioni del tutto discrezionali perché at-tualmente tutto ciò non è riconosciuto da una legislazione nazionale.
Quindi da questo punto di vista certamente le preoccupazioni sonomolte e anche un po’ l’aspettativa che, in questo quadro, gli enti localihanno nei confronti degli indirizzi delle politiche europee, che noi ve-diamo, in questa fase, come una delle possibilità per creare un quadrodi diritti più certo, che consenta ai diversi livelli amministrativi, ciascu-no con le proprie responsabilità, di svolgere meglio il proprio lavoro.
Noi a Roma in Consiglio comunale approveremo - proprio in que-sti giorni - i Consiglieri aggiunti, cioè delle figure delle comunità stra-niere che affiancheranno il Consiglio comunale nella decisione e nell’e-spressione delle valutazioni delle politiche cittadine in attesa di averestrumenti più compiuti, come la partecipazione al voto amministrativo.Si tratta di un segnale, perché se certamente lo sforzo per il riconosci-mento dei diritti va portato avanti, è molto importante aprire spazi dipartecipazione civile e di partecipazione democratica. Non è un di più,non è un’aggiunta e io credo molto che, nella capacità delle comunitàstraniere presenti nei nostri Paesi di autorganizzarsi, di promuovere e dirivendicare i propri diritti e la propria dignità, stia anche molto del futu-ro delle politiche di integrazione.
81
MAURIZIO SILVERI
Direttore Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Poli-tiche Sociali
Io vorrei parlare di due questioni. La prima è la regolarizzazionedei cittadini stranieri presenti sul territorio italiano in modo irregolare ela seconda è quella relativa al regolamento di attuazione della nuovalegge sull’immigrazione, la cosiddetta Bossi-Fini.
Considero utile affrontare il tema della regolarizzazione perché co-stituisce la premessa per qualsiasi processo di integrazione di circa700.000 persone. Non è un’operazione di esclusiva competenza del Mi-nistero dell’Interno, non è solo una questione di ordine pubblico. È unargomento su cui anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche socialiè coinvolto e che affronta, in un’ottica di raggiungimento di legalità,cioè di messa a norma delle condizioni di lavoro di queste persone, an-che l’obiettivo di favorirne i processi di integrazione, che dipendonodalle condizioni legali in cui il cittadino straniero si trova sul territorioitaliano.
È la premessa, non è la soluzione del problema. Questa premessaha delle dimensioni, da un punto di vista organizzativo e dell’impegnodelle amministrazioni coinvolte, enormi, poiché si tratta del più grande,sotto il profilo quantitativo, intervento in materia mai fatto: si tratta di700.000 persone!
Le stime, le previsioni, e anche alcuni primi risultati raggiunti,fanno ritenere che, entro la fine dell’anno, il grosso dell’operazione sarà
82
concluso. In ogni caso, se ci fossero ancora delle aree su cui intervenire,percentualmente molto ridotte, non cambierebbe il significato ed il ri-sultato complessivo dell’operazione: in un anno è stato tutto completato.
Non dico questo per porre l’enfasi su un fatto squisitamente ammi-nistrativo - che pure è importante, perché certe volte basta che funzionil’amministrazione per raggiungere dei risultati, e questa è stata unascommessa vinta - ma dico questo perché sono convinto che, dal prossi-mo anno, queste persone che già sono entrate in un canale di ufficialità,di legalità, potranno teoricamente accedere ai servizi che spettano loro,avranno diritti e doveri. Dico teoricamente in modo provocatorio per-ché l’integrazione, l’inserimento di 700.000 persone all’interno dellamacchina amministrativa dei servizi a livello regionale, a livello locale,è un impegno enorme, su cui tutti dovremo fare i conti e su cui tutti do-vremo misurarci.
A mio parere questa vicenda della regolarizzazione è letta in modoparzialmente errato, mi premeva quindi valorizzarne l’aspetto di oppor-tunità di integrazione per una quota enorme di cittadini stranieri.
La seconda questione di cui voglio parlare è invece il regolamentodi attuazione. Io credo che questo regolamento di attuazione sia perfet-tibile. Ci sono occasioni per eventuali modifiche ritenute utili e ragione-voli perché il regolamento è attualmente alla Conferenza unificata, ilsuccessivo passaggio sarà al Consiglio di Stato, dopodiché i tempi perla sua emanazione saranno abbastanza rapidi. Quindi chi vuole apporta-re modifiche ha il tempo ed il luogo per farlo. Credo che l’apporto chele Regioni potranno fornire in questo processo sarà significativo e potràintegrare quanto definito dalle amministrazioni centrali. Ritengo chequesto regolamento - naturalmente sto parlando delle aree che mi com-petono, cioè il lavoro e l’integrazione - contenga degli elementi di novi-tà significativi.
Un elemento particolarmente significativo è il cosiddetto diritto diprelazione per l’ingresso in Italia attribuito ai cittadini stranieri che han-no partecipato a corsi di formazione professionale o di insegnamentodella lingua italiana nel loro Paese di origine, promossi da Regioni ita-liane, Enti locali italiani, Organismi internazionali, Parti sociali, Sinda-cati e Organizzazioni imprenditoriali. I cittadini stranieri che faranno
83
corsi di questo tipo godranno di una sorta di corsia preferenziale nel-l’ingresso in Italia per motivi di lavoro, introdotta anche per venire in-contro alla esigenza degli imprenditori di formare e selezionare la pro-pria manodopera.
Il regolamento prevede che nel decreto flussi annuale venga inseri-ta una quota specifica per queste persone, proprio per garantire il loroingresso. Questo, a mio parere, è un grande elemento di novità, non so-lo perché viene incontro a ciò che chiedono le imprese, ma anche per-ché dà impulso alle possibilità di sviluppo, ad esempio dei sistemi for-mativi, dei Paesi stranieri.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sta realizzando, inattuazione di queste disposizioni e anticipando l’emanazione del regola-mento, un progetto “pilota” in Tunisia, con il coinvolgimento di Lom-bardia e Veneto, per selezionare, formare, insegnare l’italiano, utiliz-zando strumenti messi a punto, tra l’altro, anche dal precedente Gover-no. E’ qui presente l’ex Ministro Livia Turco che ha promosso un’atti-vità estremamente consistente per quanto riguarda l’apprendimento del-la lingua italiana, che adesso stiamo sviluppando, proprio partendo daquel canale aperto a suo tempo con la Rai e con la società Dante Ali-ghieri.
Allora, ci sono due passaggi che dovrà ancora fare questo regola-mento di attuazione: Conferenza unificata e Consiglio di Stato. Chi ri-terrà opportuno proporrà delle modifiche e però io credo si debba sape-re che ci sono delle cose buone, basta leggersi i testi. Ci sono delle cosebuone al di là del punto di vista politico da cui si guarda.
Siccome io sono un funzionario dello Stato devo presentare le co-se così come sono. Considero le nuove norme un grande elemento dinovità, di flessibilizzazione in senso positivo delle regole del mercatodel lavoro in cui operano i cittadini extracomunitari e questo progettopilota in via di realizzazione credo possa essere la dimostrazione di tut-to ciò.
84
GIUSEPPINA COPPO
Delegata dell’Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale della Re-gione Lombardia
Integrazione sociale
Il territorio lombardo presenta delle caratteristiche peculiari rispet-to al fenomeno migratorio che lo distinguono da altre regioni italiane edanticipano alcuni processi rispetto ad altre aree territoriali. Le caratteri-stiche sociali degli stranieri in Lombardia sembrano indicare una note-vole variabilità in relazione alle modalità di insediamento, ai caratteridell’integrazione, al capitale sociale e al contesto culturale di partenza.
La popolazione straniera non è un insieme indistinto ma è un col-lettivo complesso ed è possibile identificare percorsi di inserimento edintegrazione differenziati ma omogenei all’interno dei contesti culturalisociali ed economici d’origine.
Nella ricerca svolta nel 2002 dall’Osservatorio regionale si riscon-tra che il 52,3% degli extracomunitari è occupato regolarmente (il59,8% per il sottouniverso maschile), questa stabilità è strettamente cor-relata anche con l’epoca di arrivo in Italia.
Risiedono in Lombardia extracomunitari inseriti ed integrati chehanno capacità di produrre reddito, di acquistare casa, ecc., e che nonrientrano quindi nei programmi di integrazione.
Alla base della programmazione regionale in materia di politichedell’immigrazione e degli stranieri che vivono e lavorano nel territoriolombardo vi è quindi la consapevolezza della complessità del fenomenomigratorio.
85
L’approccio seguito dalla Regione Lombardia è stato quello di de-finire un programma articolato delle politiche di accoglienza e di inte-grazione nella prospettiva di sostenere il progetto di vita degli immigra-ti più fragili in correlazione alle preoccupazioni e ai bisogni della popo-lazione locale. Quando si parla di integrazione è necessario ragionaresecondo quattro dimensioni:
- la stabilità insediativa,
- la precarietà lavorativa,
- la variabile culturale,
- l’anzianità di permanenza.
La Regione Lombardia ha dato completa attuazione alle disposi-zioni ed alle possibilità derivanti dal quadro normativo e programmato-rio sancito dalla L. 40/98, il cui operato è proseguito coerentemente allemodifiche della Legge 189 del 30 luglio 2002.
Ci pare utile richiamare le seguenti principali azioni praticate dallaRegione Lombardia nelle politiche per l’integrazione degli stranieri:
• l’elaborazione del programma annuale regionale per l’attuazione dellepolitiche di integrazione degli stranieri teso a finanziare le misure re-lative all’accoglienza, all’istruzione degli stranieri ed educazione in-terculturale, alle politiche alloggiative e all’assistenza sociale, all’in-tegrazione sociale, al contrasto alle discriminazioni;
• la nomina dei rappresentanti regionali nell’ambito dei consigli territo-riali istituiti presso le Prefetture con competenze sul territorio provin-ciale. Organismo che opera a livello sub-nazionale in materia di im-migrazione e che rappresenta a livello territoriale il maggior peso isti-tuzionale sull’argomento;
• l’istituzione dell’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multie-tnicità (di cui descriveremo successivamente i compiti assolti);
• le attività organizzate direttamente dalla Direzione Generale Famigliae Solidarietà Sociale per la sperimentazione di progetti pilota nell’ot-tica di intervenire nelle aree più sollecitate dalla domanda di integra-zione e nelle aree di problematicità non ancora esplorate sufficiente-mente in termini di risposte adeguate a prevenire situazioni di disagio
86
e di contrasto sociale.
Il processo avviato ha mirato al conseguimento dei seguenti obiettivi:
- utilizzare, oltre alle risorse autonome regionali, i finanziamenti resi di-sponibili dall’istituzione del Fondo Nazionale per l’Immigrazione, oraFondo sociale (art. 43 legge 40/98 art. 45 legge 189/02) che ha asse-gnato alla Regione Lombardia la somma complessiva di 37,6 milionidi euro nel quinquennio 1998/2002;
- ricondurre tutti gli interventi regionali al quadro programmatorio organi-co dei Programmi regionali di Sviluppo. Importante a questo fine è statala “reale collaborazione” che il sistema delle autonomie lombardo ha sa-puto costruire realizzando una forte sussidiarietà tra la regione, gli entilocali (ai quali è riconosciuta l’esclusività delle proposte progettuali diinserimento nei piani regionali)e gli organismi del volontariato (che re-stano la componente maggioritaria delle gestioni e delle realizzazionidelle iniziative definite nel programma regionale);
- realizzare una rete di interventi nei settori maggiormente sollecitatidalla domanda di accoglienza e di integrazione;
- la predisposizione di centri di accoglienza e di attività di integrazione;
- la formazione linguistica, l’orientamento socio culturale e la media-zione culturale, l’informazione a tutti, immigrati neoarrivati e di lun-ga permanenza, cittadini italiani, operatori e amministratori;
- l’inserimento lavorativo e professionale;
- la tutela delle donne e dei minori e il sostegno all’ integrità dei nucleifamiliari;
- attivare l’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicitàsulla base degli strumenti di supporto conoscitivo, indispensabili allaprogrammazione regionale e locale, in raccordo con gli Osservatoriprovinciali sull’immigrazione. L’osservatorio regionale - previsto eprescritto dalla legislazione nazionale e dalla programmazione regio-nale - collega in modo programmaticamente coordinato;
- la rete regionale degli osservatori locali: 10 Provinciali e 5 Comunali;
- la rete regionale dei centri di produzione scientifica;
87
- Fondazione ISMU;
- Università degli Studi di Milano Bicocca;
- Università Cattolica del S.Cuore di Milano;
- Università degli Studi di Milano;
- Politecnico di Milano;
- Centro di ricerca Synergia;
- Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.
L’Osservatorio rappresenta la prima iniziativa organica di questogenere avviata da una Giunta Regionale, riconosciuta a livello europeocome esperienza esemplare, sia per quanto riguarda l’estensione territo-riale, sia per la gamma delle aree di studio affrontate.
Il compito assunto dall’Osservatorio Regionale è anche quello didivulgare i risultati conseguiti. Il nuovo servizio rende facilmente ac-cessibile la banca dati attraverso il collegamento ai siti internetwww.famiglia.regione.lombardia.it e www.ismu.org nella sezione Os-servatorio Regionale.
Il modello dell’Osservatorio regionale consente non solo una de-scrizione dei diversi ambiti di attenzione della realtà osservata ma di:
- razionalizzare le informazioni e ridurre sovrapposizioni e diseconomie;
- suggerire piste interpretative sia a livello territoriale sia a livello tematico;
- promuovere strategie di intervento tra i diversi soggetti istituzionali esociali;
- assicurare la partecipazione agli organismi di supporto e di coordina-mento delle politiche migratorie nazionali e locali. E’ attivata la parteci-pazione ai Gruppi di lavoro in cui è articolato l’Organismo Nazionale diCoordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri(art. 42 T.U./98) istituito presso il CNEL. E’ garantita l’adesione aiConsigli territoriali istituiti presso le singole Prefetture con la nomina diun rappresentante regionale in ciascun consiglio territoriale;
- accreditare risorse aggiuntive ministeriali definite attraverso la sottoscri-zione di accordi tra Ministero del Lavoro e della politiche sociali e la
88
Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.
La contestuale razionalizzazione programmatoria ed organizzativae la felice convergenza tra le azioni dei livelli istituzionali e quelle degliorganismi del terzo settore ha consentito il raggiungimento degli obiet-tivi posti dalla legislazione nazionale e dalla programmazione regionalei cui risultati sono evidenziati nei seguenti prodotti:
- alto numero di progetti definiti dagli Enti locali, finanziati e realizzatinel quinquennio 98-2002 che hanno assorbito il 90% delle risorse sultotale, il 10% ha sviluppato progetti di carattere regionale;
- alto utilizzo delle disponibilità finanziarie anche in termini di cofinan-ziamento da parte dei soggetti pubblici e del privato sociale territoriali;
- alto grado di realizzazione (un solo progetto revocato su n. 701 Pro-getti finanziati);
- efficienza e semplificazione amministrativa in termini di istruttoria,monitoraggio e decentramento;
- istituzione dell’osservatorio;
- realizzazione delle sperimentazioni regionali.
Sperimentazioni di progetti pilota
Particolare attenzione è stata data dalla Regione Lombardia allasperimentazione definita con il Ministero del Lavoro e delle PoliticheSociali finalizzato alla realizzazione di un progetto pilota per l’integra-zione sociale degli immigrati. Il progetto Pilota è articolato in sei speri-mentazioni specifiche coerenti con i documenti della programmazioneregionale 2002-2004 (DPEFR e PSSR) a cui corrispondono i seguentiprincipali obiettivi:
- la promozione di programmi di alfabetizzazione per la comunicazionein ambito socioeducativo. Il progetto si propone di dare risposte con-crete al bisogno di strumenti funzionali alla facilitazione del processodi integrazione fra il mondo della scuola e quello delle famiglie assi-curando pari opportunità di informazione a tutti e predisponendo sup-porti agli operatori scolastici coerentemente con quanto previsto nellediverse circolari ministeriali in materia di dialogo interculturale;
89
- lo sviluppo della funzione di mediazione linguistico cultuale in ambitoamministrativo presso gli uffici stranieri delle Questure che per speci-fiche competenze interagiscono con l’utenza straniera;
- la promozione della permanenza legale informando sull’acquisizionedella carta di soggiorno da parte della popolazione straniera;
- la riduzione del disagio abitativo. Il progetto, attraverso azioni congiunte,mira ad aumentare l’offerta alloggiativa, sia dal punto di vista quantitati-vo sia dal punto di vista qualitativo in termini di maggiore integrazione;
- l’inserimento sociale e lavorativo degli stranieri regolarmente presen-ti. Tramite una ricerca-intervento, formalizzata alla conoscenza dellecaratteristiche degli stranieri temporaneamente non occupati, si svi-luppa la sperimentazione di nuovi servizi per l’inserimento/reinseri-mento lavorativo;
- l’inserimento lavorativo per il governo dei flussi migratori. Favorire eprogrammare un governo ed una gestione controllata ed assistita deiflussi migratori in sinergia con i mercati del lavoro locali e in coeren-za con le possibilità di accoglienza offerte dal territorio.
Il progetto Pilota è stato reso operativo tramite convenzioni ed in-tese Esso vede coinvolti il Ministero dell’Interno e le Questure, il Mini-stero dell’Istruzione, Università e Ricerca e la Direzione Scolastica Re-gionale della Lombardia, l’Agenzia regionale per il lavoro, l’Osservato-rio regionale e la Fondazione ISMU, le Amministrazioni locali e il ter-zo settore impegnato sui temi dell’immigrazione.
Cooperazione allo sviluppo
Dal 1995, la Giunta regionale della Lombardia ha dato vita aquanto dispone la legge regionale 20/89, “La Lombardia per la pace e lacooperazione allo sviluppo”, disponendo che la maggior parte dei fondistanziati per la cosiddetta “cooperazione decentrata”, sarebbero statispesi sotto forma di cofinanziamenti alle Ong lombarde di solidarietàinternazionale.
Le Ong di Lombardia, radicate nella società lombarda e ricche del-l’esperienza di una lunga contiguità con le comunità dei Paesi più poveri,erano e sono portatrici di un sapere e di una conoscenza preziosa circa il
90
capitale umano e materiale di quelle comunità, oltre che dei loro problemi.
La sostituzione del “fare per” tramite il “fare con” ha rappresenta-to una svolta epocale sia nel mondo delle organizzazioni umanitarie edel dibattito sullo sviluppo, che nel mondo politico-amministrativo.
Che si tratti di crescita economica, di coesione sociale, di lotta allapovertà o di sviluppo durevole, coinvolgere tutti gli interessati nei pro-cessi di trasformazione è sempre la scelta più corretta.
Fondamentali “incubatrici” di questo tipo di sviluppo ed imprendi-torialità sono da un lato la famiglia, con i rapporti fiduciari che ne deriva-no sul piano sia del lavoro che del credito, e dall’altro la propensione allerelazioni primarie di quartiere e/o di villaggio. I cosiddetti “distretti indu-striali”, sistemi locali di imprese specializzati in un settore produttivo par-ticolare, caratterizzati da elementi di collaborazioni verticali e orizzontalie di competizione interaziendale, rappresentano la continuità delle rela-zioni sociali primarie e il loro esito a livello economico-produttivo.
La funzione della Regione, oltre al supporto alle sue Ong di soli-darietà internazionale per la cooperazione allo sviluppo, si evidenziaanche nelle azioni dirette e indirette svolte a livello locale.
Le Regioni possono rivendicare almeno tre ambiti specifici di pro-pria competenza, in cui la loro azione diretta può risultare determinanteper il raggiungimento degli obiettivi. La prima è l’“area del buon go-verno”, oggi detta anche “institutional and capacity building”, la secon-da è l’area dei servizi del territorio, la terza è l’area dello sviluppo eco-nomico su scala locale.
Il Presidente della Regione Lombardia ritiene che le Regioni ita-liane siano in grado di fornire il supporto necessario per sviluppare iprocessi di decentramento amministrativo, di devoluzione di poteri ecompetenze, di autonomia; sono in possesso delle capacità di gestionedei servizi sul territorio (gas, fognature, trasporti, sanità, ecc.); sono ingrado di dare un contributo all’organizzazione locale del sistema came-rale, delle PMI e alla formazione tecnico-manageriale.
La Lombardia ricopre un importante ruolo nello scambio di capa-cità di gestione ed organizzazione dei servizi: ad esempio lo scambio dicapacità professionale e know-how con strutture sanitarie irakene, mol-dave, albanesi, nicaraguensi, russe.
91
L’azione della Regione Lombardia si orienta, pertanto:
1. nell’intervento a sostegno dello sviluppo umano e sociale delle popo-lazioni dei Paesi in via di sviluppo del Sud del mondo e dei Paesi adeconomia in via di transizione, nonché delle popolazioni dei Paesiannualmente individuati dal Ministero degli Affari Esteri quali areedi interesse per la cooperazione allo sviluppo;
2. nell’intervento a fronte di situazioni di emergenza umanitaria causateda gravi calamità o conflitti;
3. nella realizzazione di interventi di iniziativa diretta;
4. nella definizione di azioni concrete a favore della sensibilizzazione eformazione, sul proprio territorio, relativi alle tematiche legate allosviluppo solidale, all’interculturalità, alla mondialità e alla pace econtestuale promozione di enti, associazioni e ONG lombarde che o-perano in tema di cooperazione decentrata;
5. nel favorire l’attività di coordinamento delle diverse, iniziative e diraccordo tra i diversi soggetti su tematiche specifiche.
6. La Regione Lombardia, inoltre, in linea con i principi di azione stabi-liti dalla Legge regionale 20/89 può attivarsi per la realizzazione diprogetti proposti dal Ministero degli Affari Esteri o dall’ONU e dallaUnione Europea per la cooperazione allo sviluppo.
Dal 1996 sono stati erogati circa 7,5 milioni di euro per progetti e-laborati dalle Ong e dalle loro controparti nei Paesi in via di sviluppo.
Da quanto sopra emerge la necessità di lavorare per migliorarel’integrazione degli interventi tra tutti i soggetti coinvolti nella rete so-ciale, siano essi pubblici e/o privati, anche nella prospettiva di trovarerisposte adeguate ai nuovi bisogni relativi al fenomeno migratorio, natia seguito della crescita della consistenza numerica degli immigrati, deiproblemi legati alle spinte all’integrazione e dalla necessità di sviluppa-re e sostenere modelli di impulso all’economia locale dei Paesi di origi-ne. Una soluzione a questi nuovi bisogni è individuata in forme associa-tive e professionali, nell’ambito del terzo settore integrate con le istitu-zioni per affrontare i problemi evidenziati.
92
ENRICA SARDEI*Assessorato alle Politiche della dicurezza e dei flussi migratori dellaRegione Veneto
Porto il più cordiale saluto della Giunta regionale del Veneto, delsuo Presidente Giancarlo Galan, ed in particolare dell’Assessore regio-nale alle Politiche dei Flussi Migratori e della Sicurezza, Raffaele Za-non, al Prof. Alessandrini, agli autorevoli rappresentanti delle istituzio-ni ed a tutti i convenuti.
L’Assessore Zanon si trova in missione a Montreal per parteciparead un programma di incontri con le comunità venete del Nord Americae mi ha delegato a rappresentarlo ed a manifestare il suo grande interes-se per il confronto avviato da questa Conferenza su temi strategici perl’adozione di quello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia cheil Trattato di Amsterdam ha posto tra gli obiettivi prioritari delle politi-che comunitarie.
Nel processo di europeizzazione delle problematiche dei flussi mi-gratori, e di contestuale europeizzazione delle politiche di integrazione,le comunità locali e tutto il sistema delle autonomie sono a tutti gli ef-fetti interlocutori, che hanno pieno titolo ad esserci e a contare.
Se l’integrazione del cittadino immigrato e la coesione sociale diuna comunità sono, come sono, una fondamentale risorsa di civiltà e diprogresso per l’Unione, il ruolo delle amministrazioni impegnate a ge-stire a valle il fenomeno migratorio e a governarne l’impatto sul territo-
93
__________* Testo non rivisto dall’autore
rio diventa centrale e paradigmatico. Non dobbiamo dimenticare la por-tata di questo impegno; né che l’evoluzione e la rapidità del fenomenoimmigratorio in Italia ha comportato, per le istituzioni locali, problema-tiche di rilievo, anche in relazione ad effetti di disorientamento dellacittadinanza e un impegno straordinario di reperimento di strumenti, ri-sorse, progettualità, in grado di dare risposta alle nuove domande socia-li. Un impegno reso ancor più complesso dalla trasversalità dell’immi-grazione, che investe ogni aspetto della quotidianità, e dalle tante varia-bili derivanti dai contesti sociali ed economico produttivi.
Questo impegno ha sviluppato esperienze, know-how, che per di-ventare patrimonio comune va valorizzato con politiche di sistema neiprogrammi di lavoro per la realizzazione dello spazio comune europeodi libertà, sicurezza e giustizia.
È il momento di condividere problemi e soluzioni, facendo tesorodell’esperienza dei Paesi di più vecchia immigrazione. Il dialogo tra cit-tà, regioni, Paesi deve diventare consuetudine.
In quell’immenso crocevia di flussi migratori, quale oggi viene de-finita l’Europa, emblematico è il caso del Veneto che, già terra di emi-grazione, è divenuto, in una sorta di rivoluzione copernicana, luogo diresidenza di oltre 200.000 immigrati non comunitari, la terza in Italiaper consistenza del fenomeno.
Il declino demografico, con diminuzione della popolazione in etàlavorativa, rappresenta la principale causa, in una regione di piccole emedie imprese, dell’apertura ai lavoratori stranieri del mercato dellaproduzione e del subentro del lavoro immigrato in importanti compartidell’industria, del commercio, dei servizi. Aumenta l’occupazioneextracomunitaria anche presso le famiglie.
I recenti dati sull’emersione del lavoro irregolare, introdotta dallalegge 189 - a questo proposito devo dire che nel Veneto siamo ad unbuon punto, con la conclusione della regolarizzazione, in particolare laProvincia di Vicenza, una delle più investite dal fenomeno migratorio,ha concluso - indicano che, su oltre 60.000 pratiche di legalizzazione,quasi 20.000 riguardano l’ambito domestico e l’assistenza alla persona.
94
Sono lavoratrici che arrivano nella nostra Regione come protagoniste diautonomi percorsi migratori al femminile, finalizzati al sostegno econo-mico delle famiglie rimaste nei Paesi di origine, protagoniste per troppotempo invisibili e non contabilizzate dalle statistiche. Ne consegue unaimmigrazione diffusa, che non si concentra nelle città, ma segue sul ter-ritorio la dislocazione delle imprese e delle famiglie, strutturandosi gra-dualmente in immigrazione stabile.
Il programma di legislatura del governo regionale, il piano regio-nale di sviluppo, la pianificazione pluriennale e annuale, tracciano le li-nee di indirizzo degli interventi di integrazione. Se il contrasto all’im-migrazione clandestina è riservato dall’ordinamento alla competenza e-sclusiva dello Stato, non vanno trascurati quegli obiettivi di equità equalità sociale che sono alla base della civile convivenza e su cui il Ve-neto ha investito anche grazie alle intese tra istituzioni, parti sociali,mondo associativo. Mi riferisco in particolare alla lotta al sommerso, allavoro nero della manodopera immigrata, agli alloggi fatiscenti, alle o-perazioni speculative del mercato degli affitti, allo sfruttamento lavora-tivo in seno alle stesse comunità immigrate. Dunque, sulla legalità co-struire un quadro coerente e articolato di interventi, tanto sul versantedella determinazione quali-quantitativa dei flussi, quanto sul versantedel superamento delle specifiche difficoltà connesse alla condizione diimmigrato. Il Veneto ha sempre sostenuto il vantaggio collettivo di darespazio alla peculiarità territoriale nella quantificazione delle quote, siasul fronte del fabbisogno, che su quello delle possibilità di assorbimen-to dell’immigrazione. Coerentemente la Regione, insieme al suo siste-ma delle autonomie e delle parti sociali riunite nel Tavolo Unico regio-nale di coordinamento, intende utilizzare fino in fondo gli spazi e le o-pzioni che la legge 189 offre alle Regioni e, in particolare, quei titoli diprelazione, di cui ha parlato poc’anzi il Dott. Silveri, che la rinnovatanormativa prevede per l’ingresso di lavoratori stranieri già partecipantiad attività di istruzione e formazione nei Paesi di origine.
Un obiettivo su cui si sta costruendo, con azioni congiunte, deipropri osservatori lavoro e immigrazione, per la verifica e il monitorag-gio dell’evoluzione immigratoria, anche in relazione ai processi di delo-calizzazione delle imprese e di allargamento dell’Unione Europea. Po-trei fare una lunga serie di interventi di integrazione, soprattutto riguar-
95
danti la formazione linguistica, formazione civica, formazione alla si-curezza nei luoghi di lavoro, formazione delle donne immigrate, tuttitemi che abbiamo trattato in accordi di programma con le sette Provincevenete.
Particolarmente complessa, inoltre, è la partita dell’accesso allacasa per gli stranieri, per motivi che tutti conosciamo, quali la resisten-za dei proprietari a dare in locazione le case, la scarsa flessibilità delmercato dell’affitto, che nella nostra Regione è un problema particolar-mente forte perché i veneti nel tempo hanno avuto sempre l’obiettivo diavere una propria casa e quindi non c’è disponibilità di case. Su questequestioni primarie la Regione Veneto ha attivato le autonomie locali, inparticolare i Comuni, anche mettendo a disposizione degli appositi fon-di e ha attivato convenzioni con le aziende territoriali di edilizia resi-denziale per la costruzione di alloggi temporanei, nell’ambito di proget-ti comprensivi anche di percorsi e strumenti di affiancamento ed ac-compagnamento sociale. Inizierà tra breve anche un progetto di comu-nicazione che, attraverso l’utilizzo dei mass-media, ha l’obiettivo dicontrastare ogni forma di razzismo e di favorire il dialogo sociale traveneti e nuovi cittadini in parità di diritti e doveri.
Concludo accennando a due progetti particolarmente innovativi,calibrati su obiettivi avanzati.
Il primo è un progetto di formazione dei leader e dei quadri delleassociazioni degli immigrati. Questo progetto, che sta per concludere lasua prima edizione, ha aperto canali di dialogo di grande interesse tra i-stituzione regionale e le oltre cento associazioni immigrate presenti nelVeneto. Si vuole, in sostanza, e qui riprendo un obiettivo che il CNELha spesso sostenuto, andare al di là delle feste etniche e dell’autorappre-sentazione per trovare, nelle associazioni degli immigrati, degli interlo-cutori permanenti a tutti gli effetti per le grandi questioni di caratterereligioso e culturale.
Il secondo progetto si fonda sulla costituzione di una rete di informa-zione e raccordo tra operatori pubblici e privati attivi nell’integrazione so-ciale e lavorativa della popolazione immigrata. Questa rete è già a buonpunto, vi partecipano i Comuni, le Province, le associazioni datoriali, ec-cetera. L’obiettivo è quello di costituire una comunità professionale in gra-
96
do di scambiare e trasferire in tempo reale, anche con l’aiuto della piatta-forma Internet, soluzioni, interventi, notizie, documenti, e quant’altro.
MALIKA HORCHANI
Coordinatrice della Maison des femmes di Tunisi
Questa ricerca vuole essere una valutazione delle conseguenzedell’emigrazione maschile sulle mogli rimaste nel Paese d’origine. Ilsuo obiettivo è porre l’accento sull’evoluzione dei ruoli femminili cau-sata dai cambiamenti intervenuti nella loro vita per sfatare un po’ lacredenza comune secondo la quale in una società arabo-musulmana, ilruolo della donna è pressoché fossilizzato all’interno di un quadro pre-stabilito che risale all’epoca della rivelazione e i cui limiti non sono maistati o non devono mai essere superati. Poiché stiamo parlando del ruo-lo della donna in un contesto arabo-musulmano, si ha la tendenza a fareriferimento quasi automaticamente al modello ideal-tipico che ha comeelementi costanti e immutabili la passività, la reclusione nello spaziodomestico, la superiorità dell’uomo sulla donna e della comunità sul-l’individuo. S’invoca costantemente il riferimento religioso o l’originetrascendente della norma per non lasciare alcuno spazio al cambiamen-to, come se l’impronta religiosa fosse rintracciabile solo nelle società a-rabo-musulmane e la nozione di cambiamento sociale non potesse mairiguardare simili società. Si riconosce per esempio che in Occidente ladivisione sessuale dei ruoli fondata sulla differenza di genere, consacra-ta dalla religione ed iscritta nei codici, sia scomparsa totalmente nellalegislazione se non nella pratica. Tutto questo in seguito agli sconvolgi-menti ideologici e economici dell’Ancien Regime dopo la Rivoluzione
97
Francese. Tuttavia, parlando del Maghreb, Regione nella quale i cam-biamenti sono avvenuti ad un ritmo più accelerato, si continua a ragio-nare come se il modello tradizionale fosse ancora totalmente vigente.Tuttavia, dal XIX secolo questo modello è stato scosso e messo in di-scussione dai molteplici cambiamenti che hanno investito la società ma-grebina. Sotto l’effetto congiunto di una serie di fattori, quali la colo-nizzazione, l’introduzione dell’economia di mercato, l’istruzione, il la-voro retribuito delle donne, l’emigrazione, il controllo delle nascite o lapolitica moderna di alcuni capi di Stato, ha aperto brecce sempre piùampie nel sistema tradizionale facendo emergere numerose trasgressio-ni che si situano spesso ai margini del diritto e dei codici. Questi cam-biamenti non sono stati esenti dalle resistenze, dalle contraddizioni edai conflitti inerenti ogni periodo di transizione. Fattori quali l’urbaniz-zazione, la scolarizzazione delle bambine o l’emigrazione hanno acce-lerato notevolmente qualunque cambiamento.
L’emigrazione, che introduce un brutale elemento di rottura con lostile di vita precedente e che obbliga al confronto con altri modelli cul-turali, costituisce un ambito privilegiato dei cambiamenti che riguarda-no il ruolo della donna. In questo intervento, vorrei parlare delle conse-guenze delle migrazioni internazionali sulle mogli che vengono toccateindirettamente dal fenomeno migratorio. Questo lavoro fa parte di unaricerca globale che comprende tre categorie di donne coinvolte diretta-mente o indirettamente dall’emigrazione degli uomini. Ognuna di que-ste tre categorie corrisponde, secondo l’espressione di A. Sayad, a unadelle “tre età” dell’emigrazione maghrebina in Europa. Oltre alle moglirestate nel Paese di origine, le altre due categorie sono quella delle don-ne che dagli anni ‘70 condividono l’esperienza migratoria con i mariti equella di ragazze adulte, figlie di genitori emigrati, nate e cresciute inFrancia.
La migrazione per motivi di lavoro è stata fino a qualche tempo faun fenomeno prettamente maschile e, di conseguenza, il ruolo delle mo-gli che restavano nel Paese di origine o che seguivano i mariti all’esteroè stato, per molto tempo, considerato trascurabile perché non aveva unarelazione “visibile” con il lavoro. Tuttavia, grazie ad una coscienzafemminista che comincia ad affermarsi nelle ricerche e grazie ad un in-teresse crescente per l’evoluzione del ruolo della donna nella società
98
tradizionale, il ruolo svolto dalle mogli degli emigranti inizia ad esseresottolineato.
Attualmente, considerando gli sconvolgimenti subiti dalle societàtradizionali che sono stati, tra gli altri, una delle cause delle migrazioniche a loro volta hanno svolto un ruolo importante nell’accelerazione deicambiamenti, il sistema tradizionale non funziona più con lo stesso ri-gore e le donne non hanno più un ruolo prettamente ed esclusivamentepassivo. Pur non essendo esplicitamente definito e socialmente ricono-sciuto, il ruolo che svolgono nella costellazione familiare proprio a cau-sa dell’assenza del capo famiglia ufficiale e dell’allentamento dei vin-coli tradizionali di solidarietà lascia alle donne un margine di libertàsempre maggiore.
Si tratta di valutare gli effetti indotti dall’assenza prolungata delcapo famiglia abituale, di analizzare gli adattamenti sociali ai quali ledonne interessate sono costrette e di valutare le ripercussioni che la si-tuazione nella quale si trovano avrà necessariamente sullo status e suiruoli che tradizionalmente gli sono riconosciuti.
L’assenza prolungata del coniuge sconvolge i rapporti all’internodella famiglia. Ridefinendo lo status del padre, trasforma la totalità deiruoli degli altri membri della costellazione familiare. Queste trasformazio-ni, che in alcuni casi possono tradursi in rotture traumatiche, spesso sfocia-no in adeguamenti inediti dello status e dei ruoli degli uni e degli altri.L’importanza dell’assenza prolungata del capo famiglia è legata al fattoche, introducendo uno squilibrio all’interno di un’organizzazione socialeorientata attorno al ruolo preponderante del coniuge-padre, obbliga ad unadeguamento più rapido, accelerando quindi il processo di cambiamento.
Nelle ricerche sulle migrazioni internazionali, la valutazione del-l’impatto dell’emigrazione sulle donne è un argomento poco dibattuto eanche quando è presente le donne vengono generalmente ritratte comeappartenenti soprattutto al gruppo familiare e domestico e raramentecome individui autonomi, impegnati in relazioni interpersonali con ilconiuge o con la famiglia. E’ solo a partire dagli anni ‘80 che le ricer-che e gli studi sulle donne hanno cominciato a mostrare interesse per u-na nuova problematica sempre più incentrata sulla loro condizione inquanto donne e sulla situazione nella quale si trovano all’interno di un
99
sistema nel quale le disuguaglianze cominciano ad essere esplicitamen-te stigmatizzate.
L’occultamento del ruolo di questa categoria di donne senza co-niuge che sono rimaste nel Paese di origine ma che non sono né nubili,né vedove, né divorziate, non appartiene solo al Maghreb ma è comunea tutti Paesi del Sud del bacino del Mediterraneo esportatori di manodo-pera maschile.
Condannando questa situazione, l’UNESCO, in occasione del-l’Anno internazionale della donna, ha pubblicato uno dei primi studi suquesto tema. Sebbene questa ricerca non affronti il caso maghrebino, iproblemi esposti - quali il doppio ruolo che deve svolgere la donna ilcui marito è emigrato, la diffidenza mista ad una certa invidia cui è sog-getta, i conflitti di autorità che deve affrontare - sono applicabili anchealla Tunisia, tenuto conto della vicinanza delle culture mediterranee. U-na conferma di ciò viene, tra l’altro, da una ricerca che abbiamo con-dotto sull’argomento e che evidenzia che, pur accettata con rassegna-zione come un male necessario, l’assenza prolungata del coniuge e lemolteplici responsabilità che comporta hanno delle ripercussioni evi-denti sull’equilibrio psichico di alcune donne e sugli atteggiamenti edu-cativi che esse adottano.
La ricerca
Lo studio riguarda un campione di una cinquantina di mogli di e-migranti che vivono nelle principali zone esportatrici di manodopera eche, per proteggere la stabilità della famiglia, non sono emigrate insie-me al coniuge oppure, se lo hanno fatto per un certo periodo, sono tor-nate in patria quando i figli hanno raggiunto l’età scolare. Si tratta didonne che, a causa dell’assenza prolungata del coniuge, dell’allenta-mento dei vincoli tradizionali di solidarietà e dello sconvolgimento del-le strutture familiari comunitarie (che non possono rimediare totalmentea questa assenza) sono state costrette ad assumersi responsabilità chenon erano previste nella distribuzione tradizionale dei ruoli e ad acqui-sire, così facendo, un margine di libertà sempre crescente. Più che larappresentatività statistica, le interviste condotte hanno avuto come o-biettivo l’approfondimento delle nostre conoscenze di alcuni fenomeni
100
sociali. L’obiettivo finale era perfezionare la conoscenza macroscopicadi questi fenomeni grazie all’analisi psico-sociologica del vissuto dipersone coinvolte in situazioni particolarmente sensibili al cambiamen-to. Il campione è stato “costruito” in maniera tale da considerare i variprofili delle mogli dei lavoratori emigrati che sono restate o ritornatenel Paese di origine (tenendo conto dell’età, del livello di istruzione,della durata della separazione, dell’ambiente di origine, etc...).
Il questionario utilizzato per cogliere al meglio i cambiamenti in-tervenuti nei ruoli della donna in seguito all’assenza del coniuge verteessenzialmente sulle pratiche sociali, quotidiane e non quotidiane; inol-tre analizza anche l’atteggiamento delle donne davanti alla nuova situa-zione nella quale si sono trovate a vivere e chiede una valutazione sog-gettiva della propria esperienza. E’ articolato attorno a due temi centraliche permettono di valutare la distanza che si è creata dai ruoli tradizio-nalmente riconosciuti alle donne.
Il primo tema riguarda le pratiche che potrebbero indicare il livellodi autonomia rispetto alla famiglia allargata. Concerne essenzialmentelo stile abitativo della famiglia dell’emigrante. Il ruolo che le donne sa-ranno chiamate a svolgere cambia notevolmente a seconda della lorocondizione abitativa: abitazione indipendente, condivisione dell’abita-zione con la famiglia del coniuge o con quella della propria famiglia. Ilfatto di vivere in un’abitazione indipendente rispetto al resto del gruppoè un buon indicatore del cambiamento dello status e del ruolo delladonna. Se la scelta di un’abitazione indipendente è considerata general-mente come un buon indicatore della distanza rispetto al modello tradi-zionale, è tanto più significativa quando si tratta di una donna il cui co-niuge è assente per gran parte dell’anno.
Il secondo tema affrontato nel questionario riguarda la divisionedelle attività che spettano generalmente al coniuge. Si tratta di attivitàsvolte fuori casa, che vanno dagli acquisti quotidiani ai lavori agricolipassando anche per il disbrigo delle pratiche e formalità amministrati-ve, il seguire le attività scolastiche dei figli o le loro attività sportive odel tempo libero, come anche la gestione del patrimonio. Queste attivi-tà, che possono essere o totalmente fuori dalla sua competenza o svoltein parte da lei e in parte da un componente maschio della famiglia o
101
completamente a suo carico, corrispondono ai diversi livelli di cambia-mento del ruolo della donna.
I fattori che condizionano i comportamenti femminili rispetto almodello tradizionale familiare sono essenzialmente l’età, il livello d’i-struzione, le esperienze di lavoro retribuito, il confronto con altri siste-mi di valori ed altri modelli familiari ed anche la durata della separazio-ne dal coniuge. L’analisi dei contenuti di queste interviste e di questiracconti di vita vissuta ha fatto emergere un’evoluzione notevole delruolo svolto dalle mogli restate nel Paese di origine rispetto a una venti-na di anni fa.
L’evoluzione consiste soprattutto in un graduale ma crescente al-lontanamento dalla famiglia allargata ed è caratterizzata anche da unaminore passività delledonnenell’ambito delle relazioni tra i due sessi,dalla conquista di spazi esterni e dalla tendenza confermata da diversedonne ad incentrare su di loro i ruoli femminili e maschili.
Infine, l’evoluzione sembra andare verso una maggiore afferma-zione dei valori individuali a scapito dei valori comunitari e si manife-sta nella fattispecie tramite l’individualizzazione del patrimonio, un’a-bitazione indipendente, l’importanza attribuita ai sentimenti e alla liber-tà di scelta nelle decisioni importanti della vita.
La casa
Vivere al di fuori della famiglia allargata è una pratica ormai do-minante nelle famiglie degli emigranti. La grande maggioranza delledonne intervistate vive da sola con i figli, mentre era tradizione che lamoglie di un uomo emigrato restasse sotto la tutela effettiva di un com-ponente maschile della famiglia, generalmente del suocero, presso cuisi trasferiva al momento della partenza del coniuge, a meno che nonfosse il suocero a trasferirsi da lei. In mancanza del suocero, questa fun-zione veniva svolta dalla suocera o dal cognato più grande, che eranoincaricati della sorveglianza e coabitazione.
I tre quarti delle donne intervistate vivono con i loro figli in un’a-bitazione separata da quella della famiglia. E’ pur vero che nella mag-gior parte dei casi si tratta di case situate in prossimità di quella dei pa-renti del marito che s’incaricano di fare le veci del coniuge emigrato. Si
102
tratta però quasi sempre di una supplenza solo formale, il cui obiettivoreale è rassicurare la moglie dell’emigrante piuttosto che di sorvegliar-la. Questa nuova pratica, che è indubbiamente in parte favorita dall’ac-quisto di un alloggio grazie all’emigrazione, è diffusa soprattutto pressole donne più grandi (40-55 anni) che hanno più figli (tre o più), alcunedelle quali hanno già preso una certa distanza dalle abitudini tradiziona-li accompagnando il coniuge all’estero fino all’età scolare del primo fi-glio. Di contro, le donne più giovani (24-28 anni) e quelle con un solofiglio, vivono o con la famiglia del marito o con la propria. Questo con-ferma una sorta di controllo sociale più stretto sulle donne giovani, chepossono sperare di ottenere maggiori libertà solo avendo più figli. Tuttevivono male questa situazione e progettano di (o aspirano a) raggiunge-re il coniuge all’estero o di avere una casa propria.
La tendenza delle mogli degli emigrati rimaste nel Paese d’originead abitare da sole è confermata dai risultati dei censimenti della popola-zione che le inseriscono in una categoria definita “Donne sposate configli”, che è composta da 42.500 persone, mentre le donne che vivonocon la famiglia del coniuge sono solo 5.000 e quelle che vivono con lapropria famiglia sono soltanto 1.830. Per quanto riguarda l’argomentodell’abitazione indipendente, bisogna notare che si tratta di un grandecambiamento rispetto al modello tradizionale di comportamento chestabilisce che, sposandosi, la donna abbandona la propria famiglia perentrare a far parte di quella del coniuge.
Esercizio delle attività cosiddette maschili
Un indice importante dell’evoluzione del ruolo delle mogli degliemigranti seguita all’emigrazione è che nessuna di loro si limita a svol-gere solo ed esclusivamente le attività casalinghe. Nessuna delle donneintervistate si è dichiarata totalmente esonerata, ad opera del marito o diterzi, dalle attività che vengono normalmente svolte dal marito. Menodi una donna su cinque afferma di affidarsi totalmente al coniuge quan-do torna al Paese per la visita annuale o a un altro componente della fa-miglia per svolgere attività particolarmente complesse che hanno a chefare con la gestione del patrimonio (contatti con le associazioni di cate-goria per la costruzione o la ristrutturazione della casa, transazioni com-merciali, quali la vendita dell’auto, etc.). Tutte le altre donne hanno la
103
tendenza a rimediare all’assenza del coniuge svolgendo nel contempo icompiti maschili e femminili, che si tratti delle spese quotidiane, dellepratiche burocratiche ed amministrative, del pagamento di bollette ofatture, etc. E anche quando non si fanno carico completamente e diret-tamente di alcune responsabilità, sono comunque loro ad orientare atti-vamente le decisioni.
Il forte investimento nell’istruzione dei bambini e l’aspirazione avederli accedere a condizioni di vita migliori si traduce, per la quasi to-talità delle donne intervistate che hanno dei bambini in età scolare, nel-l’assunzione totale delle responsabilità relative all’istruzione (iscrizionea scuola, contatti con gli insegnanti, etc.). In questo le donne vengonoaiutate spesso dai figli maggiori ma soprattutto dalle figlie. Certo, sitratta pur sempre di un’estensione del ruolo educativo della madre, masembra che le mogli degli emigrati, animate da un forte desiderio di nonfallire in questa missione, si impegnino con talmente tanta ansia da arri-vare a volte a turbare i rapporti con i figli che, soprattutto durante l’ado-lescenza, accettano difficilmente un’autorità ed un controllo eccessivi.Indubbiamente queste difficoltà, che nascono dallo svolgimento di atti-vità nuove da parte delle madri e in condizioni difficili (separazione dalconiuge, basso livello di istruzione o addirittura analfabetismo), sono avolte all’origine di un basso rendimento scolastico dei figli degli emi-granti - spesso stigmatizzato - anche se in realtà non è molto diverso daquello dei figli di persone della stessa fascia sociale e non emigranti.
Un tentativo di tipologizzazione
Trattandosi di uno studio qualitativo che tenta di cogliere i cam-biamenti in corso senza pretendere di darne una valutazione precisa o diquantificarne i vari fattori suscettibili di favorirli (età, livello d’istruzio-ne, durata dell’emigrazione...), invece che presentare le frequenze di u-na o dell’altra pratica o attitudine significativa di un cambiamento ri-spetto ad un modello tradizionale, ci è sembrato più interessante cercaredi delineare, a partire dal campione intervistato, qualche categoria do-minante di comportamenti e di mettere in evidenza i fattori che si co-niugano per favorirli. L’analisi dei contenuti delle interviste, completatedalle biografie dettagliate di alcune “spose di emigrati” che illustranopiuttosto bene il vissuto comune di molte mogli di emigranti, ha per-
104
messo di identificare tre tipi di comportamenti e di atteggiamenti carat-teristici di tre profili di donne, che potrebbero essere definiti rispettiva-mente “conservatrici,” “transizionali”, “cumulative”.Le conservatrici
L’assenza prolungata del capo famiglia spinge la moglie ad ade-guare il proprio comportamento alla nuova situazione e ad affrontareper forza di cose una situazione alla quale le strutture tradizionali nonsono più in grado di rispondere. Di conseguenza, alcune delle donne in-tervistate non riflettono, nei loro comportamenti, atteggiamenti ed aspi-razioni, il modello ideale tipico della donna arabo-musulmana rinchiusatra le mura domestiche, che si limita a sbrigare le faccende domestichefacendosi guidare passivamente dal padre, dal marito e poi anche dai fi-gli maschi, o da un loro sostituto. Tuttavia, alcune di loro si avvicinanorelativamente a questo modello nella misura in cui il ruolo che svolgo-no in seno alla famiglia è più incentrato sulle attività domestiche e sulbenessere piuttosto che su un’apertura verso il mondo che le circonda ela realizzazione personale. Se poi sono costrette, a causa dell’assenzaprolungata del coniuge e alla mancanza di un sostituto formale, a svol-gere alcuni compiti fuori casa, lo fanno più per rassegnazione e hannola tendenza a scaricare queste incombenze sui figli non appena raggiun-gono l’età per farlo. Pensano che la loro sia una situazione difficile davivere e che una donna senza marito sia una “donna a metà”. Preferi-scono rimettersi ad un uomo della famiglia per alcuni oneri che ritengo-no di non essere in grado di sobbarcarsi, come seguire i lavori di costru-zione di una casa, la scuola dei figli e anche in alcuni casi il disbrigodelle procedure burocratiche e a volte anche dei semplici acquisti. “Chevuoi che ti dica? Prima della partenza di mio marito non avevo maimesso piede al mercato, e lo stesso dicasi della scuola dei figli. E’ luiche li aveva iscritti a scuola, che gli comprava tutto quello che gli ser-viva all’inizio dell’anno scolastico... Da quando è partito, è mio suoce-ro o mio cognato che hanno preso il suo posto ma non è la stessa co-sa... Mio suocero è anziano e non sa leggere, ci sono delle cose che nonpuò fare o che fa male....E mio cognato, pensa solo a spillare denaro...E quindi sono stata costretta mio malgrado ad affrontare tante cose, maper me è molto difficile anche perché gli altri pensano che sia una cosasconveniente che una donna esca di casa a sbrigare le commissioni
105
quando nella stessa casa ci sono degli uomini che potrebbero farlo....Tra poco sarà mio figlio ad occuparsi di tutto e a sostituire il padre”(52 anni, vive a Zarzis con la famiglia del marito e sei figli dai dieci aitrent’anni, due dei quali sono sposati e sono a loro volta emigrati; il ma-rito ha 56 anni, è emigrato in Francia da trenta e lavora a Clermont-Fer-rand).
Questo è il comportamento tipico delle donne analfabete di unacerta età (sopra i 50 anni). In questa categoria ci sono anche donne piùgiovani (25-30 anni) alcune delle quali hanno frequentato solo la scuolaelementare e che hanno o solo un figlio o nessun figlio. E’ in questa ca-tegoria che rientra una percentuale importante di donne che continuanoa vivere con la famiglia del marito. Indipendentemente dall’età, che sia-no analfabete o modestamente alfabetizzate, tutte le donne di questa ca-tegoria riconoscono che, pur essendo piuttosto dolorosa dal punto di vi-sta materiale e affettivo, la loro situazione è meno peggio di quella chevivevano prima che il marito emigrasse, quando avevano addiritturaproblemi di sopravvivenza. Accettano con rassegnazione la situazioneche assicura alla famiglia un livello di vita migliore anche se ad un co-sto psicologico molto elevato. Il loro atteggiamento verso la loro situa-zione è caratterizzato, rispetto alle donne delle altre categorie, da unamaggiore passività. Pur soffrendo per la separazione e per le nuove re-sponsabilità che devono affrontare, si limitano a sperare di uscire primao poi da questa situazione senza fare nulla per riuscirci. Solo le più gio-vani tra di loro aspirano, passivamente, a raggiungere il marito all’este-ro, mentre le più anziane dichiarano di preferire che il marito torni defi-nitivamente in patria. Quelle che hanno già vissuto l’esperienza dell’e-migrazione, accompagnando o raggiungendo il coniuge all’estero, e chesono poi rientrate al Paese di origine per permettere ai figli di andare ascuola, sono quelle che sopportano meno bene la situazione, anche senon fanno nulla per porvi fine: “Non avevo scelta. Sono dovuta rientra-re per far studiare i miei figli; non volevo che studiassero in Francia,soprattutto le femmine, perché lì rischiano di prendere una brutta stra-da come è successo a tante ragazze.... I genitori non riescono più astargli dietro... e dopo non vogliono più tornare in patria quando i ge-nitori decidono di farlo, gli dicono tornate voi se volete, noi restiamoqui.. Ci sono donne che mandano i figli dalle nonne o da una zia e che
106
restano all’estero con il marito, ma io ho preferito sacrificarmi per imiei figli...” (40 anni, vive a Mareth nel sud della Tunisia, ha 4 figli da6 a 16 anni; due frequentano le elementari e due il liceo. Il marito ha 48anni, è operaio specializzato in una ditta di lavori pubblici nella regioneintorno a Parigi e vive in Francia da 22 anni).
Le cumulative
Questa categoria comprende le donne più intraprendenti e più au-tonome del campione. Si tratta di donne che affrontano i problemi legatiall’assenza del marito con un atteggiamento dinamico. Influenzate dallasocietà dei consumi, sviluppano strategie sistematiche per soddisfare iloro bisogni e per migliorare la loro situazione. Sin dalla partenza delmarito, che hanno spesso incoraggiato o motivato, prendono in mano lasituazione: “Prima di emigrare in Francia, mio marito era capomastro.Trovava sempre lavoro perché a M’saken tutti costruiscono... Avevamoil necessario per vivere ma non riuscivamo mai a mettere da parte nul-la per costruire una casa e non ne potevamo più di vivere tutti insiemea casa dei miei suoceri.... Aveva dei cugini che già lavoravano a Nizzae che sono riusciti a costruirsi qui delle bellissime case.... Gli ho detto:‘Perché non fai come loro? Stai via qualche anno e poi ci costruiremouna casa tutta per noi... e poi ritorni qui’. All’inizio era un po’ reticen-te, mi diceva: ‘Come faccio a lasciarvi qui da soli?’ Ma io lo rassicura-vo dicendogli che avevamo la compagnia dei suoi genitori, dei suoi fra-telli.... (42 anni, vive a M’saken in una villa della quale affitta il pianoterra; ha tre figli, dai 7 ai 15 anni; ha lavorato come metalmeccanica inun laboratorio tessile fino al matrimonio. Ha raggiunto il marito inFrancia, dove ha vissuto 6 anni, poi è tornata a M’saken quando il figliomaggiore ha iniziato le elementari; il marito ha 43 anni, lavora vicinoNizza da 18 anni, dove ha svolto diversi lavori senza alcun rapporto conquello che faceva nel Paese di origine, vale a dire l’edilizia. Al momen-to dell’intervista aveva una piccola drogheria di prodotti arabi a Nizzain società con il cugino).
Le donne di questa categoria hanno la tendenza a sostituirsi al co-niuge per svolgere tutti i ruoli che generalmente spettano al marito, anchese a volte incontrano delle difficoltà. Infatti, soprattutto all’inizio della se-parazione, devono fare i conti con situazioni di conflitto di potere con i
107
supplenti abituali del marito o con la reticenza del marito che è diventatogeloso in seguito alla separazione e che non vede sempre di buon occhioil margine di autonomia sempre maggiore che la donna conquista.
Incoraggiate dai mezzi finanziari provenienti dal lavoro del maritoall’estero, sono iperattive e hanno mille progetti da realizzare: la casada costruire o da aggiustare, le cerimonie da festeggiare... e fanno ditutto per ottenere le migliori condizioni possibili per fare fruttare il pa-trimonio accumulato. Avendo acquisito le competenze più diversificatefuori casa, sono costantemente alla ricerca di informazioni utili. Si spo-stano in continuazione, sviluppano reti relazionali, imparano a fare lecose più diverse e a sfruttare al meglio le strutture esistenti. E’ in questacategoria che troviamo la maggior proporzione di mogli di emigrantiche soggiornano frequentemente nel Paese in cui lavora il coniuge, pra-ticando quel tipo di commercio molto particolare definito “commerciocon la valigia”, come quelle che trasformano le loro case in veri negoziin cui espongono i prodotti portati dall’estero. Alcune arrivano addirit-tura a fare il giro dei mercati della regione per vendere i prodotti. Lemaggiori responsabilità che si assumono conferiscono loro un ruolo piùattivo nella dinamica familiare ed un certo potere di negoziazione perfar pendere le decisioni in una direzione a loro favorevole.
L’accumulazione dei ruoli femminili e maschili, che costituisce uncambio radicale rispetto all’abituale divisione su base sessuale e che av-viene in un contesto che non è sempre favorevole, sembra implicare unelevato costo sociale e psicologico del quale le interessate si lamentanospesso; alcune di essere arrivano al punto di ammettere reazioni depres-sive o problemi psicosomatici. “E’ una situazione infernale; sono sem-pre sotto stress... spesso svengo senza ragione”,affermava una delle in-tervistate. E un’altra ha aggiunto: “Per svolgere allo stesso tempo ilruolo di uomo e donna, per essere simultaneamente dentro casa e fuoricasa, ci si gioca la salute ma al tempo stesso bisogna sempre essere aldi sopra di ogni sospetto per rassicurare il marito assente...c’è semprequalcuno pronto a raccontargli delle frottole per fargli salire il sanguealla testa,...soprattutto i suoceri che non sopportano di non controllarepiù i soldi del figlio... e poi ci sono i vicini che si impicciano....”.
Queste “wonder women” che sono riuscite, a volte al prezzo di a-
108
spri conflitti, a liberarsi dalle pressioni esercitate dall’ambiente e aprendere in mano il destino della propria casa accentrando su di loro iruoli maschili e femminili, e indirizzando le decisioni a loro vantaggio,considerano l’emigrazione come un male necessario, visto il livello or-mai elevato delle esigenze. Tuttavia, aspirano tutte a mettere fine allaseparazione. Quelle tra di loro che non hanno mai accompagnato il ma-rito all’estero fanno di tutto per ottenere il ricongiungimento familiare eprogettano anche, nonostante le riserve del coniuge, di affidare i figli aifamiliari e di raggiungerli da sole. Quelle che invece sono rientrate nelPaese di origine per far studiare i figli si danno da fare per trovare unasoluzione per tutta la famiglia, cercando di emigrare in un Paese arabodove i loro figli avrebbero minori problemi di reintegrazione in caso dirientro nel Paese di origine. Durante l’assenza del coniuge, vivono tutteda sole con i figli e alcune di quelle che hanno preso una casa nella ca-pitale non hanno neanche la famiglia vicina. Si tratta soprattutto:
- di donne mature (35-45) con un livello d’istruzione relativamente alto(3 o 4 anni di studi secondari o professionali) e il cui coniuge vive al-l’estero da parecchio tempo (6-15 anni),
- di donne più giovani (30-40 anni) con un livello d’istruzione più basso(scuola elementare) ma che hanno soggiornato all’estero per cinque osei anni prima di rientrare in patria, o che hanno esercitato un’attivitàretribuita prima del matrimonio o fino alla partenza del marito perl’estero.
E’ chiaro che questa categoria di donne, il cui modo di agire e di viveresi allontana molto dal modello femminile tradizionale, non è la più dif-fusa tra le mogli di lavoratori emigrati all’estero. Su 56 donne del cam-pione, solo una quindicina corrisponde a questo profilo. La loro situa-zione è tuttavia interessante perché indica la direzione del cambiamentoche sta interessando il ruolo della donna. Cambiamenti che sono statiosservati anche in un’altra categoria di donne magrebine che non hannovissuto la separazione e le nuove responsabilità che questa implica mache hanno un livello socioculturale e economico elevato che rende piùfacile per loro adottare delle abitudini innovative.
La transizionali
109
Tra i due comportamenti estremi, uno più passivo e uno iperattivo,adottati dalle prime due categorie di mogli di emigranti, c’è una via dimezzo. Questa corrisponde ad un comportamento dinamico nella ge-stione dei beni, che arriva fino allo svolgimento di attività informali al-l’interno della famiglia e ad una rassegnazione di fronte ad una situa-zione che sembra insostenibile. Questa rassegnazione però non escludeaspirazioni che tendono verso nuovi modelli di comportamento. Si trat-ta di donne che aspirano al ricongiungimento familiare o al ritorno defi-nitivo del coniuge nel Paese natale. Sapendo però che nessuna delle dueipotesi è realizzabile nel prossimo futuro, si sforzano di risparmiare ilpiù possibile per velocizzare il rientro del coniuge. Alcune si dedicanoa piccole attività artigianali o commerciali sempre da casa. Il comporta-mento delle donne di questa categoria si traduce, da un lato, in un atteg-giamento dinamico nell’educazione impartita ai bambini e nella gestio-ne del bilancio e, dall’altro, in una tendenza ad affidarsi al coniuge perle decisioni importanti cercando, al tempo stesso, di orientarle a loro fa-vore ma riconoscendo sempre il potere decisionale dell’uomo in quantocapo famiglia. La partecipazione alle decisioni, alla gestione del patri-monio o all’orientamento delle scelte per la vita della famiglia è nettaanche se è sempre indiretta:“Durante l’assenza di mio marito, mi oc-cupo di tutto. Prendo l’affitto di un piccolo appartamento che abbiamoaffittato, ricevo i soldi che mi invia mio marito per posta e cerco di di-videre quello che ho per coprire le necessità della famiglia lasciandoperò sempre qualche cosa da parte che verso su un libretto di rispar-mio a mio nome. E’ così che siamo riusciti a costruirci una casa e l’ap-partamentino che abbiamo affittato... ma quando si è trattato di cam-biare la casa e i mobili è stato mio marito a decidere tutto... E’ chiaro,io esprimo sempre la mia opinione.... Sono io che ho scelto il quartiere;lui avrebbe voluto una casa vicino ai fratelli ma era lontana dalla scuo-la dei bambini e io non ho voluto... Mio fratello è venuto a vivere danoi, siamo più tranquilli con un uomo in casa... per i lavori: aspetto l’e-state affinché se ne occupi lui come si deve... a volte, quando si tratta dilavori o riparazioni urgenti, chiamo uno dei miei cognati che mi vienea dare una mano”(38 anni, vive con uno dei suoi fratelli scapolo e isuoi tre figli; ha frequentato la scuola elementare; suo marito ha 42 annie fa il cameriere in un ristorante a Lione. E’ emigrato da 12 anni).
110
Se la volontà di mettere fine alla separazione procurandosi piccoleentrate è manifesta in tutte le donne, nessuna di loro cerca però di svol-gere un’attività retribuita fuori casa. Il loro desiderio “di uscire da unasituazione penosa” si traduce piuttosto in uno sforzo al risparmio svol-gendo piccole attività informali (ricamo, cucito, confezionamento evendita di prodotti alimentari tradizionali) o vendendo da casa una partedei prodotti portati o inviati dal coniuge (elettrodomestici, cosmetici,vestiti...).
Questo tipo di comportamento è il più frequente nelle donne gio-vani e analfabete, che sono suddivise in due sottogruppi a seconda del-l’esperienza precedente in termini di migrazione: mentre quelle che nonhanno mai lasciato il Paese di origine continuano a vivere con i suocerio con la propria la famiglia, quelle che invece hanno avuto occasione diaccompagnare il marito e poi sono dovute rientrare, vivono da sole coni figli. Parliamo di:
- donne giovani (30-40 anni) e analfabete che hanno fatto l’esperienzadell’emigrazione; donne giovani, che hanno un certo livello d’istruzio-ne (scuola elementare) e che sono lontane dal coniuge da più di 5 anni;
- a volte, anche se in casi rari, donne più grandi che hanno avuto un’e-sperienza di emigrazione molti anni prima e che hanno vissuto espe-rienze dolorose (divorzio, disoccupazione oppure lunga malattia delconiuge).
La nostra ricerca ha messo in evidenza il ruolo eminentemente at-tivo delle donne nei Paesi di origine dal quale i mariti sono emigrati. E’solo grazie a loro - che continuano ad assicurare la stabilità familiare inassenza del capo famiglia, che si occupano dei bambini, che raccolgonoi proventi del lavoro all’estero, che gestiscono il patrimonio dell’assen-te e che si sforzano, anche con numerosi sacrifici, a farlo fruttare - se leregioni interessate al fenomeno dell’emigrazione registrano lo sviluppoattuale.
I colloqui approfonditi e i racconti di vita vissuta hanno anche ri-velato un aspetto spesso nascosto nella valutazione dell’impatto dellemigrazioni per motivi di lavoro, vale a dire il costo sociale e psicologi-co che la popolazione interessata al fenomeno accetta in cambio del re-
111
lativo benessere economico offerto dalla migrazione. Moltissime donneintervistate parlano con insistenza ed emozione delle molteplici diffi -coltà incontrate nel farsi carico delle tante e nuove responsabilità chedevono comunque assumersi e anche della pressione che devono eserci-tare su loro stesse per potersvolgere ruoli che non erano mai stati lorosocialmente riconosciuti, per vincere i pregiudizi e la sfiducia che susci-tano in quanto donne “sole” e per sopportare la solitudine affettiva.
A giudicare dal numero considerevole di donne che dichiarano chela situazione delle mogli degli emigranti è una situazione che “non au-gurerebbero neanche alla loro peggiore nemica” e che si opporrebberocon tutte le loro forze al matrimonio di una delle loro figlie con un emi-grato, ci sembra opportuno affermare che la loro situazione di vita è trale più difficili. Tuttavia, malgrado le difficoltà ed i conflitti, le donnecoinvolte ammettono tutte che nel loro caso l’emigrazione del coniugeera inevitabile e che non avevano nessuna alternativa possibile. Allostesso modo, la quasi totalità di loro non pensa di mettere fine alla sepa-razione prima di aver trovato un’altra maniera di guadagnarsi da vivere.
Il fatto che la maggior parte delle donne giovani (30-45 anni) ab-bia accompagnato il coniuge e che si sia rassegnata a tornare solo permandare a scuola i figli o per aver riscontrato difficoltà nel Paese di ac-coglienza, è doppiamente significativo. Da una parte indica quanto siadifficile la separazione che nel caso delle donne giovani viene accettatasolo per cause di forza maggiore. Dall’altra parte invece testimonia l’e-voluzione del ruolo della donna che diventa più attiva; infatti le donnepiù giovani non accettano la separazione dal marito con la stessa rasse-gnazione passiva delle donne più anziane.
Indubbiamente la pressione esercitata dalle donne per accompa-gnare il marito emigrante ha contribuito notevolmente al passaggio, apartire dagli anni ‘70, dalla tradizionale migrazione di uomini soli o“migrazione lavorativa” alla migrazione familiare o “migrazione di po-polamento”. L’emigrazione tradizionalmente maschile era ben vista siadal Paese di accoglienza che dal Paese di origine perché, da un lato, ilPaese d’accoglienza non doveva sostenere i costi sociali e culturali del-l’insediamento di gruppi allogeni e, dall’altro, il Paese di origine bene-ficiava delle ricadute economiche della migrazione, grazie alle rimesse
112
alle famiglie rimaste in patria.
Possiamo quindi concludere, e anche altri studi lo hanno già dimo-strato, che fin quando i Paesi di origine non conosceranno uno svilupposostenibile e armonioso che renda inutile l’emigrazione, questa conti-nuerà ad esistere in un modo o nell’altro, a prescindere dalle reticenzeculturali che la ostacolano e malgrado le barriere erette per arginarla. Lapressione interna che spinge verso l’emigrazione - crisi economica, co-sto del debito, inflazione, disoccupazione, crisi dell’agricoltura, tenta-zioni di alcuni modelli di consumo veicolati dai mezzi di comunicazio-ne occidentali - è talmente forte che inizia ad imporsi un fenomenonuovo, finora sconosciuto nei Paesi caratterizzati da una forte tradizio-ne. Ci riferiamo alle giovani donne sposate con figli che lasciano maritoe figli per andare a lavorare in Europa. Certo, si tratta di casi ancora po-co frequenti ma che sono significativi nella misura in cui indicano unatendenza in evoluzione.
D’altro canto, tenuto conto della chiusura attuale delle frontiereeuropee, se le regioni di partenza dei lavoratori migranti non si svilup-peranno abbastanza per dispensare le persone dal ricorso al lavoro all’e-stero, è certo che la pressione economica continuerà a spingere la mi-grazione clandestina - alle condizioni drammatiche che conosciamo -che porterà alla crescita di un fenomeno che è in via di sviluppo attual-mente e del quale le donne subiscono gli effetti negativi: l’abbandonodella famiglia da parte del suo capo il quale, se non muore durante unapericolosa traversata, si vede costretto alla clandestinità e alla precarietàa questa inerente.
113
GRAZIANO BATTISTELLA
Rettore dello Scalabrini International Migration Institute
L’integrazione è diventato un aspetto cruciale della gestione dellemigrazioni in Europa già da diversi anni. Si considera normalmente lacrisi economica dei primi anni ‘70 come lo spartiacque che ha fatto pas-sare l’Europa occidentale da una politica che favoriva l’immigrazionead una politica restrittiva dell’immigrazione. La restrizione sugli ingres-si veniva compensata da una maggior attenzione per l’integrazione de-gli immigrati già presenti sul territorio. Infatti, con l’utilizzo crescentedel ricorso ai ricongiungimenti familiari, la popolazione immigrata an-dava verso una progressiva stabilizzazione.
Le vie all’integrazione intraprese dai maggiori Paesi europei diimmigrazione si sono diversificate in modo abbastanza pronunciato: laFrancia riaffermava la propria fiducia nella sua capacità di integrazioneattraverso l’assorbimento dei valori della tradizione repubblicana e l’ac-quisto della cittadinanza; l’Inghilterra puntava all’integrazione attraver-so l’eliminazione della discriminazione, in particolare la discriminazio-ne razziale; la Germania imboccava la strada dell’integrazione attraver-so l’inserimento nel mondo del lavoro, anche se stentava a considerarsiPaese di immigrazione, e quindi a favorire l’insediamento permanente
114
di lavoratori stranieri. I rigurgiti nazionalisti emersi negli anni ‘80 si ri-verberavano nei tentativi dei vari governi di riguadagnare l’elettoratospostatosi verso posizioni conservatrici attraverso la riduzione dei bene-fici agli immigrati. Come in altre parti del mondo, anche in Europa simanifestava la tendenza ad usare le politiche di integrazione come stru-mento di politiche di ammissione. I soli controlli esterni, infatti, si eranorivelati insufficienti a contenere l’aumento di immigrazione irregolare.
L’erosione dei diritti concessi ai migranti, però, non si trasforma indeterrente alla spinta migratoria. Il differenziale tra i Paesi di origine e iPaesi di destinazione, accresciuto da una globalizzazione distorta, chenon distribuisce equamente i risultati della crescita economica, è taleche soltanto progetti di sviluppo a lungo termine possono cambiare letendenze migratorie. Giustamente, dunque, nel Consiglio Europeo diTampere del 1999 l’Unione ribadiva la volontà di garantire“l’equotrattamento dei cittadini dei Paesi Terzi che soggiornano legalmentenel territorio degli Stati membri”. Il punto 18 delle Conclusioni affer-mava anche che “Una politica di integrazione più incisiva dovrebbemirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadinidell’UE. Essa dovrebbe inoltre rafforzare la non discriminazione nellavita economica, sociale e culturale e prevedere l’elaborazione di misu-re contro il razzismo e la xenofobia”.
La successiva Comunicazione della Commissione su “Immigra-zione, integrazione, e occupazione” determinava il concetto di integra-zione come “processo biunivoco, che si fonda sulla presenza di recipro-ci diritti e obblighi per i cittadini di Paesi Terzi e per la società ospitanteche offre una piena partecipazione al migrante” (cfr. COM (2003) 336).Il dibattito sul concetto di integrazione ha una lunga storia e non puòcerto considerarsi finito. Non possiamo inoltrarci in quel dibattito inquesto breve intervento, anche se possiamo ribadire che l’integrazionenon va recepita o misurata né dal livello di utilità che i migranti hannoper la società ospite, né dal livello di somiglianza che raggiungono conla popolazione locale in forza della loro accettazione dei valori e dellostile di vita degli autoctoni. E’ facile capire come questo tipo di integra-zione ceda alla strumentalizzazione utilitaristica da parte della societàricevente e finisca col diventare assimilazione. Ovviamente non si puòdare integrazione neanche nel caso opposto di rifiuto dei codici in cui si
115
organizza la società di destinazione. Pertanto, giustamente la definizio-ne dell’UE parla di processo biunivoco e pone l’accento su diritti e ob-blighi. L’obiettivo dell’integrazione è la piena partecipazione e questapuò essere raggiunta soltanto se non vengono frapposti ostacoli. La pa-rità di trattamento, fermi restando i diritti e doveri che derivano dallacittadinanza, rimane quindi una condizione indispensabile per il rag-giungimento dell’integrazione. Ma l’integrazione si raggiunge se l’ac-cento non è posto soltanto sugli ostacoli da togliere (discriminazione),quanto soprattutto sugli atteggiamenti positivi da coltivare in modoconcreto. Si tratta di puntare a una interazione positiva tra immigrati epopolazione locale. Vanno pertanto accettate le seguenti premesse perun approccio corretto all’integrazione.
CONSENSOSULLE PREMESSE
I migranti come soggetto del processo integrativo
In un processo biunivoco, i migranti non sono solo destinatari di ini-ziative volte a favorire l’integrazione, ma sono protagonisti. La tradizio-nale immagine dei migranti come individui indifesi e derelitti, ancora va-lida in sistemi migratori dove lo sfruttamento del migrante rimane possi-bile, deve essere temperata dal riconoscimento della preparazione che imigranti hanno, spesso superiore all’occupazione in cui trovano impiego.Inoltre, va tenuto conto del numero crescente di immigrati qualificati, chespesso ricoprono un ruolo di leadership nelle comunità immigrate. Gliimmigrati vanno considerati come risorsa, non come problema.
Integrazione come realtà multidimensionale
Nell’inserimento degli immigrati si possono identificare quattroprocessi:
integrazione sociale come acquisizione di ruolo e di status nellasocietà di destinazione,
inclusione sociale, che varia a seconda dei rischi sociali cui sonosottoposti i migranti,
adattamento culturale, che identifica in che modo gli immigrati si
116
situano nel continuum tra assimilazione e ghettizzazione,
responsabilità, che si riferisce al livello di mantenimento di doveriche i migranti conservano verso la società di origine.
Il modo in cui queste dimensioni si combinano nell’esperienzadell’immigrato determina il grado di integrazione che raggiunge.Integrazione come un processo non lineare
L’emigrazione costituisce una rottura nel processo di progressivariduzione dell’incertezza che tutti perseguono nella vita. Infatti, gli im-migrati esperimentano incongruità tra i vari spazi sociali in cui si trova-no ad appartenere. All’incertezza che questo determina i migranti cer-cano di sfuggire in spazi in cui possono trovare identità e in cui sono i-dentificati dagli altri, ma da cui trovano poi difficoltà ad uscire (Bau-man). L’integrazione avviene se si attua un corrispettivo movimentoche permette loro di partecipare nei vari ambiti della società.
L’integrazione richiede cooperazione tra governo e società civile
Il Governo non può eludere le proprie responsabilità nel favorire iprocessi integrativi, ma deve anche saper cooperare con la società civilee le associazioni dei migranti come partners nella promozione e gestio-ne di iniziative sociali.
L’integrazione si gioca a livello locale
L’integrazione ha bisogno di politiche a livello nazionale, ma siconcretizza a livello locale, nelle iniziative dei comuni, dei gruppi divolontari, delle ONG, delle associazioni di immigrati. Le sinergie tra levarie iniziative possono generare un effetto di moltiplicatore e portareall’identificazione di best practicesriproducibili altrove.
AREE DI ATTENZIONE
L’integrazione interessa un campo molto vasto di interventi. Si vadalle politiche di inclusione alle politiche sociali, dalle politiche di adat-tamento culturale agli interventi volti a coltivare la responsabilità che imigranti devono mantenere verso il Paese di origine. Mi pare importan-
117
te porre l’accento sui seguenti aspetti.
Partecipazione
L’integrazione si evidenzia dal grado di partecipazione che gli im-migrati hanno non solo al vissuto della realtà locale, ma anche alla sua ge-stione. Diventa quindi decisivo dare agli immigrati la possibilità di parte-cipare alle elezioni amministrative. Il concetto di cittadinanza civica,pro-posto dalla Commissione, può avere una interessante funzione per proce-dere sulla strada del riconoscimento degli immigrati come portatori di di-ritti. Soprattutto, promette di far maturare l’idea dell’integrazione non tan-to come benevola concessione offerta agli immigrati, quanto piuttosto co-me status che si fonda sulle basi di riconoscimento e responsabilità.
Il passaggio dalla cittadinanza civica alla cittadinanza vera e pro-pria dovrebbe essere favorito e non ostacolato. In tal senso, in un’Euro-pa in cui la proporzione degli immigrati è in continua crescita, va rivi-sta, dove permane, la procedura di concedere la cittadinanza soltanto at-traverso lojus sanguinis,così da non mantenere come stranieri personenate e cresciute nei Paesi dell’Unione.
Accesso
Se la partecipazione sempre più piena alla vita e alla gestione dellarealtà nei Paesi di destinazione qualifica l’integrazione nella sua formapiù completa, non si può dimenticare che occorre assicurarsi anzitutto chevengano eliminati gli ostacoli a questa partecipazione. Rimane quindi im-portante ribadire la necessità di combattere la discriminazione, particolar-mente sul posto di lavoro e nella vita sociale, di assicurare che agli immi-grati siano concesse reali opportunità per avere accesso alla formazione eall’impiego e che i servizi siano forniti con i necessari adeguamenti cosìche possano davvero essere utilizzati. I programmi volti al primo inseri-mento degli immigrati, incluso il favorire l’apprendimento della linguadel posto, sono particolarmente importanti. L’adozione del Regolamentoche estende ai cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in unoStato membro i diritti relativi alla fruizione della sicurezza sociale a pari-tà di condizioni con i cittadini UE è un importante passo, anche per le ri-cadute che avrà nella politica migratoria dell’Unione.
118
Il diritto a vivere in famiglia
Il più importante degli ostacoli da rimuovere riguarda gli impedi-menti che vengono frapposti al diritto di vivere in famiglia. I tradizio-nali Paesi di immigrazione come Stati Uniti, Canada e Australia hannoda sempre posto il ricongiungimento familiare come uno dei pilastridella loro politica migratoria, consci del fatto che non si tratta soltantodi rispettare il diritto naturale a vivere in famiglia, ma che la vita in fa-miglia è la via più efficace verso un’integrazione armonica. Anche l’U-nione Europea considera l’importanza del ricongiungimento familiare.Ma è da lamentare che la Direttiva adottata di recente rappresenti un ac-cordo minimale, che ha ridotto le possibilità per la ricomposizione dellafamiglia e ha reso meno cogenti gli obblighi dello stato.
Il dialogo interculturale
L’integrazione, come processo biunivoco che tende non soltanto arendere possibile la partecipazione piena degli immigrati nella società didestinazione ma anche alla crescita di tutta la società come società inte-grata, si fonda sull’apprezzamento positivo del processo di dialogo inter-culturale arricchito dalla presenza degli immigrati. La possibilità di svi-luppare questo dialogo prospera sul rispetto delle diverse tradizioni cultu-rali e religiose, all’interno dei diritti e delle responsabilità che l’UnioneEuropea si è data come quadro di riferimento. Invece che arroccarsi susteccati contrapposti è più produttivo coinvolgere gli immigrati perché illoro apporto arricchente contribuisca al miglioramento della società.
L’ INTEGRAZIONE IN ITALIA
L’integrazione (Titolo IV e V) costituiva un punto qualificante del-la legge Turco-Napolitano del 1998. In quel testo sostanzialmente posi-tivo rimanevano delle lacune, in particolare la mancata concessione agliimmigrati in possesso di carta di soggiorno del diritto di voto nelle ele-zioni del comune di residenza.
La legge 189/02 (Bossi-Fini) ha recepito con poche modifiche la
119
parte relativa all’integrazione. Tuttavia, quelle modifiche ed altri aspettidi attuazione pratica hanno reso l’integrazione degli immigrati in Italiapiù difficile. In particolare, il ricongiungimento familiare è stato ristret-to, escludendo i genitori a carico che abbiano figli nel Paese di origine,i figli maggiorenni se possono provvedere al loro sostentamento, e glialtri parenti fino al terzo grado. Così pure, è stata mortificata la possibi-lità di accesso all’alloggio e resa più incerta la condizione di quanti be-neficiano di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Inoltre, pur rima-nendo nel testo di legge, sono stati in pratica sospesi gli organismi dipartecipazione civile e politica, come la Consulta per i problemi degliimmigrati e delle loro famiglie. Il risultato è che gli immigrati sono me-no partecipi nella gestione delle iniziative volte a favorire l’integrazio-ne. Si è tornati cioè a un concetto di integrazione determinata dal Go-verno e dalla sua maggioranza. E d’altro canto non si vogliono vagliarei risultati del processo di integrazione, dal momento che la disattivazio-ne della Commissione per le politiche di integrazione ha portato anchealla scomparsa del Rapporto sull’integrazione degli immigrati in Italia.
Soprattutto, la Bossi-Fini ha reso più precaria la condizione degliimmigrati, diminuendo la durata del permesso di soggiorno, allungandoi tempi per la concessione della carta di soggiorno, diminuendo il tem-po per la ricerca di un altro impiego in caso di perdita del lavoro, e hareso più macchinose le procedure burocratiche, creando una situazionedi insicurezza che mal si coniuga con il favorire l’integrazione anchedegli immigrati che sono presenti da tempo sul territorio. La creazionedi insicurezza probabilmente risponde all’obiettivo di rendere meno ap-petibile per i migranti l’ingresso e il soggiorno in Italia. Perseguire untale obiettivo, quando in realtà la presenza degli immigrati è diventataun fatto strutturale nella società italiana, sembra in contrasto con gli in-teressi stessi della collettività.
Non vi sono però soltanto ombre nel caso italiano. La maggioran-za degli aspetti positivi si riscontrano a livello locale. Per esempio, mol-ti comuni hanno istituito la figura del Consigliere Aggiunto. Il Comunedi Roma ha avviato 24 centri per l’infanzia immigrata; e ha istituito, incollaborazione con il CSER, il Centro di Informazione e Documenta-zione su Immigrazione e Intercultura (CIDII), uno spazio dedicato allaconoscenza della realtà multietnica e multiculturale cittadina e alla rea-
120
lizzazione di iniziative che mirino alla crescita dei valori dell’intercul-tura. Il Comune di Bologna ha elaborato una Carta dei diritti e dei do-veri per una civile convivenza per assicurare uguali opportunità a tutticoloro che vivono nella città.
A livello nazionale, la sanatoria, di cui saranno beneficiari oltre700.000 immigrati ai quali permetterà di uscire da una condizione som-mersa, è certamente un fatto positivo. Vanno anche segnalate le iniziati-ve del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, come per esempioi manuali sull’orientamento degli immigrati prodotti dall’Organizzazio-ne Internazionale delle Migrazioni (OIM).
Giustamente la Commissione sostiene che “La capacità dell’UEdi gestire l’immigrazione e di garantire l’integrazione dei migranti a-vrà enorme influenza sulla possibilità, in termini generali, di dominarela trasformazione economica e rafforzare la coesione sociale nel brevee nel lungo periodo”(cfr. COM (2003) 336). Per questo sono necessa-rie iniziative coordinate e innovative. Tra di esse vanno segnalate la ne-cessità di mettere a disposizione risorse istituzionali che consentano a-gli immigrati di affermare i propri diritti, la capacità di stabilire coali-zioni tra immigrati di diversa origine, la lungimiranza di favorire il dia-logo dinamico tra culture, e l’accortezza di valorizzare anche i momentidi confronto come occasioni per crescere nel mutuo rispetto e diventarepartners verso una società più armonica. Soprattutto, occorre ricordarela natura olistica del processo di integrazione, per evitare che la riduzio-ne economicistica degli immigrati, richiesti sul mercato del lavoro, manon benvenuti nella vita sociale.
121
MOHAMED SAADY*Copresidente della Associazione Nazionale Oltre le Frontiere (ANOLF)
Vorrei anzitutto complimentarmi con il CNEL per l’organizzazio-ne di questa Conferenza e fare i miei complimenti a Giorgio Alessan-drini per la sua relazione che è stata veramente completa. Una relazioneche ha cercato di farci capire che è ora e che c’è bisogno di una politicacomune a livello europeo di asilo e di immigrazione, che rispetti quellacornice caratterizzata dalla creazione di uno spazio di libertà, sicurezzae giustizia. E quando si parla di giustizia e di sicurezza non si guardasolo all’ordine pubblico, ma si guarda soprattutto al sociale.
Certamente è necessario dotarsi di una politica europea, ma io michiedo, soprattutto ultimamente, di fronte ad un’Europa così debole poli-ticamente, un’Europa che vive in contrasto tra le sue nazioni, se possa es-sere facile raggiungere quegli obiettivi concreti per poter assicurare a tuttigli immigrati dell’Unione Europea un percorso efficace di integrazione.
Continuo ad esprimere la mia perplessità di fronte ad un fattore es-senziale. Siccome gli Stati membri conservano la loro competenza sumolti aspetti significativi e soprattutto l’attuazione di una politica di in-tegrazione, mi chiedo se sia un bene o un fatto positivo. È emerso nellarelazione di Alessandrini e in relazione alla nuova legge Bossi-Fini.
122
Dato che ci sono degli obiettivi per poter comunque realizzare un pro-getto, ci sono dei cammini da percorrere insieme, allora io partirei dal-l’esigenza di un regime comune europeo in materia di asilo, basato sul-__________* Testo non rivisto dall’autore
la applicazione della Convenzione di Givevra. La nostra legge attuale vaverso questa direzione? Mi sembra di no. Una politica di integrazione piùincisiva, che assicuri un equo trattamento dei cittadini dei Paesi Terzi e chedovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi uguali ai cittadini dell’U-nione Europea. Siamo con questa nuova legge sulla stessa direzione? Mipare di no. Basta ricordarci la questione del ricongiungimento familiare, ba-sta ricordarci gli inviti che hanno fatto i nostri rappresentanti del Governoad incoraggiare, soprattutto sulla programmazione dei flussi, l’ingresso dialcune comunità, quelle con le quali l’Italia ha dei legami culturali e reli-giosi. Dando l’impressione che la politica si governa solo quando non cisono problemi e dando l’impressione che non c’è il coraggio di affrontareproblematiche serie. Dotarsi di una efficace gestione dei flussi migratori,basata sulla stessa cooperazione con i Paesi di origine, avere un vero parte-nariato con i Paesi di origine, anche sulle questioni connesse alla politica, aidiritti umani e allo sviluppo dei Paesi e delle regioni di origine e transito.Noi non abbiamo sino ad oggi mai sentito programmi che vanno in questadirezione. Mi preoccupo molto, anche se non vorrei dare l’impressione diessere un pessimista, ma sono quindici anni che si parla di processo di inte-grazione e noi italiani siamo così bravi da essere sempre menzionati dallaComunità Europea. Nel 1998 siamo stati considerati il Paese con la leggepiù avanzata in Europa, oggi non so dove ci potrebbero classificare conquesta nuova legge, visti i contrasti tra le nazioni e visti gli effetti o la forzacon cui alcuni Governi cercano di tornare indietro invece di andare avanti.L’integrazione per noi immigrati significa anche rispetto per l’altro. Il ri-spetto per l’altro, dopo l’11 settembre, ci fa capire che vicino al termine in-tegrazione bisogna prendere in considerazione il termine della convivenza.Il progetto del Ministro dell’Interno nell’organizzare le comunità musulma-ne ci fa capire che c’è una difficoltà di una comunità per cui è difficile l’in -tegrazione e quindi bisogna anche mettere in discussione l’altro termine,quello della convivenza, nel rispetto degli altri.
Sul diritto di voto, come abbiamo detto spesso e ripetiamo oggi inquesta sede, ce lo ha fatto capire il Prof. Diamanti, non vorrei fare la fi-
123
ne dell’America e del suo Presidente, per cui i sondaggi lo fanno salireun giorno e lo fanno scendere nell’altro giorno in base al ritrovamentodi armi chimiche o di Saddam. Non vorrei che gli immigrati venisserotrattati allo stesso modo, altrimenti sarebbe davvero un processo di inte-grazione impossibile da raggiungere.
GIOVANNA ZALDINI
Presidente della Cooperativa “La Talea” (Alma Terra)
Innanzitutto un ringraziamento al CNEL per avere organizzatoqueste due giornate di confronto.
Vorrei riportare il dibattito, con il mio intervento, sul terreno unpo’ più concreto ed operativo, entrando nella concretezza delle questio-ni rispetto all’integrazione sociale. Perché consentitemi di dire che, infondo, alla fine, dopo tanti discorsi di tipo politico, sociale, culturale,ecc., dietro tutto questo ci sono delle persone con i loro vissuti e ci sonodelle persone che, all’interno di questi vissuti, convivono e coabitano.L’associazione di cui io faccio parte è un’associazione di donne emi-granti e italiane che si chiama Alma Terra e all’interno di questa c’è poiuna cooperativa di donne emigranti abbastanza unica nel suo genere,forse perché una delle prime esperienze in Italia di questo tipo, costitui-ta unicamente da donne emigrate che, con molta fatica, hanno cercatodi percorrere il terreno dell’integrazione attraverso appunto il lavorodelle donne.
Parlando di integrazione intanto dovremmo porci il quesito di chiintegra e di chi è integrato. Io penso che l’integrazione oggi, come più
124
volte si ripete, sia l’integrazione degli immigrati e questo è indubbia-mente vero, ma perché si possa realizzare l’integrazione dei migranti civuole qualcuno che li integri. Io sono convinta che l’integrazione sia unpercorso a due vie, che è sicuramente difficile e non può essere indolo-re, sotto diversi punti di vista.
Da un punto di vista sociale bisogna pagare dei prezzi alti perun’integrazione reale, un’integrazione che non sia solo a parole, solodettata da linee di principio. Non ci può essere integrazione solo facen-do appello alla ragione e facendo appello unicamente alla legislazione,ecc., altrimenti cadiamo sul terreno della demagogia. Non ci può essereintegrazione senza che colui che deve essere integrato sia coinvolto equindi è inutile parlare di integrazione se non si mettono in atto deglistrumenti reali, concreti, percorribili e poi rispettati, valutati, monitoratie verificati, senza la presenza e la compartecipazione delle migranti, deimigranti e dei loro familiari.
Altrimenti davvero io sottolineo che continueranno a rimanere pa-role vane. Il relatore che mi ha preceduto, Mohamed Saady, diceva chesono quindici anni che stiamo parlando di questo e credo abbia perfetta-mente ragione. Io che frequento l’ambiente dell’immigrazione, io chesono in Italia da 31 anni, arrivata qui ragazzina, posso dire che sono sta-ta un po’ il barometro per misurare la temperatura rispetto alla presenzadei migranti in questo Paese. E posso dire che tante cose sono cambiate,ma tutto sommato, forse, continuiamo a dibattere sulle stesse questionida tanti anni.
Allora quale ruolo possono avere le persone, i gruppi, le associa-zioni, che insieme, collettivamente, ottenendo poi dei risultati e delle ri-cadute però a livello individuale nella vita delle persone, possono ave-re? Penso che un’associazione come quella in cui noi lavoriamo - ioposso portare solo questa piccola esperienza personale - sia un’espe-rienza che, a partire proprio dalla concretezza delle cose, dal fatto chele persone vivono insieme, o tentano di coabitare e di convivere pacifi-camente, mostra inevitabilmente come poi ci si modifichi a vicenda, an-zi ci si deve modificare a vicenda, perché altrimenti poi, di nuovo, nonesiste integrazione senza una reciproca modificazione. Talvolta si usa iltermine di contaminazione, che a me non piace, perché è un termine
125
che ha a che fare con la malattia. Io non penso che l’immigrazione, lapresenza degli immigrati, sia una malattia, per cui ci si può contagiare,ma penso che ci siano termini migliori di questo, per definire un cam-biamento reciproco.
Noi abbiamo tentato di fare questo attraverso la quotidianità del-l’agire insieme in un centro dove l’intercultura si vive quotidianamente,dove persone di tutti i Paesi lavorano gomito a gomito con le reciprochedifferenze.
Credetemi, l’intercultura non è una strada in discesa, ma in salita,e chi si illude che l’intercultura sia una strada facile, un percorso sem-plice o che la presenza degli immigrati passerà facilmente attraverso lanostra impermeabilità, è un grande illuso. Costerà sangue e fatica a tuttiquanti, a tutti, migranti e nativi. Io ho dei figli adulti e vorrei che vives-sero in un Paese dove ci si rispetta a vicenda.
Gli immigrati sono qui per lavorare, non per fare beneficenza, enon sono qui nemmeno per essere beneficiati da nessuno, ma il lavoroperò deve dare dignità alle persone, deve essere un lavoro che sia anchevalorizzato, non ghettizzante. Le donne migranti sono quasi sempre i-dentificate con il lavoro domestico o con la prostituzione. Ma come sipuò pensare di dare dignità alle persone quando noi partiamo aprioricon l’idea che le donne debbano fare solo questi due o tre tipi di lavo-ro? Questo toglie dignità alle persone, mentre ognuno dovrebbe averel’opportunità di svolgere il lavoro per cui si è formato e quindi metterein atto azioni che eliminino questi ostacoli, per far sì che queste personepossano davvero essere una risorsa per il Paese. Ci piace l’idea degliimmigrati come risorsa, ma cosa intendiamo con questo? Perché gli im-migrati siano una risorsa devono avere la possibilità di impiegarsi in unlavoro per cui hanno studiato. Tra l’altro il Paese che li accoglie non hainvestito nella loro formazione e questo è un grande beneficio per ilPaese di accoglienza delle persone già formate. Pensate a quanto costaallo Stato italiano una persona prima di arrivare all’età lavorativa, men-tre un giovane immigrato che arriva e che ha una formazione su cui hainvestito il proprio Paese è una risorsa su cui non si è speso nulla in for-mazione. Per il Paese che accoglie non è un bene che queste risorse va-dano sprecate, altrimenti poi assistiamo, non solo alla fuga dei cervelli
126
italiani, ma assistiamo alla fuga dei cervelli anche delle persone immi-grate. Io sono originaria di un Paese, la Somalia, da cui sono scappatemolte persone. La Somalia aveva, tra l’altro, storicamente rapporti conl’Italia, eppure sono rimaste poche migliaia di somali in Italia, nono-stante fossero una delle prime comunità presenti in Italia. Questo per-ché altri Stati li hanno accolti in modo differente, altri Stati hanno sapu-to valorizzare le loro risorse e questo a dimostrazione del fatto che cisono Paesi che hanno saputo costruire la loro grandezza e potenza, cul-turale e politica, grazie anche alla immissione dei cervelli degli immi-grati. Per percorrere questa strada, però, occorre che coloro che sonoimpegnati in questo abbiano un sostegno, che queste organizzazioni sia-no sostenute. Sicuramente costano meno queste organizzazioni di unapparato burocratico, perché sono strutture probabilmente molto piùsnelle, veloci ed incisive sul territorio, perché ne conoscono la realtà,non si sostituiscono al pubblico ma possono con esso lavorare in siner-gia. Ma occorre che a queste organizzazioni siano fornite gambe e brac-cia, che vuol dire risorse anche economiche, non date con i tempi bibli-ci della burocrazia statale, altrimenti queste organizzazioni rischiano dimorire e non produrre quel cambiamento che tutti auspichiamo semprea parole.
127
MARIA JOSEMENDEZ EVORA*Presidente dell’Associazione Nostri Diritti (No.Di)
Ringrazio il CNEL a nome dell’associazione No.Di per averci in-vitato a questa Conferenza.
Vorrei riportarvi un esempio pratico frutto della mia esperienzanell’associazione. La settimana scorsa ho incontrato Matteo, un ragazzodi 29 anni nato e cresciuto in Italia. Matteo mi ha raccontato la sua sto-ria: a 18 anni, gli hanno detto che doveva avere il permesso di soggior-no e lui si è trovato improvvisamente spaesato perché il padre è giàmorto, la madre è in Francia, lui è solo con la nonna che dipende da luie che vive da 44 anni in Italia, senza poter uscire di casa perché la casaè vecchia e non riesce a scendere le scale. Matteo lavora, ma non in po-sizione regolare, così anche la nonna si trova a dover affrontare la pro-blematica del permesso di soggiorno dopo aver passato 44 anni in Ita-lia: la mia intera vita, io ho 44 anni! La nostra associazione è stata chia-mata proprio per cercare di risolvere questo problema.
Ho fatto questo esempio per dire se veramente possiamo parlare diintegrazione in Italia. Io ho dei dubbi, preferisco parlare di tentativi diinserimento se un immigrato è messo nella condizione, dopo essere sta-
128
to per 44 anni in Italia, dopo essere nato e cresciuto in Italia, di non sa-pere cosa fare della propria vita. Allora penso sia presto per parlare diintegrazione.___________* Testo non rivisto dall’autore
La storia di Matteo è emblematica per No.Di., perché da noi arri-vano tante persone come Matteo, nate e cresciute in Italia, che hanno unlavoro precario, non hanno una formazione scolastica perché, comemolti ragazzi capoverdiani, lui ha abbandonato la scuola, lavora in que-sto momento dignitosamente, ma non in regola, quindi anche lui fra po-co potrebbe essere espulso secondo la legge Bossi-Fini.
E Matteo mi ha detto: forse è anche meglio per me che mi mandi-no a Capo Verde! Ma davvero vogliamo mandare Matteo a Capo Ver-de? Mandiamo sicuramente un delinquente a Capo Verde, perché Mat-teo non si integrerà lì, perché non è mai andato a Capo Verde.
Quindi io farei molta attenzione, con la normativa e con i prossimiregolamenti di attuazione, almeno a questi ragazzi nati e cresciuti in Ita-lia, se proprio non si vuole avere un occhio di riguardo anche per altri,almeno solo per quelli nella loro condizione.
Sulla mia esperienza, e su quella di tante altre donne che sono alNo.Di. e che vivono nel territorio italiano, voglio parlare dell’inseri-mento lavorativo delle donne, in particolare, della carriera delle donneimmigrate, e del ricongiungimento con i loro figli o i loro cari. Perquanto riguarda la carriera temo che, ancora oggi, siamo alla domandadi quale sia la nostra carriera visto che la maggioranza dei nostri titolidi studio non sono riconosciuti in Italia, per cui come potremmo mai in-serirci nel mercato del lavoro italiano? Saremo costrette per sempre allavoro precario. L’ho fatto anch’io per 24 anni, pur avendo una laureain tasca e lo fanno tante donne migranti. Questo mi porta a dire che diintegrazione non si può proprio parlare allo stato attuale.
Riguardo al ricongiungimento familiare manifesto tutto il mio di-sappunto, non solo per quello che la legge Bossi-Fini prevede, ma an-che verso il Consiglio dell’Unione Europea che in questo momento po-ne addirittura dei blocchi nel ricongiungerci con i nostri propri figli,prevedendo che forse potremmo ricongiungerci con i nostri ragazzi ai
129
loro 18 anni. Ma io vedo che in Italia i ragazzi restano a casa e in fami-glia per ben trent’anni, quindi come mai noi migranti possiamo ricon-giungerci solo con i ragazzi di 18 anni?
Detto questo, nella mia esperienza, penso che la strada che portaalla vera integrazione sicuramente passerà anzitutto tramite il riconosci-mento di questi diritti, possibilità di lavoro e di carriera, di ricongiungi-mento familiare, ma soprattutto la possibilità di partecipare alla vita diquesta società. Io non voglio essere un cittadino passivo, ma ho il dirit-to, dopo 24 anni vissuti qui, di votare almeno per l’amministrazione do-ve vivo e dove lavoro.
Propongo che si esca una volta per sempre dall’ottica dell’emer-genza/assistenza, che è quella che si evoca quando si parla di immigra-zione.
Per avere l’integrazione bisogna riconoscere e valorizzare le capa-cità dei migranti - a parte l’assistenza a chi arriva sui gommoni - chi staqui da anni ha tutto il diritto di integrarsi in questa società.
Il migrante non può continuare ad essere solo numero: quanti sonostati regolarizzati, quanti sono stati espulsi! Il migrante è soprattutto unuomo o una donna, quindi occorrono leggi che prevedano l’inserimentodi queste persone denominate migranti. È necessario che si esca dallalogica dell’immigrazione vista come una piaga. L’immigrazione non èaltro che una nuova realtà e una nuova dimensione della vita e dellaconvivenza.
130
RODRIGO JAIMES HIDALGO
Membro della Consulta Immigrazione-Emigrazione della RegioneLazio
La sfida dell’emigrazione nel terzo millennio
Oggi il tema “emigrazione” è uno fra i più sentiti e affrontati, nel-l’ambito della comunità europea.
Ormai questo fenomeno si è imposto all’attenzione delle Autorità,delle forze Politiche, e di tutte quelle Organizzazioni che operano nelcampo sociale e religioso: Sindacati, Comunità di base, Chiesa, ONG,ecc.
Dietro questa parola “emigrazione”, infatti c’è una realtà di uomi-ni, donne e anche fanciulli che sono stati costretti a lasciare il Paese diorigine per motivi che possiamo riassumere essenzialmente in: 1° di-soccupazione; 2° indigenza; 3° guerra e mancanza di democrazia.
Soprattutto è stato il millennio passato della tecnologia che ha rag-giunto negli ultimi anni dei traguardi assolutamente impensabili, che a-vrebbero potuto assomigliare più a eventi di fantascienza che a fatti reali.
L’elettronica applicata nelle comunicazioni ha ridotto le distanze e
131
il senso del tempo: tutto corre veloce lungo fili invisibili.
Mentre prima i popoli del mondo, (e in uno stesso Paese le variezone) erano isolati e sviluppavano usi, tradizioni, modi di vivere e pen-sare particolari, oggi assistiamo ad un’espansione e diffusione passivadi una forma di cultura dominante, rispetto a tutte le altre, che di fattoimpone il modello da imitare a qualsiasi latitudine del mondo. Rimanesempre più emarginato chi non intende conformarsi allo stile di vita co-mune, conformista, uguale per tutti. In poche parole lo chiamiamo glo-balizzazione, termine appena nato che lascia intuire anche al profanol’esistenza di un meccanismo mondiale, o meglio, una mente potenteche controlla e decide sull’andamento su ogni aspetto della vita di cen-tinaia di milioni di uomini, con lo scopo fondamentale di avere un pro-fitto in economia, un guadagno. Con la globalizzazione, quindi, tuttoviene uniformato ed appiattito: scompare il folklore, cessano le diffe-renze, e tutti veniamo incanalati a vivere, lavorare, produrre, consumareseguendo uno schema che pone come primario obiettivo non il benesse-re della comunità e della solidarietà fra i popoli, ma l’arricchimento digruppi multinazionali che estendono la loro rete opprimendo semprepiù il Paese del chiamato terzo mondo ed incrementando nuove classipovere, nuovi disagi ed emarginazione, finanche guerre quando sonoconvenienti, per loro.
Secondo dati forniti dal CNEL, coordinato dal Dott. Alessandrini,in Italia, la ricchezza si è straordinariamente concentrata: l’80% più po-vero delle famiglie possiede solo il 38,2% della ricchezza totale, e il 5%più ricco possiede il 32%, il 20% più ricco il 61,8%. Nei Paesi indu-strializzati è cresciuta l’enorme ricchezza finanziaria, e questo processodi fortissima concentrazione di capitale è seguito dall’accentuazione deidislivelli sociali.
E’ quindi un fenomeno che ha proporzioni immense, difficile daarrestare.
Tuttavia questo pericolo va smascherato, innanzitutto, conosciutoe analizzato nelle sue vere ripercussioni nell’ambito sociale; è necessa-rio un impegno che approfondisca un discorso sullo sviluppo, sulla qua-lità dello sviluppo, e per lanciare questa dialettica porsi insieme i pro-blemi dell’ambiente del lavoro lottando e denunciando ogni forma di a-
132
buso, e anche questa liberalizzazione di mercato che non protegge fascesociali più deboli. E’ necessario che siano cambiati i caratteri della pro-duzione e dei servizi, dell’evoluzione indotta dalla scienza e dalla tec-nologia, nei processi vitali vegetali, animali, umani. Quando si dicemercato, non si può intendere un arbitrio imprenditoriale finalizzato alprofitto dominante sulle condizioni dell’ambiente e dell’umanità.
E’ necessario infine sviluppare sempre più il senso umano dellavita e della solidarietà, dei valori etici, del rispetto, dell’ospitalità tra ipopoli e dell’unità nella diversità.
Dopo aver analizzato il fenomeno della globalizzazione a livellomondiale, mi permetto di fare diverse considerazioni sulle sfide delle e-migrazioni che arrivano in Europa, specialmente vedere la recente leg-ge Fini-Bossi, sorta per regolarizzare in modo pratico alcuni aspetti del-la vita sociale degli immigrati già presenti in Italia, o che dovranno arri-vare secondo i canali comunque legali, è una prima misura di questogoverno di fronte alla grande problematica italiana ma anche di tutta lacomunità Europea, circa il fenomeno dei cittadini provenienti dai Paesidell’Africa, Asia, America Latina e anche Est Europa.
Questa presenza umana in difficoltà nei Paesi di origine per que-stioni di economia, politica e regimi autoritari, si riversa continuamentequi in Italia e a Roma in modo particolare alla ricerca di un lavoro, unasistemazione e un avvenire diverso per sé e il proprio nucleo familiare.
In pratica sta succedendo quello che oltre duecento anni fa, è av-venuto in modo inverso con le emigrazioni di milioni e milioni di fami-glie italiane che partivano per l’America del sud e del nord, o la Germa-nia, Belgio, Australia, Inghilterra, Francia o Svizzera. L’emigrazionequindi è, per chi ancora non dimentica, una realtà innanzitutto dolorosa,e non certo un viaggio turistico o un’avventura.
E’ indispensabile partire da questa premessa di affrontare con sen-so pratico e con giustizia il fenomeno, da parte sia delle autorità politi-che che delle organizzazioni varie e dell’opinione pubblica.
133
EDMOND AGBETTOR
Presidente della Consulta Immigrati del Comune di Modena
Grazie al CNEL e ai personaggi illustri qui presenti per dare vita aquesto Convegno e per aggiungere un altro tassello al processo di inte-grazione.
Signor Presidente, Signor Ministro e illustri cittadini qui presentioggi, è un onore per me essere stato invitato a questo importante incon-tro, ma considero anche una responsabilità aggiungere la mia voce alprocesso di integrazione degli immigrati, dal momento che il Comunedove vivo è sensibile al problema dell’immigrazione ed ha fatto silen-ziosamente alcuni progressi in materia di immigrazione, tuttavia rimaneancora molto da fare.
Sfortunatamente l’immigrato in questo Paese è ancora consideratosolo come una forza di lavoro, e questo è largamente dovuto “all’impor-tanza” che i legislatori danno all’immigrato e all’immigrazione.
Questo scarso interesse delle autorità si riflette ad ogni livello del-la società.
134
Fondamentalmente sono qui per parlare dell’esperienza modenesee della possibilità di fare proposte che miglioreranno la situazione del-l’immigrato in tutta Italia e di sentirsi cittadini di questa terra.
Per questo è importante risalire all’inizio dell’immigrazione a Mo-dena, ma non parlare dei motivi dell’immigrazione.
Dopo molti anni, nei quali il Comune di Modena ha dovuto tratta-re con rappresentanti di diversi gruppi etnici, nel 1996 è nata la Consul-ta degli stranieri che ha giocato un importante ruolo come portavoce de-gli immigrati e mediatore tra l’amministrazione locale e gli stranieri.
Questo ruolo non è solo con il Comune di Modena, ma ha aiutatoad eliminare la differenza tra gli stranieri e le altre istituzioni come laquestura, la prefettura ed ha anche mediato tra gli immigrati e il settoreprivato.
Molte sono state le iniziative e i seminari che la Consulta ha orga-nizzato negli ultimi 6 anni cercando di eliminare la differenza tra gliimmigrati e i cittadini indigeni, e le autorità.
Nonostante tutto il lavoro fatto, l’integrazione rimane ancora a-stratta, a causa delle difficoltà linguistiche, della mancanza di strumentilegislativi a sostegno di quello che stiamo facendo livello locale.
Personalmente credo che, a livello locale (almeno a Modena), cisia la volontà di aiutare l’immigrato a diventare parte della società.
I problemi relativi al lavoro sono uno dei limiti all’integrazione. Isindacati hanno fatto parecchio lavoro.
Comunque, imprenditori senza scrupoli (specialmente le agenzieinterinali e le cooperative) continuano a rendere l’integrazione difficileper l’immigrato, non rispettando le leggi del lavoro quando si ha a chefare con quest’ultimo.
Tanti di questi imprenditori senza scrupoli, addirittura, usano me-todi non ortodossi, tipo minacce, straordinari forzati, a volte anche sen-za remunerazione dello straordinario svolto, e lavorare in condizionidisumane.
Il problema principale in Italia, specialmente nel nord Italia, rima-ne quello della casa.
Se l’immigrato vuole sentirsi a casa deve avere una casa adeguata,
135
lo Stato e i Comuni perciò devono adottare una politica migliore dellacasa. In Emilia molti Comuni stanno sperimentando l’agenzia della ca-sa, che è composta da associazioni imprenditoriali, dai Comuni, dai Sin-dacati tra tanti altri, che offrono garanzie per coloro che cercano casa.
Credo che sia arrivato il momento di considerare il costante rinno-vo dei permessi di soggiorno presso le questure. Si può considerare ilrinnovo del permesso, per coloro che hanno più 10 anni di residenza,presso le anagrafi comunali anziché presso la questura. Questo allegge-rirebbe il massiccio lavoro sulle spalle delle questure, e le frequenzequotidiane alle questure. Una misura controproducente sia per gli immi-grati sia per i datori lavoro.
Dopo tutto una famiglia immigrata con figli che conoscono comelingua e cultura solo quella italiana, e vivono in una città da 10 anni inregola, non avranno molto da nascondere dalla lunga mano della que-stura o della legge.
Rispetto ai servizi si può affermare che Modena ha fatto passi dagigante a tutti i livelli, con l’istituzione di mediatori culturali formati,che assistono nelle scuole dalla scelta degli asili nido fino all’integra-zione dei nuovi arrivati nelle scuole superiori.
Gli stessi mediatori sono a disposizione degli ospedali e dei centriper l’impiego. Si può dire che i servizi agli immigrati, da questo puntodi vista, hanno dato un aiuto massiccio all’integrazione.
Per quanto riguarda il voto amministrativo, credo che concederloagli immigrati non sarebbe sbagliato, visto le esperienze positive in altriPaesi europei. Gli esempi li trovo in Irlanda dove gli immigrati votano alivello locale da 1963, in Danimarca dal 1991, in Olanda dal 1995 e inSvezia dal 1995 dopo 3 anni di residenza.
Contrariamente in Italia si verifica una controtendenza.
Infatti fino al 1992 si poteva ottenere la cittadinanza e conseguen-temente il voto dopo 5 anni di residenza. Ma la legge 91 del 16 agosto1992 ha innalzato il requisito fino a 10 anni di residenza per ottenere lastessa.
La medesima sorte è avvenuta con la carta di soggiorno passandoda 5 a 6 anni con la legge Bossi-Fini è anche un dato di fatto quantocontribuiscono gli immigrati alla torta nazionale, circa il 3.2% del PIL.
136
Credo che dobbiamo guardare questi fatti seriamente e fare questascelta di inclusione, perché il voto amministrativo se non superato rima-ne una politica e un sistema di esclusione dei nuovi cittadini di questoPaese.
VALENTINA LESKAJ
Ministro del Lavoro e degli Affari Sociali della Repubblica di Albania
Attualmente, l’Albania vanta il più alto tasso di emigrazione in Euro-pa, valutato attorno al 22% della popolazione complessiva ed attorno al35% della popolazione attiva. Ad oggi sono emigrati all’estero circa 800-900.000 albanesi. La destinazione principale dell’emigrazione albanese è laGrecia, dove vivono circa 600.000 albanesi, seguita dall’Italia con 200.000immigrati. Alcune decine di migliaia di cittadini albanesi sono emigrateverso altri Paesi dell’Unione Europea, gli Stati Uniti e il Canada. E’ stato direcente osservato un aumento della fuga di cervelli verso USA e Canada.
Le rimesse dei migranti rappresentano una voce importante per losviluppo della società albanese. La rapida crescita economica registratadal Paese è in qualche modo dovuto all’afflusso di capitali dai migranti,stimati attorno a USD 600 milioni l’anno.
Le politiche del Governo albanese in tema di migrazioni miranotra l’altro a:
i) Non stimolare artificialmente la migrazione, realizzando politiche fi-nalizzate a promuovere lo sviluppo socioeconomico ed a migliorarela qualità della vita degli albanesi nel proprio Paese.
137
Nella convinzione che il fenomeno della migrazione sia stato e con-tinui ad essere soggetto ad un certo processo di femminilizzazione,per scoraggiare il flusso migratorio il Governo attribuisce la massi-ma priorità ed attenzione alla formazione professionale, soprattuttodi donne e giovani, alla creazione di opportunità per l’ingresso nelmondo del lavoro dei gruppi sociali più vulnerabili, nonché alla pro-mozione dell’attività delle piccole e medie imprese. La Strategia perl’Occupazione e la Formazione Professionale e le politiche del lavo-ro hanno una chiara prospettiva di genere. Colgo quest’occasione persottolineare che anche la comunità internazionale deve dare alle suepolitiche sociali ed economiche una prospettiva di genere molto piùvisibile, anche rafforzando il gender mainstreaming.
ii) Creare le condizioni perché predominino i canali legali di emigrazio-ne, riducendo e bloccando i flussi illegali e combattendo il trafficodi esseri umani.
Per facilitare l’emigrazione legale, abbiamo istituito un sistema infor-mativo che aiuti i cittadini a valutare meglio la decisione di un’even-tuale emigrazione, tenendo in considerazione le possibilità d’inseri-mento nel mercato del lavoro del potenziale Paese di destinazione. Diquesto sistema informativo fa anche parte il sito web del Ministero delLavoro e degli Affari Sociali, cui sta per pervenire l’elenco dei possi-bili emigranti inseribili nel mercato del lavoro italiano, selezionati dal-lo IOM nell’ambito del progetto “Selezione dei flussi migratori dal-l’Albania”, finanziato dal governo italiano. I possibili candidati posso-no essere facilmente chiamati e assunti dai datori di lavoro italiani at-traverso il sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il Governo ha inoltre creato degli istituti finalizzati a collaborare al-la riabilitazione ed alla reintegrazione degli emigrati illegali rientratinel Paese o delle donne e minori vittime di traffico e di violenza. E’ora in funzione il primo centro istituito con il contributo finanziarioe l’assistenza tecnica del Governo USA e dello IOM.
iii) Facilitare e promuovere l’integrazione degli emigranti albanesi nelmercato del lavoro e nella società dei Paesi di accoglienza.
iv) Creare le strutture per la coabitazione della comunità migrante conla popolazione locale nei Paesi di accoglienza, attraverso l’integra-
138
zione culturale e l’adattamento ai processi di europeizzazione e diglobalizzazione.
v) Promuovere il rientro volontario degli emigrati, perché investano il lo-ro capitale umano e finanziario nell’economia e nella società albanese.
Nel quadro del processo di Stabilizzazione ed Associazione conl’Unione Europea, e nel serio intento di creare un quadro giuridico fa-vorevole ed idoneo in materia di migrazione, il Governo albanese, incollaborazione con l’Unione Europea, con organizzazioni internazionaliquali la Banca Mondiale, lo IOM, l’OIL ed i governi dei Paesi di acco-glienza, è impegnato nel miglioramento del quadro legislativo, ancheper rispettare gli standard internazionali in materia di migrazione.
A tale fine, nel mese di maggio del 2003, è stata presentata ed ap-provata dal Parlamento albanese la nuova legge su “L’emigrazione deicittadini albanesi in cerca di occupazione”, mentre nel luglio 2003 èstata migliorata e modificata la “Legge sugli stranieri”. Questi due do-cumenti sanciscono le responsabilità dello Stato nei confronti dei mi-granti albanesi e prevedono pari diritti agli stranieri presenti in Albania.
Inoltre, il Parlamento albanese ha ratificato nel novembre 2002 laCarta Sociale Europea (modificata), e nell’aprile 2003 la ConvenzioneONU “Sulla riduzione del numero di persone apolidi” e la ConvenzioneONU “Sullo status delle persone apolidi”.
Il Governo albanese è anche impegnato nella ratifica di alcuni altritrattati internazionali, quali la Convenzione dell’Unione Europea “Sullostatus legale dei lavoratori migranti”; la Convenzione ONU “Sulla tute-la dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie”; la Con-venzione 97 (1949) “Sulla migrazione del lavoro”; la Convenzione 143(1975) “Sui lavoratori migranti - articoli aggiuntivi”; le Raccomanda-zione OIL nn. 86 e 151. Tutti questi importanti documenti forniscono labase della tutela legale dei lavoratori migranti e delle loro famiglie dalladiscriminazione e dallo sfruttamento.
Attualmente, il Governo albanese sta elaborando la Strategia Na-zionale sulla Migrazione, con il sostegno tecnico e finanziario della de-legazione della Commissione Europea a Tirana e dello IOM.
Più che nell’elaborazione di politiche, strategie e leggi, ci stiamoconcentrando sull’eliminazione del divario tra elaborazione/formulazione
139
e l’effettiva realizzazione/applicazione. Posso dire che la nostra priorità èattualmente l’applicazione degli standard europei ed internazionali.
Nell’affrontare i temi sociali e quello della migrazione, stiamo an-che passando da un’ottica di numeri e cifre ad un’ottica di individui edesseri umani, dando così una attenzione adeguata alla dimensione uma-na e sociale dei problemi.
Il Governo albanese ha firmato accordi sul lavoro stagionale con laGrecia (1996) e con l’Italia (1997) e siamo impegnati nella loro applica-zione a livello regionale, con le regioni Veneto, Puglia, Lombardia, etc.
Come già sottolineato, 200.000 emigranti vivono in Italia e lamaggioranza di essi (oltre 160.000) è dotata di regolari permessi di sog-giorno e di lavoro. Gli emigranti albanesi hanno trovato un lavoro e so-no di norma inseriti ed integrati nella società italiana. Sono in effetti di-ventati un importante fattore di comunicazione e cooperazione tra i duePaesi, finendo per essere proprio i promotori di questa comunicazione ecooperazione. Il ruolo ed il contributo dei migranti albanesi nell’econo-mia e nella società italiana sono riconosciuti persino dalle massime au-torità dello Stato e del Governo italiano. Siamo consapevoli del pro-gresso realizzato per cambiare in positivo l’immagine degli emigrati al-banesi in Italia e siamo impegnati per far sì che gli stessi emigranti pos-sano contribuire a migliorare questa immagine positiva.
Il Governo albanese ha seguito con attenzione le misure adottate dalGoverno italiano in materia di migrazioni ed apprezziamo i tentativi fattifino ad ora per creare le basi istituzionali e legali per i migranti, per il loroinserimento e la loro integrazione nel mercato del lavoro e nella vita so-ciale della società italiana. Apprezzeremmo molto anche misure e politi-che di incremento delle quote di migrazione legale degli albanesi in Italia.Queste misure contribuirebbero in maniera efficace ad impedire il feno-meno dell’immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani, dueimportanti obiettivi condivisi dai Governi dei nostri due Paesi.
Attualmente, il Governo albanese non è impegnato solamente nellasoluzione di problemi immediati, ma anche nello sviluppo di politiche estandard sostenibili che affrontino potenziali problemi e realtà dei mi-granti, tra cui potrei citare la questione del mutuo riconoscimento delleresponsabilità di previdenza sociale dei migranti nei rispettivi Paesi. Ab-biamo notato con piacere la volontà politica dei governi dei principali
140
Paesi di destinazione dei migranti albanesi, la Grecia e l’Italia, di nego-ziare e trovare le soluzioni istituzionali e legali a questa questione.
In conclusione, desidero esprimere di nuovo la convinzione chesui temi della migrazione la cooperazione del Governo albanese con ilGoverno italiano ed i Governi di altri Paesi membri dell’Unione Euro-pea aumenterà ulteriormente, dando così una dimensione sociale ed u-mana a questa collaborazione.
MAURIZIO SACCONI
Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Sono lieto di intervenire dopo il Ministro del Lavoro della Repub-blica di Albania perché considero emblematico il rapporto positivo che siè sviluppato con il Governo albanese nel corso degli anni più recenti, adimostrazione di quanto la collaborazione diretta tra Governi di Paesi diorigine e di Paesi di accoglienza possa consentire di trasformare un feno-meno irregolare e disordinato in un fenomeno, invece, altamente gover-nato. Anche se, come poi dirò, le stesse politiche cui la Signora Leskaj hafatto riferimento per quanto riguarda il mercato del lavoro, necessitano o-ra di una evoluzione ulteriore per essere effettive ed efficaci.
Più in generale vorrei ricordare quanto sia vera l’affermazione chefaceva Giovanna Zaldini quando, con molta franchezza ed onestà intel-lettuale, diceva di come il processo di integrazione sia un fenomenocomplesso - io aggiungo aspro - per il quale nessuno deve illudersi visiano soluzioni facili e di breve periodo.
Occorre avere consapevolezza delle tante oggettive frizioni che si
141
determinano, soprattutto in un Paese nel quale il fenomeno si è svolto conmolto disordine da 144 Paesi, in un arco temporale tutto sommato breve.
Solo in un contesto di ordine, di legalità, e ovviamente di politicheattive, si potranno costruire quei diritti di cittadinanza che non possononon essere l’obiettivo che una società civile vuole darsi per tutti coloroche in essa hanno assunto una stabile residenza e, nel contesto di questasocietà, si legittimano essendo utili a sé e agli altri attraverso il lavoro.Solo in un contesto ordinato sarà possibile convincere la nostra stessasocietà italiana a un diffuso riconoscimento dei diritti di cittadinanza.
Il Governo ritiene che siano tre gli elementi strutturali che posso-no consentire una compiuta e sostenibile integrazione sociale.
In primo luogo, e di questo ovviamente si è molto parlato, un lavorodignitoso. Il che significa - innanzitutto - un lavoro regolare. Non è auto-matica questa affermazione in un Paese, come l’Italia, che ha una cronicaabnorme presenza di lavoro sommerso. Un Paese che registra una dimen-sione, di economia sommersa e di lavoro sommerso, circa doppia rispettoa quella della media dei Paesi industrializzati e dei Paesi dell’Unione Eu-ropea. È ovvio che i flussi irregolari, e non solo quelli irregolari, abbianospesso finito con l’alimentare questo preesistente fenomeno che, seppurecon caratteristiche diverse, è presente su tutto il territorio italiano.
Un lavoro dignitoso significa, ad avviso del Governo, innanzituttoun lavoro esistente all’atto dell’ingresso, in modo che si produca unaintegrazione potenziale già in partenza, attraverso la coniugazione traragione dell’ingresso e disponibilità di un lavoro.
Ma questo non costituisce, per il Governo italiano, solo una sortadi vincolo, di regola. L’integrazione deve essere gestita contemporanea-mente non solo per regole, ma anche per obiettivi. Non a caso, lo stru-mento principe per governare questo risultato, quello di coniugare l’in-gresso con un lavoro dignitoso, tendenzialmente stabile o avente in po-tenza questa caratteristica, è quello di sviluppare politiche di formazio-ne e selezione nei Paesi di origine. Politiche di formazione che possonoe devono essere sostenute da un diritto di prelazione delle persone coin-volte da questi programmi di formazione.
Vorrei ricordare che le azioni di formazione e selezione nei Paesidi origine hanno uno scopo che non è rivolto soltanto all’organizzazio-
142
ne di un ingresso quanto più integrato in partenza, ma sono attività diformazione rivolte anche alle attività italiane in quei Paesi, e sono rivol-te più in generale ad arricchire le risorse umane nei Paesi di origine, aprescindere da un successivo ingresso nel nostro Paese.
Tuttavia, è poi necessario, soprattutto per il cittadino immigrato,garantire un mercato del lavoro efficiente e trasparente in Italia. Acqui-sizione che, purtroppo, ancora non possiamo dire di aver realizzato. L’I -talia non ha mai avuto un mercato del lavoro efficiente e trasparente,dove sia tempestivamente e continuamente monitorata la condizione diciascuna persona in età di lavoro, né un mercato nel quale domanda edofferta si possano incontrare agevolmente.
L’inefficienza del mercato del lavoro italiano è una caratteristica a-tavica cui stiamo cercando di porre rimedio con la recente riforma. Pro-duce conseguenze negative soprattutto sulle fasce deboli del mercatodel lavoro, cui appartiene, vorrei dire quasi per definizione, anche il cit-tadino immigrato che, pur entrato nel nostro Paese con un lavoro rego-lare, poi lo abbia perduto e ne cerchi un altro.
Lo stato di disoccupazione di questo cittadino rappresenta una condi-zione di maggiore e oggettiva debolezza e, d’altronde, le statistiche ci di-cono come, in un Paese come l’Italia, che già detiene un triste primato didisoccupati di lungo periodo, il cittadino immigrato e disoccupato è desti-nato ad un periodo di disoccupazione più lungo del cittadino residente.
Questo impone, quindi, un mercato del lavoro efficiente, trasparen-te, dove funzionino gli strumenti che la riforma prevede: l’anagrafe dellavoratore, il libretto formativo, che incoraggia anche politiche attive, co-me quella dell’apprendimento continuo, che si possono realizzare effica-cemente solo se inserite in un mercato trasparente in cui siano conoscibilitempestivamente le caratteristiche della domanda e dell’offerta.
Non è un caso che, nella stessa legge di riforma, siano previste poiazioni sperimentali per le fasce deboli del mercato del lavoro, anchepromosse dagli enti locali.
Penso alle buone pratiche che stanno avviandosi a cura della stessaamministrazione comunale per esempio a Milano, sulla base di un im-pulso che diede lo stesso Marco Biagi. Sono iniziative rivolte proprioalle fasce più deboli del mercato, alla disoccupazione degli immigrati,attraverso la collaborazione tra istituzioni pubbliche e agenzie private
143
per il lavoro, disponendo di incentivi che la legge ora prevede.
Segnalo inoltre l’importanza delle politiche di sostegno all’auto-occupazione, perché anche i cittadini immigrati possano intraprendere edare vita a forme di lavoro indipendente e autonomo, con le quali nonsolo essi realizzano un risultato per sé e per il proprio sostentamento,ma producono legittimazione anche per le comunità cui appartengono.Raggiungono cioè un risultato di interesse collettivo.
Nel nostro Paese, il Governo sta cercando di valorizzare queste e-sperienze d’intesa con le associazioni rappresentative del lavoro auto-nomo, che orgogliosamente hanno voluto sottolineare il successo dimolti cittadini immigrati che, da un lavoro dipendente, sono passati aduna forma di lavoro autonomo. E va citato anche il sostegno al ritornodi cittadini immigrati nei Paesi di origine, con l’intenzione di trasporvil’esperienza acquisita nel Paese di emigrazione in funzione di una atti-vità autonoma d’impresa.
Il secondo elemento strutturale per una compiuta e sostenibile in-tegrazione sociale che voglio segnalare, è quello dell’abitazione digni-tosa. Abitazione dignitosa che, secondo la legge di riforma, costituisceanche un vincolo.
Deve essere garantita dall’imprenditore all’atto in cui richiede ilnullaosta per l’assunzione del cittadino, che, peraltro, deve essere pro-mossa con opportune politiche attive, Prime fra tutte quelle dell’ediliziapubblica popolare, cui accedono i cittadini immigrati secondo le regolevigenti. Abbiamo cercato, d’intesa con molte Regioni, di promuoverepolitiche per il sostegno degli affitti, e alcune di esse stanno opportuna-mente intervenendo anche con provvedimenti di natura urbanistica,consistenti per esempio nelle foresterie aziendali.
Anche le associazioni imprenditoriali, giustamente e doverosa-mente, si stanno attivando d’intesa con gli enti locali per dare vita ad unpatrimonio abitativo di tipo rotativo da porre a disposizione dei cittadiniimmigrati soprattutto nel momento della prima accoglienza.
Segnalo, a questo proposito, che è necessario evitare il formarsi di ghet-ti. Nella prima fase di immigrazione, fortunatamente non si sono prodotti an-che grazie alla struttura abitativa “diffusa” che caratterizza larga parte del no-stro Paese. Ma in una seconda fase, come è quella che stiamo vivendo e che
144
tale possiamo definire, tali ghetti possono prodursi anche e proprio in relazio-ne all’evoluzione: molti cittadini immigrati sono ora in grado di comprare unalloggio e questa disponibilità all’acquisto potrebbe concentrarsi verso allog-gi a basso costo, generando talvolta quei fenomeni di concentrazione e di iso-lamento che sino ad ora fortunatamente non si sono creati.
Anche per questo considero sbagliato un atteggiamento di condi-scendenza nei confronti delle occupazioni abusive che molto spessodanno luogo, queste sì, a veri e propri ghetti con le peggiori presenze diracket e malavita organizzata. Zone franche da qualsiasi regola e chenon aiutano la legittimazione sociale, il rapporto cioè fra cittadini immi-grati e le comunità nelle quali insistono.
Il terzo elemento strutturale è quello della conoscenza della linguaitaliana, premessa assoluta per i diritti di cittadinanza. Ma premessa an-che oggettiva per ogni percorso di integrazione. Può sembrare questoun requisito banale, ma così banale non è, e forse sono ancora insuffi -cienti le politiche a ciò dedicate.
Al fine di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro,stiamo sviluppando politiche per la conoscenza della lingua italiana pri-ma di tutto nei Paesi di origine, ma anche all’interno del nostro Paese,attraverso diversi strumenti: il progetto “Io parlo italiano”, gli accordidi programma con 14 Regioni e, infine, la certificazione ufficiale di co-noscenza della lingua italiana.
Concludendo, credo che le politiche di mediazione culturale debbanoessere prioritariamente rivolte a favorire quanto più possibile il rapportotra i cittadini immigrati e le istituzioni e i servizi dello Stato ospitante.
Talvolta abbiamo la sensazione che alcune di queste politiche sianoguidate più dalle esigenze di alcuni operatori, o di alcuni intermediari,piuttosto che da esigenze effettive. E queste non possono non essere riferi-te, prima di tutto, al rapporto con le istituzioni e i servizi. Mi riferisco peresempio al rapporto del cittadino immigrato con le istituzioni che presidia-no la sicurezza, affinché egli possa fino in fondo far valere i propri diritti,comprendendo le procedure, i profili formali che le regolano. Mi riferiscoallo stesso tempo anche a quei progetti prioritari che abbiamo sostenutoper quanto riguarda i mediatori culturali rivolti all’area socio sanitaria.
In altri termini, sono queste le azioni assolutamente prioritarie alle
145
quali dedicare anche la mediazione culturale.
Ho cercato di focalizzare quelli che ho chiamato elementi struttu-
rali per una compiuta e sostenibile integrazione sociale, al fine di evita-
re la dispersione in tanti rivoli di politiche, pur generose, ma che po-
trebbero non determinare quegli effetti duraturi in termini di integrazio-
ne che vogliamo ovviamente perseguire.
II SESSIONE
QUADRO GIURIDICO COMUNITARIO
E CONTROLLO DELLE FRONTIERE ESTERNE
146
FRANCESCASANTORO
Vice Presidente del CNEL
Gentilissimi ospiti, questa sessione, come peraltro tutta la nostraConferenza, non a caso programmata in concomitanza con il Semestredi Presidenza italiana, intende dare un contributo, un impulso, un soste-gno ai lavori che, entro il 2004, dovranno portare a compimento le nor-mative comunitarie in tema di immigrazione ed asilo.
Si tratta, come acutamente ha osservato il Prof. Diamanti, di unodei test più significativi della costruzione europea, di uno snodo crucia-le, in un anno cruciale - il 2004 - che il primo maggio saluterà l’ingres-so a pieno titolo dei dieci nuovi Stati membri dell’UE, la stessa data en-tro cui il Trattato di Amsterdam obbliga il Consiglio a completare unaprima fase dell’integrazione europea - cito testualmente - “non arrestan-do l’immigrazione, ma facendo defluire in un corso normale e regolarela globalizzazione umana”.
Proprio con il Trattato di Amsterdam, come è stato rilevato a parti-re dalla relazione del Presidente del Comitato per l’immigrazione delCNEL, Giorgio Alessandrini, la materia dell’immigrazione e dell’asiloassume un’importanza nuova, determinando il passaggio obbligato dal-la cooperazione intergovernativa all’applicazione del diritto comunita-rio sovranazionale, indicando in cinque anni il tempo utile per la defini-zione di una politica comune, di un sistema uniforme di norme e di re-gole codecise a maggioranza qualificata. Di qui la scadenza del primomaggio.
148
Il Consiglio di Vienna ha successivamente approvato un piano diazione dettagliato in materia e, nel 1999, a Tampere, anche qui come èstato ampiamente ricordato nel corso dei nostri lavori, il Consiglio eu-ropeo inietta una dose ulteriore di volontà politica nell’intero processodi comunitarizzazione e viene redatto un quadro di controllo delle mi-sure necessarie alla conservazione ed al rafforzamento di uno spazio dilibertà, sicurezza e giustizia.
L’elaborazione di una politica comune, migratoria e di asilo, rappre-senta, insieme allo spazio di giustizia e di lotta alla criminalità, uno deitre macrosettori in cui l’Unione Europea si impegna ad intervenire. L’U-nione, quindi, acquista nuove competenze, anche in settori tipicamentedestinati alla sovranità nazionale, come appunto quello migratorio e del-l’asilo. Tampere, infatti, prevede espressamente che sia effettuata una co-mune, incisiva, politica di integrazione, tendente a garantire ai cittadinidei Paesi Terzi, che risiedono legalmente nel territorio degli Stati membri,diritti ed obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’Unione Europea.
È in questa linea che si ispirano le proposte presentate dalla Com-missione dal 1999 al 2000, anno in cui è promulgata la Carta dei dirittifondamentali dell’Unione Europea, ed è anche in questa direzione chela Commissione continua ad ispirarsi nelle sue proposte.
Con il Consiglio di Siviglia del giugno 2002 e poi con la secondaConferenza internazionale dell’ottobre del 2002, però, il pendolo dellepolitiche migratorie torna all’impostazione prevalente della lunga sta-gione di Shengen. L’attenzione per l’immigrazione regolare e per l’inte-grazione si indebolisce; la priorità torna ad essere il controllo dellefrontiere e la questione cruciale del rapporto tra Paesi di origine, ditransito e di destinazione dei flussi migratori, in particolare di quellinon autorizzati.
In tale orientamento emerge evidente la traccia delle paure, dellepreoccupazioni, delle incertezze profonde che, all’indomani dell’11 set-tembre, con la ripresa del terrorismo internazionale e poi con i venti diguerra, hanno sconvolto il mondo intero, generando diffidenza e chiusura.
Dobbiamo prendere atto che, negli ultimi tre anni, l’emergenzaimmigrazione, con il conseguente impatto sociale sull’opinione pubbli-ca, ha affievolito, nelle politiche nazionali dei Paesi europei, il forte im-
149
pegno di integrazione sociale che era alla base delle decisioni di Tam-pere. I più recenti orientamenti nazionali e comunitari spesso non ten-gono conto, anche questo è stato sottolineato, dei caratteri strutturali delfenomeno immigrazione. Anzi, presuppongono un’immigrazione corta,in pieno contrasto con la domanda del mondo dell’impresa e con le a-spettative e i comportamenti di stabilizzazione degli immigrati.
È auspicabile, dunque, a nostro parere, un cambiamento profondodi indirizzo, come peraltro riaffermato dal recente Vertice di Salonicco,capace di recuperare un giusto equilibrio tra necessarie politiche di si-curezza e politiche complessive di integrazione, di accoglienza civile edi diritti di cittadinanza. D’altra parte, il Governo dei flussi migratorinon può essere inteso come un capitolo a sé, ma deve essere considera-to una parte sostanziale del progetto più ampio che riguarda l’Europa,la sua capacità di dialogo con il Mediterraneo, la sua capacità di co-struire una politica di cooperazione e di pace, il suo modello di svilup-po, le sue politiche di welfare, la qualità della convivenza umana e so-ciale. In una parola, lo sviluppo economico coniugato, e anzi alimenta-to, dallo sviluppo sociale.
Occorre quindi ridare slancio alla politica comunitaria, secondo gliindirizzi che ha perseguito in questi anni il Commissario Antonio Vitorinoe che ha richiamato il Presidente Prodi: contrasto all’immigrazione clande-stina, ingresso regolare, diritto di asilo, cittadinanza per gli stranieri.
Qualche risultato comincia a maturare, come l’accordo raggiuntoin occasione del Consiglio del 27 febbraio 2003 sul diritto al ricongiun-gimento familiare, questione decisiva e strumento indispensabile ai finidell’integrazione, e quello sul tema dei residenti di lungo periodo. Vadetto che non è sufficiente stanziare un fondo per i Paesi che riammet-tono i clandestini, ma bisogna puntare sugli accordi bilaterali che, comedimostrano Tunisia, Marocco e Albania, se rispettati, sono efficaci, per-ché coniugano quote di ingressi regolari, aiuti allo sviluppo, riammis-sione dei clandestini.
Altre iniziative devono essere definite e meglio precisate. Tra que-ste, quella sul controllo comunitario delle frontiere, vale a dire la for-mazione del personale addetto, l’analisi dei rischi e la fornitura di mate-riale tecnico. Poi la proposta di direttiva del Consiglio sull’ingresso e il
150
soggiorno dei cittadini immigrati che svolgono attività di lavoro subordi-nato o autonomo per offrire ai lavoratori dei Paesi Terzi un percorso checonduca ad una maggiore stabilità e ad uno stato giuridico più certo.
La Commissione ha inoltre presentato numerose proposte di diret-tiva sull’ingresso per chi svolge attività di studio o di volontariato e stapredisponendo una nuova proposta relativa ai ricercatori.
Sono quasi tutti aspetti strutturali della politica di integrazione cheerano già alla base delle decisioni del Consiglio di Tampere.
In un nuovo documento politico sull’immigrazione, l’integrazionee l’occupazione (3 giugno 2003) la stessa Commissione sottolinea comesarà sempre più grande il fabbisogno di migranti economici nell’UE percolmare le carenze di manodopera qualificata e non, e auspica una mi-gliore integrazione dei migranti nell’Unione, invitando gli Stati membriad intensificare gli sforzi a garantire la piena partecipazione degliimmigrati.
D’altro canto, come ha osservato il Commissario per l’Occupazionee per gli Affari Sociali Anna Diamantopoulou, “l’immigrazione zero nonè un’opzione. L’aumento dei flussi immigratori è inevitabile, dati talunifattori di spinta come l’instabilità politica nel mondo o la disparità di be-nessere. Eppure, un’immigrazione gestita bene è persino necessaria perrispondere al fabbisogno futuro del mercato del lavoro europeo. Perchél’immigrazione sia un successo, soprattutto per gli attuali cittadini del-l’UE, l’Europa deve migliorare radicalmente l’integrazione dei migrantigià stabiliti e prepararsi, sin d’ora, alle immigrazioni future”.
Particolare attenzione dovrà essere data a categorie particolari dimigranti, quali le donne, che spesso subiscono una doppia discrimina-zione legata al genere e all’origine etnica, i rifugiati e i migranti di se-conda e terza generazione.
È auspicabile che, durante la Presidenza italiana, giungano a matu-razione due atti chiave nel campo delle politiche dell’asilo, quello sullecondizioni da soddisfare per ottenere la qualifica di rifugiato, o di per-sona comunque con la necessità di protezione internazionale, e quellosulle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato. Imigranti di seconda e terza generazione sono un’altra categoria cui de-ve essere prestata una attenzione particolare. La discriminazione razzia-
151
le e sociale spesso può impedire al giovane di accedere su un piano pa-ritario, rispetto ai cittadini del Paese ospitante, ad un ruolo nella societàospitante.
Questa condizione, spesso, è ulteriormente aggravata dalla man-canza di una chiara identità, poiché si ha la sensazione di essere rifiutatidalla società ospitante e, allo stesso tempo, i legami con il Paese di ori-gine si sono indeboliti o sono scomparsi del tutto. L’individuazione del-le cause e lo sviluppo di politiche dirette ad affrontarle, nelle quali unruolo fondamentale spetta all’istruzione ed alla formazione, aiuterannonel futuro a risolvere questi problemi.
In questo quadro, per dare concretezza alle sue decisioni, l’UnioneEuropea ha previsto anche strumenti finanziari che possono favorire di-rettamente o indirettamente l’integrazione dei migranti. Ma, come ab-biamo già visto ed analizzato, si tratta, pur essendo un passo avanti, an-cora di quantità decisamente insufficienti.
Per concludere, come sentiremo da due interventi della nostrasessione, in questa Conferenza vengono avanzate due proposte specifi-che di Direttiva, consolidate nell’ordinamento italiano, che devono im-pegnare la Presidenza dell’Unione. La prima riguarda l’estensione del-l’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, comunque presenti sul territoriodell’Unione. La seconda, la previsione di un permesso di soggiornotemporaneo umanitario, rinnovabile, a persone che si trovano in condi-zione di riduzione in schiavitù e che intendono accettare un percorso direinserimento e protezione sociale (ci riferiamo all’articolo 18 del TestoUnico sull’immigrazione).
Mi auguro, quindi, che la Conferenza di oggi possa contribuire adare quella spinta necessaria per un quadro giuridico comune che tengaconto dei caratteri strutturali della nuova immigrazione, senza mai per-dere di vista che il governo dei flussi migratori, come è stato sottolinea-to, non può essere considerato un tema fra i tanti, proprio perché attieneall’anima stessa del progetto politico di un’Europa allargata. Un proget-to che è radicato nel riconoscimento di una comune civiltà, intimamentelegato al Mediterraneo, ad una politica di cooperazione e di pace e adun modello di sviluppo che non deve temere, ma esaltare, la qualità del-la convivenza umana.
152
ANDREA KINTIS
Presidente del Consiglio Economico e Sociale della Grecia (OKE)
Signor Presidente, cari colleghi ed amici,
Desidero unirmi agli oratori precedenti nel ringraziarvi per la calo-rosa ospitalità che ci avete offerto a Roma e per l’eccellente organizza-zione di questa conferenza. Ma soprattutto, desidero complimentarmicon il Consiglio Nazionale dell’Economia e il Lavoro per la sua deci-sione di tenere una conferenza sul tema delle immigrazioni. Come sape-te, lo scorso febbraio, abbiamo avuto una riunione ad Atene per discute-re l’integrazione sociale ed economica degli immigrati, e una delle cosesu cui siamo stati tutti d’accordo era che il tema dell’immigrazione nonè uno dei temi della Presidenza, ma è una materia che dovremmo tratta-re nel prossimo decennio o anche decenni. Il fatto che due presidenzeconsecutive, quella greca e quella italiana, abbiano inserito il tema del-l’immigrazione tra le loro priorità è un segno incoraggiante della sem-pre maggiore consapevolezza che l’immigrazione è un fenomeno dilungo periodo e che può essere trattato in modo più efficace solo sullabase di una stretta collaborazione tre gli Stati membri dell’UnioneEuropea.
Fatte queste considerazioni, desidero entrare nel tema particolareche stiamo discutendo in questa sessione, cioè l’immigrazione illegale ei modi per combatterla a livello di Unione Europea. Il mio interventoseguirà un approccio in tre fasi: primo, tratterò il problema di come do-vremmo definire la misura dell’immigrazione legale; e questo perché ri-
153
tengo che quando parliamo di come trattare l’immigrazione illegaledobbiamo, in primo luogo, conoscere quale è la misura dell’immigra-zione desiderabile, oltre la quale l’emigrazione dovrebbe essere impedi-ta. Secondo, parlerò del tema dei richiedenti asilo e del problema di co-me distinguerli dagli immigrati illegali per ragioni economiche. Terzo,avendo stabilito come dovrebbe essere etichetta realmente l’immigra-zione illegale, parlerò delle politiche per combatterla.
a. Definizione dell’immigrazione legale
Ritengo, signor Presidente, che il primo tema da trattare, ed è unodi quelli che gli Stati membri desiderano discutere di meno a livello co-munitario, è il criterio con il quale uno Stato dovrebbe definire la misu-ra dell’immigrazione desiderabile e, conseguentemente, dell’immigra-zione legale. In altre parole, a che punto gli Stati dovrebbero tracciarela linea oltre la quale un potenziale migrante non può entrare legalmen-te nel suo territorio, il territorio dell’Unione Europea. Presso il Comita-to Economico e Sociale greco, abbiamo affrontato il tema ripetutamenteperché negli ultimi sette anni vi sono stati tre tentativi legislativi di de-finire l’ambito della immigrazione legale e illegale. Non è stato uncompito facile e non è stato facilmente raggiunto un consenso, ma laconclusione è stata che il mercato del lavoro dovrebbe essere il fattorepredominante nel determinare il numero e le qualifiche che i potenzialiemigranti devono avere per entrare legalmente nel Paese. Per quanto visono posti di lavoro vacanti per i quali non esiste un interesse o una for-za lavoro nazionale adeguata (e ve ne sono molti in Grecia, specialmen-te nell’agricoltura, nelle costruzioni e nell’industria), l’immigrazione èun prerequisito per lo sviluppo e dovrebbe, quindi, essere permessa eincoraggiata. Nel mio Paese il problema è che non siamo in grado dicreare una carta con i posti di lavoro disponibili per specialità e per re-gione e quindi informare i potenziali immigranti su queste opportunità.
Inoltre, non dobbiamo dimenticare che i fabbisogni del mercatodel lavoro possono essere distorti dal cosiddetto mercato nero. I posti dilavoro possono essere vacanti non perché nessuno è interessato a questi,ma perché alcuni datori di lavoro desiderano conservarli tali per il lavo-ro illegale senza assicurazione sociale e senza gli standard minimi deicontratti collettivi. Questo fabbisogno di forza lavoro straniera dovreb-
154
be essere scoraggiato e non tollerato. I datori di lavoro dovrebbero esse-re scoraggiati dall’occupare lavoratori stranieri non dichiarati attraversouna rigorosa applicazione dei meccanismi di controllo della forza lavo-ro che esistono in ogni Paese (in Grecia abbiamo gli “Ispettorati del la-voro”) e attraverso la prospettiva di pene severe. Queste pene dovrebbe-ro comprendere la detenzione, elevate ammende economiche e la co-pertura dei costi per il rimpatrio, come ha suggerito la CommissioneEuropea nella sua Comunicazione “Su una politica comune sull’immi-grazione illegale” e come ha sostenuto il Consiglio Economico e Socia-le Europeo nel suo Parere pertinente. Penso che possiamo essere tuttid’accordo sul fatto che, mentre le nostre società possono dimostrare laloro compassione verso gli immigrati illegali, queste stesse società do-vrebbero dimostrare tolleranza zero nei confronti di quei datori di lavo-ro (sono certo che siano una minoranza) che occupano immigrati illega-li al fine di evadere i loro obblighi salariali, fiscali e assicurativi. E que-sto perché l’occupazione sottopagata crea una domanda indesiderabileper l’immigrazione, a danno degli immigrati ed anche dei Paesi di acco-glienza.
b. Distinguere dai richiedenti asilo
Un altro aspetto del problema relativo alla definizione dell’esten-sione dell’immigrazione illegale, è la distinzione tra i richiedenti asilo egli immigrati per ragioni economiche. Siamo tutti d’accordo che dob-biamo mettere in atto la Convenzione di Ginevra sui Rifugiati e proteg-gere le persone provenienti da “un territorio dove la loro vita o la lorolibertà sono state minacciate”, come sancisce l’articolo 31 della Con-venzione di Ginevra. Il problema è che questa oppressione politica ènormalmente abbinata alla coercizione economica in aree quali il Me-dio Oriente o l’Africa e il tentativo di individuare il reale motivo dellepersone che sono entrate illegalmente in un Paese e la richiesta di asiloè un lavoro molto delicato. Il pericolo è duplice: o si è troppo flessibilie si apre un varco per l’abuso del processo di asilo o si è troppo rigidi esi respingono domande che dovrebbero essere accolte. Ancora peggio,con l’essere troppo flessibili, si incoraggiano i potenziali richiedenti adusare una strada alternativa dell’immigrazione illegale e si crea un nuo-vo caso per gli immigrati non dichiarati.
155
Non ho una soluzione facile per risolvere il problema e ritengo chenessuno ne abbia una. Inoltre, ritengo che a questo fine sarà utile unoscambio di esperienze e di pratiche tra le autorità competenti degli Statimembri. Gli Stati che vantano una lunga tradizione di accoglienza dellerichieste di asilo avranno una quantità di esperienze da condividere constati come la Grecia, la Spagna o il Portogallo che hanno poca esperien-za e quindi poca pratica. Ed a questo punto posso aggiungere che è unaironia della storia che questi tre Paesi che hanno conosciuto lunghe dit-tature e che sono stati esportatori di richiedenti asilo ora si trovano ache fare con i richiedenti asilo e tentano di distinguere il reale rifugiatopolitico dai migranti per motivi economici.
E prima di abbandonare il tema dei richiedenti asilo, vorrei richia-mare la vostra attenzione su una interessante proposta fatta dalla Com-missione Europea: devono essere trovati i modi per incoraggiare le perso-ne che sono in cerca di asilo, facendo la richiesta quando si trovano anco-ra nel loro Paese. Quindi, conosceranno in anticipo il risultato della lororichiesta e, in caso positivo, saranno meno alla mercè dei trafficanti di es-seri umani. Inoltre, il fatto che formuleranno la richiesta quando sono an-cora nel loro Paese, permetterà uno screening più informato del loro casoda parte dell’ambasciata del Paese o anche dei Paesi a cui è stata rivoltala domanda. E’ superfluo dire che la cooperazione tra gli Stati membri elo scambio di informazioni sulle richieste individuali permetteranno deci-sioni più informate sul fatto se concedere o meno l’asilo.
c. Le politiche legali ed altre per combattere l’immigrazione illegale
E dopo queste osservazioni, che io considero necessarie per avereun quadro migliore di ciò che è definito, o peggiore, di cosa potrebbeessere definita come immigrazione illegale, vorrei entrare nel cuore del-la nostra discussione che riguarda la lotta all’immigrazione illegale.
Il problema presenta due aspetti distinti: come trattare gli immi-grati illegali che si trovano già all’interno di un Paese e come impedireche futuri immigrati entrino illegalmente in quel Paese. E’ evidente cheogni caso richiede politiche diverse.
- Il trattamento degli immigrati illegali che si trovano già all’interno diun Paese.
156
E’ stato stimato che, in Grecia, vi siano circa 400.000 immigrati il-legali, una percentuale pari al 4% del totale della popolazione e al 40%del totale degli immigrati. Naturalmente, queste stime presentano sem-pre un certo grado di incertezza, ma danno un’idea dell’estensione delproblema. Evidentemente, è difficile immaginare una politica per deci-dere di espellere tutte queste persone nei loro Paesi. La tragedia umani-taria potrebbe essere immensa e il costo per le autorità ed anche per l’e-conomia potrebbe essere enorme. Quindi, abbiamo bisogno di altre po-litiche, politiche che sono discusse ed adottate a livello nazionale mache raramente riescono a raggiungere il livello europeo. Naturalmente,non parlo delle conferenze come questa ma del livello decisionale deiConsigli e della Commissione. E’ superfluo ricordare che il ConsiglioEconomico e Sociale Europeo ha criticato le proposte della Commissio-ne per aver trascurato questo aspetto del problema.
Cosa dovremmo fare? Ritengo che sia importante incoraggiare gliimmigranti perché si registrino. Come dice il Consiglio Economico eSociale Europeo nel suo parere pertinente, gli Stati membri dovrebbero“predisporre misure di regolarizzazione”, avvertendo il rischio chel’immigrazione irregolare sia considerata come una “porta di servizio”per la migrazione legale”. Penso che potrebbe essere facilmente conces-so un permesso di soggiorno di breve periodo (uno o due anni) insiemecon i pieni diritti al lavoro, alla salute e all’assicurazione sociale ed an-che molti diritti civili fondamentali, come l’educazione, l’abitazione,l’accesso ai tribunali, ecc. L’incoraggiamento dovrebbe essere diretto aidatori di lavoro ai quali si dovrebbe consentire di registrare i lavoratoriillegali senza correre il rischio di essere incriminati. E’ superfluo direche dovrebbe essere data a questo sforzo di registrazione la più ampiapubblicità possibile e che le procedure dovrebbero essere semplificate esenza molti requisiti che potrebbero scoraggiare i datori di lavoro e i di-pendenti dall’inserirsi nel processo di legislazione. Durante questo pe-riodo, dovrebbe essere analizzata la capacità dell’immigrante di trovareun posto regolare nel mercato del lavoro e solo se questa prova risultanegativa, dovrebbe essere adottata la soluzione del rimpatrio. Natural-mente, il rimpatrio dovrebbe avvenire in modo umano, nel rispetto delladignità del rimpatriato. A questo riguardo, la proposta ora in discussio-ne a livello dell’UE su come dovrebbe avvenire la procedura di rimpa-
157
trio è un passo positivo, ma gli ostacoli incontrati dimostrano la diffi -coltà di raggiungere un consenso europeo anche su questo punto chenon è uno dei più difficili nel problema generale dell’immigrazione ille-gale.
Questo passo deve essere accompagnato da un’efficace politicacontro il lavoro illegale. Ho già parlato delle misure nei confronti deidatori di lavoro e dell’intensificazione degli sforzi da parte delle autori-tà per individuare il lavoro illegale. Se avremo successo su questo fron-te, ne trarremo un duplice beneficio: da un lato, un maggior numero diimmigrati e di datori di lavoro saranno incoraggiati o costretti a dichia-rarsi e, dall’altro, per quegli immigrati che non si registrano, sarà diffi -cile nascondersi e quindi dovranno seriamente prendere in considera-zione di lasciare il Paese.
Naturalmente, la legalizzazione degli immigrati illegali non è suf-ficiente. Un immigrato può essere “legale” in teoria, sui documenti, secosì posso dire, ma può essere completamente residente in una determi-nata società, senza che gli sia concesso di godere realmente di tutti i be-nefici della legislazione. Per questa ragione, le politiche di integrazionegenerale devono essere portate avanti su tutti i fronti, e sono ansioso diascoltare le conclusioni dell’altro seminario di lavoro che affronta lepolitiche dell’integrazione sociale e di condividere con voi alcune delleconclusioni che sono state raggiunte alla Conferenza di Atene delloscorso febbraio.
- Prevenzione delle nuove immigrazioni illegali
Penso che questo sia l’aspetto della politica per le migrazioni piùdiscusso a livello europeo. Conosciamo tutti le proposte fatte dallaCommissione Europea su questo fronte, di cui le più importanti sono:
a. Rendere più sicuri i visti e cosa più importante, la creazione di strut-ture amministrative europee per il rilascio dei visti ubicate nei Paesidi origine. E’ stata, inoltre, presa in considerazione la creazione diun sistema on-line con tutti i dati relativi ai visti.
b. Migliorare la raccolta dei dati tra gli stati membri relativi all’asilo ealla migrazione e la creazione di un Osservatorio Europeo sulle mi-grazioni che dovrebbe studiare i flussi migratori.
158
c. Nominare funzionari di collegamento per l’immigrazione.
d. Finanziamento di programmi nei Paesi Terzi che dovrebbero esseremirati ad accrescere il livello di affidabilità delle registrazioni pub-bliche ed anche ad accrescere la consapevolezza pubblica circa larealtà dell’immigrazione illegale.
e. Creazione di un Guardia di frontiera europea con un curriculum, for-mazione e sorveglianza comuni attraverso squadre congiunte.
f. Adozione di leggi penali severe contro i trafficanti di esseri umani e ivettori coinvolti nel trasferimento degli immigrati legali.
Devo ammettere, signor Presidente, che non sono un esperto nellematerie relative alla legge penale o alle attività di polizia, né penso chelo siano molti presenti in questa sala. Quindi non entrerò in una discus-sione dettagliata su ciascuna di queste proposte. Vi sono altre personesono più adatte di me per questo compito.
Tuttavia, vorrei fare alcune considerazioni sulla natura politica re-lativamente a queste proposte:
a. Nessuna di queste proposte prende in considerazione le radici del-l’immigrazione che sono la disoccupazione e la povertà nei Paesi diorigine. L’Unione Europea migliorerà di molto le possibilità di limi-tare l’immigrazione illegale se dirigerà i suoi sforzi verso la stabiliz-zazione economica e politica dei Paesi che generano migrazioni. Perprendere l’esempio della Grecia, le aree principali di origine sono iBalcani e il Medio Oriente; queste sono esattamente le aree più dura-mente colpite dalla guerra che ha degradato le condizioni economi-che e sociali delle popolazioni locali. Tutti abbiamo delle responsa-bilità su questo problema e spero che le incomprensioni del passatoservano come lezioni per il futuro. Non possiamo avere un’efficacepolitica per le immigrazioni senza una politica estera comune checontribuirà alla pace e alla stabilità sulla scena mondiale.
b. Il controllo delle frontiere non è un compito solo dei Paesi più vulnera-bili dal punto di vista geografico ai flussi migratori. Le opportunità dimobilità che esistono all’interno dell’Unione Europea sono tali che u-na volta che un immigrato illegale è entrato in un Paese, può facilmen-te spostarsi in un altro Paese. L’onere finanziario del controllo delle
159
frontiere deve essere condiviso da tutti i Paesi in base alla loro capaci-tà finanziaria e non per la loro vicinanza alle correnti di migrazione.
c. La creazione di leggi penali severe contro i trafficanti di esseri umanirichiede la cooperazione delle loro vittime. Dovrebbero essere dati aglistranieri illegali motivi validi per sentirsi sicuri di andare dalle autoritàe fornire informazioni relative alle persone coinvolte nelle reti del traf-fico di esseri umani. Tali motivi dovranno necessariamente compren-dere un permesso di soggiorno temporaneo fino al termine del proces-so giudiziario e un diritto di ottenere un permesso permanente se, nelfrattempo, l’immigrato trova un’occupazione nel mercato del lavorolegale. Inoltre, deve essere tracciata una sottile linea per prevenire gliabusi del sistema che possono creare schemi che portano ad un pro-cesso di legislazione indesiderabile. Come sappiamo, in seno all’Unio-ne Europea si sta discutendo il tema del rilascio di permessi di sog-giorno di breve durata agli immigrati che collaborano con le autorità alfine di individuare, arrestare e giudicare i trafficanti di esseri umani euno scambio delle esperienze e delle pratiche contribuirà certamentead un più efficace approccio al problema.
E prima di terminare con la lotta contro il traffico di esseri umani,devono aggiungere qualcosa che ritengo importante ma che normal-mente viene trascurato: un’efficace lotta contro il traffico di esseri uma-ni richiede anche la collaborazione dei cittadini dei nostri Paesi. L’opi-nione pubblica non è pienamente consapevole della portata del fenome-no e delle condizioni a cui sono soggette migliaia di persone. Una indif-ferenza al problema è il risultato previsto di questa situazione e le agen-zie di applicazione della legge non hanno la collaborazione delle perso-ne che potrebbero fornire loro informazioni fondamentali. Questa situa-zione deve essere affrontata attraverso un’azione futura in questo cam-po a livello nazionale ed europeo.
E con queste osservazioni, mi permetta, signor Presidente, di con-cludere il mio intervento, nel corso del quale non ho avuto la pretesa diesaurire i temi coinvolti ma solo di presentarli, metterli in una prospetti-va e di fornire alcune idee per una riflessione comune per le possibilisoluzioni di un problema che non ha una risposta semplice ed univoca.
Grazie.
160
DERMOT McCARTHY
Presidente del Consiglio Nazionale Economico e Sociale dell’Irlanda(NESC)
Desidero fare i complimenti al CNEL per aver preso l’iniziativa diorganizzare questa conferenza su un tema così importante.
Desidero fare alcuni brevi cenni alla prospettiva irlandese sul temadell’incontro di oggi. L’Irlanda ha - come è evidente - una notevole fami-liarità con i problemi della migrazione. Il 25% delle persone nate sull’iso-la dell’Irlanda negli ultimi 100 anni è emigrato. Storicamente la nostra fa-miliarità con la questione dell’immigrazione e con i suoi problemi è inve-ce molto più recente. Nel 1995, ad esempio, le richieste di asilo eranomeno di 500 in un anno, mentre l’anno scorso superavano il numero di1.000 al mese. Nel 1995, l’Irlanda riceveva 4.500 domande di permessodi soggiorno per motivi di lavoro da immigrati provenienti da regionifuori dell’Area Economica Europea. L’anno scorso il numero era decupli-cato. E la nostra popolazione non supera i 4 milioni di abitanti.
La situazione attuale è che il 6% della popolazione residente è natafuori dal Paese e quindi il dibattito in corso in Europa su immigrazione,migrazioni ed integrazione ci interessa in maniera molto diretta e più diquanto non ci riguardasse qualche anno fa.
Quindi, nella sua relazione strategica predisposta l’anno scorso, ilmio Consiglio ha analizzato la questione delle politiche migratorie, valu-tando le implicazioni interne dei trend migratori e le relative sfide allapolitica ed alle istituzioni. Abbiamo raccomandato che l’Irlanda lavorasse
161
per l’adozione di un approccio più esaustivo e strategico alle politichemigratorie, su una base coerente con il quadro degli accordi sottoscrittitra il Governo irlandese e le parti sociali in tema di sviluppo economico esociale del Paese. Siamo quindi molto lieti del fatto che nel contratto so-ciale negoziato tra il Governo e le parti sociali all’inizio di quest’anno,l’intera questione delle politiche migratorie sia stata di comune accordoconsiderata come un’iniziativa speciale da realizzare nei prossimi annisulla base dell’impegno e della collaborazione tra il Governo e le partisociali, comprese le organizzazioni non governative coinvolte sul frontedella società civile nelle questioni relative all’immigrazione.
Per quanto riguarda la dimensione europea della questione, chiara-mente a livello nazionale il nostro approccio si è notevolmente ispiratoal quadro delineato nel Trattato di Amsterdam e successivamente. L’Ir -landa ha una prospettiva particolare sul dibattito europeo, perché condi-vide un’area comune con il Regno Unito, oltre ad una frontiera terrestrecon l’Irlanda del Nord. Abbiamo quindi una prospettiva particolare sucome dovrebbe o potrebbe essere realizzata la collaborazione interna-zionale nella gestione dei flussi migratori.
Il mio Consiglio ha quindi accolto con favore l’enfasi nelle con-clusioni provvisorie posta sul contesto più ampio entro cui affrontare iltema della migrazione. Siamo stati altrettanto soddisfatti dell’enfasi nel-le conclusioni del Consiglio di Siviglia posta sull’esigenza di sviluppareuna politica nell’ambito di un partenariato con i Paesi di origine e sul-l’attenzione alle politiche integrative finalizzate ad assicurare lo svilup-po economico, come mix ottimale di politiche. L’Irlanda, d’altra parte,costituisce un ottimo esempio di questa ottica: con il passaggio daPaese di emigrazione a Paese d’immigrazione grazie allo sviluppo eco-nomico ottenuto negli ultimi decenni con il sostegno dei nostri alleati.
Nell’ambito del contesto europeo, stiamo naturalmente lavorando inaree in cui sussistono punti di vista e interessi divergenti, basati sull’espe-rienza nazionale e sulla diversità di tradizioni. Ciononostante, le autoritàirlandesi, con la presidenza dell’Unione che inizierà il 1° gennaio, intendeproseguire ed approfondire il comune sentire che sta emergendo in alcuniaspetti della questione. Riteniamo che durante la nostra presidenza saràposto un impegno particolare per fare approvare alcune direttive in temadi emigrazione e di procedure di ammissione di lavoratori, studenti e ri-
162
cercatori. E se, nonostante il notevole impegno della presidenza italiana,non si riuscirà a concludere prima, alcune direttive in materia di asilo -procedure e requisiti - siamo certi che avranno la massima priorità nel-l’ambito del programma della presidenza irlandese.
Le autorità irlandesi sono convinte che sia fondamentale dare aicittadini dell’Unione un contesto di sicurezza. E’ quindi fondamentaleche un approccio equilibrato alle politiche migratorie non venga meno eche si affronti in maniera efficace le questioni dell’immigrazione illega-le e del traffico di persone per mantenere un senso di sicurezza e conti-nuare ad avere l’appoggio della popolazione, nell’ambito di una strate-gia esaustiva e complessiva.
Riconosciamo anche l’importanza ed i progressi crescenti nella con-divisione di informazioni tra Stati membri, quali ad esempio il servizio diinformazione sui visti. E naturalmente il contributo potenziale dello svi-luppo tecnologico, quali la maggiore sicurezza dei documenti di viaggio.La nostra posizione, come Consiglio consultivo per le autorità irlandesi, èdi riflettere sul fatto che si tratta di una materia sempre più importante peril benessere di tutte le nostre società: per il benessere di quelli le cui radi-ci sono nei loro Paesi di residenza e per il benessere di quelli che sonoimmigrati qui. Riteniamo fondamentale che le nostre politiche e le nostrepratiche in questo campo riflettano il meglio della nostra tradizione euro-pea, nell’equo trattamento di tutte le persone, in modi che rispettino la lo-ro dignità e specialmente in modi che rispecchino gli standard insiti negliobblighi internazionali, quali la Convenzione di Ginevra.
Infine, riteniamo che, nel perseguire una tale strategia e rispettandouna tale tradizione, occorra mobilitare il sostegno attivo della società civi-le - non si tratta infatti di una questione che riguarda solamente le autoritàpubbliche -: come nella realizzazione degli affari interni, economici e so-ciali, la mobilitazione della società civile - e soprattutto delle parti sociali- è un elemento essenziale sia a livello nazionale che nell’ambito del pro-cesso europeo. Desidero quindi ribadire che questo dibattito in corso oggiè di estremo aiuto e risulta alquanto tempestivo. Come ha già accennato ilcollega greco, esso sottolinea la giusta continuità dell’impegno e dell’e-nergia profusi dalle presidenze europee su questo argomento. Sono moltolieto di essere stato invitato a parteciparvi.
163
JURGEN HUMBURG*Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR)
Grazie al CNEL per questa occasione. Mi limiterò a due aspettidella problematica e, rispetto al primo, vorrei riprendere una riflessioneallargandola e riportandola anche nell’ambito dell’asilo che è compe-tenza dell’organismo che io rappresento.
Il Presidente Larizza ha parlato delle responsabilità europee in mate-ria di immigrazione e io vorrei riportare questo concetto alla materia del-l’asilo, aggiungendo una riflessione e dicendo che, quando parliamo di re-sponsabilità europea, non parliamo solo della responsabilità per l’Europa,per i quindici Stati attuali o per i 25 membri a partire dal maggio del pros-simo anno. Quello che sta succedendo in questo momento storico in Euro-pa, dove vengono definiti degli standard che valgono per l’Europa cometale, è anche un carattere simbolico di modello per altri Paesi. Da qui noi,come organismo, anche insieme con la gran parte della società civile, cibattiamo per mantenere o introdurre standard alti in questa materia.
Quando parliamo di standard, con una parola un po’ astratta, iovorrei ricordare che questo nostro linguaggio tecnico ha una funzione euna importanza molto concreta, molto reale, per le persone richiedentil’asilo che rischiano, quando sono respinti alle frontiere, letteralmentela vita e questo, a mio avviso, è la dimensione umana del problema percui vogliamo standard alti.
__________* Intervento non rivisto dall’autore
164
Per essere concreto voglio fare un esempio del quadro attuale, delquadro giuridico comunitario, sul controllo delle frontiere. Chiaramentequesto è un tema vasto che parte dal controllo dei criteri per il rilasciodei visti, dagli aiuti alla partecipazione di poliziotti anche di alcuni deiPaesi membri dell’Unione Europea nei Paesi di origine, nei Paesi ditransito, fino ad altre forme di cooperazione tra le polizie dell’UnioneEuropea e di Paesi terzi, le sanzioni contro i vettori che portano i pas-seggeri, l’aspetto del controllo delle frontiere dell’Unione Europea. DeAlmeida ha parlato dell’Agenzia comune che è il prossimo obiettivo,visto che il controllo vero e proprio comune delle frontiere esterne èpiuttosto un obiettivo di lunga scadenza, e poi abbiamo anche gli aspettidi riammissione, sia a livello nazionale che comunitario, i programmi dirimpatri più o meno volontari per i richiedenti asilo respinti, di cui fan-no parte anche le ultime proposte tedesche e italiane sulla facilitazionedel transito delle persone da espellere.
La tematica è troppo vasta e complessa per un intervento organicoe quindi io vorrei prendere un punto di tutta questa materia, che è quel-lo che troviamo all’interno della proposta di direttiva, ancora in discus-sione sotto la Presidenza italiana, sulle procedure di asilo dove abbiamoavuto una proposta di direttiva iniziale della Commissione con tanti a-spetti positivi, che sono anche rimasti, però, durante il processo di di-scussione abbiamo potuto assistere, da un lato, ad un annacquamentodei contenuti permettendo sempre più deroghe per gli Stati a livello na-zionale, appunto permettendo di derogare da quelli che venivano defini-ti standard minimi, in più abbiamo anche l’introduzione di alcuni ele-menti troppo restrittivi.
Un piccolo inciso, peraltro, riflette anche un po’ quello che già èstato varie volte menzionato durante gli interventi, circa questo percor-so da Tampere, passando per Laeken, a Siviglia dove abbiamo assistitopurtroppo ad una tendenza e ad un’idea della politica nella materia del-l’immigrazione e dell’asilo abbastanza aperta e liberale ad una politicache sempre di più punta sul controllo e, in termini pratici, sul respingi-mento piuttosto che sull’accoglienza.
Aggiungo anche che, spero di sbagliarmi, ma non condivido l’otti-mismo della Vice Presidente Santoro e anche dell’ex Ministro Turco se-
165
condo i quali il vertice di Salonicco rappresenti un’inversione di ten-denza. Io sarei purtroppo più cauto.
Quindi, nella direttiva abbiamo appunto questi elementi restrittivie vorrei menzionare lo spinoso problema dell’effetto sospensivo nelcontesto di ricorsi contro decisione negativa, sia di ammissibilità, sia, incerti casi, in quelli cosiddetti manifestamente infondati, nel contestodella eleggibilità. Dare la possibilità di derogare a questo principio del-l’effetto sospensivo, che peraltro purtroppo è uno dei contenuti dell’ul-tima modifica introdotta con la cosiddetta legge Bossi-Fini in Italia a li-vello nazionale, quindi anche nella direttiva europea adesso troviamoun’ampia casistica di casi richiedenti asilo che possono essere respintisenza che il loro ricorso abbia un effetto sospensivo. Questo, a nostroavviso, è una tendenza veramente pericolosa e tutte queste deroghe, chegiustamente nelle altre parti della direttiva vengono definiti standard mi-nimi, queste deroghe secondo noi non ci dovrebbero essere. In più c’èanche una cosiddetta standstill clause,che permette appunto ai governinazionali di mantenere le loro politiche in questo contesto, se già è in vi-gore prima dell’entrata in vigore della direttiva stessa, di mantenere que-ste politiche e anche questo permetterebbe all’Italia di mantenere quelche è stato introdotto appunto dalla legge Bossi-Fini, ovvero respingereil richiedente asilo senza appello, proprio nel senso giuridico della paro-la e anche nel senso un po’ figurato.
Da qui l’appello di rivedere queste restrizioni e penso che, vistoche abbiamo parlato della responsabilità europea, vorrei proprio anchefare un appello al Governo italiano che ha una particolare responsabili-tà in questo momento storico avendo la Presidenza, quindi un’influenzanon indifferente nella gestione di quel che è ancora in discussione sottola Presidenza italiana.
166
CHRISTOPHERHEIN
Direttore del Consiglio italiano per i rifugiati
1. Le organizzazioni non-governative in Europa hanno da sempre ri-chiesto una comunitarizzazione delle politiche in materia di immi-grazione e di asilo, considerando che si tratta di un movimento dipersone su scala trasnazionale che richiede delle risposte uniformidell’Europa. Peraltro c’è stata la speranza di una politica più lungi-mirante, più strategica, più umanitaria al livello comunitario, menolegata alle vicende nazionali e a considerazioni partitiche.
2. Questo è stato un lungo processo. E’ cominciato con l’inserimentonel Trattato di Roma dell’articolo 8 (a) sulla libertà di circolazione.E’ opportuno ricordare che fino ad oggi, ovvero fino al Trattato diAmsterdam, è precisamente la volontà di garantire ai cittadini la li-bertà di circolazione in tutto il territorio comunitario, il punto di par-tenza per lo sviluppo di una politica comune sull’immigrazione esull’asilo. Gli accordi di Schengen del 1985 e del 1990 sono espres-sione di questa volontà e marcano già la linea seguita in avanti: daun lato, l’abolizione dei controlli alle frontiere interne, e il diritto diresidenza per i cittadini degli Stati membri in tutto il territorio del-l’Unione; dall’altro lato, la progressiva chiusura delle frontiere ester-ne ovvero l’edificazione della cosiddetta fortezza Europa. Con ilTrattato di Maastricht, dal 1993, si introduce lo strumento della coo-perazione intergovernativa nel Terzo Pilastro, lasciando intoccata lapiena competenza nazionale a legiferare su queste materie. Durante
167
gli anni novanta, in particolare durante il conflitto nell’ex-Jugoslaviae l’esodo dei rifugiati dai Balcani si è evidenziato l’inadeguatezza ditale strumento per dare risposte comuni. E’ quindi maturata la con-vinzione di dover inserire l’immigrazione e l’asilo nel Primo Pila-stro, ovvero nel sistema di strumenti della legislazione comunitaria.Il Trattato di Amsterdam riflette questa convinzione, anche se unapiena comunitarizzazione ancora non è prevista: vige il regime del-l’unanimità delle decisioni del Consiglio e del ruolo puramente con-sultivo del Parlamento Europeo. L’attuale impasse per quanto riguar-da la Direttiva sulla definizione del rifugiato e sulla protezione sussi-diaria dimostra l’insufficienza di tale regime: un solo Paese, in que-sta caso la Germania, blocca il processo decisionale, e non si va a-vanti nella formulazione di una politica comune proprio sulla mate-ria elementare : quella di stabilire i criteri per la concessione dell’asi-lo, incluso quello che in Italia chiamiamo asilo umanitario.
3. Tuttavia, le limitazioni nell’attuale processo di armonizzazione dellepolitiche e delle normative non sono dovute solo a questioni proce-durali. La speranza espressa dal Consiglio Europeo straordinario diTampere, 4 anni fa, di arrivare entro i 5 anni prescritti dal Trattato diAmsterdam, ovvero entro aprile 2004, ad un Sistema Europeo Co-mune sull’Asilo nonché ad una gestione più efficace dei movimentimigratori, a livello comunitario, è oggi messa in discussione. Il pro-cesso negoziale sulle varie direttive e regolamenti dimostra, in parti-colare durante gli ultimi 2 anni, una chiara tendenza di ritorno ad e-goismi nazionali e di mancata volontà politica a trasferire competen-ze nazionali a quelli comunitarie. La lettura della Direttiva sulle con-dizioni minime per l’accoglienza di richiedenti asilo, adottata nelgennaio di quest’anno, illustra questa tendenza: prevalgono le dero-ghe, gli spazi dati ai singoli Stati a concedere condizioni ancora piùminime. Lo stesso si deve dire per la Direttiva sul ricongiungimentofamiliare di recentissima approvazione. Il negoziato, in questo Se-mestre condotto dalla Presidenza italiana, sulla Direttiva relativa alleprocedure di asilo è arrivato ad un punto che la comunità delle ONGeuropee ha deciso pochi giorni fa di chiedere alla Commissione Eu-ropea il ritiro della sua proposta: meglio, per il momento, non averenessuna normativa comunitaria sulle procedure d’asilo, piuttosto che
168
una che non rispetti i principi fondamentali di protezione. Si è con-cretizzato il timore che qualcuno aveva già espresso: l’armonizzazio-ne al ribasso è attualmente all’ordine del giorno del Consiglio. E di-ventato palese la contraddizione tra le proposte formulate dalla Com-missione, nello spirito e nella lettera delle Conclusioni di Tampereda un lato, e l’orientamento del Consiglio, o almeno di una parte im-portante dei Governi, dall’altro lato.
4. Ma non si deve dimenticare che l’armonizzazione delle politiche sul-l’asilo e sull’immigrazione è anche dettata dalla logica di funzionali-tà, ed è quindi nell’interesse oggettivo dei Governi. Trattati multila-terali, come quello di Schengen o quello di Dublino sulla determina-zione dello Stato responsabile per l’esame di una richiesta d’asilo, sisono dimostrati insufficienti, come strumento di governo adeguatoed efficace del fenomeno su scala europea. Lo stesso valeva poi perlo strumento della cooperazione intergovernativa. Lo stesso vale og-gi per una normativa comunitaria che in sostanza vincola ben poco isingoli Stati, e crea delle norme al di sotto di ogni standard accetta-bile e quindi fomenta le vie illegali di ingresso, di soggiorno, di la-voro, di ricongiungersi con i familiari. Ci troviamo nel mezzo di unprocesso che in questo periodo subisce una battuta d’arresto, provo-cata anche dall’11 Settembre e dalla prevalenza delle considerazionidi sicurezza, erroneamente concepite in contrapposizione alla prote-zione, e alla garanzia dei diritti fondamentali. Sono molto fiduciosoche si supererà questa fase, e penso che proprio la Presidenza italia-na, nonché l’adozione della nuova Costituzione Europea possanomarcare l’inizio di un nuovo periodo nel processo verso una vera po-litica europea in grado di governare la sicurezza delle frontiere ester-ne e, allo stesso tempo, i movimenti migratori e quindi garantire i di-ritti degli immigrati, rifugiati e richiedenti asilo.
169
VITTORIO NOZZA
Direttore della Caritas italiana
Vorrei ricordare subito - anche a correzione dell’opinione che attri-buisce alle comunità cristiane una propensione all’immigrazione indi-scriminata, magari con il retropensiero di favorire la corrosione dei sanicostumi indigeni e di compromettere i relativi valori religiosi - che laCaritas Italiana, secondo una direttiva che riceve dalla Chiesa di cui è e-spressione, non è affatto contraria a politiche dell’immigrazione che in-cludano forme efficaci di controllo alle frontiere sia a scala nazionaleche a scala comunitaria. Di tale nostro atteggiamento c’è ampia traccianelle discussioni che hanno preceduto, accompagnato e seguito sia lalegge Turco-Napolitano sia la legge Bossi-Fini. Gli apprezzamenti e lecritiche differenziati manifestati al riguardo non hanno mai messo inforse l’esigenza di dare, per quanto possibile, ordine e prevedibilitàaiflussi migratori, avendo l’unica preoccupazione di salvaguardare, all’in-terno delle norme adottate, le ragioni di rispetto della istanza di umanitàche sempre va tenuta in primo piano quando le leggi riguardano le per-sone e le famiglie.
La premessa spiega perché non ho avuto difficoltà ad accettare dipartecipare, come Direttore di Caritas Italiana, ad una sessione di que-sta Conferenza espressamente dedicata al tema del “controllo dellefrontiere esterne” dell’Europa. Ed anticipa pure il criterio che seguirònel formulare alcuni rilievi sui lavori in corso e sulle tendenze culturalie politiche che le ispirano. D’altra parte, in questa Conferenza non sitratta soltanto di misure d’ordine pubblico, essendo previste sessioni su
170
integrazione e aiuti allo sviluppo (che non sono riducibili, mi si lasci di-re, ai soli accordi bilaterali di contenimento dell’emigrazione). Ed è ap-punto in questo scenario più vasto che intendo inserire il mio interven-to.
Intanto un’osservazione sul titolo che parla di frontiere al plurale,mentre, almeno per i “Paesi Schengen”, dovrebbe parlarsi di frontieraunica, da gestire unitariamente. E’ un limite di partenza che va scontatonel momento in cui, correttamente, si lavora:
sia al controllo congiunto dei confini da parte degli Stati membri,
sia agli accordi ed agli incentivi per i Paesi d’origine e di transito,
sia ad una gestione coordinata dei flussi, peraltro problematica inassenza di un perno operativo riconosciuto ed accettato.
Osservazioni di fondo non possono avanzarsi sul Progetto Nettunocon il coinvolgimento e la divisione del lavoro tra i Paesi interessati, invista della creazione di un corpo di polizia di frontiera europea. Il con-trasto dell’immigrazione clandestina e l’attacco alle sue radici è un ob-biettivo che non può essere disatteso. Un interrogativo si pone invecesui modi di traduzione pratica delle intenzioni enunciate e sui rischi chederivano dalla mancanza di una considerazione differenziata delle spe-cie in cui si manifesta il fenomeno della clandestinità:
altro è infatti il ruolo di chi organizza ed effettua il traffico, cheproduce lucri rilevanti da una speculazione sul bisogno delle persone,
altra è la condizione di coloro che espatriano in cerca di migliorfortuna, sopportando sacrifici e rischi talvolta mortali,
altra è infine la condizione di quanti fuggono dal loro Paese persottrarsi a minacce gravi per la loro stessa esistenza o per la privazionedi fondamentali libertà; e che perciò domandano ad un altro Paese, cheritengono libero, la tutela dell’asilo o della protezione umanitaria.
Quale è la preoccupazione?
Quando si ascoltano annunci che promettono accelerazioni di rim-patrio entro 36 ore dall’intercettazione, il dubbio di trovarsi di fronte aprocedure sommarie e quindi poco attente alle istanze delle persone ènon solo legittimo ma doveroso. Al quale poi si aggiunge un dettaglio
171
tecnicocon imponderabili risvolti umani. Mi riferisco al fatto che la vi-sione oggettivamente restrittiva che si va affermando in tutta l’Europain materia migratoria - riflesso di una condizione che interpreta l’istan-za di sicurezza in modo unilaterale se non egoistico - spinge ad omolo-gare sotto il denominatore della clandestinitàfigure che vanno invecetenute separate e valutate separatamente. Vorrei dire con molta schiet-tezza che il più delle volte, per ragioni di necessità, il richiedente asilosi presenta alla frontiera come un clandestino tra gli altri. Il suo destino- se essere accolto o rinviato nel luogo da cui fugge - dipende dalla se-rietà e dalla severità del discernimento con cui viene esaminato il suocaso e viene considerato il suo diritto - poiché di questo si tratta.
E’ questa una critica già fatta per la Bossi-Fini: la sommarietà del-le procedure previste per il riconoscimento dello status di rifugiato e,prima ancora, della condizione di richiedente asilo, con le garanzie ed itempi necessari, lascia varchi a pericolose derive con conseguenze irre-parabili per le vittime di tale ingranaggio. L’esigenza è che anche iPaesi di transito abbiano non solo mezzi di controllo delle rispettivefrontiere ma anche strumenti di accoglienza e di protezione dei rifugia-ti. Nei mesi scorsi è circolata la proposta inglese di parcheggiare i ri-chiedenti asilo fuori dall’Unione Europea; ed è positivo il fatto che laCommissione di Bruxelles abbia osservato che una simile misura avreb-be violato la Convenzione di Ginevra e la Convenzione Europea sui di-ritti dell’uomo. Ma in alternativa si è suggerito - e le perplessità non siattenuano per il fatto che c’è il patrocinio dell’Agenzia dell’Onu - distivare i richiedenti asiloin campi d’accoglienza dentro il perimetrodell’Unione, per il tempo necessario - solo un mese? - all’esame delladomanda ed al responso finale: ingresso o espulsione. L’auspicio di unanormativa europea uniforme per il sistema-d’asilonon perde d’attuali-tà. Ma a condizione di non imboccare scorciatoie e semplificazioni vol-te piuttosto a ridurre l’incidenza del fenomeno che a fornire alternativerealistiche ai richiedenti anche nei Paesi di transito e durante le fasi diaccertamento.
Come ha sempre fatto in passato, Caritas Italiana continuerà amettere al servizio della comunità italiana il frutto dell’esperienza cherealizza sul campo sia per l’ascolto-accoglienza, sia per l’accompagna-mento, sia per l’integrazione, sia per l’umanizzazione del contesto cul-
172
turale e sociale in cui l’immigrazione s’innesta. Anche quando non hacondiviso i tratti limitativi delle norme, come nel caso della Bossi-Fini,la Caritas non ha mancato di cooperare all’applicazione più intelligentee socialmente utile di esse, come è avvenuto nel caso della travagliataed ancora non conclusa vicenda delle regolarizzazioni che ha compen-sato gli eccessi di rigidità dello schema di legge. Così continuerà a farein presenza di nuove iniziative che qualche parte sollecita o di impulsiulteriormente restrittivi nella gestione di esse.
Sia consentita, in proposito, una considerazione di buon senso. Sei risultati attesi o sperati non arrivano non serve prendersela con il de-stino, o con... l’illuminismo della Chiesa. Occorre anche domandarsi seper caso non si sia commesso qualche errore di impostazione o di cal-colo. Nel campo delle migrazioni si va sempre fuori misura quando sipretende di disciplinare con atti volontaristici, più o meno motivati i-deologicamente, una realtà che si esprime come una dimensione vitaledel divenire umano. Non è, di per sé, ineluttabile, ma è condizionata datanti fattori che vanno tutti considerati, pena lo scacco, la delusione el’imprecazione al vento. La Caritas opera a valle delle decisioni che ilParlamento assume e le rispetta. Ma ha il dovere di rappresentare unpunto di vista che si accredita non solo per l’ispirazione che riflette maanche per una pratica d’esercizio di cui tutti riconoscono la validità el’efficacia. La Caritas considera le migrazioni contemporanee come undato con cui convivere:
non ha preclusioni o pregiudiziali etnico-razziali e le combatte do-vunque si manifestino;
accetta con favore tutte le misure, comprese le più sofisticate tec-nologie, per controllare e regolare il fenomeno;
condivide l’impegno per colpire le fonti del nuovo schiavismo, nonsolo con la repressione ma anche con la prevenzione, sapendo che per que-sta via si ripropone il tema - che è propriamente politico - della giustizia edello sviluppo che anche il mondo globalizzato non riesce a risolvere.
Ecco perché non riusciamo e non accettiamo di rinchiudere la que-stione della vigilanza alle frontiere per il contenimento dei flussi clan-destini nell’ambito dell’ordine pubblico. Ci sembrerebbe una compres-sione dannosa e controproducente.
173
Riteniamo che la relazione tra migrazioni e frontiere va invece ri-collocata all’interno di una visione non riduttiva dei conflitti, degli inte-ressi e dei valori che attraversano il mondo. C’è da aver timore dellaspinta che si rivela in ambiti diversi e con differenti motivazioni per unripristino ed un rafforzamento dei confini: nuovi muri, reali o virtuali,da erigere a protezione di merci, identità, condizioni di benessere. Nelmomento stesso in cui l’Europa immagina come meglio presidiare lasua/le sue frontiere dall’ingresso di soggetti non desiderati, essa deveinterrogarsisul significato storico/politico che intende dare ai limiti chepone agli altri e quindi a se stessa.
Si pensi al Mediterraneo ed al rapporto tra le due sponde, al verifi-carsi di un’ipotesi di chiusura totale ovvero di un’ipotesi di aperturacontrollata. Per quale delle due passa la ricerca:
della pace,
del dialogo tra le culture,
del riconoscimento dei popoli e della cooperazione per lo sviluppo?
Io credo che quesiti di questo genere abbiano attinenza con il temache, in queste giornate, qui si discute, anche se non è possibile affron-tarli in questa sessione. Si tratta di interdipendenze vitali che, natural-mente, possiamo escludere dal ragionamento per convenienza pratica.Ma è bene tenere a mente che spesso, e più che mai nel caso delle mi-grazioni, il non considerarle comporta distorsioni di visuale ed erroripratici non riparabili.
174
ANNAMARIE DUPRÉ
Consulente della Presidenza della Federazione delle Chiese Evangeliche
Negli ultimi anni i modelli migratori sono cambiati. Mentre permolto tempo i conflitti politici e militari hanno prodotto flussi migratoria causa di violenza e persecuzione, la globalizzazione economica ha in-fluenzato i progetti migratori individuali e, in generale, la tipologia deiflussi migratori. Una ricerca dell’OIM indica che ci sono ca. 175 milio-ni di migranti nel Mondo, di cui ca. 10,5 milioni rifugiati. La massa deimigranti si sposta oggi:
a causa delle opportunità del mercato di lavoro in altri Paesi;
per migliorare le propri condizioni di vita.
I movimenti migratori non possono essere visti solo in chiave dimovimenti di masse povere che invadano i Paesi industrializzati. La mi-grazione è in molti casi una risorsa indispensabile dell’economia dimolti Paesi. Solo una parte minore si sposta perché è costretta e cercaprotezione, e anche tra questi rifugiati una notevole parte sarà molto u-tile per i nostri Paesi per soddisfare esigenze del mercato di lavoro. Cer-tamente non possiamo ignorare che esiste anche un flusso che migra percercare la sopravvivenza, essendo minacciato da una povertà estrema.In questi casi vanno considerate le possibilità della famiglia dei popolidi accogliere per motivi di solidarietà. In ultimo non possiamo negareche certi flussi sono vicini alla criminalità internazionale, ma va anchevalutato se le attuali politiche di chiusura delle frontiere non incremen-tino questo fenomeno.
175
Così come sono cambiati i modelli di migrazione, sono anchecambiati gli schemi delle politiche migratorie, ma - in un certo sensostranamente - non in funzione del cambiamento dei flussi migratori, maa causa di meccanismi e tendenze che hanno poco a che fare con larealtà dei movimenti migratori. A Tampere le Istituzioni Europee eranoarrivate a decisioni politiche molto interessanti che rispecchiavano la si-tuazione migratoria: si prevedeva una politica migratoria comprensivache doveva rispettare gli obblighi internazionali per la protezione dei ri-fugiati, che doveva tenere conto dei diritti dei migranti e considerare leesigenze dei Paesi d’origine. Cominciava un’interessante attività dellaCommissione Europea che preparava numerose proposte per direttiveed altri strumenti legislativi in materia.
Poi, dopo lo shock dell’11 Settembre, ma già prima, si sono avver-titi segnali in questa direzione, le politiche migratorie europee sono sta-te passo per passo ridisegnate, privilegiando quasi esclusivamente a-spetti di sicurezza e ordine pubblico. Negli ultimi anni le misure di poli-zia e di difesa delle frontiere sono state promosse con grande rapidità,mentre tutti gli strumenti legislativi hanno trovato un percorso difficilee pieno di ostacoli, perdendo sempre di più tutti gli aspetti di una veragestione dei flussi migratorie e diventando meri strumenti di chiusuradelle frontiere e di controllo della popolazione dei migranti per motividi sicurezza. Si è persa di vista l’importanza dei movimenti migratoriper l’economia, lo sviluppo scientifico e culturale, ed eventualmenteper ribilanciare squilibri demografici. Anche se parlo qui per le chieseProtestanti ed Ortodosse non voglio portare in prima linea la questionedella sofferenza umana che invece di essere allentata con una efficacepolitica migratoria, collegata ad una politica di sviluppo tenendo contodell’importanza delle rimesse per i Paesi in via di sviluppo, viene ac-centuata quasi come una beffa di fronte a chi chiede aiuto. Credo che ilproblema primario è che le attuali politiche apportano gravi danni ai no-stri Paesi europei: problemi per i mercati di lavoro, incremento del la-voro nero degli immigrati che danneggia i lavoratori europei, problemigravi demografici, un aumento della criminalità internazionale che ap-profitta delle difficoltà di entrare nei nostri Paesi, incrementando feno-meni come la tratta e forme di schiavitù. E’ ben noto ad ogni politicoche misure di persecuzione di questi fenomeni non possono avere suc-
176
cesso se non sono collegate con misure che tolgono alla criminalità illoro mercato. Le chiese non sono buoniste, ma non credono nemmenoche una politica punitiva e restrittiva possa gestire correttamente un fe-nomeno mondiale di queste estensioni. Siamo convinti che solo unacorretta politica di “migration management”, come abbozzata a Tampe-re, potrà dare frutti sia per i migranti che per i Paesi di accoglienza.
Le chiese hanno elaborato precise raccomandazioni su quasi tuttele proposte di direttiva o altri strumenti legali. Attualmente propongonola bocciatura in toto per due strumenti: si tratta della Direttiva sul ricon-giungimento familiare che contraddice l’etica famigliare di tutte le co-munità di fede rappresentate in Europa. Inoltre le chiese si esprimono inmodo molto negativo in merito agli ultimi sviluppi della Direttiva sulleprocedure di asilo. Viene espressa grande preoccupazione anche sullaprassi di caricare su voli charter decine, e spesso più di 100 persone, perrimpatriarle forzatamente. Si tratta di espulsione di massa che, secondoil diritto internazionale, è illegale.
Le chiese hanno inoltre preparato un elenco di raccomandazioniche non voglio presentare interamente in questa sede, ma che allego.
Purtroppo non posso nascondere che la distanza tra le chiese e le I-stituzioni politiche a livello nazionale ed europeo sta crescendo. Questoè uno sviluppo che dispiace in particolare alle chiese protestanti chehanno un concetto di Stato che prevede che ogni credente, e le chiesecome entità, siano corresponsabili con lo Stato stesso. Tuttavia esisteanche una etica che mette precisi limiti a questa responsabilità, e attual-mente le chiese si trovano davanti a questo dilemma: temiamo che i di-ritti fondamentali non siano più garantiti per tutti gli uomini e le donne.E’ significativo che in quasi tutti i Paesi dell’Unione Europea credenticattolici e/o protestanti scelgono di dare nelle chiese protezione a perso-ne espulse, i cosiddetti “sanctuaries” o “Kirchenasyl”. Questo avvienecon il sostegno delle autorità ecclesiastiche e dopo approfondite rifles-sioni sul conflitto tra etica cristiana e lealtà verso lo Stato.
177
PADRE FRANCESCODE LUCCIA SJ
Presidente dell’Associazione Centro Astalli
L’Associazione Centro Astalli è il ramo italiano del Servizio deiGesuiti per i Rifugiati, conosciuto come Jesuit Refugee Service, orga-nizzazione internazionale presente in circa 50 Paesi, che opera per l’ac-coglienza, il sostegno e la difesa dei diritti dei rifugiati. Ciò che caratte-rizza noi e tante altre organizzazioni di volontariato, è il quotidiano ser-vizio di accoglienza e di accompagnamento di richiedenti asilo, rifugia-ti ed immigrati. Questo ci permette di avere un’esperienza significativaed una conoscenza diretta ed ampia del fenomeno. E questo ci consentedi parlare e di offrire delle riflessioni che sono il frutto di riscontri diret-ti sul campo.
Il mio brevissimo intervento parte da una premessa assai semplice:l’arrivo di immigrati sul nostro territorio non può essere considerato unfenomeno transeunte. È un evento destinato a durare nel tempo.
Tutti sono d’accordo nell’affermare che i flussi migratori non siarresteranno a causa della differenza nella qualità della vita tra Paesipoveri e Paesi ricchi. La promulgazione di leggi restrittive avrà come u-nico effetto quello di far aumentare la presenza di irregolari. Il tentativodi bloccare l’arrivo di immigrati irrigidendo le norme di controllo è de-stinato invariabilmente a fallire: è la storia che ce lo insegna, bastaguardare l’esperienza di Paesi in cui l’immigrazione è più antica. Dalmio osservatorio colgo elementi che mi consentono di spingere l’affer-mazione più oltre e dire che l’immigrazione non solo non è arrestabile
178
ma non è nemmeno “controllabile”. Essa si può soltanto cercare di “in-canalare” attraverso leggi che permettano di regolare il fenomeno e noncon disposizioni che cercano di nascondere la realtà, come mi pare stiaavvenendo attualmente in Italia.
In questo periodo, sentiamo spesso parlare di immigrati e immi-grazione ma solo in relazione al diritto o meno che hanno di ottenere unpermesso di soggiorno. Non si parla mai della loro dignità e dei dirittiumani fondamentali calpestati nel loro Paese d’origine e troppo spessoanche in Italia, un Paese democratico dove dovrebbero essere una prio-rità assoluta.
Tutti coloro che fanno domanda di asilo arrivano in Italia da clan-destini perché non hanno altro modo di entrare oggi nel nostro Paese.Solo pagando qualcuno che organizzi il suo viaggio per arrivare sullecoste italiane da clandestino, il rifugiato potrà aver salva la vita. Unavolta giunto sul nostro territorio, la trafila è sempre la stessa, ossia l’ac-coglienza nei centri del sud, la richiesta di asilo, la permanenza per unoo due mesi al sud, la partenza per Roma e l’inizio del calvario dell’atte-sa del riconoscimento dello status di rifugiati, affidati più o meno a sestessi e dispersi sul territorio.
La cosiddetta legge “Bossi-Fini” è nata non per aiutare gli immi-grati ma per rendere loro la vita più difficile o per scoraggiarne l’arrivoe la permanenza nel nostro Paese. Contemporaneamente mette in gran-de difficoltà le associazioni che offrono assistenza agli immigrati masoprattutto a coloro che, in fuga da guerre e persecuzioni, cercano dimettere in salvo la propria vita. Le associazioni che operano nel settoree che dunque conoscono il fenomeno per esperienza diretta, hanno scar-sissime possibilità di essere ascoltate da chi è chiamato a governare.Eppure, per affrontare una realtà così complessa come l’immigrazioneci sarebbe bisogno dell’apporto di tutte le componenti della società (i-stituzioni, sindacati, associazioni di volontariato, associazioni di immi-grati, ecc.). L’Italia punta molto sugli accordi con i Paesi da cui partonogli immigrati e i rifugiati perché, in cambio dell’ammissione di quote diimmigrati regolari sul territorio e in cambio di assistenza in materia diattrezzatura militare e di formazione del personale, quei governi si im-pegnino ad ostacolare le partenze e i traffici. Ma cosa ne è di quelle per-
179
sone che avrebbero voluto partire e invece vengono trattenute nei Paesial di là del Mediterraneo? Chi verifica che siano rispettati i loro dirittiumani?
Ormai sappiamo bene che è principalmente il fenomeno della glo-balizzazione a provocare lo spostamento di grandi masse di persone daparti deboli ad aree forti del mondo. Le cause principali di questa “mi-grazione forzata” dal sud al nord del pianeta sono: l’incremento dellaviolenza armata, i conflitti etnici e razziali, la disoccupazione, i bassisalari, il degrado ambientale, la mancanza di democrazia, la corruzionesu larga scala, ecc. Generalmente, a spingere le persone alla decisionedi sradicare se stesse, lasciando le loro case e terre d’origine per emi-grare, vi sono più concause e non una causa sola. Per questo io credoche se l’obiettivo del governo è azzerare l’arrivo di immigrati, è desti-nato a fallire.
Vorrei, infine, fare un cenno all’Islam. Il Centro Astalli ha fatto efa quotidianamente esperienza positiva di accoglienza ai rifugiati pro-venienti da Paesi islamici. L’equiparazione che si fa fra terrorismo e I-slam è profondamente ingiusta. Il terrorismo è l’emanazione di un grup-po ristretto di musulmani mentre il resto (centinaia di milioni in tutto ilmondo) sono persone oneste che cercano il Bene. Ovviamente, il moti-vo per cui i musulmani arrivano in Italia non è la religione - non sonodei missionari - tuttavia chiedono a noi di poter continuare a professarela loro fede nei loro luoghi di culto e secondo i loro precetti. L’incontrocon gli islamici che sono passati in questi anni al centro Astalli è statoper me occasione di arricchimento e di apertura e di questo io sono lorograto.
180
SALVATORE GERACI
Presidente della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni
Nella storia dell’uomo il diritto alla salute è una acquisizione re-cente e ciò è stata tradotta nelle politiche sanitarie dei vari Stati in mododiverso.
Negli anni ‘70-’80, caratterizzati dai primi grandi flussi migratorida Paesi extracomunitari verso l’Europa, il diritto alla salute è stato pro-gressivamente esteso anche agli immigrati regolarmente presenti negliStati dell’Unione Europea. Quindi, negli ultimi decenni questo diritto,nelle moderne legislazioni degli Stati dell’Unione, si è affermato sem-pre più, non solo come diritto del cittadino, ma come diritto di ogniindividuo.
Nonostante i progressi della medicina e una diffusa democratizza-zione delle politiche, dalla metà degli anni ottanta la differenza nellostato di salute tra i gruppi di popolazione all’interno di ogni Paese (ledisuguaglianze in salute), calcolate per classi sociali, reddito e livellod’istruzione, è in una fase dilatativa e questa tendenza non accenna amodificarsi. Ciò perché non sempre il diritto alla salute si è integratocon altri diritti, con riferimento a quelli sociali (lavoro e reddito, salu-brità degli ambienti di vita, adeguata alimentazione...) ed in particolarecon il diritto all’assistenza sanitaria: di fatto non c’è eguaglianza tra di-ritto alla salute e diritto all’assistenza che è condizionato da situazionieconomico-sociali e scelte politiche contingenti, capacità di organizza-zione dei cittadini per dare voce a tale diritto.
181
Tutto ciò assume drammatica evidenza parlando di immigrati: an-cora in parte discriminati socialmente e politicamente, più a rischio perle condizioni di vita, nella migliore delle ipotesi tollerati e comunque e-sclusi da forme partecipative. Se a ciò aggiungiamo per alcuni di loro,per altro quelli maggiormente a rischio per mancanza di ogni forma ditutela, anche la condizione di irregolarità giuridica, è facile comprende-re la precarietà della loro condizione di salute e della loro ‘protezione’.
I vari Paesi europei hanno esteso agli stranieri in modo diversifica-to la possibilità di utilizzare i servizi sanitari: tra i vari “modelli” quelloItaliano ci pare il più attento e lungimirante: attualmente coloro che so-no presenti regolarmente in Italia con un permesso di media e lunga du-rata, devono (è un diritto/dovere) essere iscritti al Servizio SanitarioNazionale ed anche coloro che sono presenti temporaneamente, sebbe-ne in condizione di irregolarità giuridica, hanno garantite le prestazioniurgenti, essenziali, continuative e preventive in una logica di tutela delsingolo che diventa tutela della collettività. Per i minori e le donne stra-niere si è costruito un sistema che permette di intercettare con certezzail bisogno sanitario, spesso intrecciato con quello sociale, e che forniscegli strumenti, almeno normativi, per rispondere concretamente.
Tuttavia affinché il diritto formale (possibilità di accesso) garanti-to dalla legge si trasformi in diritto reale (fruibilità delle prestazioni) èindispensabile un’efficace politica sanitaria sia a livello locale (è a li-vello regionale, considerato anche l’avanzato federelismo proprio in sa-nità, che bisogna guardare perché delle buone norme nazionali diventi-no prassi e il diritto dalla carta si realizzi nella quotidianità), sia a livel-lo sovranazionale per avere una certezza e coerenza del diritto pur nelladifferenza dei sistemi organizzativi adottati.
Vogliamo approfondire il tema della tutela della salute dell’immi-grato in condizione di irregolarità giuridica, come indicatore di equitànel sistema e lungimiranza in termini di sanità pubblica. Nel corso degliultimi dieci anni alcuni Stati hanno provveduto a legiferare su questotema e indipendentemente dall’orientamento politico dei propri ammi-nistratori, in tali Paesi ci si è resi conto della necessità di porre rimedioad una situazione di grave lesione di diritti dell’individuo e si è pertantocercato di adottare disposizioni che prevedessero l’accesso alle cure, se
182
pur in modo variabile ed eterogeneo, anche per gli stranieri irregolar-mente soggiornanti.
In altri Stati si è scelto di operare attraverso limitazioni o sospen-sioni delle decisioni di allontanamento al fine di consentire ai soggettiinteressati la permanenza sul territorio dello Stato e il conseguente ac-cesso alle strutture sanitarie.
Paesi quali Italia, Francia, Belgio, Germania, Regno Unito e Spa-gna hanno già da tempo avviato procedure al fine di garantire ai cittadi-ni dei Paesi Terzi temporaneamente non in regola con le norme relativeall’ingresso e al soggiorno sul proprio territorio, varie forme di accessoalle cure mediche essenziali.
Ma ciò tutela solo in parte la salute degli individui presenti sul ter-ritorio dell’Unione e non garantisce un livello uniforme di protezione.A risentire di tale vuoto normativo, non sono solo i destinatari della di-sciplina proposta - i cosiddetti cittadini dei Paesi Terzi temporaneamen-te non in regola con le norme relative al soggiorno - ma tutta la popola-zione residente.
Il Trattato di Amsterdam, in vigore dal 1 maggio 1999, ha stabili-to, per la prima volta, la competenza della Comunità in materia di asiloe immigrazione. Successivamente nell’ottobre 1999 il Consiglio Euro-peo di Tampere ha riconosciuto che “gli aspetti separati, ma stretta-mente connessi, dell’asilo e della migrazione richiedono la definizionedi una politica comune dell’UE”e ha definito gli elementi che essa do-vrebbe comprendere, cioè il partenariato con i Paesi di origine, un regi-me europeo comune in materia di asilo, l’equo trattamento dei cittadinidei Paesi Terzi e la gestione dei flussi migratori.
In questo quadro ed all’interno di un procedimento di armonizzazio-ne europea, l’Area sanitaria della Caritas romana, le associazioni Naga diMilano e Oikos di Bergamo, con la consulenza di eminenti studiosi di di-ritto internazionale, hanno predisposto una proposta di Direttiva del Con-siglio dell’Unione Europea, per porre l’accento sulla questione dell’assi-stenza sanitaria per i cittadini dei Paesi Terzi temporaneamente non in re-gola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sul territorio del-l’Unione nell’ottica della realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezzae giustizia come già precisato nelle Conclusioni della Presidenza del
183
Consiglio Europeo di Tampere del 1999. In quella occasione è stato riaf-fermato il comune impegno per ancorare la libertà ai diritti dell’uomo, al-le istituzioni democratiche ed allo stato di diritto; valori necessari a ga-rantire la pace e sviluppare la prosperità all’interno dell’Unione.
“Tale libertà - proseguono le conclusioni della Presidenza- nondovrebbe, tuttavia, essere considerata appannaggio esclusivo dei citta-dini dell’Unione. La sua stessa esistenza serve da richiamo per moltialtri che nel mondo non possono godere della libertà che i cittadini del-l’Unione danno per scontata. Sarebbe contrario alle tradizioni europeenegare tale libertà a coloro che sono stati legittimamente indotti dallecircostanze a cercare accesso nel nostro territorio”. La proposta di Di-rettiva relativa all’estensione dell’assistenza sanitaria per tutti gli stra-nieri, temporaneamente non in regola con le norme relative all’ingressoed al soggiorno, comunque presenti sul territorio dell’Unione Europea,ritiene fondamentale un approccio volto a creare un equilibrio tra obbli-ghi umanitari, immigrazione legale e lotta contro le organizzazioni cri-minali dedite alla tratta di esseri umani. Si ritiene che le sole misure disanzione, repressione e controllo delle frontiere e dei movimenti illegalidelle persone non costituiscano una risposta del tutto adeguata. A tal fi-ne è necessario insistere sull’importanza di introdurre misure volte agarantire uno standard minimo di assistenza, dignità e sicurezza allestesse persone che vivono in condizioni di illegalità.
La proposta di direttiva si prefigge di:
- prevedere misure essenziali ai fini di garantire l’assistenza sanitaria aicittadini dei Paesi Terzi soggiornanti nel territorio dell’Unione;
- elaborare definizioni comuni e criteri comuni per le nozioni di “curemediche urgenti”, “cure mediche essenziali”, “cure mediche continua-tive”, “medicina preventiva”, “patologia grave”, affinché gli Statimembri che le applicano pervengano ad un approccio comune;
- introdurre, nelle procedure negli Stati membri, un livello minimo edomogeneo di assistenza sanitaria al fine di assicurare il diritto alla sa-lute nella Comunità Europea per tutti gli individui;
- rendere concreta la possibilità di accesso alle prestazioni sanitarie, ga-rantendo che tale accesso non sia impedito dallo stato di indigenza, né
184
dalla situazione di irregolarità e pertanto non sia soggetto ad alcun ti-po di segnalazione alle autorità di polizia.
Riteniamo che tale approccio risponda ad un mandato etico che o-gni stato moderno deve condividere nell’equità, nell’impegno contro lediscriminazioni (tutti uguali di fronte a dei diritti irrinunciabili comequello alla vita ed alla salute), nella lotta contro condizioni di patologiae malattia; nel contempo viene salvaguardata una impostazione di sani-tà pubblica che ben conosce come ogni esclusione produce malattia edisagio socio-sanitario per l’intera popolazione; infine, ed i primi daticominciamo ad averli proprio in Italia, la garanzia di percorsi assisten-ziali visibili, certi ed efficaci, produce una economicità del sistema evi-tando dispersioni e interventi ripetuti a livelli inadeguati (l’urgenza co-sta di più della medicina di base).
E’ necessario ed urgente avviare un percorso di promozione dellasalute che, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,non si esaurisca nella cura delle malattie ma promuova un benessere fi-sico, psicologico e sociale a tutela individuale e dell’intera collettività.Politiche di accoglienza, politiche sociali e sanitarie devono integrarsied interagire perché la fragilità sociale è il fattore di rischio maggioreper la salute della popolazione immigrata e il progressivo inserimentoed inclusione nel tessuto sociale, economico e culturale è la miglioreforma di prevenzione e benessere per l’intera popolazione.
185
MARIA PAOLA COLOMBO SVEVO
Responsabile dell’European Network Against Trafficking in Women(ENATW)
L’intervento vuole delineare, all’interno del quadro giuridico co-munitario, il complesso rapporto tra il traffico di esseri umani e le poli-tiche di immigrazione e chiedere che durante il semestre italiano si pon-ga all’attenzione del legislatore europeo l’esperienza italiana di aiuto al-le vittime del traffico prevista dall’art. 18 del Testo Unico sull’immigra-zione.
1. La tratta e l’immigrazione, in particolare il favoreggiamentodell’immigrazione clandestina, pur presentando elementi di contiguità,sono fenomeni diversi non sovrapponibili: l’immigrazione in tutte lesue forme anche quelle clandestine è sempre segno di una speranza, so-gno di un cambiamento; la tratta è violenza, riduzione in schiavitù, èviolazione dei diritti umani.
L’accostamento vale solo ad indicare che nei grandi processi mi-gratori, in presenza di restrizioni di immigrazione legale questo feno-meno della tratta può trovare un ambiente particolarmente favorevolefatto di proposte di lavoro equivoche, di falsi permessi, di agevolazioni.
Vale a segnalare che tratta e immigrazione non sono la stessa cosa,ma che le politiche immigratorie possono avere una loro influenza sullatratta e sulle situazioni di grave sfruttamento ad essa connesse.
A livello internazionale, la distinzione tra“smuggling of migran-ts” e “trafficking in persons” è stata confermata attraverso l’elabora-
186
zione di due protocolli distinti, addizionali alla Convenzione sul Crimi-ne Transnazionale, uno sul favoreggiamento dell’immigrazione clande-stina e uno sulla tratta. Il protocollo ONU sulla tratta ha questo signifi-cato: ribadire che la tratta costituisce una grave violazione dei Diritti U-mani e quindi le vittime vanno protette e i diritti reintegrati, distinguen-dolo chiaramente dal semplice smuggling, che comporta invece la vio-lazione della disciplina nazionale che regola l’ingresso degli stranieri.
Il protocollo sulla tratta, voluto dalle Ong, fornisce uno strumentointernazionale indispensabile per la lotta ai trafficanti e per l’aiuto allevittime e dimostra che la tratta oggi ha due connotati precisi: si inseri-sce nel grande flusso migratorio (regolare e irregolare) ed è gestita dallacriminalità organizzata.
Tutti i Paesi membri dell’Unione hanno firmato questo protocollo,nel corso della Conferenza di Palermo; solo due lo hanno ratificato enoi sappiamo che la ratifica non è un atto “formale”, da essa dipende lasua entrata in vigore, cioè l’applicazione del protocollo stesso.
La Convenzione ONU sul crimine transnazionale è entrata in vigo-re lo scorso 29 settembre, ma ciò non significa che entreranno in vigoreanche i tre Protocolli aggiuntivi poiché ognuno di essi necessita di stru-menti di ratifica specifici.
Da questa conferenza dovrebbe venire un appello ai vari Paesi peruna ratifica immediata di questi strumenti.
L’Unione Europea si è accorta ben presto che la tratta andava adincrociare e ad attraversare molte delle sue politiche: da quella della di-fesa dei diritti umani, a quella dell’immigrazione, della sicurezza, dellalotta contro la criminalità organizzata, dell’allargamento ai Paesi del-l’est, sino ad incidere nei rapporti con gli altri Paesi di provenienza o ditransito della tratta.
Per questo sin dai tempi in cui la competenza nel settore giustizia,sicurezza era molto limitata, con un “terzo pilastro” sostanzialmente an-cora intergovernativo, l’Unione Europea ha giocato tutte le sue possibi-lità da quella normativa (attraverso le azioni comuni) a quelle dei pro-grammi e delle azioni (Daphne e Stop), a quelle delle agenzie specializ-zate (Europol) istituendo un forum per il dialogo tra istituzioni e Ong -gruppi di esperti, politiche strutturali per fare una “politica europea”
187
contro la tratta basata su misure preventive, repressive e di aiuto allevittime e mettendo in evidenza la necessità di una forte cooperazionetra tutti i soggetti interessati.
Il risultato di queste politiche è rintracciabile sia nelle legislazionidei Paesi europei (quasi tutti hanno legiferato sul traffico definendone ilreato), sia nello scambio di buone prassi tra i vari Paesi, sia nella for-mazione di reti che sempre più mettono in collegamento i vari soggettiinteressati.
In questi ultimi anni, soprattutto dopo Tampere, siamo in presenzadi processo di comunitarizzazione sia pure a stadi della politica dell’im-migrazione con il consolidamento di uno spazio di libertà, sicurezza egiustizia. Questo processo è lento a causa di complessità tecniche, di-vergenze effettive sugli strumenti e a causa della regola dell’unanimità.Ciò nonostante la politica europea in materia di tratta ha segnato alcunetappe importanti.
Nella Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza e inseritanel prospetto di Costituzione europea la tratta è esplicitamente citatacome violazione delle dignità della persona, cioè come la violazione delfondamento di ogni diritto (articolo 5).
Nella “Decisione quadro” contro la tratta (del 19.07.2002), l’Unio-ne Europea ha fatto propria con coerenza e con chiarezza la definizionedel protocollo ONU compresa l’irrilevanza del consenso della vittima.
A chi è costretto con violenza o inganno, alla vittima in quanto vit-tima, anche se consenziente non può addossarsi l’onere della prova, chedeve invece ricadere su chi sfrutta queste debolezze.
L’Unione Europea aggiunge anche che la tratta non ha solo unaprovenienza esterna all’Unione Europea. Fenomeni di tratta possono ri-scontrarsi anche all’interno dell’Unione Europea a conferma che non èl’immigrazione che sta alla base della tratta, ma piuttosto la commercia-lizzazione a tutti i costi e i lauti guadagni connessi a questo commercioche interessa alla criminalità.
Il terzo provvedimento riguarda la proposta di direttiva per il rila-scio di un permesso di soggiorno di breve durata in favore delle vittimedella tratta che collaborano con le autorità giudiziarie. Si tratta, comegià emerge dal testo della proposta di direttiva, non di una misura uma-
188
nitaria per la tutela della vittima, ma di una misura di contrasto alle or-ganizzazioni criminali diretta ad incoraggiare le vittime a collaborarenel corso dei procedimenti giudiziari contro i trafficanti. La direttiva in-troduce la concessione di un periodo di riflessione (30 giorni), in cui lavittima deve assumere la decisione di collaborare o no, e la possibilitàdi rilasciare un permesso di soggiorno temporaneo qualora l’autorità re-sponsabile per le indagini o il procedimento giudichi utile la presenzadella vittima che ha manifestato la volontà di collaborare. Nel periododi trenta giorni previsto per la riflessione, la vittima: non può essere og-getto di un provvedimento di espulsione; beneficia di un alloggio non-ché di cure mediche e psicologiche; beneficia di assistenza legale e lin-guistica gratuita.
2. Nel panorama europeo della normativa sulla tratta che è in con-tinua evoluzione in tutti i Paesi, grazie anche all’impegno delle Ong in-teressate alla tutela delle vittime della tratta, emerge la specificità del-l’esperienza italiana di tutela della vittima della tratta prevista dall’art.18 del Testo Unico sull’immigrazione.
Questa misura è stata presentata come una buona prassi durante ilforum per la prevenzione del traffico indetto dalla DG Giustizia e AffariInterni.
L’art. 18 è una disposizione “umanitaria” inserita nella nostra leg-ge sull’immigrazione e consente allo straniero sfruttato di sfuggire allaviolenza delle organizzazioni criminali accettando di partecipare ad unprogramma di assistenza e di reintegrazione sociale e di ottenere unpermesso di soggiorno.
La condizione è che la vittima si trovi in una situazione di pericolograve o perché intende testimoniare o perché tenta di sottrarsi ai condi-zionamenti dell’associazione criminale.
La norma dunque introduce due percorsi per ottenere un permessodi soggiorno o lo status di vittima: un percorso giudiziario, se la vittimadenuncia, e un percorso sociale, nel caso in cui i servizi specializzati ri-levino una dimensione di violenza e intimidazione indipendentementedalla denuncia e dal contestuale instaurarsi di un procedimento penale.In questo ultimo caso sono i servizi stessi che presentano l’istanza uni-tamente ad una relazione sulla situazione di pericolo rilevata all’autorità
189
competente (Questura), che provvede a rilasciare il permesso di sog-giorno dopo la verifica della sussistenza dei presupposti richieste: statodi pericolo, esistenza di un programma di assistenza, consenso della vit-tima a seguire il programma, presa in carico dell’associazione.
Il percorso sociale che non prevede la denuncia immediata e ga-rantisce alcuni diritti alla vittima è stato voluto soprattutto dalle Ongche operano in questo settore nella constatazione che per molte vittimela denuncia è un punto di arrivo, quando garantite nei diritti, possonopiù liberamente lottare contro una criminalità potente e vendicativa.
L’attuazione dell’art. 18 ha dato ragione a questa ipotesi: moltipercorsi sociali si sono trasformati in denunce penali e comunque il cli-ma di sicurezza creato attorno alla vittima crea le condizioni per infor-mazioni e collaborazioni nella lotta contro il traffico.
Se quindi i percorsi sono due, l’obiettivo comune resta quello dellalotta alla criminalità e al traffico, utilizzando a questo fine anche la tute-la dei diritti della vittima.
Quando questo obiettivo è comune i rapporti di collaborazione ne-cessari tra Ong, magistrati, forze dell’ordine diventano chiari: si tutelameglio la vittima e si combatte con più efficacia la criminalità.
Così nella relazione annuale del 2002 sull’amministrazione dellagiustizia il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha ricono-sciuto che l’art. 18 e la concessione del permesso di soggiorno per pro-tezione sociale rende più facile il tentativo della vittima di sottrarsi allecondizioni dei gruppi criminali e rende possibile una collaborazione al-le inchieste.
Questo articolo ha bisogno per vivere e dare i propri frutti dellostesso clima di solidarietà e cooperazione che l’ha generato.
Deve essere raccordato con la nuova legge italiana contro il traffi -co in modo che misure preventive e repressive si accordino con la tuteladella vittima, secondo quanto previsto dall’art. 18.
Non può essere contraddetto da norme o proposte che criminaliz-zando lo straniero clandestino, impediscono di riconoscere in lui unavittima del racket.
Non può essere lasciato alla sua “evoluzione naturale” ma deve es-
190
sere coltivato attraverso un coordinamento, a livello nazionale, tra i di-versi ministeri e a livello locale, tra associazioni e operatori diversi, raf-forzato da direttive e circolari che rendano più strutturata la collabora-zione dei vari soggetti e livelli (si veda la dichiarazione di Bruxelles),monitorato da relazioni annuali che verifichino l’andamento di ognipolitica.
3. Come rappresentante di una rete di associazioni femminili cheoperano nel campo della tratta (Enatw - Aretusa coordinata dall’Asso-ciazione Irene di Milano) abbiamo potuto constatare che la normativa i-taliana è oggetto di grande attenzione ed esiste un terreno favorevole dipubblica opinione a sostegno della nostra norma.
Del resto essa è:
coerente con le indicazioni del sistema di tutela delle vittime pre-vista dal protocollo;
coerente con tutte le impostazioni delle norme e delle politiche eu-ropee che, considerando il traffico come una violazione dei diritti uma-ni non può non tutelare la vittima in quanto vittima e non solo in quantotestimone.
Per questi motivi riteniamo che sarebbe un’occasione perduta se ilGoverno Italiano tra le priorità di questo semestre non ponesse all’at-tenzione del Consiglio e della Commissione una proposta di direttivanel senso dell’art. 18.
191
REMIGIO MUSARAGNO
Presidente dell’UCSEI
Come premessa, qualche dato.
Sono stati 5.394 gli studenti stranieri che si sono immatricolati perl’anno accademico 2002-2003 contro un contingente di 20.000 posti mes-si a disposizione dalle università italiane. Di questi, 3.228 provengono daPaesi non comunitari (in testa ci sono gli studenti albanesi, in coda glistudenti africani). Di fronte a questi numeri - i più bassi dei Paesi europei,e più bassi rispetto agli anni precedenti secondo un trend a decrescere chedura ormai da tempo - le università italiane s’interrogano sul perché essenon costituiscano più un polo di attrazione e su che cosa si debba fare pertornare ad esserlo e per esserlo sempre più e sempre meglio.
La ragione di questo dato sconfortante è che manca una considera-zione attenta e positiva, da parte delle autorità italiane, nei confronti de-gli studenti internazionali (o esteri, come li ha chiamati, decenni or so-no l’Ufficio Centrale Studenti Esteri in Italia).
Un primo motivo è che l’Italia, di fronte al fenomeno nuovo e tuttosommato recente di una consistente immigrazione extracomunitaria per ra-gioni di lavoro e di sopravvivenza, è ancora prevalentemente occupata inpolitiche di accoglienza e di primo inserimento. E lo fa con un certo affan-no. Coloro che emigrano in Italia per ragioni di studio - fenomeno che pureha una storia assai più vecchia (sebbene con numeri esigui) dell’emigrazio-ne per motivi di lavoro - vengono da qualche tempo considerati come unaesigua minoranza di privilegiati di cui non vale la pena di occuparsi.
Di fatto, nessuna legge è mai stata fatta per dare una identità più pre-cisa allo studente internazionale, e per valorizzarne il ruolo: di ponte tra leculture, di soggetto rilevante per i progetti di collaborazione inter-universi-
192
taria e di cooperazione allo sviluppo, di attore di interventi di educazioneallo sviluppo nelle scuole italiane e nelle nostre comunità civili, etc.
Un secondo motivo, addotto ultimamente in sede di Ministero degliEsteri a proposito della concessione delle borse di studio (le quali sono indrastico calo negli ultimi anni), è che non si giustificherebbe un impegnoitaliano in questo senso perché si è riscontrata la tendenza degli studenti anon fare ritorno nei Paesi di origine. Come se questo del ritorno fosse l’u-nico obiettivo valido di una politica a favore degli studenti internazionali.E come se il ritorno stesso non fosse reso più possibile proprio da una po-litica di valorizzazione dello studente internazionale: una politica mirata,capace di promuovere e sostenere percorsi personalizzati di rientro, in unquadro di cooperazione con il suo Paese di origine.
Ciò a cui assistiamo, dunque, quando uno studente progetta di venirea studiare in Italia, sono le tante pastoie burocratiche e le difficoltà cui sitrova di fronte: i tempi e le procedure per riconoscere i titoli di studio, lascarsezza delle borse di studio, la carenza di opportunità di accedere ad unalloggio a prezzi contenuti, l’obbligo di rinnovare il permesso di soggior-no anno per anno (con immense perdite di tempo), le peripezie per ottene-re il permesso di rientrare al proprio Paese durante l’arco degli studi (conil rischio di non riuscire più a rientrare...), e così via.
Gli ostacoli sono tali e tanti - e così evidente è l’assenza di una po-litica di incoraggiamento e di valorizzazione - che lo studente spessopreferisce optare per un altro Paese.
E’ facile constatare come tante difficoltà siano legate non solo al-l’assenza di una specifica normativa a favore degli studenti internazio-nali, ma anche soltanto alla completa mancanza di coordinamento tra itre ministeri interessati: Esteri, Istruzione-Università e Ricerca, Interni.Diventa inutile, ad esempio, un’iniziativa positiva delle Università senon è accompagnata da una coerente regolamentazione del Ministerodegli Interni e delle Questure in tema di permessi di soggiorno o daquella del Ministero degli Esteri in tema di visti.
Dovrebbe emergere la consapevolezza che offrire - con una politicacoordinata e ad hoc - serie possibilità di studio nelle Università italiane agiovani dell’Africa, dell’America Latina, del Medio e dell’Estremo Orien-te, e dell’Europa dell’Est, è un investimento straordinario per sviluppare ipercorsi di integrazione delle culture, dei saperi, e delle stesse comunitàlocali e nazionali, e per ridurre le distanze e le diffidenze.
193
MICHELE LEPRI GALLERANO*Prefetto - Vice Capo Dipartimento delle libertà civili e dll’immigrazio-ne del Ministero dell’Interno
Io sono il Vice Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’im-migrazione. È una dizione questa, creata dal dicembre del 2001, cheriecheggia molto quello che è il tema di questo convegno ed indica an-che l’obiettivo del Governo, cioè quello di garantire le libertà civili agliimmigrati, iniziando dalla libertà religiosa, ed è per questo che è stataassorbita dal Dipartimento anche la Direzione dei culti, e favorire l’in-tegrazione, quantomeno promuovendola, perché poi c’è una competen-za degli enti locali, attraverso i Consigli territoriali. Sino ad arrivare an-che alla cittadinanza, che pure è un altro aspetto che rientra nella com-petenza del Dipartimento e che indica la piena integrazione nel tessutosocio-economico italiano.
Innanzi tutto sento il dovere di ringraziare il CNEL per aver orga-nizzato questo incontro, in questo semestre di presidenza italiana e que-sto perché costituisce sicuramente un’occasione per approfondire ulte-riormente gli aspetti dell’immigrazione.
Immigrazione che è senz’altro la risultante di più aspetti, come èstato detto, perché è la risultante della circostanza dei molti che fuggo-no dalla fame, che fuggono da pericoli collettivi e personali e che sonospinti, quindi, a vendere tutto, a giocarsi tutto, per cercare una soluzionea questi problemi.__________* Intervento non rivisto dall’autore
194
Anch’io penso che senz’altro si debba partire da questo per com-prendere quelli che sono gli aspetti di una politica sull’immigrazione eanche arrivare poi al controllo delle frontiere. In quanto, in tale ambito,assume appunto un ruolo fondamentale la definizione delle politichedell’ingresso nei singoli Paesi dell’Unione Europea. Ed in particolare,con la soppressione dei controlli alle frontiere interne, prevista dall’ac-cordo di Shengen, le frontiere esterne sono divenute fattore fondamen-tale per definire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’UnioneEuropea nel suo insieme. Condivido quello che è stato detto circa lafrontiera unica, perché appunto, entrando in uno Stato, poi si entra dap-pertutto.
La libera circolazione delle persone e delle merci, lo sviluppo del-le attività economiche integrate, gli scambi culturali e sociali all’internodello spazio comune, devono essere tutelati attraverso una gestione piùefficace ed integrata delle frontiere esterne. Questo proprio per poteroffrire, a chi c’è regolarmente e legalmente, la massima integrazione, lamassima accoglienza.
E il controllo delle frontiere costituisce elemento cruciale della lot-ta all’immigrazione clandestina, alla tratta degli esseri umani, a tutti itraffici della criminalità organizzata, nonché alla lotta contro il terrori-smo. Ciò non significa che l’Europa debba diventare una fortezza, co-me si è detto, ma è necessario ergere barriere contro tutti coloro chesfruttano illecitamente le potenzialità offerte dalla globalizzazione edallo sviluppo tecnologico.
Il concetto di gestione integrata delle frontiere esterne non è e-spressamente contemplato dai Trattati, ma si è via via consolidato sinoa divenire patrimonio condiviso di tutti i Paesi membri. Esso è oggi unprincipio non controverso che ritroviamo nella bozza di CostituzioneEuropea. Questo principio ormai si sta sviluppando in una serie di ini-ziative. Risale al giugno 2002 l’approvazione da parte del ConsiglioGAI del piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membridell’Unione Europea, che prende spunto da uno studio di fattibilità ita-liana per l’istituzione di una polizia europea delle frontiere.
In attuazione di questo piano, si sta realizzando una struttura a re-te, articolata in centri specializzati per le frontiere terrestri, marittime ed
195
aeree, nonché in un centro per l’analisi del rischio, uno per la formazio-ne e uno per lo sviluppo delle tecnologie.
Occorre anche tener conto dell’allargamento dell’Unione Europea,che ci pone di fronte a nuove sfide in materia di protezione delle fron-tiere esterne. I futuri Stati membri diventeranno responsabili di confinistrategici ad Est e nel Mediterraneo. Si tratta di frontiere particolarmen-te esposte ai flussi migratori irregolari, ai traffici della criminalità orga-nizzata e, non ultimo, a pericolose infiltrazioni terroristiche. L’Unionedeve perciò sviluppare un approccio coerente in stretta cooperazionecon i nuovi Paesi membri. Per tale ragione si favorisce la partecipazio-ne di questi Paesi a tutti i progetti nel settore.
Però, nessuna politica di sicurezza dell’Unione è possibile senza lacollaborazione dei Paesi Terzi. Ciò è vero sia per i fenomeni di terrori-smo e di criminalità organizzata, che non conoscono confini, sia, in mi-sura ancor più evidente, per l’immigrazione.
La presidenza italiana ha fatto, della collaborazione con i Paesi diorigine e transito dei flussi migratori, la chiave di volta per una politicaeuropea dell’immigrazione. Essa si sostanzia in tre assi che sono colle-gati alle premesse di cui vi dicevo: aiuto allo sviluppo, regolazione deiflussi legali, lotta alle organizzazioni criminali che sfruttano l’immigra-zione clandestina.
L’immigrazione è innanzi tutto un problema umano ed economicoed è quindi necessario mettere in atto politiche di investimento e svilup-po per rinforzare le basi di stabilità sociale ed economica dei Paesi po-veri. In questo quadro l’Europa ha uno speciale dovere in particolarenei confronti dell’Africa. Ciò sia per la collocazione geografica del con-tinente africano, gigante che è appena alle porte d’Europa, sia per lastoria degli ultimi duecento anni. L’immigrazione, infatti, trae originidalle condizioni di estremo bisogno dei Paesi di provenienza, nonchédalla condizione di insicurezza che viene avvertita sulla pelle da partedi chi poi è costretto a fuggire.
E per contenere tali spinte occorre rafforzare la politica di cooperazio-ne nell’accezione di un organico sviluppo locale. Per interventi articolati estrutturali occorrono interventi dell’Unione Europea, diversamente avremointerventi isolati e marginali, destinati ad avere una limitata efficacia.
196
Uno degli strumenti, che in questo quadro può determinare positi-vi effetti, è sicuramente quello della regolazione dei flussi legali, mache è uno degli elementi, sicuramente che va accompagnato da quellodello sviluppo degli Stati in loco, proprio per consentire dignità e svi-luppo che vanno garantiti ad ogni uomo.
La regolazione dei flussi legali è certamente lo strumento più effica-ce di contrasto all’immigrazione clandestina. Per questo l’Italia ha lancia-to la proposta per un sistema di quote legali d’ingresso a livello europeo,su cui ora la Commissione Europea effettuerà uno studio che dovrebbeconcludersi per la primavera del 2004. Queste quote potranno essere uti-lizzate nell’ambito dei negoziati per accordi di riammissione e per stimo-lare la collaborazione dei Paesi di origine e di transito dei clandestini nelcontrollo delle proprie frontiere e nella lotta ai trafficanti di esseri umani.
L’Italia ha positivamente sperimentato il sistema delle quote di in-gresso, quote privilegiate si può dire, proprio per evitare che poi ci sia-no ingressi clandestini, nel senso di dare queste quote a chi accetta dicollaborare con il nostro Paese. Certamente questo discorso è collegatoanche agli accordi di riammissione, ad una attività di collaborazione,ma noi abbiamo l’esempio di molti Paesi dove abbiamo visto che hafunzionato molto bene con una cooperazione che è andata anche con loscrivere le regole, perché poi un primo fattore di instabilità degli Stati ènon avere regole e questo ingenera la precarietà che si vive in alcuniStati e costituisce l’elemento di insicurezza notevole.
È questo il motivo per cui sicuramente è da sviluppare quanto si èdetto sui corsi di formazione all’estero, anche per creare quel collega-mento, il motivo per cui la nuova legge ha voluto il collegamento alcontratto di lavoro. È stata fatta una sanatoria, ci sono sicuramente an-cora fasce di clandestinità, purtroppo, ma che ha consentito a 700.000persone di uscire dalla clandestinità e quindi da situazioni che si presta-vano per certe persone e certi datori di lavoro che sfruttano e fanno la-vorare in nero. È stata un’operazione non indifferente. Non so se ricor-date la precedente regolarizzazione con le file e quant’altro, questa vol-ta non ce ne sono state e abbiamo utilizzato gli sportelli delle poste, co-sì in un anno pensiamo di riuscire a chiudere questa regolarizzazione.Già oggi direi che quasi al 90% è chiusa e per fine anno forse resteran-no due città, ma in buona parte sarà chiusa.
197
L’auspicio che faccio è quello che le due direttive in discussionesull’asilo possano essere chiuse quanto prima con standard accettabili.Purtroppo la situazione è quella per cui - la conoscete - è sufficienteun’opposizione e non passa. Si sta lavorando enormemente perché siarrivi ad una conclusione soddisfacente sotto tutti gli aspetti, anche perfare accettare a tutti le conseguenze che possono anche lavorare coloroche non si trovano in situazioni per cui non si riesce ad ottenere la qua-lifica di rifugiato ma magari quella che noi chiamiamo protezione uma-nitaria. Esami affrettati? Penso di no. Io ho sotto gli occhi i risultati del-l’ultima settimana di lavoro della Commissione a Foggia, proprio per irecenti sbarchi. E ho visto che la Commissione ha fatto pochissimi rico-noscimenti, ma riconoscimenti con protezione umanitaria per i dueterzi.
Non so fino a che punto facciamo bene quando mischiamo le cartee andiamo a confondere l’immigrazione clandestina con situazioni in-vece che vanno risolte. Allora, penso che tutto questo si stia facendo.Naturalmente tutto è perfettibile, tutto è migliorabile e vanno miglioratesicuramente molte cose. Ma direi che si sta camminando in questosenso.
Si è parlato delle procedure. È stato detto delle procedure per la ri-chiesta di asilo all’estero e noi a breve faremo questo seminario per stu-diare la fattibilità del poter accogliere le domande dall’estero in ambitoeuropeo.
Stiamo dando un enorme contributo anche alla direttiva sulla trattache è un argomento sul quale l’Italia è all’avanguardia e sul quale ha ot-tenuto grandi risultati. Attualmente credo si riscontri una sensibilità nel-l’ambito dell’Unione Europea e anche di altri Stati.
È con l’augurio che queste e altre direttive possano andare in portoquanto prima e chiaramente poi si è parlato pure della legge organicasull’asilo, ma che si ha intenzione di realizzare subito dopo l’approva-zione delle direttive proprio perché stia nell’ambito delle decisioni pre-se a livello europeo.
198
ANGELO GENNARI
Presidente della Commissione Internazionale del CNEL
Siccome non dobbiamo prevaricare sulla sessione che segue la no-stra, a me spetta un difficile compito di prestidigitazione per il qualenon posso che fare appello alla nostra, comune e personale, autodisci-plina e responsabilità.
Dobbiamo far entrare, nell’arco di meno di due ore ormai, gli in-terventi programmati, ma non credo proprio rituali, di otto autorevoliinterlocutori.
Ognuno di questi contributi dovrà, perciò, contenersi sotto i 10’.Era previsto che fosse il Sottosegretario agli Esteri ad aprire illustrandoi contenuti degli accordi bilaterali dell’Italia. Non è potuto, purtroppo,venire e dovremo perciò farli emergere nel corso della discussione.
In essa, daremo la parola a diversi colleghi del Sud del Mediterra-neo vicino all’Italia e di due Paesi dell’Est europeo la cui immigrazionesi rivolge in particolare all’Italia.
E, infine, come tutti sinteticamente, ci esporranno il loro punto divista alcuni osservatori particolarmente qualificati che questo tema lotrattano, lo studiano e cercano di gestirlo ogni giorno.
Se tutto funziona, restano per la mia introduzione 7-8’. Ho fiduciache tutti ci autodisciplineremo e ci daremo una mano - comunque, di-scretamente, io farò qualche segnale opportuno, al momento opportuno- per non essere obbligati, poi, verso la fine a strozzare la parola a chista intervenendo.
202
Quindi, solo qualche breve, spero non troppo superficiale conside-razione, da parte mia per inquadrare questo nostro dibattito.
Direi che più le cose cambiano, più sembrano rimanere le stesse.Non tutte, però.
Preparandomi a questa discussione, mi è tornato alla mente - e so-no, perciò, andato a ripescare - quello che Melville, l’autore di MobyDick, raccontava un secolo e mezzo fa del suo primo viaggio oltreocea-no. Come facesse sentire a chi lo leggeva, in tre righe pregnanti, la con-dizione umana “dei migranti senza amicizie, stivati come balle di coto-ne, impacchettati come schiavi su navi da trasporto di schiavi, confinatiin sentine che, in tempo di tempesta, devono essere chiuse, senza ariané luce”1.
E’ un racconto che sembra scritto per oggi. Dove è anche peggio,però, perché le carrette del mare di oggi non trasportano, con la massadei disperati, anche i passeggeri paganti come, per sua fortuna, era Mel-ville. Oddio, lo sappiamo: anche i migranti pagano, e come! ma nonvanno certo in cabina, né di prima né di decima classe... Loro, del resto,per chi li trasporta, hanno anche un valore economico minore di quellodegli schiavi, perché il passaggio lo pagano sempre in anticipo.
Solo ripensando al passato si riesce, spesso, a capire per bene ilpresente. Anche se ci scoppiano in mano mille contraddizioni nel nostrofare e nel nostro dire.
L’immigrazione è una di queste. Perché mentre la globalizzazioneridisegna sotto i nostri occhi e nelle nostre vite scenari di grandi sconfi-namenti ed il mondo apre sempre di più e più facilmente le propriefrontiere a capitali, merci e servizi, proprio la globalizzazione tende in-vece, in contraddizione lancinante coi princìpi proclamati e con la stes-sa logica economica, a regolamentare e limitare, più duramente chemai, la libertà di movimento delle persone.
Qui le cose, chiaramente, sono cambiate... e sono cambiate in peg-gio:
______1. Herman Melville, Redburn: His First Voyage, 1849.
203
- è storia, infatti, che Johann Wolfgang Goethe facesse il suo Viaggio inItalia senza alcun documento di identità, a fine ‘700;
- è storia che Stendhal, negli anni ‘20 e ‘30 dell’800, scrivesse sette-ot-to Diari di viaggio, andando su e giù sempre in Italia, senza dover esi-bire alcun documento di identità proprio a nessuno;
- è storia che Alexis de Tocqueville, nella prima metà dell’800, andassedalla Francia a scoprire l’America, come racconta lui, sans aucunpapier2, e
- ed è storia che milioni di italiani a cavallo del ‘900 - uno forse ognicinque-sei famiglie - sbarcassero ad Ellis Island, in America, senza al-cun passaporto...
Provateci oggi, in questo inizio di XXI secolo della libera circola-zione di tutto ma non certo di tutte e di tutti, a fare quel che, un secolo,due e tre secoli fa, hanno fatto mia nonna, o Goethe, Stendhal e Toc-queville... a entrare in America o, se è per questo in Italia, senza passa-porto e senza visto senza diventare automaticamente, e forse inevitabil-mente, dei fuorilegge...
Viene drasticamente ignorato, così, che a muovere oggi le migra-zioni di massa del nostro tempo sono, insieme, l’integrazione in pro-gress delle economie locali e regionali in un unico spazio-mondo e, an-che ed ancora di più, il persistere diffuso e indecente nel mondo attualedi forme estreme di povertà endemica e sistematica.
Se, dunque, l’immigrazione è, oltre che per noi anche per chi vie-ne da noi, come si dice ed è vero, una grande occasione - ne abbiamodiscusso già per una giornata - ma, nella sua dimensione non regolata eselvaggia, rischia di “contagiare” l’insieme e di diventare un problema -non foss’altro perché da noi larghe parti della popolazione come unproblema la vedono e la percepiscono e dunque la impongono, e sicco-me nella psicologia di massa oltre che in politica la percezione, alla finefa realtà, allora è necessario che anche come un problema dobbiamofarci i conti.
__________2. Charles-Alexis Clérel de Torqueville, De la démocratie en Amérique, 1840.
204
Ma, ecco il punto su cui, forse, questa sessione di lavoro ci puòaiutare. Il movimento di masse di popolazioni oltre le frontiere - in cer-ca di sicurezza, di libertà o, semplicemente, di una vita migliore - è unasfida sicura: sia per chi opera nelle istituzioni dei Paesi ospitanti, sia perle cittadine, i cittadini, dei nostri Paesi.
Provo, dunque, chiudendo, a buttar giù, a mo’ di provocazione,due domande e qualche spunto di riflessione che, se lo riterrete oppor-tuno, potrete riprendere nei vostri interventi:
- che significa questo flusso di umanità per l’Europa, ora e in futuro?
- e il dibattito sull’emigrazione e l’immigrazione, può - potrà mai - di-ventare concretamente un’esperienza di speranza? non scaccerà maidel tutto, probabilmente, ma riuscirà a rendere marginale il senso del-la paura e del rischio?
- il primo spunto di riflessione parte dalla constatazione che, per moltee svariate ragioni (due, mi sembra, quelle essenziali: il bisogno di a-vere una casa stabile, radicata, distinta dalle case degli altri ma dentroun gruppo al quale si appartiene; e il bisogno di muoversi: per curiosi-tà, per una miglior prospettiva di vita, per non subire passivamente undisastro, una catastrofe personale, familiare o di gruppo) - per molte esvariate ragioni, dicevo - il movimento delle popolazioni da una parteall’altra del mondo e la loro ricollocazione sono caratteristiche intrin-seche e proprie della specie umana;
- il secondo spunto considera che nel cercare di far fronte a questo tipodi flusso c’è molto da imparare da altri tipi di flusso: quello dell’ac-qua, ad esempio, che va regolato e governato per non subirne la forzadistruttiva. Senza mai scordare però che, al contrario dell’acqua, quinon abbiamo a che fare con una materia inorganica, ma con la carne ecol sangue, coi sentimenti e con l’anima di un’umanità che vuole con-tare - come ogni donna e ogni uomo vogliono poter contare da noi -nel forgiare il proprio destino e quello dei propri figli;
- il terzo concetto, che tutti conosciamo ma che troppo spesso ci sfuggeè che ormai tutto è cambiato:
- sono cambiati i mezzi di comunicazione e di trasporto;
205
- si sono diffuse senza precedenti la ricchezza ed un certo grado di sicu-rezza, e anche di opulenza, dei tanti che “hanno”: in modo prossimo eormai ben visibile ai tanti di più che in questo mondo proprio “nonhanno”, e non hanno neanche la prospettiva di avere;
- il fatto nuovo è che ormai grazie a quei mezzi di comunicazione - leradio a transistor costano poco e raccontano come stanno le cose tantoal pastore dell’Asia centrale come al fellah egiziano - tutti, o quasitutti, quelli che muoiono di fame nel mondo sanno che non sono staticondannati a quella fine coi loro figli perché un qualche Dio crudele ola natura maligna hanno così decretato, ma perché la società modernaè organizzata com’è, e ben si potrebbe - se si volesse - cambiarla;
- e, infine, c’è l’altro fatto nuovo al quale siamo richiamati di prepoten-za ogni tanto, per scordarcene spesso subito dopo, da tragedie e mi-sfatti come ad esempio gli attentati alle Torri gemelle: che i tanti chenon hanno - gli have-nots- sono ormai in grado di destabilizzare se-riamente, direttamente o indirettamente, il nostro mondo, quello deglihaves.
Mi fermo qui - sono obbligato a fermarmi - mettendo sul tavolo diquesta discussione tre elementi che, ne sono personalmente sicuro, do-vranno far parte del mix con cui dovremo imparare a gestire - noi e loroperò: non noi da soli - questa probloccasione(problema e occasione)costituita, insieme, da due facce della stessa medaglia come sono immi-grazione ed emigrazione.
Tre elementi decisivi: pragmatismo, coerenza (che è essa stessal’insieme di fermezza e di intelligenza) e - soprattutto - immaginazione.
206
RADU COLCEAG
Segretario Generale del Consiglio Economico e Sociale della Romania
Gli sviluppi socio-economici e le politiche degli ultimi decennihanno creato le premesse dei cambiamenti importanti registrati sul fron-te delle migrazioni. E’ stato necessario prestare un’attenzione particola-re a questo fenomeno che è messo sempre più spesso in discussione nelquadro del dialogo politico e della cooperazione internazionale.
La migrazione internazionale costituisce una delle principali sfidedel nuovo mondo in pieno processo di globalizzazione, che richiedeun’analisi approfondita e politiche appropriate. La pressione esercitatadall’emigrazione dall’Est e dal Sud, più sprovvisti di mezzi, verso l’O-vest ed il Nord, più prosperi, ha acuito il sentimento d’insicurezza negliStati membri dell’Unione Europea ed ha suscitato dei timori - talvoltagiustificati - tra le popolazioni ed i governi.
Esiste un bisogno imperioso di riconoscere la migrazione come unarisorsa per lo sviluppo. Tuttavia, l’intensificarsi dei flussi migratori hacausato un’amplificazione dei timori nella maggior parte degli Stati eu-ropei di fronte a questo fenomeno. L’Organizzazione Internazionale delLavoro conferma che l’ampiezza della migrazione mondiale non è cono-sciuta a fondo e che non esistono dati statistici affidabili per una valuta-zione corretta e politiche idonee. Le conseguenze sociali della migrazio-ne sono tanto importanti quanto la loro influenza sull’economia.
La migrazione causa molteplici problemi di collocazione e di di-slocamento della manodopera, di violazione dei diritti dei cittadini al-
207
l’estero, di ingresso irregolare degli stranieri, di transito illegale, di traf-fico illegale di esseri umani, etc. In alcune regioni dove una quota rile-vante della popolazione è emigrata, il mercato del lavoro deve fare iconti con gli squilibri derivanti dall’assenza di manodopera qualificata,il cui rinnovamento richiede risorse e tempo.
L’intensificarsi dei controlli sull’immigrazione, percepita come u-na minaccia per la sicurezza, si fonda sull’ipotesi che l’immigrazionenon controllata e di massa potrebbe compromettere la coesione socialea causa dell’aggravarsi delle difficoltà sul fronte del mercato del lavoroe della sicurezza sociale degli Stati membri dell’Unione Europea e, per-sino, mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Se il diritto a lasciareun Paese, compreso il proprio, è stato generalmente riconosciuto, lapossibilità di entrare sul territorio di un altro Paese è stata messa in di-scussione e deliberamente sottoposta a limiti. A più riprese, l’UnioneEuropea ha espresso i suoi timori sulla migrazione illegale ed ha sottoli-neato l’importanza di una politica europea comune sul diritto d’asilo.Potrebbe così essere combattuto il pericolo dello “shopping” delle do-mande di asilo: le numerose domande di asilo che una sola persona pre-senta presso le autorità di molti Paesi dell’Unione Europea nella spe-ranza di avere maggiori possibilità di ottenere il permesso di soggiorno.
Un’adeguata gestione della migrazione e dell’immigrazione puòcontribuire alla prosperità, alla crescita ed all’intesa reciproca. Il princi-pio di solidarietà riveste un ruolo importante nel raggiungimento dell’o-biettivo prioritario dell’Unione Europea che si propone di promuovereuno spazio di libertà, sicurezza e legalità.
La domanda di manodopera “immigrata” negli Stati europei deveanche essere riconosciuta e riflettersi negli accordi e nei meccanismi inmateria quali, ad esempio, il tasso d’immigrazione della manodoperaqualificata richiesta sui mercati europei, in un dato periodo.
Ad oggi, nell’Unione Europea vi sono 15 milioni di disoccupati etuttavia si registra una forte domanda di manodopera in alcuni settori,tra cui quello IT ai primi posti, e di manodopera non qualificata per i la-vori che non interessano i cittadini dell’Unione Europea. Inoltre, l’in-vecchiamento della popolazione aumenterà il bisogno di manodoperamigratoria.
208
Per risolvere il problema dell’invecchiamento della manodopera eper mantenere costante il periodo d’attività, l’Unione Europea dovrà in fu-turo accettare un gran numero di immigrati. Per assicurare la sostenibilitàdella crescita economica nel lungo termine, l’adozione di politiche appro-priate sull’immigrazione, intesa come fenomeno generale, e sulla migra-zione della manodopera rappresentano decisioni politiche non rinviabili.
Le misure di gestione dei flussi migratori di breve-medio terminedevono assicurare il corretto equilibrio tra la politica d’integrazione de-gli immigrati residenti e la lotta all’immigrazione illegale ed al trafficodi esseri umani.
La risoluzione dei problemi di migrazione nell’ambito dell’allar-gamento dell’Unione Europea si fonda su due assi portanti: (1) la rego-larizzazione delle politiche d’immigrazione e di rilascio dei visti ai cit-tadini di altri Paesi che desiderino entrare legalmente nell’Unione Euro-pea e nei Paesi candidati; (2) la cooperazione tra l’Unione Europea ed iPaesi candidati nella lotta contro il fenomeno migratorio.
A questo punto, gli accordi bilaterali assumono un ruolo importan-te per quanto riguarda il ritorno degli immigrati irregolari nei loro Paesid’origine, così come il reperimento di manodopera o la tutela e l’inte-grazione economica, sociale, culturale degli immigrati.
In quanto futura frontiera orientale dell’Unione Europea, la Roma-nia avrà un ruolo essenziale nella riduzione delle minacce transnaziona-li alla sicurezza europea. In tal senso sono stati registrati dei progressisul controllo e la sorveglianza delle frontiere, sull’adeguamento allenormative dell’Unione Europea, sulla gestione della migrazione illega-le, sulla lotta alla criminalità organizzata.
La Romania è ancora considerata un Paese di transito con chiaratendenza a trasformarsi in Stato di destinazione; ad oggi, la migrazioneè importata piuttosto che esportata.
La Romania non può essere percepita come una fonte permanentedi migrazione in massa verso l’Unione Europea. La vocazione stanzia-le, anche in assenza dei benefici che seguiranno all’ottenimento dellaqualità di membro dell’Unione Europea e che ridurranno lo stimolo atrasferirsi ad Ovest, nonché gli sviluppi di ordine demografico bastanoa giustificare questa affermazione.
209
La Romania è dell’avviso che la conclusione di nuovi accordi bila-terali, soprattutto con i Paesi identificati come le principali destinazionidella migrazione, rappresenta un utile strumento politico che precede lafase di liberalizzazione della circolazione della manodopera. Si tratta, inprimo luogo, di un tentativo di canalizzazione dei flussi esistenti e, insecondo luogo, di un supporto utile per rendere legale la posizione di u-na parte degli operai rumeni illegali/informali dei Paesi dell’UnioneEuropea.
Un’importanza particolare è rivestita dalla conclusione e dall’ag-giornamento degli accordi bilaterali di riammissione, soprattutto con gliStati membri dell’Unione Europea ed i Paesi vicini. Ad oggi, la Roma-nia ha concluso 28 accordi di riammissione delle persone irregolari suiterritori di altri Paesi: Albania, Austria, Benelux, Bulgaria, RepubblicaCeca, Croazia, Danimarca, Svizzera, Finlandia, Francia, Germania,Grecia, India, Irlanda, Italia, Lituania, Moldavia, Norvegia, Polonia,Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Gran Bre-tagna.
La Romania ha avviato, nel rispetto delle normative comunitarie,la conclusione di accordi di ammissione con i Paesi ad alto potenzialemigratorio, quali l’Afganistan, il Bangladesh, la Cina, l’Estonia, la Ma-cedonia, il Messico e lo Sri Lanka.
E’ inoltre necessaria la creazione di nuovi strumenti di lavoro,compresi protocolli di cooperazione destinati ad assicurare il controlloefficace della legalità del soggiorno degli stranieri, nonché la preven-zione dei loro ingressi nell’Unione Europea senza una reale motivazio-ne.
La migrazione è una priorità politica dell’Unione Europea; da quila necessità d’istituire misure strutturate a livello comunitario che inclu-dano: la conclusione immediata degli accordi di riammissione con iPaesi d’origine degli emigranti, la cooperazione con tali Paesi nella lot-ta contro la migrazione irregolare e l’utilizzo dei canali di migrazionelegale.
210
KAMIL EDDINE BENHABIB
Responsabile Studi Sociali del Consiglio Economico e Socialedell’Algeria (CNES)
Uno degli obiettivi fissati per questa conferenza è quello di realizzare“una forte saldatura tra le politiche immigratorie e le politiche di coopera-zione allo sviluppo, attraverso la promozione di accordi tra l’UE e i Paesidi origine”. Si tratta di due problematiche principali, che coprono settorimolti vasti e interferenti tra loro, e che pongono la necessità di un chiari-mento politico e giuridico in una dinamica di attuazione concomitante.
La pertinenza del tema, dunque, consiste nell’avviare insieme unariflessione su una serie, non esaustiva, di strumenti che permettano dirafforzare il partenariato per lo sviluppo sostenibile della regione. Que-sta serie di riflessioni dovrà soddisfare le condizioni di equilibrio, dicoerenza e di giustizia, sollevate dai movimenti di persone, quello deibeni e dei servizi e quello delle nuove tecnologie.
Ciò è tanto più pertinente per Paesi europei come l’Italia, la Spa-gna e il Portogallo che sono stati Paesi di forte emigrazione. Così la lo-ro responsabilità è maggiore per una trattazione appropriata, giusta edumana dei temi posti.
Dopo Barcellona, su questi problemi è stato scritto molto e si sonosvolti numerosi dibattiti, senza che, realmente, prendesse corpo il co-svi-luppo e la co-prosperità desiderati e conclamati. Paradossalmente, si assi-ste al rafforzamento dei “sistemi di controllo” dei movimenti umani e deiflussi migratori, rafforzamento che polarizza l’interesse dei Paesi dell’UEin un dibattito unilaterale che rimane di sola competenza degli Stati del-
211
l’UE, nel senso in cui sono messe in evidenza e poste a priorità altamentepolitiche solo le preoccupazioni dei Paesi di accoglienza.
Così, continuano ad aumentare, sotto diverse forme, gli appelli di-retti per il reclutamento di élite e di quadri stranieri nell’UE ed a svuo-tare i Paesi di origine.
Questo paradosso si rafforza in un ambiente a tre dimensioni cau-sali, che si tratta, per altro, di approfondire: la persistenza dei miti, lacultura di idee e di teorie generose e le situazioni conflittuali d’interessetra l’UE e il mondo americano.
Se il volume degli scambi commerciali, malgrado gli ostacoli e lebarriere alle esportazioni dei PVD, segue una curva ascendente, quellodegli IDE mostra ancora reticenze, incertezze ed una mancanza di deter-minazione. Esistono attualmente1 programmi di cooperazione e di parte-nariato, numerosi e diversi, ma sono ancora insufficienti per affrontare lesfide dello sviluppo e dell’emigrazione. Ne discende una conseguenzaimportante: i ripetuti guasti ai motori dello sviluppo economico e socialedei Paesi di emigrazione offrono ai Paesi di accoglienza manodopera,qualificata ed altamente qualificata, facile, e ad un costo simbolico di uneuro, per il mantenimento e l’accelerazione dei loro motori di sviluppo.
Nella maggior parte dei Paesi dell’UE, con il pretesto di controlla-re i flussi migratori, la condizione degli stranieri, in situazione di immi-grati o di non immigrati, non presenta un modello di conformità ai dirit-ti dell’uomo e alle libertà pubbliche. Con qualche sfumatura, tutte lepolitiche hanno portato ad una stigmatizzazione2 degli stranieri extraco-munitari: discriminazioni nell’occupazione, nell’educazione e nell’al-loggio, differenze nei salari, nel rilascio dei permessi di soggiorno, neicontrolli amministrativi e di polizia, nel rilascio dei visti....
Questa situazione imposta rimane incomprensibile per la popola-zione e la società civile organizzata, nel momento in cui viene firmatoun atto principale, quello dell’adesione all’UE.____________1. Nel settore dell’istruzione, della formazione professionale e dell’insegnamento
superiore (Avicena, coordinato dall’UNESCO, Tempus, Mednet, coordinato dal-l’Università Ovunque d’Italia), nei settori della sanità, delle PME/PMI, dellacultura e del turismo, del commercio elettronico, e degli NTIC.
2. Vedere Rapporto CNES: “La comunità algerina stabilita in Francia: quale appor-to allo sviluppo economico e sociale dell’Algeria?” 22esima sessione, maggio2003, Algeri.
212
Oltre ad una responsabilità storica calpestata, con l’aiuto di alcunimezzi di informazione, si esasperano i sentimenti di paura e di rifiutonei confronti dell’extracomunitario e, attraverso una serie di leggi, diregolamenti e di procedure, lo straniero diventa una minaccia sociale epolitica; il passo è breve, esso viene presentato come un criminale o unpotenziale terrorista.
Questo estremismo o questo egoismo, senza le sue manifestazionibarbare e tragiche, si collega all’integralismo che l’Algeria, sola ed iso-lata, ha dovuto combattere e di cui ha dovuto sopportare le moltepliciconseguenze distruttive. Gli eventi innominabili dell’11 settembre, chehanno scosso il mondo intero, hanno sconvolto la visione ed hanno por-tato alla costruzione di una nuova carta mentale e politica, basata sullacooperazione, mirata ad eliminare questo flagello.
Per tornare alla minaccia, qual è il peso di questa emigrazione? Suuna popolazione di circa 380 milioni di persone, nell’UE sono presentisolo 13 milioni di stranieri, cioè il 3,5%. In questi, solo il 40% (5 milio-ni) sono originari dei Paesi del Sud del Mediterraneo, compresa la Tur-chia che ne conta la metà. I cittadini immigrati del Magreb sono solo 2milioni e 300 mila di cui 1 milione e 200 mila marocchini, 700.000 al-gerini e 300.000 tunisini.
A partire dagli anni ‘90, si è imposta una nuova forma di emigra-zione selettiva, come un’esigenza imprescindibile per le economie eu-ropee - vittime anch’esse dello stesso movimento in favore dell’Ameri-ca del Nord - e delle organizzazioni dei datori di lavoro.
Per citare solo il settore informatico, la Francia nel 2000 ha rilascia-to 1.600 permessi di soggiorno e 4.000 nel 2001. La Germania con il suodispositivo “carta verde” aveva reclutato, a fine agosto 2002, cioè due an-ni dopo il lancio dell’operazione, 12.500 informatici di cui 300 algerini.
A questo livello di analisi, è consentito porsi un interrogativo es-senziale. Attraverso questa “fuga organizzata di cervelli”, complemen-tare a quelle delle materie prime e dei capitali, i Paesi di origine deiflussi migratori non assicurano, pienamente, il loro contributo alla coo-perazione allo sviluppo dei Paesi di accoglienza?
In quest’ottica, il mercato europeo (mondiale) delle competenze do-vrà rappresentare il segmento privilegiato del partenariato euromediterra-neo. Ora, tutti i Paesi della riva Nord hanno concepito e messo in atto di-
213
spositivi particolari3 per attrarre gli stranieri diplomati nei settori deficitari,mancanza di investimenti e di finanziamenti delle strutture di formazione4.
Questi sistemi di facilitazioni, anche se criticabili, sottolineano uncontrasto eclatante con le forme scritte o suggerite della discriminazio-ne nell’occupazione, vissute dagli immigrati già presenti. Questa situa-zione appare ambigua.
Più si è spinti a rendere più rigide le condizioni di entrata (visti) equelle dell’immigrazione più:
• il mercato del lavoro richiede il reclutamento di lavoratori stranieri,
• il mercato sociale cerca di equilibrare i meccanismi della sicurezzasociale,
• e il “mercato” demografico a riprendere la crescita e a rinnovare la suaforza produttiva.
Contrariamente alle analisi e alle interpretazioni avanzate dai so-stenitori di questo movimento, l’esodo delle competenze ha pesanti enegative conseguenze per i Paesi di origine: gli effetti facilmente misu-rabili toccano la formazione, la ricerca e la produzione.
Infatti, una parte delle competenze immigrate sono di formato-ri/inquadri, ricercatori e produttori e questo in tutti i campi (scientifico,tecnologico, culturale, artistico e sportivo) e in tutti i settori (economi-co, sociale, commerciale e finanziario).
A titolo di esempio, secondo l’OMI lasciano l’Africa 20.000 pro-fessori, ingegneri e medici, mentre lo sviluppo del continente richiedeun (1) milione di quadri.
Secondo uno studio realizzato da un centro di ricerca egiziano sul-la fuga dei cervelli, pubblicato sulla stampa algerina5, i Paesi arabiaccusano annualmente perdite stimate in 1,5 miliardi di dollari USA; ilmondo arabo perde, ogni anno, il 50% dei medici, il 23% degli ingenerie il 15% di scienziati.____________3. Quote basate sugli interessi economici, culturali e storici, a punteggi basati sulle
qualifiche, l’esperienza ed il talento, deroghe secondo i bisogni manifestati daisettori o dagli enti territoriali.
4. In Germania, il fabbisogno di informatici è stimato in 75.000 mentre l’Universi-tà sforna solo 6.000 diplomati.
5. Quotidiano El Moudjahid del 3 settembre 2003.
214
Questa emorragia, subita dai Paesi di emigrazione, dimostra che:
• l’alternativa, per i Paesi di origine dei flussi migratori, si iscrive, sempre,nelle prospettive di sviluppo ai molteplici vincoli e rischi interni ed ester-ni: il peso del debito costituisce certamente uno dei vincoli principali;
• il ritorno e i trasferimenti di denaro appartengono ai miti ed ai mirag-gi. A questo livello, è auspicabile condurre un dibattito contradditoriobasato su opinioni e dati, lontano, quindi dalle generalità di una certasuperficialità che offrono idee preconcette, che affermano che i Paesidi origine incoraggiano l’emigrazione perché per loro rappresenta “u-na fonte di ricchezza”.
Si nasconde, allora, che l’emigrazione:
• è stata largamente favorita per ricostruire l’Europa;
• è stata il proseguimento della colonizzazione nei suoi effetti perversi ei suoi legami di dipendenza. Ricordiamo che, dal 1972, l’Algeria nonè più un Paese di origine di migranti e che è diventato, in questi ultimianni, un Paese di transito e di immigrazione forzata;
• è il risultato delle condizionalità, con forti ricadute sociali, insite neisistemi di aiuto alla cooperazione;
• è la conseguenza naturale di una situazione economica e sociale pre-caria con la sua serie di disuguaglianze spaziali e di squilibri settorialie di una situazione di povertà6 inaccettabile per gli esseri umani dioggi e di domani.
Conseguentemente, questa emoraggia chiede, con forza, una coo-perazione reale ed efficace allo sviluppo sostenibile e riparatrice delleperdite subite.
Alcune proposte
* Il partenariato sulla base di interessi reciproci giusti ed equilibrati ri-chiede, per essere centrato di nuovo, un chiarimento dei sistemi pro-cedurali dell’UE al fine di eliminare o, almeno, attenuare i vincoliche incontra attualmente il partenariato.
____________6. AICESIS, 8° incontro internazionale, Algeri, 24/25 giugno 2002: La lotta contro
la povertà per lo sviluppo sostenibile: per un approccio in partenariato.
215
* Il quadro degli accordi nazionali bilaterali e gli altri quadri di cooperazio-ne non governativi, da una parte, e il processo di adesione all’UE, dal-l’altra, devono porre come priorità la valorizzazione del potenziale uma-no, la salute, le infrastrutture, e le PME, in ogni finanziamento di proget-ti e in ogni assistenza scientifica e tecnica, destinati ai Paesi di origine.
* Per il fatto che il contributo alla produzione e alla produttività mate-riale e immateriale dei lavoratori immigrati è riconosciuto come im-portante, si impone un nuovo approccio al partenariato nei suoi seg-menti giudicati prioritari per lo sviluppo sostenibile dei Paesi di origi-ne. Ciò sembra imperativo per permettere il fiorire e/o il rafforzamen-to delle opportunità economiche, culturali,....
* Le soluzioni per il trattamento del debito devono essere inserite inquesto nuovo approccio al partenariato.
* I progressi tecnologici, i cambiamenti delle spese economiche e so-ciali e la crescita vertiginosa delle nuove tecnologie dell’informazio-ne e della comunicazione segmentano il mercato del lavoro come unmercato di competenze, di qualifiche e di impiegabilità. Ciò compor-ta, pertanto, che l’insieme dei decisori politici e degli attori economi-ci e sociali, in particolare la società civile organizzata, siano coinvoltiin un dialogo permanente mirato al consolidamento della cooperazio-ne regionale, basato su meccanismi e regole a beneficio dei Paesi diorigine di migranti.
* Un dibatto disuguale, asimmetrico e studi che tengono conto solo del-l’interesse dei Paesi di accoglienza sono elementi devianti nell’ap-proccio globale al fenomeno dell’immigrazione. Devono essere messiin opera progetti di studio, finanziati o co-finanziati dall’UE, condottida specialisti e da ricercatori dei Paesi di origine.
Infine, una misura di buona volontà, in particolare di apertura sulmondo, di rispetto dei valori propri e dei diritti dell’uomo che non pos-sono essere dissociati dallo sviluppo, e misure di alleggerimento dellecondizioni di entrata, unitamente da un certo numero di convergenzedegli interessi economici, finanziari, commerciali e culturali, fornireb-bero un quadro idoneo per la cooperazione.
216
TAHAR FELLOUS
Membro della Commissione Lavoro e Salute del Consiglio Economico eSociale della Tunisia
Vorrei portarvi i saluti ed i ringraziamenti del Presidente del Con-siglio Economico e Sociale, il signor Kaabi e ringraziare il CNEL perquesta interessante opportunità offerta a noi Paesi di origine. Per noiquesta partecipazione è fondamentale innanzitutto perché ci permette diconstatare l’esistenza di una percezione ai Paesi di partenza e a quelli diaccoglienza di un fenomeno antico e comune che è l’emigrazione e, insecondo luogo, perché questa riunione è stata organizzata dall’Italia cheè un Paese che ha più facce.
In passato, l’Italia è stato un Paese d’emigrazione, attualmente èun Paese d’immigrazione, ma soprattutto è un Paese che ha un’espe-rienza reale del fenomeno visto che la popolazione d’immigrati raddop-pia da un decennio all’altro. Inoltre, a causa della sua vicinanza geogra-fica, l’Italia è una sorta di testa di ponte tra un continente di partenza eun continente d’arrivo. Per farvi un esempio: tra la Tunisia e l’Italia ladistanza minima è 76 chilometri, tra Pantelleria e Kelibia. Tra Lampe-dusa e Mahdia ce ne sono 176. La distanza massima tra la frontiera ita-liana e quella tunisina è di soli 250 chilometri. Un gommone Zodiac(che fa dieci nodi) impiega appena 8 ore per andare dalla Tunisia all’I-talia. E questo vi fa capire l’importanza di aver organizzato questa riu-nione proprio a Roma, che è ancor più importante se consideriamo chel’Italia è in questo periodo è “Presidente di turno dell’Unione Europea”
217
e può trasmettere il messaggio dei Paesi di partenza agli altri Paesi eu-ropei che, forse, non hanno la stessa percezione e la stessa esperienza diquesto fenomeno.
Cercherò di attenermi il più possibile al titolo di questa sessione,cominciando con l’esempio della Tunisia ed illustrando anche le politi-che di sviluppo e cooperazione con alcuni Paesi. Citerò qualche esem-pio. Innanzitutto condivido gli interventi fatti finora aggiungendo cheho la fortuna e l’onore di partecipare a riunioni di questo genere da 20anni, ma ho l’impressione di sentire sempre lo stesso linguaggio, lestesse parole, le stesse buone intenzioni, le stesse dichiarazioni di buonavolontà, gli stessi valori nobili ma c’è sempre una frattura tra i discorsi,la teoria, la volontà, le tesi e la gestione quotidiana dell’immigrazione.C’è qualcosa che non va. Forse abbiamo bisogno di una percezione co-mune del fenomeno che permetta di accorciare le distanze tra Paesi diarrivo e Paesi di origine. Siamo tutti d’accordo nel dire che l’emigrazio-ne non è un flagello, ma è un bene, non è una piaga. Purtroppo, ieriDiamanti ci ha parlato di alcuni sondaggi che mostrano una certa paura,una sorta anche di ossessione che viene esacerbata da alcuni partiti e daalcuni politici. Quindi bisogna innanzitutto chiarire questo punto e farein modo che i governanti, coloro che devono cristallizzare la realtà del-le cose, comunichino quello che sanno all’opinione pubblica.
La posizione tunisina sulla questione è piuttosto chiara: il nostroobiettivo è mantenere una stretta correlazione tra l’emigrazione legale ela lotta contro l’emigrazione illegale. E’ il minimo che si possa fare esembra una cosa lapalissiana, ma è un punto sul quale lavoriamo moltoe con grande interesse. La Tunisia pensa che se l’emigrazione viene bengestita, in uno spirito di partenariato, può rappresentare un elemento dico-sviluppo. Sarò sintetico visto il poco tempo a disposizione. Affinchél’emigrazione si trasformi in un’esperienza valida ed arricchente sia peril Paese di partenza che per quello di accoglienza - e parlo di migliora-mento delle condizioni di vita in termini di sicurezza sociale, di allog-gio, di inserimento nella vita attiva - è necessario combattere l’emigra-zione clandestina. Credo che questo sia un argomento che tutti voi co-noscete meglio di me, almeno in teoria. Vi parlerò dell’approccio dellaTunisia e soprattutto della sua esperienza con l’Italia, perché ci è statochiesto di parlare degli accordi bilaterali con l’Italia, un Paese che come
218
ho già accennato all’inizio funge da testa di ponte tra l’Africa e l’Euro-pa. Con l’Italia abbiamo firmato un accordo il 16 agosto 1998. Non èun accordo solenne - e qui vorrei aprire una parentesi per spiegarvi lasituazione: la Costituzione tunisina, all’articolo 11, impone d’impedireai tunisini di partire in condizioni rischiose e fa appello alle autorità tu-nisine affinché riaccolgano in patria tutti i cittadini tunisini che si trova-no all’estero in posizione irregolare. Di conseguenza, con l’Italia ci sia-mo limitati a firmare uno scambio di lettere e non un accordo solenne.La nostra politica parte dalla dissuasione; dobbiamo dissuadere dal par-tire tutti i candidati potenziali che si trovano in condizione di irregolari-tà, anche coloro i quali in virtù della Convenzione delle Nazioni Unitisono considerati vittime. L’Europa non è più l’Eldorado, e partire incondizioni irregolari rischierebbe di farli precipitare nella disperazione,nell’emarginazione e nella precarietà. Inoltre gli organizzatori delle o-perazioni clandestine devono essere perseguiti e puniti in maniera seve-ra. La legislazione esiste ed è stata modificata affinché sia ancora più ri-gida e dura.
Un’altra maniera di prevenire le partenze illegali è la sensibilizza-zione dei potenziali candidati al viaggio. Attraverso una politica internaeconomica e sociale - che è valsa alla Tunisia il plauso di varie persona-lità occidentali che hanno visitato il nostro Paese e hanno assistito ad unprocesso democratico irreversibile - la Tunisia è riuscita a combattere ilfenomeno della disoccupazione e, soprattutto, a migliorare il livello divita in molte regioni più colpite dal fenomeno dell’emigrazione clande-stina. L’accesso all’occupazione, malgrado le difficoltà del momento, èfacilitato anche se i Paesi dell’Unione Europea sono chiamati a compie-re un maggiore sforzo. La Tunisia è stata uno dei primi Paesi stranieri afirmare un accordo con l’Unione Europea il 17 luglio 1995. L’accordoprevede un capitolo che s’intitola “Aspetto Sociale” ma soprattutto unarticolo, il n. 71, che mette l’accento sulla riduzione della pressione mi-gratoria grazie alla creazione di occupazione e sull’incoraggiamento diiniziative che favoriscano lo sviluppo della Tunisia. A titolo di esempio,nel quadro della cooperazione Italia-Tunisia ci sono due programmi pi-lota. Il primo è stato realizzato dal Governo italiano e da una regionecentro occidentale della Tunisia e mira a sviluppare le capacità profes-sionali locali e ad ancorare i candidati potenziali all’emigrazione al loro
219
luogo di origine dandogli la possibilità di trovare un lavoro o dei mezzidi sussistenza. Un secondo progetto, lanciato insieme all’Italia, tenta dimigliorare le capacità dei responsabili dell’emigrazione. C’è un proget-to italiano sulle quote d’immigrazione che è stato applicato per assume-re in Italia circa 3.000 operai. E’ un progetto riuscito e ci sono le pro-messe di ripeterlo. Ieri ho seguito con grande interesse la proposta a-vanzata durante l’apertura della riunione che appoggia questa idea evuole sostenerla a livello dell’Unione Europea. E questo è un messag-gio molto forte perché trasmette ai potenziali immigrati l’idea che l’Eu-ropa non è quella cittadella o quella fortezza della quale si parla, ma èanche una porta verso la speranza, come ha detto il Presidente Gennari,a condizione che l’emigrazione avvenga nel rispetto della legge e delleculture, dalle quali scaturiscono le nozioni di tolleranza e di solidarietà.
Quando si parla di prevenire l’emigrazione irregolare, si parlasempre di dissuasione, di prevenzione, ma bisognerebbe anche miglio-rare la circolazione legittima delle persone. Spesso una richiesta di vistosi trasforma in una vera e propria umiliazione. Bisognerebbe fare inmodo che i viaggiatori in buona fede potessero muoversi liberamente inEuropa: questo è per noi un fattore di arricchimento che rientra nellostesso liberalismo che prevede la libera circolazione dei capitali, dellemerci, dei servizi e delle persone.
E ora parliamo del problema del rimpatrio, punto molto importan-te, perché è necessario che i Paesi di partenza accettino di riaccoglierele persone emigrate in maniera clandestina. Tuttavia bisogna anche ca-pire che questo rimpatrio deve avvenire nel rispetto dell’umanità, delladignità e senza nessuna spettacolarizzazione. Ieri uno dei relatori haparlato del rimpatrio massiccio di 120 persone. Il rimpatrio massiccio èinaccettabile per noi. Purtroppo, quando si parla di emigrazione ci sa-rebbero tante cose da dire e i Paesi del Sud avrebbero dovuto avere al-meno una ventina di minuti, perché hanno sempre molte cose da comu-nicare, preoccupazioni da esprimere che permetterebbero di migliorarela percezione comune di un problema comune.
220
SAID IHRAI
Presidente del Consiglio Economico e Sociale del Marocco (CNJA)
Le politiche demografiche e di mobilità della popolazione sono frale principali preoccupazioni di tutti i Paesi. Alcuni sono sottoposti allepressioni demografiche dovute agli elevati indici di natalità, di mortali-tà e di esodo rurale, mentre altri subiscono gli effetti dell’invecchia-mento della popolazione.
I fenomeni demografici sono il risultato di molte variabili: econo-miche, culturali, sociali e climatiche. Le loro reazioni sono lente, pro-fonde ed hanno effetti duraturi.
Ecco perché dopo quasi dieci anni dagli accordi che hanno dato vi-ta alla Dichiarazione di Barcellona, ci si è resi conto che le questionidemografiche sono di natura trasversale ed interagiscono costantementecon gli altri parametri del processo euro-mediterraneo.
Per loro stessa natura, i movimenti demografici vanno al di là del-le frontiere e non possono essere relegati in un solo settore. Essi in-fluenzano la competitività dell’economia, le questioni riguardanti laformazione, le qualifiche, i problemi migratori ed il riavvicinamento frai popoli, ma anche la disoccupazione, i traffici illeciti ed il terrorismo.
La zona di libero scambio, che tende ad essere sovrastimata nelprocesso di Barcellona in confronto ad altri settori, non potrebbe averesignificato e conseguire gli effetti attesi se non prendesse sempre più inconsiderazione i problemi causati dalle variabili demografiche.
Non esistono colpevoli in questo campo; esistono interessi e re-sponsabilità condivise.
221
Le questioni migratorie, sia quelle dell’immigrazione regolamentatache dell’immigrazione clandestina, diventano sempre più problemi che ungran numero di Paesi si trova ad affrontare. Ne sono interessati tanto iPaesi d’origine che quelli transito, nonché quelli di destinazione. Al di làdei malintesi che sono nati a Maastricht con l’instaurazione dei visti, o alvertice di Siviglia sulla creazione di strumenti comuni europei per la lottaall’immigrazione clandestina, 1’immigrazione resta un problema che tra-scende le frontiere. Solo politiche concertate di cooperazione fra Paesi didestinazione e Paesi d’origine possono contribuire ad attenuarne gli effettinefasti e ad intraprendere misure alternative virtuose a beneficio di tutti.
I problemi migratori chiamano in causa due livelli d’azione nel-l’ambito delle scelte euro-mediterranee multilaterali, bilaterali e nazio-nali nei Paesi d’origine.
1. I fenomeni demografici
1.1 Il Marocco sta vivendo una transizione demografica che hacambiato di netto gli indicatori del periodo precedente gli anni ottanta.
Questa transizione è caratterizzata da:
- una popolazione giovane: il 54% della popolazione ha meno di 30 anni;
- un tasso di crescita demografica in netto miglioramento dal 2,1% de-gli anni ottanta all’1,6% a partire dal 2000;
- un tasso di mortalità che diminuisce per effetto dei progressi registratinel settore dell’igiene, della salute preventiva e della fornitura di ac-qua potabile alla maggioranza della popolazione;
- un aumento del numero della popolazione di età compresa fra i 15 ed i65 anni, con un’età mediana ancora bassa per almeno due generazioni.
1.2 Tutti questi indicatori fanno sì che si eserciti e si continui ad e-sercitare in futuro una forte pressione demografica - per almeno due ge-nerazioni - sulle risorse economiche, le risorse naturali ed i servizi pub-blici collettivi.
L’esodo rurale permane molto pronunciato e crea il fenomeno del-l’eccessivo sviluppo delle periferie suburbane tentacolari ove affluisco-no i giovani che abbandonano definitivamente le zone rurali senza alcu-
222
na prospettiva di trovare un impiego, una sistemazione o possibilità diformazione se non quelle che permettono di sopravvivere con attività il-legali e parassitarie. Una città come Salé, ad esempio, supera il milionedi abitanti, ma le sue infrastrutture sono adatte a soddisfare le esigenzedi meno di 300.000 abitanti.
1.3 Una pressione insostenibile sull’occupazione
La popolazione attiva aumenta più che proporzionalmente rispettoalle capacità dell’economia - sia formale che informale - di creare occu-pazione e produrre reddito.
Nel 2002 la popolazione attiva era stimata a 10,4 milioni di abitan-ti, con un aumento dell’1,4% rispetto al 2001.
La popolazione occupata è di 9,2 milioni di abitanti. Nel 2002 lapopolazione in cerca di un’occupazione aveva raggiunto una cifra pari a1,2 milioni di persone.
Secondo le statistiche ufficiali il tasso di disoccupazione nazionaleè pari all’11,6%, con una diminuzione di 0,9 punti percentuali rispettoal 2001. Nelle zone rurali questo tasso era pari al 18,3% nel 2002, inleggera diminuzione rispetto al 20017.
Questa situazione è un destino comune per tutti i Paesi del sud delMediterraneo.
Unitamente all’aumento dei divari in termini di reddito e di tenoredi vita fra le due sponde del Mediterraneo, questa situazione non puònon portare a quei risultati che tutti conosciamo. Il divario in termini direddito è di 1 a 20 fra le due sponde.
Il reddito pro capite è 10 volte superiore nei Paesi dell’Unione Euro-pea rispetto a quello dei Paesi del Sud. L’interscambio fra il Sud ed il Suddel Mediterraneo rappresenta meno del 5% del volume degli scambi dei 12Paesi. Questi Paesi ricevono soltanto l’1% degli investimenti diretti esteri(IDE) a livello mondiale ed il 2% degli investimenti europei nel mondo.
2. La cooperazione e l’attuazione delle politiche di limitazione dei flus-si migratori
____________7. Rapporto della Banca AL-MAGHRIB (Banca del Marocco) sull’esercizio 2002.
223
2.1 I flussi in crescita
Nel 1994, quasi due milioni di persone provenienti dai Paesi delSud del Mediterraneo vivevano nei Paesi dell’Unione Europea: il 5% inFrancia, il 10% in Italia ed il 4% in Spagna.
Attualmente, soltanto i marocchini residenti all’estero sono 2 mi-lioni la cui quasi totalità vive nei Paesi dell’Unione Europea: la Francia,la Spagna, l’Italia, la Germania, il Belgio e la Gran Bretagna.
Nonostante le numerose restrizioni imposte a coloro che intendonoemigrare verso l’Europa, molto prima delle decisioni prese al vertice diMaastricht e dell’imposizione dei visti che ne è seguita, i flussi migra-tori verso l’Europa non si sono mai interrotti. Oltre ai clandestini, sonocontinuate ad esistere diverse forme di immigrazione regolamentata.
Dalla fine degli anni ottanta si sono sempre più sviluppate rotte, cir-cuiti e forme di immigrazione clandestina. La fortezza Europa, che si con-solida e si chiude a doppia mandata, è sempre più presa d’assalto. L’immi-grazione clandestina viene sempre più gestita dalle reti di economia crimi-nale e mafiosa. Paesi come il Marocco continuano a generare immigrazio-ne clandestina, ma sono anche, e sempre più lo saranno in futuro, zone ditransito verso l’Europa per gli immigrati provenienti dai Paesi a sud delSahara. Tutto ciò causa altri problemi in termini di accoglienza e sistema-zione, di xenofobia e di sviluppo di attività parassitarie e non regolamenta-te che ruotano intorno agli ambienti criminali, al traffico di documenti, al-le frodi di ogni genere e, purtroppo, al dramma quotidiano dei naufragi dei“gommoni della speranza” che colpiscono sempre più donne e bambini.
Due logiche perverse si stanno consolidando sulle due sponde delMediterraneo.
Al Sud, il Mediterraneo diventa un colabrodo, una zona clandestinadi transito degli emigranti del Sud, che vengono da Paesi sempre più lon-tani e mettono a mal partito quei Paesi di destinazione che non hanno lecapacità di lottare contro queste reti e tanto meno di organizzare l’acco-glienza e la sistemazione dei clandestini in fuga dalla disperazione.
I Paesi e queste popolazioni travagliate cadranno sempre più predadi mercanti di sventura.
Al Nord, dal vertice di Maastricht a quello di Siviglia, l’UnioneEuropea tende a cedere spesso alla tentazione di far prevalere le consi-derazioni relative alla sicurezza ed al rispetto della legge, nonché leconsiderazioni elettorali.
224
Bisogna sviluppare altre vie ed inventare altre soluzioni; bisognaosare di più in termini di cooperazione e concertazione.
2.2 Il contributo significativo degli immigrati alle risorse del Paese
Le popolazioni migranti contribuiscono in modo significativo almiglioramento delle condizioni di vita dei loro Paesi d’origine. Oltre al-le normali rimesse, essi sono spesso gli ispiratori di piccoli progetti chevanno dall’habitat familiare, alle seconde case fino ai micro-progettiche producono reddito a beneficio delle loro famiglie e dei loro carinelle regioni d’origine o in altre città.
In Marocco, le rimesse contribuiscono considerevolmente al mi-glioramento della bilancia delle partite correnti. Esse ammontavano a31,7 miliardi di DHS nel 2002 (16 miliardi nel 1998). A fini di confron-to, le spese a titolo di servizio del debito pubblico esterno sono pari a28,3 miliardi di DHS.
2.3 Le misure intraprese nel quadro dei PEM
Il processo di Barcellona - quale concepito fra l’entusiasmo e lepaure dell’inizio degli anni novanta, dopo la caduta del muro di Berli-no, la riunificazione tedesca, la fine del regime dello scià in Iran e laprima guerra del Golfo - è un concetto lungimirante e generoso. I tresettori sono articolati in funzione di un’unica finalità: “la pace e la pro-sperità condivise”. L’attuazione di questo processo è tutt’altra cosa. Lapolitica vacilla, l’economia e gli affari sociali sono subordinati ai contifinanziari ed il dialogo fra i popoli è occultato dai sussulti d’identità,dal rifiuto, dagli atteggiamenti di dominazione e dall’ostilità.
Tuttavia, nel processo di Barcellona, esistono elementi di rispostaai problemi migratori. I loro effetti sono lenti, le loro logiche contrad-dittorie ed i loro effetti di lunga durata. L’urgenza dei problemi imme-diati e le divisioni geo-strategiche a livello mondiale hanno seminato ildubbio e nutrito 10 scetticismo.
Vale la pena ricordare alcuni fattori:
- gli emigrati fanno da ponte, stabiliscono legami culturali, economicied intimi fra i popoli;
- il loro contributo arricchisce tanto i Paesi di destinazione che quellid’origine;
225
- non bisogna confondere immigrazione regolamentata ed immigrazio-ne clandestina.
La sola alternativa valida ed efficace va ricercata nel co-sviluppo apartire dai Paesi d’origine. E’ essenziale una cooperazione volta a con-seguire un equilibrio strutturale attraverso programmi per la costruzionedi moderne infrastrutture di base, attraverso la formazione, la lotta allapovertà, i progetti generatori di reddito e la modernizzazione del tessutoeconomico. Ciò non si riferisce soltanto all’interscambio, ma chiama al-tresì in causa le politiche di entrambe le sponde.
In Marocco, da un decennio a questa parte, sono stati varati pro-grammi di vasto respiro in tal senso. I loro effetti sono percepibili; l’ac-cumularsi dei problemi rende il compito difficile, ma non impossibile.
Le riforme che la Commissione Europea ha timidamente intrapre-so attraverso il decentramento e le azioni di prossimità vanno in questadirezione. Esse devono essere accompagnate da ulteriori sforzi nellalotta alla povertà ed in favore dei bisogni di base delle popolazioni.
MEDA II ha inaugurato questo processo; l’investimento diretto èlimitato, il commercio resta bloccato nei conti d’esercizio.
Lo sviluppo locale ha registrato notevoli progressi. Alcune associa-zioni che fanno riferimento a MEDA, alle ONG del Nord ed alla coopera-zione bilaterale hanno varato progetti con il contributo dei marocchini re-sidenti all’estero. Notevoli risultati sono stati conseguiti in molte zone,nelle regioni semi-aride e nelle regioni sfavorite. Riguardano la fornitura i-drica, l’elettrificazione delle aree rurali, l’aumento del livello di scolariz-zazione delle donne, la costruzione di ambulatori, le attività di micro-cre-dito, la disponibilità di piccoli capitali di rischio, i fondi di garanzia, ecc.
Alcuni immigrati ritornano nei loro Paesi creando piccoli progetti:piccole aziende per la produzione di formaggio di capra, piccoli alber-ghi di montagna, servizi informatici, ecc.
Esistono altre possibilità. Bisogna incoraggiare queste tendenze.
Ma esiste anche l’urgente necessità degli altri che vogliono partire.Riflettiamo su altre possibilità in due tempi: adoperarsi per il consolida-mento dello sviluppo economico, delle infrastrutture, delle imprese edel commercio, ma non far sì che le considerazioni relative alla sicurez-za ci sbarrino la strada del futuro.
226
UGO MELCHIONDA*Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)
Grazie al CNEL per averci invitato. Vi porto le scuse del Direttoredel programma ricerche e politiche migratorie, che non è potuto esserepresente per motivi indipendenti dalla sua volontà.
Giustamente poco fa si faceva notare il punto di vista, espresso ie-ri, dei Paesi del Nord, mentre oggi tocca ai Paesi del Sud esprimere leproprie ragioni e mi pare azzeccata questa collocazione dell’OIM, A-genzia terza, intergovernativa, di cui fanno parte Paesi del Nord e delSud, a conclusione di questo primo giro e prima che i responsabili poli-tici possano darci le risposte che tutti quanti ci aspettiamo.
Credo che oggi i temi dell’emigrazione e dello sviluppo siano aduna svolta epocale. Sino a qualche anno fa tutti gli analisti più attentimettevano in luce le correlazioni negative, il nesso negativo. Si è parla-to per anni dei danni che l’emigrazione comportava per i Paesi di origi-ne, della povertà, di quello che era l’impoverimento del tessuto econo-mico ma anche sociale, anche di relazioni umane. E non è un caso che,fino a qualche anno fa, le menti più avvertite dei problemi dell’emigra-zione, dicevano che l’emigrazione va prevenuta, e il nostro approccionei confronti dell’immigrazione e dell’emigrazione era proprio di pre-venzione.__________* Intervento non rivisto dall’autore
227
Invece, da qualche anno a questa parte, si comincia a cogliere l’a-spetto positivo. Anche i fenomeni migratori, anche quelli internaziona-li, possono essere occasione positiva per lo sviluppo. E forse comincia,a poco a poco, a farsi largo una diversa parola d’ordine, si cominciamoa vedere alcuni dati di fatto.
Si calcola - con tutte le possibilità di errore che questi calcoli com-portano - che oggi gli immigrati nel mondo, cioè le persone che vivonostabilmente fuori dal loro Paese di nascita, siano 175-180 milioni. LaBanca Mondiale calcola che le rimesse dei migranti siano attorno ai 72miliardi di dollari ogni anno. Paesi come il Lesotho rappresentano il26%, Paesi come il Nicaragua il 16%.
Da questi fatti, da questo sviluppo dell’emigrazione, che non è piùdovuta solo a motivi di calamità naturali, ma si sta sviluppando per mo-tivazioni positive, come ricchezze delle relazioni comunicative, libera-lizzazione degli scambi e dei commerci, sta cominciando a prendereforma una nuova parola d’ordine: non più prevenire l’emigrazione, magestirla. Io credo che questa sia la parola d’ordine di svolta in questoperiodo.
L’OIM, nel suo mandato istituzionale, da cinquant’anni a questaparte, ha avuto esattamente questa visione: proviamo a gestire l’emigra-zione. Ma provare a regolare significa passare da una logica unilateralead una logica bipolare, vuol dire che si è insieme a gestire l’emigrazio-ne, perché nessuno, né i Paesi del Nord da soli, né i Paesi del Sud da so-li, può gestire fenomeni che, per definizione, sono intercontinentali.
Io credo che questa sia la parola chiave su cui lavorare e che noiabbiamo provato a sviluppare, in questi anni, con una serie di progetti disviluppo, alcune ricerche e studi, molte volte in collaborazione con i Go-verni e davvero, il Governo italiano come anche quelli dei Paesi del Me-diterraneo, ci hanno dato la possibilità di lavorare assieme. Lavoro a Ro-ma proprio nella sede di coordinamento delle attività per il Mediterraneoe con tutti questi Paesi, dall’Albania, al Marocco, alla Tunisia, all’Egitto,abbiamo avuto opportunità di scambi enormi, abbiamo provato a metterein piedi un modello, una strategia che lega emigrazione e sviluppo e cheva oltre - è il caso di dire - il nostro conosciuto slogan: l’emigrazione or-dinata è beneficio per tutti i Paesi, di partenza e di arrivo.
228
Noi stiamo cercando di andare oltre questo approccio, per esempiolavorando, come abbiamo fatto nel programma MIDA per formare gliimmigrati, in questo caso un progetto limitato, dell’Africa sub-saharia-na come reali agenti di sviluppo. Il che significa favorire, non solo il lo-ro ritorno, quindi non limitare il ritorno al rientro fisico, ma favorire, adesempio, la disponibilità di persone che hanno redditi, che hanno rimes-se che inviano in patria ai loro familiari, per avviarli alla creazione dipiccola impresa, cooperativa in quei Paesi, per favorire persone che so-no disposte ad assumersi responsabilità imprenditoriali qui, restando inquesto Paese, per fare in modo che il loro ritorno sia virtuale.
Lavorare su questi terreni è un’esperienza che è possibile fare gra-zie al Ministero degli Affari Esteri italiano e credo vada sviluppata inaltri Paesi.
Lavorare ad esempio ad un progetto realizzato con il Governo tu-nisino, per trasformare un’area a forte pressione emigratoria in un’areadi sviluppo locale, coinvolgendo la Confcooperative, le micro imprese,i volontari, i ragazzi che vanno a fare lì, per alcune settimane, attività divolontariato in un’area archeologica da ristrutturare. Lavorare con ilGoverno tunisino a favorire la nostra esperienza, il trasferimento di e-sperienza, perché loro potessero costruire quella banca dati di candidatitunisini all’emigrazione, è stata un’esperienza di cooperazione bilatera-le che ci ha visti soggetti cardine.
Lavorare con l’Albania sullo stesso terreno, fare formazione all’e-stero che la legge Bossi-Fini permette, in modo tale che le persone inte-ressate a lavorare in Italia siano formate in Tunisia da personale tunisi-no, non da personale italiano, perché per noi l’essenziale è trasmettereconoscenza, metodologia, capacità di lavoro, capacità di costruire ponti.
Questo è il quadro delle attività che una cooperazione decentrata,multilaterale, a livello regionale, come noi stiamo facendo, nell’area delMediterraneo occidentale con il dialogo 5 più 5 può offrire.
Questo tipo di strada va sviluppata e può permettere che effettivamen-te l’emigrazione sia, al di là di un benefico effetto per i Paesi di origine, e diarrivo, qualcosa in più, cioè la molla che trasforma e azzera, che dà un va-lore positivo agli effetti negativi, alle sofferenze, alle costrizioni che glispostamenti di popolazione comportano. Questo è possibile se noi lavoria-mo assieme, Paesi di origine, Paesi di approdo e Agenzie come la nostra.
229
ADELA ROS
Istituto Europeo del Mediterraneo di Barcellona
Da tempo immemorabile i movimenti di persone nel Mediterraneohanno rappresentato una fonte di arricchimento economico, sociale eculturale per i Paesi delle sponde nord e sud del Mare Nostrum. Gli at-tuali movimenti migratori accentuano l’interdipendenza della zona e,pertanto, la rafforzano. Tuttavia, dobbiamo lasciare da parte i sogni idil-liaci di un Mediterraneo come incontro di culture e di genti. Le disu-guaglianze esistenti all’interno dell’area mediterranea sono uno dei mo-tori del movimento costante di persone. Dobbiamo trovare punti di dia-logo e di cooperazione che ci consentano di fare progressi nel nuovoquadro, più regolamentato e caratterizzato dall’abbondanza di meccani-smi di controllo delle frontiere, soprattutto nella cosiddetta fortezzaEuropa.
Il quadro delle relazioni euromediterranee che si sta disegnandodal 1995 manca di una risposta integrale per quanto riguarda le migra-zioni. Piuttosto che la creazione di una zona di libero scambio economi-co produce più contraddizioni decretare, allo stesso tempo, una defini-zione di frontiere impermeabili al movimento delle persone. E questo,tuttavia, ancora di più se concepiamo l’area mediterranea in termini diuna economia polarizzata che richiede, da un lato, progressi e dall’altro,manodopera. Le politiche migratorie spesso sono definite al di fuoridella realtà dei movimenti e delle cause dei movimenti delle persone.Dobbiamo fare un maggiore sforzo per conoscere i veri elementi cheprovocano le migrazioni dalle società di origine, le loro caratteristiche, i
230
gruppi coinvolti, le loro preoccupazioni e i loro problemi reali e, perchéno, più umani. Coloro che, da luoghi e da posizioni diverse, lavoranosul tema dell’immigrazione non dovrebbero essere guidati da un tratta-mento mercantilistico del fenomeno migratorio.
Da questa posizione, ci sembra che una delle possibili strategie piùrispondenti a questa necessità sia quella di avvicinare di più e di coordi-nare meglio i temi dello sviluppo e dell’immigrazione nella direzione diquello che intendiamo come co-sviluppo. Questa prospettiva apre leporte della co-responsabilità e, perché no, implica il fatto di fare unmaggiore sforzo nella conoscenza e nella comprensione reciproche. Inun momento in cui in Europa il discorso sul Mediterraneo viene asso-ciato rapidamente ai temi più conflittuali relativi alle migrazioni (in-gresso dei clandestini, traffico di immigranti, saturazione dei campi diraccolta, ecc.), pensare in chiave di co-sviluppo apre prospettive - que-sto si, di lungo termine - meno allarmanti e modella la figura dell’im-migrante come un agente attivo con capacità di generare cambiamentinelle società di origine e di accoglienza.
231
GILDO BARALDI
Direttore Generale dell’Osservatorio Interregionale Cooperazione alloSviluppo
Qui avrebbe dovuto esserci il Presidente della Regione Marche Vi-to D’Ambrosio, delegato alla Conferenza dei Presidenti di tutte le Re-gioni e Province autonome italiane per la Cooperazione Decentrata equindi designato anche alla Presidenza dell’OICS, organismo inter-re-gionale per la cooperazione internazionale, di cui io sono direttore.
Impegnato oggi in giunta regionale, D’Ambrosio mi ha chiesto disostituirlo, cosa di cui mi dispaccio verso tutti i presenti, non solo perl’evidente divario di livello, capacità e statura, ma soprattutto perché è atutti chiara la differenza sul contributo che potrebbe portare in questaConferenza un politico e quello, solo di natura tecnica e informativa,che potrò dare io.
Mi limiterò pertanto ad illustrare schematicamente che cosa sta fa-cendo e, a nostro avviso, che cosa può fare la Cooperazione Decentrataa livello regionale per contribuire a ridurre le negatività e, soprattutto,ad esaltare le positività del fenomeno immigratorio.
Innanzitutto desidero precisare che l’attività delle Regioni per lacooperazione internazionale e per il supporto ai processi di internazio-nalizzazione territoriale non considera solo i flussi migratori in entrata,ma anche gli effetti ad oggi di quelli in uscita. Infatti la presenza inmolti Paesi di importanti comunità italiane offre strumenti importantisia sul piano delle business opportunity all’estero, sia su quello dellacostruzione di partenariati per lo sviluppo reciproco, come dimostra ilrecente intervento interregionale per tamponare la crisi argentina.
232
Tornando al tema dell’immigrazione, concordo con la collega dellaCatalogna che mi ha preceduto, quando afferma che, almeno nel breve emedio periodo, più e migliore cooperazione con un determinato Paesenon riduce, ma anzi aumenta quantitativamente il flusso migratorio daquel Paese. Tuttavia bisogna ricordare che tale flusso è costituito da di-verse componenti, con diverso impatto sul tessuto sociale ed economicosia del nostro Paese che di quelli di origine. Semplificando, vi è un flusso“di chiamata” di persone attirate dalle migliori condizioni di lavoro e diautorealizzazione che l’Europa può offrire e il cui ingresso è necessario alnostro sistema economico. E’ questo un fenomeno sostanzialmente posi-tivo sia per i territori di accoglienza (basta ricordare il grande contributodato dai nostri emigranti allo sviluppo di molti Paesi, soprattutto nelle A-meriche e in Australia, e, più di recente, il ruolo determinante dell’immi-grazione interna per il “miracolo economico” dell’Italia settentrionale),sia per quelli di origine (non a caso anche per il bilancio italiano le rimes-se degli emigrati sono state tra le voci più importanti fino a ben oltre laprima metà del secolo scorso). Naturalmente nel breve termine anchequesto fenomeno pone dei problemi, di ordine sociale, di accoglienza e diintegrazione nel nostro territorio, di depauperamento delle risorse umanenei Paesi d’origine (spesso gli emigrati per lavoro sono tra le persone piùdinamiche e meglio formate). In questo campo le Autonomie locali italia-ne collaborano sia nel loro territorio, in tutti gli ambiti di loro competen-za, in molti casi, anche istituendo forme di partecipazione democraticadelle Comunità immigrate all’amministrazione locale, spesso interme-diando domanda e offerta di lavoro tra il proprio sistema economico e gliimmigrati (quelli entrati, ma in alcuni casi anche nei Paesi di origine),realizzando attività mirate di formazione professionale e linguistica, ecc.
Vi sono poi altre componenti immigratorie, molto più problemati-che; si tratta del flusso “di fuga”, costituito da immigrati, spesso clande-stini, spinti dalla necessità di sopravvivere alla fame, alla miseria estre-ma, a guerre o persecuzioni etniche e religiose, oppure “importati”, nonsempre consenzienti, da organizzazioni criminali dedite alla trattaschiavistica. La legge di sopravvivenza costringe spesso queste perso-ne, anche quando non ridotte in schiavitù, a operare come manodoperasottocosto per la criminalità organizzata (spaccio, prostituzione, furti,ecc.) o per imprenditori senza scrupoli (lavoro in nero). La pur necessa-
233
ria repressione dell’illegalità non rientra nei compiti delle Regioni e de-gli Enti locali, tuttavia essi offrono un importante contributo alla pre-venzione e all’attenuazione dei fenomeni sia collaborando con le istitu-zioni nazionali e comunitarie, sia soprattutto attivando i propri enti stru-mentali e sostenendo le attività delle organizzazioni di volontariato delloro territorio, sia infine, come dirò tra poco, cercando con la coopera-zione decentrata di contribuire al contenimento della spinta di fuga neiPaesi di origine.
In generale, dunque, l’azione delle Autonomie locali non mira a ri-durre quantitativamente i flussi immigratori, né peraltro è questo l’o-biettivo desiderato, ma a renderli più utili e meglio governabili ed amodificarne la composizione riducendo il rapporto tra flusso di fuga eflusso di chiamata.
Affinché si comprenda meglio il ruolo della cooperazione decentratarispetto alle problematiche migratorie, è forse opportuno un breve accenno ache cosa si intende in Italia per “cooperazione decentrata”. Nella pratica del-le nostre Regioni la cooperazione decentrata consiste nella costruzione e im-plementazione di accordi di partenariato con le istituzioni di altri Paesi, ba-sato su criteri di reciprocità e sulla promozione di vantaggi condivisi tra lecomunità territoriali, con il coinvolgimento dei soggetti attivi dei rispettiviterritori (Enti locali ed Enti strumentali, ONG, Università e Centri di forma-zione, PMI, Istituti di credito, Comunità organizzate di immigrati in Italia eComunità italiane all’estero, ecc.). Se mi si consente una metafora, è comese la Regione ed il suo partner straniero si mettessero insieme a comporre unmosaico, per quanto possibile armonico e di reciproca utilità, le cui tesseresono per l’appunto tutti i soggetti attivi dei rispettivi territori. Essa dunquecostituisce uno strumento importante per la cooperazione internazionale eper lo sviluppo congiunto “del sistema Italia” e dei Paesi partner in campo e-conomico, sociale, culturale, scientifico, di stabilizzazione e di rafforzamen-to della democrazia. E’ una forma di “cooperazione circolare”, che si collo-ca a cavallo tra la tradizionale cooperazione “vettoriale” dell’Aiuto Pubblicoallo Sviluppo e il sostegno ai processi locali di internazionalizzazione eco-nomica e si muove in sinergia sia con le politiche nazionali, comunitarie einternazionali, sia con l’azione della società civile e delle ONG.
La nostra cooperazione decentrata si rivolge a tutti i Paesi, ma pre-valentemente a quelli di prossimità (Balcani, Africa Mediterranea, Est
234
Europeo e Medio Oriente), da cui peraltro proviene la maggioranza de-gli immigrati.
Essa si esplica in diversi settori, ma prevalentemente in tre: il soste-gno alle politiche di decentramento amministrativo dei Paesi partner ed ilrafforzamento istituzionale della capacità di governo territoriale in taliPaesi; la collaborazione nella realizzazione e gestione dei servizi pubblicilocali (acqua, energia, rifiuti, ambiente, reti, ecc.); lo sviluppo economicoe sociale locale. Trasversale in tutto ciò è l’impegno per la formazione:professionale, amministrativa, gestionale, manageriale, ecc.
Da questa brevissima presentazione si può facilmente evincere ilruolo della cooperazione decentrata rispetto ai flussi migratori. Nei ter-ritori amministrati dalle Regioni si tratta sostanzialmente, come ho giàaccennato, di favorire l’integrazione, di riqualificare qualitativamente iflussi, di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, di poten-ziare la formazione professionale e linguistica degli immigrati, di age-volare il loro inserimento culturale, di vita e, per quanto possibile, am-ministrativo, di contrastarne lo sfruttamento da parte della criminalitàorganizzata o in termini di lavoro in nero, di coinvolgerli nelle azioni dicooperazione con i loro Paesi di origine.
In tali Paesi le azioni più significative sono mirate alla crescita e-conomica e occupazionale, al rafforzamento delle amministrazioni terri-toriali locali, anche nel controllo e prevenzione della tratta e dei viaggidi immigrazione clandestina, nel sostegno alle azioni sociali di integra-zione delle fasce giovanili, disoccupate ed emarginate a maggior rischiodi emigrazione, ecc.
Dovrei presentare alcuni esempi particolarmente significativi, ma iltempo è tiranno e non mi dilungo oltre. Concludo ricordando a tutti che aBari, il 22 e 23 di questo mese, nell’ambito del semestre di Presidenza i-taliana dell’Unione Europea, si terrà una conferenza euromediterraneaproprio su questo tema: il ruolo dei governi territoriali europei, mediterra-nei e balcanici rispetto ai movimenti migratori. Poco dopo, a Tunisi, il 17e 18 novembre, il sistema regionale parteciperà ad un’altra importanteconferenza euromediterranea promossa dai sindacati italiani, tramite laUIL, da quelli europei, tramite la CES, e di quelli nordafricani sulle pro-blematiche del lavoro, dell’occupazione e quindi anche delle migrazioni.
235
ROGERBRIESCH
Presidente del CESE
Signor Presidente, signore e signori,
anzitutto desidero ringraziarvi per il vostro invito a questo conve-gno tanto importante quanto interessante.
Non serve che mi dilunghi sull’importanza del tema scelto dalCNEL, in quanto esso è già stato oggetto di numerosi interventi moltopertinenti. Si tratta, invero, di un tema di portata comunitaria che nonpuò limitarsi a un esame su scala nazionale. Pertanto, sono lieto che ilconvegno odierno sia stato organizzato nel quadro della Presidenza ita-liana, tanto più che quest’ultima ha fatto della politica in materia di im-migrazione e di asilo una delle sue priorità per il secondo semestre del2003. La Presidenza italiana desidera soprattutto contribuire alla defini-zione di norme comuni in materia di asilo, all’intensificazione dei rap-porti di collaborazione con i Paesi di origine e di transito dei flussi mi-gratori e al miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri inmateria di visti.
Quest’oggi, perciò, eviterò di soffermarmi sui suddetti aspetti del-l’immigrazione, pur riconoscendone l’assoluto carattere di urgenza, perconcentrarmi invece soprattutto sulla dimensione sociale del problema,dimensione che il Comitato Economico e Sociale Europeo ha messo inparticolare rilievo nel quadro dei propri lavori.
Il vostro gentile invito a questo convegno contribuisce ad avvici-nare ulteriormente il CNEL e il Comitato Economico e Sociale Euro-
238
peo. Tra le nostre due istituzioni esiste una stretta collaborazione nelquadro delle riunioni regolari dei consigli economici e sociali degli Statimembri dell’Unione Europea e nell’ambito della nostra - AssociazioneInternazionale Mondiale, ma quando è possibile manteniamo anche unacooperazione bilaterale alla quale teniamo in particolar modo. Inoltre,considero molto importante e attendo con impazienza il convegno suivari aspetti dell’ampliamento dell’Unione Europea che il CNEL e il CE-SE organizzeranno di concerto il 24 novembre qui a Roma, e che rappre-senterà il nostro contributo comune al semestre di presidenza italiana.
Prima di entrare nel vivo dell’argomento, consentitemi di approfit-tare della mia presenza nella città in cui è appena iniziata la Conferenzaintergovernativa relativa al progetto della Convenzione sulla futura Co-stituzione Europea, per dire alcune parole sulle nostre aspettative ed e-sigenze nei riguardi della Conferenza stessa e della Costituzione su cuiessa si dovrà pronunciare.
Per quanto riguarda le nostre aspettative, mi limiterò a due osser-vazioni: in linea generale approviamo il progetto di Costituzione redattodalla Convenzione. Si tratta infatti di un importante passo avanti nellamisura in cui apporta un valore aggiunto all’Unione Europea in terminidi democrazia, di chiarezza e di visibilità. Il nostro auspicio è che i Capidi Stato e di Governo, come pure i ministri degli Affari Esteri, abbianola saggezza di non mettere in discussione il consenso delineatosi in se-no alla Convenzione e di non modificare le formule e le disposizionicontenute nel progetto, in quanto ciò potrebbe pregiudicare l’equilibrioistituzionale raggiunto.
Ciò non esclude peraltro la possibilità di migliorare taluni aspettidel testo con una serie di aggiunte e precisazioni. Ci riferiamo in parti-colare ai cinque punti seguenti, che ai nostri occhi rivestono un’impor-tanza di spicco, in quanto potrebbero precisare maggiormente la volon-tà della Convenzione di promuovere il dialogo tra istituzioni e societàcivile.
l. Anzitutto chiediamo che il nome della nostra istituzione vengamodificato in “Consiglio Economico e Sociale Europeo”.
Questa nuova denominazione mira a sottolineare meglio il caratte-re europeo del Comitato e la sua specificità nel quadro istituzionale del-
239
l’Unione, distinguendolo, da un lato, dai suoi omologhi nei vari Statimembri e, dall’altro, dai molteplici comitati settoriali, consultivi o di al-tro genere, che gravitano intorno alle istituzioni.
2. In secondo luogo, rivendichiamo la necessità di inserire gli or-gani consultivi nel novero delle istituzioni e degli organi che costitui-scono “il quadro istituzionale dell’Unione”.
Il Comitato Economico e Sociale Europeo e il Comitato delle re-gioni contribuiscono, a tutti gli effetti e nell’ambito delle competenze lo-ro attribuite dalla Costituzione, al conseguimento degli obiettivi di cui alparagrafo I dell’articolo 18. Dato che essi consentono alla società civileorganizzata e agli enti territoriali di partecipare effettivamente ai proces-si di formazione, di attuazione e di controllo delle politiche comunitarie,concorrono altresì ad accrescere la legittimità democratica dell’Unionenell’interesse generale della stessa e degli Stati membri, ai sensi dell’ar-ticolo 1-31 del progetto di Costituzione. Questi due comitati consultiviformano quindi parte integrante del quadro istituzionale unico dell’U-nione e andrebbero menzionati al paragrafo 2 dell’articolo 18.
3. In terzo luogo, insistiamo sulla necessità di rispettare il princi-pio di parità con il Comitato delle regioni, e chiediamo in particolareche anche al Comitato Economico e Sociale Europeo venga attribuitoun diritto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia affinché possa salva-guardare le proprie prerogative.
Il CESE e il CdR rappresentano due dimensioni distinte, ma aven-ti pari importanza, della realtà europea e della vita democratica dell’U-nione, e assumono una diversa funzione di rappresentanza che investe,per il primo organo, la società civile organizzata e, per il secondo, glienti territoriali. È quindi necessario che essi vengano trattati a parità dicondizioni e che beneficino dei medesimi diritti in base alle loro prero-gative.
4. In quarto luogo, proponiamo l’inserimento di un nuovo articolotale da precisare il mandato e le funzioni del CESE, formulato comesegue:
“Nel quadro della funzione consultiva conferitagli dall’articolo 1-31 della Costituzione, il Consiglio Economico e Sociale Europeo”:
240
- assiste le istituzioni legislative ed esecutive dell’Unione nel processodi formazione delle politiche e delle decisioni, come pure nella loroattuazione,
- assiste la Commissione e le Parti sociali nell’organizzazione del dialo-go sociale nel rispetto della loro autonomia,
- facilita il dialogo tra l’Unione e le organizzazioni rappresentative dellasocietà civile, conformemente ai principi stabiliti all’articolo 1-46,
- accompagna l’azione esterna dell’Unione mantenendo il dialogo conle organizzazioni della società civile dei Paesi e insiemi geograficiterzi”.
Il CESE costituisce uno strumento di rafforzamento della legitti-mità democratica dell’Unione, giacché consente alle organizzazioni del-la società civile di essere davvero parte integrante del processo di defi-nizione delle politiche e di preparazione delle decisioni comunitarie. U-na formulazione come quella proposta permetterebbe di definire chiara-mente le funzioni del Comitato e rappresenterebbe inoltre un utile com-plemento alle norme relative agli organi consultivi e alla vita democra-tica dell’Unione.
5. Infine, chiediamo di estendere gli ambiti che formano oggetto diconsultazione obbligatoria del Comitato Economico e Sociale Europeoagli aspetti seguenti:
- l’applicazione del principio di non discriminazione,
- i grandi orientamenti delle politiche economiche,
- la cultura,
- e infine, beninteso, la politica comune in materia d’asilo e d’immigra-zione.
Si tratta infatti di settori nei quali il CESE, data la sua composizio-ne e la competenza dei suoi membri, apporta sin d’ora, sia nel quadro diconsultazioni facoltative sia di propria iniziativa, un contributo impor-tante e riconosciuto. Il fatto di prevedere per tali settori una consulta-zione obbligatoria significherebbe riconoscere chiaramente questo ap-porto e contribuirebbe ad aumentare la visibilità del suo intervento in
241
questi ambiti; inoltre, darebbe concretezza all’intento dell’Unione dirafforzare ulteriormente la legittimità democratica delle politiche comu-nitarie.
Caro Presidente, signore e signori, care amiche e amici!
Giungo così finalmente al tema del nostro convegno, la politica diimmigrazione e asilo, e alle posizioni assunte in materia dal ComitatoEconomico e Sociale Europeo. Le osservazioni formulate finora dalCESE a questo riguardo testimoniano chiaramente la scelta risoluta ditrattare questi temi sullo sfondo della dimensione sociale della costru-zione europea.
Il CESE, in quanto rappresentante istituzionale della società civileorganizzata, ha fatto presente in varie occasioni che confida nella co-struzione di un’Europa dei cittadini, nella consapevolezza che un tale o-biettivo richiede un atteggiamento favorevole all’integrazione dei citta-dini dei Paesi Terzi che vivono nell’Unione Europea, giacché l’Europadei cittadini non può essere costruita discriminando parte della popola-zione.
In materia di immigrazione e asilo, abbiamo discusso e adottato u-na lunga serie di pareri in risposta alle proposte che la Commissione an-dava via via elaborando.
La posizione adottata dal CESE è stata quella di sostenere senzariserve lo slancio impresso dalla Commissione Europea all’attuazionedi politiche e normative comunitarie in tema di immigrazione e di asilo,nella convinzione che dovranno servire a correggere le tendenze attual-mente dominanti negli Stati membri.
Questa posizione del CESE si è andata consolidando a misura chesi osservava lo scarso entusiasmo del Consiglio dei Ministri della Giu-stizia e degli Affari interni nell’approvare le proposte della Commissio-ne in materia.
Le restrittive politiche d’immigrazione condotte dagli Stati mem-bri dell’Unione nel corso degli ultimi 25-30 anni hanno avuto l’effettodi favorire l’aumento dell’immigrazione clandestina.
Una gran quantità di immigrati in cerca di lavoro è entrato illegal-mente, il che ha portato al permanere all’interno delle nostre frontieredi un considerevole numero di persone in una situazione irregolare.
242
Ciò non toglie che il lavoro di queste persone abbia contribuito al-lo sviluppo di alcuni settori della produzione.
La maggioranza dei responsabili politici e dei ricercatori ammetteoggi che l’immigrazione verificatasi in Europa per morivi di lavoro haapportato un importante contributo alla nostra economia.
La nostra idea al riguardo è che la nuova politica dei flussi migra-tori debba comprendere azioni condotte parallelamente su due fronti dicruciale importanza: da un lato, l’apertura di vie d’accesso legali e, dal-l’altro, la lotta contro le cause profonde che favoriscono l’immigrazioneclandestina.
A giudizio del CESE, la politica dell’immigrazione è da correlarestrettamente a quella del lavoro, il che implica la necessità sia di raffor-zare le azioni volte ad accrescere gli sbocchi occupazionali (attraversola formazione) di quanti cercano lavoro sia di sviluppare le politiche afavore delle pari opportunità.
Per quanto riguarda i piani d’azione nazionali per l’occupazione, ènecessario includervi le previsioni relative ai flussi migratori e far sìche tutte le parti sociali partecipino attivamente alle decisioni in materiadi politica dell’immigrazione.
Nel corso dell’ultimo decennio, le società europee, le loro istitu-zioni pubbliche e le loro organizzazioni sociali hanno riconosciuto chegli immigrati erano destinati soprattutto ad integrarsi nella società ospi-tante.
Nondimeno, siamo ancora lontani da una piena accettazione diquesta realtà da parte delle società europee.
Restano infatti alcuni ostacoli all’esercizio del diritto al ricongiun-gimento familiare e al conseguimento del permesso di soggiorno per-manente. I diritti civili, sociali e politici degli immigranti non sono glistessi di cui benefici ano i cittadini originari del Paese di accoglienza.
La parità di opportunità e di trattamento è lungi dall’essere effettiva.
Inoltre, le politiche sociali volte a combattere la discriminazione ea promuovere l’integrazione sociale sono quanto mai diversificate: seinfatti talune istituzioni (comuni, governi regionali o nazionali) le attua-no dagli anni ‘70, altre non le hanno neanche in previsione.
243
Il concetto stesso di integrazione sociale non ha il medesimo signi-ficato per tutti, specie quando è legato ad aspetti culturali.
Pertanto, il CESE ha definito una nozione di integrazione che met-te in secondo piano gli aspetti culturali e dà invece la priorità ai dirittidi cittadinanza.
In base a tale approccio, l’integrazione è definita come “la pro-gressiva equiparazione degli immigrati al resto della popolazione perquanto riguarda i diritti e i doveri, l’accesso ai beni, ai servizi e alle basidella partecipazione civile a condizioni di parità di opportunità e di trat-tamento”.
Questa impostazione civica e non culturale dell’integrazione socia-le si accompagna a una visione molto positiva della diversità culturale.
Il Comitato fa presente al riguardo che la diversità culturale è unacaratteristica specifica dell’Europa democratica e pluralistica, e che es-sa risulta arricchita attraverso l’immigrazione.
Gran parte delle azioni a favore dei diritti e dell’integrazione so-ciale degli immigrati e dei profughi è stata promossa dalle organizza-zioni sociali.
Sarebbe opportuno che tale sinergia continuasse, poiché è impen-sabile far progredire l’integrazione sociale senza un forte impegno dellasocietà civile organizzata.
È tuttavia vero che, a questo scopo, si rende indispensabile unamaggiore coerenza tra l’operato di queste organizzazioni e quello delleistituzioni pubbliche.
Inoltre, le organizzazioni della società civile devono poter disporredi maggiori dotazioni finanziarie per esercitare le proprie attività.
L’importanza dell’intervento delle organizzazioni sociali riguardaanzitutto la fase della prima accoglienza degli immigrati o dei profughi:questi ultimi, infatti, si rivolgono in primo luogo ad associazioni o a co-munità di conterranei che a loro volta li instradano nel processo di inte-grazione nella società d’accoglienza, con l’appoggio di organizzazioniche forniscono loro determinati servizi (ONG, sindacati, ecc.).
Questo sostegno viene spesso visto dagli immigrati e dai profughicome la prova che non tutto osta alla loro presenza nella società di ac-
244
coglienza, il che di conseguenza accentua la loro predisposizione all’in-tegrazione sociale.
Le organizzazioni che intervengono nella fase della prima acco-glienza devono poter contare su un sostegno istituzionale, affinché ogninuovo arrivato abbia accesso ai servizi necessari alla propria integrazio-ne: consulenza giuridica, corsi di lingua e alloggio, se necessario, orien-tamento socio-professionale, ecc.
Non bisogna infatti dimenticare che un cattivo inserimento nelleprime fasi di arrivo in una nuova società conduce all’isolamento e all’e-sclusione sociale, il che a sua volta ritarda considerevolmente il proces-so d’integrazione sociale.
L’inserimento professionale è un altro aspetto di importanza pri-mordiale, in quanto il lavoro è non solo il mezzo che consente di pro-cacciarsi tutti gli altri beni, ma anche il principale collante nell’ambitodelle relazioni sociali.
Le parti sociali, che gestiscono in ampia misura il funzionamentodel mercato del lavoro e figurano fra i cardini della vita economica esociale europea, hanno un ruolo importante da svolgere per favorirel’integrazione degli immigrati. Ciò non toglie che sul mercato del lavo-ro e sul piano delle modalità di lavoro gli immigrati siano soggetti acondizioni contrastanti con le norme professionali e sociali in vigore,come pure a forme inaccettabili di discriminazione.
È necessario quindi che, nel quadro delle contrattazioni collettivee dei rapporti lavorativi, le parti sociali assumano la responsabilità chespetta loro in materia di integrazione degli immigranti.
A tal fine, esse dovranno promuovere l’esclusione di ogni formadiretta o indiretta di discriminazione dai contratti collettivi, come puredalle legislazioni e dalle pratiche professionali.
La discriminazione può essere riferita al sesso, all’origine etnica oalla nazionalità, alla cultura, alla religione, all’età, ecc. In molti casi, gliimmigrati accumulano parecchi fattori di discriminazione.
Il Comitato Economico e Sociale propone alle parti sociali nel con-testo europeo di esaminare, nel quadro del dialogo sociale, la possibilitàdi promuovere accordi sociali e iniziative per favorire l’integrazione de-gli immigranti attraverso sia il miglioramento delle relazioni e delle
245
condizioni di lavoro, sia l’eliminazione di ogni forma di discriminazio-ne.
Al riguardo bisognerà in ogni caso tenere conto dei differenti si-stemi di contrattazione collettiva, di relazioni industriali e di sicurezzasociale esistenti negli Stati membri.
Inoltre, all’interno di tutti questi sistemi, sarà necessario che leparti sociali a vari livelli - Stato, regione, settore, impresa - creino stru-menti di valutazione e negoziazione per incoraggiare l’integrazione de-gli immigranti nel mondo del lavoro.
La formazione continua è uno strumento essenziale per favorire u-na reale eguaglianza degli individui sul mercato del lavoro.
Le parti sociali devono rafforzare la loro azione affinché gli immi-grati abbiano accesso alla formazione continua a parità di condizionicon i cittadini dei Paesi ospitanti.
L’ignoranza delle lingue parlate nella società di accoglienza costi-tuisce un ulteriore ostacolo all’accesso degli immigrati alla formazionecontinua e al lavoro: pertanto, occorrerà prevedere azioni specifiche diformazione continua destinate agli immigrati allofoni.
Molte persone incontrano problemi, nel corso della loro carrieraprofessionale, per via della loro condizione di immigrati.
Di conseguenza, le parti sociali devono adoperarsi per incoraggia-re, nei vari settori, una reale eguaglianza nello svolgimento delle carrie-re professionali e nell’evoluzione salariale di tutti i lavoratori, senza al-cuna forma di discriminazione.
L’accesso all’alloggio e la distribuzione dello spazio urbano in for-ma da evitare la discriminazione e la segregazione sono altri due aspettichiave che devono essere oggetto di una cooperazione fra istituzionipubbliche e organizzazioni sociali.
L’accesso al sistema scolastico per i figli di immigrati e profughideve essere garantito a parità di condizioni sin dalla fase prescolastica.
Per garantire siffatte condizioni sarà spesso necessario dedicareparticolare attenzione alla scolarizzazione dei minori, combattendo ogniforma di discriminazione e destinando maggiori risorse a quegli istitutiscolastici che devono confrontarsi con situazioni di integrazione tardivao con altri problemi specifici.
246
I sindacati, così come le associazioni di insegnanti e dei genitori,sono investiti di una grave responsabilità in materia e devono aprirsi al-la partecipazione degli immigrati e dei profughi.
I servizi sanitari e sociali devono essere pienamente accessibili a-gli immigrati e ai profughi.
Inoltre, poiché sono spesso le ONG o le organizzazioni a caratterereligioso che agevolano loro l’accesso a tali servizi, esse vanno dotatedelle risorse necessarie a questo compito.
Nel processo di integrazione sociale, le istituzioni e le organizza-zioni religiose svolgono un ruolo importante sia perché favoriscono ilegami fra le comunità di immigrati e di profughi, sia per la loro capaci-tà di promuovere i valori umanitari e di solidarietà.
Il ruolo svolto dalla società civile nell’integrazione degli immigra-ti e dei profughi è dunque, come si può constatare, della massimaimportanza.
Pertanto, la sua azione deve essere corroborata da interventi delleistituzioni pubbliche che vadano nello stesso senso.
Pochi progressi sono possibili quando le organizzazioni sociali e-sercitano sforzi considerevoli per l’integrazione, mentre i governi adot-tano politiche d’asilo e d’immigrazione penalizzanti, discriminatorie olesive dei diritti degli immigrati e dei profughi. Le società europee de-vono ammettere che il miglior modo per favorire l’integrazione socialeè evitare gli interventi capaci di provocare l’esclusione sociale, e a suavolta questa constatazione deve condurre a una verifica delle politiched’immigrazione e d’asilo.
Care amiche, cari amici!
Per terminare, desidero richiamare la vostra attenzione sul legameesistente tra gli sforzi volti a elaborare una Costituzione trasparente, de-mocratica e federale per l’Unione Europea e quelli finalizzati all’ado-zione di una politica equa, solidale e responsabile in materia di immi-grazione e asilo. Questo legame a mio avviso si presenta sotto una du-plice ottica.
In primo luogo, la Costituzione consoliderà sensibilmente il siste-ma politico della nostra Unione, non solo perché il suo quadro istituzio-
247
nale ne uscirà rafforzato e quindi più saldo, ma anche perché lo Stato didiritto risulterà più forte e la sicurezza giuridica maggiore. La fiduciadei cittadini nell’Unione è anch’essa destinata a crescere: a loro giudi-zio, infatti, l’Unione sarà sempre più in grado di affrontare i problemiche gli Stati membri ormai non possono risolvere o possono risolveresolo in modo insoddisfacente. Questa situazione andrà a vantaggio inparticolare della capacità dell’Unione di dare risposta a problemi com-plessi e delicati, come la gestione degli immigrati e dei richiedenti asi-lo, nella misura in cui gli Stati membri saranno sempre più propensi arichiedere e ad accettare soluzioni comunitarie.
In secondo luogo, forte di una Costituzione democratica che neconferma la legittimità, ne consolida l’identità e ne accresce la capacitàd’azione nei riguardi del mondo esterno, l’Unione Europea potrà adot-tare le necessarie iniziative politiche nei settori della pace e dello svi-luppo al fine di neutralizzare il problema dell’immigrazione e dell’asilosul proprio territorio. Il miglior modo per affrontare un problema consi-ste infatti nel prevenirlo.
248
STEFANO CETICA
Segretario Generale dell’UGL
Il 2004 è un anno di fondamentali cambiamenti per l’Unione. Lafirma ad Atene del trattato di adesione ha aperto la strada a dieci nuoviStati membri. Questo allargamento, il più grande mai verificatosi nel-l’Unione Europea, costituisce un importante cambiamento e, allo stessotempo, la sfida per l’Unione che deve prepararsi, riformando le propriestrutture e il loro funzionamento per renderle più comprensibili e piùefficaci.
Il Consiglio, inoltre, nel 2004 dovrà concentrarsi sul rinvigorimen-to della coesione economica e sociale dell’Europa e sulla promozionedello sviluppo sostenibile.
Soprattutto esiste la concreta possibilità che, proprio a Roma, vedala luce la Costituzione Europea nell’ambito della Conferenza intergo-vernativa che sta per aprire i suoi lavori.
L’Unione a venticinque rappresenterà uno scenario inedito anchedal punto di vista del fenomeno dell’immigrazione.
Molti immigrati provenienti proprio dai 10 nuovi Stati membri di-verranno, a pieno titolo, cittadini dell’Unione; le frontiere “esterne”cambieranno rendendo necessario un nuovo approccio per la lorogestione.
La massima priorità, dunque, dovrà essere riservata all’attuazionerapida e completa delle decisioni prese dal Consiglio Europeo di Sivi-glia nei settori dell’asilo e dell’immigrazione e del controllo delle fron-
249
tiere esterne quali parti del processo volto a rendere l’area di Shengenuno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.
Nella nuova “grande” Europa, inoltre, dovrà essere assicurata, e ladata stabilita coincide con la fine del 2003, una efficace attuazione agliimpulsi impartiti attraverso la firma del Trattato di Amsterdam, checonferiva alle istituzioni europee, la facoltà di prendere provvedimentilegislativi allo scopo di combattere ogni forma di discriminazione, epertanto anche quelle attuate nel settore lavorativo.
L’Europa del futuro dovrà essere uno spazio di sicurezza e giusti-zia sociale, in cui l’ingresso sia disciplinato da norme certe ed efficacied in cui, parallelamente, la permanenza dello “straniero” sia tutelata egarantita, da diritti certificati e rispettati, anche e soprattutto in ambitolavorativo.
Le migrazioni costituiscono un fenomeno di dimensioni epocali,che nasce da squilibri economici e demografici del pianeta, destinati nelfuturo ad intensificarsi, che va inquadrato in un contesto globale.
Per questo, in materia di immigrazione regolare, l’impegno del no-stro Sindacato sarà rivolto alla cooperazione con i Paesi di provenienzadegli immigrati, per fare in modo di risolvere le complesse questioni e-conomiche e politiche, che sono alla base di questo fenomeno.
A riguardo del tema dell’integrazione sociale dei cittadini immi-grati e dei lavoratori extracomunitari, Unione Generale del Lavoro hacreato uno specifico sindacato, il Sei (Sindacato Emigrati ed Immigra-ti), che è il primo sindacato per immigrati ed emigrati nato in Italia. Lanostra organizzazione sindacale considera la presenza dei cittadini stra-nieri e dei lavoratori extracomunitari regolari nel nostro Paese come u-na ricchezza che deve essere tutelata.
La UGL, infatti, da sempre si batte per il rispetto dei diritti lavora-tori, indipendentemente dalla loro provenienza.
In Italia ci sono circa un milione e mezzo di stranieri, cifra di pocoinferiore al 3% della popolazione, la metà in meno rispetto alla mediadei Paesi dell’Unione. Non riconosciuti, sfruttati, minoritari e spessocostretti ad accrescere il numero di lavoratori in nero (il 30% del totaledegli irregolari, secondo le nostre stime), gli stranieri faticano ad inte-grarsi.
250
L’Italia, che negli Anni 20 e nel Dopoguerra ha offerto alti contin-genti di immigrati alle Nazioni europee ed alle Americhe, si cura anco-ra poco della sorte riservata a coloro che vengono nel nostro Paese cer-cando un avvenire migliore per se stessi e per le proprie famiglie, comefecero un tempo i nostri connazionali.
Il SEI ha l’obiettivo di offrire un’assistenza agli stranieri sia all’e-sterno che all’interno delle imprese, di aiutarli nelle loro pratiche am-ministrative di regolarizzazione, di accompagnarli nelle loro sceltefinanziarie.
Queste, infatti, sono le problematiche reali, di cui il nostro sinda-cato ha voluto assumersi l’onere, per garantire una tangibile ed effettivaintegrazione degli immigrati.
Il Sindacato Emigrati ed Immigrati verifica che, tra italiani e stra-nieri, sia garantita l’equità di trattamento principalmente nelle condizio-ni di lavoro e di remunerazione, secondo la normativa vigente, rafforza-ta anche dai due nuovi decreti legislativi: il D.Lgs. n. 215/2003 ed ilD.Lgs. n. 216/2003 entrati in vigore rispettivamente il 12 e 13 agosto,di attuazione delle direttive europee 2000/43/CE e 2000/78/CE, controla discriminazione diretta ed indiretta, che stabiliscono un quadro gene-rale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizio-ni di lavoro ed hanno lo scopo di realizzare una società in cui tutti ab-biano le stesse possibilità di esprimere le proprie potenzialità e svolgereappieno il proprio ruolo all’interno della comunità.
Tutto ciò necessita di una condotta equa da parte del datore di la-voro ed in genere dell’ambiente lavorativo, di un trattamento che tengaconto esclusivamente delle reali capacità lavorative dì ogni individuo enon delle sue caratteristiche etniche.
Le modalità attraverso cui si esprime l’eguaglianza di trattamentosono molteplici: vanno dall’accesso all’impiego, alle condizioni di la-voro, all’ammontare della retribuzione, al trattamento pensionistico, maincludono anche la possibilità di accedere a corsi di formazione ed ag-giornamento, l’assistenza sanitaria o la possibilità di affittare, ad esem-pio, una casa.
D’altra parte, l’azione propositiva dell’UGL è orientata alla pro-mozione di un approccio bilanciato tra la corretta gestione dell’immi-
251
grazione regolare ed un rinnovato impegno alla lotta all’immigrazioneclandestina.
Giova evidenziare che il nostro Paese nei prossimi mesi sarà ingrado di adottare il permesso di soggiorno elettronico, che consentirà disnellire le procedure, ridurre i tempi di rilascio del documento e identi-ficare immediatamente gli extracomunitari che hanno un contratto di la-voro e quindi in base alla legge hanno diritto di risiedere in Italia.
Il Permesso di Soggiorno Elettronico rappresenta uno strumento digaranzia per gli extracomunitari immigrati in Italia, allo stesso mododella Carta d’Identità Elettronica per i cittadini italiani, poiché è fonda-to sul principio di integrazione e di uguaglianza tra italiani e stranieriresidenti sul territorio nazionale.
L’obiettivo che l’Unione Generale del Lavoro intende perseguire,quindi, è quello di una immigrazione regolare che riesca ad integrarsipienamente nella società civile, e di un rispetto imprescindibile dei di-ritti fondamentali, della giustizia e dell’equità su tutto il suolo europeo,per tutti coloro che vi risiedano, temporaneamente o a tempo indetermi-nato, qualunque sia la loro provenienza o la loro cittadinanza.
252
MASSIMO VIVOLI
Vicepresidente Vicario della Confesercenti
I fenomeni migratori raccontano la storia dell’uomo: uomini in fu-ga dalla povertà, dalle guerre, dalle dittature, dagli squilibri demografi-ci, verso una terra promessa. Quella famosa “America”, tante volte vi-sta in TV, che rappresenta la speranza di una vita migliore.
Una dinamica che incrocia i grandi problemi delle società contem-poranee e della globalizzazione e che per questo necessita di un approc-cio politico, culturale e sociale di grande complessità.
Basta guardare il “caso” italiano per rendersene conto.
Nel 1989 si contavano in Italia 600.000 immigrati, oggi se ne con-tano oltre 2.500.000 con un incremento medio di circa 140.000 immi-grati ogni anno.
Tale aumento è dato dalla forte pressione migratoria provenienteda quei Paesi e da quelle zone in cui gli assetti sociali ed economici sisono modificati in conseguenza dei grandi sconvolgimenti socio-politi-ci, pensiamo all’Europa dell’Est, ma anche delle guerre e della povertà.
Non è un caso quindi che a metà degli anni novanta, quando ini-ziarono gli sbarchi di massa in Italia, a valicare le nostre frontiere eranoin maggioranza uomini, donne e bambini provenienti dai Paesi dell’Est,mentre oggi a costoro si sono sostituiti curdi, iracheni e palestinesi invirtù degli eventi bellici e dell’alto livello di instabilità che contrasse-gna il Medio Oriente.
Questo approccio è essenziale se si vuole dare una risposta di “go-
253
verno” ai fenomeni migratori, che rifugga dalla propaganda e dallademagogia.
Un sano realismo è necessario. I singoli Stati possono intensificarei controlli alle frontiere, ma non possono impedire che l’avvento di re-gimi dittatoriali, la nascita di movimenti fondamentalisti, o la diasporacausata da eventi bellici, piuttosto che dalla fame o dalla siccità, provo-chino nuovi flussi di richiesta d’asilo o semplicemente esodi di massa.
Senza sottovalutare che le società mature hanno bisogno di mano-dopera immigrata per mantenere alti standard di sviluppo e di crescita,sia pure in condizioni di sicurezza.
In virtù di questa premessa, si è andato sempre più affermando unapproccio comune europeo al problema delle politiche migratorie. Ciòha rappresentato una delle novità degli ultimi decenni.
La logica del processo di integrazione europea comporta, indub-biamente, il passaggio da una forma di cooperazione sempre più siste-matica ed organizzata tra Stati in materia migratoria ad una vera e pro-pria politica comune elaborata da istituzioni comuni.
Ma tale trasformazione strutturale implica un’evoluzione altrettan-to profonda dei presupposti culturali europei rispetto a queste stesse po-litiche. Nel corso degli anni Novanta si è ceduto il passo ad una visionearticolata del fenomeno migratorio che combina obiettivi di controllo edi prevenzione dei flussi ad un coinvolgimento sempre maggiore deiPaesi di origine; approccio che prende in considerazione le connessionitra movimenti migratori e processi di integrazione e che mira ad elimi-nare o quantomeno attenuare le cause profonde dell’immigrazione.
Tre sono le tendenze registrate negli orientamenti dei Governieuropei:
• la progressiva convergenza su politiche orientate al controllo dell’im-migrazione: politiche difensive-restrittive dei flussi di ingresso;
• la crescente esigenza di cooperazione internazionale nella gestione deiprocessi migratori, in particolare con i Paesi di origine;
• la tendenza a coordinare la politica migratoria con altre politiche set-toriali: dalla cooperazione allo sviluppo, alla politica commerciale, daquella ambientale a quella della sicurezza, dalla promozione dei dirittiumani alla prevenzione dei conflitti.
254
Questo nuovo approccio dell’Unione al fenomeno dell’immigra-zione, chiamato “approccio integrato”, si rifletterà inevitabilmente sullapolitica estera e sulle grandi strategie dell’Unione. La dimensione mi-gratoria assume, infatti, un rilievo crescente non solo nel quadro di al-largamento dell’Unione ad un vasto numero di Stati dell’Europa centra-le, orientale e mediterranea, ma anche in un ambito assai più ampio, checomprende il Parlamento Euro-Mediterraneo, il Patto di stabilità perl’Europa sud-orientale, i rapporti di libero scambio con i Paesi della co-sta africana del mediterraneo dal 2010.
Le decisioni del Consiglio Europeo sulla creazione di uno spaziodi libertà e sicurezza, almeno da Tampere (15-16 ottobre 1999), hannoconfermato pienamente la volontà di procedere alla costituzione di unapolitica migratoria europea attiva, che rientra nell’ambito della realiz-zazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, obiettivo colloca-to al primo posto nell’Agenda del Consiglio.
Inoltre, con il Trattato di Amsterdam, i Paesi hanno di fatto cedutosu questa materia e quella del diritto d’asilo una parte della loro sovra-nità alla Comunità, che dal 2004 potrà decidere a maggioranza qualifi-cata dei componenti dei Governi.
La necessità che l’Unione elabori politiche comuni in materia diimmigrazione e asilo viene fondata sul fatto che la “libertà non dovreb-be, tuttavia, essere considerata appannaggio esclusivo dei cittadini del-l’Unione, “ma anche di coloro che” siano stati legittimamente indottidalle circostanze a cercare accesso nel nostro territorio”. Gli elementisu cui dovrà fondarsi la politica comune europea debbono riguardare:
- il partenariato con i Paesi d’origine
- un regime europeo comune in materia di asilo
- equo trattamento dei cittadini dei Paesi Terzi
- gestione dei flussi.
In questo modo verrà delineata una strategia globale e integratache pone il controllo dei flussi in relazione con le azioni sulle cause del-le migrazioni e la tutela dei diritti umani. Ciò significa che occorre agi-re concretamente, nei Paesi di provenienza degli immigrati, per concor-rere a combattere la povertà, migliorare le condizioni di vita e le oppor-
255
tunità di lavoro, prevenire i conflitti, stabilizzare gli stati democratici,garantendo il rispetto dei diritti umani.
Temi questi che troveranno cittadinanza nella Carta dei diritti fon-damentali dell’Unione Europea.
Questa politica si sta affermando anche nell’indirizzo concreto cheil Ministro dell’Interno del nostro Paese sta dando all’attuazione dellaLegge Bossi-Fini, con un atteggiamento più pragmatico che tiene contodei problemi della sicurezza non disgiunti però dalla necessità, avvertitadal sistema delle imprese, di garantire quella manodopera essenziale al-la crescita del Paese.
In base alle stime più recenti in Italia vivono quasi due milioni emezzo di immigrati, una cifra che supera il 4% della popolazione: que-sto vuol dire che con gli arrivi tumultuosi che hanno caratterizzato ilnostro Paese nell’ultimo decennio ci siamo avvicinati, e in alcuni casiabbiamo superato, Paesi che possono contare su fenomeni migratori diben più vecchia data.
Evidentemente un arrivo così massiccio di immigrati, spinti in Ita-lia principalmente dal desiderio di emancipare le proprie condizioni divita, ci ha posto una serie di problemi, innanzitutto di accettazione delfenomeno, poi di collocazione lavorativa dei nuovi arrivati e infine dipiena integrazione degli stessi all’interno del tessuto sociale.
Va anche detto con chiarezza che ormai il tasso di immigrazione siva standardizzando ed anche l’immigrazione clandestina e irregolare,malgrado gli sbarchi che si succedono anche in questi giorni, ha persoquel carattere di emergenza che per largo tempo ha animato il dibattitopolitico italiano.
Del resto, come è stato autorevolmente affermato, non può esistereun’immigrazione non conflittuale e quindi il conflitto sull’immigrazio-ne non va drammatizzato.
Al di là di alcune deformazioni ed esagerazioni, possiamo affer-mare che gli immigrati si sono inseriti a pieno titolo e senza produrrealcuna tensione sociale all’interno dei circuiti lavorativi: ne sono unaprova le 702.156 domande di regolarizzazione pervenute al Ministrodell’Interno nel novembre 2002; le 659.847 assunzioni registrate dall’I-nail per il 2002, pari all’11,5% del totale (con una crescita di due punti
256
percentuali rispetto all’anno precedente), i 125.457 imprenditori extra-comunitari, gli 80.000 lavoratori in agricoltura, pari a circa il 10% deltotale. Di pari passo non vi è indagine sociologica che non confermi co-me all’interno del corpo sociale e delle imprese abbia ormai preso il so-pravvento l’opinione che gli stranieri rappresentino manodopera di cuinon possiamo fare a meno, quantomeno per quei lavori che gli italianinon sono più disposti a svolgere.
Se problemi di integrazione si pongono è quando lo straniero fuo-riesce dall’oscurità della collocazione lavorativa di una casa o di un’a-zienda per usufruire degli spazi pubblici e partecipare alla vita colletti-va.
Ma questo è un problema che va affrontato con specifiche politi-che sociali, chiamando in causa in prima persona gli Enti locali.
L’economia del nostro Paese, e di tutti i Paesi Europei dell’areamediterranea, è centrata sull’ espansione di alcuni settori occupazionali(commercio, turismo, servizi alla persona) e sulla presenza di alcunicompari tradizionali (agricoltura, pesca, costruzioni) che richiedonomanodopera flessibile, a buon mercato, disponibile alle richieste del da-tore di lavoro e alla mobilità, che trova nei lavoratori immigrati unafonte insostituibile e non solo nelle zone ad alta produttività e ad altotasso di occupazione.
Il sistema delle imprese quindi ha bisogno di manodopera: perqueste ragioni rivendichiamo da tempo la necessità di maggiore flessi-bilità e minori vincoli nel mercato del lavoro che riguarda i lavoratoristranieri, mentre chiediamo fermezza verso l’immigrazione clandestinae tutte quelle forme di irregolarità, a cominciare dall’abusivismo com-merciale, che nuocciono oltre che all’economia di intere aree territorialianche a virtuosi processi di integrazione sociale e culturale.
257
EDOARDO PATRIARCA
Forum Nazionale del Terzo Settore
Il Convegno promosso dal CNEL mi pare ci dia la possibilità di ri-prendere e riaprire un confronto serio ed ampio sul tema dell’immigra-zione. Il dibattito di questi mesi ha finalmente ridimensionato il “para-digma della sicurezza” che ha segnato il confronto politico nell’ultimoanno e che pure è importante (il giusto controllo delle frontiere per im-pedire le entrate illegali, il contrasto al traffico clandestino dei bambi-ni), per recuperare l’altro paradigma, non meno importante che è quellodella solidarietà. Le politiche improntate alla solidarietà si declinano at-traverso le parole integrazione, inclusione, promozione dei diritti e deidoveri di cittadinanza. Soprattutto va colto il fenomeno dell’immigra-zione non solo nei suoi aspetti problematici ma come opportunità e ri-sorsa per questo nostro Paese. Non si tratta di ridurre l’immigrazione,ma di aumentare quella regolare e di contrastare quella clandestina. Au-mentare quella regolare per gestire con serietà i flussi migratori e pergarantire un inserimento giusto a coloro che giungono in Italia da unaparte, e dall’altra per soddisfare il bisogno di manodopera e “mentedo-pera” richiesto dalle nostre aziende. L’inserimento di energie nuove, dicapacità di intrapresa, di culture assai diverse dalla nostra può ridare adun Paese di anziani e con uno dei tassi di natalità più bassi nel mondorespiro e capacità di pensare il futuro.
Ed allora mi preme qui riprendere e semplicemente tratteggiare alcu-ni punti che da sempre sono nell’agenda del Forum del Terzo Settore, conla speranza di contribuire in tal modo ad un dibattito fattivo e concreto.
258
La prima notazione riguarda le direttive dell’Unione Europea chesul tema indicano prospettive che non combaciano appieno con l’attualelegislazione in vigore in Italia. Questo gap, dopo una auspicabile verifi-ca sulla legge attualmente in vigore, andrebbe recuperato con urgenza.
Un primo elemento su cui occorre riflettere e riprendere con co-raggio riguarda le politiche di ricongiungimento familiare. Nel nostroPaese l’attuale Governo ha posto al centro delle politiche di welfare ilruolo, significativo e strategico, delle famiglie. Il Libro Bianco sul wel-fare va in questa direzione: ebbene come non essere coerenti nel favori-re il ricongiungimento delle famiglie degli immigrati! Ricongiungimen-to familiare vuol dire sostenere una buona ed utile integrazione e rico-noscere il prezioso contributo che queste famiglie possono svolgere nelriequilibrio generazionale del welfare italiano. Il ricongiungimento fa-miliare è il vero antidoto alla delinquenza degli adulti e dei minorennistranieri, ed è un elemento forte di coesione e di integrazione culturale.
In una recente ricerca del CNEL molti degli stereotipi che infor-mano l’opinione pubblica vengono letteralmente smontati: le donne chelavorano nelle famiglie italiane sono donne laureate, istruite, portatricidi valori e di un’esperienza di vita che può arricchire e ricostruire per-corsi che le famiglie italiane hanno da tempo perso: l’attenzione all’an-ziano come portatore di sapienza e di una memoria ancora utile ai gio-vani, e la premura educativa esigente, non accomodante, verso i figli.
Altrettanto importante credo sia riflettere sulla reintroduzione, pernoi auspicabile, dello sponsor prevista dalla precedente legge. A noi pa-re un istituto che nonostante alcuni abusi abbia dato i suoi buoni frutti.
Mi pare tuttora problematica se non ingiusta la stretta connessioneche intercorre tra perdita del lavoro e perdita, quasi contemporanea, delpermesso di soggiorno. Un approccio inutilmente punitivo che rischiadi creare precarietà, insicurezza e di incrementare la clandestinità.
La pur auspicata emersione del lavoro irregolare degli immigratinon ha dato tutti i frutti sperati: i dati, se ben ricordo fotografano il gaptra regolarizzazioni effettuate ed iscrizioni all’Inps. Un richiamo alla re-sponsabilità di tutte le forze sociali, in specie a quelle imprenditoriali,mi pare assai urgente.
Credo, ancora, sia importante rilanciare i percorsi di integrazione
259
che riguardano l’intero mondo. I tagli di risorse alla scuola e ai trasferi-menti agli enti locali non sono di buon auspicio: inevitabilmente i primiad esserne colpiti saranno i ragazzi provenienti dalle categorie socialpiù deboli: le persone disabili e i bambini di famiglie immigrate non piùsupportati nella fase iniziale assai delicata di inserimento scolastico.Questi ragazzi oggi sono più di 150.000.
Particolare cura andrà posta sui messaggi e sui programmi propo-sti dai media. Da anni il mondo del non profit svolge una opera silen-ziosa ma strategica di mediazione cultuale tra il sistema dei media e leculture dei migranti. I segnali però non sono confortanti: pochi gli spazidedicati; la stesa Rai vocata ad essere servizio pubblico, in questo ulti-mo anno, ha ridotto molte delle trasmissioni che raccontavano positiva-mente il mondo delle immigrazioni, senza nascondere difficoltà e disa-gi. Su questo annotiamo un netto arretramento che ci inquieta.
Riguardo il tema della cittadinanza dei diritti e dei doveri va ripre-sa con decisone e coraggio il tema del voto agli immigrati presenti daanni sul territorio italiano, almeno per le amministrative. Le risoluzionidel Parlamento europeo vanno in quella direzione, alcuni disegni di leg-ge sono depositati in Parlamento: perché non riprenderli in esame?
Ed infine: ritengo vada riconosciuto il ruolo essenziale che in que-sto campo hanno svolto le organizzazioni non profit italiane. Non solole forze dell’ordine, non solo le Prefetture: oggi chi svolge un ruolo di“cuscinetto”, di sportello ad orario continuato con gli immigrati sonoproprio le organizzazioni di volontariato e dell’intero terzo settore ita-liano.
Questo ruolo ritengo non sia stato riconosciuto adeguatamente: itavoli di concertazione sui quali incontrarci e condividere esperienze eanche immaginare nuove prospettive, non sono stati più convocati. L’e-sperienza dice che oggi, per avviare una effettiva integrazione nel no-stro Paese, occorre l’intervento e la presenza continua e assidua sui ter-ritori di quei corpi intermedi che la nostra Costituzione riconosce nelTitolo V, laddove appunto si parla di sussidiarietà orizzontale.
Integrazione vuol dire costruire sul territorio reti fitte e solide traimmigrati e cittadini italiani che, giorno dopo giorno, contribuiscono arendere il nostro Paese migliore.
260
Concludo con una battuta. Ad un recente convegno un docente sta-tunitense, parlando appunto di integrazione culturale o di non integra-zione, citava a mo’ di esempio le biografie dei terroristi dell’11 settem-bre: tutte biografie interne al nostro sistema culturale, compreso nellasue accezioni più deleterie e negative. Un esempio di cattiva integrazio-ne che ha poi sortito effetti devastanti. L’integrazione e l’incontro traculture nell’impegno di ricerca di una sintesi che metta al centro la per-sona e i suoi diritti, la democrazia la partecipazione mi pare la frontierada percorrere senza paure e timori di sorta, per rinnovare e ripensare informe nuove il concetto di cittadinanza a noi tutti molto caro.
261
GUGLIELMO LOY
Segretario Confederale della UIL
La migrazione è un processo in costante evoluzione che continueràa giocare un ruolo essenziale nelle società di tutto il mondo, con impli-cazioni politiche, economiche, sociali e culturali.
Oggi nel mondo - sono dati dell’ONU - 175 milioni di persone ri-siedono in un Paese differente da quello di nascita, cifra che è raddop-piata negli ultimi 25 anni. Di questi, quasi un terzo (56 milioni) vivonoin Europa: cifra destinata ad aumentare anche per ragioni demografiche.
Secondo recenti dati (sempre di fonte ONU), il differenziale de-mografico tra Africa ed Europa è di oltre 5 punti percentuali, un gapstoricamente tra i più grandi. In termini numerici questo significa chetra il 2000 ed il 2020 sono stati ipotizzati 50 milioni di persone in più(in età tra i 20 ed i 40 anni) nell’Africa del Nord e ben 120 milioni inpiù nell’Africa Subsahariana.
Anche in Italia il fenomeno comincia ad essere consistente datoche, già oggi, vi è un immigrato ogni 20 persone. D’altro canto il nostroPaese e tutta l’Europa hanno un bisogno vitale di migranti per arginareil declino demografico ed economico altrimenti irreversibile.
Siamo convinti che Italia si debba focalizzare la propria attenzionesu due grandi questioni che potremmo riassumere nella “glocalizzazio-ne” dell’immigrazione. Perché glocalizzazione? Perché il fronte su cuisi misura la capacità di un sistema Paese e della sua comunità di gover-nare tali processi, sono quello internazionale e quello del territorio.
262
E’ per la UIL positivo che negli ultimi mesi si stia concretizzandouna riflessione più ampia sulle grandi politiche migratorie. Non a caso èda alcuni mesi (ma a livello Europeo è da più tempo) che il “tema” cen-trale, al di là di qualche cinica e inopportuna affermazione, è quello del“governo” dei grandi flussi migratori. Convinti, non solo noi, che nonc’è muro che tenga di fronte alle spinte del bisogno ma anche alla ri-chiesta di energie nuove che viene dall’economia nazionale e, in gene-rale, dalle società “anziane”, come quella europea ed italiana. Certa-mente nessuno, tantomeno la UIL, può ragionevolmente pensare al “ta-na libera tutti”, e cioè entri chi vuole o chi può, pena una crisi di rigettoche provocherebbe più danni che benefici agli stessi cittadini non co-munitari. Però rimane aperto il problema, appunto, del come regolare iflussi. Certamente una politica europea è inevitabile e obbligatoria. Par-tiamo quindi dai dati europei per dire che è presumibile che lo stessodato italiano (4% della popolazione non comunitaria) e tenderà a cre-scere.
Trovare la quadra tra la rigidità di chi sostiene “entra solo chi hagià un lavoro” - cosa che fa a pugni con il convivere con la mobilità chele nuove economie impongono (e di cui si esalta la modernità) - e lacontrorigidità di chi è fautore del “entra chi vuole” a prescindere dalgrado di assorbibilità sociale ed economica, non è facile. Uno degli a-spetti più contraddittori della recente legislazione italiana è proprioquello della rigidità dell’ancoraggio ad un lavoro stabile e duraturo delpermesso di soggiorno e della possibilità (scarse) d’ingresso. Contrad-dittorio per la forte discrepanza tra alcune normative sul lavoro, rifor-mate con la recente legge 30 (Biagi), e la tipologia di lavoro imposta allavoratore immigrato considerato, a torto o ragione, più disponibile aforme di flessibilità regolata. Viene da pensare, ad esempio, al lavoro achiamata, al di là del giudizio critico che si vuol dare a tale strumento, ecome tale tipologia sia sostanzialmente inapplicabile ad un cittadinonon comunitario che voglia, o abbia la necessità, di entrare nel nostroPaese e come questa normativa sia, di fatto, inutilizzabile da impreseche intendono avviare lavoratori in base a questa modalità.
Sempre sul versante Global, o internazionale, sono due, a nostroavviso, i più significativi terreni da approfondire dal punto di vista ge-nerale: il rapporto bilaterale, ma non solo, con il Paese di provenienza,
263
e vi sono esperienze interessanti su questo terreno, e le politiche di svi-luppo verso i Paesi stessi. Cosa intendiamo per politiche di svilupponon è facilmente riassumibile: sostegni alla creazione di imprese, soste-gno a politiche formative adeguate e grandi interventi infrastrutturali. Sideve tener conto, però, che rispetto ad anni fa molte sono le condizionisociali, culturali ed economiche cambiate: le risorse da utilizzare al me-glio, le sinergie sovranazionali ed europee, lo stato del livello di libertàe democrazia nei Paese destinatari degli aiuti e, non ultimo, il fatto chein Europa, e quindi anche in Italia, vi sono decine di migliaia di cittadi-ni di quei Paesi, che hanno ottenuto soddisfazioni e successo anche co-me piccoli e medi imprenditori e che potrebbero essere un veicolostraordinario di accompagnamento allo sviluppo nel loro Paese d’origi-ne, veri e propri “testimonial” che potrebbero svolgere un ruolo moltopiù efficace di aiuti diretti ai governi, la cui “produttività” e “redditivi-tà” non sempre è dimostrabile.
Si deve, però, prendere atto che va superata una impostazione chesembra applicare all’immigrato un trattamento “punitivo”, rispondendoal luogo comune che vede nel cittadino migrante una sorta di “bestia ra-ra”, diversa da noi italiani e con meno diritti, contraddicendo così - nel-la filosofia, ma anche nella pratica - le Convenzioni internazionali inmateria di diritti della persona, prima tra tutte la Convenzione Onu del1990 sul diritto dei migranti e delle loro famiglie, entrata in vigore loscorso luglio, e contraddicendo lo spirito delle Direttive UE che nonpossono essere recepite solo sulla parte, anche se importante, del con-trollo delle frontiere e della sicurezza, così come la Confederazione Eu-ropea dei Sindacati ha, in questi giorni, espresso al Presidente di turnodell’Unione Europea.
Vi è poi tutto il versante delle politiche d’integrazione a partiredalla stessa integrazione delle politiche sociali, ed i suoi strumenti legi-slativi, che sono a nostro avviso una grande opportunità a partire dallarivisitazione della 286 e del necessario protagonismo delle istituzionilocali. C’è da riscrivere, in sintesi, la politica sociale dell’immigrazionealla luce dei grandi cambiamenti che il nostro Paese ha vissuto. Oggi,come detto, non c’è una figura “rigida” dell’immigrato. La stessa lette-ratura ci descrive, in molti casi efficacemente, come siamo entrati nellafase adolescenziale dell’immigrazione. Il grosso dei cittadini non comu-
264
nitari è entrato tra gli anni ‘80 e ‘90; ha stabilizzato la sua posizione daanni; nascono bimbi in Italia figli di immigrati; le scuole vedono sem-pre più visibile e significativa la presenza di alunni provenienti da piùPaesi. Tutto ciò, come detto, modifica dal basso il nostro modello di so-cietà e di convivenza. Lo modifica naturalmente anche nel mondo dellavoro e questo lo vedremo più avanti.
C’è il secondo grande fronte a cui abbiamo accennato: è quellodelle città, dei grandi territori e delle loro istituzioni. Politiche socio-as-sistenziali, sanità, casa, trasporto locale, lavoro e Formazione professio-nale intesa come strumentazione a sostegno dei mercati di lavoro localema anche come progetti in loco per i giovani candidati alla migrazione.Tutte materie e competenze ormai in maniera concorrente o esclusiva inmano alle Istituzioni locali. Ecco perché attribuiamo grande importanzaall’azione ed all’attività delle Regioni.
A proposito di lavoro i dati sono crudi ma significativi: per ognidieci avviati al lavoro 1 almeno è extracomunitario. In alcune aree delPaese questa percentuale arriva ad 1/3 ed in alcuni sistemi produttivi, inspecie quelli stagionali (agricoltura e turismo), vi è quasi un “monopo-lio” e, per dirla brutale, se non vi fossero lavoratori non comunitarimolte imprese entrerebbero in crisi drammatica. Crediamo sia un graveerrore politico, anche per questi motivi, non aver avviato, nella maggio-ranza delle Regioni, una stagione di Riforme della legislazionesull’immigrazione.
Ma la questione dell’integrazione non può essere, ad avviso dellaUIL, solo legata alla questione del lavoro o strettamente assistenziale.Pensiamo, e su questo insistiamo con forza, ad altri terreni significativicome la scuola. Nel 2002 gli alunni stranieri hanno raggiunto le 182 mi-la unità, pari al 2,31% rispetto agli alunni italiani. Con una crescita co-stante e significativa negli ultimi anni. E la scuola, a partire dalle mater-ne ed elementari, è il primo luogo di integrazione.
Ma l’integrazione, inevitabilmente, pone, in una moderna attua-zione del principio dei diritti e dei doveri, anche il tema della “cittadi-nanza”. Ci riferiamo, in particolare, alla questione del diritto di Voto,nel caso di quello amministrativo, che è ormai questione ineludibile:siamo in presenza di quasi tre milioni di “contribuenti”, di cittadini che
265
sono esclusi dalla partecipazione all’elezione del proprio rappresentantenelle istituzioni.
Riguardo la questione della partecipazione, non possiamo esimercidal non aprire una finestra su ciò che è più direttamente competenza delSindacato: lo strumento contrattuale. I metalmeccanici hanno di recenteinnovato il Contratto apportando parziali ma significative norme chetengono conto delle specificità che consistenti presenze di lavoratoriimmigrati pongono. Così come è avvenuto con il Contratto degli ali-mentaristi e nell’edilizia (ricordando che in alcune provincie questa ca-tegoria vede tassi di lavoratori non comunitari a due cifre).
Partecipazione e contratto di lavoro non possono essere disgiunti,perché solo attraverso una nuova regolamentazione di rapporti di lavoroe delle norme che li regolano, si riuscirà a coniugare certezze del dirittoe risposte moderne ai bisogni dei lavoratori. Tenendo conto che, cosìcome cambiano la composizione del mercato e dell’organizzazione dellavoro, va prodotta una riflessione sull’aggiornamento degli strumentidi regolazione (i contratti in primis) di questi aspetti. Di fondo rimaneper il sindacato un principio irrinunciabile: parità di diritti, di doveri, dinorme e di tutele. A prescindere da dove si è nati.
266
TULLIO UEZ
Vice Presidente Vicario della Confartigianato
Nell’immaginario collettivo la figura dell’immigrato evoca irrego-larità, clandestinità, disperazione. Il fenomeno dell’immigrazione è pe-rò assai complesso e non può essere ridotto a semplici slogan poichécoinvolge realtà molto diverse e in continua trasformazione. Tale feno-meno ha assunto una connotazione di carattere strutturale: l’Italia, concirca 2,4 milioni di stranieri presenti, è ormai il terzo Paese europeo,per flussi immigratori, dopo la Francia e la Germania.
Il fenomeno dell’immigrazione abbraccia diverse realtà: è ormaichiaro che fare riferimento alla categoria degli immigrati come unicumè improprio; è sempre più necessario approfondire i diversi percorsi diinserimento, le differenze esistenti tra i gruppi nazionali. La Confarti-gianato si è inserita in questo sforzo conoscitivo considerando gli immi-grati come portatori di risorse e capacità imprenditoriali, e non più ed e-sclusivamente come una figura destinata a colmare le carenze di mano-dopera presenti nel territorio. La nostra Associazione, in particolare, haconcentrato la propria attenzione sul fenomeno dell’imprenditoria im-migrata: il tasso di lavoro autonomo degli immigrati è cresciuto più diquello degli autoctoni in diversi Paesi del nostro continente. In Italia so-no presenti più di 125 mila imprenditori immigrati provenienti da Paesiextracomunitari; 34 mila, in particolare, sono artigiani.
Chi sono gli imprenditori immigrati? Da dove provengono e inquali settori operano prevalentemente? Qual è il loro percorso lavorati-vo? E, ancora, quali sono i loro progetti imprenditoriali?
267
A queste domande la Confartigianato ha cercato di dare una rispo-sta attraverso un’Indagine a carattere prevalentemente qualitativo con-dotta nel maggio del 2003 e rivolta ad un campione rappresentativo di530 imprenditori immigrati artigiani.
La ricerca si è posta una duplice finalità:
a) fare emergere le principali caratteristiche e i più rilevanti problemidegli immigrati sia come persone sia come imprenditori;
b) presentare una panoramica dei servizi che possono essere offerti dal-le Associazioni imprenditoriali a favore degli immigrati.
Dall’Indagine emerge un percorso ben definito e finalizzato ad unprogetto di vita (diventare imprenditore) che permette all’immigrato dimigliorare il proprio status economico e sociale. Abbandonato il pro-prio Paese di origine, il 71% del campione ha scelto l’Italia come primoPaese di destinazione. Qui, si è inserito seguendo uno schema classico:da posizioni irregolari e clandestine in settori produttivi interstiziali, po-veri (generalmente abbandonati dagli autoctoni) l’immigrato è riuscitoad inserirsi gradualmente e, soprattutto, regolarmente, nel mercato dellavoro.
Il 63% del campione segnala di aver svolto un lavoro come dipen-dente nel settore privato prima di iniziare l’attuale attività imprendito-riale; l’11% e il 14% degli intervistati indicano, rispettivamente, di es-sere stati studenti e disoccupati prima dell’attuale attività.
Il percorso di avviamento all’attività autonoma prevede nella mag-gioranza dei casi l’acquisizione delle competenze tecnico managerialiin una precedente esperienza di lavoro subordinato: l’80% degli immi-grati intervistati afferma di essere in possesso dei requisiti tecnico-ma-nageriali e di averli acquisiti prevalentemente durante l’esperienza pro-fessionale precedente e, in misura meno rilevante, attraverso corsi diformazione professionale e nell’impresa di famiglia.
L’acquisizione di queste competenze - unitamente ad una evidentepropensione al lavoro autonomo (“dichiarata” dal 58% del campione) -ha spinto l’immigrato ad iniziare l’attività imprenditoriale. Quest’ulti-mo dato rappresenta il principale motivo di creazione dell’impresa in I-talia da parte dell’immigrato ed è seguito a grande distanza da altri fat-
268
tori tra cui la previsione di un maggior reddito rispetto al lavoro dipen-dente e le maggiori possibilità di avviare, in Italia, un’attività in propriorispetto al Paese di origine.
La figura di imprenditore immigrato che si delinea dall’Indaginecontiene elementi di entrambe le teorie dominanti in letteratura: il filo-ne di pensiero che riconduce a spiegazioni di natura culturale la sceltaimprenditoriale degli immigrati riconoscendo a chi avvia un’attività im-prenditoriale una propensione, un’attitudine legata a caratteristiche psi-cologiche, socio-culturali; e la tesi nota come teoria dello svantaggiocomparatoche intravede nell’avvio di un’attività autonoma degli immi-grati una reazione a condizioni di disagio sociale ed economico, alla ca-renza di competenze professionali e di credenziali educative, nonché al-lo scarso livello e alle difficoltà di integrazione nel territorio.
La ricerca evidenzia inoltre che le imprese dirette dagli immigratisono assimilabili (nei relativi punti di forza e di debolezza) alle aziendedi piccole dimensioni e a carattere artigianale dirette da imprenditori i-taliani. L’imprenditore immigrato segnala di essere ben inserito nel ter-ritorio; di avere ottimi rapporti con i propri dipendenti italiani (che rap-presentano il 29% dell’occupazione totale) e con le altre imprese e dinon sentirsi discriminato e/o svantaggiato rispetto alle imprese gestiteda italiani.
I problemi non appaiono molto diversi rispetto a quelli delle pic-cole e piccolissime imprese locali; alcuni specifici vincoli (tra cui, inparticolare, il problema dell’abitazione e della lingua e le difficoltà ag-giuntive di carattere burocratico per l’avviamento dell’attività impren-ditoriale) possono, però, porre gli imprenditori extracomunitari in unasituazione di svantaggio concorrenziale. A ciò si devono aggiungere iproblemi relativi al finanziamento bancario a causa, soprattutto, dellamodesta disponibilità del sistema creditizio nei confronti di stranierisconosciuti e raramente in possesso di beni immobili da offrire ingaranzia.
A questa tipologia di imprese le Associazioni - come Confartigia-nato - dovranno rivolgere sempre più la propria attenzione ed offrire glistessi servizi generalmente offerti alle imprese dirette da imprenditori i-taliani tenendo conto, però, di alcuni specifici problemi.
269
L’Indagine della Confartigianato, sulla base delle risposte degliimmigrati, ha individuato una serie di possibili campi di intervento peragevolare l’integrazione degli immigrati nel nostro Paese; in particolaresi è focalizzata l’attenzione su due distinte fasi di vita dell’impresa:start up e consolidamento.
Tra i vari servizi mirati che possono essere predisposti dalle Asso-ciazioni imprenditoriali a favore degli imprenditori immigrati nella fasedi avvio si possono evidenziare:
• i servizi di assistenza tecnica per le varie pratiche amministrative (li-cenze, permessi, ecc.). In questa fase l’imprenditore immigrato deveconcentrarsi sul core business ed essere alleggerito dai mille lacci elacciuoli burocratici che accompagnano l’impresa nella fasi inizialidella propria attività;
• l’individuazione dei fabbisogni formativi e la diffusione di informa-zioni sui corsi di formazione professionale;
• l’assistenza in campo creditizio per la concezione di finanziamenti atassi di interesse di mercato e agevolati;
• la creazione di Organismi ad hoc (in collaborazione con Fondazioni nonprofit, Banche, Enti locali, ecc.) per la concessione di microcredito;
• la fornitura di specifiche garanzie.
I servizi a favore degli imprenditori immigrati (nella fase di conso-lidamento dell’impresa) non si discostano, nella sostanza, da quelli for-niti alle imprese dirette da italiani.
Rimane, ovviamente, fondamentale l’assistenza in campo crediti-zio: l’impresa, per crescere, realizza nuovi investimenti produttivi ed haquindi bisogno di capitali. Parallelamente, le Associazioni dovrebberoaccompagnare la crescita delle imprese favorendo il loro ingresso incircuiti produttivi (fiere; consorzi; ecc.); individuando nuovi clienti;fornendo infine informazioni sull’andamento del settore di appartenen-za e del mercato locale del lavoro.
I vari servizi su indicati possono favorire la creazione di imprese atitolarità extracomunitaria e, nel contempo, rispondere ad un’importantefunzione sociale finalizzata sia ad eliminare forme ancora esistenti di
270
discriminazione sia a favorire ulteriormente l’integrazione degli immi-grati nel tessuto economico.
Questo processo di integrazione potrà ovviamente essere rafforza-to se tutte le parti sociali coopereranno per una comune politica di im-migrazione che, nella fattispecie qui esaminata, dovrà essere finalizzataa sostenere il fenomeno degli imprenditori immigrati attraverso un am-pio spettro di interventi. In particolare, attraverso: la semplificazionedell’ancora complessa normativa legata al riconoscimento dei titoli distudio e delle qualifiche professionali degli immigrati extracomunitari;il miglioramento delle condizioni di accesso ad alloggi dignitosi e al fi-nanziamento bancario; l’abbattimento delle varie forme di discrimina-zione.
271
TITTI DI SALVO
Segretario Confederale della CGIL
Intendo affrontare due ordini di ragionamenti: il primo.
I dati dell’ONU prima riferiti sulla presenza di persone in Paesi di-versi da quelli di nascita, sono molto significativi. Altrettanto significa-tivi sono quelli che registrano la dimensione del fenomeno in Europa: sitratta di 56 milioni di persone.
La cifra ricordata non fotografa semplicemente una realtà impor-tante: è scontato osservare che la globalizzazione determina un flussomigratorio continuo dal Sud al Nord del mondo. Ma quella quantità dàil senso della grande responsabilità dell’Europa. Ho sentito - e le condi-vido - le cose dette dal Presidente del Comitato Economico e SocialeEuropeo. L’Europa oggi ha un’enorme responsabilità esattamente comeattore globale, cioè come attore che è in grado di influenzare quel diva-rio tra Nord e Sud del mondo che è all’origine del fenomeno migrato-rio: il tema all’ordine del giorno dunque non mi pare essere solo quellodelle politiche di integrazione in Europa, ma di come l’Europa si muo-ve per definire un nuovo ordine geo-politico in cui i Paesi del Sud delmondo possano svilupparsi.
Da questo punto di vista, dico con assoluta sincerità e franchezza,che a Cancun così non è stato e lì l’Europa ha giocato un ruolo assolu-tamente discutibile.
D’altra parte, mentre l’Europa è impegnata a definire il suo trattatocostituzionale, deve tradurre in quel trattato le politiche di integrazione
272
e di sviluppo che insistono nella sua responsabilità come attore globaleinternazionale.
Il trattato costituzionale e la Conferenza intergovernativa che si èaperta sono in via generale una grande opportunità. La bozza che arrivadalla Convenzione è sicuramente un passo avanti verso la costituzionedell’Europa politica. Ma sarebbe sbagliato negarne aspetti contradditto-ri o negativi. So che la mediazione prodotta è delicatissima e so che,quindi, accentuare le critiche, può mettere a rischio quella mediazione.Ne sono assolutamente consapevole. So anche però che se la costruzio-ne dell’Europa è un processo non concluso di cui la Conferenza inter-governativa ed il suo esito costituiscono una tappa nella direzione giu-sta, sottolineare le contraddizioni della bozza di Trattato ha il senso ditenere aperta una prospettiva, delineando i binari del percorso futuro.
In questo senso per restare al tema in discussione, è un errore l’as-senza nella definizione della cittadinanza europea, di una cittadinanzadi residenza, che riconosca alle persone immigrate residenti da moltotempo in Europa i diritti fondamentali dei cittadini europei.
Inoltre - è un ragionamento generale sul Trattato ma si associa per-fettamente all’argomento in discussione oggi - così come è auspicabileun’Europa federale, non somma di Governi, capace di fare politiche fi-scali, economiche, sociali, sulla base del principio di maggioranza, pen-so che anche e soprattutto le politiche di integrazione debbano avere unorizzonte europeo.
Dunque ragionando di politiche di integrazione credo non si possa,né, da un lato, chiudere gli occhi rispetto alla responsabilità che l’Euro-pa ha nei confronti dei Paesi del Sud del mondo, né, dall’altro, saltarel’appuntamento della Carta costituzionale per segnarla anche di questoprofilo, poiché la scommessa alta è che il Trattato costituzionale conva-lidi e consolidi il modello sociale europeo, quello in virtù del qualel’Europa può giocare un ruolo straordinario nel mondo: in quel modelloil tema dell’integrazione tra culture deve trovare una sua codificazioneed una sua evidenza, per superare il rischio che le enunciazioni solennisiano smentite nella traduzione concreta.
Secondo ordine di ragionamenti. Tutti gli interventi precedentihanno sottolineato, anche se da punti di vista differenti, il bisogno per
273
l’economia italiana di persone che arrivano da altri Paesi. E’ un bisognoche esprime anche la società italiana più complessivamente. Basti pen-sare al ruolo delle donne immigrate nell’accudimento di anziani e bam-bini, un ruolo svolto da donne a sostegno di altre donne, italiane questavolta. La stampa italiana anche recentemente ha sottolineato come “cu-riosità antropologica” il livello di istruzione molto alto conseguito inpatria dalle donne immigrate. Troppo poco al contrario si evidenzia co-me quelle persone vengano sottoposte ad una doppia discriminazione:perché immigrate e perché svolgono lavori di cura che non hanno gran-de rilievo nella considerazione generale e nella gerarchia sociale del no-stro Paese.
Senza approfondire ulteriormente mi pareva utile però evidenziareche è la società italiana ad aver bisogno del lavoro e della cura di questepersone: abbiamo tutti bisogno, quindi, che le politiche di integrazionee di riconoscimento dei loro diritti abbiano una efficacia reale.
Non credo di svelare un arcano nell’affermare che, a mio avviso ead avviso della CGIL, la legge Bossi-Fini, non risponde a tali obiettivi.Il nostro giudizio è noto, è peraltro unitario e conosciuto anche dal VicePresidente del Consiglio: ne voglio argomentare le ragioni. In primoluogo se è vero che l’immigrazione non è un fenomeno emergenziale,ma un fenomeno strutturale, vanno individuate normative che abbianoquesto approccio, un approccio strutturale e non emergenziale.
La restrizione sugli ingressi prevista in quella legge e attuata attra-verso la modifica dei ricongiungimenti familiari, così come il legamecosì stretto tra soggiorno e lavoro, sono esempi di come l’impianto del-la legge è ispirato esclusivamente dalla logica dell’emergenza.
In secondo luogo osservo che la legge Bossi-Fini, poiché si confi-gura come modifica alla legislazione precedente, peraltro di diversa i-spirazione, la 40/98, determina in aggiunta ai suoi limiti confusionenormativa e difficoltà di applicazione.
Ultima questione. Venivano indicate da molti interventi le direttri-ci di marcia delle scelte di politiche di integrazione da attuare. Non c’èdubbio che la realtà ci impone un ragionamento molto pressante sul di-ritto al lavoro, all’istruzione e alla formazione, sul diritto alla casa e suldiritto al voto. Se è vero che il fenomeno non è emergenziale ma strut-
274
turale, il punto è come si integrano culture diverse, cioè come si dà vo-ce ad una politica che contrasti un sentimento di paura, di insicurezzache c’è ed esiste tra le persone. Le politiche di integrazione non servonosolo ad oleare i meccanismi di convivenza forzosa di una società, deb-bono essere in grado anche di proporre e costruire una cultura dell’inte-grazione.
Mi è capitato di leggere quotidiani francesi del novecento che de-scrivevano quartieri in cui c’era l’immigrazione italiana e mi sembravala medesima descrizione che si legge oggi sui quotidiani italiani in rife-rimento a quartieri di Torino come San Salvario o Porta Palazzo! E’ unelemento che non va mai dimenticato, al di là delle emergenze, al di làdella necessità economica e sociale. Occorre cioè assumersi la respon-sabilità del contrasto alla cultura dell’insicurezza, dell’ostilità verso ildiverso-nemico che oggi deriva dalla globalizzazione, ricordando che èla stessa di cui sono stati vittime per tanti anni gli italiani immigrati.
Infine, Loy parlava delle cose importanti che il sindacato e le im-prese devono assumere per parte loro nella propria responsabilità. Il da-to di partenza, cioè il fatto che, a oggi, su 350 contratti solo 30 affronti-no il tema, dimostra che si tratta di una direzione di marcia da imbocca-re con più decisione. Esiste anche in questo caso un problema di raccor-do europeo del sindacato e delle imprese europee e forse la necessità diuno spirito nuovo per cui, sia il sindacato nazionale, che le imprese na-zionali, assegnino alle loro rappresentanze europee, UNICE e CES, unruolo maggiore perché oggi lì si decide e lì è bene che si conti.
275
STEFANO PARISI*Direttore Generale di Confindustria
Oggi nel nostro Paese, la politica per l’immigrazione deve tenerconto di quattro aspetti che forse nel passato erano tenuti in minor con-siderazione.
Il primo aspetto è quello del funzionamento del nostro mercato dellavoro che ha al suo interno alcune forti distorsioni: carenza di manodope-ra nel Sud, elevata quota di lavoro sommerso, basso tasso di occupazione.Tutti problemi che non si possono risolvere solo con l’immigrazione.
Sono necessarie iniziative che favoriscano una crescita dell’occu-pazione regolare e al contempo offrano le risorse necessarie per renderepossibile l’integrazione degli immigrati, che è una questione di assi-stenza, di case, di scuole e così via.
Finché l’Italia conterà su una base occupazionale così ristretta, a-vremo grande difficoltà a fare sviluppo e soffriremo di notevoli proble-mi sociali.
Se tutta la nuova occupazione che faremo nei prossimi dieci annidovesse essere coperta solo con l’immigrazione, ne conseguirebbe unaforte modifica della composizione sociale del Paese.
Dobbiamo aver presente che anche nelle aree di massima occupa-zione, dove il livello di disoccupazione è vicino allo zero, l’Italia ha__________* Intervento non rivisto dall’autore
276
tassi di occupazione ancora troppo bassi - nel migliore dei casi intornoal 64-65% - quando nei Paesi più dinamici e industrializzati siamo al73-75%.
Il fatto è che in Italia scontiamo una percentuale ancora troppobassa di donne che lavorano e abbiamo molti adulti che escono troppopresto dal mercato del lavoro.
Oltre che sotto il profilo quantitativo, la situazione del mercato dellavoro va vista dal lato della qualità.
Se avessimo una forte immissione di immigrati in un cattivo mercatodel lavoro creeremo instabilità sia per i nostri concittadini che per gli stessiimmigrati. E anche questo è un risvolto che va esaminato con attenzione.
Un secondo aspetto riguarda il welfare con particolare riferimentoalla composizione della spesa sociale.
Se noi non modifichiamo la composizione della spesa sociale, li-berando risorse per l’assistenza e per i nuovi bisogni - tra cui ci sonoanche quelli degli immigrati - non potremo realizzare una efficace poli-tica dell’immigrazione.
Dobbiamo essere meno egoisti. Non dobbiamo interessarci solo dichi è già garantito. Dobbiamo dare più spazio ai nuovi bisogni e a quan-ti sono oggi esclusi dal circuito produttivo e dal benessere.
La terza questione è quella della globalizzazione, che va affrontatain prospettiva.
È vero che gli italiani dall’inizio del secolo fino a tutti gli anni ‘50e ‘60 sono stati soggetti di emigrazione. Ma poi, grazie al forte sviluppoche ha interessato il nostro Paese, molti dei nostri emigranti sono torna-ti indietro. La chiave di volta è allora lo sviluppo.
La globalizzazione si traduce in un fenomeno tanto più positivoquanto più saremo capaci di coinvolgere nello sviluppo i Paesi dai qualioggi provengono gli immigrati.
I Paesi europei debbono essere meno egoisti e investire di più nel-la cooperazione allo sviluppo.
La globalizzazione, la cooperazione industriale, la localizzazionedi nuovi stabilimenti produttivi devono guardare alle aree che hannovalore maggiore da un punto di vista strategico e politico.
277
L’Italia ha tutto l’interesse a che il Mediterraneo sia un’area pacifi-ca e sicura e quindi ha interesse allo sviluppo dei Paesi mediterranei.
Per la cooperazione allo sviluppo non bastano l’assistenza e le or-ganizzazioni non governative. Servono le aziende che portano in queiPaesi ricchezza e benessere.
È l’emergenza che richiede gli interventi di assistenza delle Ong edelle Onlus. Noi dobbiamo superare l’emergenza e portare sviluppomediante investimenti produttivi.
Dobbiamo portare le nostre attività produttive nei Paesi da doveprovengono gli immigrati per fare sviluppo in loco e far sì che ritorninoal Paese d’origine con il bagaglio di cultura di impresa acquisita dall’e-sperienza italiana.
La conoscenza della nostra lingua, del nostro ambiente, della no-stra cultura può rivelarsi un asset formidabile per dare a questa immi-grazione di ritorno gli elementi necessari a creare e realizzare in loco u-na politica di sviluppo.
Un problema fondamentale è poi quello della sicurezza.
Oggi non possiamo parlare di immigrazione come ne avremmoparlato fino al 10 settembre 2001. Dall’attentato alle Torri gemelle diNew York, la questione della sicurezza è diventata centrale. In partico-lare per l’Italia che confina, più di tutti gli altri Paesi europei, con zonea rischio, dove c’è terrorismo e tensione.
Dobbiamo allora cercare di fare ogni possibile sforzo per stringereun grande accordo sulla sicurezza con i Paesi da cui provengono gliimmigrati.
Tra le questioni da esaminare c’è anche quella della legge Bossi-Fini.
È da ritenere giusto aver collegato l’immigrazione al lavoro: è unfatto di dignità e di tenuta sociale. Non esiste del resto la possibilità diintegrarsi se non c’è innanzitutto il lavoro, quindi la casa, l’istruzione,la famiglia.
Vanno poi esperite le possibilità offerte dalla maggiore flessibilitàdel mercato del lavoro ottenuta con la riforma Biagi, che con l’adattabi-lità ha trovato il modo per far incontrare domanda e offerta di lavoro.
278
Perché non seguire questo criterio anche per gli immigrati invecedi affidarsi alle quote? Le imprese italiane non hanno bisogno di un nu-mero prestabilito di immigrati che poi non hanno le qualità professiona-li per svolgere il lavoro che serve.
Oggi che c’è un sistema informativo che consente anche ai privatidi gestire la banca dati dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro,perché non immettere anche le esigenze qualitative delle imprese? Eperché non fare la stessa operazione anche presso le ambasciate italianenei principali Paesi di emigrazione verso l’Italia?
Decidere per quote significa decidere ogni anno qualcosa che nonè possibile decidere, perché non siamo in grado di sapere quante perso-ne servono e finiamo per alimentare il lavoro nero.
Proviamo invece a gestire i flussi in modo intelligente, utilizzandola formazione nei Paesi di origine, facendo in modo che la selezione av-venga lì per poi portare i lavoratori laddove le aziende ne hanno biso-gno.
Tutto questo va fatto in un quadro che aumenti il numero degli ita-liani che lavorano, che favorisca la mobilità tra Nord e Sud del Paese,che affronti in maniera intelligente il fenomeno dell’immigrazione.
Credo sia infine molto importante avere un processo decisionale u-nivoco. Ancora oggi in Italia, dopo tanti anni che ci occupiamo di im-migrazione, la competenza è suddivisa fra quattro, cinque Ministeri.
Abbiamo invece bisogno di una struttura unica, come accade negliStati Uniti, dove c’è un’Agenzia per l’immigrazione che gestisce in ma-niera efficace l’ingresso, la sanità, la sicurezza, il lavoro, la collocazio-ne sul territorio, le banche dati.
Altrimenti corriamo il rischio di gravi contraddizioni e smagliaturetra le diverse responsabilità, con ricadute negative su una coerente poli-tica per l’immigrazione che deve essere fattore positivo sia per gli im-migrati che per il Paese che li accoglie.
279
SAVINO PEZZOTTA
Segretario Generale della CISL
Ringrazio il Presidente del CNEL per avere voluto un convegnocosì importante, e ritengo apprezzabile e importante la presenza delPresidente della Commissione Sociale Europea e soprattutto del VicePresidente del Consiglio.
Forse mai come oggi, le emigrazioni mettono in questione i fonda-menti stessi della società e gli sviluppi della convivenza sociale, e credoche questo richieda un grande impegno per la costruzione di una societàin cui si allarghino gli spazi di appartenenza e di partecipazione e si re-stringano quelli della esclusione.
A questo riguardo, penso che l’obiettivo principale che dobbiamoporci, di fronte a questo fenomeno, sia quello di capire se il nostro Pae-se e l’Europa siano in grado, non soltanto di integrare gli immigrati, madi diventare “società integrate”. E questo implica, non tanto la difesa diculture contrapposte, quanto piuttosto l’incontro tra di esse in modo dafavorirne la relazione.
Questo è il tema fondamentale che, a mio avviso, ci sta sfuggendo.Parliamo soltanto di quanti immigrati riusciamo ad integrare nelle no-stre società, quanti ne facciamo entrare, quanti ne riusciamo ad inserirenel mondo del lavoro. Ma nella valutazione del fenomeno immigrato-rio, non può essere esaustiva la considerazione della convenienza eco-nomica - ed è stato il limite anche delle leggi che abbiamo avuto finora- perché in questo fenomeno si misurano i più profondi valori solidari-
280
stici delle civiltà, nei confronti di persone che chiedono accoglienza neivari Paesi, per motivi tra i più disparati: trovare un lavoro, riunire la fa-miglia e, soprattutto, sfuggire alla miseria, alla persecuzione, alla guer-ra. E’ sbagliato dire che si tratta soltanto di forza lavoro, e non riuscire-mo mai a risolvere il problema se continueremo a ridurre la questionesoltanto al mercato ed alla forza lavoro.
Non possiamo ragionare solo in questi termini, c’è qualcosa in più.
Certamente, il fenomeno immigratorio va visto anche come unagrande opportunità per una futura società multiculturale che sia all’altez-za proprio delle sfide della globalizzazione e dell’integrazione europea.
Pertanto, l’immigrazione, se vogliamo guardare la questione nellasua complessità, non può che porsi come una “questione sociale”. Ri-guarda, infatti, non solo i diritti e le condizioni degli immigrati, ma an-che l’impatto con la “cultura dell’accoglienza” del Paese ospitante, pro-prio rispetto ai processi di reciproca integrazione e alle preoccupazionisul piano dell’identità, dell’occupazione, dell’ordine pubblico, dellasicurezza.
Da ciò emerge che il problema comune nei diversi Paesi europei,oltre che in Italia, non è quello di ridurre l’immigrazione - come sentospesso affermare, e come vedo sui giornali dove, in questi giorni, leggocose davvero orrende - ma di aumentare l’immigrazione regolare e dicontrastare quella clandestina. Questo avrebbe un impatto positivo an-che sulla questione del welfare, che tanto anima i nostri dibattiti in que-sti giorni.
L’immigrazione, dunque - come viene fuori anche da autorevolidocumenti dell’Unione Europea, che tutti noi riconosciamo - è un fatto-re di grande rilievo per gli obiettivi della strategia di Lisbona e quindiper lo sviluppo economico e la coesione sociale della comunità che stia-mo costruendo.
Le politiche dell’immigrazione, a mio parere, rappresentano, e nonsoltanto per l’Italia, ma per tutta l’Unione Europea, un “banco di pro-va”, dei valori di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di democrazia,presenti nella nuova bozza di Costituzione. Valori che vanno misuratinella concretezza, non nell’astrattezza, un po’ metafisica, che siamo a-bituati ad utilizzare.
281
Occorre un vero impegno in questa direzione, che non trasmetta,come avviene ora, un’idea di Europa egoista, chiusa, ma che sia voltoall’insieme delle iniziative interne ed esterne, e per questo dovrà essereriequilibrato per intero. Anche per ciò che riguarda le frontiere, aspetto,tra l’altro, che è stato privilegiato nettamente dal Consiglio di Siviglia.
Lo spirito di Tampere dell’ottobre ‘99, a livello di Unione, pensa-va ad una politica di cooperazione allo sviluppo con i Paesi di origine ead una forte politica di inserimento, di integrazione dei cittadini immi-grati e delle loro famiglie regolarmente residenti.
Perché questo non rimanga un semplice auspicio, è necessario, co-me primo passo, tradurre questo “riequilibrio” in alcuni obiettivi concretisui quali chiediamo l’impegno della Presidenza e del Governo italiano.
Innanzi tutto l’Unione - e comunque l’Italia - deve rafforzare ilquadro giuridico internazionale a tutela dei migranti, ratificando, sia laConvenzione dell’ONU, del dicembre 1990, sui diritti degli immigrati edelle loro famiglie - entrata in vigore il primo luglio di quest’anno sen-za la firma di nessuno dei grandi Paesi di immigrazione - sia, come dal-la recente proposta della Commissione Europea al Consiglio, la Con-venzione ONU contro il crimine internazionale, il protocollo sulla pre-venzione, la repressione del traffico di persone, in particolare donne ebambini, e il protocollo contro il traffico di immigrati entrato in vigoreil 29 settembre scorso.
L’uguaglianza- è scritto nel trattato costituzionale - è un valorefondante della nuova Costituzione. Ma questo principio deve avere unriscontro forte nella previsione costituzionale della cittadinanza europeaper i cittadini emigrati residenti da lungo periodo, come richiesto dallostesso Comitato Sociale ed Economico Europeo.
Come sappiamo, nell’attuale proposta, essa è riconosciuta solo achi ha la cittadinanza di uno Stato membro. Per questi stessi cittadiniimmigrati occorre, in ogni caso, prevedere la semplificazione delle pro-cedure per l’ottenimento della cittadinanza nazionale e, a mio parere,anche “il riconoscimento del diritto di voto”, almeno amministrativo,come hanno iniziato a fare alcuni Stati membri dell’Unione.
Apprezziamo molto l’equilibrio, umano e politico, con cui il Mini-stro degli Interni sta affrontando aspetti importanti delle politiche im-
282
migratorie: dal controllo integrato delle frontiere esterne, al partenariatocon i Paesi d’origine, alla programmazione europea dei flussi. Ma sia-mo sempre più preoccupati per le conseguenze della estrema incertezzadella programmazione dei flussi e della rigidità delle vie legali per en-trare nel nostro Paese, che escludono una quota di permessi per trovarelavoro, come chiede, soprattutto, il mondo delle piccole imprese e comeindicato dallo stesso Comitato Economico e Sociale.
Per rafforzare le politiche di integrazione di competenza degli Sta-ti membri, sono necessari - come è stato detto più volte in questa occa-sione - una politica di coordinamento aperto e indirizzi e risorse comu-nitari. Ma per il nostro Paese occorre anche un forte rilancio dell’impe-gno di quelle regioni che accusano un grave ritardo nelle leggi di ade-guamento alla “Turco-Napolitano” ed alla “Bossi-Fini” - a tale proposi-to, sembra essere a buon punto solo l’Emilia Romagna - e del Governo,che ancora non ha definito il nuovo regolamento di attuazione ed entrodicembre dovrà presentare il nuovo documento di programmazionetriennale delle politiche immigratorie 2004-2006. In realtà, la mancan-za, oramai da tempo, di una politica nazionale di indirizzo e sostegno,rende l’iniziativa di coloro che dovrebbero essere le protagoniste dellepolitiche di integrazione sociale, vale a dire le regioni e le autonomielocali, sempre più difficile e precaria.
Per il percorso di integrazione del modello italiano - per fare un e-sempio - il compito della scuola è davvero decisivo sia per i cittadinistranieri, minori ed adulti - rispetto alle specifiche esigenze di inseri-mento ed al futuro della seconda generazione - nonché per tutti gli allie-vi, rispetto alla prospettiva di una società multiculturale.
In tal senso, vi è un grande impegno da parte di istituti, insegnanti,dirigenti, nei confronti degli oltre 200.000 giovani inseriti nelle scuole i-taliane, e anche delle stesse istituzioni locali attraverso progetti formativie culturali integrati nel territorio. Al contrario, appare del tutto assente, amio parere, una politica nazionale del Governo centrale che tenga vera-mente conto della presenza dei nuovi cittadini con problemi di apprendi-mento della lingua italiana (non come lingua madre, ma come secondalingua); della necessità di un sistema standardizzato di certificazione deilivelli del suo apprendimento; della necessità dell’impiego di mediatori
283
culturali ben formati; della conoscenza del mantenimento dei rapporticon la lingua e la cultura di origine. Questo vuoto nazionale esiste, pur-troppo, anche in questa fase dell’autonomia scolastica.
Soprattutto il lavoro, l’inserimento, le condizioni di sicurezza, latutela negoziale, la qualificazione professionale, le pari opportunità,chiamano in causa il nostro ruolo di sindacato. Abbiamo espresso criti-che, ad esempio, su alcuni aspetti della legge 30, ma, credo, che unosforzo vero lo dovremmo fare soprattutto sul terreno dell’incontro delladomanda e dell’offerta e anche valorizzare gli spazi che, comunque,questa legge apre alle parti sociali. A questo proposito, nel favorire que-sto incontro, noi potremmo davvero avere un ruolo importante.
E in questa idea di integrazione, probabilmente, anche il nostromodello di contrattazione, di affermazione di diritti e tutele, dovrà esse-re in grado di cogliere le diversità che arrivano, con le loro differenti e-sperienze culturali e religiose, e non soltanto di assorbirle e di omoge-neizzarle. Anche il sindacato, quindi, dovrà avere la capacità di mutarein alcuni aspetti. In parte, è quello che, il sindacato italiano, così comela mia organizzazione attraverso l’ANOLF, la nostra Associazione, statentando di fare. Da tempo ci siamo posti il problema di come far socia-lizzare queste persone, come accoglierle, come farle diventare dirigenti.
In tal senso, forse siamo l’unica grande organizzazione, il sindaca-to nel suo complesso, che ha dentro il suo gruppo dirigente la figuradell’immigrato come figura costante, permanente, dando la dimostra-zione concreta e reale che l’integrazione è possibile dove i percorsi sipossono mettere in campo, dove le discriminazioni possono essere eli-minate.
E questo è possibile, proprio nelle regioni dove le politiche di inte-grazione hanno maggior sviluppo, e che, se andiamo a ben guardare,sono quelle in cui i tavoli di concertazione sociale hanno attivato patti eaccordi territoriali, hanno rafforzato il consenso sociale, la collaborazio-ne interistituzionale, l’integrazione di energie pubbliche e private, delprivato sociale e del volontariato.
In altri termini, la cultura del patto, dell’accordo, della concerta-zione, anche nella gestione di questo fenomeno nei livelli locali, nei li-velli territoriali, diventa vincente.
284
Se sperimentiamo più a fondo, la stessa cultura della bilateralitàtra le parti sociali, soprattutto per ciò che riguarda il mercato del lavoro,probabilmente qualche passo in avanti in questa direzione possiamo far-lo. Ma stiamo molto attenti, perché l’abbandono della concertazione, daparte del Governo, il crescente affievolirsi del riconoscimento del ruolopolitico e autonomo del sociale, non fa che ridurre sempre di più, quellarisorsa, che io continuo a pensare strategica per il Paese.
L’immigrazione è l’icona della complessità vera che dovremo af-frontare nel prossimo futuro. Ecco perché continuiamo a rimanere lega-ti al modello, all’idea - che è quella del patto - della concertazione, deipercorsi, e non riteniamo sufficiente “il dialogo sociale”.
In questo momento, e spero si tratti di una questione di tempora-nea difficoltà di quel modello, siamo addirittura passati ad una sorta di“monologo”. E ciò è significativo anche nella dimensione della realtàlocale.
Dobbiamo riflettere, ragionare con molta attenzione sul fenomenoe sul rapporto tra noi e i Paesi dai quali l’immigrazione proviene. Laquestione delle politiche di cooperazione allo sviluppo deve individuarealcune priorità. Per questo motivo, continuo a pensare che, per la nostradimensione dell’immigrazione, non per dimenticare altri, la nostra prio-rità debba essere quella dell’Africa, e non solo per i Paesi del Nord A-frica, di origine e di transito dell’immigrazione, ma anche per i Paesisubsahariani, le cui grandi e tremende migrazioni, premono sempre più.E se questa pressione dovesse aumentare, la situazione potrebbe diven-tare davvero drammatica.
Ecco perché sostengo che il problema dell’Europa sia proprio“l’Africa” e come poter affrontare alcune questioni.
Su questo terreno io credo che occorra fare molto di più di quelche stiamo facendo. Tutti insieme, perché qui non c’è solo il compito oil ruolo del Governo e dello Stato - primario in ogni caso - ma c’è an-che la questione del ruolo delle forze sociali e della loro capacità di in-tervento in questa dimensione.
La verità, è che tutti i Paesi - compresa l’Italia, forse per le suequestioni economiche - hanno molto ridotto l’intervento sulla coopera-zione, e questo è un errore.
285
Al G8 di Genova - che noi ricordiamo per altri motivi - tra i Paesipartecipanti, era stato assunto l’impegno di destinare, una certa percen-tuale del PIL, alla cooperazione allo sviluppo. Ebbene, nessun Paesel’ha raggiunta, tantomeno il nostro, che pure aveva presieduto quellariunione.
Non voglio rivolgere accuse, ma solo ricordare che gli impegni as-sunti non possono essere disattesi né dall’Europa, né dall’Italia. Ma vo-glio anche ricordare che la sicurezza la si può costruire, non solo con learmi e con la polizia, ma anche e soprattutto con lo sviluppo. Non per-ché io pensi che vi sia una correlazione tra terrorismo e povertà - tesiche non accetto - ma perché, certamente, l’aumento della povertà e del-la debolezza potrebbero favorire il terrorismo. Dobbiamo svuotare ilbacino entro il quale si alimenta, attraverso due strade: l’apertura cultu-rale e della multiculturalità e, in secondo luogo, attraverso progetti disviluppo, perché il fondamentalismo si vince se si apre all’attenzione, alrispetto delle culture altrui.
Ritengo vada fatto molto sulla cooperazione allo sviluppo, abban-donando quelle forme di paternalismo, di neocolonialismo pietoso cheogni volta mettiamo in campo. Dovremmo partire dalle realtà di questiPaesi e cercare di fare interventi che valorizzino le loro risorse umane,le loro economie, e non sono convinto che esista un unico modello dieconomia.
Se vogliamo che la ricchezza di questo mondo, non solo quella e-conomica ma quella umana e culturale, non vada dispersa, vanno rispet-tate le diverse realtà dei Paesi, con le loro storie, le loro culture e tradi-zioni.
Ecco perché sostengo che, quando parliamo di immigrazione e dicooperazione, ci si presenta una complessità che chiama in causa, certa-mente gli interventi economici e gli interventi sul lavoro, ma che esigesoprattutto una apertura culturale totalmente diversa da quella che ab-biamo avuto sino ad ora.
286
CONCLUSIONI
GIANFRANCO FINI
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
Ringrazio Pietro Larizza e Giorgio Alessandrini per aver organiz-zato questa importante sessione di confronto. Mi sembra che le duegiornate che avete alle spalle dimostrino quanto il CNEL possa contri-buire, come del resto la nostra Costituzione prevede, alla elaborazionedi quelle che sono poi le politiche attive ai vari livelli tra azione del Go-verno, delle Regioni e delle Parti sociali e, pur essendo perfettamenteconsapevole di quel che diceva molto efficacemente Pezzotta, vale a di-re della complessità di un tema quale quello dell’immigrazione, sperodi non deludere le aspettative se affronterò la questione con un taglioleggermente diverso.
Nel senso che, non so se per caso o per scelta, ma il vostro conve-gno cade un anno dopo rispetto al 10 settembre 2002, giorno in cui fupubblicata quella legge, la 189, che porta anche il mio nome, e che ave-va la volontà, per certi aspetti la presunzione, di affrontare in modo di-verso un tema, quello dell’immigrazione nel nostro Paese, di fronte alquale - valutazione politica - qualche errore nel passato era stato com-piuto.
Per cui, preparandomi al confronto di oggi con voi, mi sono dettoche forse la cosa più corretta da fare era, un anno dopo, tentare un pri-mo bilancio. Tra l’altro è un riconoscimento al ruolo costituzionale del
287
CNEL. Allora, ancor prima di farlo in Parlamento, come del resto cisiamo impegnati a fare, questa è un’occasione altrettanto importante esolenne.
Quale era l’intendimento che avevamo nello stesso momento incui decidemmo di metter mano legislativamente ad una modifica pro-fonda, in termini culturali, rispetto all’ordinamento precedente?
Partivamo da un dato difficilmente contestabile: l’Italia si trovavain una condizione di fronte alla quale, non agire, avrebbe rappresentatouna responsabilità pesante. Dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezzadel Ministero degli Interni quantificavano in numero di non meno di unmilione, forse più, i cittadini extracomunitari residenti sul territorio na-zionale, esistenti sul territorio nazionale, senza alcuna garanzia, senzaalcun diritto, senza alcuna cittadinanza, sans papiers,condannati inevi-tabilmente allo sfruttamento, alla marginalità, alla clandestinità.
Una condizione di fronte alla quale non intervenire avrebbe com-portato una responsabilità di tipo morale, nel senso che eravamo, e sia-mo convinti, che se si vuol sconfiggere alla radice quella infezione cheè la xenofobia, tutto si può fare, tranne che tenere gli occhi chiusi difronte alla realtà.
Dico una cosa in modo molto diretto. Il nostro è un popolo che,per tradizione culturale, per storia, non conosce la xenofobia. Ma, a dif-ferenza di altri Paesi europei però - credo di dire cosa altrettanto vera -c’è stato un momento in cui, a fronte di una sostanziale impressione,vale a dire l’impossibilità o l’incapacità delle istituzioni di governare iltema dell’immigrazione, qualche sintomo di intolleranza, qualchepreoccupante segnale di rigetto c’era.
Non lo dico per giustificare le scelte che abbiamo fatto, anche per-ché credo che i numeri si incarichino di dimostrare che quelle scelte sisono rivelate esatte. Lo dico proprio perché ero e sono perfettamenteconsapevole, insieme ad altri, nel momento in cui abbiamo cominciatoa scrivere la legge, del fatto che, se il primo dovere è quello di un’inte-grazione solidale, se vogliamo davvero evitare che l’immigrato vengaconsiderato solo un lavoratore, perciò solo una “merce”, se vogliamotenere alto il piano della discussione, quindi confrontare anche aspettidi tipo culturale, se è vero tutto ciò è altrettanto vero che in Italia dove-
288
vamo contemperare le due esigenze, quella di un’effettiva solidarietà e,al tempo stesso, quella dell’affermazione di un principio di legalità che,a mio modo di vedere, era richiesto anzitutto da chi bussava alle portedel nostro Paese.
Quando si parla di sicurezza non la si deve vedere solo nell’otticadel cittadino italiano che chiede, a mio modo di vedere giustamente,che ci sia maggior sicurezza e quindi auspica che non vi siano fenomeniche possano sfuggire al controllo da parte delle autorità. La garanzia disicurezza io la vedevo, e la vedo, con la stessa intensità dalla parte dicolui che entra nel territorio nazionale, sia sicurezza in termini sociali,sia in termini civili.
Il primo diritto di colui che entra in Italia, credo sia quello di esse-re considerato alla stregua, da ogni punto di vista, di chi è nato in Italia.Voi sapete meglio di me che il dramma di coloro che entrano nel territo-rio nazionale senza avere il permesso, senza essere in regola, è anzituttoil dramma di quella clandestinità che comporta una marginalizzazione,uno stato di frustrazione.
La sicurezza, e nella legge questo concetto è molto chiaro, non èsolo l’aspetto connesso all’azione del Ministero degli Interni, ma è con-nesso soprattutto al dovere che avvertivamo di garantire un’effettivaintegrazione.
Cosa è accaduto un anno dopo? Non è azzardato dire che in Italiaabbiamo, un anno dopo, un numero di immigrati regolari di gran lungamaggiore. Di converso abbiamo un numero di clandestini minore, masoprattutto abbiamo assunto sul punto, sia in sede europea, sia sul pianointernazionale, un dinamismo maggiore rispetto a quello che aveva ca-ratterizzato l’azione delle istituzioni nel passato.
In questa sede non spendo una parola per ricordare la differenzasostanziale tra regolarizzare e sanare. Mi ha colpito il fatto che i duetermini siano stati utilizzati come sinonimi. Non si tratta di sinonimi.Nel passato altri Governi avevano individuato il giorno limite per lapresenza sul territorio nazionale, con la sanatoria, il nostro Governo hadato vita ad una scelta diversa. Ha certamente indicato il giorno, manon ha legato la regolarizzazione alla presenza sul territorio; ha legatola regolarizzazione alla dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di
289
lavoro, dando vita a quella che è stata chiamata la più massiccia azionedi emersione dal lavoro nero, e quindi di emersione dallo sfruttamento,realizzata negli ultimi tempi.
Vi dico, e questo è un elemento aggiuntivo rispetto ai dati cono-sciuti, che la gravità della situazione era talmente rilevante che anchenoi sbagliammo le previsioni. Pensavamo a non più di 400-500 miladomande di regolarizzazione e ci siamo trovati a dover fronteggiare750-800 mila domande di regolarizzazione.
Qualche elemento positivo su come questo sforzo è stato supporta-to. Piccola cosa rispetto ai temi alti che sono stati trattati, innanzituttoabbiamo evitato quel fenomeno mortificante che nel passato aveva ca-ratterizzato le lunghe file davanti alle Questure. È una piccola cosa, mac’è modo e modo per dimostrare rispetto dell’altrui dignità e per dimo-strare capacità delle istituzioni di governare fenomeni complessi. Laconvenzione fatta con le Poste italiane ha consentito di distribuire il la-voro sul territorio nazionale e io confermo che, al 31 dicembre del2003, prevediamo che siano almeno 650.000 gli extracomunitari che a-vranno il regolare contratto di lavoro, accompagnato dal versamento deicontributi, dall’assistenza sanitaria, dal pagamento delle tasse, in uncontesto quindi di sicurezza sociale per l’immigrato. Ancor prima di va-lorizzare l’aspetto della sicurezza relativa ai controlli di polizia, io vo-glio valorizzare questo aspetto. Noi abbiamo dato vita ad un’azione dieffettiva solidarietà ed integrazione che ha messo centinaia di migliaiadi lavoratori, che erano nel territorio nazionale e che erano oggetto disfruttamento, nella condizione di acquistare piena cittadinanza attiva.Personalmente, ritengo che i tempi per discutere, ad esempio, del dirittodi voto, almeno per le amministrative, per coloro che sono sul territorionazionale, siano maturi, ma prima di parlare di questi livelli certamentealti da un punto di vista di confronto tra il nostro ordinamento e quelloeuropeo, per un attimo rendiamoci conto che con la nuova legge si è da-to corso ad un riconoscimento di cittadinanza attiva e di piena dignità edi diritto di integrazione che era stato richiesto in moltissimi convegni,declamato in mille circostanze, ma che scontava poi qualche oggettivoproblema nel momento in cui si tentava di passare dalle buone intenzio-ni ai fatti.
290
Piccola considerazione marginale. Per la prima volta si è capitoche lo Sportello unico della Pubblica Amministrazione può funzionarequando c’è una certa sinergia, perché è vero che non abbiamo, a diffe-renza di altri Paesi, un unico luogo decisorio in seno al Governo perfronteggiare un tema così complesso quale quello dell’immigrazione.Per altri campi lo abbiamo fatto, ad esempio, sapete che per il coordina-mento delle politiche antidroga abbiamo dato vita ad un apposito Dipar-timento presso la Presidenza del Consiglio. Per le tematiche collegateall’immigrazione non abbiamo dato vita a questa scelta, proprio perchéè tema trasversale che riguarda il lavoro, riguarda la pubblica istruzio-ne, le politiche sociali, l’aspetto collegato all’ordine pubblico. Però, purcogliendo la pertinenza dell’osservazione, ricordo a me stesso che, difronte al fenomeno della regolarizzazione di centinaia di migliaia di do-mande, lo Sportello unico della Pubblica Amministrazione ha funziona-to.
Come avviene la regolarizzazione, attraverso il confronto, pressola sede deputata istituzionalmente preposta, il confronto tra coloro chedovevano dimostrare l’esistenza del lavoro in essere e coloro che devo-no garantire che quel lavoro sia, a parità di diritti e di doveri, inseritonella nostra legislazione. Credo che, tra tante cose che tutti siamo abi-tuati a mettere in evidenza non funzionanti nel nostro sistema, questo a-spetto meriti, al contrario, una considerazione positiva.
Dico subito, perché mi sembra l’aspetto più innovativo, nella leg-ge, che ha una sua flessibilità, perché la legge non risponde ad una logi-ca emergenziale, eravamo di fronte ad un tema in qualche modo dettatodalla grandezza dei numeri, perciò, per certi aspetti, carico di drammati-cità, ma la legge è una legge di sistema.
La legge ha la presunzione di andare al di là di quello che era ilmomento dell’emergenza. Dico subito che, nel momento in cui arrive-remo al termine della regolarizzazione - e io confermo che il Governoentro il 31 dicembre presenterà in Parlamento il bilancio che stiamotracciando della regolarizzazione e molti profeti di sventura sarannosmentiti ancora una volta dai fatti - nel momento in cui ci accingiamo adichiarare chiuso il percorso della regolarizzazione, dovremo preoccu-parci, e lo stiamo facendo, di garantire che il sistema sia funzionale an-
291
che per il prossimo futuro. Non solo eliminando la rigidità della doman-da che deve incrociare l’offerta, ma completando quello che è il colle-gamento fra le Prefetture, le Ambasciate, i Consolati.
Noi non escludiamo affatto - lo dico a Parisi, ma anche ad altri e-sponenti delle parti sociali che hanno posto questa questione - in futuro,e non parlo di un futuro tra anni, ma di un futuro che può essere traqualche mese, di fare a meno del meccanismo nazionale delle quote diingresso. Lo dico perché la nuova legge afferma il principio del raccor-do stretto tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro, e questo è atutti noto. Ma dico, anche qui, a chi ci accusava di dar vita ad una poli-tica che non sarebbe stata capita dall’Europa o peggio ancora sarebbestata contestata dall’Europa, che dovrebbe riflettere sulla scarsa lungi-miranza di quell’accusa, perché l’Europa sta facendo esattamente quel-lo che l’Italia ha anticipato. E non lo fa adesso che noi abbiamo il Se-mestre di Presidenza, lo sta facendo da qualche tempo.
In Europa, lo sapete, è in corso di elaborazione una risoluzione chesi muove esattamente nella direzione che il Governo italiano ha antici-pato. Una risoluzione che in qualche modo subordinerà, condizionerà, ilpermesso di soggiorno al possesso del contratto di lavoro. Poiché que-sta è la tendenza europea, è evidente che il problema delle quote di in-gresso è un problema che si pone, perché, completata la rete telematica,messi anche per la tecnologia che lo consente in correlazione i dati del-la domanda e i dati dell’offerta, si può pensare di far entrare in Italia,prescindendo dai limiti quantitativi, tanti lavoratori stranieri quanti con-tratti di lavoro saranno effettivamente a disposizione. Poi è evidente chesi dovrà lavorare, ma questo la legge lo prevede, per favorire la forma-zione professionale, per considerare in modo privilegiato quegli Statiche dimostrano un’effettiva volontà di collaborazione, perché non è so-lo il problema relativo alle espulsioni.
Quando ci si accusa di aver fatto una legge che parte dal problemadella sicurezza, come se questo problema fosse finto, si dice una cosache non corrisponde allo spirito della legge. È vero che noi consideria-mo, sul tema della prevenzione e dell’espulsione, importante la collabo-razione degli Stati - e colgo l’occasione della presenza del Ministro delLavoro albanese, Valentina Leskaj per ribadire che il Governo albanese,
292
negli ultimi tempi, ha dato vita ad una politica, non solo di fattiva colla-borazione, ma ha dimostrato, perché i numeri non dicono bugie, che ilcanale d’Otranto non è più zona sensibile, ha dimostrato che, quandoc’è reciproca volontà si fronteggia il problema. La legge considera ilrapporto bilaterale tra gli Stati e - in un’ottica più ampia il rapporto del-l’Unione con i Paesi rivieraschi del Nord-Africa, con i Paesi che sono aldi fuori dell’Unione Europea - essenziale, non solo per fronteggiarel’ingresso dei clandestini, ma per fare in modo che vi sia un’adeguataformazione di coloro che entrano sul territorio nazionale e domani, al-l’interno del territorio dell’Unione, per dar vita ad una integrazione ba-sata sul lavoro.
Io non voglio eludere il problema. È indubbio che non si tratti solodi una questione economica, ma è altrettanto vero che, se noi vogliamogarantire la dignità dell’uomo, dobbiamo garantire il lavoro e, se nonfacciamo questo, rischiamo di rendere più difficile l’obiettivo della pie-nezza dei diritti e dei doveri, l’assenza di ogni discriminazione, il ri-spetto di ogni diversità e di ogni identità linguistica, religiosa e cultura-le. Mi fa specie sottolinearlo in questa sede! Non c’è una visione econo-micistica, non c’è la logica tardo capitalista, ma c’è la considerazioneper cui, chi entra in Italia e chi oggi viene in Europa mosso da quellamolla fondamentale che è il bisogno, la fame, chiede anzitutto di poterlavorare, chiede di poter fare quello che l’italiano o l’europeo facevacinquanta o cento anni fa, lavorare per liberare se stesso dal bisogno,per affrancare la famiglia, per inviare il capitale laddove la famiglia èrimasta. Problemi noti, non credo che vi sia insensibilità da questo pun-to di vista.
Anche qui, nella legge, se la si guarda con attenzione e se la siconfronta con i dati di fatto, si scopre che le cose poi vanno molto me-glio di quel che qualcuno preventivava. L’ho detto in relazione alla re-golarizzazione, ancor più semplice è dimostrarlo in ragione dell’altrotema che era quello del controllo della clandestinità. Non si può dar vitaad una politica che alzi muri, sarebbe banale pensarlo, ma non possia-mo far finta di non sapere che, se vogliamo garantire effettiva integra-zione, se vogliamo garantire una leale collaborazione, se vogliamostroncare ogni forma di xenofobia, noi dobbiamo distinguere in mododirei evidente e cogente il lavoratore che è integrato nella società, in
293
quanto garantito nei suoi diritti e nei suoi doveri, dal fenomeno dell’im-migrazione clandestina.
Non esiste più un solo Paese che non attui questa distinzione. Mipermetto di dire che l’11 settembre tante volte è richiamato a sproposi-to. L’11 settembre ha dimostrato la necessità del controllo, perché la si-curezza è diventato uno dei bisogni primari del cittadino, ma questoproblema del controllo e della sicurezza era tema posto all’attenzione ditutte le pubbliche opinioni di tutti i Governi.
I numeri, che non dicono bugie, dimostrano che in Italia il feno-meno si sta attenuando. Il fenomeno dell’ingresso clandestino sta dimi-nuendo, perché funziona la cooperazione tra gli Stati, si sta attenuandoperché funziona il fenomeno della regolarizzazione e quindi della pienaintegrazione, si sta riducendo perché abbiamo dato vita a misure di al-lontanamento che rendono meno agevole, per i mercanti di schiavi e peri trafficanti, la collocazione, in questo caso sì della “merce”, nel territo-rio nazionale.
Spero di non scandalizzare nessuno al riguardo, ma se siamo con-sapevoli - e lo siamo tutti - che dietro le “carrette del mare” c’è la spe-culazione, c’è la criminalità, c’è la mafia, c’è la quintessenza del di-sprezzo nei confronti della dignità umana, se è così, è altrettanto evi-dente che, laddove ci sono delle politiche atte a contrastare questo feno-meno, si determina ovviamente, per chi organizza quel fenomeno, unadifficoltà aggiuntiva.
In Italia il fenomeno dello sbarco clandestino è in notevole dimi-nuzione, proprio perché sono cambiate non solo le leggi, ma le azionidelle istituzioni, e nei confronti di quei criminali, e nei confronti di queiPaesi che sono con noi chiamati a collaborare.
A parità, dal primo gennaio del 2001 al 15 settembre del 2001, ab-biamo avuto 13.888 sbarcati sul territorio nazionale, dal primo gennaio2002 al 15 settembre 2002 ne abbiamo avuti 17.360, dal primo gennaio2003 al 15 settembre di quest’anno, ne abbiamo avuti 9.865, la metà diquello che è accaduto lo scorso anno. Per completezza di dati bisogne-rebbe considerare anche gli allontanamenti, perché, una volta sbarcati,come sapete, il problema non lo si risolve se non dando vita, da un latoa quella politica di integrazione per chi chiede l’asilo politico, dall’altro
294
lato con l’accompagnamento alla frontiera per chi non rientra in questecondizioni.
Un’ultima considerazione circa la flessibilità in relazione alla leg-ge Biagi, in ordine al mercato del lavoro che si è modificato.
Credo che, da questo punto di vista, ci si debba confrontare. Iocontinuo a ritenere che la legge sia tutt’altro che rigida. Ricordo che,nello stesso momento in cui si prevedono sei mesi di tempo, cessato ilcontratto di lavoro per trovarne un altro, si dà in qualche modo perscontato che quel cittadino non sia una merce, non sia ridotto al rangopoco dignitoso di produttore di benessere, non è il calcolo della mano-dopera, è un uomo. E sei mesi, se il mercato tira, sono un arco suffi -ciente per ritrovare il lavoro. Il problema si pone nei momenti di condi-zione economica di stagnazione, nei momenti di difficoltà. Prevedereforme di ulteriore flessibilità, perché abbiamo cambiato la legislazionenazionale, mi sembra idea che debba essere perseguita, ma - vorrei chequesto elemento fosse in evidenza - non si può dire che la legge che ab-biamo predisposto sia una legge che deprime la dignità del lavoratoreperché lega il suo permanere sul territorio nazionale al contratto di la-voro. Se fosse stato così, avremmo detto che, chi perde il lavoro, se neva.
Al contrario, riteniamo che, chi perda il lavoro, abbia e debba ave-re la possibilità di trovarne un altro, ovviamente in ragione di quellache è la condizione del mercato, in ragione della capacità di dialogo conle parti, in ragione della capacità degli enti locali di corsi di preparazio-ne e di adeguamento professionale, perché, se è sempre più difficile in-crociare la domanda e l’offerta, è proprio perché in molti casi c’è unaeccedenza di offerta e, al contrario, c’è una domanda sempre più quali-ficata.
Anche qui, però, se vogliamo uscire dal reciproco confronto ani-mato più che dalla volontà di risolvere il problema, da schemi o da pre-giudizi culturali, dobbiamo anche essere consapevoli che, per renderequesto percorso più agevole, dobbiamo investire risorse, non solo sul-l’aspetto collegato alla professionalità, ma dobbiamo investirle sull’a-spetto collegato alla capacità del cittadino, che giunge in Italia per lavo-rare, di integrarsi nel senso letterale della parola.
295
Io sono convinto che il primo processo di integrazione, fermo re-stando ovviamente il rispetto delle identità, consista nella capacità di e-spressione, nell’uso e nella padronanza della lingua. Non voglio aprirea latere altri elementi di confronto, ma la storia dell’immigrazione ita-liana nel mondo - che è nota, almeno in questa sede - evidentementenon tutti la ricordano bene. Quando si dice che agli italiani non veniva-no chieste le impronte digitali, credo “si sia visto un altro film”! Andatea vedere il museo dell’immigrazione a New York e vi renderete contoche, almeno per quell’epoca, vi erano forme che oggi considereremmotutt’altro che compatibili con il vivere civile. Certo si tratta di un secolofa, ma la storia dell’immigrazione italiana nel mondo è in molti casi lastoria di chi rimane orgoglioso di un’identità e il più delle volte vede lapermanenza sul territorio che lo ospita come forma di affrancamento daun bisogno - quanti Paesi del Sud si sono risollevati con le rimesse de-gli emigranti, e non solo del Sud e qualcuno dovrebbe capirlo al Nord -ma la storia della nostra immigrazione è anche una storia di integrazio-ne che passa attraverso l’apprendimento della lingua.
Non riesco a capire come in Italia questa elementare considerazio-ne si scontri, qualche volta, con la logica di chi obietta di ritenere ingiu-sto negare a coloro che vengono qui il diritto di continuare ad avere laloro identità, la loro forte connotazione etnico, religiosa, culturale, lin-guistica. Nessuno vuol negare nulla, ma diciamolo in termini chiari cheè molto più utile un corso di italiano che un corso di lingua araba percoloro che giungono qui, perché se non lavoriamo per una integrazione,che significa capacità di rivendicazione dei propri diritti attraverso lacapacità di esprimersi, li condanniamo ad essere cittadini di serie “b”.
Non esiste un cittadino che esercita parità di diritti e di doveri senon è in grado di comunicare, se non è in grado di esprimersi. È ovvia-mente un discorso a latere, rispetto al tema della immigrazione, machiama in causa il tema della integrazione.
Non mi sottraggo, infine, sul tema della cooperazione, su cosadebba fare l’Europa e non c’è dubbio che un’Europa che voglia esseregaranzia di stabilità, di pace, di progresso nel mondo - ne abbiamo di-scusso alla Convenzione - si debba porre il problema di essere protago-nista attivo e non debba essere solo - lo diceva la Di Salvo - il luogo del
296
confronto. Però è altrettanto vero che questo è un processo che, se pren-de il via, svilupperà i suoi effetti nel corso del tempo.
Il testo della Costituzione europea uscito dalla Convenzione, permolti aspetti, è al di sotto di quelle che sono le aspettative, ma è un pas-so indispensabile da compiere se vogliamo che l’Europa non sia solo ildato economico, se vogliamo che abbia un suo protagonismo politico epoi magari riesca a darsi anche una sua identità culturale comune. Manon c’è ombra di dubbio che dobbiamo approvare quella Costituzioneuscita dalla Convenzione anche se è un passo indietro rispetto ad alcunetematiche che sono state poste anche qui.
L’alternativa è il nulla o, se volete, l’alternativa è la fotografia di u-na dimensione europea in cui, in termini economici, siamo già protagoni-sti, ma in termini politici siamo sempre e solo spettatori. Non lo dico soloin riferimento a quando ci sono i conflitti, lo dico anche per quando sitratta di regolare dei fenomeni. È stato proprio il richiamo al deficit di ca-pacità propositiva dell’Europa a Cancun, perché l’Europa non parla unasola lingua quando si confronta su questi scenari internazionali.
Allora la legge ha raggiunto l’obiettivo che si era dato, vale a direbonificare una palude. Oggi il fenomeno della clandestinità è un feno-meno che è rientrato in una percentuale di carattere europeo. Nella leg-ge è chiara la strategia e la volontà del Governo di garantire la piena in-tegrazione partendo dal riconoscimento di quel diritto che il lavoratoreha, nello stesso momento in cui lo si mette alla pari con il lavoratore na-zionale, di non subire alcuna discriminazione.
La legge ovviamente può e deve essere migliorata perché nessunalegge è statica in uno scenario che, al contrario, cambia rapidamente.
Ma credo che, se per davvero, così come era intenzione di tutti, sivuol dar corso ad una politica capace di coniugare solidarietà e legalità,perché di questo si tratta, la solidarietà è nell’azione quotidiana delle i-stituzioni. Non solo, la legalità non può essere vista solo come la tuteladel cittadino italiano, perché non è così nella nostra legge, la legalità vavista anzitutto come tutela della piena e pari dignità di colui che vienein Italia e non è ospite.
Voglio concludere così: la nostra emigrazione cosa dimostra? Cer-tamente le rimesse e il ritorno di tanti italiani, ma c’è anche l’altra pagi-
297
na: il mondo è pieno di discendenti italiani che, nei Paesi che li hannoospitati, sono giunti al vertice della società. Quanti parlamentari di ori-gine italiana, quanti imprenditori, quanti scienziati in giro per il mondo!La sfida è fare in modo che in Italia, fra trenta o cinquant’anni, ci sianoi discendenti degli amici, dei lavoratori che sono giunti dal Nord Africa,dalle Filippine, dal Centro e Sud America, anch’essi al vertice della so-cietà italiana, perché questa è l’integrazione.
Dobbiamo essere consapevoli che il tema non è controllare ed evi-tare che ci sia clandestinità. Il tema è come facciamo a far sì che, senzatraumi nella nostra società, ci sia una integrazione tale da determinare,non una prospettiva multietnica - non so se ci sarà - in Italia ed in Euro-pa quel che è già accaduto nei Paesi che un tempo ricevevano gli emi-granti. Vale a dire la piena integrazione e la nascita di una società pro-fondamente diversa rispetto a quella che si confrontava con l’immigra-zione. Gli Stati Uniti, il Canada, l’Australia di oggi sono mille miglialontani da quel che erano quando ricevevano gli italiani. L’Italia, tracinquant’anni sarà profondamente diversa rispetto all’Italia che oggi siconfronta con il tema dell’immigrazione.
298
APPENDICE 1
CONTRIBUTO DELLA COMMISSIONEEUROPEAPERLA IIª SESSIONEDI LAVORO
“Quadro giuridico comunitario e controllo delle frontiere esterne”
1) Introduzione
Il controllo delle frontiere esterne è un tema politicamente ipersen-sibile, che è fortemente influenzato dalle politiche d’immigrazione e, asua volta, ha un impatto sostanziale sull’immagine dell’Unione Europeanel mondo ed in particolare nei Paesi Terzi vicini. Su quest’assunto sibasano le linee portanti della politica comunitaria in questo campo:
a) massima sicurezza e rigore assoluto, lungo tutto il perimetro dellefrontiere esterne che non possono essere un colabrodo, nei cui buchitutti i malintenzionati possano infilarsi indisturbati;
b) allo stesso tempo, impegno a garantire la capacità permanente di fil-tro alle frontiere per lasciare entrare tutti coloro che sono in regola, eil cui ingresso testimonia la volontà europea di non chiudersi nellaFortezza Europa.
L’insieme giuridico ed istituzionale creato e sviluppato dalla Com-missione Europea insieme con gli Stati membri per elevare la qualitàdella gestione delle frontiere esterne degli Stati membri nel quadro piùvasto del complesso di misure atte ad inquadrare e controllare i flussimigratori in provenienza dai Paesi Terzi.
L’esposizione si basa sulla descrizione di due strumenti, che si so-no sviluppati nel corso di questi anni, seguendo anche l’evoluzione del-la sicurezza internazionale.
299
Il primo strumento è dato dall’esistenza di un dispositivo giuridicocomune: l’apparato di norme Schengen.
Il secondo è dato dallo sviluppo di una cooperazione operativa raf-forzata e permanente tra gli Stati membri, che sfocia nella definizione emessa in opera di una politica comune ed integrata per la gestione dellefrontiere esterne.
Le frontiere esterne sono quelle degli Stati membri, aderenti allospazio Schengen, con i Paesi Terzi. Talvolta si parla di frontiere esternedell’Unione Europea: esistono giuridicamente solo quelle statuali.
Le parole “Stato membro” si riferiscono ai Paesi partecipanti allospazio Schengen: vale a dire tutti gli Stati membri dell’UE, salvo Irlan-da e Regno Unito. La Danimarca ha pure una posizione particolare,mentre Norvegia ed Islanda sono associate al processo d’esecuzione esviluppo dell’apparato di norme/acquis di Schengen e sono membri delComitato Misto in seno al Consiglio dei Ministri.
2) ll quadro giuridico europeo
Assicurare un alto livello di protezione delle nostre frontiere ester-ne è strettamente funzionale all’esercizio del diritto di libera circolazio-ne dei cittadini europei e dei Paesi Terzi tra gli Stati membri, tra i qualil’applicazione delle regole di Schengen ha permesso d’eliminare lefrontiere interne.
La premessa politica e giuridica per eliminare i controlli interni al-le frontiere tra gli Stati membri, siano esse terrestri, marittime o aeree, èdata dall’applicazione di un dispositivo comune agli Stati membri ade-renti per i controlli e la sorveglianza alle frontiere esterne.
Un complesso di norme che vanno sotto il nome di Acquis diSchengen. Vale a dire la Convenzione di base, quella d’applicazione ealtre norme relative alle modalità d’applicazione.
Quest’apparato di norme convenzionali e frutto di accordi intergo-vernativi, conclusi a latere della tradizionale produzione legislativa co-munitaria, è stato incorporato, il Primo Maggio 1999, nel quadro giuri-dico comunitario e dell’Unione Europea col “Protocollo di Amster-dam”, allegato al relativo Trattato. Il Titolo IV del Trattato CE discipli-na le materie comunitarie come l’attraversamento delle frontiere ester-
300
ne, che rilevano del cosiddetto Primo Pilastro. D’altro canto, il TitoloVI del Trattato sull’Unione Europea regola misure di sicurezza com-pensative come la cooperazione di polizia e giudiziaria che rilevano delcosiddetto Terzo Pilastro.
Essenzialmente, queste norme Schengen in materia di frontiere e-sterne coprono i seguenti punti:
Principi comuni e uniformi per i controlli e la sorveglianza allefrontiere esterne degli Stati membri.
Regime comune per gestire l’ingresso di stranieri, non comunitari,per soggiorni non superiori a tre mesi nello spazio comune di libera cir-colazione.
Condotta comune delle guardie di frontiera per trattare le personenon ammissibili.
Obblighi uniformi per gli Stati membri per il tipo e le modalità deicontrolli e della sorveglianza alle frontiere esterne per garantire che illivello di protezione sia equivalente dappertutto. Esempio: tutte le per-sone che attraversano i posti autorizzati di passaggio devono esserecontrollate con verifica sistematica della loro identità.
Uniformi disposizioni per la responsabilità dei trasportatori e dellepersone che organizzano o favoriscono il traffico d’esseri umani o l’im-migrazione illegale.
Creazione del Sistema d’Informazione Schengen - SIS per lo stoc-caggio e lo scambio tra gli Stati membri d’informazioni sulle personesospette e non ammissibili nello spazio Schengen. Le autorità nazionaliper i controlli alle frontiere possono accedere a questa banca dati percontrollare la posizione di certe persone che attraversano la frontiera e-sterna al fine di garantire la funzione di filtro per la sicurezza interna.L’accesso a questi dati è obbligatorio per le autorità consolari degli Sta-ti membri prima di rilasciare un visto ad uno straniero.
Un meccanismo di sorveglianza reciproca tra gli Stati membri del-la corretta applicazione delle norme comuni per l’attraversamento dellefrontiere esterne. Tale meccanismo, incardinato nella CommissionePermanente di Valutazione e d’Applicazione di Schengen, ha due scopidistinti:
301
Valutare la situazione di nuovi stati aderenti in vista della decisio-ne del Consiglio che li autorizzerà ad applicare l’acquis di Schengen.
Verificare in seguito che gli Stati membri applichino correttamentel’acquis di Schengen.
L’applicazione delle norme Schengen, ha prodotto i benefici attesie permesso di eliminare le frontiere interne tra gli Stati membri. Tutta-via, non tutti i problemi di qualità ed efficacia nei controlli e nella sor-veglianza alle frontiere esterne sono stati risolti.
3) Verso una politica comune ed integrata per la gestione delle frontie-re esterne
Infatti, le valutazioni e le verifiche condotte dalla Commissione edagli Stati membri, nonché l’impulso dato dal Consiglio Europeo diLaeken del dicembre 2001, in seguito ai tragici eventi terroristici diNew York del settembre dello stesso anno, hanno spinto la Commissio-ne e gli Stati membri a prendere atto della necessità urgente di elevare illivello di sicurezza alle nostre frontiere esterne per garantire la sicurez-za interna. C’è stata unanimità nel constatare l’inadeguatezza del dispo-sitivo comune esistente, nonché una serie d’esigenze gravi, urgenti ecomuni nel settore del controllo delle frontiere esterne e nel concepire,adottare e gradualmente realizzare una politica comune per la gestionedelle frontiere esterne.
E tutto questo si è fatto nello spazio di qualche mese: il che provaancora una volta che quando c’è la volontà politica degli Stati membri,l’Europa si muove rapidamente ed efficacemente per darsi i mezzi co-muni nell’interesse dei cittadini europei.
Il Consiglio Europeo di Laeken osservò che la lotta al terrorismo,all’immigrazione clandestina ed alle organizzazioni che la gestisconoha bisogno di una gestione più efficace delle frontiere esterne degli Sta-ti membri. A tal fine occorrono meccanismi di cooperazione tra i servi-zi nazionali per i controlli e meccanismi o servizi comuni di controlloalle frontiere esterne.
Nella sua Comunicazione del 7 maggio 2002, la Commissione in-dividuò una serie di punti deboli nelle pratiche operative dei servizi na-zionali, che continuavano a lavorare ciascuno per proprio conto e conmodalità proprie.
302
La diagnosi della Commissione stabilì, tra l’altro, la necessità diun miglioramento e di un’armonizzazione delle strategie e delle prati-che dei servizi nazionali addetti ai controlli ed alla sorveglianza dellefrontiere esterne nel valutare i rischi, nell’impiego delle risorse e nellaformazione del personale.
A questa diagnosi, la Commissione fece seguire une proposta diterapia consistente in cinque punti fondamentali:
(1) Un corpus legislativo comune.
(2) Un meccanismo comune di concertazione e di cooperazione operativa.
(3) Una valutazione comune dei rischi.
(4) Una formazione comune ed europea per il personale addetto ai con-trolli e attrezzature interoperative.
(5) L’applicazione del principio di solidarietà finanziaria comunitariaper assistere quegli Stati membri, le cui frontiere sono maggiormen-te esposte ai fenomeni da combattere.
Nel giugno 2002, il Consiglio GAI adottò un Programma d’Azio-ne, che ricalcava le proposte della Commissione. Tale programma è sta-to in parte realizzato e per il resto è in fase di realizzazione. Esso preve-de azioni ed iniziative della Commissione e degli Stati membri in cam-po giuridico, istituzionale ed operativo. Una Road Map ne verifica larealizzazione.
Il Consiglio Europeo di Siviglia, nello stesso giugno 2002, incitòCommissione e Consiglio a proseguire nella realizzazione della politicacomune per la gestione delle frontiere esterne.
Sul piano istituzionale, in seno al Consiglio si è creato un’UnitàComune dei responsabili nazionali delle frontiere esterne per dar loromodo e capacità di lavorare insieme per trovare le soluzioni più appro-priate ed efficaci.
Sul piano operativo, una serie di progetti ed operazioni congiunte,approvate e coordinate dall’unità comune e co-finanziate dal Program-ma comunitario ARGO, è stata avviata dagli Stati membri.
Intanto la Commissione lavorava per l’applicazione del principiodi solidarietà finanziaria tra gli Stati membri e per un cofinanziamento
303
comunitario in favore degli Stati, le cui frontiere sono particolarmenteesposte, a causa della loro posizione e delle loro caratteristiche, ai flussid’immigrazione illegale.
In questo campo, nell’immediato il bilancio comunitario ha messoa disposizione del programma ARGO ed in particolare del settore rela-tivo alla gestione delle frontiere esterne, il quasi raddoppio dei fondiper il 2003 e 15% per il 2004. Questi fondi sono utilizzati per sviluppa-re la cooperazione tra gli Stati membri nell’attività quotidiana di con-trollo e sorveglianza e per i centri specializzati per tipo di frontiera. Essiservono ugualmente per sviluppare quelle attività fondamentali e comu-ni ai servizi nazionali, quali l’analisi comune dei rischi e un comune distandard di formazione professionale per le guardie di frontiera.
L’intensa attività di cooperazione degli Stati membri in questi ulti-mi mesi ha prodotto dei risultati tangibili ed utili.
L’iniziativa di uno o più stati ha dato vita a centri di cooperazionee coordinamento per le operazioni congiunte, specializzati per tipo difrontiera. A Berlino ci si occupa di organizzare con tutti gli stati che lovogliono, dei programmi di operazioni congiunte ai posti di frontiera diquesto o quello Stato, seguendo le indicazioni del Modello Comune diAnalisi dei Rischi, elaborato dal centro finlandese.
A Roma, il Centro per le frontiere aeree ha avviato anch’essoun’attività di cooperazione e coordinamento tra gli Stati membri permigliorare, tra l’altro, le attrezzature per il controllo dei documenti diviaggio e per il tempestivo allarme in caso di rischio.
Per quanto riguarda le frontiere marittime, seguendo i suggerimen-ti dello studio di fattibilità concluso lo scorso luglio, due centri distinti ecoordinati dall’unità comune potrebbero essere installati in due Statimembri. L’uno in Spagna sarebbe competente per il Mediterraneo Occi-dentale e l’Atlantico e l’altro in Grecia per il Mediterraneo Orientale.
Al Consiglio Europeo di Salonicco nel giugno scorso, gli Statimembri e la Commissione hanno fatto il punto sull’insieme degli aspet-ti rilevanti della gestione delle frontiere esterne su base di une comuni-cazione della Commissione del 3 giugno 2003 sullo sviluppo di una po-litica comune in materia d’immigrazione illegale, traffico d’esseri uma-ni, frontiere esterne ed il ritorno dei residenti illegali.
304
In questa comunicazione si passano in rassegna i diversi punti del-la politica comune e per quanto riguarda la gestione delle frontiere, sipromuove la realizzazione del VIS o VISA Information System, percontrollare la regolarità dei visti anche alla frontiera. Accanto a questosistema, si avviano le proposte per contrastare le possibilità di falsifica-zione dei documenti di viaggio e dei visti, ricorrendo ai dati biometrici.Le proposte relative della Commissione sono state adottate in settembree presentate al Consiglio dei Ministri.
Si conferma, inoltre, la definizione della politica comune ed inte-grata per la gestione delle frontiere esterne che ha al centro l’applica-zione del principio di solidarietà finanziaria e la cooperazione ed ilcoordinamento dei progetti e delle operazioni congiunte, la loro valuta-zione, la creazione dell’unità Comune e la costituzione di una strutturapermanente per la cooperazione operativa. Infine, si sollecita la revisio-ne del Manuale Comune per le frontiere esterne e l’adozione delle mi-sure sul piccolo traffico frontaliero.
Avendo valutato pregi e lacune di quest’intensa attività di coopera-zione, il Consiglio Europeo di Salonicco ha, da un lato, confermato lascelta di rafforzare le capacità di coordinamento dell’Unità Comune deicapi delle polizie di frontiera. Dall’altro lato, esso ha chiesto alla Commis-sione di esaminare la necessità di creare una struttura operativa per miglio-rare l’efficacia della cooperazione per la gestione delle frontiere esterne.
Cos’è questa struttura operativa?
La Commissione e gli Stati membri riconoscono i meriti ma anchei limiti obiettivi della cooperazione e del coordinamento gestito dall’u-nità comune in seno al Consiglio. Efficacia limitata o inadeguata e di-scontinuità nell’azione di coordinamento hanno convinto prima laCommissione e poi il Consiglio della necessità di una struttura operati-va permanente e dotata di poteri e mezzi adeguati.
Il consenso degli Stati membri si è manifestato proprio qui a Ro-ma, durante i lavori del Consiglio informale GAI dei 12-13 settembre.Essi sollecitarono una proposta d’atto comunitario per la creazione del-l’Agenzia per il coordinamento operativo dei centri e delle operazionicongiunte. I servizi della Commissione lavorano in tal senso per la pre-sentazione in Consiglio al più presto.
305
Questa nuova struttura dovrebbe, essenzialmente dare consistenzae coerenza permanente e visibile alle missioni di coordinamento e coo-perazione operativa tra le differenti azioni degli stati membri, nonchédelle attività dei centri, che abbiamo poco sopra menzionato. Inoltre,l’agenzia s’incaricherebbe delle missioni di definizione e sviluppo delModello comune di valutazione dei rischi e del nocciolo comune distandard della formazione professionale per le guardie di frontiera. Infi-ne essa dovrebbe avere un bilancio di funzionamento e di gestione perfinanziare le sue attività o quelle degli Stati membri, che rientrano nel-l’ambito delle sue attività istituzionali.
Con la realizzazione e l’avviamento dell’agenzia, il secondo stru-mento - quella di una politica comune ed integrata per la gestione dellefrontiere esterne - acquista un profilo concreto e visibile.
4) ConclusioneNegli ultimissimi anni, grandi passi in avanti sono stati fatti verso unapolitica comune per la gestione delle frontiere esterne.
La Commissione continua nel suo lavoro di proposta di riforma,riorganizzazione e sviluppo degli strumenti sopra descritti anche nellaprospettiva dell’ampliamento dell’Unione Europea e del rafforzamentodelle relazioni con i nuovi Paesi limitrofi, sia in Europa Orientale sianel Mediterraneo lavora per un’efficace relazione di buon vicinato.
306
SCHEMA DI PROPOSTA DI DIRETTIVA
relativa all’estensione dell’assistenza sanitaria per tutti gli stranieri, nonin regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno o richiedentiasilo, comunque presenti sul territorio dell’Unione Europea, per assicu-rare la piena realizzazione del diritto alla salute per ogni individuo.
Proponenti: Naga di Milano, Caritas di Roma, Oikos di Bergamo.Con ilpatrocinio della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e del CNEL.
Hanno aderito 50 enti e associazioni che si occupano del problemadella salute dei cittadini dei Paesi Terzi.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato cheistituisce la Comunità Europea, in particolare l’articolo 63, punto 3, vi-sto il parere del Parlamento Europeo, considerando quanto segue:
(1) Il trattato dispone che il Consiglio adotti misure in materia di poli-tica dell’immigrazione nei settori delle condizioni di ingresso e di soggior-no, ma anche dell’immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare.
(2) La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomoe delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, che è parte integrante deldiritto comunitario, all’articolo 3, proscrive “trattamenti disumani o degra-danti”, e fra questi rientra senza dubbio la mancata assistenza sanitaria.
(3) Il Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ri-badito la volontà di istituire uno spazio di libertà, di sicurezza e di giusti-zia. A tal fine è necessario che una politica europea comune in materia diasilo e di migrazione si prefigga, nel contempo, un trattamento equo per icittadini di Paesi Terzi e una migliore gestione dei flussi migratori.
307
(4) Il diritto alla vita, e di conseguenza il diritto alla salute per tutti gliindividui, è tutelato anche dall’articolo 35 della Carta dei Diritti Fonda-mentali dell’Unione Europea, elaborata a Nizza il 7 dicembre 2000.
(5) Secondo il principio di sussidiarietà, l’obiettivo dell’azioneprevista, vale a dire una cooperazione tra Stati membri in materia di as-sistenza sanitaria per i cittadini di Paesi Terzi temporaneamente non inregola con le norme relativa all’ingresso ed al soggiorno, non può esse-re sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a moti-vo degli effetti dell’azione in questione, essere realizzato meglio a livel-lo comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessa-rio per il raggiungimento di tale obiettivo.
Ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
Ai fini della presente direttiva:
a) per “cittadino di un Paese Terzo, non in regola con le norme relativeall’ingresso ed al soggiorno” s’intende qualsiasi persona che non ab-bia la cittadinanza di uno degli Stati membri e si trovi nel territoriodi uno Stato membro senza idoneo titolo di soggiorno;
b) per “cure urgenti” s’intendono le cure che non possono essere diffe-rite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona;
c) per “cure essenziali” s’intendono le prestazioni sanitarie, diagnosti-che e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell’immedia-to e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinaremaggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, croni-cizzazione o aggravamenti);
d) per “cure continuative” s’intendono tutte le prestazioni sanitarie neces-sarie a non vanificare i trattamenti intrapresi con la prestazione iniziale;
e) per “medicina preventiva” s’intende l’insieme delle misure sanitarievolte a evitare l’insorgenza e l’aggravamento delle forme morbose,come definito dai programmi di profilassi internazionale;
f) per “patologia grave” si intende una forma morbosa che ponga ingrave pericolo la vita stessa della persona.
308
Articolo 2
1. Agli stranieri presenti sul territorio dei singoli Stati, non in regolacon le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono assicurate -nei presidi pubblici o comunque parificati - le cure ambulatoriali e o-spedaliere urgenti o essenziali, (episodiche o continuative), per ma-lattia e infortunio. Ai medesimi soggetti sono estesi i programmi dimedicina preventiva, ivi compresi diagnosi e cura delle malattie in-fettive, a salvaguardia della salute collettiva ed individuale. Sono al-tresì garantite la tutela della gravidanza responsabile e della materni-tà, nonché la tutela della salute del minore, anche in esecuzione dellaConvenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo del20 novembre 1989.
2. Ai richiedenti asilo, (dalla presentazione dell’istanza di asilo, fino al-la definitiva conclusione della procedura per il riconoscimento dellostatus di rifugiato), è garantita l’assistenza sanitaria alle miglioricondizioni previste per i cittadini degli Stati membri.
Articolo 3
1. L’accesso alle prestazioni e alle strutture sanitarie dello straniero pre-sente sul territorio dei singoli Stati, non in regola con le norme rela-tive all’ingresso ed al soggiorno, non può comportare alcun tipo disegnalazione alle autorità di polizia, salvo i casi in cui ciò sia obbli-gatorio per i cittadini dello Stato.
2. Le prestazioni previste dall’articolo 2, ad eccezione delle prestazioni dibase che sono sempre gratuite, sono erogate dietro il pagamento dellequote di partecipazione alla spesa, quando previste dalla legislazionedei singoli Stati membri, a parità di condizioni con i cittadini.
Articolo 4
1. In nome del principio della continuità della cura, nessuna misura diallontanamento potrà essere presa nei confronti di un cittadino di unPaese Terzo - non in regola con le norme relative all’ingresso ed alsoggiorno, che si trovi sul territorio dell’Unione - che sia colpito dauna patologia grave, (né tale misura può essere presa nei confronti
309
dei suoi genitori o tutori se minore, o del coniuge). Durante tutto ilperiodo del trattamento, dovranno inoltre essergli garantite possibili-tà adeguate di lavoro ovvero di sostentamento.
Articolo 5
1. I livelli di assistenza, forniti ai cittadini dei Paesi Terzi, non in regolacon le norme relative all’ingresso ed al soggiorno ed ai richiedenti a-silo, devono essere equivalenti a quelli previsti per i cittadini delloStato membro, anche se forniti con differenti modalità.
Articolo 6
1. La protezione dei dati personali e la sicurezza dei dati sono garantiteai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Con-siglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisichecon riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-colazione di tali dati.
Articolo 7
1. Gli Stati membri compensano tra di loro gli squilibri finanziari chepossono eventualmente risultare dall’applicazione della presentedirettiva.
2. Per consentire l’applicazione del presente articolo il Consiglio adot-terà, su proposta della Commissione, i criteri e le modalità praticheappropriati.
Articolo 8
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regola-mentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente di-rettiva entro 18 mesi. Essi ne informano immediatamente la Com-missione.
2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengo-no un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffat-to riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità ditale riferimento sono decise dagli Stati membri.
310
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposi-zioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disci-plinato dalla presente direttiva.
Articolo 9
1. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.
Articolo 10
1. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva, in base altrattato che istituisce la Comunità Europea.
311
APPENDICE 2
RASSEGNA STAMPA
6 OTTOBRE 2003
Le agenzie
ANSA (12:47)Immigrazione: UE; cresce paura, un europeo su tre la teme. I timori più alti frachi non ha orientamento politico
ANSA (13:20)Immigrazione: UE; entro l’anno agenzia controllo frontiere. Lo annuncia rap-presentante Commissario Europeo Giustizia
ASCA (13:37)UE/Immigrati: per il 25% degli europei sono una minaccia. E la Spagna si sco-pre intollerante
ASCA SOCIALE (14:02)UE/Immigrati: De Almeida, si pensa ad agenzia controllo frontiere
ANSA (18:03)Immigrazione: formati all’estero in Italia fuori dalle quote. Italia avrà prelazio-ne per ingresso a fini di lavoro
ANSA (18:40)Immigrazione: UE; Conferenza CNEL, appello a Berlusconi. Esperti chiedonosanità per tutti e permesso per schiavi
ASCA SOCIALE (19:01)Immigrati: Sacconi, diritto di prelazione per chi studia italiano
ANSA (19:10)Immigrazione: UE; fra paure e novità, l’Europa cambia
312
7 OTTOBRE 2003
I quotidiani
IL SOLE 24 OREImmigrati, nuovi flussi 2004. Il Governo punta a emanare il decreto entro la fi-ne di dicembre(M. Lud.)
IL MESSAGGEROClandestini, il 15 alla Consulta la costituzionalità dell’arresto. Convegno al CNEL, il Governo: “Entro l’anno il decreto flussi per il 2004”(C.G.)
IL GIORNALEImmigrazione, pronta l’Agenzia per il controllo delle frontiere. Definita la proposta operativa. Sacconi: entro fine anno il decreto sulle quote2004 degli stranieri in Italia(Diana Alfieri)
IL TEMPOAgenzia dell’UE per il controllo delle frontiere.Entro l’anno il nuovo organismo sarà proposto dalla Commissione di Bruxel-les, con l’appoggio del governo italiano. Cresce fra i cittadini dell’Unione lapaura degli immigrati, soprattutto di quelli provenienti da Balcani e Paesiarabi
AVVENIREUE, cresce la paura dell’immigrazione: la teme uno su tre.Due anni fa il dato era fermo al 27 per cento. Per la prima volta c’è omoge-neità tra gli Stati: la percentuale scende in Italia, ma aumenta in Francia eSpagna.Le indagini presentate al CNEL rivelano che per l’81% degli intervistati lalotta all’ingresso dei clandestini è una priorità. Più preoccupati i ceti bassi echi non ha orientamento politico. In arrivo l’Agenzia europea per il controllodelle frontiere(Pino Ciociola)
IL MANIFESTOPolizia di frontiera: “Non sarà europea”Bruxelles boccia la proposta del governo italiano. “A respingere gli immigratinon ci saranno poliziotti misti.” Probabile invece l’Agenzia UE per il control-lo dei confini. L’annuncio ieri a Roma in un convegno del CNEL. L’Italia bac-chettata anche per la mancata attuazione della direttiva sull’asilo politico. Le
313
critiche del mondo cattolico.(Sara Menafra)
LIBERAZIONELa Fortezza Europa ha paura dell’“uomo nero”Migranti, le statistiche diffuse dal CNEL(Giada Valdannini)
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOIn Europa cresce la paura per gli arrivi di immigratiIndagine. Più sei per cento negli ultimi due anni
LA PADANIALa grande pauraUna statistica rivela che in Europa un cittadino su tre teme l’immigrazione.L’onorevole Borghezio: “Questo sondaggio è la prova migliore di quanto le tesisostenute da sempre dalla Lega Nord siano condivise in tutta l’Unione Europea”
IL GIORNALE DI VICENZA - L’ARENAL’Europa vuole Schengen II. “Paura dell’immigrazione”UE. Partono nuovi progetti per la sicurezza: saranno archiviati milioni di dati
LA PROVINCIA DI COMOImmigrati: cresce la paura
Le agenzie
ANSA (13:20)Immigrazione: Parisi; basta con le quote, ci vuole qualità
ADNKRONOS (13:31)Immigrati: Parisi, basta con le quote puntiamo alla qualità
ANSA (13:49)Immigrazione: Fini, tempi maturi per diritto di voto almeno nelle elezioniamministrative
ASCA SOCIALE (13:53)Immigrati: Fini, tempi maturi per voto amministrativo
ANSA (13:56)Immigrazione: Fini, quote potrebbero sparire
314
ADNKRONOS (13:59)Immigrati: Fini, maturi i tempi per discutere diritto voto, almeno in sedeamministrativa
ADNKRONOS (14:01)Immigrati: Fini, al 31/12 2003 650mila con contratto regolare, a breve forse fa-remo a meno del meccanismo quote ingresso
APBISCOM (14:02)Immigrazione: Fini, diritto di voto, è tempo di discuterne
AGI (14:04)Immigrazione: Fini, tempi maturi per diritto al voto
APBISCOM (14:05)Immigrazione: Fini, a fine anno almeno 650 mila regolarizzati. “Sbarchi clan-destini dimezzati”
ASCA (14:08)Immigrati: Fini, tempi maturi per voto amministrativo
RADIOCOR (14:12)Immigrati: Fini, si può discutere voto amministrativo
ASCA (14:21)Immigrati: Fini, non escludo fine meccanismo quote ingressi
ASCA SOCIALE (14:27)Immigrati: Sindacati, riconoscere diritto voto e cittadinanza
RADIOCOR (14:34)Immigrazione: Parisi, “buttare via le quote d’ingresso”
ADNKRONOS (14:57)Immigrati: Fini, nostra legge assicura cittadinanza piena, clandestini diminuiti,non vogliamo alzare muri ma...
ANSA (14:59)Immigrazione: Fini, entro l’anno 650mila regolarizzazioni. In Italia più regola-ri; nel 2003 solo 9.865 sbarchi
ANSA (15:56)Immigrazione: Pezzotta, contratti nazionali ne tengano conto; posizione condi-visa anche dalla UIL
315
ANSA (16:25)Immigrazione: CNEL, assicurare cittadinanza legale; Forum Terzo Settore,troppe difficoltà per ricongiungimento
ANSA (16:37)Immigrazione: ARCI, rischio di una Bossi-Fini europea; più polizia, meno di-ritti in UE; combattere fortezza Europa
AGI (16:50)Immigrazione: ARCI critica, più polizia, meno diritti
ADNKRONOS (17:30)Immigrati: ARCI, rischio di una Bossi-Fini europea. Miraglia, indirizzo UEsempre più proibizionista
AGI (17:53)Immigrati: Loy (UIL), importante intervento Fini
ANSA (18:33)Immigrazione: Stiffoni, finché Lega al governo niente voto; così Fini snaturalegge che porta suo nome
ASCA SOCIALE (18:50)Immigrati: Fini, su diritto voto spero Lega sia cosciente
APBISCOM (18:56)Immigrazione: Fini, confermo, maturi i tempi per diritto di voto. Maturi ancheperché nuova legge funziona
AGI (19:03)Immigrati: Fini, diamogli il voto, la Lega insorge
ANSA (19:18)Immigrazione: Voto e quote, Fini ipotizza novità
AGI (19:20)Immigrati: Stiffoni (Lega), da Fini operazione elettoralistica
ADNKRONOS (20:09)Immigrati: ARCI, temiamo che a parole Fini non seguano fatti. Miraglia, allademagogia segua la pratica dei diritti
ANSA (20:13)Immigrazione: Forza nuova, AN si ribelli a Fini
316
8 OTTOBRE 2003
I quotidiani
CORRIERE DELLA SERAScossa agli elettori“Finora la destra è andata al governo con la forza dei numeri. Io voglio por-tarcela per la sua credibilità”(Maria Latella)
LA REPUBBLICAFini, sfida sugli immigrati“Diamogli il voto”. Rivolta della Lega. Applaude l’UlivoAppello a Berlusconi: “Richiami tutti al senso di responsabilità. E quando di-co tutti intendo uno in particolare”Follini: “Scelta doverosa, quella legge è più di Gianfranco che di Bossi.” Vio-lante: confrontiamoci seriamente(Giovanna Casadio)
LA STAMPAFini: “Voto agli immigrati”. E’ rottura con la LegaCalderoli e Cè: se vuole la crisi di governo lo dica, noi siamo pronti. Il leader di AN: “Berlusconi richiami Bossi alla responsabilità”Follini prende posizione in favore di AN, Forza Italia nicchia: “Il dibattito sultema è prematuro”(M.t.m.)
IL GIORNALEFini: “E’ ora di far votare gli immigrati”Il vicepremier difende la sua legge: presto si potrà anche fare a meno delle quote“Berlusconi richiami tutti al senso di responsabilità. E quando dico tutti inten-do soprattutto uno”(Roberto Scafuri)
IL MESSAGGEROVoto agli immigrati, Fini sfida BerlusconiIl vicepremier dice sì alla partecipazioni degli stranieri alle elezioni. Ma dopola bufera sollevata dalla Lega, scatena la resa dei conti nella Cdl“Richiami Bossi al senso di responsabilità e dimostri con i fatti di guidare lacoalizione”(Corrado Giustiniani)
L’UNITA’Voto agli immigrati, è quasi crisiFini lancia a sorpresa la proposta facendo infuriare Bossi e Berlusconi. L’Uli-vo: subito la legge
317
“Stranieri alle urne, i tempi sono maturi”: il vicepremier getta la destra nellosconforto. E non esclude il superamento delle quote di ingressoIl capo della Lega attacca: “Sono cose del tutto irrealizzabili. Se si va avanticosì andiamo immediatamente alle elezioni anticipate”(Maristella Iervasi)
IL GIORNOFini: “Voto agli immigrati” E la Lega minaccia la crisiIl caso. Proposta del vicepremier divide la Cdl. Scontro anche sulle quotePoi il leader di An attacca Bossi che replica: “Sono imbarazzato, idee irrealizzabili”(s.m.)
IL TEMPOAi vu’ cumpra’ la Casa delle libertàIl vicepremier ipotizza di concedere l’elettorato attivo agli extracomunitari re-golari, s’incendia il centrodestraFini lancia la proposta del voto agli immigrati, insorge Bossi e minaccia la crisiIdea choc per An, quasi tutti sorpresi e Gasparri dissente
IL TEMPOFini: “Voto agli immigrati”. Insorge BossiIl numero due del governo annuncia anche la possibile abolizione delle quote.Applausi dall’Udc, Forza Italia frenaIl vicepremier: “Intervenga Berlusconi, chieda a tutti più responsabilità”.Gongola l’Ulivo“Del mio partito non mi preoccupo. Il governo galleggia, ora le riforme”(Fabrizio Dell’Orefice)
IL TEMPOImbarazzo a via della Scrofa: “Gianfranco ha aperto al Ppe” Gasparri non cista e attacca(Fabrizio Dell’Orefice)
ITALIA OGGIImmigrati, Fini apre sul votoPer il vicepresidente del consiglio va concesso il diritto per le amministrativeStop al meccanismo delle quote d’ingresso in Italia(Annarita Padovano)
AVVENIREFini: diritto di voto agli immigratiMaggioranza divisa. Le proposte del presidente di AN raccolgono il plausodell’opposizione, ma riaprono la polemica nella Cdl. Agli alleati: non avere lanazionalità non vuol dire essere cittadini di serie BIl vicepremier chiede inoltre l’abolizione delle quote di ingresso. Sbarramentodella Lega e appoggio dell’Udc. Bossi: m’imbarazza piano irrealizzabile(Arturo Celletti)
318
IL MATTINOSul voto agli immigrati scontro tra Fini e BossiIl vicepremier: tempi maturi. Il senatur: irrealizzabile. L’Udc: ma siamo piùvicini a lui che alla Lega“Occorre anche rivedere le quote d’ingresso.” Sindacati, imprenditori e cen-trosinistra applaudono(Teresa Bartoli)
IL MATTINOSchiaffo all’alleato, primo atto della verificaSconcerto in An, ma il leader rilancia “E’ l’ultima delle mie preoccupazioni”(Claudio Sardo)
IL MATTINOSorpresa coraggiosa(Eugenio Mazzarella)
IL MANIFESTOUn diritto di voto contro Bossi“I tempi sono maturi per concedere il diritto di voto amministrativo agli immi-grati”. Gianfranco Fini alza un vespaio nella Casa delle libertà, attacca la Le-ga e sposa la linea dell’Udc. Ma sulla Bossi-Fini non ci sono dubbi: è unabuona legge, che ha anticipato le tendenze europee. Forse presto la revisionedel sistema delle quote: non più numeri, ma professionisti(Cinzia Gubbini)
IL MANIFESTOIl “Dies irae” di Gianfranco FiniAvvisa la Lega e Berlusconi e costringe il suo partito a venire allo scoperto(M. Ba)
LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNOFini: voto agli immigratiL’Ulivo applaude. La Lega insorge: se vuole la crisi lo dicaNella maggioranza scoppia un’altra polemica: per il vicepresidente del Consi-glio sono ormai maturi i tempi per concedere il diritto di accesso alle urne al-meno alle elezioni amministrative
IL SECOLO XIXFini: voto agli immigratiLa Lega insorge: “Vuole le elezioni anticipate”Scontro nella maggioranza dopo l’apertura del leader di AN che avverte: Berlu-sconi richiami Bossi all’ordine. L’Udc approva. Reazioni e sospetti nell’Ulivo(Angelo Bocconetti)
319
IL GAZZETTINOAppello di Fini al premier: tieni a freno BossiIl leader di AN vuole il rispetto del patto e riapre il fronte con la Lega propo-nendo il voto per immigrati e l’abolizione delle quote(M. Ant)
IL GIORNALE DI SICILIAImmigrati. Fini: “E’ tempo che votino anche loro”Il leader di AN: “Ognuno rispetti il programma, altrimenti ci finirà come ilcentrosinistra”(Renato Giglio Cacioppo)
IL GIORNALE DI VICENZA - L’ARENAFini: “Ora il voto agli stranieri”“Stop al sistema delle quote”. Il Carroccio: “Si rischiano crisi ed elezioni”Immigrazione. Il presidente di AN auspica modifiche alla legge e Bossi repli-ca: “Sono stupito e imbarazzato”
IL GIORNALE DI VICENZA - L’ARENALe reazioni. “Una sfida alla Lega”Opposizione e Confindustria soddisfatti
L’ECO DI BERGAMOImmigrati e previdenza. Se anche Alì versa i contributi(Francesco Anfossi)
LA PROVINCIA PAVESEAn apre al voto degli immigrati, Lega in rivoltaFini: “Sono maturi i tempi, almeno per le elezioni amministrative”Il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli minaccia la crisi di governo,l’opposizione di congratula con il vicepremier(Maria Berlinguer)
PREALPINA“Tempi maturi per il voto agli immigrati”Fini lancia la proposta ma la Lega non ci sta e si appella a Berlusconi
GIORNALE DI BRESCIAFini sfida Berlusconi e la LegaIl vicepremier lancia la proposta del voto agli immigrati nelle amministrative.Sconcerto tra gli alleati
BRESCIAOGGIFini: “Ora il voto agli stranieri”
320
“Stop al sistema delle quote”. Il Carroccio: “Si rischiano crisi ed elezioni”Immigrazione. Il presidente di An auspica modifiche alla legge e Bossi repli-ca: “Sono stupito e imbarazzato”
LA PROVINCIA DI CREMONAImmigrazione, Fini sfida Bossi“Voto a chi è in regola, i tempi sono maturi”. La Lega: elezioniIl vicepremier mette alla prova il Cavaliere: “Richiami il Carroccio, non noi”.AN spiazzata. Plaude l’Ulivo, Mancino: finalmente. In arrivo 650mila regola-rizzazioni(Giuliana Palieri)
LA PADANIALa giravolta di Fini
LIBERAZIONEImmigrati. Fini espelle BossiIl leader di AN: diamogli il voto. E al premier: richiami il Senatur. Carrocciosulle furieCalderoli (Lega): “Se insiste, il governo va a casa”. Follini (Udc) con il vicepremier per riconquistare parte del mondo cattolico. Le opposizioni, incredu-le, puntano il dito sulle vere ragioni della polemica: lo scontro dentro la Cdl.Il Prc: “L’iniziativa di Fini è un inutile belletto.”(Angela Azzaro)
LIBERAZIONEUe, all’accoglienza si preferisce la sicurezzaIeri si è concluso il convegno del CNEL. Il presidente di Alleanza Nazionaleha rivendicato i presunti effetti positivi della sua legge. Ma i clandestini sonoaumentati e stanno sempre peggio. Anche Pezzotta ha lanciato un monito suimigranti: “Non sono solo forza lavoro”(Stefano Galieni)
Le agenzie
ADNKRONOS (11:05)Immigrati: Pezzotta, non capisco atteggiamento Lega. Se un immigrato paga letasse perché non deve votare?
APBISCOM (11:19)Immigrazione: Pezzotta, non capisco opposizione Lega. Abbiamo apprezzatoposizione e risposta del vicepremier Fini
321
9 OTTOBRE 2003
IL SECOLO XIXUn leader moderno(Enrico Deaglio)
EUROPADalla Bossi-Fini alla “svolta del CNEL”: ecco perchè la Cdl è finita(Chiara Geloni)
EUROPA“E’ un tema nostro”. Il centrosinistra riprende una battaglia molto difficile(Fabrizia Bagozzi)
322
APPENDICE 3
ELENCO PARTECIPANTI
Antonio ADRAGNAPresidente del Comitato Pro Immigrati
Awuye Edmond AGBETTORPresidente della Consulta Immigrati di Modena - Centro stranieri del Comunedi Modena
Rossella ALBERINIDocente MIUR Direzione generale formazione
Giorgio ALESSANDRINIPresidente Vicario dell’ONC-CNEL
Edoardo ALMAGIAPresidente del Centro Welcome
Ayman ALY KAMELConsigliere dell’Ambasciata d’Egitto
Vittorio AMATOGiornalista di Adn-Kronos
Maria Sabina ANDREUZZIFunzionario UGL dell’Ufficio internazionale
Luigi ANGELETTISegretario Generale della UIL
Mahjouba AQIQPresidente della Comunità marocchina
323
Virginio ARINGOLIRicercatore della FUSIE - Federazione unitaria stampa italiana all’estero
Lassaad AZZABIOperatore sociale della Cooperativa sociale Dedalus
Maria Clecy BACCINResponsabile della mobilità etnica dell’USMI
Laura BADARACCHIGiornalista dell’Agenzia “Redattore Sociale”
Abdelmajid BAOUABMembro del Consiglio Economico e Sociale di Tunisia
Gildo BARALDIDirettore Generale dell’OICS - Osservatorio interregionale sulla cooperazio-ne allo sviluppo
Sandra BARBIR JOJADirettore del settore cooperazione bilaterale e multilaterale del Ministerodel’Interno croato
Clementina BARILIDirettore dell’Associazione della cooperazione lombarda
Kosta BARJABACapo di Gabinetto del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali albanese
Charito BASAPresidente Filipino Women’s Council
Valentina BASCHERINIOperatrice dell’ufficio stranieri Patronato dell’ACLI
Abdellah BATANMediatore culturale del Forum per l’intercultura
Graziano BATTISTELLARettore Scalabrini international migration institute
Paula Isidora BAUDET VIVANCOCorrispondente dell’Agenzia Migra
Vanna BECHELLIFunzionario della Regione Toscana - Area sistema dei servizi e delle presta-zioni socioassistenziali
Bernard BEDASDirettore dei servizi amministrativi e relazioni internazionali del ConsiglioEconomico e sociale francese
324
Kamel - Eddine BELAITOUCHEPresidente dell’Associazione dell’AINAI
Anna BELPIEDESociologa del Comune di Torino
Kamil Eddine BEN HABIBCapo del dipartimento del Consiglio Nazionale Economico e Sociale algerino
Franco BENTIVOGLIEsperto del Dossier Immigrazione della Caritas
Manfred BERGMANNRicercatore della Casa dei diritti sociali
Vinicio BIAGI Dirigente della Regione Toscana - Area sistema dei servizi e delle prestazionisocioassistenziali
Alejandra BLAZQUEZ VILARConsigliere tecnico della Regione di Madrid - Assessorato ai servizi sociali
Eugenia BONETTIResponsabile Settore Tratta dell’USMI
Corrado BONIFAZIPrimo ricercatore del CNR - Istituto di ricerche sulla popolazione e le politi-che sociali
Massimo BORDINIConsigliere del CNEL
Gianluca BORGHIAssessore alle politiche sociali della Regione Emilia-Romagna
Elisa BOTTONIICCREA Holding SpA
Giuseppe BRATTELLIDirigente di Confindustria
Roger BRIESCHPresidente del Comitato Economico e Sociale Europeo
Federico BRINIConsigliere del CNEL
Leonardo BRONGOCNEL
Luigi BULLERIConsigliere del CNEL
325
Alberto BUTTIGLIERISOS Razzismo Italia
Claudio CALVARUSODirigente Generale dell’ISPESL
Giulio CALVISIResponsabile dell’immigrazione dei Democratici di Sinistra
Antonio CAMPANELLIProvveditore agli studi di Lecce
Patrizia CAPITALIMIUR Direzione Generale Organizzazione Servizi Territorio
Giuseppe CAPOPresidente della Commissione Informazione del CNEL
Loretta CAPONIPresidente del Forum Comunità straniere in Italia
Daniela CARBONIResponsabile delle relazioni istituzionali di Amnesty international
Carlo CASTIGLIONIPresidente del CESTIM - Centro studi immigrazione onlus
Giuseppe CASUCCICoordinatore dell’ufficio politiche migratorie della UIL
Immanuel CAZALE’Giornalista di Adn-Kronos
Francesca Romana CECIGR RAI
Laura CENTISMonte dei Paschi di Siena
Paolo CERRONIFotoreporter di Italiaeconomica
Giuseppe CICOLINIFORUM Intercultura
Giuseppe CIONTIGiornalista di ASCA
Oberdan CIUCCIResponsabile nazionale immigrazione della CISL
Kasim CIZMIC
Presidente dell’Associazione Rom Opera Nomadi
326
Franca COEN ECKERTConsigliera delegata per la multietnicità del Comune di Roma
Giuseppe COGLIANDROConsulente alla Presidenza della Regione Calabria
Maria Paola COLOMBO SVEVOPresidente dell’Associazione IRENE
Enrico COMESDirigente Generale del CNEL
Roberto CONFALONIERIConsigliere del CNEL
Massimo CONVERSOPresidente Nazionale Opera Nomadi Ente morale
Giuseppina COPPODirigente Unità organizzativa Interventi Sociosanitari e Socio assistenzialidella Regione Lombardia
Anna COROSSACZConsigliere del CNEL
Silvia COSTAConsigliere del CNEL
Amedeo CROCEConsigliere del CNEL
Francesca DANESEVicepresidente del CESV - Centro servizi volontariato della Regione Lazio
Khalid DAOUMERPresidente dell’Associazione marocchina per i diritti degli immigrati
Marta DAPENA CALVOInvitato
Matteo DE ANGELISUfficio stampa del Gruppo Cerfe
Francesco DE LUCCIAPresidente dell’Associazione Centro Astalli
Augusto DEL PAPACNEL
Gavino DERUDAConsigliere del CNEL
327
Rando DEVOLECoordinatore immigrati di FAI-CISL
Paola DI PRIMAOperatore sociale
Titti DI SALVOSegretario Confederale della CGIL
Ilvo DIAMANTISociologo dell’Università di Urbino
Franco DOTOLOAddetto stampa della Fondazione Migrantes
Cesare DUJANYConsigliere del CNEL
Annemarie DUPRE’Responsabile del servizio rifugiati e migranti della Federazione chiese evange-liche in Italia
Luca EINAUDIUniversità di Cambridge
Hafid EL JILALIPresidente dell’Unione delle Associazioni del Marocco in Emilia-Romagna
Ali EL KETROUSSIPresidente Commissione Comunità algerine all’estero del Consiglio NazionaleEconomico e Sociale algerino
Zeinab EL SADANYPresidente di ADASER - Associazione donne arabe e straniere dell’Emilia-Romagna
Amjad ELOURIPresidente di ARDALSALAM (Terra della pace)
Maria Marta FARFANINAS-CISL
Aly Baba FAYECoordinatore del Forum Fratelli d’Italia
Lorenz Johann FELDERERIspettore amministrativo della Provincia autonoma di Bolzano - Ufficio anzia-ni e distretti sociali
Tahar FELLOUS
Presidente del Consiglio Economico e Sociale tunisino
328
Concepcion FERNANDEZ ALVAREZResponsabile dell’immigrazione Regione di Madrid - Assessorato ai servizi sociali
Benedetta FERONEInvitato
Angela FERRANTEFunzionario di Presidenza del Consiglio dei Ministri
Abderazak FETNAN Membro del Consiglio Economico e Sociale regionale della Provenza
Veronica FINCATIRicercatore dell’Osservatorio Regionale sull’immigrazione del Veneto
Gianfranco FINIVicepresidente del Consiglio dei Ministri
Serena FIORLETTACasa dei diritti sociali
Silvia FONDIStagista dell’Osservatorio donne immigrate della CGIL
Benito FORTEPresidente dell’ANFE - Associazione Nazionale Famiglie emigrati
Barbara FRIDELProject development officer OIM - Organizzazione internazionale delle migrazioni
Federica FRIONIAddetto alla comunicazione dello SPES - Centro servizio volontariato
Rocco Domenico GALATIConsigliere del CNEL
Pierangelo GALLORINICo-presidente di ANOLF-Arezzo
Andrés GARCIA PRADODirettore generale immigrazione, cooperazione allo sviluppo e volontariatodella Regione di Madrid Assessorato ai servizi sociali
Oria GARGANOResponsabile Differenza Donna Giornalista donna Centro antiviolenza dellaprovincia di Roma
Angelo GENNARIPresidente della Commissione Internazionale del CNEL
Salvatore GERACIPresidente della Società italiana di medicina delle migrazioni
329
Giorgio GHENZICNEL
Andrea GIANFAGNAConsigliere del CNEL
Marina GIGLIOCollaboratrice legale di UIL-SI del Veneto
Anna GIUSTINIANIProject manager di OIM - Organizzazione internazionale delle migrazioni
Corrado GIUSTINIANIGiornalista de Il Messaggero
Arbana GJYLJAMediatore culturale di UCODEP
Claudio GNESOTTOSacerdote Missionari Scalabriniani
Kinga GÖNCZSottosegretario del Ministero della Sanità, Affari sociali e famiglia
Franco GRECOPresidente di ANPIE - Associazione italiani d’Egitto
Brankica GRUPKOVICConsigliere del Ministero dell’Interno serbo
Cinzia GUBBINIGiornalista de Il Manifesto
Carlo GUELFIVicepresidente di IPALMO
Anita GUELFICentro studi di Confindustria
Paolo GUELFIInvitato
Pino GULIAResponsabile del progetto Immigrazione Patronato dell’ACLI
Rodolfo GUTIERREZ PALACIOSDirettore area studi e analisi del Consiglio Economico e Sociale spagnolo
Cristopher HEINDirettore del CIR - Consiglio Italiani Rifugiati
Renate HEINISCHMembre del Comitato Economico e Sociale europeo
330
Alexander HOFMANNSegretario generale del Consiglio Consultivo Economico e Sociale austriaco
Jurgen HUMBURGFunzionario per la protezione di UNHCR - Alto Commissariato delle NazioniUnite per i rifugiati
Aniza HUSHAEsperta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Emanuele IACUSSORMC
Mariapia IAMMARINOAssistente sociale delle Francescane dei poveri
Said IHRAIPresidente di sessione del Consiglio Nazionale della gioventù e dell’avveniremarocchino
Mohamad IKRIMIPresidente dell’Associazione emigrati marocchini di Reggio Emilia
Rodrigo JAIMES HIDALGOPresidente della Comunità peruviana in Italia
Mustapha JAMALISegretario regionale Campania SEI-UGL
Jan JANGANOLF
Thomas JANSENCapo di gabinetto del Presidente del Comiato Economico e Sociale Europeo
Innocent KABERAPresidente ANOLF di Bari
Andreas KINTISPresidente del Consiglio Economico e Sociale greco
Driss KROUZCoordinatore del Consiglio Nazionale della gioventù e dell’avvenire marocchino
Francesca LA MATTINACasa dei diritti sociali
Gianfranco LAGOSTENAConsigliere del CNEL
Damiano LANZONEResponsabile dell’Associazione La Quercia
331
Pietro LARIZZAPresidente del CNEL
Debora LEIVAResponsabile progettazione-informazione immigrati del Comune di MorlupoDistretto RM 14
Michele LEPRI GALLERANOVice Capo Vicario del Ministero Interno - Dipartimento libertà civili e immi-grazione
Valentina LESKAJMinistro del Lavoro e degli Affari Sociali albanese
Jociaria LIMA DE OLIVEIRAMembro direttivo dell’Associazione Candelaria
Raymond LOBE’Copresidente ANOLF di Barletta
Mamba LOKAMBA LOUSResponsabile del Centro Accoglienza Armadillo
Cristiana LOMBARDIFunzionario Provincia di Roma - Assessorato politiche sociali e per la famiglia
Pina LOPEZTraduttrice dell’ANPIE - Associazione italiani d’Egitto
Eugenia LORENZIVolontaria carcere - immigrati di USMI
Guglielmo LOYSegretario Confederale della UIL
Marco LUDOVICOGiornalista de Il Sole-24 Ore
Jens Erik LUNDFunzionario OCSE, LEED PROGRAMME
Chiara LUTIProgetto Integra Fondazione del CENSIS
Suhey MACHADOOperatore Patronato dell’ACLI
Giovanni MAGLIAROConsigliere del CNEL
Glauco MAGLIOCNEL
332
Roberto MAGNIInvitato
Agnese MALATESTAGiornalista dell’ANSA
Federica MALFAAddetto comunicazione dello SPES - Centro servizio volontariato
Orietta MANTOVANIAvvocato ENFAP dell’Emilia Romagna
Valeria MANZIAREA Giornalista
Federica MARGARITORAGiornalista di SAT 2000
Beatriz MARTIN NIETOFunzionario del Consiglio Economico e Sociale spagnolo - Dipartimento rela-zioni internazionali
Barbara MARTINELLIInvitato
Alceo MARTINIISSAS Membro direttivo Rivista
Gianluca MARTINICNEL
Carla MARTOGLIOResponsabile politiche a supporto fasce deboli della Regione Piemonte -Assessorato alle politiche sociali e della famiglia
Dermot MC CARTHYPresidente del Consiglio Nazionale Economico e Sociale irlandese
Michal MEDUNADirettore di Dipartimento Ministero del Lavoro e Affari Sociali della Repub-blica ceca
Elisabetta MELANDRIPresidente di CIES
Ugo MELCHIONDAProject manager OIM - Organizzazione internazionale delle migrazioni
Sara MENAFRAGiornalista de Il Manifesto
Maria Jose MENDES EVORAPresidente Associazione di No.Di. “I nostri diritti”
333
Giuseppe MIGLIOPastore battista della Chiesa evangelica battista di Pordenone
Raffaella MILANOAssessore ai servizi sociali del Comune di Roma
Cristina MINGUZZIAssociazione PARSEC
Filippo MIRAGLIAResponsabile Nazionale dell’ARCI - Nuova associazione
Germana MONALDIRicercatrice ISFOL
Maria Beatrice MORANODocente MIUR Direzione generale formazione
Goffredo MORGIAGiornalista INFORM
Camillo MOSERDirettore dell’UPI - Rivista “Le province”
Umberto MOSIELLOVice presidente vicario dell’ANOLF
Jolanta MROSZCZAKComitato profughi polacchi
Libero NARDODirettore servizi sociali del Comune di Vicenza
Andrea NARDONESegretario Generale della Fondazione risorsa donna
Antonella NARUCAInvitato
Marianne NATI STOFFELSegretario Generale del Consiglio Economico e Sociale lussemburghese
Amadou NDIAYEAssociazione senegalese in Roma
Sokol NDRECAMediatore culturale della Casa dei diritti sociali
Paola NEGRIInvitato
Michele NEGROSegreteria Assessore Antonaz della Regione Friuli Venezia-Giulia - Assessora-to immigrazione
334
Françoise NGANKOUERicercatrice di Fondazione
Cesar Lê Quyên NGÔ DINHResponsabile immigrazione della Caritas Diocesana
Jerome NGOMPresidente dell’Associazione senegalese della provincia di Rimini
Vittorio NOZZAPresidente della Caritas Italiana
Joaquim NUÑES DE ALMEIDACommissione Europea del Gabinetto del Commissario Vitorino
Lidia OBANDOResponsabile Nazionale di ACLI-COLF
Matthias OBERBACHERSociologo dell’Osservatorio sulle immigrazioni della Provincia di Bolzano
Liliana OCMIN ALVAREZResponsabile del Coordinamennto studenti stranieri all’Università La Sapienza
Olumide OKUNUGAResponsabile del Coordinamento provinciale associazioni straniere
Pierfranco OLIVANISocio Associazione NAGA
Vinicio ONGINIDocente MIUR
Malika ORCHANIDirectrice AFTURD Maison des femmes
Ercole Vincenzo ORSINIDirigente della Regione Abruzzo - Servizio servizi sociali
Claudia OTTOLENGHISenior legal counsellor OIM - Organizzazione internazionale delle migrazioni
Annarita PADOVANOGiornalista di Italia Oggi
Antonella PAGLIALUNGACNEL
Donatella PARISIResponsabile per l’informazione della Fondazione Centro Astalli
Paolo PASCUCCIAssessore del Comune di Ancona - Assessorato immigrazione e servizi sociali
335
Edoardo PATRIARCAConsigliere del CNEL
Petar PAVICMinistro Consigliere incaricato d’affari A.I. all’Ambasciata Serbia e Montenegro
Rosetta PELLEGRINIResponsabile progetti dell’UCSEI - Ufficio centrale studenti esteri
Giuseppe Maria PELLICANO’Addetto stampa del Programma nazionale asilo
Sara PERAAssistente progetto immigrati del Patronato-ACLI
Fulvio PERINIConsigliere del CNEL
Monica PERONACEVolontaria servizio civile della CGIL
Lidia PESCIInvitato
Trajko PETROVSKISegretario Generale di UNIRSI
Davide PIAZZAAssessore del Comune di Vicenza - Assessorato agli interventi sociali
Angelica PICCIOCCHICNEL
Fabio PIETRIBIASIRedattore dell’Associazione Ozanam - Rivista “Incontri”
Elena Luisa PILOSUVolontaria del Centro Welcome
Pietro PINTOPresidente di OASI - Osservatori associati sulle immigrazioni
Franco PITTAUResponsabile del Dossier statistico di Caritas Migrantes Cser
Marialaura POLLICEEsperto amministrativo politiche sociali della Regione Abruzzo - Delegazionedi Roma
Makis POLYDOROUFunzionario amministrativo del Ministero dell’Interno cipriota Dipartimentostato civile e immigrazione
336
Daniela POMPEIResponsabile immigrazione della Comunità di S.Egidio
Raffaella PRIAROCONFAPI
Isabella PUGLIESEFunzionario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Servizio immigrati
Maria Guadalupe QUEZADA LEONMediatrice culturale dell’Associazione Donne immigrate
Ben Amara RADHIAPresidente dell’Associazione interculturale Mammafrica
Colceag RADUSegretario generale del Consiglio Economico e Sociale romeno
Beatrice RANGONI MACHIAVELLIConsigliere del CNEL
Marta REALIAssistente progetto immigrati del Patronato-ACLI
Abdellah REDOUANECentro Islamico Culturale d’Italia
Tahar REFAIMembro del Consiglio Economico e Sociale tunisino
Valter REGGIANIMembro del Comitato di Presidenza di ONC
Gianluca REINAOperatore di SAT 2000
Bernadette RIGAUDAssistente progetto dell’Istituto per il Mediterraneo
Chiara RIGHETTIGiornalista di Radio 24
Lucia RITROVATOGiornalista di LUMSA News
Roberto RIZZIAssistente sociale del Comune di Vicenza
Adela ROSSociologa dell’Istituto Europeo del Mediterraneo
Claudio ROSSIFunzionario del Comune di Roma - Ufficio speciale per la multietnicità
337
Alessandro ROTTARicercatore del CESPI
Margherita RUGGIEROProgettazione iniziative immigrati-rifugiati-richedenti asilo di IPSIA-ACLI
Maria RUSCAAddetto alla comunicazione di SPES Centro servizio volontariato
Mohamed SAADYCopresidente di ANOLF
Patrizia SACCHIOperatore culturale di Libertybell Prod.
Mario SAIPresidente della Commissione attività produttive e risorse ambientali delCNEL
Agim SAITIMediatore culturale dell’Associazione “Rasim Sejmic”
Salvatore SALTARELLIFunzionario della Provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione formazioneprofessionale italiana
Martina SALVADORICNEL
Debora SAMIRInvitato
Alvaro SANCHEZ CASTILLOCoordinatore Nazionale mediatori culturali di CIES
Guido SANSONETTIConsigliere del CNEL
Francesca SANTOROVicepresidente del CNEL
Enrica SARDEIFunzionario della Regione Veneto - Ufficio Immigrazione
Angela SCALZODirettrice dell’Agenzia CHANCES
Francesca SCALZOPsicologa SOS Razzismo Italia
Gianfranco SIGNORINSindaco del Comune di Arzignano
338
Maria Teresa SILANIDocente dell’Ufficio scolastico regionale del Lazio
Giuseppe Maurizio SILVERIDirettore generale del Ministero del Lavoro - Direzione immigrazione
Pietro SOLDINIResponsabile Immigrazione della CGIL
Paola SPADAPresidente dell’Associazione “Casa della mamma”
Rita SÜSSMUTHPresidente del Consiglio federale tedesco su immigrazione e integrazione delGoverno tedesco
Alessia TAGLIACOZZOGiornalista dell’ANSA
Sandra TAPIA TORRESPresidente di ANDES - Associazione di Latino-americani residenti in Italia
Maria Teresa TAVASSIAssociazione La Lucerna
Ali TAZEKOUTPresidente Associazione Italia-Marocco
Andrea TESTAGiornalista di AP.biscom
Donata TIRELLIFunzionario di Confcommercio
Fatima TOMASSIFunzionario di Federsolidarietà-Confcooperative
Gianni TOSINIPresidente della Commissione Cattolica per le migrazioni in Italia
Simona TRADARDICNEL
Maria Teresa TRAMONTIAddetto relazioni esterne della Regione Emilia-Romagna - Servizio di Roma
Teresa TRILLO’Giornalista del Radiocorriere migrazioni in Italia
Alessia TRIVELLICNEL
339
Livia TURCODeputata dei Democratici di Sinistra
Franco Giovanni VALENTIDirigente del Centro Stranieri del Comune di Brescia
Roberta VALETTIConsulente di IRES Piemonte - Osservatorio per l’immigrazione
Andrea VALZANIAConsulente della Regione Toscana
Fulvio VASSALLO PALEOLOGORicercatore universitario all’Università degli Studi di Palermo
Sergio VENDITTICopresidente della Società geografica italiana
Anna VENTRELLACNEL
Enrica VERGER BUSIRI VICIVice Presidente del Centro Welcome
Silvano VERONESEConsigliere del CNEL
Maria VIARENGORicercatrice di Alma Terra
Gianni VINAYCGIL
Massimo VIVOLIVicepresidente Vicario di Confesercenti
Pellumb XHUFIAmbasciatore dell’Ambasciata d’Albania
Osman YILDIZComitato Consultivo misto UE-Turchia - Camera dell’Industria di Istanbul
Ali YOUNESARDALSALAM Terra della pace
Giovanna ZALDINIPresidente della Cooperativa La Talea
Iulia ZAMFIRESCUAttaché per gli Affari Europei dell’Ambasciata di Romania
Flavio ZANOLLAIstruttore direttivo del Comune di Vicenza
340
Naim ZOTO
Consigliere del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali albanese
Irene ZUCCONI
Impiegata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Servizio immigrati
TG1
TG2
TG5
341