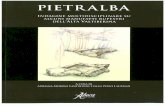Arcà Andrea, Rubat Borel Francesco 2014. Rocce a coppelle, elementi di un paesaggio progettato e...
Transcript of Arcà Andrea, Rubat Borel Francesco 2014. Rocce a coppelle, elementi di un paesaggio progettato e...
PPE.Atti XI
PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA
Paesaggi cerimonialiRicerche e scavi
ATTI DELL’UNDICESIMO INCONTRO DI STUDI
CENTRO STUDI DI PREISTORIA E ARCHEOLOGIAMilano
PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA
ATTI DELL’UNDICESIMO INCONTRO DI STUDI
Paesaggi cerimonialiRicerche e scavi
volume II
Centro Studi di Preistoria e ArcheologiaMilano
Atti dell’Undicesimo Incontro di StudiValentano (VT) – Pitigliano (GR), 14-16 Settembre 2012
Paesaggi cerimonialiRicerche e scavi
a cura di Nuccia Negroni Catacchio
In copertina disegno di Ercole Negroni
ISBN 978889435520
© 2014 by Centro Studi di Preistoria e Archeologia – Onlus viale Lazio 26, 20135 Milano www.preistoriacsp.it
Tutti i diritti riservati
333
Rocce a coppelle, elementi di un paesaggio progettato e monumentalizzatoContestualizzazione archeologica e ambientale nella regione alpina
Andrea Arcà*Francesco Rubat Borel**
IntroduzioneLe coppelle sono incisioni a piccola coppa a sezione emisferica, tron-co-conica o cilindrica, di diametro mediamente compreso tra 2 e 20 cm, realizzate tramite percussione e/o rotazione di un utensile per lo più litico. Si tratta del “segno” inciso di più alta presenza, per quanti-tà e per copertura territoriale, in tutto l’arco alpino. È altresì l’elemen-to più rappresentativo dei petroglifi non figurativi1, categoria che mo-stra caratteristiche ben diverse rispetto ai figurativi, ai quali non è quasi mai associata, al più compresente, salvo che nel caso dei pedi-formi; tale distinzione appare congruente anche a livello interpretati-vo, discriminando segni a valenza iconografica da elementi di verosi-mile origine funzionale-strumentale. L’inquadramento archeologico è problematico, anche perché non è praticabile il riferimento iconogra-fico a oggetti ben datati2, quali armi o attrezzi. Al fine di individuare elementi di analisi per l’arco alpino, il presente contributo intende procedere da un lato all’approfondimento dei contesti archeologici significativi per un inquadramento cronologico, dall’altro all’esame delle situazioni ambientali diagnostiche ai fini interpretativi.
Ante, post, ad quemFra le possibilità di datazione, sono stati indagati vari percorsi, particolarmente in Schwegler 1992; pare opportuno privilegiare l’esame dei contesti stratigrafici, compresi quelli iconografici, inte-si come rapporti di sovrapposizione o di associazione tra i segni incisi, presentando una panoramica dei non molti casi disponibili. Tra questi si escludono Vollein (Aosta), le rocce di Santa Maria di Pont Canavese (Torino) e Balm’ Chanto di Roure (Torino), oltre alla vasta area di abitato golasecchiano di Como-Pianvalle, in quanto i contesti archeologici e le strutture, seppure molto vicini a rocce coppellate, non sono con esse in diretto rapporto stratigra-fico (Mezzena, Morandi 1992; Cima 1988; Ricchiardi, Seglie 1987 pp. 121-122; Negroni Catacchio 1981)3.
* Università degli Studi di Pisa, Scuo-la di dottorato in Scienze dell’Antichi-tà e Archeologia.** Soprintendenza per i Beni Archeo-logici del Piemonte e del Museo Anti-chità Egizie, Torino. 1 È recentemente invalsa per i non figu-rativi la definizione di “arte schemati-ca”, potenzialmente fuorviante, sia per l’adozione del termine “arte”, sia per-ché anche segni pienamente figurativi
possono assumere carattere schematico.2 Né sono noti casi in ambito alpino di analisi archeometriche, sia perché l’inci-sione rupestre, al contrario della pittura, asporta e non deposita materiale, sia per la mancanza di patine dure o concrezio-ni in grado di inglobare particelle data-bili tramite AMS o altre metodologie.3 Per la lastra del Paleolitico Medio di La Ferrassie, trattasi più propriamen-te di incavi irregolari che di coppelle.
Rocce a coppelle, elementi di un paesaggio progettato e monumentalizzatoContestualizzazione archeologica e ambientale nella regione alpina
335
1. Sesto Calende (VA), CascinaGajaccio, tavola coppellata SCL.GJC1: restituzione vettoriale del rilievo per trasparenza a contatto e ripresa fotografica a luce radente (rilievi e foto A. Arcà 2013). Castelletto Ticino (NO), da fondo di proprietà del senatore Serafino Belfanti, lastra coppellata CST.SSB03: restituzione vettoriale del rilievo per trasparenza a contatto e ripresa fotografica a luce radente (rilievi e foto F. Rubat Borel 2013).
Ante quem. Nell’area megalitica di Velturno-Tanzgasse (Bolza-no) una delle lastre di pietra dal catino del tumulo A mostra quat-tro piccole coppelle; è in sede di reimpiego e precede il tumulo campaniforme (Tecchiati 2013). Nella fase più antica dell’insedia-mento del Tummihügel di Maladers (Grigioni), transizione Bronzo Antico-Bronzo Medio, è stata rinvenuta in reimpiego una pietra con una cinquantina di coppelle emisferiche (Gredig 1979). A Douvaine (Alta Savoia) una tomba a cista del Bronzo Medio riuti-lizza una lastra con 20 coppelle, due delle quali collegate da cana-letti, altre tronche (Reber 1893; Schwegler 1992 pp. 63-64; Ballet, Raffaelli 1990 p. 74). Dall’acciottolato stradale dell’abitato del Bronzo Recente e Finale presso Ponte San Marco a Calcinato (Bre-scia) proviene un masso recante cinque coppelle in fila (Poggiani, Ruggiero 2012). Ad Aussois (Savoia) una pietra con quattro cop-pelle a sezione conica è stata rinvenuta in reimpiego in uno strato d’abitato di una fase recente del Bronzo Finale (Ballet, Raffaelli 1990, p. 108). Da un tumulo di Uffing (Baviera) proviene una lastra con 19 coppelle allineate “a pallottoliere” reimpiegata come coper-chio di una sepoltura a cremazione del passaggio tra Bronzo Medio e Bronzo Finale nord alpino (Naue 1887 pp. 53-54, 133-134). A Como-Rondineto una lastra con coppelle troncate dalla risagoma-tura copriva, con la faccia interna incisa, una tomba di prima o seconda fase della cultura di Golasecca (Galli 1899 pp. 18-19). Per Castelletto Ticino (Novara), si segnalano le lastre che formano una tomba a cassetta della seconda metà del VI-inizi V secolo a.C. donata nel 1936 ai Civici Musei di Varese dal sen. S. Belfanti (Ban-chieri 2003): le coppelle sui bordi della lastra di copertura e di una laterale sono tagliate, indizio di riutilizzo di questa successivamen-te all’incisione per essere impiegata nella costruzione della tomba (non è chiaro però se le coppelle fossero verso l’interno o l’esterno della cista, che fu ricostruita per l’esposizione museale). Recente-mente in via delle Acacie di Castelletto Ticino, al margine tra l’abi-tato e l’area di necropoli di VIII-VII secolo a.C., è venuta alla luce una struttura costituita da un terrazzamento di massi e grandi ciot-toli ricoperta da una frana nel corso del VI secolo a.C. (Rubat Borel et alii 2013). La superficie di numerosi componenti è ricoperta di coppelle, che paiono essere sempre state poste in maniera da non essere visibili all’esterno del terrazzamento.
Nello scavo di Montesei di Serso (Trento), al di sotto del livel-lo con ceramica tipo Sanzeno, fu rinvenuto un masso con undici coppelle poco profonde e due vaschette oblunghe (Broglio, Peri-ni 1964).
Andrea Arcà - Francesco Rubat Borel
336
lo di Varese, dottoressa Daria Banchie-ri, per la collaborazione dimostrata durante le operazioni di documenta-zione del monumento. 5 Quattro di esse, nel territorio del comu-ne di Zubiena, sono state documentate da Le Orme dell’Uomo per la Soprinten-denza per i Beni Archeologici del Pie-monte e il DocBi-Centro Studi Biellesi.
4 La lastra, assieme a quella della tom-ba da Castelletto Ticino donata dal sen. Belfanti, è stata recentemente esa-minata dagli scriventi con rilievo per trasparenza a contatto. Si ringraziano la Soprintendenza Archeologica della Lombardia per l’autorizzazione alla realizzazione del rilievo e la conserva-trice dei Musei Civici di Villa Mirabel-
Nel luglio del 1945 Mario Bertolone, nei pressi della cascina Gajaccio a Sesto Calende Varese), riesaminò i lastroni di una tom-ba “della civiltà di Golasecca” (Bertolone 1946, p. 19). Fatta rivol-tare la lastra di copertura, venne alla luce una superficie incisa con “venti cuppelle e dieci piante di piedi umani” (ibidem), giudicata da Bertolone proveniente da un erratico già inciso4. Si conferma la natura di superficie di stacco della faccia aniconica, di superficie naturale esposta della faccia incisa e di risegatura di tre lati su quattro. Le sezioni delle incisioni indiziano un’esecuzione a stru-mento litico. I pediformi più piccoli corrispondono ai piedi di un neonato, i più grandi alle misure 35-39. La sepoltura “di età gola-secchiana” costituisce un terminus ante quem o al massimo ad quem; non è da escludere il riutilizzo di una stele già incisa.
Nell’area della Bessa (Biella), formata dagli accumuli dei detriti del lavaggio dei giacimenti auriferi di età tardo repubblicana-alto imperiale delle Victimularum aurifodinae, sono numerose le rocce coppellate5. La ZUB-BSS-41, con 34 coppelle eseguite a strumento litico, è circondata dai cumuli di ciottoli residuo delle attività estrattive, che lambiscono il masso e ne rendono probabile l’inci-sione in epoca precedente al loro deposito, tra la seconda metà del II e la prima metà del I secolo a.C. Negli scavi dell’antica prigione di Saint-Antoine a Ginevra è stata rinvenuta una lastra che reca incise quindici coppelle, proveniente da un fossato di fine I secolo a. C. (Haldimann et alii 1991). Dagli scavi della villa romana delI-II sec. d.C. di Eichholz a Grenchen (Soletta) proviene uno spez-zone che mostra sei coppelle regolari (Strub 1949, pp. 4-7; Schwe-gler 1992, p. 79). Due di esse sono troncate in corrispondenza del-la frattura dello spezzone. A Susa (Torino), poco a monte dell’Arco di Augusto, un affioramento roccioso ospita quindici grandi cop-pelle, otto canaletti, una vaschetta e una serie di sette gradini orto-gonali (Capello 1949). Si tratta di incavi realizzati su di un suppor-to precedentemente sbozzato a piccone e sottoposto ai basamenti dell’acquedotto tardo-imperiale noto come “Terme Graziane”. Le sezioni indiziano l’uso di strumenti incisòri metallici.
Rocce a coppelle, elementi di un paesaggio progettato e monumentalizzatoContestualizzazione archeologica e ambientale nella regione alpina
337
Nella necropoli longobarda di VI-VII secolo di Monte San Zeno a Montichiari (Brescia) è stata rinvenuta una lastra di copertura tombale recante sulla faccia esterna oltre 40 coppelle, alcune delle quali tronche (Poggiani Keller, Ruggiero 2012). Dagli scavi presso la chiesa di St. Stephan a Biel-Mett (Berna) proviene un lastrone con coppelle a sezione conica, troncate dal-la frattura, e canaletti, riutilizzato come copertura di una tomba altomedievale (Lehner 1978; Matile 1979; Schwegler 1992, p. 79). Infine, una delle 13 coppelle incise sulla parte sommitale del poggio di Montaldo di Mondovì (Cuneo) – simili a quelle di Susa e per gli autori databili tra fine IV e inizi II secolo a.C. – è troncata dal taglio della roccia realizzato per erigere il castello del XIV secolo (Gambari 1991; Gambari, Mano 1991).
Post quem. La stele Tina 1 è un lastrone emerso durante i dragaggi di una cava di pietrisco a Tina di Vestigné (Torino) (Gambari 2004; Gambari, Arcà 2012). Le scalfitture provano che era collocata con la faccia orizzontale coppellata rivolta ver-so l’alto. La faccia A mostra due fasi incisorie, di Rame 2 e Rame 3, alle quali si aggiunge una terza fase di 82 coppelle omogenee sulla faccia B. La mancanza di coppelle tronche lungo il perime-tro lascia intendere un’esecuzione posteriore alla sagomatura del lastrone, quando la stele, riutilizzata come copertura di una cista litica o abbattuta al suolo, formava una sorta di tavola. Simile a Tina 1 la situazione del lastrone di copertura della Tomba I (ini-zi del Bronzo Antico) di St.-Martin-de-Corléans ad Aosta; ospita circa centotrenta coppelle prive di canaletti, incise a percussore litico (Mezzena 1997, fig. 73). La loro distribuzione non in corri-spondenza dei margini e l’assenza di troncatura indiziano anche in questo caso un’esecuzione quando il lastrone poteva emergere dal suolo a mo’ di tavola litica.
Il già citato masso coppellato dei Montesei di Serso è stato poggiato sullo strato più antico, del Bronzo Antico (Broglio, Peri-ni 1964).
La valenza stratigrafica delle coppelle dell’Arcelle Neuve a Lanslevillard (Savoia), non è fisica ma iconografica, con evidenti rapporti di sovrapposizione, laddove i moduli di coppelle e cana-letti tagliano precedenti figure spiraliformi (Nelh 1980, p. 20; Bal-let, Raffaelli 1990, p. 125). La datazione del terminus post quem, cioè degli spiraliformi, è ardua. Emergono due attribuzioni possi-bili, una “antica” di ambito megalitico, corrispondente, per analo-gia iconografica a monumenti delle Isole Britanniche (Newgrange, Knowth e Lougcrew), alla seconda metà del IV millennio a.C.,
Andrea Arcà - Francesco Rubat Borel
338
una più recente di Bronzo Finale-prima età del ferro, favorita dai rapporti di associazione ad Aussois-les Lozes (Savoia) tra mean-driformi e topografiche della prima età del ferro.
Nel complesso petroglifico di Sils im Domleschg a Carschenna (Grigioni), in particolare nelle rocce II, III e VIII, coppelle unite da lunghi canaletti tagliano i cerchi concentrici. Lo stesso, in ambito extra-alpino, in Spagna al monte Teleno a Maragatería (León), dove coppelle collegate da canaletti tagliano motivi a labi-rinto, molto più consunti (Campos Gómez 2011).
Sulla Rupe Magna di Grosio (Sondrio) coppelle e canaletti sono costantemente sovrapposti a figure dell’età del rame, del bronzo e della prima età del ferro (Arcà 1995). Trentanove casi dimostrano la loro posteriorità rispetto a figure geometriche rettangolari del Neoli-tico Finale-età del rame, a figure ad archi concentrici dell’età del rame (settore AL), a serpentiformi e meandriformi dell’età del bron-zo (AK), ad antropomorfi schematici del Bronzo Finale e della prima età del ferro, nonché ad armati (AG, ZH), a pugili (AB) e cavalli schematici (AD, ZS) della prima età del ferro. Dati confermati in Valcamonica a Capo di Ponte (Brescia) dalla cosiddetta Mappa di Bedolona, dove coppelle a disposizione semicircolare sovrappongo-no una composizione topografica recente, analoga a quella della vici-na Mappa di Bedolina del VII-IV sec. a.C. (Turconi 1997). Ritornan-do al complesso di Susa, il fatto che gli incavi insistano su di un supporto già sbozzato a scalpello o a piccone, con evidenti tracce dei relativi colpi, delinea come terminus post quem l’adozione dei corri-spondenti attrezzi metallici, verosimilmente non di bronzo.
Anche se si tratta di un argumentum a silentio, peraltro assor-dante per l’iconografia rupestre alpina, va considerata la totale assenza di coppelle al Bego, dove pressoché tutte le figure pic-chiettate appartengono a fasi incisorie dal Neolitico al Bronzo Antico; allo stesso modo in Valcamonica non sembra possibile asseverare alcuna associazione tra coppelle e figure delle fasi dal Neolitico al Bronzo Medio.
Ad quem. A Vallon-des-Vaux (Vaud), in corrispondenza di strati di una fase antica della cultura Cortaillod, a cavallo tra il V e il IV millennio a.C., sono venute alla luce una serie di piccole cop-pelline allineate, un “puntinato” ben diverso dalle coppelle pro-priamente dette (Sitterding 1972). Un piccolo masso flottato triangolare è stato trovato nel 1946 negli scavi di Egolzwil 4 (Lucerna); proviene da un contesto di Neolitico Medio nord alpi-no (circa 3800 a.C.) e reca incise dieci coppelle picchiettate in posizione ravvicinata, quasi allineate.
Rocce a coppelle, elementi di un paesaggio progettato e monumentalizzatoContestualizzazione archeologica e ambientale nella regione alpina
339
Dagli scavi dell’abitato del Bronzo Medio di Champ-Vully a Rances (Vaud), proviene un frammento di macina con otto cop-pelle in parte troncate dalla frattura (Gallay et alii 1980). Sulla collina di Jolimont (Berna), all’interno di una sepoltura del Bron-zo Medio, fu rinvenuta una piccola pietra con quattro coppelle (Keller 1863, p. 176 e fig. 1 in tav. XVII). Riferendosi ancora ai Montesei di Serso, la connessione con lo strato con ceramica tipo Luco è probabile, sia perché il masso coppellato è poggiato sullo strato di Bronzo Antico, già formato, sia perché è coperto, prima che dal livello più recente di orizzonte Sanzeno, da uno strato ste-rile di argilla con ciottoli (Broglio, Perini 1964).
Dagli scavi del villaggio minerario del VI-V secolo a.C. di Dos Curù a Cevo (Brescia), a 2000 m di quota, sono emersi massi inci-si con coppelle in un contesto stratigrafico di media età del ferro (Poggiani Keller et alii 2012). In Spagna a Ulaca (Ávala), in cima all’abitato fortificato del III-I sec. a.C. dell’etnia celtica dei Vetto-ni, un’emergenza rocciosa granitica mostra due vasche circolari collegate a una terza cavità inferiore con canaletto efferente (Ruiz Zapatero 2005, pp. 15-19). Una doppia scalinata intagliata nella roccia permette l’accesso alla superficie sommitale, così come a Susa e nel sito con strutture cultuali di Panoias, in Portogallo.
Per il rapporto con i pediformi, si può citare la roccia scoperta nel XIX secolo sulla cresta del Truc Monsagnasco a Villarbasse (Torino), nell’anfiteatri morenico di Rivoli (Piolti 1880; 1881). La Pierre aux Pieds di Pisselerand (Savoia), con i suoi 2730 metri di quota è forse una delle più alte rocce incise europee; ospita nume-rose coppelle a sezione cilindrica associate a 40 paia di pediformi di misura medio-piccola. Va infine citato il Ròch dij Gieugh di Usseglio (Torino), dove alle oltre 150 coppelle, dalla sezione a spi-goli vivi, indizio di esecuzione a strumento metallico, si associano una ventina di impronte di suola, di misura adatta a bambini da 4 a 11 anni (Drappero 1974). Per gli aspetti cronologici, giova spe-cificare che i pediformi compaiono in Valcamonica solo nell’età del ferro, a partire dalla fase IV2 (VII-VI sec. a.C.), quando altresì raggiungono la massima diffusione; proseguono con minore con-sistenza sino alla romanizzazione.
Rapporti ambientaliConsiderando il rapporto con l’ambiente antropico, la distribuzio-ne dei complessi coppellati mette in evidenza alcuni elementi dia-gnostici; tra questi la distribuzione maggioritaria lungo percorsi montani – in coincidenza con la rete di sentieri e mulattiere – la
Andrea Arcà - Francesco Rubat Borel
340
predilezione per posizioni dominanti nel paesaggio, una certa pre-ferenza per linee di demarcazione orografica e/o confinaria, e infi-ne, salvo rare ma significative eccezioni, la non associazione con insediamenti. Parte di questi assunti sono confortati dall’esame dell’archivio informatizzato delle rocce incise della Bassa Valle di Susa, realizzato dal Gruppo Ricerche Cultura Montana (1990); su 102 schede di massi coppellati con 1540 coppelle e canaletti è si-gnificativa la casistica di rocce “vicino a vie di comunicazione” (90%), “su versante” (79,6%) e in “posizione dominante” (43,7%).
Per quest’ultima è spettacolare il Brich Lombatera a Paesana (Cuneo), in Valle Po (Seglie 1987, Arcà et alii 2001), una dorsale sommitale a 1400 m di quota che gode di una eccezionale posizio-ne panoramica e che ben si presta alla definizione di “complesso monumentale” di tavole coppellate. Le coppelle hanno sezione cilindrica, mostrano reticoli di canaletti e denotano l’utilizzo di uno strumento metallico, come a Montaldo di Mondovì (Gamba-ri 1991) e a Susa, a indizio di un contesto di età del ferro. Altro caso di posizione particolarmente dominante, tra Quincinetto (Torino) e Donnas (Aosta), è quello del Bec Renon, a 1950 m di quota, una concentrazione di cinque massi ricoperti da profonde coppelle a sezione cilindrica, in parte unite da canaletti, e da vaschette quadre e rettangolari, in alcuni casi residui di pediformi disgregati. Secondo i dati del Gruppo Archeologico Canavesano il sito ha restituito qualche frammento ceramico della tarda età del ferro.
Per la posizione confinaria si possono citare nella Bassa Val di Susa (Torino) le più importanti rocce coppellate dell’area come la Pera dle Masche (pietra delle streghe), un grosso masso con 131 coppelle prive di canaletti, situato a pochi metri dall’attuale confi-ne comunale tra S. Antonino e Vaie; il masso SUS113 Buia, domi-nante, con 13 coppelle e canaletti, proprio sul confine comunale Condove-Caprie; la Pera Marsa (pietra marcia) SUS6 Peroldrado, altro masso dominante, superficie incisa piana con 29 coppelle e 8 canaletti, sul confine comunale Condove-Caprie. Per la Bassa Val-le di Susa, i casi citati comprendono le più importanti rocce cop-pellate dell’area. Lo stesso complesso di Bec Renon è sulla cresta che segna il confine tra il Piemonte e la Val d’Aosta.
Per la corrispondenza con linee di demarcazione orografica, ci si può riferire all’indritto del Monte Musiné a monte di Caselette (Torino), dove tre rocce coppellate seguono la linea di costone verticale che sale dal Castello di Camerletto alla Costa della Croce, e alla cresta della collina di Monsagnasco tra Rivoli e Villarbasse
Rocce a coppelle, elementi di un paesaggio progettato e monumentalizzatoContestualizzazione archeologica e ambientale nella regione alpina
341
(Torino), confine naturale tra zona morenica e pianura, dove si susseguono tre rocce coppellate.
Tra le principali rocce coppellate del versante alpino piemonte-se, solo quella di Susa è situata nei pressi di un abitato, in un area che corrispondeva, in origine, all’acropoli dell’insediamento della fine dell’età del ferro e di età romana. Le coppelle si trovano tut-tavia sull’affioramento roccioso sullo spartiacque della collina del castello medievale, sorto sull’antico palazzo di re Cozio e del pre-fetto romano. A pochi metri di distanza si trova l’arco fatto erigere nel 13 a.C. dedicato all’imperatore Augusto, attraverso il cui for-nice si vede la cima del Rocciamelone, montagna sulla quale si concentrano diverse testimonianze cultuali protostoriche (Rubat Borel 2008).
Riguardo ai rapporti ambientali, va considerata la presenza di tavole litiche appositamente sbozzate, spostate e “installate”. Ciò presuppone la necessità di avere un supporto coppellato nel pun-to in cui non ve ne poteva essere disponibile uno naturale. Gli esempi più espliciti provengono dalle valli di Susa e Chisone (Tori-no), con le tavole coppellate “gemelle” di Menolzio e di Crô da Lairi (il buco dei ladri) a monte di Fenestrelle (Gruppo Ricerche Cultura Montana 1990, pp. 59-60, 111-112) . La prima, la cosid-detta Pera Crevolà (la pietra bucherellata), è una tavola litica con 237 coppelle tagliata artificialmente e collocata in piano su sup-porti litici artificiali. La seconda, a monte dell’abitato di Puy in Val Chisone, è uno dei migliori casi di coppelle associate a reticolo “idrico” di canaletti.
Vanno infine citati alcuni complessi che presentano chiari indi-zi di monumentalizzazione – si potrebbero quasi definire “aree attrezzate coppellate” – quali Susa, l’altare rupestre di Ulaca e il Serapeo del III secolo d.C. di Panoias in Portogallo (Alföldy 1997; Correia Santos 2010). Emergono almeno tre elementi in comune: gradini di accesso scolpiti nella roccia, superficie incisa rialzata e ripianata, coppelle e vasche con canaletti. Sono tutti elementi che, combinati insieme, rendono più che plausibile, comprovata per Panoias, l’ipotesi di area sacrificale-offertoria, dove le cavità incise potevano giocare un ruolo di supporto funzionale.
ConclusioniA livello cronologico, una sintesi della trentina di casi esposti di-mostra una sostanziale carenza di riferimenti neolitici; i due casi presentati sembrano avere poco in comune con la maggior parte delle rocce coppellate. Esigua la casistica eneolitica, con un’unica
Andrea Arcà - Francesco Rubat Borel
342
presenza ante Rame 3 di poche coppelle medio-piccole distanzia-te. Maggioritaria per contro la contestualizzazione lungo le varie fasi dell’età del bronzo e soprattutto dell’età del ferro. Se si orga-nizzano graficamente i termini ante, ad e post quem compattando-li in un’unica tabella (fig. 2), emergono tre elementi qualificanti: - progressivo aumento, nel tempo, del numero e della concentra-zione delle coppelle;
- i canaletti – dapprima di congiunzione lineare tra le coppelle e poi a reticolo – appaiono solo nell’ultima parte dell’età del Bron-zo e soprattutto nell’età del ferro;
- l’associazione con i pediformi, che spesso comprende anche i canaletti, è pertinente al I millennio a.C.
Va però osservato che la maggior parte dei reperti coppellati rinvenuti in stratigrafia è, per forza di cose, di dimensioni limitate; ciò non permette un confronto soddisfacente con la monumenta-lità espressa da molte superfici incise su roccia continua. Ciò potrebbe significare o che si tratta di reperti a diversa funzione, strumentale-produttiva (molitoria, contabile, alimentare, ludi-ca…), oppure che essi erano collegati ad una ritualità meno pub-blica rispetto a quella presumibile delle superfici più estese. La disponibilità però di stratigrafie iconiche, come nel caso della Rupe Magna di Grosio, della Nuova Mappa di Bedolina e delle
2. Restituzione grafica in tabellasinottica delle rocce coppellate con contesto archeologico; lungo l’asse orizzontale superiore i reperti con termini ante quem (a eccezione di Vallon de Vaux ed Egolzwil, termini ad quem) ordinati in senso cronologico, i più antichi da sinistra (colonne verticali discendenti); lungo la fascia orizzontale centrale i reperti con termini ad quem, la cui posizione cronologica è contrassegnata dal cerchio con le doppie frecce orizzontali; lungo la fascia orizzontale inferiore i reperti con termini post quem (colonne verticali ascendenti); lungo l’asse verticale la scansione cronologica; le restituzioni grafiche riportano i contorni dei segni incisi, le curve di profondità e i rapporti di sovrapposizione, laddove presenti.
Rocce a coppelle, elementi di un paesaggio progettato e monumentalizzatoContestualizzazione archeologica e ambientale nella regione alpina
343
associazioni con i pediformi, sembra in grado di ovviare in parte al problema, per lo meno dal punto di vista cronologico.
Sotto l’aspetto interpretativo, tenendo in considerazione sia i dati provenienti dai complessi “monumentali” di Susa, Ulaca e Panoias, che le peculiarità ambientali – distribuzione lungo percor-si montani, predilezione per posizioni dominanti, preferenza per siti o linee di demarcazione orografico-confinaria – si può da un lato estendere la valenza monumentale-cerimoniale ad una parte significativa delle rocce coppellate, dicasi le maggiori, e dall’altra avanzare ipotesi riguardo alle ritualità ad esse sottese. Per quanto riguarda la valenza monumentale, gli elementi esposti lasciano intendere una sorta di gestione progettuale e architettonica dello spazio, tramite la scelta del sito, preferibilmente dominante e con superfici rocciose aggettanti e tabulari, e la distribuzione delle inci-sioni, anche a coprire certe aree o determinati percorsi. Rispetto alle motivazioni delle ipotetiche azioni offertorie, si può pensare ad atti o patti di sanzione-controllo dei perimetri territoriali e dei per-corsi intervallivi, e/o a culti dedicati alle sommità montane. In entrambi i casi la posizione dominante e tabulare, intesa come rivolta rispettivamente al territorio dominato o alle cime sovrastan-ti, pare essere elemento fondamentale e diagnostico.
Andrea Arcà - Francesco Rubat Borel
344
Bibliografia
G. Alföldy 1997Die Misterien von Panoias (Vila-Real, Portugal), in Madrider Mitteilungen 38, pp. 176-246.
A. Arcà 1995La Coppellazione, in A.Arcà, A. Fossati, E. Marchi, E. Tognoni, Rupe Magna: la roccia incisa più grande delle Alpi, vol. 1, Sondrio, pp. 87-93.
A. Arcà, A. fossAti, E. MArchi, E. toGnoni 2001Le ultime ricerche della Cooperativa archeologica “Le Orme dell’Uomo” sull’arte rupestre delle Alpi, in Secondo convegno internazionale di archeologia rupestre. Archeologia e arte rupestre: l’Europa - le Alpi - la Valcamonica, Atti del convegno di studi, Milano, pp. 139-166.
f. BAllEt, P. rAffAElli 1990Rupestres. Roches en Savoie, gravures, peintures, cupules, Chambéry.
d.G. BAnchiEri 2003Antiche testimonianze del territorio varesino, Azzate.
M. BErtolonE 1946Nuove scoperte archeologiche a Sesto Calende, in Rassegna storica del Seprio, VI, pp. 5-22.
A. BroGlio, r. PErini 1964Risultati di uno scavo nell’abitato preistorico dei Montesei di Serso in Valsugana, in Studi Trentini di Scienze Naturali, anno XLI, n. 2, pp. 159-180.
J.c. cAMPos GóMEz 2011Petroglifos en Maragatería, el enigma de los laberintos del Teleno, León.
c.f. cAPEllo 1949Scoperta di rocce cuppelliformi nell’agro segusino, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti I-IV, pp. 29-37.
M. ciMA 1988L’abitato dell’età del Bronzo finale di Santa Maria-Pont Canavese in valle Orco, in Preistoria e Protostoria del Piemonte, Atti XXXII Riun. Sc. IIPP, Firenze, pp. 253-264.
M.J. corrEiA sAntos 2010Inscripciones rupestres y espacios sagrados del norte de Portugal: nuevos datos y contextualización, in J. Alberto Arenas-Esteban (a cura di), Celtic religion across space and time, Toledo, pp. 181-198.
n. drAPPEro 1974La roccia dei giochi presso Andriera (m 1568) di Usseglio, in Bulletin d’Études Préhistoriques Alpines VI, pp. 179-184.
A. GAllAy, d. BAudAis, c. BoissEt 1980Rances, distr. d’Orbe, VD, in Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte 63, p. 233-236.
A. GAlli 1899Scoperta di una tavola Cuppelliforme a Rondineto, in Rivista Archeologica della provincia di Como 42, pp. 18-19.
f.M. GAMBAri 1991Le incisioni rupestri di Montaldo: analisi culturale ed ipotesi di interpretazione, in E. Micheletto, M. Venturino Gambari (a cura di), Montaldo di Mondovì. Un insediamento protostorico. Un castello, QSAP Monografie, Torino, pp. 29-34.
F.M. Gambari 2004Le statue-stele di Tina di Vestigné, in Notizie Archeologiche Bergomensi 12, pp. 175-193.
f.M. GAMBAri, A. Arcà 2012Le statue-stele di Vestigné, fraz. Tina. Indagini geologiche, verifiche subacquee ed esame degli elementi iconografici, in Preistoria Alpina 46, vol. II, p. 211-233.
f.M. GAMBAri, l. MAno 1991 L’area a coppelle: descrizione ed analisi delle incisioni, in E. Micheletto, M. Venturino Gambari (a cura di), Montaldo di Mondovì. Un insediamento protostorico. Un castello, QSAP Monografie, Torino, pp. 91-94.
A. GrEdiG 1979Die ur- und frühgeschichtliche Sedlung am Tummihügel bei Maladers, in Archäologie der Schweiz 2, n. 2, pp. 67-74.
GruPPo ricErchE culturA MontAnA 1990La pietra e il segno: incisioni rupestri in Valle di Susa, Susa.
M.A. hAldiMAnn, E. rAMJoué, c. siMon 1991Les fouilles de la cour de l’ancienne prison de Saint-Antoine: une vision renouvelée de la Genève antique, in Archäologie der Schweiz 14, 2, pp. 194-204.
f. KEllEr 1863Pfahlbauten, fünfter bericht, Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich XIV, Heft 6, Zurich.
f. lEhnEr 1978Die Ausgrabungen in der Kirche Biel-Mett BE, in Archäologie der Schweiz 1, 4, pp. 149-154.
h. MAtilE 1979Der Schalenstein in Grenchen Eichholz, in Archäologie des Kantons Solothurn 1, pp. 9-11.
Rocce a coppelle, elementi di un paesaggio progettato e monumentalizzatoContestualizzazione archeologica e ambientale nella regione alpina
345
M. sittErdinG 1972Le Vallon des Vaux. Rapports culturels et chronologiques, les fouilles de 1964 ä 1966, Monographien zur Ur- und Frühgeschichte der Schweiz 20, Basel.
W. struB 1949Heimatbuch Grenchen, die vergangenen Jahrhunderte bis in die Gegenwart dargestellt, Solothurn.
u. tEcchiAti 2013Luoghi di culto, sepolture e sepolcreti dell’età del Rame dell’area atesina, in R.C. de Marinis (a cura di), L’età del Rame, la pianura padana e le Alpi al tempo di Ötzi, Brescia, pp. 457-480.
c. turconi 1997 La mappa di Bedolina nel quadro dell’arte rupestre della Valcamonica, in Notizie Archeologiche Bergomensi 5, pp. 85-114.
r. PoGGiAni KEllEr, f. MAGri, M.G. ruGGiEro 2012 Arte schematica da un contesto della media età del Ferro: Cevo-Dos Curù (BS), in Preistoria Alpina 46, II, pp. 371-373.
B. rEBEr 1893Recherches archéologiques dans le territoire de l’ancien évêché de Genève, in Mémoires et documents publiés par la Société d’Histoire et d’Archéologie de Genève XXII, pp. 282-326.
P. ricchiArdi, d. sEGliE 1987Le incisioni rupestri del versante, in R.Nisbet, P.Biagi, Balm’ Chanto: un riparo sottoroccia dell’Età del Rame nelle Alpi Cozie, Como, pp. 121-122.
f. ruBAt BorEl 2008Confronti per le aree di montagna e di valico: frequentazione e immaginario dei passi alpini piemontesi, in PPE.Atti VIII, pp. 463-476.
f. ruBAt BorEl, M. squArzAnti, c. nEriccio, c. cErutti 2013 Castelletto Ticino (NO), via delle Acacie 1. Struttura monumentale dell’età del Ferro, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte 28, pp. 239-241.
G. ruiz zAPAtEro 2005Castro de Ulaca, Solosancho, Ávila.
u. schWEGlEr 1992Schalen-und Zeichensteine der Schweiz, Veröffentlichung der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte, Antiqua 22, Basel.
d. sEGliE 1987Incisioni rupestri nella valle Po, in Arte rupestre nelle Alpi Occidentali dalla Valle Po alla Valchiusella, Cahiers Museo Montagna 55, pp. 42-26.
f. MEzzEnA 1997La Valle d’Aosta nel Neolitico e nell’Eneolitico, in La Valle d’Aosta nel quadro della preistoria e protostoria dell’arco alpino centro-occidentale, Atti XXXI Riun. Sc. IIPP, Firenze, pp. 17-133.
f. MEzzEnA, r. MorAndi 1992La datazione delle più antiche incisioni rupestri dell’arco alpino alla luce dei ritrovamenti di Vollein (Valle d’Aosta), in L’Arte in Italia dal Paleolitico all’Età del bronzo, Atti XXVIII Riun. Sc. IIPP, Firenze, pp. 385-398.
J. nAuE 1887Die Hügelgräber zwischen Ammer- und Staffelsee: geöffnet, untersucht und beschrieben, Stuttgart.
n. nEGroni cAtAcchio 1981Como preromana: scavi a Pianvalle, in Sibrium 1963, pp. 67-113.
G. nElh 1980Aperçu sur l’art rupestre de Haute-Maurienne, Cahiers du GERSAR 2, Milly-la-Forêt.
G. Piolti 1880 Nota sopra alcune pietre a scodelle dell’anfiteatro morenico di Rivoli (Piemonte), in Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino XVI (1880-81), pp. 403-406.
G. Piolti 1881 Nuove ricerche intorno alle pietra a segnali dell’anfiteatro morenico di Rivoli (Piemonte), in Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino XVII (1881-82), pp. 221-226.
r. PoGGiAni KEllEr, M.G. ruGGiEro 2012Arte schematica dall’abitato del XIII sec. a.C. di Ponte S. Marco (Calcinato, BS), in Preistoria Alpina 46, II, pp. 363-364.
Andrea Arcà - Francesco Rubat Borel
Riassunto / Abstract
346
Le coppelle, l’elemento più rappresentativo dei petroglifi non figurativi, sono il segno inciso più diffuso in tutto l’arco alpino. Il contributo esamina una trenti-na di casi di contesto archeologico, sia stratigrafico che iconografico. Si espon-gono elementi diagnostici di rapporto con l’ambiente antropico, quali la distri-buzione maggioritaria lungo percorsi montani, la predilezione per posizioni dominanti e per linee di demarcazione orografica o confinaria. Si evidenzia una presenza a partire dalle varie fasi dell’età del Bronzo e soprattutto dell’età del ferro. Si nota un progressivo aumento, in queste fasi, del numero e della con-centrazione delle coppelle. Si sottolineano spunti di monumentalità, tramite la scelta di siti dominanti e la preparazione di superfici rocciose aggettanti e tabu-lari. A livello interpretativo si ipotizzano azioni offertorie rivolte al controllo dei perimetri territoriali e dei percorsi intervallivi, nonché a culti dedicati alle som-mità montane.
Cup-marks, the top representative element of non-figurative petroglyphs, are the most common engraved sign in the Alps. The paper examines some thirty cases of archaeological context, stratigraphic or iconographic. Exposes diagnostic ele-ments of relationship with the anthropic environment, such as the prevailing distribution along mountain trails, the preference for dominant positions and for orographic or bordering demarcation lines. Highlights a development starting from the various phases of the Bronze Age, which increases during the Iron Age, and a progressive boost, in this range, of cupmarks number and concentration. Emphasizes aspects of monumentality, like through the selection of overlooking sites and the placement of tabular and jutting out rock surfaces. Hypothesises offering acts, aimed at controlling territorial boundaries and pass routes between the valleys, as well as cults dedicated to the mountain tops.