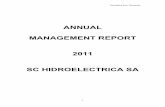Antonelli Archetipo Sc Sic
Transcript of Antonelli Archetipo Sc Sic
4 S. DE SANTIS
Società Filologica Romana c/o Dipartimento di Studi europei e interculturali, Università di Roma “La Sapienza” Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma
ISSN 0391-1691
Rivista annuale, anno 2012 n. 8, nuova serie.Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 514/2005 del 19/12/2005
Direttore responsabile: RobeRto Antonelli
Direzione: RobeRto Antonelli, GiovAnnellA DesiDeRi, AnnAlisA lAnDolfi, MiRA MocAn, MADDAlenA siGnoRini
Comitato scientifico: fAbRizio beGGiAto, coRRADo boloGnA, MeRceDes bReA, PAolo cheRchi, luciAno Rossi, eMMA scoles, cesARe seGRe, GiusePPe tAvAni
Redazione: sAbinA MARinetti (coord.), vAlentinA AttuRo, silviA conte, silviA De sAntis, loRenzo MAinini, MARtA MAteRni
La rivista si avvale della procedura di valutazione e accet-tazione degli articoli double blind peer review
Stabilimento Tipografico « Pliniana »V.le F. Nardi, 12 - 06016 Selci-Lama (Perugia) - 2012
5TOLLE MAGAN, TOLLE MALEFICAM
INDICE
Silvia Conte: Il chantar della rana e la topicadell’esordio Pag. 7
Valentina Atturo: Dalla pelle al cuore. La “pun-tura” e il « colpo della pietra », dai trovatoria Petrarca » 61
Roberto Antonelli: Interpretazione, ricezione evolontà dell’autore dai Siciliani a Guittone » 119
Isabella Proia: I componimenti in esasillabi del Can- cionero de Herberay des Essarts: una possibileinterpretazione metrica » 151
119INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
INTERPRETAZIONE, RICEZIONEE VOLONTÀ DELL’AUTORE
DAI SICILIANI A GUITTONE (*)
Partirò dalla volontà dell’autore, per (ri)esaminare brevemente, e secondo prospettive ancora aperte, il punto di passaggio nevralgico, in assenza di originali o d’altro che possa valere per tale, per ogni filologia formale che aspiri a ricostruire più da vicino la vo-lontà dell’autore: mi riferisco ovviamente all’archetipo e alle sue problematiche. Mi limiterò ai Siciliani, e più specificamente ancora, ai cosiddetti Federiciani e affini, ovvero a coloro che in vario modo opera-rono a contatto stretto con la Magna Curia e che i primi fascicoli del Vaticano latino 3793 confermano come tali. È un’identificazione che risale, come noto, a Gianfranco Contini (1), ancor oggi sostanzialmente rispettata, come l’unica valida, anche nell’ultima edi-zione complessiva, pubblicata nei “Meridiani” Mon-dadori (2). La scelta è dovuta non solo all’esperienza
(*) L’articolo riproduce, con l’aggiunta delle sole note biblio-grafiche, la relazione letta e discussa al convegno La tradizione della lirica nel medioevo romanzo. Problemi di filologia formale (Firenze-Siena, 12-14 novembre 2009), per sopravvenuti impegni non conse-gnata agli Atti pubblicati a cura di Lino Leonardi, con lo stesso titolo del convegno, Firenze 2011.
(1) Poeti del Duecento, a c. di G. Contini, Milano-Napoli 1960, 2 voll., I, p. 45.
(2) I poeti della scuola siciliana, edizione promossa dal Centro di studi filologici e linguistici siciliani, 3 voll. (vol. I: Giacomo da Lentini, edizione con commento a c. di R. Antonelli; vol. II: Poeti
120 R. ANTONELLI
elaborata nel corso dell’edizione mondadoriana, ma anche al fatto che l’esistenza di un archetipo comu-ne « per quasi tutto (o tutto addirittura) il materiale siciliano », già sostenuta dallo stesso Contini (3), è stata posta in dubbio proprio a partire da un convegno preparatorio all’edizione dei “Meridiani”, svoltosi a Lecce nel 1998 (4), ed è stata poi alquanto pedissequa-mente ripetuta anche in opere di carattere generale, senza peraltro mai discutere ulteriormente nel merito.
Nel convegno leccese Giuseppina Brunetti in un intervento per molti aspetti intelligente e pregevole, dedicato a Il libro di Giacomino e i canzonieri individuali: diffusione delle forme e tradizione della scuola poetica sici-liana (5), si era proposta di investigare, oltre all’even-tuale presenza di tracce di canzonieri individuali nella tradizione manoscritta, « le numerose e plausibilmente diverse transizioni » del processo costitutivo dei canzo-nieri lirici, limitatamente « a episodi rintracciabili nella preistoria dei canzonieri lirici italiani », precisando che intendeva, in particolare, « interrogare il modello vulgato dell’archetipo toscano per verificare se esso ottempera ancora efficacemente alla comprensione dei materiali manoscritti, e, per quanto possibile,
della corte di Federico II, edizione con commento dir. da C. Di GiRo-lAmo; vol. III: Poeti siculo-toscani, edizione con commento dir. da R. ColuCCiA), Milano 2008.
(3) G. Contini, Questioni attributive nell’ambito della lirica siciliana, in VII Centenario della morte di Federico II imperatore e re di Sicilia. Atti del Convegno internazionale di studi federiciani (Università di Palermo, Catania e Messina, 10-18 dicembre 1950), Palermo 1952, pp. 367-395; poi in Contini, Frammenti di filologia romanza. Scritti di ecdotica e linguistica (1932-1989), a c. di G. BResChi, Firenze 2007, 2 voll., I, pp. 205-234, p. 232.
(4) Dai Siciliani ai Siculo-toscani. Lingua, metro e stile per la definizione del canone. Atti del Convegno (Lecce, 21-23 aprile 1998), a c. di R. ColuCCiA - R. GuAlDo, Galatina 1999.
(5) G. BRunetti, Il libro di Giacomino e i canzonieri individuali: diffusione delle forme e tradizione della scuola poetica siciliana, in Dai Siciliani ai Siculo-toscani cit., pp. 61-92, in part. 61-62.
121INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
degli accadimenti determinati che li sostennero e li produssero ». Constatato che di canzonieri individuali si potrebbe parlare tutt’al più per Giacomo da Lentini e Giacomino Pugliese e dedottone che dunque tutto il resto deve essere circolato in antologie o in rotoli sciolti, Brunetti fonda l’esame della tradizione quasi totalmente sul rapporto fra versioni “corte” e versioni “lunghe”, attribuendo agli spazi bianchi dal Vaticano latino 3793 un valore significativo che in realtà non sembrano avere (come si è tentato di dimostrare a suo tempo (6)). La Brunetti ne deduceva, riprendendo, per rovesciarla, una nota proposizione continiana, che era ormai necessario
riconsiderare il problema dell’archetipo toscano se-condo una lente d’ingrandimento che privilegi la risoluzione, nei limiti del plausibile, dei singoli testi e poi dei singoli corpora. L’ “abecedario” perciò non potrà che fornire soluzioni parziali, caso per caso, e l’archetipo forse occorrerà ripensarlo anch’esso più mobile nel tempo e contornato di altre, peraltro ovvie e plausibilissime, esperienze scritte; carte sciolte e mi-croaggregazioni testuali (7).
Malgrado la prudenza e la metodologia esposte, entrambe condivisibili e paradigmatiche, almeno dalla relazione palermitana di Contini in poi, ci possiamo chiedere come stiano oggi effettivamente le cose e se non sia possibile provare a tirare un nuovo bilancio complessivo e non episodico ora, dopo una nuova edizione integrale e commentata della Scuola siciliana, che ha ripreso ab imis il problema della classificazione di ogni singolo componimento.
(6) R. Antonelli, Struttura materiale e disegno storiografico del canzoniere vaticano, in I canzonieri della lirica italiana delle origini. IV. Studi critici, a c. di l. leonARDi, Firenze 2001, pp. 3-23, pp. 20-21.
(7) BRunetti, Il libro di Giacomino cit., p. 91.
122 R. ANTONELLI
Come si è ricordato, l’esame analitico più attendi-bile dei rapporti stemmatici fra i manoscritti relatori dei Siciliani, a cominciare dai tre più antichi, V, P, L (nelle parti per noi interessanti dovuto a tre mani distinte, La, Lb1, Lb2) (8), si deve infatti a tutt’oggi a Gianfranco Contini, che concludeva così il suo saggio:
L’esistenza d’un archetipo comune a V L P è certa in due casi su undici (...), probabile in altri quattro (...), possibile in un quinto (...), non dimostrabile in quattro (più il sonetto, per definizione troppo breve). Sono cifre non prive di significato, in particolare il basso esponente dell’ultima categoria, gravata sempre d’una suspicione di casualità che è inversamente proporziona-le al numero degli esempi. Ne risulta che l’ipotesi d’un archetipo comune per quasi tutto (o tutto addirittura) il materiale siciliano, il cui tenore linguistico non si riesce a sorprendere molto più siciliano del vulgato (...) e in cui già s’includevano testi siculo-toscani (...), in altre parole d’un archetipo toscano, appare seriamente verisimile (9).
Contini alla fine del suo articolo aveva preso in esame le undici canzoni tràdite da tutti e tre i ma-noscritti (tardo) duecenteschi V P e La per risolvere i problemi attributivi relativi ai testi assegnati in almeno un codice a Federico II, ciò che imponeva l’individuazione o meno di un antecedente comune
(8) Le tre sigle rimandano notoriamente, rispettivamente, ai canzonieri Vaticano latino 3793, Laurenziano rediano 9 (prima parte, pisana, La , Lb fiorentina) e Banco rari 217 (ex Palatino 418, da cui l’improvvida sigla P invalsa negli ultimi decenni, proprio a ricollocazione avvenuta); per il riconoscimento definitivo delle tre mani del Laurenziano cfr. s. ZAmponi, Il canzoniere Laurenziano: il codice, le mani, i tempi di confezione, in leonARDi, I canzonieri della lirica italiana cit., pp. 215-245 (in part. 221-238).
(9) Contini, Questioni attributive nell’ambito della lirica siciliana, pp. 393-394, ora in Frammenti di filologia romanza cit., pp. 231-233, a cui d’ora innanzi si rinvierà.
123INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
con V e P, ferma restando la dipendenza di questi ultimi due da un comune e vicino antecedente, con-diviso anche con Lb, sezione fiorentina di L, stretta affine di V. Ripartiamo anche noi da quegli undicicomponimenti e vediamo come si presenta la questio-ne dopo quasi sessant’anni di studi e dopo la recente edizione critica mondadoriana, elemento quest’ultimo assumibile come significativo poiché ha impegnato nella ricognizione stemmatica dei Siciliani, con assolu-ta autonomia investigativa, quattordici editori di varia estrazione metodologica (10), certo rispettosi dell’autori-tà del Contini, ma inevitabilmente dediti, semmai, a poterne migliorare o correggere taluni punti, come è normale in imprese del genere, ed in genere pro-pensi ad evitare il ricorso ad una stemmatica troppo formalizzata per stabilire il testo.
Mi limiterò a enunciare i risultati raggiunti dalla critica più recente e discuterò soltanto i casi ancora dubbi o in cui vi sia forte contraddizione con le
(10) R. Antonelli per Giacomo da Lentini; A. FRAttA per Ruggeri d’Amici, Odo delle Colonne, Paganino da Serzana, Iacopo d’Aquino, Jacopo Mostacci, Folco di Calavra, Filippo da Messina, Iacopo, canzoni e sonetti anonimi siculo-toscani; s. RApisARDA per Tommaso di Sasso, Federico II; C. CAlenDA per Guido delle Co-lonne, Re Giovanni, Arrigo Testa, Ruggerone da Palermo, Rug-geri Apugliese, Re Enzo, Percivalle Doria; A. Comes per Rinaldo d’Aquino; G. mACCioCCA per Pier della Vigna; m. pAGAno per Ste-fano Protonotaro e Anonimi siciliani; m. spAmpinAto BeRettA per Cielo d’Alcamo e Anonimi siciliani; G. BRunetti per Giacomino Pugliese; F. lAtellA per Mazzeo di Ricco; m. BeRisso per Galletto Pisano, Neri Poponi, Tiberto Galliziani, Lunardo del Guallacca, Betto Mettefuoco, Ciolo de la Barba, Petri Morovelli, Guglielmo Beroardi, Megliore degli Abati, Pucciandone Martelli, Inghilfredi, Arrigo Baldonasco; s. luBello per Compagnetto da Prato, Neri de’ Visdomini, Folcacchiero, Bartolomeo Mocati, Caccia da Siena, Carnino Ghiberti, Brunetto Latini, Bondie Dietaiuti, Maestro Fran-cesco, Ugo di Massa, Maestro Torrigiano; R. GuAlDo per canzoni e sonetti anonimi siculo-toscani e per i sonetti anonimi del Chigiano; p. lARson per un’appendice di frammenti e testi vari.
124 R. ANTONELLI
conclusioni raggiunte nelle Questioni attributive (di cui adotto la progressione seriale) e poi nei Poeti del Due-cento, ove lo stesso Contini aveva a volte rimesso in discussione le proposte formulate nel lavoro del 1952:
a) Madonna, dir vo voglio; Contini prudenzialmente considerava l’archetipo soltanto « possibile », mentre nei Poeti del Duecento non veniva neppure ipotizzato; ne è stata invece dimostrata l’esistenza con certezza (11), grazie alla tradizione indiretta assicurata dalla fonte provenzale, da Contini non considerata (12); per lo stesso motivo, e consequenzialmente è stato possibile definire la posizione di ogni singola testimonianza della tradizione: V con Mm (Memoriali bolognesi) e P con Gt (Giuntina), tutti e quattro dipendenti da un comune subarchetipo vs La, secondo una costellazione che ritroveremo anche altrove.
b) Meravigliosa-mente; per Contini era uno dei due casi in cui l’archetipo era « veramente palese »; in realtà proprio « palese » non sembra, stante che quasi tutti gli errori comuni “sicuri” individuati da Conti-ni possono essere a volte diversamente interpretati. Ma, salvo a voler molto cavillare (come il sottoscritto nell’edizione mondadoriana) (13), sembra resistere ad ogni tentativo di scardinamento l’errore individuato al v. 46, per l’uso del femminile in rima, di tutti i
(11) GiAComo DA lentini, Poesie, edizione critica a c. di R. An-tonelli, Introduzione, testo, apparato, Roma 1979, p. 8; iD., Metrica e testo, in « Metrica », 4 (1986), pp. 37-66, p. 49 nota.
(12) I poeti della scuola siciliana cit., vol. I, pp. 6-7.(13) Consegnata nel febbraio 2005, cfr. p. Cvii dell’Introduzione
(con conseguente chiusura della bibliografia, salvo motivate ecce-zioni, alla stessa data, p. Cxxiv); incaute (come del resto le propo-ste di correzioni, sovrabbondanti di singolari errori metodologici e fattuali) le osservazioni di m. peRuGi, Su Meravigliosamente di Giacomo da Lentini e sul frammento ravennate, in « Per leggere », n. 17, 9 (autunno 2009), pp. 9-32, p. 27, n. 5.
125INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
mss., trascinato dalla seguente madonna; in 53, invece, secondo un’ipotesi già del Gaspary, è molto probabile una diversa lettura dei tre manoscritti (« sacciatelo per singa / zo ch’e’ voi dire’ a linga, / quando voi mi vedite »), garantita anche dalle unità di scrittura (14). Occorre inoltre aggiungere che tutti gli altri casi, seppur singolarmente non decisivi, formano serial-mente un bel gruppetto di possibili errori comuni ai tre manoscritti.
c) Ben m’è venuto prima cordoglienza, ancora del Notaro; « archetipo immaginabile » per Contini, essen-zialmente da due luoghi (29, 37), che non sembrano aver tenuto completamente alla distanza, in quanto in 29 la lezione giusta potrebbe essere assicurata da La, così come in 37 la lezione corretta appare tràdita ancora da La cui nell’occasione si aggiunge P; sembra invece evidente la genesi comune della diffrazione in 40, ove la lezione corretta è deducibile da La, che peraltro interpreta in altro modo, come testimoniano le unità di scrittura, tutte orientate sul congiuntivo sofra invece che sul necessario indicativo sofr(e), da cui le difficoltà del passo per gli interpreti moderni (15).
(14) I poeti della scuola siciliana cit., vol. I, pp. 40-46.(15) Ibid., pp. 176-178: « Non soccorrono a prima vista tracce
evidenti d’archetipo (cfr. eventualmente 40, a spiegare la con-seguente diffrazione), (...). In 40 si cela quasi certamente una difficoltà in archetipo determinata da due possibili situazioni: (1) una sequenza di scrittura chisofracompleuincie, preferibile, in ragione di V e P, a chisofracompleeuincie = chi sofr’acompl’e vince, variamente distinta e/o percepita negli spazi fra un’unità di scrittura e un’altra, con difficoltà interpretative legate all’elisione della vocale finale di sofre e attribuzione dell’iniziale di acompie al verbo precedente, errore comune a tutti e tre i manoscritti, ma non necessariamente già in archetipo (che può aver solo oggetti-vamente favorito, nella disposizione grafica, tale distinctio, pur se resta difficile determinare con esattezza le unità di scrittura origi-narie); si spiegherebbe pertanto bene la progressiva deformazione
126 R. ANTONELLI
Il tutto motivato, o accompagnato, dall’incompren-
della lezione originaria, con La al solito più vicino all’archetipo (chi sofra conpie [con riduzione del nesso pl- a pi-] e uincie ogni tardanza < chi sofr’aconpl’e uincie ogni tardanza), e l’antecedente di V e P ki sofra sconpra (con usuale rotacizzazione del nesso pl- a pr- e assimilazione analogica della desinenza del secondo verbo al primo) euince ogni tardanza da cui la diffrazione, in entrambi i casi per rendere più comprensibile il senso: in V se (con inter-pretatio del chi ipotetico e banalizzazione di scompra per cavarne un senso) sofera sgombra euincie ogne tardanza, in P ki sofra uince e scompra one acordança (con pesanti interventi nell’ordine delle parole e nel rimante per cavarne anch’egli un qualche senso);(2) una sequenza del tipo sofra conplere uince ogni tardanza (= chi sofr’a compler vince ogni tardanza ‘chi pazienta a completare [l’amore] supera ogni difficoltà’) con difficoltà interpretative causate nella scrittura forse da una r abbreviata in conple(r)e (con l’abbreviazione sulla prima e o addirittura più arretrata, verso la i, da cui una lettura conprie, o simile, che spiegherebbe anche V P) e dal (con-seguente?) misconoscimento analitico dell’unità di scrittura sofra + compler (costruzione di sofrir + a e infinito, secondo il modulo identificato in G. Colussi, Ricerche sulla lingua del Duecento e primo Trecento: reggenza infinitiva e temi afferenti, Helsinki 1978, p. 20), con conseguenti diversi comportamenti dei tre manoscritti. La (il più vicino all’archetipo) copia semi-meccanicamente e interviene in modo meno impegnativo, (riduzione del nesso pl- e obliterazione della r, (...), realizzando due verbi di modo finito coordinati dalla -e finale di conple(r)e: sofra conple(r)e uincie > sofra conple e uincie; l’antecedente comune di V P derivando scompraeuincie da uno scompre con s- intensiva o addirittura, immediatamente, scompra euincie, che V e P dotano ulteriormente di senso, ‘chiarendo’ ognuno a suo modo (di nuovo, con comportamenti analoghi aquelli accertati in Madonna, dir vo voglio): V sgombra euincie, P, in-vertendo, uincie e sco(n)pra, per offrire ulteriore senso rispetto allalezione scompra (“riscatta”). La soluzione più economica e in grado di spiegare più facilmente le altre sembra la (1), già proposta da S. sAntAnGelo, Giacomo da Lentini e la canzone « Ben m’è venuto » (1947), poi in Saggi critici, Modena 1959, pp. 191-209, p. 198 (che però non ne traeva tutte le conseguenze nella restituzione del testo stampando chi sofre acompie e lasciando così spazio alla di-versa soluzione di Contini), ma la (2), che potrebbe aver prodotto di fatto la (1) in un interposito, spiegherebbe forse maggiormenteil grado di difficoltà incontrato dai copisti e la conseguente diffrazione (...). Non è verosimile che in archetipo vi potesse
127INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
sione evidente di conpie. Dunque archetipo sostanzial-mente sicuro, malgrado tutti i possibili e metodologi-camente necessari dubbi (16), poiché non testimoniato con certezza da un errore ma perlomeno da una disposizione testuale che ha portato alla diffrazione.
d) Vostr’argogliosa cera di Arrigo Testa (in questo caso e in seguito mi riferirò, di fronte ad attribuzioni multiple, soltanto all’autore comunemente accettato); per Contini « Nessuna traccia d’archetipo, come nes-sun sicuro apparentamento binario » (17). Valutazione confermata anche dall’ultimo editore, Corrado Ca-lenda (18).
e) Contra lo meo volere, di Paganino da Serzana; archetipo forse deducibile da 55 secondo Contini, con cui concorda il recente editore, Aniello Fratta (e di fatto anche le Concordanze di Avalle (19), che leggono mostran): « Quando fra due amanti / Amore igualemente / si mostra benvolente, nasce e vene / di quello amore manti / piaceri, ond’omo sente / gioia al core parvente – e tuto bene; » (55 mostran La P; ben uoglente La, benuogle(n)te P; nasciene V, nasce bene La). Si può però pensare (anche vs Clpio) a una lettura, difficilior, ’n benvolente (“in atteggiamento benvolente, come benvolente”) di La P, che in più punti sembra-no assicurare la lezione migliore, e dunque cadrebbe l’ipotesi Contini; V P potrebbero invece dimostrare unsegno di parentela per derivazione da un ue, integrato congetturalmente da P, riprodotto come ne da V e mo-
essere già una lezione erronea, ma certo alla base c’è quanto-meno una diversa modalità di reazione a uno stesso problema ».
(16) Ibid., pp. 176-179.(17) Contini, Frammenti di filologia romanza cit., p. 230.(18) I poeti della scuola siciliana cit., vol. II, p. 236.(19) Concordanze della lingua poetica italiana delle origini, a c. di
D’A. s. AvAlle e con il concorso dell’Accademia della Crusca, Milano-Napoli 1992 (d’ora innanzi Clpio).
128 R. ANTONELLI
dificato, più profondamente, da La (V nascene, La nasce e bene per nasce e vene di P). Il luogo dimostrerebbe cioè un punto di difficoltà reso in vario modo da La, molto probabilmente in anticipazione da 58, e V; P potrebbe a sua volta aver interpretato (o emendato?) autonomamente (nascene < nasceue [nasce e ve’ secon-do l’archetipo, non compreso dagli altri due mss.] all’origine anche di V, per perdita del titulus?). Si tratterebbe allora di errore in archetipo (e comunque non di congiunzione La P, posta la correttezza, difficilior, di mostran, o La V) (20); semmai La V P derivano da una stessa lezione monca o non comprensibile (diffrazione in presenza), da cui anche La che emenda in errore vs P che integra correttamente. Sembra dunque con-fermato, seppure per altra via, l’archetipo.
f) Amore avendo interamente voglia di Mazzeo di Ricco; l’unico altro « archetipo veramente palese », con (b) per Contini; confermato anche dall’ultimo editore, Fortunata Latella, che peraltro mette in discussione (con argomenti diversi e meno convincenti di Brunet-ti per 26) (21) entrambe le proposte continiane (22), che
(20) Poeti del Duecento cit., vol. II, p. 809.(21) BRunetti, Il libro di Giacomino cit., p. 90.(22) I poeti della scuola siciliana cit., vol. II, pp. 661-662: « Condi-
visibile la teoria della comune ascendenza, pur se qualcuno degli argomenti addotti è opinabile: per quel che concerne il v. 24, infatti, non è da escludere che partute, in cui le tre lettere finali sono oltretutto frutto di intervento correttivo, sia introdotta da La per sanare un’ipometria generata, forse, dalla voce verbale contrat-ta, toscaneggiata, faite registrata pure da P (...); quanto al v. 26, si potrebbe anche affacciare l’ipotesi di una scrizione iniziale piangi’en l’alegranza, con primitivo titulus sulla vocale della preposizione caduto nell’archetipo; la lezione risultante sarebbe stata accolta tal quale da V e complicata da tentativi di interpretazione da P e La. Non soccorre, invece, alcun errore congiuntivo inequivoco che permetta un raggruppamento in famiglie: l’unico motivo d’appa-rentamento di qualche validità riguarda 55, ove V e P omettono un dinanzi a luntan / lontano; complementare si può poi considerare
129INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
effettivamente possono in parte essere ridiscusse (in particolare in 26 la lezione corretta è contenuta in P), ma una almeno delle quali, 24, parti per partute, è degna ancora di attenta riflessione; lievi indizi a favore di una congiunzione V P secondo Latella, vs Contini, per il quale « nulla prova che i tre codici non siano mutuamente indipendenti » (23).
g) Amor mi fa sovente di Re Enzo; « di archetipo nessuna traccia » per Contini, ma « Sicura è la paren-tela di V con P, Ch, V2 (e i loro affini) » (24), in più punti, a cominciare dalla comune mancanza delle due ultime strofi, il che isola La nei piani alti dello stemma, come sottolinea anche Corrado Calenda (25) (non ben comprensibile la posizione Brunetti, fon-data comunque di nuovo, sembrerebbe, sulla diversa estensione della canzone in La rispetto al resto della tradizione) (26).
h) S’eo trovasse pietanza di re Enzo/Semprebene; per Contini, che pure non lo inserisce accanto ai due casi sicuri, l’archetipo è dimostrato per ipometria in 39, « come prova la varietà dei supplementi » di tutta la tradizione (da iniziale di La V2 poria per pò di P, poi iniziale in Barbieri, mai V, mai con sostituzione di
l’accordo di V e P al v. 41 (jo so ch’io n’agio doloroso core V, eo so k’io n’agio doloroso core P vs. pur so ch’eo n’aggio adolorato il core La) e al v. 47 (che l’omo V, ke l’omo P vs. che ll’om La) ».
(23) Contini, Frammenti di filologia romanza cit., p. 229.(24) ibid., p. 230.(25) I poeti della scuola siciliana cit., vol. II, p. 718: « Per la
parte comune, la semplice escussione dell’apparato dimostra lim-pidamente la bipartizione dei rami alti dello stemma, con La in posizione isolata. La famiglia in cui si aggruppano tutti gli altri codici, con apparentamenti inferiori facilmente operabili, è dimo-strata, oltre che dalla citata lacuna delle ultime due strofi [vs La], soprattutto dall’ipermetria del v. 25 e dalle corruzioni varie delle esatte lezioni di La ai v. 12 (di cioe), 15 (delo) e 36 (matuttor laterro). ».
(26) BRunetti, Il libro di Giacomino cit., p. 88.
130 R. ANTONELLI
poi a che Ch) »; l’assunto Contini (27) ha dato luogo allo stemma Ageno (28) ed è accettato da Calenda (29), che af-ferma « la plausibilità di un archetipo ». Notoriamente più complessa, ed estremamente rilevante anche ai nostri fini, la distribuzione dei mss. nello stemma, a cominciare dalla posizione reciproca di V e Ch, per i Siciliani normalmente solidali.
i) Blasmomi dell’amore, di Tiberto Galliziani secondo V; per Contini « nessuna traccia d’archetipo, ma solo evidente parentela di V con P (e il parallelo Ch) » (30); « indimostrabile l’archetipo » per Marco Berisso, che riconosce anch’egli, come già Contini, la congiunzione P Ch, arrivando però a ipotizzare addirittura la possi-bilità che Ch sia descritto da P (31), ciò che appare del tutto da scartare. Si osservi comunque che la canzone è contenuta nella seconda parte di P (Pb secondo la sigla introdotta da Brunetti) e dunque va con una seconda fonte, disponibile per il copista solo dopo aver copiato la parte alfabetica (Pa). È dunque par-ticolarmente interessante l’opposizione La vs P Ch V.
j) Già lungiamente, Amore, pure di Tiberto Gallizia-ni; « I dati sono i seguenti: 16 errore di V L (di quella c’ò temenza per quella cui ho t., P q. di cui t.); 19 errore di V L (or) o di V P (O iniziale); 37 ipometria comu-ne, variamente supplita (E V, Ka P,), in V P, da cui s’inferisce S’eo per Sed (o Se più dialefe) eo (L se io). L’ultimo caso fa indubbiamente pensare all’archetipo,
(27) Confermato in Contini, Ancora sulla canzone S’eo trovasse pietanza, in « Siculorum Gymnasium », n. s., 8 (1955), pp. 122-138, poi in Frammenti di filologia romanza cit., pp. 265-280, mentre appare in dubbio in Poeti del Duecento cit., vol. II, p. 816.
(28) F. BRAmBillA AGeno, L’edizione critica dei testi volgari, Padova 1975, pp. 257-258.
(29) I poeti della scuola siciliana cit., vol. II, p. 729.(30) Contini, Frammenti di filologia romanza cit., p. 230.(31) I poeti della scuola siciliana cit., vol. III, p. 114.
131INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
e così il primo (di anticipato dal verso successivo), incerto rimane l’aggruppamento binario, ma è debito registrare le molte varianti deteriori di forma a carico di V P » (32) (6, 9, 27, 36, 39, 44). Per Berisso l’archetipo potrebbe essere dimostrato solo da 19 ove ipotizza(vs il dubbio, o meglio, la pura descrizione fenomeno-logica di Contini) un intervento congetturale di La e quindi errore congiuntivo comune ai tre codici, men-tre risolve nettamente a favore di una congiunzioneV La vs P il dilemma esplicitato da Contini nello stesso 19 (33). In effetti anche in questo caso sembra più op-portuno cogliere una parentela V P vs La, oltre che in 16, come propone Berisso vs Contini (34), anche su altriluoghi: 43, ove la lezione di La V è difficilior rispetto a P (ch’è più per suo servire vs e più per lei servire, a patto d’interpretare correttamente 42 per ch’io, “per il fatto che io”) e conseguentemente 45, ove si verifica la stessa congiunzione e dove perdimento è anche sorretto da buona compagnia siculo-toscana (ca˙ss’eo mi moro (...) perdimento); in 19 del resto è certo preferibile la lezione di La vs V P, che danno un unicum in O deo negli incipit duecenteschi. Il dato ha una qualche rilevanza per l’interpretazione complessiva della tra-dizione dei Federiciani e affini, poiché non porta a presupporre – almeno qui – pluralità di fonti per uno stesso autore, pur pisano (rappresentato per di
(32) Contini, Frammenti di filologia romanza cit., p. 231.(33) I poeti della scuola siciliana cit., vol. III, pp. 126-128 e spe-
cialmente 127 (dove non si comprende perché La avrebbe dovuto congetturare su una lezione tràdita correttamente) « 19 odeo cor V odio kio P deo cor La; l’errore di V P non è disgiuntivo, vista la facilità dell’intervento congetturale di La (e del resto interviene, seppur più pesantemente, anche P) per ristabilire la misura del verso (indica semmai errore d’archetipo, preservato come tale dal solo V) ».
(34) Ibid., p. 127: « la costruzione di V La a 16 appare inap-puntabile ».
132 R. ANTONELLI
più da due soli componimenti), mentre non sembra resistere nessuna delle indicazioni d’archetipo cauta-mente ipotizzate da Contini e Berisso.
k) Membrando ciò ch’Amore di Guglielmo Beroardi; per Contini « Più che incerto ogni raggruppamento, anche binario, semmai a carico di V L: che parrebbero mancare di è in 34 (ma non bisognerà leggere morte = mort’è, lezione primitiva?) e 43 (in realtà è solo V ad avere Ma s’ella, poiché L e P identificano il bàglia fi-nale col bailìa di 35, e L ripete l’intero 35, quella ...) » (35).Berisso condivide le conclusioni di Contini, reputan-do i tre testimoni « di fatto, indipendenti tra loro », contro le conclusioni di Catenazzi (36), fornendo una tabella comparativa di « opposizioni » sia di La P vs V sia di V P vs La e contestando le congiunzioni in errore fra V e P vs La (37). Per 34 Contini aveva di fatto già fornito la risposta, mentre apparentemente più duro è ammettere che in 43 l’errore bailia di La P vs bàglia di V, per ripetizione di 35, non congiunga La e P contro V: per Berisso, giustamente, « sarà l’errata individuazione della rima in bàglia (per La P -ia, e dunque bailia) a portare i testimoni opposti a V a individuali aggiustamenti del distico (più disin-volti, e perciò più pericolosi, in La) ». Poiché il caso è importante, complesso e forse utile anche per più generali considerazioni, lo discuto analiticamente. Riporto la lezione dei singoli manoscritti, tentando di interpretarla secondo le intenzioni dei copisti, e facendola precedere dai versi 34-42:
Così la mort’è miaquella che m’à ’n bailia 35che sì dura mi tene.
(35) Contini, Frammenti di filologia romanza cit., p. 231.(36) F. CAtenAZZi, Poeti fiorentini del Duecento, edizione critica
con introduzione e commento, Brescia 1977, p. 216.(37) I poeti della scuola siciliana cit., vol. III, pp. 292-293.
133INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
P V La
43 Ma s’ell’è ke m’à in bailia, Ma˙ss’ella ke m’à im bàlglia, Quella che m’à ’n bailia, 44 in cui sença follia di chui sono sanza fàlglia in cui son tuttavia 45 tucte belleze messe tute belleze messe, tutte bellesse messe, 46 più ke stare in travallia più che stare in travalglia più che star in travagla 47 pur ke sofrir mi vallia, pare che sofrire mi valglia, par che ’l sofrir mi vagla: 48 e Deo, che mi valese! o Deo, che mi valesse! o Deo, che.mmi vallesse!
(La: con s recenziore inserita, fra e e s, in valese)
IV Sì fera non pensai che fusse, né sì dura che la sua altura inver me no scendesse, 40 la spera ch’io amai, La: la bella né che la sua figura in tanta arsura languir mi facesse.
Rispetto a Clpio è proponibile soltanto qualche correzione interpuntiva per V e La, ma per P la lezio-ne è molto diversa, poiché Avalle interviene emendan-do pesantemente la lezione del ms. in: « [...] bàilia, / in cui [son] sença fàllia, / tucte belleçe messe, / par ke soffrir mi vallia. / O Deo, ke mi valesse! », con conseguenze inevitabili, per un lettore incauto (che non ricorra cioè alla tabella finale delle correzioni ap-portate alla lezione dei mss.), nella valutazione della questione e dei rapporti fra i codici relatori.
La e P possono in effetti rappresentare due casi diversi, poligenetici, pur congiungendosi nel risultato finale per quanto riguarda il trattamento del rimante. La – o meglio, il suo antecedente – potrebbe aver ri-petuto per intero il v. 35, modificando di conseguenza il v. seguente (44), anche nel rimante; P condivide invece con V la lezione (corretta) di 43 e innova solo in rima mutando però anch’egli al verso seguente il rimante corretto, fàglia, di V e La, in follia. Il compor-tamento di La e P rispecchierebbe, indipendentemen-
134 R. ANTONELLI
te, una prassi di scambio balìa / bàglia pluriattestata nella tradizione manoscritta (ricordo solo, a parti invertite, Giacomo da Lentini Troppo son dimorato ove V innova con bàglia vs balìa, corretto, di La) e non andrebbe dunque considerato indizio di un comune antecedente.
Ma P e La reagiscono in tal modo soltanto per il cambiamento di rimante in 44, o il cambiamento di rimante è frutto di altre difficoltà? È una questione ancora aperta, legata all’interpretazione di tutti e sei i versi e in particolare al rapporto fra 43 e 48, poiché non è escluso che un errore congiuntivo a tutta la tradizione possa annidarsi proprio in 43. Comunque, anche se si ritiene che l’innovazione di 44 proceda da 43 la conclusione non cambia: 43 dimostra che è poli-genetica. Per quanto riguarda poi eventuali parentele binarie, sembra ancora da considerare l’indicazione di Catenazzi, che riconosce un errore comune fra V e P in 26 (38). Alle argomentazioni di Catenazzi si potrebbe-ro aggiungere le seguenti, per quanto non decisive. La porta anche in 26 sospiri e pianto, con collegamento a coblas capfinidas rigoroso in 23 fra le strofe II e III (la strofa III è quella centrale), su celeberrimo sin-tagma lentiniano, in una canzone intessuta fittamente di richiami al Notaro: la dittologia è attestata in 11 casi sui 19 complessivi di pianti in rima nella lirica duecentesca e copre quasi integralmente le occorren-ze in endiadi di pianti in rima (per di più gli undici casi sono tutti di assidui frequentatori del Notaro, come è appunto il caso di Beroardi). Con pianto in rima, la dittologia è rara, e doglie e pianto nella lirica duecentesca è solo in Rustico di Filippi V 92 Poi che
(38) CAtenAZZi, Poeti fiorentini cit., p. 216: « La parentela VP, suggerita dal costante accordo nella lezione, sembra assicurata dagli errori comuni seguenti: 26 jndolglie e(d)imp. (è coppia non rispondente a quelle di 8 e 23); (...) ».
135INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
guerito sono v. 8, in altro contesto. Meno decisivi gli altri luoghi segnalati da Catenazzi, che appaiono tutti adiafori, salvo maggiori probabilità di lezione buona di La in un paio e di V P in un altro (spera 40, dif-ficilior?). Si tratta peraltro di un tipico caso in cui la soggettività dell’interprete non riuscirà probabilmente mai a creare un consenso diffuso (non dirò unanime): del resto l’intera filologia (neo-)lachmanniana si fonda sempre su quello che i suoi detrattori hanno definito un circolo vizioso, basato inevitabilmente sull’interpre-tazione dell’operatore, con buona pace di Lachmann e del suo « recensere sine interpretatione possumus atque debemus »: l’individuazione critica di una va-riante come errore serve a decidere criticamente delle varianti indifferenti, lo ricordava a suo tempo Contini.
L’archetipo è il punto in cui necessariamente si realizza il massimo dell’intepretazione, posto che dal documentato occorre cercare proprio ciò che non è documentato ma ricostruibile o supponibile, ma è anche il punto in cui occorre attentamente valutare i possibili percorsi della ricezione: da questo punto di vista la pur delicatissima valutazione dei casi di diffrazione, in absentia e in praesentia (secondo la classificazione continiana), appare uno strumento ec-cellente, se usato con prudenza e buon senso. Anche l’individuazione dell’archetipo nella tradizione e nelle relative vicende ecdotiche dei Siciliani (che tuttavia sembravano aver trovato un punto di equilibrio ge-neralmente condiviso), è stata ed è in buona parte dei casi il regno dell’interpretazione e, sembrebbe, di una possibile fertilità della diffrazione, almeno in indagini seriali come questa, pur se in sede lirica sia-mo sostenuti da gabbie strutturali potenti e quindi da regole la cui deroga nei mss. ha talvolta caratteri tali da permettere comportamenti il più vicino possibile all’ “oggettività” operativa.
Cosa ricaviamo da questa nuova disamina dei testi tràditi da tutti e tre i canzonieri più antichi? Che a
136 R. ANTONELLI
stare agli ultimi accertamenti, all’ultima edizione e a qualche considerazione aggiuntiva, ci troveremmo di fronte ad archetipi sicuri o molto probabili in sei casi (a, b, c, e?, f?, h), a un archetipo dubbio in un caso (j, probabile peraltro per l’ultimo editore), alla mancanza di ogni indicazione d’archetipo in quattro casi (d, g, i, k), uno dei quali, k, ancora problema-tico. Saremmo dunque, pur considerando a parte un caso “possibile” inserito fra i dubbi, di fronte ad una conferma e ad un possibile incremento di quanto a suo tempo stabilito da Contini, pur con qualche rime-scolamento interno del “canone” continiano e mal-grado ogni legittima sospettosità metodologica nei confronti dell’istituto “archetipo”. Soprattutto viene confermato che, anche nei casi in cui la tradizione rimanda a seconde fonti utilizzate da un singolo ma-noscritto, è esistito un comune archetipo all’intera tra-dizione “siciliana”. Se infatti per quattro canzoni di Pb(Blasmomi de l’amore di Tiberto Galiziani, A pena pare di Jacopo Mostacci, Amor che lungiamente e Ancor che l’aigua di Guido delle Colonne), non si è riusciti a trovare prova di archetipo, in altri casi della stessa sezione di Pb la certezza sembra invece raggiunta(e in un caso la probabilità è molto forte Contra lo meo volere di Paganino da Serzana): si tratta di Poi no mi val merzede di Giacomo da Lentini, Credeam’essere lasso di Galletto, Sì come ’l pescio di Lunardo del Gual-lacca. Si conferma sia la parentela V-Lb che quella P V2 e, ove raggiunto l’archetipo, la parentela V P vs La (39), nonché la posizione primaziale di quest’ultimo nei confronti del resto della tradizione, già rilevata nei famosi undici casi, e turbata solo in occasioni particolari (in cui è talvolta apparsa la possibilità di contaminazioni, cfr. Meravigliosa-mente). Certo, induce
(39) vs BRunetti, Il libro di Giacomino cit., p. 81, che però pru-dentemente aggiunge « almeno per i testi della Scuola ».
137INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
a qualche sospetto la situazione di Guido delle Co-lonne, ultimo della sezione per i componimenti di certa attribuzione, considerando anche che Poi no mi val merzede, attribuita in Pb a Guido ma di Giacomo, è all’inizio, ottava della sezione. Non c’è dubbio che la posizione di Guido nella tradizione (si ricordi l’ag-giunta in V di Amor che lungiamente, alla fine e certo da altra fonte rispetto alla principale dei Siciliani in V)è del tutto particolare, come ricordava già Contini, che sottolineava in conclusione la possibilità che le canzoni di Guido « nella tradizione comune stessero in coda, fuori dell’ordine competente » (40). Il caso Guido va osservato con attenzione, pur se non costituisce prova di una tradizione estravagante, così come va osservata con attenzione, a cominciare da Guido delle Colonne e da Re Enzo, la diffrazione nella lunghezza delle canzoni, ma per motivi diversi da quelli avanzati dalla Brunetti, fondati sugli spazi bianchi.
Anche il caso più straordinario della tradizione siciliana, S’eo trovasse pietanza, propone un archetipo “probabile” secondo tutti gli editori, in mezzo a tanti problemi ancora aperti: mi riferisco, per esempio, alla posizione abnorme di La, derivato dalla stessa fonte di P e V2, distinta da quella, o quelle, di V e Ch (indizio da sommare forse a quanto rilevato per Meravigliosa-mente). Sono problemi che denunciano certo una si-tuazione eccezionale, ma confermano comunque che nelle antologie manoscritte ogni componimento ri-chiede un’analisi esclusiva. Mi limiterò in questa sede a sottolineare che S’eo trovasse presenta per tutti gli editori, da Monteverdi a Contini a Calenda, la forte « plausibilità di un archetipo » e quindi confermerebbe la derivazione di tutti i codici della tradizione “to-scana” da un unico antenato, mentre le due ultime strofe “siciliane” riportate in Bb si segnalano per una
(40) Contini, Frammenti di filologia romanza cit., pp. 224-225.
138 R. ANTONELLI
sostanziale vicinanza alla tradizione toscana (due sole varianti, indifferenti e di evenienza del tutto normale nella trasmissione dei testi duecenteschi: pir vs prova– la probabile genesi di prova da pir segnala forse un errore comune al resto della tradizione – pirò vs onde, plui chi vs e non). In definitiva, e in fine, è da sotto-lineare piuttosto la quantità di casi, percentualmente parlando, in cui nella tradizione italiana è indivi-duabile con certezza o buona probabilità l’archetipo, piuttosto che l’evenienza contraria.
Il problema della tradizione federiciana e della sua possibile complessità, non si esaurisce naturalmente nell’individuazione dell’archetipo, come ha ben visto anche G. Brunetti, e noi siamo stati appena poc’anzi costretti a introdurre nel discorso anche alcuni casi, di Guido delle Colonne, in cui i mss. relatori non con-templavano La ma soltanto P V e affini. Per delineare il quadro complessivo della tradizione occorre dunque considerare anche i casi della tradizione in cui non siano presenti tutti e tre insieme i codici più antichi. È infatti evidente che un quadro complessivo unificato non dovrebbe comportare eccessivi scarrocciamenti nella collocazione reciproca dei singoli codici, una volta che se ne sia accertata la posizione.
Per le parentele “binarie”, negli stessi undici esemplari ove è possibile il confronto fra tre testi-moni, abbiamo nell’ultima edizione della Scuola sici-liana un’evidente congiunzione V P, e eventuali affini(per V: Mm; per P: Gt, V2, Ba1, Bo, con il vicinissimo Ch e suoi affini: Ba3, Magl e Vall) (41), vs La nelle tre canzoni di Giacomo da Lentini (a, b, c), in g (Re Enzo,Amor mi fa sovente), i (Tiberto Galliziani, Blasmomi de l’Amore), forse in f (Mazzeo Ricco), j (Tiberto Galli-ziani, Già lungiamente) secondo il sottoscritto (ma non
(41) Sono le sigle impiegate nell’ultima edizione completa dei Siciliani, I poeti della scuola siciliana cit., vol. I, p. lxxix ss.
139INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
secondo l’ultimo editore). Alla stessa congiunzione abbiamo tentato di ricondurre in questa sede anche il caso per Contini abnorme di Paganino da Serzana, Contra lo meo volere.
Per Contini la situazione era sostanzialmente iden-tica, salvo a prevedere in due casi la congiunzione V La e P La:
Quanto ai raggruppamenti binari, l’ascendenza comune di V P, a noi ben nota anche in assenza di terzo testi-mone, è certa in due casi (g, i), a cui perciò aggiun-geremo i [Blasmomi de l’amore] (che altrimenti andrebbe ad altrettanto sicuro carico di V L), almeno possibile in un quarto (a, ove non fosse rinviabile all’archetipo); quella di V L è certa in un caso (b, vedi qui sopra per j), probabile in un altro (e), non più che possibile in un terzo (k); quella di P L è certa in un caso (h, più il sonetto), probabile in un altro (c). Per ognuno di questi canzonieri (e non è escluso che sia vero per tutti) è dunque ammissibile dualità, se non pluralità, di esemplari, ma ciò vale indispensabilmente per uno almeno di essi: e per uno proprio, P [= Pb di Brunetti], la cosa era già provabile su fondamenti esterni, benché non nell’ambito siciliano (42).
In nessuno di questi appare però sicura la devian-za dalla coppia V P, mentre in alcune quest’ultima risulta certamente apparentata: in particolare, rispet-to alle conclusioni di Contini, sembra dimostrato il contrario per j e per e, mentre per b la situazione è realmente complessa, ma molto probabilmente si deve partire da una primazia di La vs gli altri mss., turbata però nell’occasione da accidenti esterni (come denuncia già la posizione abnorme della canzonetta nella serie dei componimenti lentiniani: in coda e non dopo Madonna, dir vo voglio come in V) (43).
(42) Contini, Frammenti di filologia romanza cit., p. 233.(43) I poeti della scuola siciliana cit., vol. I, pp. 40-46, in part. 44.
140 R. ANTONELLI
Ma cosa aveva evinto Contini anche dal confronto fra i testi relati da due soli manoscritti “antichi” per volta e cosa risulta dall’edizione mondadoriana dei Poeti della scuola siciliana? Nelle tredici canzoni di cui erano relatori i soli V e Pa o suo affine, Contini individuava l’antecedente (preferirei così e non “ar-chetipo”, visti i risultati dell’analisi della tradizione a tre testimoni, che rimandano ad un quadro più ampio e solidale in cui i singoli antecedenti si configurano semmai come subarchetipi), individuava l’antecedente in otto casi (44), cui vanno aggiunti i 5 casi su sette in cui accanto a Pa (e eventualmente affini) figura V con l’affine Lb (45). Complessivamente 18 vs 7, pur se sui sette occorrerà tornare in altra sede per esaminarne finalmente tipologia e collocazione.
La recente edizione dei Siciliani, per le stesse canzoni esaminate da Contini, offre questo quadro complessivo:
conferma in tutti i casi della stretta affinità V Lb, fin a livelli di organizzazione grafica, con rare difformità attributive, su cui occorrerà forse rimeditare non in ordine alla soluzione dei singoli problemi (su cui già Contini in Questioni attributive nell’ambito della lirica siciliana), ma per la fisionomia del comune ante-cedente; conferma, in tutti i casi di testimonianza trina (La V P), si è visto, della parentela V P (del tutto particolare il caso di Re Enzo S’eo trovasse, dove rimane non per nulla ancora aperto il proble-ma attributivo, forse davvero da risolvere, del tutto eccezionalmente, con l’ipotesi di rimaneggiamento o collaborazione); conferma della discendenza da un comune antecedente per V P (e Ch) in tutti i casi ove sia possibile individuare errori comuni.
(44) Contini, Frammenti di filologia romanza cit., p. 225 n. 34.(45) Ibid., p. 218 n. 21.
141INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
Rimangono fuori dall’individuazione di errori i seguenti casi (ma sarà da riflettere su Amando lun-giamente v. 3 e Madonna mia, a voi mando con La vs Pa con notevoli varianti), oltre a quelli già segnalati da Contini, fra cui particolare attenzione meritano Rinaldo d’Aquino Venuto m’è in talento, per la doppia versione dei vv. 15-70, non riconducibile comunque a varianti d’autore, secondo quanto conferma Comes (46), e Gioiosamente canto di Guido delle Colonne: rimessa in discussione da parte di G. Macciocca dell’archetipo (/ antecedente) di Uno piagente sguardo, non del tutto convincente, ma legittima (poligenesi di dispera per disispera con conseguente ipometria comune) e di Amando con fin core (è per este poligenetico, definito – vs il precedente editore – incerto). Per Umile core Fratta non si esprime rispetto a Contini Questioni attri-butive (47), mentre non ne condivide le conclusioni per Di sì fina ragione (48): si può concordare in due casi su cinque, ma non per si possa vs possa e soprattutto 53 ch’io la gioia avesse V vs keo lasso avesse, ove l’argomen-to continiano sembra tuttora valido. Contesta l’ascen-denza ad un comune antecedente V P di Per la dolce cera piasente, postulata da Contini, anche G. Brunetti, ma l’ipometria di 23 comune a V P Ch sembra signifi-cativa, anche in comparazione con altri casi analoghi. A « varianti redazionali » attestate in Ch rispetto a V, e non a collaborazione fra Percivalle e Semprebene, pensa invece Calenda per Come lo giorno: la questione sul piano della critica interna è aperta ed è risolubile soltanto sul piano più generale dei rapporti V Ch e sulla plausibilità specifica di una “collaborazione” o di un rifacimento: di rifacimenti abbiamo peraltro altri significativi esempi coevi.
(46) I poeti della scuola siciliana cit., vol. II, pp. 139-141.(47) Contini, Frammenti di filologia romanza cit., p. 218 n. 21.(48) I poeti della scuola siciliana cit., vol. II, p. 419.
142 R. ANTONELLI
Il quadro complessivo risultante dalle indagini specifiche per ogni singola canzone, conferma dun-que la non-plausibilità – rispetto ai dati attualmente disponibili – di due archetipi distinti, « che peraltro – notava Contini – sarebbero presumibili solo quando quegli errori comuni non esistessero mai, e la cui di-mostrazione non è di conseguenza perentoria in casi singoli, poiché ivi l’assenza di errori potrebb’essere casuale » (49). Sarà forse un circolo vizioso e comunque pericoloso, ma sarà al contempo difficile non pensare, a questo punto, anche nei casi in cui l’archetipo non è dimostrato o è dubbio, all’apparentamento V P e a quante maggiori probabilità ha un’organizzazione stemmatica orientata come quella dimostrabile nelle altre canzoni, piuttosto che a singole devianze non razionalizzabili, fermo restando che ovviamente, nella costituzione del testo, è la singola situazione quella che va rispecchiata e su cui occorre orientarsi, poiché nelle antologie ogni componimento, lo sappiamo e si è visto, fa storia a sé (50).
Dovremo quindi concludere che tutto è pacifico e che l’archetipo comune a “tutta o quasi tutta” la tradi-zione dei Siciliani rimane confermato, senza necessità di approfondimenti? No, rimangono valide alcune suggestioni della Brunetti, da approfondire ancora (presenza e ruolo di canzonieri o raccolte individuali – come in Giacomo, sempre più verosimilmente – e antologiche perdute, eventuali rotoli per singoli casi, come in Isplendiente, modalità di formazione dell’archetipo toscano – ovvero pisano), e rimangono indubbiamente alcuni dubbi e alcune questioni pure da approfondire. In particolare sarà da riesaminare ancora P iuxta propria principia: è da rivedere, sia per
(49) Contini, Frammenti di filologia romanza cit., p. 226.(50) Come ripeteva Contini, ibid., p. 233.
143INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
le versioni brevi indubbiamente abbondanti (in taluni casi già dell’antecedente e comunque non solo di P),sia – e solidalmente? – per i caratteri codicologici specifici del ms. e della sua destinazione, sia per la presenza di numerosi casi in cui Pa (anche in presenza di possibile archetipo?) si distacca decisa-mente, con varianti specifiche, fino a vere doppie redazioni, da V. Una spiegazione il caso ancora la esige. P è stato infatti generalmente studiato in relazione a V e a problemi stemmatici, appunto di filologia formale, per risolvere problemi particolari (le dubbie attribuzioni, con Contini, ad esempio), salvo alcune suggestioni di Contini e Brunetti, la quale giustamente invitava ad analizzare quale fosse la ricezione “canonica”, o forse meglio “storico-culturale”, dei Siciliani presso i Toscani: discorso importante, ma ancora tutto da approfondire. Stesso discorso per il negletto, per i Siciliani, Chigiano L. VIII. 305, si vedano i casi S’eo trovasse e Come lo giorno, entrambi di Re Enzo, che testimoniano una qualche connessione bolognese; e si ricordi che Ch è anche relatore, con V, di parte della tenzone fraGiacomo da Lentini e l’Abate di Tivoli (notissima già ai contemporanei) e che le canzoni di Guinizzelli sono tutte nei tre codici duecenteschi, tranne Tegno de folle ’mpres’, a lo ver dire, del solo Ch. Ch intervie-ne anche in altre occasioni a correggere « la lezione erronea del suo raggruppamento » (51), ovvero P V2 e affini, in significativa autonomia, da collegare pro-prio a quanto rilevato per S’eo trovasse pietanza, senza peraltro dimenticare l’ipotesi continiana, verisimile almeno per un gruppo di canzoni, secondo cui l’an-tecedente di Ch per i Siciliani sarebbe stato ordinato alfabeticamente, come P. E del resto a V, solitamente
(51) Poeti del Duecento cit., vol. II, p. 894.
144 R. ANTONELLI
dipendente dallo stesso subarchetipo di P Ch, ci por-ta di nuovo l’unico caso comparabile dei Memoriali (siamo di nuovo a Bologna!), il già citato Madonna, dir vo voglio, trascritto in Mm da fonte scritta (è bene sottolinearlo) affine appunto a V.
Rimarrebbe il problema dei rapporti fra tradizio-ne “veneta” (B, ovvero il Barberiniano latino 3953: non analizziamo il caso del frammento zurighese del tutto eccezionale) (52) e toscana, risolto da Mario Pagano in favore di un antecedente comune anche per Assai mi placeria di Stefano Protonotaro, con Contini e vs Debenedetti (53), conclusione accettabile e confermata anche dalla tradizione di Guinizzelli (54).
Risulta anche confermata la posizione alta nello stemma del Laurenziano rediano 9, sezione pisana, e la probabile origine pisana dell’archetipo comune a La, V, P: un archetipo composto di Siciliani e di alcuni Siculo-toscani, posto che di un manoscritto di Siciliani soli non v’è ancora alcuna traccia, mentre per contro la sezione “siciliana” di P e di La chia-risce bene quale fosse il quadro storico-culturale dei primi canzonieri toscani. Anzi, occorrerà aggiungere, che nella coscienza storico-culturale toscana più anti-ca – quella rappresentata in La e P, poi organizzata in senso storico-geografico e gerarchico da V, con
(52) Non affronto neppure la questione del sonetto lentiniano tràdito anche da B, così come tralascio le problematiche relative ai sonetti, poiché la tradizione dei sonetti appare più complessa e “materialmente” forse diversa da quella delle canzoni (se non altro, per l’abbondanza estrema di tenzoni certe), pur se sembra manifestarsi sostanzialmente solidale con l’altra, almeno fin dove controllabile.
(53) I poeti della scuola siciliana cit., vol. II, pp. 338-339.(54) La dimostrazione in D’A. s. AvAlle, La tradizione mano-
scritta di Guido Guinizzelli, in « Studi di filologia italiana », 11 (1953), pp. 137-162, ora in iD., La doppia verità. Fenomenologia ecdotica e lingua letteraria nel Medioevo romanzo, Firenze 2002, pp. 53-75.
145INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
qualche maggiore distacco storico, per prospettiva e articolazione, ma non in modo divergente – nella coscienza storico-culturale prestilnovistica, Siciliani veri e propri e primi seguaci toscani non sono di-sgiungibili (come notoriamente dichiara Dante nel De vulgari eloquentia), fino a comprendere al proprio interno, in La e P, Guinizzelli e Bonagiunta (col Guittone cortese in posizione magari antinomica ma sostanzialmente interna in V, del tutto autonoma in La e P, organizzati in ambienti guittoniani). Il che dovrebbe indurre a qualche ulteriore riflessione anche in ordine ai rapporti reali fra Guinizzelli, Bonagiunta e i Siciliani e, forse, al problema della ballata. Ma so-prattutto deve indurre ad esaminare unitariamente la situazione stemmatica di Guinizzelli e Bonagiunta con le risultanze stemmatiche relative alla Scuola siciliana ricavate dalla precedente analisi comparativa fra le Questioni attributive continiane e quelle della più recen-te edizione dei Poeti della scuola siciliana. L’archetipo toscano sotteso a tutta la tradizione toscana (e anche veneta, verosimilmente) comprendeva infatti con ogni evidenza già Guinizzelli e Bonagiunta, e la dimostra-zione di archetipi e affinità accertabili in questi ultimi sarà quindi utilizzabile a riscontro di quanto osservato per la tradizione dei Siciliani e Siculo-toscani.
Di « privilegiata posizione periferica entro l’albero di L [= La] rispetto a V P (e Ch), quale è dimostrabile per le canzoni di Guittone e del Guinizzelli » parlava sempre Contini (55), precisando però che andava « rin-tracciata volta per volta ». È quanto ha fatto a suo tempo D’A. S. Avalle (56) e ha confermato sostanzial-mente lo stesso Contini nella Nota ai testi dei Poeti del Duecento. L’archetipo comune a La V e P è dimostrato
(55) Contini, Frammenti di filologia romanza cit., p. 233.(56) AvAlle, La tradizione manoscritta di Guido Guinizzelli cit.,
pp. 56-68.
146 R. ANTONELLI
per tutte le canzoni tramandate dai tre codici duecen-teschi (II Madonna, il fino amor; III Donna, l’amor mi sforza; IV Al cor gentil; V Lo fin pregi’avanzato).
È molto significativa e importante ai fini del no-stro discorso la posizione nello stemma delle canzoni di Guinizzelli, finora non associata fino in fondo ai testi della Scuola siciliana, per inveterate abitudini classificatorie di tipo scolastico, ma a torto, poiché dal punto di vista ecdotico è solidale con altri Siculo-toscani di pertinenza della Scuola (Paganino da Ser-zana) o ad essa molto vicini (i già analizzati Tiberto Galliziani e Guglielmo Beroardi per la tradizione a tre testimoni), mentre dal punto di vista poetico-culturale appare integralmente inserita nel dibattito toscano ed emiliano precedente lo Stil novo. L’archetipo cui risale la tradizione dei Siciliani, giusta La, conteneva oltre ai testi di Giacomo da Lentini, almeno quattro canzoni di Guido, a conferma ed estensione di quanto ipotizzato da Contini per i Siculo-toscani, e dunque la dimostrazione dell’esistenza di un archetipo per Guido, proposta da Avalle, più facile da acclarare probabilmente per le minori traversie e adattamenti testuali, si riflette anche sui Siciliani veri e propri (57): tanto più che in La a Guinizzelli e alle sue quattro canzoni, seguite da due rimatori pisani, Galletto Pi-sano e Lunardo del Guallacca, e poi dalla serie dei Siciliani aperta da Giacomo da Lentini, nello stesso ordine di V (ma con più modesta selezione), viene riservata l’apertura del X quaderno del Laurenziano rediano 9, ovvero della sezione antologica immediata-mente seguente ai nove fascicoli dedicati a Guittone. Guinizzelli, dunque, come patrono e coonestatore
(57) Significativo che anche nel caso di Bonagiunta, come è desumibile ora dall’edizione Menichetti, si ripresenti la stessa situa-zione per tutte le canzoni (Bonagiunta Orbicciani da Lucca, Rime, ed. crit. e commento a c. di A. meniChetti, Firenze 2012).
147INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
della tradizione siciliana in Toscana (« padre », avrebbe detto Dante), in partibus infidelium, ovvero nell’am-biente guittoniano di La. Anche Bonagiunta è parte rilevante del X quaderno, con tre canzoni, e seguito da tre rimatori nativi della Toscana (Betto Mettifuoco, Tiberto Galliziani e, a inizio del successivo fascicolo XI, Paganino da Serzana): canone storiografico e storia della tradizione andranno d’ora in poi ricon-siderati unitariamente, per evidente solidarietà, al di là delle partizioni passate in giudicato.
Proprio una delle canzoni del “canone” toscano di Guinizzelli, Donna, l’amor mi sforza, una delle più “lentiniane”, ci pone ancora una volta il problema del rapporto fra originale e testo tràdito, anche per quanto riguarda la veste formale e per la sua in-fluenza sulla ricezione dei Siciliani in Toscana e sul relativo dibattito. Ancora una volta la lezione di La è eccellente, al di là pur di quel che pensava Contini, e vicinissima all’archetipo, dimostrato dall’ipometro contrarie s’accoglie, per aplografia, vs il settenario con-trar’are dell’archetipo e dell’originale:
Madonna, audivi dire 25che ’nn-are nasce un focoper rincontrar dei venti;se non more ’n venirein nuviloso loco,arde immantenenti 30ciò che dimora loco:così le nostre vogliecontrar’ [ar]e s’accoglie,unde mi nasce un focolo qual s’astingue un poco 35i˙llacrime e in doglie.
In Guinizzelli all’origine dell’errore è evidente-mente, nell’originale, il sintagma contrar’are, mentre l’archetipo, con tutti i manoscritti derivati, doveva avere contrare, come in V: la lezione contrar’are del
148 R. ANTONELLI
resto è ulteriormente dimostrata da are di P al v. 26 (contro gli altri aire, anche in rima) e dal v. 48 ove in rima con fare : portare di 44-45 è aire, certamente non originale. Che fare in un caso del genere? È lecito oltrepassare l’archetipo e risalire all’originale? La si-tuazione è simile a quella che si presenta almeno per Madonna, dir vo voglio v. 9 (mor’e viv’eo / moru e viv’eo oppure mor’u viv’eo?) e per Ben m’è venuto v. 40 (chi sofr’acompl’e vince ogni tardanza o chi sofr’aconpie e vince ogni t.?). Nei due casi siciliani si tratta di lezioni sostanziali, non formali, diversamente dal caso delle rime “siciliane”, che non si restaurano, in quanto at-tinenti in buona parte – ma non in tutto – al livello formale: almeno nelle edizioni a stampa, a differenza di quanto si potrà fare magari nel caso di edizioni “virtuali”. Le lezioni corrette vanno dunque a mio parere inserite: dimostrano inoltre l’archetipo e dun-que un’unità di tradizione, pur se interessano soltanto un frammento testuale opposto a tutto il resto, ove non è lecito trascendere l’archetipo toscano. Analogo ma diverso, per ragioni storico-culturali, il caso di Guinizzelli, posto che mentre la rima siciliana si con-serva anche per fondamentali ragioni storico-culturali, essendo all’origine del tipo rimico “italiano”, la forma aire al v. 48 e altrove, anche all’interno di verso, è riflesso di un intervento normalizzatore (tradìto da P 26 e da V 33) e dunque deve essere corretta nei due casi, all’interno e all’esterno della rima, in quan-to oggettivamente documentata. Per la veste formale dei Siciliani prevale invece, da Tallgren, Monteverdi e Contini in poi, la forza della ricezione su quella della ricostruzione della volontà autoriale, per di più in molti casi molto incerta.
Per un’altra canzone famosa, Amor tanto altamente di Guittone, la problematica è alquanto diversa ma va sempre a toccare, come nei criteri di rappresen-tazione dell’originale, oltre l’archetipo, il rapporto fra interpretazione, volontà dell’autore e ricezione. Della
149INTERPRETAZIONE, RICEZIONE E AUTORE
canzone il Vaticano 3793 ci offre una versione in cin-que strofe più due tornate; il canzoniere Laurenzia-no rediano 9 una versione in quattro strofe più una tornata ricavata dai piedi della quinta strofa di V. Il copista del canzoniere laurenziano era perfettamente consapevole che mancava qualcosa, tanto che lascia uno spazio vuoto per inserire una quinta strofa, ma ritiene appunto che la lacuna non sia dopo gli ultimi versi di cui dispone, bensì immediatamente prima e costringe i versi rimanenti al ruolo di tornata, segnandone anche il ruolo a margine, con la solita R tagliata (58).
Per noi quella canzone, dal 1977 in poi, si è rive-lata una miniera di notizie sui rapporti fra Guittone e Giacomo da Lentini, sull’ideologia e il progetto guittoniano e sui rapporti con altri rimatori coevi (in primis Mazzeo Ricco, destinatario della secon-da tornata) (59). È dunque una canzone importante. E certo deve esser apparsa tale ai contemporanei: almeno a un altro rimatore, per noi anonimo (lo stesso Mazzeo?), anch’egli frequentatore dello stesso elaboratissimo schema metrico delle altre due e cor-rispondente in tenzone. Chi avesse letto però La, e la sua fonte, di una gran parte del discorso intertestuale non avrebbe appreso nulla: o meglio, avrebbe potuto comprendere parte della portata del discorso ideolo-gico, ma gli sarebbe sfuggito il resto, ben condensato nella II tornata.
In questo caso è possibile affermare con certezza che la versione di La è una riduzione della tradizione di V e non una prima versione autoriale (caso ben
(58) Cfr. R. Antonelli, Ri-pensamento guittoniano?, in Filologia aperta, ovvero per amicizia, scritti offerti a Fabrizio Beggiato, a c. di s. mARinetti, Perugia 2009, pp. 1-12.
(59) R. Antonelli, Rima equivoca e tradizione rimica nella poesia di Giacomo da Lentini, I. Le canzoni, in « Bollettino » del Centro di Studi filologici e linguistici siciliani, 13 (1977), 20-126.
150 R. ANTONELLI
ipotizzabile in caso di presenza/assenza di tornate) e dunque non risale alla volontà dell’autore, ma ciò ci esime dal ragionare su La, a cominciare dall’im-paginazione e dalla coscienza dell’ordinatore/copista? Certamente no, e non solo perché solo grazie alla “filologia materiale”, ovvero alla considerazione co-dicologica attenta di La, possiamo dirimere la storia interna di Amor tanto altamente, ma anche perché il nostro caso ci può aiutare forse a capire meglio la situazione della tradizione guittoniana e perché co-munque La e i suoi derivati sono stati letti e hanno dato a loro volta origine a una tradizione.
Tutte cose che sappiamo ma che forse è sempre bene ripetere proprio nel momento in cui abbiamo tentato di riprendere il filo di una sempre ineludibile e più che mai necessaria filologia formale: filologia materiale e filologia formale si sostengono a vicenda, l’una senza l’altra è condannata alla parzialità e tal-volta alla cecità.
RoBeRto Antonelli