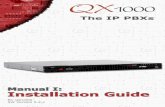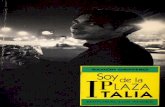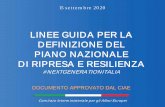Spazi per vendere e spazi per abitare: i casi di Anversa, Londra e Siviglia
Agenzie italia + Londra
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Agenzie italia + Londra
LE AGENZIE DI MOBILITÀ:ASSETTO E PROCESSI ORGANIZZATIVIAgenzie di gestione, agenzie esecutive e agenzie di supporto
nei sistemi di trasporto pubblico locale
Marcello Martinez
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
direttoreCarlo Mario Guercidirezione di redazioneEnrico Chiesa (Direttore Responsabile)Riccardo MercurioBarbara MarinoMariella La Monica
segreteria amministrazioneCesit - Centro Studi e RicercheSistemi di Trasporto CollettivoNapoli via Carducci, 37tel 081/408102fax 081/409496progetto grafico e impaginazioneAnnalisa Camerlingo
PRESENTAZIONE 5di Carlo Mario Guerci
PREFAZIONE 9di Ennio Cascetta
LA COMPETIZIONE NEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALE 13di Riccardo Mercurio
L’ORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE PER LA MOBILITÀ IN EUROPA E IN ITALIA 19di Marcello MartinezLa separazione fra livello politico, tecnico e operativo nei sistemidecisionali per il trasporto pubblico locale e regionale p. 19, Leagenzie per la mobilità previste dalle legislazioni regionali inItalia p. 26, Le agenzie operative in Italia p. 34, Il confronto fra leagenzie per il trasporto e la mobilità p. 35
L’ORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE PER LA MOBILITÀ IN EMILIA ROMAGNA 39di Marcello MartinezIl sistema di mobilità in Emilia Romagna p. 39, Le imprese di tra-sporto e di gestione dell’infrastruttura p. 40, Il sistema di tariffa-zione integrata STIMER, di Gianluigi Mangia p. 41, L’agenziaRegionale Trasporti Pubblici p. 44, Il Consorzio ATR di Forlì eCesena p. 49, Il Consorzio TRAM di Rimini p. 52, Altre agenzie inEmilia Romagna p. 55
L’ORGANIZZAZIONE DI STA-ATAC SPA A ROMA 59di Marcello MartinezIl sistema di mobilità nel Lazio p. 59, Il sistema di TariffazioneIntegrata Metrobus, di Gianluigi Mangia p. 59, Il sistema di mobilitàa Roma p. 62, L’organizzazione e le funzioni di STA p. 63, L’orga-nizzazione e le funzioni di ATAC p. 65
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA MILANESE MOBILITÀ E AMBIENTE SRL 69di Marcello MartinezIl sistema di mobilità della Lombardia p. 69, Il sistema di mobilitàdi Milano p. 70, Il sistema di Tariffazione Integrata SITAM, diGianluigi Mangia p. 72, L’Agenzia Milanese Mobilità e AmbienteS.r.l. p. 74
INDICEQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
3
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA PER LA MOBILITÀ A LONDRA 81di Ernesto De NitoIl sistema mobilità nell’area metropolitana di Londra p. 81, L’a-genzia di Londra: Transport for London p. 82, Il sistema di tariffa-zione Integrata a Londra, di Gianluigi Mangia p. 87
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA PER LA MOBILITÀ A PARIGI 89di Paolo CanonicoIl sistema di mobilità della regione Ile de France p. 89, L’Agenziadi Parigi: Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF) p. 91, Ilsistema di tariffazione Integrata a Parigi, di Gianluigi Mangia p. 97
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA PER LA MOBILITÀ A LIONE 101di Paolo CanonicoIl sistema di mobilità di Lione p. 101, L’Agenzia di Lione: Syndicatdes Transport pour le Rhône et l’Agglomeration Lyonnaise p. 103
TRE MODELLI DI AGENZIA: AGENZIE DI GESTIONE, ESECUTIVE E DI SUPPORTO 109di Marcello Martinez
NOTE 119
BIBLIOGRAFIA 121
Indice
4
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
Il settore del trasporto locale in Italia impegna circa 1.230 impresea livello nazionale, di cui circa 150 a controllo pubblico, conta circa130.000 addetti e recenti stime lo valutano pari a 8.100 milioni di euro. Iprincipali problemi del comparto sono noti: costi eccessivi, limitataattenzione alla qualità erogata e percepita, forte condizionamento politi-co sulle scelte gestionali delle imprese.
Il decentramento delle funzioni di amministrazione e programmazio-ne dei servizi e degli investimenti dallo Stato alle Regioni, il trasferimentodella proprietà delle imprese e delle reti ferroviarie locali alle Regioni el’obbligo di introdurre meccanismi di affidamento concorsuale dei serviziferroviari e autofilotranviari dal 2004 sono misure potenzialmente in gradodi attivare processi virtuosi di cambiamento e innovazione.
Contrariamente a quanto accaduto per i servizi ferroviari di inte-resse nazionale, in Italia, la riforma dei servizi di trasporto pubblicolocale è stata avviata in maniera forse più rapida e veloce che non inaltri paesi membri dell’Unione, quali ad esempio Germania e Francia,peraltro senza una esplicita direttiva comunitaria che imponesse regolee modelli. Gli stessi interventi del legislatore nazionale spesso rimanda-no, e non potrebbe essere altrimenti, le scelte operative alle amministra-zioni regionali, provinciali e comunali. Occorre tuttavia evidenziare chenon sempre quest’ultime sono dotate delle capacità e competenze tecni-che necessarie a conciliare le diverse esigenze o del sufficiente poterecontrattuale atto a contrastare i molteplici interessi in gioco. Il rischio diun falso liberismo, fondato sulla tutela delle posizioni delle impreseincumbent, sulla presenza di invisibili economie di entrata e di uscita èsicuramente molto elevato.
Come accaduto in altri paesi europei, anche in Italia l’introduzionedi meccanismi di concorrenza per il mercato richiede l’attivazione diprocessi di innovazione istituzionale: la costituzione di agenzie per lamobilità in grado di fornire servizi tecnici agli enti locali e di proporsicome un terzo livello fra i soggetti politici e le imprese può rappresenta-re una soluzione a tali difficoltà.
di CARLO MARIO GUERCI, presidente del Cesit
PRESENTAZIONEQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
5
Lo studio realizzato dal Cesit per conto della Regione Campania siè posto dunque l’obiettivo di confrontare, laddove previste e/o istituite,le agenzie per il trasporto e la mobilità che le Regioni o gli enti localihanno definito per agevolare il processo di introduzione della concor-renza per il mercato nei sistemi di trasporto locale di loro competenza.
Il lavoro, diretto dal prof. Riccardo Mercurio, Direttore scientificodel Cesit, e coordinato dal prof. Marcello Martinez, della Seconda Uni-versità degli Studi di Napoli con la collaborazione del dr. Paolo Canoni-co, del dr. Ernesto De Nito e del dr. Gianluigi Mangia dell’Università diNapoli Federico II ha evidenziato che, anche se ancora limitate nelnumero, già le agenzie presenti in Italia appaiono estremamente diffe-renziate in termini di ruolo, area di competenza, organico e risorse, for-ma giuridica. Alcune agenzie sono tipicamente “agenzie di gestione”,responsabili delle infrastrutture e dei veicoli necessari all’erogazione delservizio, altre invece sono “agenzie esecutive”, organizzazioni cui leRegioni e/o gli enti hanno affidato la responsabilità di alcuni processiamministrativi e contrattuali, altre infine sono “agenzie di supporto”, e sioccupano di assistere le Regioni e gli enti locali nello svolgimento deiprincipali processi di regolazione, di pianificazione, di amministrazione,di affidamento degli investimenti, delle reti, dei servizi.
Ogni agenzia risulta essere il risultato specifico di una precisascelta di policy making relativa al modo di amministrare il trasportolocale: i processi che ne hanno sostenuto ed indirizzato la costituzionesono la diretta espressione del contesto politico, sociale, ed economicoche ha contraddistinto negli anni il sistema di trasporto pubblico dellediverse regioni, province e comuni italiani. Lo stesso assetto delleimprese di trasporto, la loro dimensione e rilevanza o i loro problemieconomici, finanziari ed occupazionali hanno più o meno esplicitamen-te condizionato la ricerca del modello di agenzia che infine si è adotta-to. Inoltre, non bisogna dimenticare che la stessa presenza o assenza dicompetenze e conoscenze in tema di sistemi di trasporto all’interno del-le amministrazioni regionali e locali ha influito sul modello prescelto.
Data la elevata contestualità dei diversi modelli, la loro valutazio-ne comparativa non può condurre ad una ricerca della soluzione miglio-re: ogni agenzia ha compiti e funzioni diverse che rendono difficile ladefinizione di indicatori omogenei di performance il cui raggiungimentosia di autonoma competenza dell’agenzia stessa. Il risultato di una com-parazione fra le agenzie può invece rappresentare una utile “mappa” cuipossono fare riferimento sia i policy maker delle Regioni e degli altrienti locali impegnati nella scelta del modello di agenzia da adottare o
Presentazione
6
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
7
che stanno valutando l’opportunità o la convenienza di una soluzione;sia gli amministratori delle imprese di trasporto pubblico chiamate a sti-pulare contratti e accordi per l’erogazione dei servizi; sia gli amministra-tori delle altre imprese della filiera del trasporto che ormai devono inte-ragire con centri decisionali regionali e locali cui sono affidate leresponsabilità in tema di investimenti in infrastrutture e veicoli.
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
La riforma del trasporto locale e regionale indotta dai D.L. 422 del1997 e 400 del 1999 ha esercitato importanti e rilevanti effetti sulleamministrazioni regionali e locali e anche sulle imprese di trasporto inItalia. Le diverse Regioni hanno definito modelli spesso diversi per intro-durre la concorrenza fra operatori e per attivare processi di cambiamen-to nelle procedure, nelle strutture e nelle competenze delle amministra-zioni impegnate nell’attuazione della riforma.
La Regione Campania è stata l’ultima Regione a statuto ordinarioad emanare una legge di riforma: nel marzo del 2002 il Consiglio regio-nale ha approvato il disegno di legge proposto dalla Giunta, risultato diun articolato e ricco processo di confronto e integrazione da parte ditutti i soggetti coinvolti: partiti politici, enti locali, associazioni imprendi-toriali, associazioni sindacali, rappresentanti dei consumatori e dellediverse categorie sociali.
La legge della Regione Campania infatti ha voluto introdurre prin-cipi di regolazione e meccanismi operativi di funzionamento del sistemadi trasporto regionale per conciliare le esigenze dei diversi soggetti isti-tuzionali e sociali: i cittadini che richiedono servizi di trasporto qualitati-vamente e quantitativamente migliori; la Regione chiamata ad attuare lariforma e responsabile del finanziamento del sistema; gli enti locali (Pro-vince e Comuni) responsabili della qualità e quantità di servizi di tra-sporto e spesso proprietari delle aziende di trasporto pubblico; le 9aziende pubbliche stesse, impegnate già da tempo in difficili interventidi riorganizzazione e recupero di efficienza; le 123 imprese private chehanno investito e scommesso sul settore; i sindacati impegnati nellatutela dell’occupazione e nello sviluppo professionale dei lavoratori.
Le principali finalità della legge sono migliorare la qualità e laquantità dei servizi di trasporto offerti con tutte le modalità nella regio-ne, favorire l’accessibilità e la mobilità di passeggeri e merci, sostenerelo sviluppo economico, e ridurre la congestione e l’inquinamentoambientale.
In coerenza alle indicazioni della normativa nazionale, la legge
PREFAZIONEdi ENNIO CASCETTA, professore di Ingegneria dei trasporti, Università degli Studi di Napoli Federico II • Assessore aiTrasporti e Viabilità, Porti e Aeroporti, Demanio Marittimo della Regione Campania
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
9
Prefazione
10
della Campania intende raggiungere tali obiettivi da un lato sviluppandoil confronto concorrenziale fra le imprese pubbliche e private responsa-bili dell’erogazione dei servizi, tenendo conto delle esigenze di crescitacompetitiva delle aziende e di quelle dei lavoratori loro dipendenti; dal-l’altro ridisegnando i processi di pianificazione, programmazione e con-trollo dei servizi e degli investimenti, in modo da consentire alla Regio-ne e agli enti locali di aumentare l’offerta di servizi di trasporto e miglio-rare la dotazione infrastrutturale della Campania.
In sintesi, i principali cambiamenti che la riforma può attivare pos-sono essere considerati i seguenti:1) Miglioramento della qualità dei servizi e introduzione della Carta per
la qualità dei servizi;2) Snellimento del processo di pianificazione degli investimenti;3) Ridefinizione del processo di programmazione dei servizi;4) Integrazione del sistema dei servizi, delle reti e delle tariffe;5) Ridefinizione delle competenze e trasferimento di funzioni agli enti
locali;6) Introduzione di procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi
dal 2004;7) Riduzione dei costi sostenuti dalla Regione e dagli enti locali per
erogare i servizi di trasporto pubblico sul territorio;8) Ricezione delle indicazioni e dei pareri dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato per ridurre le barriere all’entrata ed i sus-sidi incrociati;
9) Scomparsa degli assetti monopolistici e delle rendite da posizione esviluppo della competitività delle attuali aziende concessionarie;
10) Riorganizzazione delle aziende pubbliche di trasporto pubblico loca-le e recupero di efficienza e produttività;
11) Sviluppo professionale e tutela del personale delle aziende di tra-sporto;
12) Istituzione di una struttura organizzativa di supporto per la Regionee gli Enti locali, articolata in diverse unità: l’Agenzia regionale per lamobilità sostenibile, la Consulta Regionale per la mobilità, le Agen-zie territoriali per la mobilità sostenibile.
In particolare, l’istituzione delle agenzie per la mobilità sostenibilerappresenta una innovazione importante per il sistema di trasportoregionale, ed è essa stessa il risultato di un processo di confronto e divalutazione di diversi punti di vista, alternative e soluzioni già adottatenell’esperienza europea e italiana. La legge regionale n°3 del marzo2002 presenta infatti un modello originale di agenzia regionale, denomi-
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
11
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
nata Agenzia Campana per la Mobilità sostenibile, ACaM, cui si dà tipi-camente un ruolo di supporto all’ente regionale nello svolgimento deisuoi processi e delle sue funzioni.
Il compito dell’ACaM è infatti di fornire un supporto tecnico allaRegione e, ove richiesto agli enti locali, in attività che richiedono elevatilivelli di professionalità, quali la progettazione e programmazione dei ser-vizi minimi e aggiuntivi per la mobilità, la gestione delle procedure con-corsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e la vigi-lanza sulla correttezza dei comportamenti e sul rispetto degli obblighiassunti dalle imprese di trasporto affidatarie di servizi di competenza dellaRegione.
Il modello organizzativo dell’ACaM privilegia una logica di flessi-bilità di funzionamento, snellezza nelle procedure, alta professionalità,velocità di comunicazione interna, organico limitato, organizzazione perprogetti. Soprattutto, l’agenzia rappresenterà un centro di coordinamen-to e di integrazione delle numerose competenze in tema di trasportoche in Campania sono già presenti all’interno dell’amministrazioneregionale, delle Università, dei Centri di ricerca, delle imprese, degli entilocali.
La legge regionale prevede inoltre che anche le Province ed iComuni Capoluogo di Provincia possano costituire, nelle modalità daloro ritenute più opportune, agenzie territoriali per la mobilità.
Lo sviluppo di tali agenzie richiede che si affrontino problemati-che diverse e di elevata complessità, che investono le funzioni degli entilocali e dei corrispondenti assessorati ai trasporti, la riorganizzazione e ilruolo che tali enti vorranno attribuire sia alle aziende responsabili dell’e-rogazione del servizio da loro spesso direttamente controllate sia a quel-le imprese che risulteranno in un futuro non lontano vincitrici delle pro-cedure di affidamento concorsuale.
Alcune di queste decisioni sono in grado potenzialmente di condi-zionare l’efficacia del confronto competitivo fra imprese: ad esempio, ilcontrollo di alcune infrastrutture o dei veicoli può rappresentare unabarriera all’ingresso di nuovi operatori, o la mancata soluzione delle dif-ficoltà economiche e finanziarie delle aziende attualmente concessiona-rie potrebbe rappresentare un handicap in grado di limitarne le possibi-lità di sviluppo e di sopravvivenza. La costituzione di agenzie territorialiper la mobilità deve dunque tener conto anche di queste diverse esigen-ze, spesso contrastanti.
Una attenta riflessione sulle soluzioni adottate anche in altre regio-ni italiane rappresenta dunque un valido contributo per scegliere poi le
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
Prefazione
12
soluzioni ritenute più coerenti con le esigenze di mobilità dei cittadini,di sviluppo delle imprese di trasporto, di valorizzazione delle competen-ze delle amministrazioni locali e di incremento dell’occupazione delsistema di trasporto della Campania.
La pubblicazione e la diffusione dello studio condotto dal Cesitper conto della Regione, e di seguito presentato, vuole dunque renderedisponibile anche agli altri enti locali, alle imprese e alle altre organizza-zioni che partecipano attivamente al dibattito sulle modalità di attuazio-ne della riforma del trasporto pubblico, le informazioni e le riflessioni dicui già l’amministrazione regionale ha potuto avvalersi nel suo processodi decisione e pianificazione.
Una attenta comprensione delle esperienze già sviluppate da altrirappresenta infatti un indubbio vantaggio e può senz’altro agevolare laprogettazione di soluzioni innovative per soddisfare le esigenze di unterritorio e dei suoi cittadini in tema di mobilità, sviluppo, occupazione.
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
Tutti gli stati membri dell’Unione Europea hanno introdotto ostanno sperimentando modelli di riforma dei sistemi di trasporto pubbli-co locale. Le esperienze già attuate hanno consentito di evidenziarecome il modello del mercato chiuso, in cui cioè le imprese di trasportosono titolari di diritti esclusivi e non sono sottoposte alla concorrenzaproveniente da altri operatori, rappresenti la forma economica ed orga-nizzativa meno efficiente ed efficace per erogare servizi di trasporto diqualità ai cittadini. Le altre forme di organizzazione dei sistemi di tra-sporto locale già introdotte in Europa invece sono il modello del freemarket e quello della concorrenza per il mercato.
Nel caso del free market è noto che non vi sono diritti esclusivi eche la concorrenza si esplicita direttamente nel mercato. Secondo talemodello, infatti, il sistema di trasporto dovrebbe consentire l’openaccess, cioè il libero accesso a qualunque operatore abilitato (cioè dota-to di licenza); si consente che si sviluppi una concorrenza diretta fraoperatori su una determinata tratta e che sia il cliente finale a “bocciare”o “promuovere” ciascun operatore.
Gli esempi più spinti di introduzione della concorrenza con ilmodello del free market in Europa si sono osservati in Gran Bretagna. Iprincipi alla base di tale modello si concentrano sulla convinzione deipolicy maker che la riduzione dei sussidi pubblici sia prioritaria rispettoagli obiettivi sociali e che gli obiettivi sociali possono meglio essereconseguiti tramite il ricorso a forme di concorrenza diretta fra operatori.Ma è ormai accertato che gli effetti del free market e dell’open accesssono stati ambigui; si sono infatti conseguiti i seguenti risultati:•riduzione dei costi operativi delle imprese (misurati in rapporto ai vei-
coli-km erogati);•riduzione del costo sostenuto dagli enti locali per il finanziamento dei
servizi di trasporto;•concentrazione del settore delle imprese di trasporto pubblico e svi-
luppo di grandi gruppi aziendali privati;•aumento delle tariffe relative ai titoli di viaggio offerti ai cittadini;
di RICCARDO MERCURIO, professore di Organizzazione aziendale, Università degli Studi di Napoli Federico II Direttore scientifico del Cesit
LA COMPETIZIONE NEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E REGIONALEQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
13
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
La competizione nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale
14
•riduzione del veicoli-km offerti complessivamente dalle imprese di tra-sporto;
•riduzione dei passeggeri trasportati complessivamente dalle imprese eriduzione della quota di mercato del trasporto pubblico a vantaggiodel trasporto privato.
In altri paesi europei (Francia, Olanda, Svezia) si sono inveceintrodotti nel sistema di trasporto locale meccanismi di concorrenza peril mercato: il confronto concorrenziale fra imprese avviene prima dellafase di erogazione del servizio, vale a dire nel momento di assegnazionedi un contratto o di una concessione mediante una procedura di garabandita dall’ante locale di riferimento.
Il ricorso a forme di concorrenza per il mercato presenta il vantag-gio di consentire ad un ente pubblico di erogare un servizio attraverso ilricorso al mercato e alla concorrenza, assicurando comunque un ade-guato livello qualitativo ai cittadini. Il principio che guida le forme diconcorrenza per il mercato tuttavia non è fondato sull’ipotesi che i pri-vati sappiano gestire il servizio di trasporto meglio delle aziende a con-trollo pubblico. Si ritiene, invece, che sia la concorrenza in fase di garaa stimolare in ogni operatore una riflessione consapevole sulle modalitàpiù adeguate per ridurre i costi e per migliorare la qualità offerta. L’o-biettivo infatti è di incentivare le imprese affidatarie a ridurre i prezzid’offerta e, dunque, garantire alla collettività una riduzione dei costirelativi all’erogazione di servizi socialmente necessari. In tal modopotranno conseguirsi dei recuperi di efficienza e produttività in grado ditrasformarsi un beneficio per l’intera collettività.
Per attribuire ad un unico operatore il diritto e la responsabilitàdella gestione del servizio, si effettua una gara (competitive bidding) perl’individuazione del soggetto dotato dei requisiti migliori (in senso eco-nomico ed organizzativo) per lo svolgimento dell’attività. Alla gara, inlinea di principio possono partecipare sia operatori pubblici sia operatoriprivati interessati ad entrare in nuovo business (public private competi-tion). Risulterà vincitore l’operatore che per erogare quel determinatolivello minimo di servizi ha richiesto un compenso inferiore agli altri oche si è dichiarato disponibile a pagare allo Stato o all’ente pubblico unprezzo superiore a quello offerto dai concorrenti. Si è dunque in presen-za di formule contrattuali che legano l’ente regolatore pubblico e l’ope-ratore secondo modalità tipicamente fixed price, in cui cioè l’entità delleentrate dell’operatore è prefissata sulla base di un meccanismo d’asta.
Gli studi e le analisi condotte in Europa hanno esaurientementedimostrato come dei tre modelli alternativi, (mercato chiuso, free market
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
e concorrenza per il mercato) la concorrenza per il mercato sia sicura-mente quello più efficace in termini di capacità di perseguire contempo-raneamente obiettivi di recupero di efficienza e di miglioramento dellaqualità del servizio. In particolare, nel caso dei servizi di trasporto auto-filotranviari, in Europa il costo per autobus-km risulta essere in mediapari a 3,02 euro per i servizi erogati all’interno di mercati chiusi, 2,26euro laddove vi è la concorrenza per il mercato e 1,44 euro nei freemarket.
Tuttavia, se si confronta l’attrattività dei sistemi di trasporto pub-blico locale mediante l’aumento dei passeggeri/chilometro, si riscontrache dal 1990 al 1997, nei paesi in cui era prevalente la formula del mer-cato chiuso, l’aumento è stato del 5%; nei paesi dove si è attuato l’openaccess l’aumento è del 6%. Invece, i sistemi nei quali si sono introdottimeccanismi di concorrenza per il mercato, hanno fatto registrare unincremento del 14% dei passeggeri/chilometro.
In conclusione, rispetto alla concorrenza per il mercato i free mar-ket sono meno costosi ma peggiori in termini di attrattività del trasportopubblico rispetto a quello privato, mentre i mercati chiusi sono a mino-re attrattività e più costosi.
Le forme di introduzione della concorrenza in sperimentazione inEuropa sono desumibili dalla tavola seguente.
Tav. 1 La concorrenza nei sistemi di trasporto pubblico locale e regionale in Europa
15
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
Trasporti regionali e Trasporti urbani, Trasporti ferroviariinterregionali con autobus autobus metropolitana,
ed autocorriere metropolitana leggeraAustria Mercato chiuso Mercato chiuso Mercato chiusoBelgio Mercato chiuso Mercato chiuso Mercato chiusoDanimarca Concorrenza per il mercato Concorrenza per il mercato Mercato chiusoFinlandia Concorrenza per il mercato Mercato chiuso Mercato chiuso
Concorrenza per il mercatoFrancia Mercato chiuso Mercato chiuso Mercato chiuso
Concorrenza per il mercatoGermania Concorrenza per il mercato Concorrenza per il mercato Mercato chiuso
Concorrenza per il mercatoGrecia Mercato chiuso Mercato chiuso Mercato chiusoIrlanda Free market Mercato chiuso Mercato chiusoLussemburgo - Mercato chiuso Mercato chiusoPaesi Bassi Mercato chiuso Mercato chiuso Mercato chiuso
Concorrenza per il mercato Concorrenza per il mercato Concorrenza per il mercatoPortogallo Free market Mercato chiuso Mercato chiuso
Concorrenza per il mercatoSpagna Concorrenza per il mercato Concorrenza per il mercato Mercato chiusoSvezia Free market Concorrenza per il mercato Concorrenza per il mercatoRegno Unito Free market Free market Concorrenza per il mercato
Concorrenza per il mercato
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
La competizione nei servizi di trasporto pubblico locale e regionale
16
Per lo sviluppo di una efficace concorrenza fra operatori all’inter-no dei sistemi di trasporto pubblico locale gli studi effettuati evidenzia-no la necessità di predisporre alcune condizioni:1) creare una pluralità di soggetti che offrono in concorrenza servizi
sostitutivi;2) ammettere la possibilità di un intervento di privati sia pure nel rispet-
to di certi standard definiti e controllati dai pubblici poteri;3) far definire la quota di domanda soddisfatta con strutture pubbliche a
chi richiede il servizio;4) far diventare il cliente/utente la fonte diretta o indiretta di almeno una
parte di fondi che affluiscono alle strutture di erogazione dei servizi;5) lasciare autonomia nella ricerca delle forme organizzative e delle
innovazioni con cui produrre/erogare il servizio (salvo il rispetto dideterminati standard);
6) introdurre sistemi di incentivo del management e del personale piùorientati ai risultati;
7) assegnare al management pubblico la gestione della qualità del pro-dotto servizio da erogare.
Nella maggioranza dei paesi europei il tentativo di stabilire talecondizioni e di incentivare il superamento di assetti monopolitistici harichiesto la costituzione di nuove organizzazioni pubbliche nelle qualiraccogliere e sviluppare risorse professionali dotate delle competenze econoscenze necessarie per gestire i processi di regolazione, pianificazio-ne, affidamento e controllo di progetti di investimento e di erogazionedei servizi di trasporto pubblico. Le denominazioni utilizzate in Europaper individuare tali organizzazioni sono spesso diverse: centri di regia,sindacati, authority, agenzie. In alcuni casi tali organizzazioni hanno unalunga tradizione come ad esempio Transport for London che è solo l’ul-tima denominazione attribuita all’ente che da più di 50 anni coordina ilsistema di trasporto dell’area di Londra, forse uno dei sistemi di traspor-to regionale più complessi e ampi presenti in Europa. In altri casi, comead esempio accade in Italia, è solo da poco che si sono costituite orga-nizzazioni cui assegnare compiti di coordinamento e gestione dei siste-mi di trasporto.
Sembra tuttavia che per discutere sui modelli e sulle diverse fun-zioni assegnate a tali organizzazioni possa ormai serenamente utilizzarsila dizione di agenzie per la mobilità. In Italia infatti è questa la termino-logia cui si fa riferimento per discutere di organizzazioni in verità spessomolto diverse le une dalle altre. Anche se la denominazione assunta datali organizzazioni non è omogenea nei diversi paesi europei e le loro
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
specifiche competenze possono variare anche all’interno di una stessanazione, è possibile identificare alcune tipologie ricorrenti, distinte inbase all’assetto giuridico e al controllo proprietario, tipiche di organizza-zioni di tal genere:•Organizzazione pubblica esterna alla struttura amministrativa degli enti
locali e dotata di autonomia decisionale rispetto agli organi politicilocali che rappresenta, come si riscontra per la attuale Transport forLondon a Londra; o come la Syndicat des Transports d’Ile-de-France aParigi.
•Organizzazione pubblica controllata e rappresentativa dei diversi entilocali, come per le diverse forme di sindacati francesi (ad esempioCommunauté Urbaine de Bordeaux o il Syndicat des Transport pour leRhône et l’Agglomeration Lyonnaise, SYTRAL) cui sono assegnati icompiti di autorità organizzatrici.
•Società a responsabilità limitata controllata da un ente locale, come ilcaso tedesco della Società di trasporto pubblico locale e di brevedistanza del Land Niedersachsen, o come la Storstocholms LokaltrafikAB di Stoccolma.
•Società per azioni o a responsabilità limitata controllata da più entilocali e dotata di autonomia decisionale e indipendenza rispetto agliorgani politici locali, come la Verkehrsverbund Berlin BrandenburgGmbH per la regione di Berlino Brandeburgo in Germania.
•Consorzio o società a responsabilità limitata a partecipazione mista siadi imprese di trasporto (pubbliche o private) sia di enti locali, come ilconsorzio München Verkehrs Tarifverbund GmbH di Monaco.
In Italia la trasformazione del trasporto regionale e locale indottadal D.L 422 del 1997, e dal successivo D.L. 400 del 1999 ha rispettatoquel principio per cui quando si è in presenza di una riforma la cuiattuazione si decentra alle Regioni e agli enti locali, si realizzano di fatto21 sistemi diversi ciascuno corrispondente ad ognuna delle 15 regioni astatuto ordinario, alle 4 regioni a statuto speciale e alle due provinceautonome di Trento e Bolzano, cui evidentemente sono conferiti i poteridecisionali in tema di programmazione e amministrazione dei servizipubblici, tra cui anche i trasporti locali. Corrispondentemente le agenziedi mobilità italiane, anche se non numerose, sono già diverse le unedalle altre: Emilia Romagna, Campania, Lazio e Lombardia sono regioninelle quali si sono già sperimentate o si è avviata la definizione di diver-si modelli di agenzia. Se e come tali nuovi organismi saranno in gradodi agevolare l’introduzione e l’intensità del confronto competitivo fraimprese è ciò che dovrà essere osservato nei prossimi mesi.
17
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
La separazione fra livello politico, tecnico e operativo nei sistemidecisionali per il trasporto pubblico locale e regionale
L’introduzione di meccanismi concorrenziali per l’affidamento deiservizi di trasporto pubblico in Europa ha evidenziato come sia necessa-ria una garanzia dell’indipendenza fra gestione politica, pianificazionedel sistema e controllo della quantità e qualità del servizio, e gestionedelle operazioni. In particolare numerose ricerche svolte nell’UnioneEuropea hanno sottolineato come sia necessario conseguire una ade-guata separazione fra tre livelli decisionali, tutti di rilevante importanza,ma tuttavia distinti in termini di competenze, conoscenze e responsabili-tà relative ai sistemi di trasporto regionale e locale: il livello politico, illivello tecnico e il livello operativo della produzione dei servizi.
Il livello politico è responsabile della pianificazione dei principie degli obiettivi generali di organizzazione del trasporto regionale, edella definizione delle caratteristiche di base del servizio in termini diperformance di sistema. Nel sistema italiano tali decisioni sono chiara-mente da attribuire agli organi politici territoriali quali il Consiglio, laGiunta e l’Assessorato ai trasporti delle Regioni, delle Province e deiComuni, secondo le competenze ad essi trasferite delle distinte leggiregionali.
Il livello tecnico si riferisce a decisioni relative alla progettazione ealla gestione delle modalità di affidamento dei servizi di trasporto locale,al controllo della qualità, della sicurezza, alla definizione delle tariffe,alla comunicazione e all’informazione, alla definizione dei livelli di ser-vizi minimi, alla definizione dei servizi supplementari, alla determinazio-ne dei percorsi e delle tratte, alla vendita dei titoli, alla definizione degliorari, alla gestione dell’integrazione tariffaria e della ripartizione dei rica-vi tra gli operatori. In sintesi, a tale livello occorre tradurre gli obiettivipolitici in programmi operativi rivolti a coordinare il sistema di traspor-to. Tali compiti non possono essere facilmente trasferiti ad un operatoreprivato, ma vanno svolti in coerenza alla indicazioni politiche di tuteladi interessi sociali.
di MARCELLO MARTINEZ
L’ORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE PER LA MOBILITÀ IN EUROPA E IN ITALIAQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
19
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
20
La gestione operativa si riferisce, infine, ai processi decisionali affi-dati all’autonomia manageriale e imprenditoriale in merito alle soluzioniorganizzative ad adottare per l’erogazione del servizio. Alle imprese ditrasporto spetta infatti assumere il rischio connesso alla produzione delservizio, alle scelte commerciali, alle relazioni con personale. Il livellooperativo, pertanto, si riferisce alla gestione dei mezzi, dei sistemi dicontrollo dell’esercizio, alla gestione del personale, alla manutenzione,eventualmente alla gestione della rete e delle infrastrutture.
L’elemento di maggiore difficoltà e complessità che occorreaffrontare nell’ambito di una riorganizzazione dei modelli di trasportopubblico locale è relativo alla duplice separazione da effettuare fra laresponsabilità politica e la responsabilità tecnica e fra la responsabilitàtecnica e la responsabilità operativa.
La necessità di distinguere il livello delle decisioni politiche è insostanza determinata dalla volontà di ridurre quelle tipiche disfunzioniriconoscibili nei sistemi di trasporto locale in Europa:•Distorsioni politiche nel funzionamento del sistema: gli organismi poli-
tici hanno spesso imposto vincoli e obblighi insostenibili dal punto divista dell’autonomia economica delle aziende di trasporto.
•Costi operativi eccessivi: i costi di gestione del servizio sono cresciutisenza controllo, spesso a causa di politiche occupazionali non coerenticon l’esigenze di erogazione del servizio.
•Incentivi manageriali devianti: una influenza politica eccessiva ha spes-so condizionato le scelte e i comportamenti manageriali orientandoli aperseguire obiettivi di legittimazione piuttosto che di economicità einnovazione.
•Mancanza di dinamismo: un forte controllo politico e una forte regola-zione hanno impedito l’innovazione imprenditoriale e un rinnovo nelleforme e modalità di offerta del servizio.
L’esigenza di separare il livello operativo dal quello tecnico è det-tata invece dalla necessità di introdurre modalità efficaci di affidamentoconcorsuale dei servizi e di concorrenza. Le attività tecniche e operativenel modello tradizionale di organizzazione dei sistemi di trasporto pub-blico locale (mercati chiusi) sono attribuite alla azienda pubblica di tra-sporto locale, sia perché essa è considerata ancora parte della pubblicaamministrazione, sia perché, anche se societarizzata, comunque operain condizioni di monopolio e di fatto propone, impone o suggerisceall’ente locale la modalità di erogazione del servizio, ne definisce i costie finisce per rappresentare il centro di competenze di riferimento delledecisioni politiche assunte dall’ente locale.
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Europa e in Italia
21
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
Tuttavia è evidente che in un sistema in cui gli enti locali indivi-duano i servizi minimi per cui sono disposti a riconoscere compensi pergli obblighi di servizio pubblico imposti alle imprese, e in cui occorremantenere integrato il funzionamento del sistema, non è più coerenteche sia una specifica azienda, tra l’altro titolare di un contratto di servi-zio dalla durata limitata, a svolgere attività di pianificazione e progetta-zione o di coordinamento.
Secondo l’esperienza di paesi come Gran Bretagna, Francia, Ger-mania, Paesi Bassi, Svezia, la separazione fra i tre livelli si può consegui-re più efficacemente costituendo delle organizzazioni intermedie fra gliorganismi di rappresentanza politica locale e le imprese di trasporto.
Gli organismi politici locali sono chiamati solo a definire gli obiet-tivi generali da conseguire nell’ambito del trasporto locale, mentre lacomplessità tecnica connessa alla progettazione e organizzazione dellarete dei servizi di un sistema di trasporto locale è affidata a una organiz-zazione distinta, dotata delle opportune competenze, che agisce nell’in-teresse degli enti locali cui fa riferimento e che per tale motivo viene inquesta sede definita come agenzia dell’ente locale per il trasporto, oagenzia per la mobilità.
A tali organizzazioni può essere attribuita la responsabilità relativaa territori di diversa ampiezza; non è possibile infatti predefinire taledimensione che invece va valutata rispetto ai flussi di traffico e al gradodi interdipendenza dei sistemi. Un’agenzia può riferirsi ad esempio all’a-rea metropolitana relativa ad una grande città (come accade nel caso diLondra), ad un territorio afferente a più municipalità piccole e grandi(come accade in Svezia e in Germania) o anche ad una regione di mag-giori dimensioni (coma accade in Olanda e in Germania). Ad esempio,la agenzia di Berlino Brandeburgo (Verkehrsverbund Berlin Branden-burg - VBB) è responsabile dei servizi che si svolgono su un’area di cir-ca 30.000 kmq e con una popolazione di circa 6 milioni di persone; aParigi la agenzia STIF (Syndacat des Transport d’Ile de France) organiz-za i servizi di trasporto pubblico su un territorio di 12.000 kmq e per cir-ca 11 milioni di abitanti.
Spesso il carattere di organizzazione espressione diretta degli entilocali condiziona la responsabilità delle agenzie, collegandole alla strut-tura amministrativa tipica di uno specifico paese e al grado di decentra-mento politico e amministrativo adottato. Tuttavia, alle volte, dato che siè ritenuto necessario agevolare l’integrazione nei flussi di trasporto frauna grande municipalità e le altre, più piccole e comprese nei suoi din-torni, in alcuni paesi europei si è costituita una nuova istituzione
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Europa e in Italia
22
responsabile del coordinamento e della pianificazione del trasporto chenon coincide con nessun livello amministrativo territoriale, ma che èrappresentativa di tutte le comunità coinvolte dal sistema di trasportolocale. In sostanza il panorama europeo appare molto articolato e leagenzie spesso assumono una configurazione diversa anche all’internodi uno stesso paese.
In Gran Bretagna, sin dal 1968, si è definita una separazione fralivello politico e livello tecnico nei sistemi di trasporto locale. Il primolivello è stato affidato alla responsabilità delle PTA (Passenger TransportAuthority) organizzazioni rappresentative delle amministrazioni localipresenti su un territorio, mentre le scelte tecniche relative al trasportosono state affidate alle PTE (Passenger Transport Executive) che dunquesi sono occupate di implementare le decisioni politiche. Le PTA/PTEfurono abolite nel 1972 ma sono state ricostituite nel 1985 con l’introdu-zione del free market nei sistemi di trasporto locale. Le principali agen-zie attualmente esistenti sono la GMPTA/PTE di Manchester; laWMPTA/Centre di Birmingham e delle West Midlands; la WYPTA/Metrodi Leeds, Bradford, West Yorkshire; la Merseyride PTA/Merseytravel diLiverpool Merseyside; la TWPTA/Nexus, di Newcastle Tyne and Wear; laSYPTA/SYPTE di Sheffield South Yorkshire; la SPTA/SPT di GlasgowStrathclyde.
Prima della riforma del 1985 le PTE erogavano direttamente i ser-vizi di trasporto, invece con il free market i loro compiti principali sonogestire le fermate degli autobus, rilasciare le concessioni per le nuoveinfrastrutture per le light rail, sviluppare eventualmente accordi con leimprese private per migliorare la qualità dei servizi, sostenere con age-volazioni tariffarie le categorie protette e le fasce deboli di popolazio-ne, stipulare contratti di servizio per quei servizi che i privati decidonodi non erogare su tratte poco remunerative ma valutate ad interessesociale.
In Francia, invece, esistono le autorità organizzatrici, istituite sindal 1982, e responsabili della definizione delle linee, dell’acquisto deimezzi, dell’elaborazione dei piani tariffari, della scelta delle imprese ditrasporto, della pianificazione, costruzione e gestione delle infrastruttu-re, del controllo, del finanziamento del sistema. Il ruolo dell’autoritàorganizzatrice viene rivestito dal Comune sul territorio del quale il servi-zio di trasporto viene effettuato, o dall’organismo pubblico locale creatoall’uopo, su iniziativa dei Comuni aventi interesse alla realizzazione delservizio di trasporto. Può trattarsi, in questa seconda eventualità, di unsindacato di Comuni dotato di quest’unica competenza (c.d. SIVU), o di
23
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
competenze multiple tra le quali rientra quella inerente al trasporto pub-blico urbano (SIVOM), o ancora di un organismo pubblico di coopera-zione intercomunale a fiscalità propria, che annovera la competenzarelativa al trasporto pubblico urbano tra le sue prerogative obbligatorie(ad es. il caso di Bordeaux) o opzionali (nel caso dei distretti e dellecomunità di Comuni). Infine, può trattarsi di un sindacato misto (comenel caso del Sytral di Lione) quando l’organismo pubblico di coopera-zione creato comprende soggetti appartenenti a categorie differenti(cioè Comuni, gruppi di Comuni, Dipartimenti, ecc.). Le autorità orga-nizzatrici possono decidere di erogare direttamente i servizi con propriestrutture (Régie) oppure affidare contratti mediante procedure di affida-mento concorsuale (délégation de service public). Attualmente circa il90% delle agenzie francesi ha stipulato contratti di servizio con impreseprivate di trasporto.
In Germania, dal 1980 le strutture di coordinamento cui partecipa-no direttamente le imprese di trasporto pubblico (le Verkehrsverbund) sisono trasformate in agenzie di trasporto. Le competenze del trasportolocale possono essere esercitate da un singolo ente locale e da più entilocali in cooperazione, ma anche mediante una delega esercitata a favo-re di un consorzio di enti locali (i Verkehrsverbund) o una nuova orga-nizzazione costituita ad hoc (le Zweckverband). Ad esempio, a Franco-forte la FVV (Frankfurter Verkehrsverbund) si è trasformata da associa-zione di imprese di trasporto responsabile del coordinamento dei servizinella Verkehrsverbund Rhein Main (RMV), un consorzio di enti localiche compra servizi di trasporto dalle imprese. Simili cambiamenti e nuo-ve agenzie per la mobilità si sono realizzati ad Amburgo, nella regioneRhein Ruhr, e nella zona di Berlino Brandeburgo.
In Olanda, la recente riforma del trasporto locale prevede che l’e-rogazione delle concessioni per i servizi di trasporto sia di competenzadi specifiche organizzazioni, denominate autorità provinciali e regionali,distinte dalle amministrazioni delle grandi e piccole città. Tali autoritàprovinciali e regionali sono responsabili, ad esempio, dell’elaborazionee finalizzazione del piano dei trasporti per il loro territorio, per l’elabo-razione delle specifiche tecniche e giuridiche relative al servizio da met-tere a gara, per la gestione della procedura concorsuale, per l’affida-mento del contratto di servizio, per la rescissione dei contratti, per ladefinizione dei prezzi minimi e massimi delle concessioni.
In Svezia, infine, dagli anni ’80, l’attività di pianificazione delletratte, degli orari, dei veicoli, delle tariffe è determinata da specificheorganizzazioni amministrative denominate County Public Transport
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Europa e in Italia
24
Authority. Tali organizzazioni, tipicamente agenzie delle 24 contee in cuiè diviso il territorio svedese, sono responsabili anche della gestione del-le procedure concorsuali introdotte per l’affidamento dei servizi.
In base all’analisi delle diverse esperienze europee, la creazionedelle agenzie locali di mobilità può avvenire secondo due modalità, perscomposizione o per aggregazione.
La prima modalità prevede la scomposizione della azienda exmunicipalizzata e la separazione delle competenze di pianificazione daquelle operative. Un processo di tale tipo è avvenuto, ad esempio, inGran Bretagna, in Svezia e in Danimarca, dove sono state organizzateaziende di trasporto locale prive però della responsabilità della pro-grammazione, affidata a agenzie composte dai vecchi uffici delle stesseaziende di trasporto. Un approccio simile si sta realizzando anche adAmsterdam in Olanda. In sostanza, al posto di un’unica azienda pubbli-ca si sviluppano due soggetti: l’agenzia pubblica e una o più imprese ditrasporto responsabili solo della gestione operativa.
La seconda modalità prevede invece la costituzione di una agen-zia mediante l’aggregazione di competenze provenienti da diversi entilocali, tutti attivi su un territorio interessato da flussi interdipendenti dispostamento. In Germania, ad esempio, le agenzie sono società control-late dai diversi enti locali, e la loro competenza si sviluppa su tutte lemodalità di trasporto.
La legislazione italiana esplicitamente impone alle Regioni, alleProvince e ai Comuni nuovi ruoli e nuove responsabilità in tema di tra-sporto locale, tuttavia non dà indicazioni specifiche in riferimento allemodalità organizzative mediante le quali tali enti potranno esercitare lenuove funzioni assegnategli. Con l’introduzione di procedure concor-suali di affidamento del servizio, le decisioni operative, vale a direquelle legate alla produzione del servizio, sono da trasferire, assieme alrischio ad esse relativo, a imprese di trasporto pubbliche o private cheabbiano dimostrato di esser più competitive di altre. Tuttavia, la rifor-ma è meno esplicita in termini di separazione fra livello politico e livel-lo tecnico e, di fatto, rimanda tale decisione alle singole legislazioniregionali.
La creazione di agenzie di mobilità potrebbe rappresentare, ancheper l’Italia, una possibile soluzione per risolvere la frequente confusionedi ruoli; se gli enti locali mantengono le responsabilità politiche, all’a-genzia possono essere affidate le responsabilità relative alle attività tec-niche e si possono stabilire due tipologie di relazioni governate da diffe-renti contratti o accordi:
25
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
1) un contratto\accordo di performance fra l’organismo politico e l’a-genzia, nel quale si assegnano e si definiscono obiettivi al sistema ditrasporto e con il quale si definisce il budget di spesa;
2) uno o più contratti di servizio fra l’agenzia e gli operatori, con i qualisi stabiliscono le caratteristiche operative del servizio da produrre, lemodalità di incentivo e controllo e i compensi.
In tal modo, l’agenzia può rappresentare un organo esecutivo delsistema politico e si colloca in una posizione intermedia fra esso e leimprese di trasporto, per controllare e valutare i comportamenti di que-ste ultime, garantendo un impiego dei fondi assegnati al trasporto pub-blico coerente con gli obiettivi sociali e economici stabiliti dagli organipolitici di rappresentanza locale. In questo senso, l’agenzia locale per lamobilità può assumere il compito di conciliare gli obiettivi di politicapubblica (equità sociale, sviluppo economico, equilibrio territoriale,allocazione delle esternalità positive e negative, tutela ambientale) conle esigenze delle imprese di trasporto (equilibrio economico finanziario,assenza di conflittualità sindacale, aumento della qualità, aumento dellaquota di mercato) e con quelli dei cittadini (accessibilità, disponibilità,informazioni, comfort, sicurezza, protezione ecc).
Occorre poi evidenziare che la costituzione di agenzie per lamobilità in Italia può rappresentare una occasione per le Regioni e glienti locali chiamati ad adottare uno dei modelli di gestione e affidamen-to delle infrastrutture per il trasporto locale coerenti con le indicazionidell’art. 35 della legge finanziaria 2002. In particolare, come noto, talearticolo emenda l’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267(Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che regola laGestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza indu-striale, fra cui si fanno rientrare anche i servizi di trasporto pubblicolocale.
La nuova versione dell’art. 113 pertanto indica due possibili solu-zioni per la gestione delle reti, degli impianti e della altre dotazionipatrimoniali, qualora questa sia separata dal servizio (comma 4):a) affidare tale gestione ad una società di capitali con partecipazione
maggioritaria degli enti locali;b) affidare tale gestione ad imprese idonee identificate mediante proce-
dura di affidamento concorsuale.L’articolo inoltre indica che gli enti locali possono conferire la pro-
prietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali asocietà di capitali (vedi punto a) di cui detengano la maggioranza che èincedibile (art. 113, comma 13). A loro volta tali società possono affida-
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Europa e in Italia
26
re mediante procedure concorsuali la gestione degli asset ad imprese aisensi del precedente punto b.
Il rapporto fra enti locali e società o imprese responsabili dellagestione delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali deve poi esse-re regolato da contratto di servizio. I gestori (siano essi le società di cuial punto a o le imprese affidatarie di cui al punto b) delle reti, impiantie altre dotazioni patrimoniali devono porre tali asset a disposizione deigestori del servizio, a fronte di un canone stabilito.
I modelli suggeriti dall’art. 35 dunque rappresentano una modalitàgiuridica e amministrativa con cui le Regioni e gli Enti locali potrebberocostituire delle agenzie per la mobilità. In particolare, già in alcuneregioni, province o comuni si sono costituite delle agenzie sottoforma disocietà di capitali e ad esse è stata conferita la proprietà degli assetnecessari per l’erogazione del servizio.
Le agenzie per la mobilità previste dalle legislazioni regionali in ItaliaLa riforma avviata dai decreti legislativi n°422 del 1997 e n°400 del
1999 impone che dal 1 gennaio 2004 i sistemi di trasporto pubblicoregionali e locali in Italia siano contraddistinti dall’affidamento dei servi-zi a seguito dell’espletamento di procedure concorsuali.
Ormai tutte le Regioni a statuto ordinario hanno recepito le indi-cazioni del legislatore nazionale ed hanno avviato significativi interventidi cambiamento degli assetti delle imprese, dei meccanismi di regolazio-ne dell’affidamento dei servizi, delle modalità giuridiche e organizzativedi gestione delle infrastrutture.
Le esigenze che hanno sostenuto la riforma del trasporto pubblicolocale e regionale sono molteplici, ma tra tutte è possibile evidenziarne tre: 1) incrementare la qualità e quantità dei servizi di trasporto pubblico
nelle aree urbane ed extraurbane;2) ridurre il costo sostenuto dalla collettività per l’erogazione dei servizi
per i quali sussistono obblighi di servizio pubblico;3) migliorare la competitività delle imprese pubbliche e private affidata-
rie del servizio. Per conseguire tali obiettivi la riforma ha introdotto rilevanti cam-
biamenti nell’ordinamento giuridico e amministrativo dei sistemi di tra-sporto pubblico regionali e locali. In particolare sono stati attuati iseguenti interventi:a) delega alle Regioni dei compiti di programmazione e amministrazio-
ne del sistema dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale(inclusi i trasporti ferroviari, marittimi e aerei di interesse regionale);
27
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
b) delega alle Regioni della responsabilità del finanziamento dei servizidi trasporto ritenuti essenziali per la mobilità sul loro territorio (defi-niti servizi minimi) e agli enti locali della responsabilità del finanzia-mento di ulteriori servizi, definiti servizi aggiuntivi;
c) definizione di una procedura di programmazione triennale con cui leRegioni, tenuto conto della programmazione delle Province e deglialtri enti locali, individuano i servizi minimi da finanziare con unapposito Fondo Regionale Trasporti;
d) trasferimento dei beni, degli impianti e dell’infrastruttura delle ferro-vie in ex gestione commissariale governativa e delle ferrovie in con-cessione al demanio e al patrimonio delle Regioni;
e) adozione del principio di separazione contabile e/o organizzativa frala gestione dell’infrastruttura ferroviaria e l’esercizio dei servizi di tra-sporto ferroviario locale e regionale, applicando anche al trasportolocale i principi espressi dalla direttiva CEE n°440 del 1991;
f) adozione del contratto di servizio come strumento con cui regolare lerelazioni che Regioni, Province, Comuni e altri enti locali stabilisconocon imprese di trasporto pubbliche e/o private cui si affida l’eserciziodi qualsiasi servizio di trasporto pubblico, scegliendo di recepire leindicazioni espresse nei regolamenti (CEE) 1191/69 e 1839/91;
g) obbligo di perseguire nei contratti di servizio un progressivo incre-mento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi, che dovràessere pari almeno al 35%;
h) subentro delle Regioni allo Stato nel rapporto con Trenitalia per lastipulazione e amministrazione dei contatti di servizio per i serviziferroviari di interesse regionale e locale;
i) introduzione di forme concorrenziali (gare europee) di affidamentodi qualsiasi servizio di trasporto pubblico locale e regionale adimprese di trasporto pubbliche e/o private;
l) obbligo delle Regioni e degli enti locali di attuare, la trasformazionedelle aziende speciali e dei consorzi in società di capitali ovvero incooperative a responsabilità limitata;
m)possibilità per le Regioni di prevedere un periodo transitorio da con-cludersi comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale viè la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti dei servizi alle aziende eimprese attuali concessionarie.
Nella legge nazionale di riforma tuttavia non vi è un esplicito rife-rimento alla costituzione di agenzie per la mobilità, la cui definizione èstata lasciata alla volontà del legislatore regionale, o anche all’iniziativaamministrativa degli enti locali.
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Europa e in Italia
28
Nei fatti solo alcune leggi regionali hanno previsto la presenza diagenzie per la mobilità e non è detto che a tale obbligo sia seguita lacostituzione di tali organizzazioni. In altri casi, invece, anche se la leggeregionale non prevede esplicitamente le agenzie, alcune Province o, piùspesso alcuni Comuni, hanno deciso comunque di costituire una orga-nizzazione per regolare, gestire o amministrare alcuni servizi relativi alsistema di trasporto pubblico e mobilità del loro territorio. Le Regioniche hanno previsto una agenzia per la mobilità sono tutto sommatopoche, solo 5 su 15 a statuto ordinario: Regione Abruzzo con la L.R.n°152 del 23/12/98; Regione Campania con la L.R. 13/3/2002; RegioneEmilia Romagna con la L.R. n°30 del 2/10/98; Regione Lazio con la L.R.n°30 del 16/7/98; Regione Piemonte con L.R. n°1 del 4/1/2000.
L’agenzia regionale della Regione AbruzzoLa legge regionale della Regione Abruzzo (legge 23 12 1998
n°152) prevede una agenzia regionale per la mobilità all’art. 25.Art. 251. Al fine di monitorare la mobilità regionale, l’offerta e la domanda di
trasporto e le relative reti di infrastruttura, la qualità e il livello deiservizi prodotti, l’efficienza e l’efficacia nella produzione degli stessida parte delle aziende, è istituita con apposita legge regionale, pressoil Settore trasporti della Regione Abruzzo, l’agenzia per la mobilità.
2. Per il raggiungimento dei fini su indicati l’agenzia si avvarrà delsistema informativo regionale. Nell’ambito dell’agenzia verrà costitui-to il Comitato regionale per la mobilità di cui faranno parte leOO.SS., le organizzazioni imprenditoriali del settore e le associazionidei consumatori.
In Abruzzo dunque si prevede che l’agenzia regionale sia istituitasuccessivamente con un ulteriore intervento del legislatore, e che essasia organizzata all’interno del settore trasporti dell’amministrazioneregionale.
L’agenzia regionale e le agenzie territoriali della Regione CampaniaLa legge regionale della Regione Campania (legge 13 marzo 2002
n°3) prevede sia la costituzione di una agenzia per la mobilità sostenibi-le regionale all’art. 21 e seguenti, sia la possibilità per le Province e per iComuni Capoluogo di Provincia di dotarsi essi stessi, secondo le moda-lità da loro ritenute più appropriate, di agenzie territoriali per la mobilitàsostenibile, (art. 28).Articolo 21 - Agenzia regionale per la mobilità sostenibile:
È istituita l’agenzia campana per la mobilità sostenibile, denominata
29
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
ACaM, ente dotato di personalità giuridica pubblica, nonché di auto-nomia gestionale, amministrativa, contabile, tecnica.
Articolo 22 - Funzioni dell’ACaM: 1. All’ACaM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e, ove
richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monito-
raggio del sistema dei trasporti mediante il Centro studi; b) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e
di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiunti-vi, integrati fra loro e con la mobilità privata;
c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi dicompetenza della Regione e, ove richiesto, degli enti locali;
d) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti diservizio;
e) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi everifica del rispetto della parità e dell’uguaglianza di trattamentodegli utenti;
f) definizione e gestione della politica tariffaria. 2. L’ACaM realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità,
del sistema della qualità dei servizi, del sistema di informazione allaclientela, e predispone una relazione annuale sull’andamento deiservizi di trasporto da trasmettere all’Assessorato ai Trasporti ed allaCommissione consiliare competente.
Articolo 28 Agenzie territoriali per la mobilità sostenibile 1. Le Province e i Comuni Capoluogo di Provincia possono istituire, con
l’eventuale cofinanziamento della Regione, per ciascun ambito terri-toriale provinciale o metropolitano, una agenzia per la mobilitàsostenibile e il trasporto pubblico locale di loro competenza.
2. L’agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali,ai sensi del titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267. LeProvince e i Comuni Capoluogo di Provincia possono identificaremodalità congiunte di organizzazione e gestione delle agenzie terri-toriali per la mobilità sostenibile al fine di favorire l’integrazione e ilmiglioramento dei servizi di propria reciproca competenza.
3. Alle agenzie territoriali sono demandate le funzioni di supporto aglienti locali nelle seguenti materie:a) gestione del processo di pianificazione degli investimenti;b) gestione della pianificazione dei servizi per la mobilità e di proget-
tazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, inte-grati fra loro e con la mobilità privata;
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Europa e in Italia
30
c) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi dicompetenza degli enti locali;
d) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti diservizio;
e) controllo vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi everifica del rispetto della parità e dell’uguaglianza di trattamentodegli utenti;
f) ogni altra funzione loro assegnata dagli enti locali, compatibil-mente con le norme previste dalla presente legge.
4. Ove non sia costituita l’agenzia territoriale, le Province e i ComuniCapoluogo di Provincia, d’intesa con la Regione, possono ricorrere alsupporto dell’ACaM.
In Campania, l’agenzia regionale per la mobilità sostenibile è isti-tuita con la stessa legge di riforma del trasporto pubblico locale, ma neifatti la sua operatività è condizionata dalla nomina del direttore dell’a-genzia da parte del Presidente della Giunta, su indicazione dell’Assesso-re ai trasporti. Il direttore, cui è affidata la responsabilità di organizzarel’agenzia è pertanto una diretta espressione della volontà politica dellaGiunta e decade con il venir meno della stessa.
L’agenzia si presenta come un’organizzazione dotata di autonomiarispetto all’amministrazione regionale, ma il suo compito è precisamentequello di supportare l’amministrazione regionale nella gestione e ammi-nistrazione dei processi di pianificazione degli investimenti, di program-mazione dei servizi, di gestione delle procedure di affidamento concor-suale e di controllo dell’erogazione e della qualità dei servizi. Nel casoin cui le Province ed i Comuni Capoluogo di Provincia non decidano dicostituire delle proprie agenzie territoriali, essi possono rivolgersi all’A-CaM che si articolerà su base territoriale per assistere gli enti locali neiprocessi relativi alla amministrazione e programmazione delle funzioniad essi delegate dalla legge regionale in tema di trasporto pubblicolocale.
Le Province ed i Comuni Capoluogo possono costituire a loro vol-ta, con l’eventuale cofinanziamento della Regione, delle agenzie territo-riali, ma la legislazione regionale lascia loro completa libertà in meritoalla scelta delle modalità con cui istituirle e alle funzioni da trasferirgli.
L’agenzia regionale e le agenzie locali della Regione Emilia RomagnaLa legge regionale n°30/98 dell’Emilia Romagna prevede sia la
costituzione dell’agenzia regionale della mobilità sia la costituzione daparte di Province e Comuni di agenzie locali della mobilità.
31
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
Articolo 18 Agenzia per il trasporto pubblico regionale e locale1. In applicazione della presente legge la Regione può istituire un’agen-
zia regionale, dotata di autonomia organizzativa, a cui affidare iseguenti compiti: a) svolgimento delle procedure concorsuali per l’affidamento della
gestione della rete e del servizio di trasporto pubblico regionale elocale, con esclusione dell’aggiudicazione;
b) monitoraggio sui contenuti e sull’attuazione dei contratti di servi-zio e degli accordi di programma;
c) monitoraggio e valutazione comparativa della qualita’ dei servizidi trasporto pubblico regionale e locale;
d) collaborare con l’Osservatorio regionale per la Sicurezza stradale; e) gestione e sviluppo di un sistema informativo accessibile e coordi-
nato con quello regionale e degli enti locali nelle materie riguar-danti i compiti ad essa attribuiti;
f) ogni altra funzione ad essa affidata ai sensi della presente legge edelle disposizioni attuative della stessa.
2. La Giunta regionale definisce il limite di spesa per l’organico, nonchéla struttura organizzativa dell’agenzia.
3. Le funzioni di direttore dell’agenzia sono svolte da un dirigente regiona-le, anche assunto ai sensi dell’art. 24 della L.R. 19 novembre 1992, n°41.
4. Per l’esercizio di funzioni progettuali, di studio e di ricerca l’agenziapuò stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazio-ne coordinata e continuativa. Può altresì stipulare convenzioni consocietà, enti qualificati e Università per l’espletamento di particolariservizi.
5. Il direttore dell’agenzia stipula i contratti e le convenzioni di cui alcomma 4 secondo le modalità e il limite massimo di spesa fissati dallaGiunta regionale con apposita direttiva.
Articolo 19 Agenzie locali per la mobilità e il trasporto pubblico locale1. Le Province e i Comuni possono costituire, per ciascun ambito territo-
riale provinciale o metropolitano, una agenzia locale per la mobilitàe il trasporto pubblico locale di loro competenza.
2. L’agenzia è costituita nei modi e nelle forme stabilite dagli enti locali.Essa può essere costituita anche a seguito di scissione dei Consorziper l’esercizio del trasporto pubblico locale operanti alla data dientrata in vigore della presente legge.
3. L’agenzia esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisionidegli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazio-ne di settore, con particolare riguardo ai seguenti compiti:
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Europa e in Italia
32
a) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblicidi trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata;
b) progettazione e organizzazione dei servizi complementari per lamobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all’ac-cesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informa-zione e controllo;
c) gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi; d) controllo dell’attuazione dei contratti di servizio; e) ogni altra funzione assegnata dagli enti locali con esclusione della
programmazione e della gestione di servizi autofilotranviari. 4. L’agenzia può intervenire negli accordi di programma di cui all’art.
12 e nei contratti di servizio in relazione alle specifiche funzioni adessa attribuite dagli enti locali.
5. Ove non sia costituita l’agenzia locale, le Province e i Comuni, d’inte-sa con la Regione, possono affidare, con onere a carico degli entilocali, le procedure concorsuali di cui al comma 3, lett. c) all’agenziaprevista dall’art. 18. In tal caso restano nella piena responsabilitàdegli enti locali l’atto di affidamento, la stipula del contratto di servi-zio e ogni connessa funzione di controllo.
In Emilia Romagna, diversamente dalla Campania, all’agenziaregionale sono affidati compiti e responsabilità dei processi di ammini-strazione e gestione del sistema di trasporto regionale e locale. Adesempio, l’agenzia stipula in prima persona i contratti di servizio con leimprese ferroviarie regionali e con Trenitalia. Tuttavia, le funzioni didirettore sono affidate ad un dirigente regionale, soluzione questa chericonduce l’agenzia l’interno della struttura organizzativa dell’ammini-strazione regionale preesistente.
Anche alle Province ed ai Comuni (non solo a quelli Capoluogo)la legislazione regionale suggerisce la costituzione di agenzie locali perla mobilità, magari all’interno di un processo di ristrutturazione delleaziende e dei consorzi responsabili dei servizi. Eventualmente gli entilocali possono ricorrere al supporto dell’agenzia regionale per l’espleta-mento delle procedure di affidamento concorsuale dei servizi, a frontedi un pagamento di un corrispettivo per i servizi acquisiti.
L’agenzia regionale della Regione Lazio AREMOLCon la legge 16 luglio 1998 n°30 la Regione Lazio si obbliga ad
istituire entro sei mesi una agenzia regionale per la mobilità, comeespresso dall’art. 27 comma 3, ma le modalità di organizzazione, i com-piti e le funzioni dovranno essere dunque stabiliti successivamente.
33
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
Art. 27 comma 3 Al fine di dotare la Regione e gli enti locali di un idoneo strumento disupporto tecnico-operativo per l’attività di programmazione e pianifica-zione del trasporto pubblico locale, entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, la Regione con apposito atto istituisce l’a-genzia regionale per la mobilità, che si può avvalere della collaborazio-ne del personale della Regione, degli enti locali e di esperti esterni. Conlo stesso atto vengono definite le competenze, le funzioni, la struttura e lemodalità di funzionamento.
Nell’agosto del 2002 la Giunta regionale del Lazio ha approvatouna proposta di disegno di legge per l’istituzione dell’agenzia regionaledella mobilità (AREMOL). L’agenzia si occuperà della definizione e del-l’attuazione della attività di pianificazione e programmazione del tra-sporto pubblico locale. In particolare dovrà elaborare studi e monitorag-gi per l’analisi dell’evoluzione delle reti dei servizi e delle infrastrutture,della qualità, del livello e dell’efficienza dei servizi erogati, della sicurez-za e dell’impatto del sistema della mobilità su territorio e ambiente. Saràresponsabilità dell’agenzia elaborare studi e ricerche per l’ottimizzazionedei finanziamenti, e progetti per armonizzare il traffico privato con il tra-sporto pubblico.
Nella proposta dell’assessore ai trasporti e ai lavori pubblici dellaRegione Lazio, l’agenzia svolgerà un ruolo di supporto alla Giunta, rap-presenterà un organismo flessibile e agile, in termini di struttura organiz-zativa.
Il Consorzio per la mobilità nell’ambito metropolitano torinese dellaRegione Piemonte
In Piemonte la legge regionale 4 gennaio 2000, n°1 prevede all’art.8 che si costituisca un’organizzazione per il coordinamento delle politi-che di mobilità dell’area metropolitana torinese.Art. 8 Consorzio per la mobilità nell’ambito metropolitano torinese1. Al fine di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito metropolita-
no torinese, la Regione insieme agli enti locali interessati, promuove,entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, aderendo-vi, la costituzione di un consorzio denominato Agenzia per la mobili-tà metropolitana.
2. Il consorzio gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materiadi trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano edin particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata delsistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programma-
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Europa e in Italia
34
zione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale dicompetenza degli enti aderenti relative all’ambito metropolitano.
3. Al fine di assicurare la concorrenza, i servizi extraurbani su gommadell’ambito metropolitano sono appaltati per aree omogenee. I servizitotalmente compresi nei confini dell’area della conurbazione di Tori-no possono essere suddivisi in più lotti ove ciò sia opportuno pergarantire l’economicità, l’efficienza e la qualità del servizio.
4. Gli enti aderenti possono esercitare attraverso il consorzio ulteriorifunzioni di propria competenza in materia di mobilità.
5. La convenzione e lo statuto del consorzio disciplinano, in particolare,gli organi e le relative competenze, i rapporti tra gli enti aderenti alconsorzio, la quota di partecipazione dei medesimi in funzione deiservizi conferiti, le risorse finanziarie e la dotazione organica delpersonale ed ogni altro aspetto necessario.
La legislazione piemontese dunque prevede la costituzione di unconsorzio cui il Comune di Torino e gli altri enti locali deleghinoresponsabilità e funzioni in tema di trasporto. Gli stessi enti assumeran-no di conseguenza il ruolo di soci del consorzio. All’agenzia si assegnail compito di coordinare le politiche di mobilità nell’ambito metropolita-no torinese. In particolare, le viene delegata la responsabilità di attivarei procedimenti di affidamento concorsuale dei servizi dal 2004. Ulterioricompiti sono la pianificazione delle strategie di sviluppo del sistemadella mobilità, la programmazione degli investimenti nelle infrastrutture,nel materiale rotabile e nelle tecnologie di controllo, la programmazionedei livelli qualitativi e quantitativi del servizio, l’amministrazione delletariffe, dei finanziamenti agli enti consorziati, la stipulazione del contratticon le imprese affidatarie dei servizi, la comunicazione con i cittadini.
Nel luglio del 2002 è stato siglato il protocollo d’intesa fra RegionePiemonte, Provincia e Comune di Torino per la nascita dell’agenzia perla mobilità metropolitana torinese. L’operatività dell’agenzia è allo statoattuale subordinata all’approvazione di un apposita legge regionale chene disciplini il funzionamento. Nella fase attuale si prevede che l’agen-zia abbia la forma giuridica di consorzio con le seguenti quote di parte-cipazione: 38% regione Piemonte, 37% Comune di Torino, 12,5% pro-vincia di Torino, 12,5% altri comuni della provincia di Torino.
Le Agenzie operative in ItaliaNonostante gli obblighi e le scadenze individuate dalle diverse
legislazioni regionali, non tutte le agenzie previste sono state costituite.Allo stato attuale le Agenzie previste dalla normativa regionale in Abruz-
35
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
zo, Campania, Piemonte e Lazio non risultano essere ancora operative.Al contempo, tuttavia, alcuni enti locali, anche in assenza di una
esplicita previsione o indicazione da parte della legislazione regionale,hanno sviluppato proprie agenzie per il trasporto e la mobilità. In parti-colare al momento di conclusione dello studio (giugno 2002) le agenzieoperative in Italia risultano essere:•Agenzia Trasporti Pubblici Emilia Romagna;•Consorzio ATR, agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale
di Forlì-Cesena;•Consorzio TRAM (Trasporti Riuniti Area Metropolitana) Agenzia di
Rimini;•Consorzio ACAP, agenzia locale per la mobilità e i trasporti pubblici di
Piacenza;•Consorzio ACT, agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico
locale di Reggio Emilia;•Società per la mobilità e il trasporto pubblico S.p.a, agenzia per la
mobilità e il trasporto pubblico locale di Parma;•STA-ATAC S.p.a., agenzia del trasporto pubblico locale per la città di
Roma;•Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente S.r.l., agenzia del Comune di
Milano.È da evidenziare che il comune di Genova intende sviluppare una
Autorità che eserciti compiti di controllo e regolazione del mercato deiservizi di trasporto locale. Compito essenziale dell’Autorità è infatti rego-lare i rapporti tra Comune, utenti e azienda di erogazione del servizio,garantendo la qualità del servizio per gli utenti, soprattutto in riferimen-to alle frequenze e agli orari. L’Autorità è poi incaricata di fornire parerie consulenze al Comune, a cui spetta il compito di redigere il bando e ilcapitolato d’appalto per l’affidamento dei servizi secondo procedureconcorsuali. Dato l’avvio recente del progetto di Genova non sonoancora disponibili dati e informazioni relativi all’assetto dell’Autorità.
Il confronto fra le agenzie per il trasporto e la mobilitàLo studio sviluppato dal Cesit ha effettuato un’analisi e un con-
fronto fra le seguenti agenzie già operative:•Agenzia Trasporti Pubblici Emilia Romagna; •Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Forlì-Cesena;•Agenzia TRAM (Trasporti Riuniti Area Metropolitana) di Rimini;•STA-ATAC S.p.a. Agenzia del trasporto pubblico locale per la città di
Roma;
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Europa e in Italia
36
•Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente.Tali agenzie rappresentano le organizzazioni caratterizzate da un
maggior grado di operatività, anche se non in tutti casi il loro assetto haraggiunto la configurazione finale e definitiva. Le altre agenzie presentiin Emilia Romagna (Piacenza, Reggio Emilia, Modena) sono apparsesimili dal punto di vista del modello e delle funzioni a quelle di Rimini edi Forlì Cesena. La loro valutazione si è concentrata dunque solo sualcuni aspetti peculiari e/o particolarmente interessanti.
Il confronto fra i modelli di agenzia sviluppati ha inteso evidenzia-re il ruolo svolto da ciascuna agenzia all’interno del sistema di mobilitàdi riferimento. Le agenzie si differenziano in primo luogo in termini diarea territoriale di competenza: la regione per l’agenzia regionale dell’E-milia Romagna, la provincia per le agenzie di Rimini e di Forlì Cesena,l’area metropolitana per l’agenzia di Roma e l’agenzia di Milano. Tutta-via, occorre anche distinguere le funzioni ed il ruolo che sono stati affi-dati a ciascuna agenzia all’interno del sistema di mobilità. Sono statiindividuati a tal proposito alcuni processi critici del sistema di trasportoregionale e locale, e si è valutato quali siano le responsabilità attribuitea ciascuna agenzia in riferimento a ciascun processo, in coerenza almodello di regolazione, amministrazione, gestione e controllo del siste-ma di trasporto e di mobilità previsto dalle normative nazionali e regio-nali di riferimento. In particolare i processi critici osservati sono stati iseguenti.•Pianificazione degli investimenti: si intende il processo di elaborazione
dei piani generali trasporti di competenza regionale, provinciale,comunale; il risultato di tale processo è la identificazione degli investi-menti in infrastrutture e veicoli per il trasporto e la mobilità regionalee locale.
•Gestione del finanziamento per investimenti: si intende il complessodelle attività da svolgere per individuare, raccogliere, allocare e trasfe-rire i fondi necessari per attuare gli investimenti previsti dai pianigenerali elaborati dal processo precedente.
•Controllo dell’attuazione degli investimenti: si intende l’insieme delleattività da svolgere per verificare, valutare e controllare che i progettidi investimento siano eseguiti in coerenza ai piani approvati e finan-ziati.
•Gestione del finanziamento per i servizi minimi: si intende l’insiemedella attività per allocare e amministrare le risorse finanziare da corri-
37
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
spondere alle imprese affidatarie per erogazione dei servizi minimi sta-biliti nei contratti di servizio.
•Programmazione dei servizi minimi: si intende il complesso delle atti-vità da svolgersi per la programmazione triennale dei servizi minimiprevista dalla normativa nazionale (D.L. 422 del 1997; D.L. 400 del1999).
•Definizione delle tariffe e gestione del sistema tariffario integrato: siintende il complesso delle attività di pianificazione, gestione e svilup-po di un sistema di tariffazione integrata per il trasporto regionale elocale.
•Affidamento e gestione delle gare per i servizi minimi: si intende ilcomplesso delle attività di amministrazione e gestione delle proceduredi affidamento concorsuale dei servizi, da realizzarsi in coerenza conla normativa nazionale (D.L. 422 del 1997; D.L. 400 del 1999).
•Stipulazione del contratto di servizio: si intende il complesso di attivitàe di responsabilità che afferiscono al soggetto che firma i contratti diservizio con le imprese affidatarie dei servizi o della gestione delle reti.
•Gestione dei ricavi commerciali: si intende l’insieme delle attività diemissione e vendita dei titoli di viaggio e di riscossione dei ricavi datraffico.
•Proprietà degli asset: si intende l’insieme dei diritti relativi alla proprie-tà delle infrastrutture, dei veicoli e degli impianti dei sistemi regionalie locali di trasporto e di mobilità.
•Affidamento della gestione delle infrastrutture: si intende il complessodelle attività di amministrazione e gestione delle procedure di affida-mento concorsuale della gestione delle reti e degli impianti.
•Monitoraggio e controllo dell’attuazione dei contratti di servizio: siintende il complesso delle attività da svolgere per monitorare che leimprese affidatarie dei servizi o responsabili della gestione delle retirispettino gli obblighi assunti con i contratti di servizi.
•Monitoraggio e controllo della qualità percepita dai clienti: si intendel’insieme delle attività da svolgersi per verificare e valutare la qualitàdel servizio percepita dai cittadini clienti dei servizi di trasporto.
•Gestione delle banche dati: si intende il complesso di attività necessa-rie per costruire, gestire e sviluppare i sistemi informativi per la raccol-ta, elaborazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazionisul sistema della mobilità e di trasporto.
•Altri servizi per la mobilità: rientrano in tale categoria tutti i servizi dimobilità diversi dai servizi di trasporto e gestione delle infrastrutture,
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Europa e in Italia
38
quali ad esempio la gestione della sosta, dei parcheggi, centri di infor-mazione al pubblico, attività di formazione, ecc.
Nel prosieguo del lavoro saranno sintetizzate le modalità con cuinelle Regioni oggetto di indagine si svolgono tali processi, e si eviden-zierà in tal modo il ruolo e le funzioni che eventualmente in tali proces-si sono assegnate alle agenzie per la mobilità operative sul territorioregionale.
L’ORGANIZZAZIONE DELLE AGENZIE PER LA MOBILITÀ IN EMILIA ROMAGNAQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
Il sistema di mobilità in Emilia Romagna
Tav. 1 Il sistema di mobilità dell’Emilia Romagna
È possibile evidenziare i principali attori che compongono il siste-ma di trasporto regionale dell’Emilia Romagna, in coerenza con ilmodello scaturito dalla legge regionale n°30/98 di riforma del trasportolocale. La legge in particolare ha stabilito:•la separazione tra amministrazione e gestione dei servizi di trasporto;•la competenza della Regione in tema di sistemi di trasporto ferroviari;•la delega agli Enti locali (Province) della responsabilità amministrativa
relativa ai sistemi di trasporto autofilotranviari;•la costituzione dell’Agenzia Regionale Trasporti Pubblici;•la possibilità per le Province di costituire un’Agenzia di Trasporti per
ogni bacino provinciale.Ne è conseguito che il sistema è composta dai seguenti attori:
•la Regione, con compiti di indirizzo, pianificazione, programmazione eamministrazione;
•l’Agenzia Regionale, con precise responsabilità in tema di trasportoferroviario;
•Trenitalia S.p.a., responsabile dei servizi di trasporto ferroviario erogatia seguito di contratto di servizio stipulato con l’agenzia regionale;
di MARCELLO MARTINEZ
39
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Emilia Romagna
40
•quattro operatori che gestiscono ferrovie locali (FER, ACT, ATCM eATC), titolari di contratti di servizio stipulati con l’agenzia regionale;
•le Province e i Comuni responsabili della pianificazione programma-zione e amministrazione dei servizi autofilotranviari;
•le Agenzie Provinciali, con precise responsabilità in tema di serviziautofilotranviari;
•le imprese affidatarie di servizi autofilotranviari nei vari bacini pro-vinciali.
È bene evidenziare che a livello provinciale alcuni consorzi cheprima della riforma gestivano i servizi di trasporto in regime di affida-mento diretto si sono trasformati in agenzie per la mobilità, e che sonostati costituiti nuovi soggetti deputati a gestire il servizio, sotto forma disocietà di capitali. Le scelte in termini di proprietà dei veicoli e delleinfrastrutture sono differenti nelle varie realtà locali. In particolare, nelsistema di trasporto regionale dell’Emilia Romagna sono apparse esem-plificative di diversi modelli e realtà tre soluzioni su cui si è concentratal’indagine:•Agenzia Regionale Trasporti Pubblici;•Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale di Forlì-Cesena;•Agenzia TRAM (Trasporti Riuniti Area Metropolitana) di Rimini.
Va evidenziato inoltre che anche alcune delle altre province han-no in corso la costituzione di Agenzie locali per la mobilità: Parma,Società per la mobilità e il trasporto pubblico S.p.a.; Reggio Emilia, Con-sorzio ACT; Modena, Consorzio ATCM.
Le imprese di trasporto e di gestione dell’infrastrutturaLe imprese ferroviarie attualmente presenti nel sistema di mobilità
della regione Emilia Romagna rappresentano il risultato di un processodi evoluzione e trasformazione degli operatori presenti prima della rifor-me e del trasferimento degli asset ferroviari dallo Stato alla Regione,come previsto dal D.L. 400 del 1999.
La società RFI controlla in Emilia Romagna una rete ferroviaria dicirca 1.000 km di linea. Trenitalia fornisce su questa rete circa 12,1milioni di treni-km con un contratto di servizio a fronte del quale laRegione eroga un corrispettivo annuo pari 64 milioni di euro.
La FER (Società Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.) rappresenta il pri-mo nucleo del soggetto unitario di gestione delle ferrovie non affidate aTrenitalia che è stato previsto dal PRIT (Piano Regionale Trasporti) 98-2010. In essa è confluita la gestione di tutti i trasporti esercitati sulle 4linee di Gestioni Commissariali Governative operanti nel territorio regio-
41
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
nale. Le quote di tale società sono allo stato attuale di totale proprietàdella Regione.
La rete ferroviaria regionale complessiva è pari a 350 km e laRegione finanzia con circa 33,5 milioni di euro 2 milioni di treni-km.
Le altre ferrovie locali di minore rilevanza sono gestite dalle socie-tà di trasporto delle province in cui sono ubicate: ACT di Reggio Emilia,ATCM di Modena, ATC di Bologna.
Le imprese di trasporto su gomma a livello provinciale sono socie-tà costituite per trasformazione delle aziende speciali, con capitale con-trollato dagli enti che in precedenza costituivano il consorzio di gestionediretta del servizio, o in alcuni casi (come Reggio Emilia, Rimini e Forlì)direttamente dall’agenzia provinciale. Le agenzie provinciali per la mobi-lità (ove costituite) o le Province applicano contratti di servizio grosscost con gli esercenti del trasporto su gomma.
Nel complesso l’ammontare delle vetture-km erogate nelle provin-ce dell’Emilia Romagna è pari a 107 milioni, a fronte di 192 milioni dieuro annui di contributi regionali. Le vetture-km offerte dalle 9 aziendeprovinciali sono riportate nella tavola seguente:
Tav. 2 L’offerta di trasporto provinciale in Emilia Romagna
Il sistema di tariffazione integrata STIMER di Gianluigi Mangia
Mediante l’acronimo STIMER si indica il Sistema Tariffario Integra-to Magnetico - zona Emilia Romagna. Lo sviluppo dell’area di integrazio-ne STIMER ha attraversato fasi e momenti diversi. Il procedimento direalizzazione del sistema STIMER ha inizio nel 1987; nel quinquenniosuccessivo, fino al 1991, furono, infatti, effettuati i primi studi prelimina-ri sulla riforma tariffaria. Nei successivi cinque anni (1992 - 1997) si pas-sò alla fase di progettazione esecutiva, ed alla realizzazione ed attuazio-ne del progetto di integrazione all’interno dell’area territoriale rappre-sentata dal bacino del Comune di Modena. Tra il 1998 ed il 2001 vi èstata la programmazione definitiva del sistema di integrazione esteso
Vetture-km (in milioni)ATC Bologna 35,4ACT Reggio Emilia 11E-bus-Setram Forlì Cesena 8,4TRAM servizi Rimini 7,3ATCM Modena 12,7ACFT Ferrara 10,1ATM Ravenna 5TEP Parma 12,1TEMPI Piacenza 7,5
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
all’intero territorio regionale. Nel corso del 2002, l’obiettivo è stato quel-lo di realizzare ed implementare il sistema in tutta l’area geografica diriferimento. Nel 2003 si punta, invece, alla introduzione del titolo diviaggio integrato STIMER.
Inizialmente, il progetto STIMER è stato implementato all’interodell’area territoriale del Comune di Modena, che rappresenta con i pro-pri 625.000 abitanti circa il 16% del totale complessivo della popolazio-ne della Regione Emilia Romagna. L’ente regionale nello sviluppo delprogetto STIREM ha stabilito dall’inizio un sistema di relazioni di colla-borazioni con le imprese di trasporto pubblico locale: conseguentemen-te, un ruolo chiave nell’implementazione del presente progetto è statoaffidato all’azienda operante nell’area di Modena, il consorzio ATCM.
I soggetti (sia operatori sia agenzie) interni al sistema di integra-zione STIMER sono i seguenti: Tempi S.p.a. - Piacenza; TEP S.p.a. - Par-ma; Agenzia ACT - Reggio Emilia; ATCM S.p.a. - Modena; ATC S.p.a. -Bologna; ACFT S.p.a. - Ferrara; ATM S.p.a. - Ravenna; Agenzia ATR -Forlì e Cesena; Agenzia TRAM - Rimini; Vettori privati della RER; FerS.r.l.; Trenitalia S.p.a.
Nel corso del 1999, nel caso del servizio autofilotranviario, glioperatori integrati hanno garantito 107 milioni di bus-km; 234 milioni diviaggiatori; 3.000 autobus e 5.500 addetti.
Nel caso del servizio ferroviario, gli operatori integrati hannogarantito, su 1.400 km di rete ferroviaria di cui 1000 gestiti da Trenitaliae 242 stazioni ferroviarie di cui 140 di Trenitalia, 900 treni passeggeri algiorno di cui 450 a contributo di servizio Trenitalia.
Mediante la realizzazione del progetto STIREM, la Regione EmiliaRomagna ha voluto perseguire alcuni principali obiettivi: •una forte forma di integrazione modale tra i sistemi di trasporto urba-
no extra-urbano e servizi ferroviari regionali; •semplicità, trasparenza e flessibilità della struttura tariffaria; •innovazione tecnologica; •un più agevole accesso mediante l’adozione di standard della moneti-
ca attraverso un’integrazione con servizi diversi, tra cui quelli bancari.Il criterio di organizzazione dell’area di integrazione è a carattere
zonale. Infatti, il sistema STIMER prevede l’abbandono del vecchio siste-ma di scaglionamento chilometrico e della divisione tra servizi urbani eservizi extraurbani. Il criterio zonale significa l’articolazione dell’area diintegrazione in zone definite al cui interno il viaggiatore viene trattatoattraverso l’applicazione di una regola fissa: qualsiasi spostamento all’in-terno della medesima zona e nel rispetto di predefinito limite temporale
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Emilia Romagna
42
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
43
di validità del titolo di viaggio, comporta l’applicazione della medesimatariffa in maniera completamente svincolata dalla modalità di trasportoprescelta. Il passaggio da una zona ad un’altra implica il progressivoincremento tariffario. Si realizza quindi, il superamento dei principi cheregolano il funzionamento del precedente sistema di tariffazione, secon-do il quale il prezzo dei titoli di viaggio variava secondo un modello dicerchi concentrici (che equivalgono a scaglioni chilometrici) in relazioneall’origine del viaggio.
La realizzazione del sistema integrato STIMER significa anche l’in-troduzione dell’innovazione tecnologica rappresentata da titoli di viag-gio elettronici a microchip, idonei ad essere registrati, annullati e memo-rizzati dagli appositi dispositivi elettronici, previsti a bordo dei mezzi ditrasporto in dotazione ai vettori integrati, nonché presso tutte le stazioniferroviarie che rientrano nell’area di integrazione. L’impianto del sistemadi tariffazione si centra su alcuni titoli di viaggio principali.
Biglietto di corsa sempliceSi tratta di un biglietto cartaceo a banda magnetica, che ha una
validità zonale, autorizzando il viaggiatore anche all’utilizzo combinatodi differenti mezzi di trasporto. Il biglietto di corsa semplice ha una vali-dità temporale predeterminata, che è parametrata al numero di zone daattraversare. Al viaggiatore si chiede di obliterare il titolo di viaggio, almomento di salire in vettura ed anche ogni qual volta decida di cambia-re mezzo. La tariffa è calcolata come sommatoria di una quota fissa “A”,definita come prezzo base da pagare per accedere alla zona con qual-siasi mezzo di trasporto, e di una quota variabile (B x n) dove “B” rap-presenta un incremento tariffario fisso e “n” il numero di confini zonaliattraversati.
Carta valore ordinariaSi tratta di una carta magnetica prepagata in plastica a carattere
pluriennale. Sono disponibili carte valore ordinarie di importi diversipredefiniti. Tali titoli di viaggio hanno valore sull’intera rete compresaall’interno dell’area di integrazione tariffaria. Ad ogni viaggio il viaggia-tore indica la propria destinazione e l’importo corrispondente vienedecurtato dal valore globale della carta al momento della obliterazione.La carta può essere ricaricata e utilizzata da più persone contempora-neamente.
Carta valore per abbonatiAl pari della carta valore ordinaria, anche la carta valore per abbo-
nati è una carta magnetica, prepagata e ricaricabile, a validità plurienna-le. Tale titolo di viaggio ha validità limitata ad un percorso delimitato da
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
una origine e da una destinazione predeterminate. La procedura diaddebito dell’importo corrispondente al viaggio effettuato segue le rego-le descritte nel caso della carta valore ordinaria; la principale differenzariguarda il fatto che l’incremento del numero dei viaggi determina unariduzione della tariffa applicata. Tale regime di sconti si estende perdodici mesi a partire dalla prima obliterazione. La carta valore per abbo-nati impersonale può essere ceduta ad altri utilizzatori. Può essere utiliz-zata per più di un viaggio nella stessa occasione di viaggio. È previstauna particolare variante di queste carte per le categorie protette.
L’Agenzia Regionale Trasporti PubbliciL’agenzia è stata creata mediante atto della Giunta regionale nel
marzo 2001 ed è interna all’Amministrazione regionale, in particolaredipende, in quanto ufficio amministrativo, dall’Assessorato ai trasportidella Regione. Le risorse di funzionamento provengono dal bilancioregionale e le funzioni di Direttore dell’agenzia sono svolte da un diri-gente regionale.
L’organico dell’agenzia comprende 30 dipendenti, di cui 4 conqualifica dirigenziale. Venti dipendenti sono laureati, con una prevalen-za di lauree tecniche. La modalità di reclutamento è quella dei concorsipubblici. La possibilità di ricorrere a contratti di outsourcing consentecomunque all’agenzia di ricevere supporto esterno qualificato.
L’organigramma dell’agenzia prevede alcune funzioni in posizionedi staff, e due divisioni specializzate per ambito di attività: divisione fer-rovie e divisione mobilità urbana e trasporto pubblico locale.
Tav. 3 La struttura organizzativa dell’agenzia regionale
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Emilia Romagna
44
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
45
Tav. 4 La struttura della Divisione Mobilità Urbana
Tav. 5 La struttura della Divisione Ferrovie
Il ruolo e la responsabilità dell’Agenzia Regionale Trasporti pub-blici possono essere specificati illustrando le modalità di svolgimentodei processi critici per la regolazione amministrazione, gestione econtrollo del sistema di trasporto e di mobilità della Regione EmiliaRomagna.
Pianificazione degli investimentiIn Emilia Romagna, la Regione programma le reti di infrastrutture
e i servizi relativi alla mobilità delle persone e delle merci ed il trasportopubblico regionale e locale con il concorso degli Enti locali e tenendoconto della loro programmazione ed in particolare dei piani di bacinopredisposti dalle Province.
La Regione poi stipula Accordi di Programma con lo Stato edeventualmente altre Regioni interessate per definire le opere da realizza-re e i mezzi di trasporto da acquisire, i tempi di realizzazione, i soggetticoinvolti e i loro compiti, le risorse necessarie, le fonti di finanziamentoe i tempi di erogazione.
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
Il ruolo dell’agenzia è quindi solo di supporto, ed in genere diassistenza alla Giunta regionale nella definizione degli Accordi di Pro-gramma con il Governo nazionale.
Gestione del finanziamento per investimentiL’agenzia regionale amministra direttamente il finanziamento degli
investimenti relativi ai beni e alle infrastrutture ferroviarie, in concorsocon il Demanio regionale.
Il finanziamento degli investimenti per i servizi autofilotranviaritransita invece per gli Accordi di Programma stipulati tra agenzia regio-nale, enti locali (Province e Comuni) e agenzie provinciali, ove costitui-te. L’agenzia regionale gestisce l’assegnazione dei contributi ed elaboraproposte di criteri per la valutazione degli investimenti da inserire negliAccordi di Programma. Il flusso di finanziamenti viene poi gestito dalleagenzie provinciali, o, in mancanza, dalle Province.
Controllo dell’attuazione degli investimentiL’agenzia regionale esercita il controllo sugli investimenti realizza-
ti, sia per quanto riguarda quelli relativi al settore ferroviario, sia perquelli relativi al settore autofilotranviario.
Programmazione dei servizi minimiLa legislazione dell’Emilia Romagna prevede che il Consiglio
regionale adotti, con cadenza triennale, un atto di indirizzo generale inmateria di programmazione e amministrazione del trasporto pubblicoregionale e locale, in attuazione del PRIT.
L’atto di indirizzo contiene la definizione dei principi per la deter-minazione dei servizi minimi, tenendo conto degli standard di qualità equantità definiti nel PRIT e dell’ammontare complessivo di risorse regio-nali erogabili a fronte degli obblighi di servizio pubblico.
L’agenzia regionale interviene quindi come supporto tecnico perla Giunta regionale impegnata nell’attuazione dell’atto di indirizzo delConsiglio.
Per quanto riguarda poi i servizi minimi ferroviari, gli Accordi diProgramma Stato-Regione contemplano un periodo sperimentale di treanni (2001-2003), caratterizzato da programmi di esercizio ben definiti, afronte delle risorse trasferite dal Governo alla Regione. L’agenzia regio-nale è dunque responsabile della programmazione degli orari dei serviziferroviari, in rapporto con gli esercenti, ma con i vincoli determinatidagli Accordi di Programma.
Per i servizi di trasporto autofilotranviario, invece, la programma-zione dei servizi minimi è stata delegata dalla Regione agli enti locali
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Emilia Romagna
46
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
47
(Province e Comuni), che a loro volta l’hanno attribuita alle agenzieprovinciali per la mobilità (ove costituite). Gli Accordi di Programmatriennali tra Regione, Province ed agenzie delimitano in valore l’ammon-tare dei servizi minimi, mediante l’ammontare dei contributi erogati. Intale processo è compito dell’agenzia regionale elaborare delle proposteper la definizione di criteri e parametri per la individuazione dei serviziminimi autofilotranviari.
Definizione tariffe e gestione sistema tariffario integratoIn Emilia Romagna la Giunta regionale stabilisce i criteri che rego-
lano il sistema tariffario, fissando le tipologie dei titoli di viaggio e pro-movendo l’integrazione tariffaria tra le modalità di trasporto. La regola-zione delle tariffe autofilotranviarie è invece di competenza di Provincee Comuni.
L’agenzia regionale ha seguito in particolare l’implementazione delprogetto STIMER, che prevede un sistema tariffario a zone, esteso a tut-to il territorio della regione, e l’impiego di titoli di viaggio elettronici amicrochip, con entrata in vigore prevista entro il 2002.
Affidamento e gestione delle gare per i servizi minimiL’agenzia regionale cura lo svolgimento delle procedure concor-
suali per l’affidamento dei servizi ferroviari, con l’obiettivo di affidaresecondo tale modalità tutti i servizi entro il 2003.
Le agenzie provinciali (o le Province, qualora le agenzie non sia-no state costituite) gestiscono invece gli affidamenti concorsuali dei ser-vizi autofilotranviari.
Stipulazione del contratto di servizioL’agenzia regionale quale ufficio della Regione stipula con Trenita-
lia un contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi ferroviari diinteresse regionale sulla rete R.F.I.
Nel caso delle ferrovie in concessione e di quelle in ex gestionecommissariale governativa, l’agenzia regionale stipula un contratto siaper la disciplina dell’affidamento della gestione delle reti (di proprietàregionale), sia per la gestione del servizio.
Infatti, la legge regionale prevede la possibilità che gli affidamentisiano separati, ma possano confluire sullo stesso soggetto nella fasetransitoria (che si conclude entro il 2003).
Gestione dei ricavi commerciali
L’agenzia regionale non gestisce direttamente i ricavi commerciali deiservizi di trasporto ferroviario.
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Emilia Romagna
48
Proprietà degli assetL’agenzia regionale non è direttamente proprietaria di infrastruttu-
re o veicoli. Gli asset delle imprese ferroviarie regionali sono affidati loro in
uso ma restano di proprietà regionale. A seguito dello svolgimento delle procedure concorsuali, si preve-
de che le infrastrutture resteranno di proprietà regionale e dunque com-prese nel patrimonio demaniale della Regione. Il costo degli investimen-ti ad esse relativo sarà coperto interamente con contributi pubblici.
Per investimenti in materiale rotabile e beni strumentali è previstoinvece un contributo pubblico fino a un massimo del 70%. Tali assetverranno quindi acquisiti dalle imprese affidatarie con obbligo di rever-sibilità nei confronti della Regione, fatto salvo il riscatto della quota nonammortizzata del 30% finanziata in proprio.
Affidamento della gestione delle infrastruttureLa gestione delle infrastrutture ferroviarie di proprietà regionale è
attualmente affidata alle imprese ferroviarie regionali mediante contrattodi programma, e sarà assegnata tramite meccanismo concorrenziale apartire dal 2004. L’agenzia regionale cura direttamente la gestione delprocesso di gara e l’affidamento.
Monitoraggio e controllo dell’attuazione del contratto di servizioL’agenzia regionale verifica l’adempimento dei contratti relativi ai
servizi ferroviari, sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quanti-tativo.
Monitoraggio e controllo della qualità percepita dai clientiL’agenzia regionale gestisce le rilevazioni sulla qualità percepita
dagli utenti del trasporto pubblico in ambito regionale, per migliorare epotenziare lo standard dei servizi resi ai viaggiatori.
Essa inoltre attiva strumenti per la gestione dei rapporti con l’uten-za ferroviaria, e sviluppa ed aggiorna l’Accordo Qualità tra Regione eTrenitalia.
Altri servizi per la mobilitàL’agenzia regionale svolge un’azione di coordinamento e confron-
to delle politiche di riqualificazione della mobilità urbana rispetto aduna rete di città europee.
Gestisce inoltre il sistema informativo dedicato al monitoraggiodella mobilità ferroviaria e autofiloviaria, nonché dei fattori economici,sociali ed ambientali ad essa più strettamente correlati.
Realizza l’aggiornamento delle banche dati relative allo stato di
49
attuazione degli investimenti, alla dotazione di materiale rotabile, ai datieconomici delle imprese, all’offerta di servizi in termine di percorrenze,all’andamento della vendita dei titoli di viaggio. Infine promuove edorganizza attività formative in materia di trasporti pubblici.
Il Consorzio ATR di Forlì e CesenaL’assetto del sistema di mobilità della provincia di Forlì e Cesena
si è definito a seguito della trasformazione del precedente Consorzio. Inparticolare sono state create le seguenti organizzazioni: •l’agenzia provinciale trasporti Forlì Cesena, denominata Consorzio
ATR;•E-bus, una S.p.a. controllata da ATR al 100% e responsabile per affida-
mento diretto fino al 2003 dell’erogazione del servizio nel bacino diForlì e Cesena per un totale di 6,4 milioni di bus-km;
•Setram S.r.l. società mista pubblico-privata formata da E-bus Cesena,Coerbus di Lugo e Cooperativa Trasporti di Riolo Terme (due soci pri-vati, scelti con un bando di gara) che gestisce in subconcessione 2,2milioni di bus-km.
Tav. 6 Le relazioni proprietarie a Forlì Cesena
L’Agenzia Provinciale Trasporti Forlì-Cesena è un Consorzio costi-tuito dalla Provincia di Forlì-Cesena più i 29 comuni del bacino.
Gli enti locali che lo costituiscono hanno deliberato di far assume-re al precedente Consorzio di produzione del servizio di trasporto fun-zioni di agenzia della mobilità.
Le quote di partecipazione sono state determinate nel tempo infunzione dei disavanzi che il Consorzio locale aveva accumulato per lagestione del trasporto pubblico per conto degli enti locali.
Gli addetti dell’agenzia sono circa 60, tutti ex addetti del Consor-
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
zio ATR: 30 addetti alla manutenzione, 15 alla sosta e 15 distribuiti frapianificazione, settore commerciale e staff. I laureati sono circa 10.
Al momento buona parte del personale che svolge il proprio lavo-ro nell’agenzia è ancora nella E.Bus, dato che quando la S.p.a. è statacostituita si è scelto di spostare tutto il personale del Consorzio nellaS.p.a. In agenzia sono attualmente già presenti il direttore generale e ilpersonale di due settori specifici: sosta e officina.
Si è tuttavia in procinto di trasferire ulteriore personale da E-Busall’agenzia. Per le assunzioni, l’agenzia è soggetta ad evidenza pubblicaper gli avvisi di selezione, ma non a concorso pubblico. L’organigrammadell’agenzia rispecchia un’articolazione per aree di business, con un’at-tribuzione a ciascuna funzione di un proprio budget.
Tav. 7 L’organizzazione dell’agenzia di Forlì Cesena
Il ruolo e la responsabilità dell’Agenzia Provinciale Trasporti Forlì-Cesena possono essere specificati illustrando le modalità di svolgimentodei processi critici per la regolazione amministrazione, gestione e con-trollo del sistema di trasporto e di mobilità della Provincia. Di seguitosaranno evidenziati in particolare i processi critici complementari a quel-li già illustrati in riferimento al ruolo dell’agenzia regionale.
Gestione del finanziamento per l’esercizio e gli investimentiL’agenzia provinciale gestisce nell’interesse degli enti consorziati
le risorse finanziarie e i contributi locali, regionali e statali per l’esercizio
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Emilia Romagna
50
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
51
dei servizi autofilotranviari, nonché le risorse erogate per gli investimen-ti e le relative infrastrutture.
Definizione tariffe e gestione del sistema tariffario integratoL’agenzia è responsabile della formulazione di proposte ed attua-
zione della politica tariffaria e della zonizzazione del territorio ai finitariffari. L’ATR controlla e attua il sistema di integrazione tariffaria dellaprovincia.
La programmazione dei servizi minimi L’agenzia è responsabile dell’attività di programmazione dei servizi
di trasporto su gomma nel suo bacino di riferimento.Alle imprese affidatarie viene assegnata il compito di erogare i ser-
vizi secondo quanto stabilito nei contratti gross cost aggiudicati.
Affidamento e gestione delle gare per i servizi minimiL’agenzia provinciale è attualmente responsabile per l’affidamento
concorsuale dei servizi non affidati direttamente ad E-Bus e Setram.Dal 2003 l’agenzia sarà responsabile dell’affidamento concorsuale
dei servizi minimi relativi a tutto il bacino di Forlì e Cesena.
Stipulazione dei contratti di servizio L’agenzia stipula contratti di servizio con le imprese responsabili
del servizio. Attualmente sono stati stipulati dall’agenzia contratti con 12imprese private che erogano servizi di trasporto nel territorio, e relativa-mente a 16 servizi di linea, con scadenza nel 2003. Fino a quella data ilcontratto di servizio che lega l’agenzia alle imprese responsabile del ser-vizio è di tipo gross cost. La durata del contratto di servizio affidatomediante procedure concorsuali è pari a tre anni.
La gestione dei ricavi commerciali L’agenzia ha mantenuto la gestione dei ricavi commerciali, coeren-
temente con l’applicazione dei contratti gross cost. La scelta si motivacon l’esigenza di facilitare, in prospettiva, l’integrazione fra le impreseaffidatarie dei diversi servizi. L’introduzione del biglietto unico emessodalla ATR nel 2002 ha consentito di integrare il sistema di trasportoextraurbano, e rappresenta il necessario presupposto per potere ancherealizzare e comunicare l’orario unico dei servizi di trasporto pubblicodella provincia.
Monitoraggio e controllo dell’attuazione del contratto di servizioL’agenzia è responsabile della verifica dell’attuazione dei contratti
di servizio e della loro corrispondenza agli standard di qualità stabilitidalle imprese con l’adozione della carte dei servizi formulate in coeren-za ad una standard predisposto dalla stessa ATR.
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Emilia Romagna
52
Proprietà degli asset L’agenzia ha mantenuto la proprietà di tutti gli asset, compresi gli
autobus. Alla base di tale scelta, si colloca la valutazione delle proble-matiche relative al trasferimento di contributi in conto capitale. Si è rite-nuto che se il gestore fosse anche proprietario degli autobus, potrebbesussistere un elemento discriminante nel contratto di servizio. Infatti, siè stabilito che il corrispettivo del contratto non possa includere i contri-buti in conto capitale. Si dovrebbe teoricamente andare a determinare ilcorrispettivo del contratto tenendo conto dei contributi in conto capitaleeffettivamente ricevuti dal gestore. Attribuire la proprietà degli assetall’agenzia è apparsa dunque la soluzione migliore per risolvere taleproblematica.
Altri servizi per la mobilità L’agenzia svolge tutta una serie di attività relative ai servizi per la
mobilità, tra cui in particolare la gestione della sosta e la gestione deiservizi scolastici.
L’agenzia svolge inoltre anche l’attività di manutenzione dei veico-li che rappresenta una propria area di business.
Il Consorzio TRAM di RiminiL’assetto del sistema di mobilità della provincia di Rimini si è defi-
nito a seguito della trasformazione precedente Consorzio. In particolaredalla scissione del ramo d’azienda che espleta il servizio di trasporto dalConsorzio TRAM si sono costituiti nel gennaio del 2001:•l’agenzia TRAM (Trasporti Riuniti Area Metropolitana), un consorzio
controllato dagli enti locali del territorio;•TRAM servizi S.p.a., responsabile del servizio e controllata direttamen-
te dagli enti locali del territorio;•Team (società consortile a r.l. che offre servizi di granturismo, control-
lata da TRAM servizi).L’agenzia ha la forma giuridica di un Consorzio, i cui soci sono la
Provincia di Rimini più i 25 comuni del bacino. Il comune di Rimini par-tecipa all’84%, la Provincia ha circa l’8%, il restante 8% è ripartito tra glialtri comuni.
Gli enti locali hanno deliberato di far assumere al Consorzio fun-zioni di agenzia della mobilità e con l’adesione al Consorzio i soci con-feriscono all’agenzia la titolarità per l’affidamento e il controllo dei servi-zi di trasporto pubblico locale afferenti il territorio della provincia diRimini. Gli addetti dell’agenzia provengono tutti dal precedente consor-
53
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
zio, e sono circa 35. Una parte consistente (10 unità) è rappresentata dapersonale operativo che fa parte dell’ufficio vendite dei biglietti, conbasso grado di scolarità. I dipendenti sono per 1/3 laureati e 2/3 diplo-mati.
Tav. 8 L’organizzazione dell’agenzia di Rimini
Gli organi dell’agenzia sono: l’Assemblea Consorziale, il Consigliodi Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ilDirettore.
L’Assemblea determina gli indirizzi dell’azione dell’agenzia, appro-va la politica tariffaria e i piani di programma
Il Consiglio di Amministrazione delibera sul piano di programma ei bilanci dell’agenzia, nomina il Direttore.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato diretta-mente dall’Assemblea degli enti locali che costituiscono il Consorzio,rappresenta il Consiglio nei rapporti con gli enti locali e le autoritàregionali e statali e risponde della gestione all’Assemblea.
Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell’agenzia e la rappre-senta legalmente nei confronti dei terzi.
La struttura organizzativa prevede poi in posizione di line: l’ufficioche gestisce la rete e i servizi, il Servizio Tecnico che realizza la proget-tazione dell’infrastruttura e degli investimenti, un ufficio che si deveoccupare della realizzazione di una metropolitana di superficie (traspor-to rapido costiero), l’ufficio che gestisce i parcheggi, e l’Ufficio Contabi-lità. In staff sono l’Ufficio legale, l’Ufficio di Elaborazione dati e l’UfficioQualità e Marketing.
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Emilia Romagna
54
Il ruolo e la responsabilità dell’agenzia TRAM di Rimini possonoessere specificati illustrando le modalità di svolgimento dei processi cri-tici per la regolazione, amministrazione, gestione e controllo del sistemadi trasporto e di mobilità della Provincia. Di seguito saranno evidenziatiin particolare i processi critici complementari a quelli già illustrati in rife-rimento al ruolo dell’agenzia regionale.
Gestione del finanziamento per l’esercizio e gli investimentiL’agenzia è responsabile della gestione, nell’interesse degli Enti
consorziati, delle risorse finanziarie e dei contributi locali, regionali estatali per l’esercizio del trasporto pubblico locale e per gli investimentiin infrastrutture e nei servizi per la mobilità.
L’agenzia sottoscrive gli Accordi di Programma con la Regione, alfine di realizzare interventi per la mobilità. Gli Accordi di Programmadeterminano il concorso finanziario delle parti per gli investimenti e sta-biliscono quantità, tempi, modalità e condizioni dei trasferimenti regio-nali per la copertura degli oneri relativi ai servizi minimi.
Programmazione dei servizi minimiL’agenzia è responsabile della progettazione, organizzazione, pro-
mozione e amministrazione dei servizi pubblici di trasporto locale inte-grati tra loro e con la mobilità privata.
L’agenzia è responsabile della progettazione, organizzazione eamministrazione dei servizi di trasporto scolastico e trasporto disabiliche i singoli enti decidano di non gestire in forma diretta.
Definizione tariffe e gestione del sistema tariffario integratoL’agenzia è responsabile della progettazione e gestione della
zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tarif-fario e dell’eventuale attività di riparto qualora l’integrazione comprendaanche altri soggetti.
L’agenzia è responsabile della gestione della politica tariffaria, incoerenza con le previsioni del sistema integrato regionale STIMER.
Affidamento e gestione delle gare per servizi minimi All’agenzia è affidata la responsabilità delle procedure concorsuali
per l’affidamento dei servizi. L’obiettivo dell’agenzia consiste nel realiz-zare un contratto gross cost incentivato di durata triennale. L’incentiva-zione dovrà coinvolgere gli aspetti dell’efficacia (quantità di passeggeritrasportati, miglioramento degli indici di customer satisfaction).
Stipulazione dei contratti di servizio L’agenzia è responsabile della stipulazione dei contratti di servizio.
55
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
La gestione dei ricavi commercialiL’agenzia gestisce direttamente i ricavi commerciali, stipulando
contratti di tipo gross cost con gli operatori, e partecipa al progetto STI-MER.
I proventi dei titoli di viaggio di servizi di trasporto pubblico loca-le affidate ai gestori rappresentano entrate del Consorzio.
Proprietà degli asset L’agenzia è proprietaria delle infrastrutture per i servizi autofilo-
tranviari: impianti filoviari, paline di fermata, pensiline, e il deposito. Iveicoli sono conferiti a TRAM servizi S.p.a., che esercita anche l’attivitàdi manutenzione. È da notare che, in caso di avvicendamento nellagestione del servizio, il soggetto subentrante dovrà assorbire tutto il per-sonale e tutti i mezzi in uso in precedenza. Può essere interessante evi-denziare che, dato che in caso di subentro di nuova impresa il passag-gio del personale implica anche il trasferimento del TFR; nel sistema diRimini si è ipotizzato infatti che il TFR da corrispondere possa esserecompensato dagli introiti derivati dal trasferimento del parco autobus.L’agenzia sarà inoltre proprietaria dell’infrastruttura e dei veicoli di unametropolitana di superficie di circa 20 km, la cui costruzione è in fase dimessa a gara. La metropolitana riguarderà i collegamenti tra Rimini eRiccione, tra Rimini e la Fiera di Rimini, e tra Riccione e Cattolica. L’a-genzia sarà responsabile in particolare della gestione in concessione e/oin affidamento del servizio di metropolitana per il primo periodo trien-nale.
Monitoraggio e controllo attuazione del contratto di servizio L’agenzia è responsabile del monitoraggio e del controllo dell’at-
tuazione dei contratti di servizio.
Altri servizi per la mobilità L’agenzia è responsabile della progettazione, organizzazione e
amministrazione dei servizi complementari per la mobilità: preferenzia-mento semaforico; gestione della sosta, dei parcheggi, realizzazione direti telematiche per il controllo dei servizi; sistemi e centri informativiper i servizi turistici.
Altre agenzie in Emilia RomagnaIl consorzio ACAP di Piacenza
Il consorzio ACAP di Piacenza dal dicembre 2000 si è trasformatonella società TEMPI S.p.a., controllata dal Comune, dalla Provincia diPiacenza e dagli altri Comuni del bacino.
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’organizzazione delle agenzie per la mobilità in Emilia Romagna
56
Il Comune e la Provincia di Piacenza con delibera dell’AssembleaConsorziale nel 2000 hanno proposto la costituzione di un’Agenzia perla mobilità con caratteristiche di Consorzio di funzioni cui affidare icompiti di progettazione, organizzazione e promozione dei servizi ditrasporto pubblico collettivo, di gestione delle procedure concorsualiper l’affidamento dei servizi e di controllo dell’attuazione dei contratti diservizio.
Il Consorzio ACT di Reggio EmiliaNella Provincia di Reggio Emilia l’assetto del sistema di mobilità a
cui gli Enti Locali hanno deliberato di pervenire prevede:•l’assegnazione di un ruolo di Agenzia all’attuale Consorzio ACT, che
attualmente eroga il servizio automobilistico e ferroviario su tutto il ter-ritorio della provincia;
•la costituzione di una società di erogazione del servizio di trasportoautomobilistico nella provincia di Reggio Emilia, denominata Autolineedell’Emilia S.p.a. e controllata al 98% dall’agenzia.
Nell’assetto così definito l’agenzia per la mobilità e il trasportopubblico locale di Reggio Emilia mantiene la forma del Consorzio tra laProvincia e i 45 Comuni del bacino. L’agenzia mantiene la proprietà ditutti gli asset (infrastrutture, mezzi e depositi) ed ha come compiti: •progettare, organizzare e amministrare i servizi pubblici e privati di
mobilità;•gestire l’esercizio e l’infrastruttura di servizio ferroviario regionale di
bacino;•svolgere attività di manutenzione, gestire la politica tariffaria;•svolgere le procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi auto-
mobilistici e controllare l’attuazione dei contratti di servizio;•gestire le risorse e i contributi per l’esercizio e per gli investimenti.
Il Consorzio ACT controlla il 97% della T.I.L. (Trasporto Integratoe Logistica), che con 40 autobus offre servizi di trasporto di tipo specia-listico non sovvenzionato.
Nella provincia di Reggio Emilia è inoltre di prossima costituzioneuna società mista (51% ACT, 40% F.S., 9% altri soggetti di interesse pub-blico) per la gestione dello scalo merci di Dinazzano.
La Società per la mobilità e il trasporto pubblico S.p.a di ParmaA Parma dalla trasformazione del Consorzio TEP, mediante scissio-
ne totale si sono costituite due S.p.a.:•la Società per la mobilità e il trasporto pubblico S.p.a., controllata per
il 50% ciascuno dalla Provincia e dal Comune di Parma, a cui sono sta-
57
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
te conferite le infrastrutture per i servizi automobilistici e filoviari, eche eventualmente in futuro potrà svolgere il ruolo di agenzia;
•la TEP S.p.a., a partecipazione prevalente degli enti locali, cui è stataconferita la proprietà dei veicoli e che è responsabile dell’erogazionedei servizi di trasporto e degli altri servizi per la mobilità nella provin-cia di Parma.
L’agenzia di ModenaL’agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena
assumerà la forma di consorzio costituito probabilmente dalla Provinciae dai 47 Comuni del bacino, e si ritiene che sarà operativa nel 2002. L’a-genzia avrà compiti di organizzazione e programmazione dei servizi ditrasporto pubblico locale, di svolgimento delle procedure concorsualiper l’affidamento dei servizi. In particolare sarà responsabile del control-lo dell’esecuzione dei servizi affidati, e altri servizi per la mobilità, tracui la progettazione di piani urbani di traffico e di piani di parcheggi ela promozione di piste ciclabili.
Attualmente i servizi di trasporto della provincia di Modena sonoofferti dalla ATCM S.p.a. (Azienda Trasporti Collettivi e Mobilità S.p.a.) atotale capitale pubblico locale i cui soci proprietari sono dal 1° gennaio2001 l’Amministrazione Provinciale ed i 47 comuni della provincia diModena.
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
Il sistema di mobilità nel Lazio La legge regionale n°30 del 1998 di riforma del trasporto locale ha
conferito alcune specificità al sistema di mobilità della Regione Lazio:•la Regione ha assunto compiti di indirizzo e controllo generale, svol-
ge compiti di programmazione e amministrazione dei servizi ferrovia-ri, assegna ed eroga alle Province e alla Città metropolitana di Romale risorse finanziarie per i servizi minimi svolti nel territorio di compe-tenza;
•fino alla costituzione della Città metropolitana di Roma, le funzioni ele risorse finanziarie relative alla programmazione e amministrazionedei servizi minimi sono attribuite dalla Regione al Comune di Roma;
•la Regione ha delegato alle Province i compiti di programmazione eamministrazione relativamente ai servizi automobilistici provinciali eregionali; le Province a loro volta individuano i Comuni (con popola-zione non inferiore a 10.000 abitanti) cui assegnare le risorse finanzia-rie per i servizi minimi urbani e di interurbani;
•sono delegate ai Comuni, con popolazione non inferiore a 10.000 abi-tanti, le funzioni di programmazione e amministrazione dei serviziminimi automobilistici, urbani e interurbani individuati d’intesa con laProvincia di competenza;
•al fine di dotare la Regione e gli enti locali di un idoneo strumento disupporto tecnico-operativo per l’attività di programmazione e pianifi-cazione del trasporto pubblico locale, la legge regionale n°30 del 1998prevede che la Regione costituisca l’agenzia regionale mobilità, e neidentifichi le funzioni, la struttura e le modalità di funzionamento.
Il sistema di Tariffazione Integrata Metrobus di Gianluigi Mangia
Il sistema di integrazione tariffario nella Regione Lazio (sistemaMetrebus) nasce nel 1994 su iniziativa di ATAC, Cotral e F.S. Ad oggi,aderiscono al sistema di integrazione ATAC, Metroferro, Linee Laziali,Trambus, Trenitalia. Nel 2000, gli operatori aderenti al sistema Metrebushanno realizzato circa 251 milioni di vetture-km pari a circa il 98% del
L’ORGANIZZAZIONE DI STA-ATAC SPA A ROMAQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
di MARCELLO MARTINEZ
59
totale regionale1; trasportato circa 3,4 miliardi di passeggeri, pari circa al99% del totale regionale2.
Il sistema Metrebus si articola in due sub-sistemi, dei quali il pri-mo riguarda l’area metropolitana di Roma (Metrebus Roma) e consenteai passeggeri di muoversi con i mezzi pubblici sul territorio della Capita-le, mentre il secondo (Metrebus Lazio) si riferisce all’intero territorioregionale, ed include, quindi, tutti gli spostamenti a carattere extraurba-no all’interno della Regione Lazio.
Il sistema di integrazione tariffaria interessa l’intera area regionalee si estende su di una superficie di 17.203 kmq servendo tutta la popo-lazione della regione, che conta circa 5.300.000 abitanti.
Per quanto riguarda l’articolazione interna al sistema Metrebus, laRegione Lazio è stata suddivisa in sei distinte zone concentriche rispettoalla Capitale, all’interno delle quali sono stati inseriti i 378 Comuni dellaRegione; le zone vengono identificate dall’associazione di una letteradell’alfabeto: A, B, C, D, E, F, dove la lettera A serve ad individuare lacittà di Roma.
Tav. 1 L’articolazione territoriale del sistema Metrebus
Concentrando l’attenzione sulla struttura tariffaria, le diverse tipo-logie di titoli di viaggio Metrebus danno il diritto a viaggiare: •su più mezzi (bus, tram, metropolitana, e treni metropolitani); •su più percorsi; •all’interno di una zona; •tra più zone ad esclusione dei collegamenti speciali.
Avendo adottato un sistema zonale, la determinazione dei prezzidei titoli di viaggio è collegata al numero di zone che i viaggiatori attra-versano, senza che il numero dei mezzi utilizzati oppure la lunghezzadel percorso incidano sul prezzo finale di vendita dei biglietti oppuredegli abbonamenti.
L’organizzazione di STA-ATAC Spa a Roma
60
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
61
In considerazione della centralità del territorio della Capitale, lacompetenza sulla determinazione delle tariffe dei titoli di viaggio spettaall’ATAC, il vecchio operatore del trasporto pubblico locale dell’area delComune di Roma. In particolare, l’ATAC realizza la gestione dell’integra-zione tariffaria, curando e sviluppando il sistema tariffario integrato.
Complessivamente il sistema Metrebus offre: •17 tipologie di biglietti; •26 tipologie di abbonamenti.
I titoli di viaggio (biglietti e abbonamenti) sono stati analizzati eclassificati in base a differenti criteri:•durata temporale, quando il prezzo di acquisto varia al variare del
limite temporale di validità del titolo;•tipologia di utilizzatore, quando il prezzo di acquisto varia al variare
delle caratteristiche dell’utilizzatore (militari, studenti, anziani, ecc…); •aree territoriali, quando il prezzo di acquisto varia al variare della
distanza percorribile oppure del numero di zone attraversabili con iltitolo di viaggio;
•modalità di acquisto, quando il prezzo di acquisto è influenzato dallemodalità di acquisto dei titoli (a rate, in contanti ecc…).
Tav. 2 Le tipologie di titoli di viaggio nel sistema Metrebus
Dalla lettura della tavola precedente emerge con chiarezza il fattoche il sistema tariffario sia stato costruito sul perno del criterio di riparti-zione zonale, ma è opportuno sottolineare che alcune tipologie di titolidi viaggio (sia biglietti sia abbonamenti) sono costruite in considerazio-ne anche del limite temporale entro il quale hanno validità.
Per quanto riguarda le caratteristiche materiali dei titoli di viaggio,si deve sottolineare che è stata recentemente introdotta la MetrebusCard. Si tratta di una carta magnetica a carattere personale dotata di unpiccolo chip, e contenente la foto e i dati del titolare, la scadenza, l’am-bito di validità ed ogni altra informazione rilevante. L’obiettivo sottesoall’introduzione della nuova tipologia di titolo di viaggio, è quello di
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
Biglietti Abbonamenti
n° dei titoli di viaggio 17 n° dei titoli di viaggio 26durata temporale 3 durata temporale 3tipologie di utilizzatori 0 tipologie di utilizzatori 2aree territoriali 14 aree territoriali 14modalità di acquisto dei titoli di viaggio 0 modalità di acquisto dei titoli di viaggio 7
inserire uno strumento destinato nel tempo a sostituire i tradizionaliabbonamenti su carta.
Il sistema di mobilità a Roma
Tav. 3 Il modello di agenzia di Roma
La legge regionale di riforma del trasporto pubblico locale nelLazio non prevede la costituzione di agenzie locali o territoriali. Tutta-via, la legge riconosce una particolare funzione al Comune di Roma cuidelega, in attesa che si costituisca la città metropolitana, compiti eresponsabilità in tema di pianificazione, amministrazione e regolazionedel trasporto pubblico. I servizi erogati nel sistema di mobilità di Romarappresentano infatti circa il 12% del volume della produzione nazionaledi servizi di trasporto pubblico locale.
Le risorse necessarie al funzionamento del sistema romano dimobilità sono parzialmente coperte dal Fondo Regionale Trasporti (per206 milioni di euro per il servizio autofilotranviario, oltre a 13 milioni dieuro per il servizio metropolitano). Il Comune a sua volta deve finanzia-re i costi non coperti dal contributo regionale per una cifra di 180 milio-ni di euro.
Il Comune di Roma ha elaborato ed implementato un particolaremodello di organizzazione del sistema di trasporto, assegnando il ruolodi agenzia all’ATAC, la vecchia azienda municipalizzata, e progettandoun intervento di integrazione con STA, altra società responsabile dinumerosi servizi per la mobilità nella Capitale.
L’organizzazione di STA-ATAC Spa a Roma
62
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
63
Il modello ha dunque al vertice il Comune di Roma, il quale svol-ge una funzione di indirizzo, Il Comune controlla direttamente le dueAgenzie le quali dovranno integrarsi e fondersi.
La STA, controllata da Comune di Roma al 98% e da ATAC al 2%,si occupa del traffico privato, ed opera anche attraverso soggetti edimprese terze cui affida lo svolgimento di interventi relativi alla pianifi-cazione, gestione e investimento nel trasporto.
L’ATAC S.p.a., controllata al 100% dal Comune di Roma, svolgeinvece tipicamente funzioni di agenzia del trasporto pubblico locale.L’integrazione di ATAC e STA è finalizzata a costituire una società diregia responsabile anche dell’affidamento dei servizi.
ATAC non controlla le società operative responsabili dei servizi,che sono invece di proprietà del Comune di Roma. I servizi di trasportosono infatti affidati con contratti gross cost ad imprese responsabili delservizio.
Co.Tra.l. S.p.a., controllata dalla Regione e dalle Province delLazio, eroga servizi di trasporto pubblico extraurbano su gomma, equalche servizio urbano in alcuni Comuni. Con circa 3.900 addetti, com-plessivamente eroga un’offerta di circa 80 milioni di vetture-km, e tra-sporta circa 2.300 milioni di viaggiatori;
Trambus Spa, controllata dal Comune di Roma, eroga annualmen-te servizi di trasporto autofilotranviari per 120 milioni di bus-km, sostie-ne 900 milioni di spostamenti annui, ed ha circa 9.500 addetti.
MetRo S.p.a., controllata dal Comune di Roma, responsabile deiservizi ferroviari metropolitani nella città di Roma, dei servizi ferroviariextraurbani, invece eroga annualmente 42,6 milioni di veicoli-km,sostiene 270 milioni di spostamenti annui ed ha circa 2.960 addetti.
A queste aziende pubbliche si aggiungono altre imprese private ditrasporto pubblico su gomma che in alcuni casi hanno anche vinto pro-cedure per l’affidamento concorsuale di servizi banditi dall’agenziaATAC S.p.a. L’agenzia, in particolare ha già stipulato contratti di serviziocon un’ATI composta da Sita, Apm, Arpa, Transdev, Star e Cotri, peralcuni segmenti specifici dell’offerta di trasporto pubblico su gomma.
L’organizzazione e le funzioni di STAL’organico della STA è di circa 270 addetti, cui vanno aggiunti 195
operatori della sosta, ausiliari assunti a tempo determinato che probabil-mente in futuro torneranno ad essere dipendenti da un soggetto terzo.
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
Tav. 4 La struttura organizzativa di STA
La struttura organizzativa di STA si basa su 4 aree: Ingegneria, Pia-nificazione, Innovazione e sistemi e Servizi di mobilità.
La Direzione Ingegneria sta progettando il nuovo sistema dellemetropolitane di Roma, tra cui la terza linea che andrà in appalto a finemaggio 2002 (un’opera del valore di 3.600 milioni di euro). Si tratta diappalti banditi dal Comune di Roma, che deciderà a chi affidare il servi-zio, con tecniche di project financing. Ha poi progettato alcune tranvieche saranno operative nel corso del 2002. Si occupa di ingegneria e pro-gettazione di altre infrastrutture di mobilità (parcheggi); di attuazione edirezione lavori di miglioramento del sistema di metropolitane esistenti;attività di validazione progetti .
La Direzione tecnica e pianificazione svolge attività di pianificazio-ne urbanistica, studi per il piano regolatore del Comune di Roma eriqualificazione urbana, e ha al suo interno l’Osservatorio permanentesul traffico, un sistema informativo su tutti i principali indicatori dellamobilità cittadina. Sta sviluppando lo studio a medio-lungo termine delsistema di mobilità integrato del Comune di Roma, che coinvolge inquesto caso anche il trasporto pubblico (Pianificazione del traffico e del-la mobilità, Piani di sviluppo della rete viaria, Piano generale del trafficourbano, Piano integrato della mobilità a 10 anni).
La Direzione innovazione tecnologica applicata alla mobilità svi-luppa progetti ITS (Intelligent Transport System), e ha in corso 12 pro-getti europei di ricerca, in partnership con le amministrazioni delle prin-cipali città europee.
La Direzione Servizi di mobilità gestisce la centrale traffico delComune di Roma, controlla i varchi automatici di accesso al centro stori-
L’organizzazione di STA-ATAC Spa a Roma
64
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
65
co e gestisce progetti e servizi di mobilità sostenibile. Gestisce i sistemidi sosta tariffata (50.000 posti auto sul territorio comunale), di sosta diinterscambio (una dozzina di parcheggi di interscambio generati dallarete di trasporto pubblico), gestisce su delega del Comune la proceduradi rimozione e sblocco delle auto private.
Il Comune ha anche delegato a STA la funzione di permessisticarelativi alle discipline di limitazione del traffico privato, la gestione delprocesso sanzionatorio relativo alla sosta e ai varchi automatici di acces-so, la pianificazione e progettazione della sosta e manutenzione e svi-luppo della segnaletica stradale, e gestione del sistema semaforico.
L’organizzazione e le funzioni di ATACATAC S.p.a. ha un organico di circa 700 dipendenti che compren-
dono anche gli addetti del sistema commerciale e gli addetti alla con-trolleria (circa 200). Il personale proviene dall’organico delle precedenticonfigurazioni di ATAC e Cotral. Ipoteticamente la fusione fra ATAC eSTA originerà un organizzazione con circa 1.200 addetti.
Il ruolo e la responsabilità dell’agenzia ATAC possono essere spe-cificati illustrando le modalità di svolgimento dei processi critici per laregolazione amministrazione, gestione e controllo del sistema di traspor-to e di mobilità del Comune di Roma.
Pianificazione degli investimentiIl Comune di Roma pianifica a livello generale gli investimenti in
reti ed infrastrutture, nell’ambito della gerarchia tra il proprio PianoUrbano di Mobilità e il Piano regionale dei trasporti.
Il Comune stipula poi con ATAC un accordo quadro dove si defi-niscono gli obiettivi generali delle politiche di trasporto da seguire e lerisorse da investire.
Gestione del finanziamento per investimentiIl ruolo di ATAC è molto limitato in riferimento a questo processo
critico. Nella Regione Lazio, infatti, gli investimenti in infrastrutture sonofinanziati dalla Regione e dagli enti locali mediante la sottoscrizione diappositi Accordi di Programma.
Per quanto attiene ai mezzi di trasporto, e alle relative attrezzaturee beni strumentali, con esclusione del materiale ferroviario, la GiuntaRegionale, previa intesa da raggiungersi con apposita Conferenza deiServizi con le Province e la Città Metropolitana di Roma, approva Pianispecifici contenenti la tipologia di mezzi e attrezzature per i servizi dicompetenza della Regione, delle Province e dei Comuni, le risorse
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
finanziarie e la loro fonte, i soggetti assegnatari.
Controllo dell’attuazione degli investimentiATAC si occupa di definire e attuare i piani di investimento definiti
nella Conferenza dei Servizi per lo sviluppo delle infrastrutture e deiveicoli per il trasporto pubblico locale.
Programmazione dei servizi di mobilitàATAC realizza la programmazione triennale dei servizi minimi e
aggiuntivi del Comune di Roma. Il Comune e ATAC sottoscrivono unaconvenzione che fissa gli indirizzi delle attività di ATAC. Quest’ultimarealizza la programmazione dei servizi, definendo programmi di eserci-zio e standard qualitativi; rappresenta inoltre l’interfaccia di coordina-mento e integrazione con i servizi regionali ferroviari e autofilotranviariche attualmente sono svolti da Trenitalia e da CoTral.
Definizione delle tariffe e supporto per lo sviluppo dei sistemitariffari
ATAC realizza la gestione dell’integrazione tariffaria, curando e svi-luppando il sistema tariffario integrato Metrebus anche attraverso la rea-lizzazione di innovazioni tecnologiche.
Affidamento e gestione delle gare per i serviziL’agenzia integrata ATAC STA affiderà mediante gara tutti i servizi
di trasporto pubblico locale relativi all’area metropolitana di Roma (oggitale ruolo è svolto parzialmente da ATAC). I contratti che si metterannoa gara prevederanno percorrenze definite, servizi molto dettagliatamentedescritti, e mezzi di proprietà del concedente.
Stipulazione del contratto di servizioATAC definisce, negozia e stipula i contratti di servizio con gli
operatori. I contratti sono di tipo gross cost con meccanismi di premi epenali, anche mediante ripartizione di quote di ricavi da traffico, perincentivare le imprese affidatarie sull’incremento della qualità dei servizie sulla crescita dei passeggeri trasportati paganti. I contratti definisconoanche le modalità di accesso e di utilizzo dei mezzi e delle infrastruttu-re, per le quali è previsto un canone di utilizzo. I contratti di serviziosono poi approvati dal Comune di Roma.
La gestione dei ricavi commercialiATAC acquisisce e gestisce i ricavi da traffico relativi ai servizi di
trasporto erogati dalle imprese affidatarie. È inoltre responsabile delmarketing e della vendita dei titoli di viaggio, nonchè della gestione esviluppo degli spazi per i servizi agli utenti: aree di transito e intratteni-mento, aree di informazioni e ticketing, aree commerciali.
L’organizzazione di STA-ATAC Spa a Roma
66
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
67
Proprietà degli assetNell’attuale sistema ATAC è proprietaria dei mezzi e delle infra-
strutture per i servizi autofilotranviari, ma non di quelle relative allemetropolitane, che sono ancora di proprietà del Comune di Roma. Aregime ATAC sarà il soggetto che avrà in dotazione tutte le infrastruttu-re e i veicoli per il trasporto sia su gomma sia su ferro.
È bene ricordare che nel 2002 il Consiglio Comunale ha approvatouna delibera che prevede una ulteriore patrimonializzazione di ATAC,conferendole beni afferenti il trasporto pubblico e la titolarità di progettidi investimento che genereranno nuove infrastrutture di trasporto pub-blico.
Controllo dell’attuazione del contratto di servizio e controllo dellaqualità percepita dai clienti
ATAC realizza il monitoraggio e il controllo contrattuale della qua-lità e quantità dei servizi erogati dagli operatori. È responsabile inoltredel monitoraggio della qualità del servizio percepita dagli utenti.
Altri servizi per la mobilitàA seguito del processo di fusione tra ATAC e STA, la nuova agen-
zia sarà responsabile anche delle attività strumentali di pianificazione egestione dei servizi della mobilità attualmente svolte da STA.
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
Il sistema di mobilità della Lombardia La legge regionale n°22 del 1998 ha così caratterizzato il sistema
di mobilità della Regione Lombardia.•La Regione ha compiti di indirizzo e controllo generale, svolge compiti
di regolamentazione, programmazione e regolazione dei servizi di tra-sporto ferroviario, assegna ed eroga alle Province e ai Comuni Capo-luogo di Provincia le risorse finanziarie per i servizi su gomma, aimpianti fissi e a guida vincolata.
•Le Province svolgono compiti di programmazione per i servizi auto-mobilistici interurbani e gestiscono le relative gare per l’affidamentoconcorsuale; individuano con i Comuni interessati i servizi di areaurbana, assegnano le risorse finanziarie ai Comuni non Capoluogo perla stipula dei contratti di servizio.
•I Comuni Capoluogo di Provincia svolgono compiti di programmazio-ne per i servizi comunali e di area urbana. Svolgono le procedure con-corsuali per i servizi su gomma, su impianti fissi e a guida vincolata, inambito comunale, o di area urbana o interurbana.
La L.R. n°1 del 2002 emendando l’art.15 della L.R. 22/98 in cui siprevedeva la costituzione di un’Autorità Garante per i servizi di traspor-to pubblico locale, dispone l’istituzione di un Organo di Garanzia delTrasporto Pubblico, stabilendone altresì le relative attribuzioni funzionalie operative, la struttura organizzativa, le modalità di relazione con laRegione, con gli Enti Locali destinatari dei trasferimenti delle funzioni inmateria di programmazione e di affidamento dei servizi di trasportopubblico, nonché con i gestori dei servizi medesimi.
In attuazione de D.L. 400 del 1999 la Regione Lombardia ha rice-vuto dallo Stato 167 milioni di euro per il finanziamento dei servizi sullarete RFI per 19,4 milioni di treni-km e 62 milioni di euro per il finanzia-mento dei servizi di FNME pari a 7,2 milioni di treni-km su una rete paria circa 200 km. Il servizio di trasporto ferroviario regionale è legato finoal 2003 da contratti di servizio stipulati dalla Regione Lombardia conTrenitalia e Ferrovie Nord Milano S.p.a. Dal 2004, invece i servizi ferro-
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA MILANESE MOBILITÀ E AMBIENTE SRLQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
di MARCELLO MARTINEZ
69
viari saranno affidati mediante procedure concorsuali.L’organizzazione del servizio automobilistico è caratterizzata da
una realtà produttiva fortemente differenziata, con una rilevante presen-za di soggetti imprenditoriali privati. In Lombardia, infatti, su 142 azien-de che beneficiano di contributi in conto esercizio, ve ne sono ben 111private. L’ammontare complessivo relativo alla gestione dei servizi chegodono dei contributi dalla Regione è pari a 275,3 milioni di bus-km per516 milioni di euro annui di contributi. L’offerta di trasporto per serviziautofilotranviari urbani è pari a 138 milioni di bus-km, di cui 110 appar-tengono all’ATM di Milano, che da sola rappresenta il 38% delle percor-renze di ogni tipo, ed assorbe circa 300 milioni di euro di contributiregionali.
Il sistema di mobilità di Milano Il sistema analizzato è quello del territorio metropolitano centrale
della Lombardia che comprende il Comune Capoluogo della Lombardia(Milano) e le cinture più consolidate, composte da altri 31 comuni. Laresponsabilità della gestione e soluzione delle problematiche legate altrasporto locale compete pertanto sia al Comune di Milano sia alla Pro-vincia di Milano.
Alla Provincia e al Comune di Milano spettano in particolare icompiti di definire il Programma Triennale dei Servizi, attraverso cuiorganizzare l’offerta di trasporto pubblico locale per la stipula dei con-tratti di servizio.
Tav. 1 Il modello di sistema di mobilità di Milano
L’organizzazione dell’Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente Srl
70
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
71
La legge regionale di riforma del trasporto pubblico locale dellaRegione Lombardia non ha previsto esplicitamente che gli enti locali sidotino di agenzie per la mobilità. Tuttavia, il Comune di Milano ha datempo realizzato significativi interventi di riorganizzazione del sistemadella mobilità per il proprio territorio e per quello dei comuni contigui.
L’assetto complessivo del sistema di mobilità nell’area di Milanoprevede che il Comune rappresenti una holding di cui l’agenzia è unadelle articolazioni. Infatti il Comune di Milano controlla direttamente siaMetropolitana Milanese sia l’ATM ed indirettamente anche l’agenzia perla Mobilità. Più precisamente il Comune di Milano controlla al 100%l’ATM S.p.a. e la Metropolitana Milanese S.p.a.; quest’ultima controlla al100% l’Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente S.r.l. Si segnala comunqueche alcuni dei 31 comuni dell’area urbana di Milano hanno manifestatol’interesse ad entrare eventualmente nelle quote di capitale dell’agenzia.
In particolare la Metropolitana Milanese S.p.a., con 235 addetti, sioccupa di progettare e realizzare infrastrutture per la mobilità: è di fattouna società di ingegneria che copre tutto il ciclo della progettazione nelsettore delle opere civili e degli impianti di linee ferroviarie urbane edextraurbane. Cura inoltre servizi di general contracting, constructionmanagement, assistenza tecnica, gestione degli appalti e dei contratti,project financing, preparazione dei documenti per le gare di appalto econtrattuali e attività di supporto delle pubbliche amministrazioniresponsabili del procedimento di gara.
Il Comune di Milano ha stipulato un contratto di servizio con l’A-genzia Milanese Mobilità e Ambiente S.r.l. la quale svolge funzioni dipianificazione della rete del trasporto pubblico locale, di supporto alComune per la redazione dei contratti di servizio, di analisi e pianifica-zione degli interventi ambientali per la riduzione dell’inquinamento, direalizzazione di sistemi informativi di comunicazione all’utenza.
L’Azienda Trasporti Milanesi si è trasformata in S.p.a. il 3 gennaio2001. Attualmente gestisce il trasporto pubblico locale nell’area metro-politana milanese e i suoi rapporti con il Comune sono regolati daapposito contratto di servizio. La rete dell’ATM è costituita da tre lineemetropolitane e 118 linee di superficie (suddivise in linee tranviarie,filoviarie ed automobilistiche) che si snodano per oltre 1.300 km sul ter-ritorio di Milano ed altri 85 Comuni dell’hinterland. Il sistema di retemetropolitana e a guida vincolata si sviluppa su tre linee per 70 km, con86 stazioni. Nel 2000 complessivamente sono stati trasportati 582 milionidi passeggeri. La tabella seguente presenta analiticamente l’ammontaredelle vetture-km prodotte dall’ATM.
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
Tav. 2 L’offerta di ATM Spa
Il sistema di Tariffazione Integrata SITAM di Gianluigi Mangia
All’interno della Provincia di Milano è in vigore un sistema di inte-grazione tariffaria denominato SITAM (Sistema di Integrazione Tariffariadell’Area Milanese), in ragione del fatto che a partire dal 1991 all’ATM sisono aggiunti altre operatori del trasporto pubblico della Provincia diMilano e dell’area milanese. Ad oggi, al sistema SITAM aderisce la mag-gior parte degli operatori che erogano servizi di trasporto pubblico sugomma nella Provincia di Milano. In particolare, nel 2000 il sistema SITAMcomprendeva 99 linee coperte da quattordici operatori, oltre alla ATM.
Nel corso del 2000 i quindici operatori aderenti al SITAM hannorealizzato circa 174 milioni di vetture-km pari a circa il 68% del totaleregionale3; e trasportato circa 655 milioni di passeggeri pari a circa il78% del totale regionale4.
Il sistema SITAM è un sistema di integrazione a carattere locale eriguarda i 187 Comuni della Provincia di Milano. L’area geograficacoperta dal sistema SITAM ha un estensione pari a 1.982 kmq (pariall’8% del territorio regionale). La popolazione residente all’interno del-l’area di integrazione è pari a 3.773.893 corrispondente al 41% del totaledella popolazione regionale.
Il sistema SITAM si basa su di una articolazione del territorio pro-vinciale per corone concentriche rispetto a Milano che è divisa in duecorone. Le corone diventano progressivamente più ampie5 e sono iden-tificate da colori diversi.
È opportuno rilevare che all’interno dell’area di integrazione tarif-faria SITAM, oltre a questo criterio di zonizzazione, ne è previsto ancheun secondo: infatti, è previsto un raggruppamento delle corone concen-triche (semizone) già individuate. In questo modo, si definiscono areeconcentriche rispetto al territorio comunale della città di Milano (areapiccola, area media, area grande, area plus1, area intera, area esterna).
A differenza del sistema di integrazione Metrebus, nel quale l’uni-co soggetto competente in materia di integrazione tariffaria è rappresen-
L’organizzazione dell’Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente Srl
72
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
M
Vetture-km anno 200 (in migliaia) Urbane Interurbane TotaleMetropolitana 40.982 11.591 52.573Tram 22.040 1.336 23.376Autobus 41.488 13.012 54.500Filobus 4.229 - 4.229TOTALE 108.739 25.939 134.678
73
tato da ATAC, nel caso del sistema SITAM vi è la competenza di dueenti: il Comune di Milano per le tratte urbane e la Regione Lombardiaper le tratte extra-urbane.
Per quanto riguarda l’articolazione del sistema tariffario, si posso-no distinguere tre tipologie di titoli di viaggio: •urbani, che consentono spostamenti esclusivamente sul territorio della
città di Milano; •interurbani, che consentono spostamenti sulle linee interurbane, dall’
hinterland fino ai rispettivi capolinea all’interno di Milano e viceversa.I documenti di viaggio interurbani non consentono però di proseguireil viaggio sulla rete urbana;
•cumulativi, che consentono di viaggiare, oltre che sulle linee interurba-ne, anche sulla rete urbana di Milano.
Per quanto riguarda i criteri seguiti nella determinazione delletariffe, i biglietti urbani hanno tariffa unica in modo indipendente rispet-to al numero di linee utilizzate ed hanno una validità di durata limitata(75’). Nel caso dei titoli interurbani, le tariffe sono costruite sul numerodi zone attraversate dai viaggiatori, ed anche l’intervallo temporale divalidità è determinato in funzione del numero di zone all’interno dellequali il titolo di viaggio dà diritto a viaggiare6. Le tariffe dei titoli di viag-gio cumulativi sono determinate partendo dalla tariffa urbana alla qualesi aggiunge una quota progressiva correlata al numero delle semizoneattraversate. Come nel caso dei titoli di viaggio interurbani, anche inquesta circostanza la durata temporale di validità si determina in funzio-ne del numero di semizone che il titolo di viaggio autorizza ad attraver-sare7.
In maniera analoga alle considerazioni svolte sul sistema Metre-bus, i titoli di viaggio del sistema SITAM (biglietti e abbonamenti) sonostati analizzati e classificati in base a differenti criteri: •durata temporale, quando il prezzo di acquisto varia al variare del
limite temporale di validità del titolo;•tipologia di utilizzatore, quando il prezzo di acquisto varia al variare
delle caratteristiche dell’utilizzatore (militari, studenti, anziani, ecc...); •aree territoriali, quando il prezzo di acquisto varia al variare della
distanza percorribile oppure del numero di zone attraversabili con iltitolo di viaggio;
•modalità di acquisto, quando il prezzo di acquisto è influenzato dallemodalità di acquisto dei titoli (a rate, in contanti, età...).
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
Tav. 3 Le tipologie di titoli di viaggio nel sistema SITAM
Dall’analisi si deduce la presenza di un un’interessante differenzanei criteri prevalenti alla base della struttura tariffaria dei biglietti e degliabbonamenti. Infatti, se nel caso dei biglietti è evidente la centralità delcriterio territoriale, che determina le tariffe dell’80% delle tipologie dibiglietti complessivamente predisposte nel sistema SITAM, nel caso degliabbonamenti, invece, la situazione è diversa, poiché pur riconoscendosiche la tariffa di ben 11 titoli di viaggio poggia sul criterio zonale, è evi-dente che nella determinazione degli abbonamenti si è preso in consi-derazione anche l’ulteriore importante parametro rappresentato dallatipologia di utilizzatori.
L’Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente S.r.l.L’agenzia è una S.r.l. controllata al 100% dalla Metropolitana Mila-
nese, ma si prevede di trasformarle in S.p.a. a partecipazione mista. Ènei fatti una società di servizi che svolge alcune attività per conto delComune di Milano, da cui riceve l’incarico di svolgere attività di suppor-to mediante la stipulazione di un contratto di servizio rinnovabile. L’or-ganico dell’agenzia è di circa 40 addetti, con una netta prevalenza dilaureati.
Le risorse a disposizione dell’agenzia ammontano a circa 4,5milioni di euro, che sono il corrispettivo del contratto stipulato con ilComune di Milano. Quest’ultimo destina a tale scopo gli introiti prove-nienti dalla gestione dei parcheggi. L’erogazione del corrispettivo delcontratto all’agenzia è effettuato dal Comune di Milano per il 50% all’ini-zio dell’anno e per il residuo a consuntivo sulla base della verifica dellosvolgimento del programma assegnato. Si segnala comunque che lo sta-tuto dell’agenzia prevede che il 20% dei ricavi derivi da attività svoltaper soggetti diversi dal Comune di Milano. Per verificare l’adempimentodegli obblighi dettati dal contratto, il Comune intende sviluppare al pro-prio interno delle professionalità tecniche in grado di verificare il risulta-to delle commesse assegnate all’agenzia.
L’organizzazione dell’Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente Srl
74
Biglietti Abbonamenti
n° dei titoli di viaggio 40 n° dei titoli di viaggio 33durata temporale 2 durata temporale 5tipologie di utilizzatori 1 tipologie di utilizzatori 17aree territoriali 32 aree territoriali 11modalità di acquisto dei titoli di viaggio 5 modalità di acquisto dei titoli di viaggio 0
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
75
La scelta di costituire l’agenzia come controllata dalla Metropolita-na Milanese è stata dettata da diverse considerazioni. Nel processo dipolicy making che ha condotto all’attuale configurazione dell’assetto delsistema di mobilità dell’area di Milano, si è escluso di costituire l’agenziaall’interno dell’ATM per avviare il processo di separazione tra attività dipianificazione e gestione dei servizi di trasporto locale. D’altronde, lasocietà Metropolitana Milanese aveva già nel suo statuto degli obiettiviche erano coerenti con interventi di carattere anche ambientale. In que-sto modo, si è scelta inoltre una soluzione che colloca l’agenzia all’inter-no di un sistema di società che fanno comunque riferimento al Comune,in modo da non modificare l’assetto del sistema di erogazione dei servi-zi ancora affidato interamente all’ATM. In ogni caso si prevede che l’a-genzia continui a mantenere un rapporto contrattuale diretto con l’Am-ministrazione comunale.
Tav. 4 La struttura dell’Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente
Nel sistema di mobilità di Milano si è ritenuto di costituire un’A-genzia che si occupasse sia di mobilità che di ambiente.
L’agenzia è costituita da quattro settori dedicati alla mobilità, duededicati all’ambiente e due di supporto:•una prima unità si occupa della pianificazione dei trasporti pubblici;•una seconda unità si occupa di regolazione dei trasporti pubblici e
svolge una funzione di supporto al Comune nella predisposizione deicontratti di servizio e nella verifica dei servizi erogati;
•una terza unità si occupa della pianificazione del trasporto privato,compresa la predisposizione dei PUT;
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
•una quarta unità rappresenta l’ufficio del mobility manager di area,responsabile del coordinamento dei mobility manager aziendali di tut-ta l’area produttiva milanese.
Delle due unità che si occupano dell’ambiente, la prima si occupadella pianificazione degli interventi relativi all’energia e all’inquinamentoelettromagnetico ed acustico, mentre l’altra si occupa della qualità dell’aria.
Tra le attività di supporto, la banca dati ha la funzione di gestire idati per costruire i modelli della mobilità e del carico inquinante nel-l’ambiente; l’unità Comunicazione si occupa di costruire e gestire i siste-mi di comunicazione e informazione per i cittadini.
Attualmente l’agenzia fa riferimento, tramite una convenzione, allabanca dati e alla modellistica dell’ATM, anche se l’obiettivo è di svilup-pare propri modelli e dati originali.
Il ruolo e la responsabilità dell’agenzia possono essere specificatiillustrando le modalità di svolgimento dei processi critici per la regola-zione amministrazione, gestione e controllo del sistema di trasporto e dimobilità del Comune di Milano.
Pianificazione degli investimentiNella Regione Lombardia gli investimenti infrastrutturali vengono
ad essere definiti tramite il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria.
Per la definizione del programma esecutivo di interventi coinvol-genti l’Amministrazione statale, regionale e degli enti locali ci si avvaledi un Accordo di Programma Quadro con cui si individuano gli obietti-vi, le finalità, l’impatto ambientale, le opere da realizzare, i tempi di rea-lizzazione, i soggetti coinvolti, le risorse necessarie e le relative fonti, itempi di erogazione e il periodo di validità dell’Accordo.
L’Agenzia Milanese realizza per conto del Comune di Milano ilpiano urbano della mobilità, piano strategico basato su investimenti einnovazioni organizzativo-gestionali da attuarsi nell’arco di 10 anni.
Gestione del finanziamento per investimentiIl ruolo dell’Agenzia Milanese è alquanto limitato in riferimento a
questo processo critico. La Regione infatti assegna mediante appositoaccordo alle Province e ai Comuni Capoluogo di Provincia le risorsefinanziarie volte a sostenere gli investimenti di rinnovo del materialerotabile e di miglioramento delle strutture funzionali al servizio per lariqualificazione del trasporto pubblico locale.
La Regione promuove mediante apposito accordo con gli entilocali il rinnovo e il potenziamento del materiale metrotranviario e degli
L’organizzazione dell’Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente Srl
76
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
77
impianti tecnologici delle linee metropolitane e tramviarie, nonché losviluppo e l’introduzione di tecnologie innovative di rilevazione ebigliettazione.
Programmazione dei servizi minimiIl Comune di Milano è responsabile della programmazione trien-
nale dei servizi minimi, e ha affidato all’Agenzia Milanese Mobilità eAmbiente lo sviluppo del Programma funzionale all’attuazione delleprocedure concorsuali nel 2002. L’Agenzia Milanese ha svolto tale attivi-tà in stretta collaborazione con l’ATM.
L’attività fondamentale dell’agenzia è infatti la redazione triennalee l’aggiornamento annuale del PTS (Programma triennale dei servizi),che individua linea per linea i servizi offerti, oltre a specificarne i para-metri di qualità.
L’agenzia ha poi curato l’inserimento in sede di pianificazione diservizi alternativi all’interno dell’Area urbana, o comunque servizi adomanda debole o estremamente dispersa.
Definizione delle tariffe e supporto per lo sviluppo dei sistemitariffari
In base alla L.R. n°1 del 2002, la giunta regionale disciplina i crite-ri e le modalità di applicazione dei seguenti modelli tariffari:•Modello lineare applicabile a livello locale e regionale;•Modello a zona, applicabile a livello locale per i servizi di trasporto
pubblico interurbani, di area urbana e comunali.Agli enti locali compete individuare le zone e definire le proprie
tariffe in base ai valori di riferimento individuati dalla Regione.
Affidamento e gestione delle gare per i serviziIn Lombardia l’attivazione delle procedure di affidamento concor-
suale per i servizi di trasporto pubblico su gomma è partita nel corsodell’anno 2002. Si è attivato l’affidamento di contratti di servizio delladurata di sette anni, dal 2003 al 2009.
La Regione offre agli enti locali un supporto tecnico che consistenella definizione degli obiettivi generali da perseguire, nella trasmissio-ne degli indirizzi per le gare, del capitolato tipo, del modello di valuta-zione e del contratto tipo. È previsto anche un fondo incentivante perl’attuazione della riforma.
In base alla L.R. 22/98 è il Comune di Milano ad essere responsa-bile per la gestione delle procedure concorsuali per l’affidamento deiservizi automobilistici, su impianti fissi e su sistema a guida vincolatacomunali e di area urbana.
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
Con la L.R. n°1 del 2002 ai fini della risoluzione del conflitto diinteressi potenzialmente esistente tra il ruolo degli enti locali di soggettisia responsabili dell’affidamento dei servizi, sia proprietari delle societàdi gestione dei servizi, si enuncia che:•la Regione favorisce l’abbandono delle posizioni di controllo degli Enti
Locali nelle società di gestione dei servizi;•più precisamente, nel caso in cui le Province o i Comuni che stipulano
i contratti di servizio scaturenti da gara possiedano quote partecipativeall’interno della società di gestione dei servizi, le commissioni aggiudi-catrici delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi devonoessere integrate da un componente nominato dalla Giunta Regionale;
•inoltre, qualora la dimensione delle reti provinciali o comunali oggettodi gara sia superiore a 50 milioni di vetture-km, gli enti locali affidanti,devono provvedere alla suddivisione delle reti in più sottoreti, e cia-scuna sottorete non può superare il 30% dell’ammontare complessivodelle vetture-km dell’intera rete comunale o provinciale; le reti dimetropolitana possono invece costituire oggetto di un’unica sottorete.
In tale nuova configurazione del sistema di trasporto locale dellaLombardia, il contratto stipulato fra il Comune di Milano e l’AgenziaMilanese per la Mobilità e l’Ambiente prevede che quest’ultima forniscaun supporto tecnico al Comune predisponendo gli atti e i documentiper le procedure di affidamento concorsuale dei servizi.
Stipulazione dei contratti di servizioIl contratto stipulato fra il Comune di Milano e l’Agenzia Milanese
per la Mobilità e l’Ambiente prevede che l’agenzia fornisca un supportotecnico al Comune predisponendo i contratti di servizio da stipulare conle aziende affidatarie dei servizi, e partecipando al controllo dell’eroga-zione dei servizi stessi.
La gestione dei ricavi commerciali L’agenzia non gestisce ricavi commerciali, che invece sono ripartiti
fra le aziende che aderiscono al sistema di tariffazione integrata SITAM.
Proprietà delle infrastrutture per i servizi automobilisticiCon la nuova L.R. n°1 del 2002 si formula la previsione che i beni
infrastrutturali possano essere conferiti ad una società di capitali o ad altrosoggetto dotato di personalità giuridica, a partecipazione pubblica mag-gioritaria, mentre l’esercizio può essere affidato a soggetti del tutto privati.
È bene notare che, a differenza dell’art. 35 della Finanziaria 2002,la nuova legge regionale della Lombardia si riferisce esplicitamente areti ed impianti e non include altre dotazioni patrimoniali.
L’organizzazione dell’Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente Srl
78
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
79
Accesso alle infrastrutture per i servizi automobilisticiLa nuova L.R. n°1 del 2002 della Lombardia prevede che alla
società a cui venisse conferita la proprietà delle infrastrutture nonpotranno essere affidati servizi di trasporto pubblico locale.
Qualora la medesima società abbia il controllo o la partecipazionein società di gestione del trasporto pubblico locale, la stessa deve garan-tire condizioni di accesso dei beni non discriminatorie rispetto alle con-dizioni assicurate alle società dalla stessa controllate o partecipate.
Proprietà del materiale rotabileLa L.R. n°1 del 2002 prevede che, in sede di prima applicazione
delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi, il gestoreuscente è tenuto a mettere a disposizione delle imprese subentranti ilmateriale metrotranviario adeguato al servizio, qualora sia stato finanzia-to da risorse pubbliche. Spetta agli enti locali prevedere nei bandi e neicapitolati di gara il titolo e le modalità di trasferimento dei beni dalgestore uscente al nuovo aggiudicatario.
Controllo dell’attuazione del contratto di servizio e controllo dellaqualità percepita dai clienti
Nel sistema di mobilità della Regione Lombardia, la Regione, leProvince e i Comuni, in base alle relative competenze esercitano la vigi-lanza ed effettuano controlli per l’accertamento della regolarità e dellasicurezza dei servizi di trasporto pubblico di rispettiva competenza.
La Regione, d’intesa con le Province e i Comuni Capoluogo, svi-luppa un sistema di monitoraggio per la verifica del livello di efficacia,efficienza e qualità dei servizi di trasporto pubblico erogati.
Per il Comune di Milano, l’agenzia svolge il monitoraggio dellacustomer satisfaction, rilevando la qualità del servizio di trasporto perce-pita dai clienti.
Altri servizi per la mobilitàIl Comune di Milano ha approvato il Piano Urbano di Traffico rife-
rito al territorio metropolitano. L’agenzia si occupa di definire le coordi-nate modellistiche per indirizzare l’attività di redazione dei piani partico-lareggiati distinti per zone di decentramento della città. La redazione ditali piani è affidata a terzi soggetti mediante procedure di affidamentoconcorsuale. L’agenzia governa i processi di verifica dei risultati. L’agen-zia inoltre coordina interventi per lo sviluppo della mobilità sostenibile,quali ad esempio:•progettazione di 10 isole ambientali con il finanziamento del Ministero
dell’Ambiente;
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
•indagine sulla distribuzione delle merci per ridurre le emissioni inqui-nanti derivanti dal traffico su gomma, affidata al Politecnico di Milano;
•supporto ai mobility manager e creazione di una banca dati, con ilcofinanziamento del Ministero dell’Ambiente;
•pianificazione di interventi ambientali nei settori Area, Rumore, Radia-zioni elettromagnetiche;
•campagna di censimento, certificazione e controllo degli impianti diriscaldamento nel Comune di Milano.
Infine si può evidenziare che il contratto stipulato fra il Comunedi Milano e l’Agenzia Milanese per la Mobilità e l’Ambiente ha affidato aquest’ultima anche i seguenti progetti:•la costituzione e gestione dell’osservatorio del traffico e della banca
dati;•l’implementazione e lo sviluppo dei simulatori nella mobilità;•l’elaborazione del programma urbano dei parcheggi;•la realizzazione di studi in materia di regolazione della circolazione
stradale, di regolazione della sosta;•la predisposizione di specifiche di gara per le concessioni delle aree
per lo stazionamento pubblico e privato;•lo svolgimento di attività di comunicazione e informazione al pubblico
su temi specifici del traffico e della qualità ambientale.
L’organizzazione dell’Agenzia Milanese Mobilità e Ambiente Srl
80
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
Il sistema mobilità nell’area metropolitana di LondraL’area metropolitana di Londra è collocata all’interno della Regio-
ne del South East che, con circa 17 milioni di abitanti e composta da 11Contee e dall’area di Greater London, è la più ampia delle regioni dellaGran Bretagna. L’area amministrativa di Greater London a sua volta, haun’estensione di circa 1.400 kmq e una popolazione di 6,7 milioni diabitanti pari al 39% della popolazione del South East e a 12% di quelladel Regno Unito.
Tav. 1 Numero di km offerti dai tre operatori nei primi dieci mesi dell’anno 2002
Per quanto concerne alcuni dati sul trasporto pubblico locale, utilia definire il mercato all’interno del quale i diversi operatori si muovono,si può rilevare che rispetto ai tre principali operatori, il numero di pas-seggeri trasportati8 è stato rispettivamente di 1.187 milioni per gli auto-bus e 834 milioni per la London Underground e la Dockland Light Rail-ways. Oggi la metropolitana di Londra rappresenta il comparto più con-sistente nell’intero sistema ferroviario della Gran Bretagna, con oltre 3milioni di passeggeri al giorno, 507 treni e 253 stazioni e circa 16.500dipendenti. La rete metropolitana è costituita da 12 linee lunghe com-plessivamente 392 km e si estende anche nelle zone extraurbane. Perquanto concerne gli autobus la rete di Londra è costituita da 35 stazioni,100 capolinea, 17.000 fermate e 9.000 pensiline, su di un’area di circa1.630 kmq. In tutta la città esistono percorsi riservati, corsie preferenzia-li, linee rosse, che costituiscono il sistema del Bus Priority Network. In
di ERNESTO DE NITO
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA PER LA MOBILITÀ A LONDRAQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
81
particolare sono circa 450 i km di Red Routes, cioè strade di grandescorrimento, che servono circa il 20% dell’intero traffico stradale londi-nese e prevedono: il divieto assoluto di sosta, il divieto di fermata e dicarico, una speciale vigilanza e specifiche sanzioni. A questa rete sistanno aggiungendo circa 50 km di strade del centro urbano che svolgo-no una funzione di collegamento fra le arterie a grande scorrimento.
L’agenzia di Londra: Transport for LondonNel 1984 il London Regional Transport Act ha dato il via alla tra-
sformazione dell’assetto del trasporto pubblico locale londinese, conl’assunzione di una nuova missione e relativa organizzazione. La Lon-don Transport Limited (LT), una Statutory corporation, era una societàche già in precedenza direttamente o mediante alcune società operativegestiva il trasporto nell’area della Greater London.
Il 1999 ha segnato una profonda trasformazione nel sistema deltrasporto pubblico locale londinese a causa dell’introduzione del Grea-ter London Authority Act 1999, un atto parlamentare che ha costituitouna sorta di meta-agenzia formata dal Sindaco di Londra e da un’assem-blea composta da 25 membri. Tra le deleghe della Greater LondonAuthority figura quella sui trasporti affidati alla Transport for London(d’ora in avanti TfL), una Statutory corporation che ha il compito di assi-curare e facilitare l’implementazione della strategia dettata dal Sindacodella città di Londra e di garantire un servizio efficace, rapido e sicuronell’area denominata Greater London. Alla guida della TfL è stato istitui-to un consiglio di amministrazione costituito da non meno di 8 membrie non più di 15, tutti scelti dal Sindaco; le responsabilità del consigliosono sia di tipo strategico legate all’obbligo di implementare la strategiadecisa dal Sindaco, sia di tipo gestionale, quali l’approvazione del Bud-get, del Business Plan, degli investimenti nel caso in cui i costi previstisuperino i 100 milioni di sterline. Ha inoltre il compito di approvare laformazione, l’acquisizione di nuove società, nonché la costituzione dipartnership o di joint venture.
Oltre al consiglio di amministrazione sono previste alcune figurepiù strettamente manageriali che formano un comitato esecutivo di cuifanno parte il Director Finance and Planning, il Director of Street Mana-gement, il Director of Surface Transport, il Director of Rail Services, ilDirector of Media & Public Affairs. Il Director Finance and Planning è ilresponsabile della gestione finanziaria, anche se per gli investimentisuperiori ai 100 milioni di sterline deve chiedere autorizzazione alBoard, e per quelli superiori ai 25 milioni al Sindaco.
L’organizzazione dell’agenzia per la mobilità a Londra
82
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
83
Il passaggio che ha portato alla creazione della TfL segna unmomento significativo perché realizza lo spostamento del potere digestione dal governo centrale a quello metropolitano; oggi è il Sindacoinsieme al TfL board a determinare le scelte più importanti, e la TfL ha ilcompito di implementarle in stretto rapporto con London Borough e laStrategic Rail Authority.
In particolare la TfL controlla: London Buses, Croydon Tramlink,London River Services, Woolwich Ferry, LT Museum, Dial a Ride, Victo-ria Coach Station (ha il compito di garantire i servizi per gli autobus inarrivo e partenza, e provvedere ad un elevato standard di confort per iviaggiatori), TfL Street management (gestisce i 550 km di rete stradalenell’area di Londra - the Transport for London Network), Public CarriageOffice (PCO, che ha il compito di regolare le tariffe dei taxi e di altrioperatori che offrono un servizio di trasporto a noleggio); DocklandsLight Railway.
Tav. 2 L’agenzia Transport for London
Quando nel 1999 si è attuato il passaggio da London Transport aTransport for London la London Underground Limited (LUL), societàresponsabile del servizio metropolitano nella città di Londra, è rimastadi proprietà del Governo, creando quindi una frattura con la gestionedelle società relative alle altre tipologie di trasporto pubblico locale. Iltrasferimento alla TfL è previsto, comunque, nel momento in cui si con-
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
cluderà il Public-Private Partnership (PPP), e questo di fatto determinauna già forte ingerenza nelle scelte della LUL da parte dell’amministra-zione locale.
La presenza di un numero così ampio di operatori presenti all’in-terno della TfL determina la coesistenza di differenti realtà e modi digestire e di erogare il servizio di trasporto. È per questo motivo che,dove è possibile, è preferibile analizzare i diversi processi critici allaluce dei comportamenti dei singoli.
Pianificazione degli investimenti. La London Buses ha la responsabilità degli investimenti nelle
infrastrutture di rete e di sistema. Per quanto riguarda la metropolitana,con l’attuazione del PPP la pianificazione degli investimenti sarà effet-tuata dall’operatore privato, ma dovrà essere autorizzata dalla LUL. Perquanto concerne l’ammontare degli investimenti esiste uno schema rigi-do entro il quale i diversi attori del sistema possono muoversi.
Tav. 3 La gestione degli investimenti del gruppo TFL
Definizione tariffe e supporto sviluppo sistemi tariffariÈ la TfL a definire le tariffe. Nel caso di Croydon Tramlink le tarif-
fe sono concordate tra la TfL e l’operatore che eroga il servizio.
Stipulazione dei contratti di servizioNel caso degli autobus, London Buses determina e gestisce il pro-
cesso di tendering. Il processo di privatizzazione è iniziato nella secon-da metà degli anni ‘80, quando si è costituita la Tendered Bus, divisa in13 aziende sussidiarie, con la missione di coordinare il processo di pro-gressiva messa a gara della gestione delle linee. Il passaggio successivofu quello di conferire dei contratti, anche se, senza l’applicazione di unaprocedura concorsuale di affidamento. Nel 1996, infine, le 13 aziendecontrollate della London Buses sono state cedute a privati e da allora il
L’organizzazione dell’agenzia per la mobilità a Londra
84
Soggetto che autorizza Valore economico del progetto Valore economico del progetto(se previsto nel Budget) (non previsto nel Budget)
TfL Board Illimitato IllimitatoPresidente £ 100 milioni £ 25 milioni, eccetto i casi di
emergenza per lavori urgenti di sicurezza o di manutenzione degli asset
Managing Director, £ 25 milioni £ 10 milioni, eccetto i casi diFinance Planning emergenza per lavori urgenti
di sicurezza o di manutenzione degli asset, in assenza del Presidente
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
85
servizio viene erogato da privati; le gare si svolgono prevalentementeattraverso procedure concorsuali del tipo net contract. Oggi i servizi ditrasporto pubblico sono gestiti attraverso contratti di servizio con Lon-don Buses da oltre 30 società di trasporto.
Nel caso della Docklands Light Railway le attività di erogazionedel servizio e di manutenzione sono state affidate in franchising ad unoperatore privato nel 1997 con un contratto di sette anni, esteso ad altridue, per cui la Serco Docklands Ltd erogherà i servizi di trasporto emanutenzione fino al 2006.
Croydon Tramlink nel 1996 ha dato in concessione per 99 anni lagestione del servizio tram al consorzio Tramtrack Croydon Limited.
La LUL, invece, continuerà a gestire in proprio l’erogazione delservizio, mentre curerà la relazione che dovrebbe nascere in virtù del-l’attuazione del PPP con l’operatore o gli operatori privati che gestiran-no la rete per il periodo previsto (pari a circa 15 anni).
Gestione dei ricavi commercialiLa London Buses e la LUL gestiscono i ricavi commerciali e da
traffico.
Proprietà degli assetLa London Buses programma il servizio bus nella città di Londra
definendo le linee cedute in concessione, i livelli specifici di servizio emonitorando la qualità. È anche responsabile ed effettua la manutenzio-ne delle stazioni, delle fermate e degli altri servizi di supporto.
Per quanto concerne la LUL, l’elemento più innovativo legato allagestione della metropolitana è dato dalla volontà del Governo di imple-mentare un PPP, uno strumento che consente l’intervento dei privati nel-la manutenzione, rinnovo e miglioramento delle infrastrutture e dei tre-ni, senza il trasferimento della proprietà. La logica è di favorire l’afflussodi capitali privati garantendo contratti di lungo termine (investimenti di8 miliardi di sterline per un periodo di 15 anni) che consenta un ritornoeconomico dall’investimento per i privati. In questo modo si vuoleattuare una separazione tra l’infrastruttura, di cui la gestione pubblicanon riesce a garantire la massima efficienza e sicurezza, e il servizio ditrasporto che continuerà ad essere erogato dal soggetto pubblico. D’al-tronde la LUL conosce la tecnologia che utilizza, ma non possiede lecompetenze necessarie per effettuare i nuovi investimenti specialmenteper quanto riguarda gli aspetti tecnologici maggiormente innovativi. Atal fine nel 1999 la LUL ha indetto un invito a presentare delle offerterelative a tre contratti:
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
•BCV (Bakerlo, Central, Victoria, Waterloo & City Lines);•JNP (Jubilee, Northern e Piccadilly Lines);•SSL (subsurfaces lines - District, Circle, Hammersmith & City, Metropo-
litan e East London Lines);Le migliori offerte scelte vedono:
•Metronet, un gruppo di aziende che include Adtranz, WS Atkins, Bal-four Beatty, Seeboard e Thames Water per i lotti BCV e SSV;
•Tube Libes un gruppo di aziende che comprende Bechtel, Amey, Hal-crow e Jarvis per il lotto JNP.
Una serie di ragioni hanno ostacolato la realizzazione del proces-so, sia di natura tecnica (le difficoltà di natura legale e di valutazionedel progetto) sia di tipo politico (discussioni con la Railtrack e sopratut-to la delicata fase di trasferimento della LUL dal Governo alla TfL).
L’idea di fondo del PPP è quella di permettere un intervento fortenegli investimenti delle infrastrutture attraverso l’entrate di privati permigliorare in termini di efficienza, ma sopratutto di sicurezza per gliutenti. Al settore pubblico rimarrebbe la responsabilità per la segnaleti-ca, la sicurezza, le stazioni e il servizio di trasporto. Anche nel caso del-la DLR la proprietà è nelle mani del soggetto pubblico.
Manutenzione dei veicoli La manutenzione è a cura della LUL, spetta ai singoli operatori
affidatari dei servizi nei casi di London Buses e DLR.
Monitoraggio e controllo dell’attuazione dei contratti di servizio edella qualità percepita dai clienti
La TfL effettua un monitoraggio del servizio e un controllo costan-te sulla qualità erogata.
Altri servizi per la mobilità La TfL gestisce una serie di servizi di mobilità (dalla manutenzione
delle strade, alla segnaletica e alla regolazione delle tariffe dei taxi) enon, come il LT Museum.
Sulla base della sintetica presentazione dell’Agenzia di Londra,degli attori e delle responsabilità ad essa connesse si delinea una situa-zione alquanto complessa dovuta alla pluralità di soggetti presenti e allediverse tipologie di servizi di trasporto locale offerti. Ciò che emergedalle informazioni raccolte è che TfL è una sorta di meta-agenzia, uncontenitore dove diversi soggetti gestiscono in modo differente le diver-se tipologie di trasporto. Questo rende difficile un eventuale posiziona-mento alla luce della classificazione utilizzata per le diverse tipologieitaliane. Inoltre, rispetto ai casi italiani nei quali le agenzie di gestione
L’organizzazione dell’agenzia per la mobilità a Londra
86
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
87
sono nate dalle precedenti aziende consortili o municipali, il caso londi-nese evidenzia due peculiarità.
La prima concerne l’istituto dell’Agenzia che era già presente nel1999, e che attraverso il Greater London Authority Act 1999 ha modifica-to il proprio assetto proprietario passando dal Governo all’amministra-zione locale.
La seconda è legata al delicato passaggio di gestione della LULche vede alcuni contrasti di natura politico-strategica tra l’amministrazio-ne locale e il Governo. In relazione a quest’ultimo punto è opportunorilevare che l’Agenzia si è posta come obiettivo quello di una gestioneintegrata del trasporto locale nelle sue diverse tipologie e perciò perce-pisce come particolarmente critico il passaggio della gestione della LUL.
Il sistema di tariffazione integrata a Londra di Gianluigi Mangia
L’area territoriale interessata dal sistema di integrazione tariffaria diLondra comprende oltre 7 milioni di abitanti. Il numero di occupati del-l’area della Grande Londra è cresciuto nel 1999 fino a sfiorare i 4,2milioni, con un incremento del 16% rispetto al minimo toccato nei primianni ‘909.
Un ulteriore indicazione della complessità del sistema della mobi-lità londinese è offerto dal fatto che nel 1999 1,1 milione di personeentravano durante un normale giorno della settimana tra le 7 a.m. e le10 a.m. nel centro di Londra.
Per quanto riguarda i criteri di organizzazione del sistema di inte-grazione tariffaria, l’area della Grande Londra è stata suddivisa in 10zone: 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D.
Passando a considerare le caratteristiche dei titoli di viaggi, in pri-mo luogo si deve sottolineare che l’offerta complessiva comprende com-plessivamente: 92 tipologie di biglietti; 178 tipologie di abbonamenti.
Tav. 4 Le tipologie di titoli di viaggio nell’area londinese
In maniera analoga a quanto fatto nei casi dei sistemi di integra-zione tariffaria precedentemente analizzati, i titoli di viaggio sono stati
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
Biglietti Abbonamenti
n° dei titoli di viaggio 92 n° dei titoli di viaggio 178durata temporale 0 durata temporale 0tipologie di utilizzatori 46 tipologie di utilizzatori 71aree territoriali 45 aree territoriali 107modalità di acquisto dei titoli di viaggio 1 modalità di acquisto dei titoli di viaggio 0
classificati in base ai seguenti criteri: •durata temporale, quando il prezzo di acquisto varia al variare del
limite temporale di validità del titolo;•tipologia di utilizzatore, quando il prezzo di acquisto varia al variare
delle caratteristiche dell’utilizzatore (militari, studenti, anziani, ecc…); •aree territoriali, quando il prezzo di acquisto varia al variare della
distanza percorribile oppure del numero di zone attraversabili con iltitolo di viaggio;
•modalità di acquisto, quando il prezzo di acquisto è influenzato dallemodalità di acquisto dei titoli (a rate, in contanti, età...).
Il titolo di viaggio cardine dell’intero sistema tariffario è rappre-sentato dalle travel card che consentono di viaggiare sui seguenti mezzi:LUL; Buses che portano l’indicazione del simbolo TfL; Croydon Tram-link; Docklands Light Railway; National Rail.
Esistono diverse tipologie di travel card, che sono definite in baseal numero di zone che danno diritto ad attraversare, alla tipologia di uti-lizzatori (bambini ed adulti), alla durata ed al periodo della settimana divalidità10.
Altra categoria di titoli di viaggio è rappresentata dalle LT Cards,che a differenza delle travel card, autorizzano il transito sui seguentimezzi: LUL; Buses; Tramlink; DLR.
Le LT Cards non hanno invece validità sui treni della National Rail,neppure nel caso delle linee interne alla Greater London.
Il sistema di tariffazione di Londra presenta quindi forme di inte-grazione, che però non si estende all’intero sistema. Infatti, i singolioperatori prevedono numerose tipologie di biglietti che hanno validitàlimitata alle linee del solo operatore che emette il titolo di viaggio. Adesempio, si possono considerare i single tickets che danno il diritto aviaggiare esclusivamente sui mezzi della LUL. Anche i single tickets sonoarticolati in diverse tipologie, in funzione delle zone attraversate e dellatipologia di utilizzatori.
L’organizzazione dell’agenzia per la mobilità a Londra
88
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
di PAOLO CANONICO
Il sistema di mobilità della regione Ile de FranceIl sistema di trasporto pubblico locale dell’agglomerato urbano di
Parigi, e più in generale dell’intera regione Ile-de-France che circonda lacapitale, è connotato da caratteristiche peculiari rispetto al resto dellaFrancia, comprensibili se si considera l’enorme importanza che questoterritorio riveste per il Paese sotto il profilo economico e sociale. Laregione Ile-de-France, infatti, pur costituendo solo il 2% della superficiedella Francia metropolitana, presenta undici milioni di residenti, cosìripartiti:•due milioni nella città di Parigi;•quattro milioni nei tre dipartimenti immediatamente periferici (la cosid-
detta petite couronne): Hauts-de-Seine (Nanterre), Seine-Sant Denis(Bobigny) e Val-de-Marne (Créteil);
•cinque milioni nei quattro dipartimenti più esterni (grande couronne):Essonne (Evry), Seine-et-Marne (Melun), Val-d’Oise (Cergy-Pontoise) eYvelines (Versailles).
Negli ultimi anni si è assistito ad una tendenza all’aumento dellapopolazione residente nella grande couronne, e ad una contemporaneariduzione degli abitanti nei comuni della petite couronne e della città diParigi. Nel complesso, con cinque milioni di posti di lavoro, l’Ile-de-France rappresenta circa il 23% dell’economia nazionale: il 33% di taliposti si trova all’interno della sola area di Parigi.
L’offerta di servizi pubblici di trasporto nella regione include larete RER, la metropolitana di Parigi ed una fitta rete di servizi di traspor-to di superficie.
La rete RER (Réseeau Express Régional) è un sistema di trasportosu ferro di grande capacità, che assicura collegamenti rapidi tra Parigi ele zone limitrofe, ma anche tra varie località della periferia, in primoluogo i comuni di più recente istituzione.
Essa comprende 4 linee, gestite a seconda delle tratte dalla RATPo dalla SNCF:•Linea A: Cergy-Poissy-Saint Germain en Laye/Parigi/Boissy-Saint Léger-
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA PER LA MOBILITÀ A PARIGIQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
89
Marne-la-Vallée-Chessy (gestita dalla SNCF nella tratta Cergy/Poissy eNanterre-Préfecture);
•Linea B: Aeroporto Roissy Charles de Gaulle-Mitry-Claye/Parigi-SaintRémy le Chévreuse-Robinson (gestita dalla SNCF nella tratta Roissy-Gare du Nord);
•Linea C: Montigny-Beauchamp-Argenteuil-Versailles-SaintQuentin/Pari-gi/Massy-Palaiseau-Dourdan-Saint Martin d’Etampes (a gestione esclu-siva della SNCF);
•Linea D: Orry la Ville-Gare du Nord-Chatelet-Les Halles-Gare de Lyon-Melun-Malesherbes (a gestione esclusiva della SNCF, ma con utilizzodei binari RATP della linea B tra Gare du Nord e Chatelet-Les Halles).
La metropolitana di Parigi comprende 16 linee, tutte gestite dallaRATP, per una lunghezza complessiva di 211,3 km e 380 fermate, loca-lizzate in città e nell’immediata periferia.
Il servizio di trasporto di superficie è costituita nell’area cittadinadi Parigi, dal servizio diurno di autobus della RATP, articolato in unarete del centro città (59 linee, 566 km e 1.836 fermate) e in una rete diperiferia (202 linee, 5.216 fermate e 2.191 km). La RATP offre poi, inperiferia, un servizio di tram, con 3 linee, 56 fermate e 32 km. Nellapetite couronne e nella grande couronne sono poi attivi i bus della reteOPTILE, per un totale di 928 linee.
La RATP gestisce poi anche il servizio di trasporto su funicolare diMontmartre.
Nel complesso, dunque, il 90% del volume di traffico della regio-ne è prodotto da due grandi imprese di trasporto collettivo:•la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), impresa pubblica
che eroga annualmente 2,6 miliardi di spostamenti, pari all’80% del tra-sporto pubblico, gestendo un sistema integrato di treni locali (RER,Réseau Express Régional), metropolitana, autobus, tram, nonché il col-legamento ferroviario automatico Orlyval. Rispetto alle tre aree territo-riali dell’Ile-de-France, la RATP agisce in situazioni competitive diffe-renti: nella città di Parigi è in situazione di monopolio, poiché gode diun diritto esclusivo di sfruttamento delle infrastrutture di trasporto esi-stenti sul territorio, conferitole dalla legge che regola l’assetto del tra-sporto pubblico locale nell’area di Parigi promulgata il 21 marzo 1948e tuttora in vigore; nella petite couronne (la zona formata dai diparti-menti dell’Ile de France immediatamente periferici rispetto alla città diParigi) opera in concorrenza con autobus di altri operatori privati (chesaranno menzionati tra breve); nella grande couronne (che comprendei dipartimenti più esterni) è presente in maniera limitata, con i tratti
L’organizzazione dell’agenzia per la mobilità a Parigi
90
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
91
periferici delle linee RER;•la SNCF- Ile-de-France (filiale della SNCF nazionale), che gestisce una
rete regionale su ferro di 900 km e trasporta 500 milioni di passeggeriall’anno.
Il residuo 10% del volume dei passeggeri trasportati in Ile-de-Fran-ce è ripartito tra una serie di imprese private di trasporto su gomma, cheagiscono al di fuori dell’area cittadina di Parigi, che sono state raggrup-pate fino al 2000 in due associazioni: l’APTR (Association Professionnel-le des Transporteurs Routiers) e l’ADATRIF (Association pour le Déve-loppement et l’Amelioration des Transports en Ile-de-France). Nel 2000APTR e ADATRIF hanno realizzato un processo di fusione, creando ununico network di operatori, OPTILE (Organisation Professionnelle desTransports d’Ile de France), che allo stato attuale comprende 96 impresedi trasporto per un totale di 5.000 dipendenti. Tali imprese sono ricon-ducibili, per l’assetto proprietario, ai principali gruppi di trasporto fran-cesi: CGEA, VIA GTI, TRANSDEV e Cariane.
L’Agenzia di Parigi: Syndicat des Transports d’Ile de France (STIF)La responsabilità di organizzare, sviluppare e pianificare il traspor-
to pubblico nella regione di Parigi (Ile-de-France) spetta dal 1959 alSyndicat des Transport Parisiens (STP), che nel dicembre 2000 si è tra-sformato in STIF (Syndicat des Transports d’Ile de France)11.
Lo STIF è governato da 34 consiglieri, 17 rappresentanti delGoverno, 7 rappresentanti degli otto dipartimenti dell’Ile de France, 5rappresentanti della Regione e 5 rappresentanti del Comune di Parigi. Èpresieduto dal Prefetto della Regione, che è anche il Prefetto di Parigi.
Tav. 1 Il modello del sistema di mobilità di Parigi
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
L’organico dello STIF è di 97 dipendenti, di cui 63 dirigenti e 34quadri e impiegati; l’Agenzia presenta una struttura organizzativa funzio-nale, come si evince dall’organigramma.
Tav. 2 Organigramma della STIF
Pianificazione degli investimentiI principali investimenti in infrastrutture di trasporto nella regione
Ile-de-France sono individuati e finanziati nell’accordo di programma fralo Stato (tramite il Fondo di Sviluppo Economico e Sociale, FDES) e laRegione, di durata pari a sei anni. Il finanziamento delle opere è perl’80% a carico di Stato e Regione, e per il 20% a carico delle imprese ditrasporto interessate.
L’azione dello STIF è consistita essenzialmente, sin dalla sua istitu-zione, nell’integrare la rete di trasporto collettivo tra le diverse modalitàdi trasporto, e nell’indirizzare lo sviluppo della rete sulla totalità dellasuperficie della regione Ile-de-France. In questa ottica lo STIF ha il com-pito di approvare l’accordo di programma, verificandone la coerenzacon le logiche di integrazione e di universalità del servizio.
Gestione del finanziamento per investimentiLo STIF ha il compito di gestire operativamente il finanziamento
per investimenti previsto nell’accordo di programma Stato-Regione,
L’organizzazione dell’agenzia per la mobilità a Parigi
92
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
93
mediante supervisione delle opere e supporto alle attività di projectmanagement. Finanzia poi direttamente una parte degli investimenti darealizzare per garantire la qualità dei servizi di trasporto (sicurezza,informazioni, accessibilità delle stazioni, parcheggi di interscambio),attraverso i proventi delle contravvenzioni della regione, destinati permetà allo STIF (circa 75 milioni di euro all’anno). Effettua inoltre a con-suntivo il monitoraggio degli investimenti realizzati.
Programmazione dei servizi minimiLo STIF ha la responsabilità della determinazione delle tratte: una
delle attività fondamentali dell’agenzia è infatti la redazione e l’aggiorna-mento annuale del programma dei servizi, che individua linea per lineai servizi offerti.
Definizione delle tariffe e supporto allo sviluppo dei sistemi tariffariLo STIF determina le tariffe praticate dagli operatori e promuove
l’integrazione tariffaria tra questi.
Affidamento e gestione delle gare per i serviziLo STIF affida agli operatori descritti in precedenza il compito di
erogare i servizi di trasporto pubblico locale.
Stipulazione dei contratti di servizioCome in ogni città della Francia, anche a Parigi i ricavi provenienti
dalla vendita dei titoli di viaggio non sono strutturalmente in grado dicoprire i costi di funzionamento del sistema di trasporto, né, a maggiorragione, di garantire gli investimenti necessari al suo sviluppo. Questasituazione deriva dalla duplice volontà dei poteri pubblici di favorire ilricorso al trasporto pubblico mediante tariffe convenienti e di controlla-re l’inflazione amministrando i prezzi dei beni/servizi di consumo pri-mario.
Oltre ai ricavi commerciali, si ricorre dunque ad altre fonti difinanziamento per riequilibrare i conti di gestione delle imprese di tra-sporto e garantirne la remunerazione:•fondi provenienti dalle imprese della regione, tramite il versement
transport, per compensare in particolar modo le perdite di introitidovute alle favorevoli condizioni di abbonamento concesse ai lavora-tori. Le imprese (sempre a mezzo del versement transport prelevatosulla massa salariale) finanziano anche una parte del costo degli spo-stamenti casa-lavoro dei loro dipendenti;
•fondi provenienti dalle collettività locali (per il 30%, articolato in muni-cipalità di Parigi per il 18% e i Dipartimenti per il 12%), dalla Regione(per il 19%) e dallo Stato centrale (per il 51%), tramite sovvenzioni alla
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
gestione sotto forma di ‘indennità compensatrici’ dell’insufficienza deiricavi commerciali (dovuta al basso livello generale delle tariffe), e sot-to forma di rimborso di perdite di ricavi dovute a particolari riduzionitariffarie concesse, per motivi sociali, ad alcune categorie di utenti(famiglie numerose, handicappati, ecc.).
La stipula del contratto di servizio tra lo STIF e le principali azien-de di erogazione dei servizi di trasporto (RATP e SNCF) ha modificato ilprecedente regime di ripartizione delle risorse e dei rischi commercialitra gli attori del sistema di mobilità12. In passato, il disavanzo di gestionedegli operatori era coperto dallo Stato e dai Dipartimenti della RegioneIle-de-France mediante la corresponsione di indennità compensatrici.
Tav. 3 Il flusso dei finanziamenti prima della riforma
Tale situazione non incentivava evidentemente gli operatori amassimizzare i risultati di gestione del servizio, sia in termini di incre-mento dei ricavi (vendita dei titoli di viaggio) sia in termini di conteni-mento dei costi.
Attualmente lo STIF acquisisce ed amministra i fondi provenientidal versement transport e dai sussidi pubblici, secondo lo schemadescritto in tavola 4.
Con il regime di contrattualizzazione tra STIF, RATP e SNCF, sisono affermati alcuni principi cardine:•una impostazione prospettica della quantificazione dei servizi di tra-
sporto nell’arco di quattro anni;•un maggiore dettaglio nella determinazione del servizio da erogare;•un’attribuzione di responsabilità agli operatori, conseguita sopprimen-
do l’indennità compensatrice, e attribuendo obiettivi di gestione in ter-mini di:
L’organizzazione dell’agenzia per la mobilità a Parigi
94
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
95
•costi;•qualità del servizio;•aumento dei ricavi provenienti dalla vendita dei titoli di viaggio.
Tav. 4 Il flusso dei finanziamenti dopo la riforma
Le sovvenzioni pubbliche a RATP e SNCF sono ora erogate esclu-sivamente dallo STIF, che le articola in:•compensazioni tariffarie calcolate in rapporto a prezzi di riferimento
stabiliti nel contratto;•remunerazione per l’attività di vendita dei titoli di viaggio corrispon-
dente al 6% dell’ammontare dei titoli venduti;•un contributo forfetario determinato anticipatamente in funzione delle
esigenze specifiche degli operatori (ad esempio, in relazione a oneridel personale o finanziari).
Tali sovvenzioni sono poi completate da un meccanismo di interes-samento delle aziende ai risultati di gestione. In particolare si prevedono:•un incentivo allo sviluppo del traffico, mediante un sistema che sensi-
bilizza l’operatore ai volumi di traffico ma limita la responsabilità del-l’impresa nel caso di scarti elevati tra previsioni e realizzo effettivo del-la vendita dei titoli di viaggio. Se lo scostamento è contenuto in unintervallo del 2% in più o in meno, la responsabilità dell’impresa èconsiderata preponderante. Se lo scostamento è più ampio, vieneimputato a fattori esterni alla responsabilità dell’impresa di trasporto.All’interno dell’intervallo del 2%, la ripartizione dei risultati di venditadei titoli di viaggio avviene per il 40% a vantaggio o svantaggio dell’o-peratore e per il 60% per lo STIF. All’esterno dell’intervallo lo scosta-mento in più o in meno incide solo sullo STIF.
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
•una penalizzazione entro un massimale per l’operatore in caso di man-cata erogazione dei servizi di trasporto;
•una previsione di qualità del servizio computata mediante 21 indicatoriper la RATP e 15 per la SNCF. Tali indicatori si riferiscono sia alla pun-tualità del servizio che alla pulizia delle stazioni e dei mezzi e alla dis-ponibilità dei distributori automatici di titoli di viaggio.
Il contratto con la SNCF prevede inoltre che questa diventi interlo-cutore unico dello STIF per quanto concerne il trasporto ferroviario, sti-pulando a sua volta un accordo con Réseau Ferré de France per lamanutenzione delle infrastrutture.
Gestione dei ricavi commerciali L’agenzia non gestisce ricavi commerciali, che invece sono introi-
tati e ripartiti fra le aziende di trasporto che aderiscono al sistema ditariffazione integrata.
Proprietà delle infrastrutture L’Agenzia detiene dal 1964 (prima in capo allo STP e poi allo
STIF) la proprietà delle infrastrutture di trasporto concesse originaria-mente a RATP (rete metropolitana, stazioni, depositi, pensiline).
Proprietà del materiale rotabileLa proprietà del materiale rotabile è delle imprese di trasporto
(RATP, SNCF, OPTILE), che ne realizzano la manutenzione e il rinnova-mento ordinario, oltre a curare la manutenzione ed il rinnovamento ordi-nario delle infrastrutture. Per finanziare tali spese la RATP ricorre alla rac-colta di capitali di prestito mediante ricorso al mercato finanziario.
Controllo attuazione contratto di servizio e controllo della qualitàpercepita dai clienti
I contratti di servizio stipulati dallo STIF con le imprese di traspor-to prevedono un monitoraggio continuo dei parametri attraverso riunio-ni trimestrali per accertare lo stato di esecuzione dei servizi, il livello ela struttura dei ricavi articolati per titoli di viaggio, e il livello di ciascunodegli indicatori di qualità. Lo STIF è poi anche tenuto per legge al con-trollo consuntivo dei bilanci delle imprese di trasporto
Altri servizi per la mobilitàLo STIF sta curando la realizzazione di un sistema avanzato di
bigliettazione elettronica che consentirà di sostituire i biglietti magneticicon una tessera a scalare senza contatto dotata di microchip. Gli ufficidello STIF conducono poi una serie di studi volti a diversificare i profili
L’organizzazione dell’agenzia per la mobilità a Parigi
96
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
tariffari e a prevedere le modificazioni future dei flussi di traffico e irelativi adeguamenti delle infrastrutture. Lo STIF conduce poi periodica-mente rilevazioni della qualità del servizio percepita dai passeggeri.
Volendo riassumere in breve i compiti principali dello STIF, taleagenzia: •coordina l’azione della RATP, della SNCF- Ile-de-France e delle imprese
private appartenenti al raggruppamento OPTILE; •incamera il versement transport e lo ripartisce tra gli operatori;•detiene dal 1964 la proprietà delle infrastrutture di trasporto gestite da
RATP;•determina le tariffe praticate dagli operatori e promuove l’integrazione
tariffaria tra questi;•è incaricato di formulare il piano dei trasporti con la descrizione delle
tratte da servire e di determinare la consistenza del servizio erogato;•approva i bilanci della RATP e della SNCF- Ile-de-France, che com-
prendono l’indennità compensatrice versata dallo Stato e dai diparti-menti per completare le risorse necessarie;
•si pronuncia (mediante l’espressione di un parere vincolante) sui gran-di investimenti di trasporto pubblico finanziati dallo Stato;
•promuove (grazie ai proventi delle contravvenzioni stradali in Ile-de-France, che gli vengono destinati per metà del loro ammontare) unapolitica di modernizzazione delle reti di trasporto finanziando specifi-camente investimenti in qualità del servizio in materia di regolarità del-le corse, sicurezza, creazione di punti di scambio intermodale, accessi-bilità delle infrastrutture.
Il sistema di tariffazione integrata a Parigi di Gianluigi Mangia
Nella regione dell’Ile-de-France l’offerta di servizi di trasportopubblico locale è garantita dalla Regie Autonome des Transports Pari-siens (RATP), la SNCF e da 96 imprese private, che sono raggruppatenell’associazione di categoria OPTILE.
Nel corso del 2000 RATP ha trasportato circa 2,6 miliardi di pas-seggeri pari a circa il 76% del totale realizzato nella regione dell’Ile-de-France.
Il sistema di integrazione tariffaria interessa l’intera regione dell’I-le-de-France che conta 11 milioni di abitanti ed è la più popolata diFrancia.
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
97
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
Tav. 5 I passeggeri trasportati da RATP (dati in milioni) 13
Il criterio di articolazione del sistema di tariffazione integrata è acarattere zonale; conseguentemente, la regione dell’Ile-de-France è statasuddivisa in 8 zone distinte, che si sviluppano a partire dal territorio delMunicipio di Parigi.
Per quanto riguarda il sistema dei titoli di viaggio, il perno centra-le è rappresentato dalla Carta Orange che può avere carattere: giornalie-ro; settimanale; mensile; annuale.
La Carta Orange, in maniera condizionata al tempo di validità con-sente, di realizzare la piena integrazione su tutta la rete. Il viaggiatoreche acquista la Carta Orange, acquisisce, infatti, il diritto a viaggiare perun numero di spostamenti illimitato all’interno delle zone indicate sullacarta e prescelte dal cliente.
Il processo di determinazione del prezzo dei singoli titoli di viag-gio che abilitano i viaggiatori ad attraversare differenti zone all’internodella regione parigina, risente di due distinti criteri, dal momento chenon si prende in considerazione solamente il numero di zone attraversa-te, ma anche la posizione delle zone prescelte all’interno dell’area diintegrazione.
In maniera analoga a quanto fatto nei casi dei sistemi di integra-zione tariffaria Metrebus e SITAM, i titoli di viaggio sono stati classificatiin base ai seguenti criteri:•durata temporale, quando il prezzo di acquisto varia al variare del
limite temporale di validità del titolo;•tipologia di utilizzatore, quando il prezzo di acquisto varia al variare
delle caratteristiche dell’utilizzatore (militari, studenti, anziani, ecc...); •aree territoriali, quando il prezzo di acquisto varia al variare della
distanza percorribile oppure del numero di zone attraversabili con iltitolo di viaggio;
•modalità di acquisto, quando il prezzo di acquisto è influenzato dallemodalità di acquisto dei titoli (a rate, in contanti ecc...)
L’organizzazione dell’agenzia per la mobilità a Parigi
98
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
dati 1998 dati 1999 variazione 20001998/1999
Metro 1157 1190 +2,9% 1247RER 368 384 +4,3% 404Paris Buses 350 353 +0,8% 358Suburban Buses and other traffic 540 560 3,7% 594RATP TOTALE 2415 2487 +3,0% 2603
Tav. 6 Le tipologie di titoli di viaggio nell’Ile-de-France
Il dato fondamentale che emerge dalla analisi riguarda la profondadifferenza nella numerosità delle tipologie previste per le due grandiclassi di titoli di viaggio: biglietti e abbonamenti. Infatti, il sistema ditariffazione in vigore nell’Ile-de-France offre complessivamente 14 tipo-logie di biglietti a fronte di 168 tipologie di abbonamenti. La ragione diciò può essere individuata nella volontà di realizzare un sistema di tarif-fazione che agevoli soprattutto gli utenti abituali dei servizi di trasportopubblico locale, attraverso la previsione di un numero elevato di tipolo-gie di titoli di viaggio, in modo tale da soddisfare le esigenze di un uni-verso di utilizzatori sufficientemente ampio.
Biglietti Abbonamenti
n° dei titoli di viaggio 14 n° dei titoli di viaggio 168durata temporale 0 durata temporale 0tipologie di utilizzatori 5 tipologie di utilizzatori 56aree territoriali 8 aree territoriali 84modalità di acquisto dei titoli di viaggio 1 modalità di acquisto dei titoli di viaggio 28
99
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
Il sistema di mobilità di LioneLa città di Lione ha da sempre beneficiato di un rilevante livello di
sviluppo economico14 ed è caratterizzata da un territorio morfologica-mente variegato (è ubicata alla confluenza di due fiumi - Saône e Rhône- e vede la presenza in aree ravvicinate sia di colline che di pianura). Leesigenze di mobilità degli abitanti sono da molti anni soddisfatte ricor-rendo a un sistema integrato, identificato con il marchio commercialeTCL (Transport en Commun Lyonnais) che prevede differenti modalitàdi trasporto: autobus, autobus elettrici a trolley, minibus elettrici, tram insede propria, metropolitana, funicolari.
Il sistema è fondato dall’inizio degli anni ’80 sul principio delladivisione dei ruoli (sancito in Francia dalla TPIL, legge sul trasportopubblico di interesse locale) tra un’autorità organizzatrice del trasporto(Syndicat des Transport pour le Rhône et l’Agglomeration Lyonnaise,SYTRAL), che deriva i suoi poteri dalla collettività locale, e un unicosoggetto privato (Société Lyonnaise de Transport en Commun, SLTC),che gestisce il complesso di mezzi ed infrastrutture (le quali sono diproprietà del SYTRAL)15.
Tav. 1 L’offerta di trasporto pubblico locale a Lione Fonte: Sytral, 2000
Il sistema di mobilità nell’agglomerato urbano ha subìto un cam-bio di orientamento negli indirizzi strategici di fondo a partire dal 1995,in coincidenza con un avvicendamento al vertice della CommunautéUrbaine de Lyon. La precedente presidenza aveva preso importanti
di PAOLO CANONICO
Modalità Linee km linee N° di mezziAutobus 84 1.110 789Minibus elettrici 6 26 24Autobus a trolley 8 37 87Autobus in servizio scolastico 111 1110 87Metro 4 27,2 178Funicolari 2 1,2 6Tram 2 18,7 n.d.
L’ORGANIZZAZIONE DELL’AGENZIA PER LA MOBILITÀ A LIONEQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
101
decisioni a favore del trasporto automobilistico (costruzione di un nuo-vo tratto di tangenziale, creazione di parcheggi per 6.000 posti nel cen-tro della città), e, malgrado l’apertura della quarta linea della metropoli-tana, l’uso dei mezzi pubblici ristagnava da diversi anni. L’elaborazionedi un Piano di mobilità urbana (PDU, Plan de Déplacements Urbains),documento reso poi obbligatorio da successive modifiche legislativeapportate alla LOTI (Legge di Orientamento dei Trasporti Interni), hasegnato una decisa inversione di rotta, in termini di scelte politiche loca-li, a favore dei trasporti in comune, in coerenza con i risultati dell’inda-gine sulle preferenze dei cittadini in tema di mobilità, condotta concadenza decennale e realizzata da ultimo nel 1995. Da essa era sostan-zialmente emerso un netto aumento (+25% rispetto alla precedente rile-vazione del 1986) del complesso degli spostamenti giornalieri, risultantedall’effetto combinato di un incremento sia dei residenti che delle esi-genze di mobilità avvertite da questi: Lione si inseriva ormai tra le gran-di metropoli europee, con circa quattro spostamenti giornalieri per abi-tante. Si era poi constatata una forte crescita (+38%) nell’uso dell’auto-mobile (incentivata del resto, come si è detto, da precise opzioni politi-che), mentre l’aumento in valore assoluto degli spostamenti effettuaticon mezzi pubblici era stato di molto inferiore (+17%).
Tav. 2 Evoluzione del ricorso alle varie modalità di trasporto per spostamenti urbaliFonte: Garnier et al. (2000), “Du PDU au tramway: l’expérience lyonnaise”, Trasport en commun n° 158, mars-avril.
Rispetto al totale degli spostamenti effettuati, anzi, la proporzionedi quelli effettuati con mezzi pubblici era in calo (tavola 2), nonostantela progressiva messa in funzione delle linee della metropolitana, a parti-re dal 1978.
L’organizzazione dell’agenzia per la mobilità a Lione
102
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
L’Agenzia di Lione: Syndicat des Transport pour le Rhône et l’Agglomeration Lyonnaise (SYTRAL)
Le competenze all’interno del sistema di mobilità lionese sono,come si è già accennato, ripartite tra il SYTRAL (Syndicat des Transportpour le Rhône et l’Agglomeration Lyonnaise) e la SLTC (Société Lyon-naise de Transport en Commun). In particolare, il SYTRAL rientra nellatipologia dei sindacati misti, costituiti cioè da enti locali di diversa natu-ra, e svolge funzioni di autorità organizzatrice: il comitato sindacale(l’organo decisionale) è composto da venti membri, dieci eletti dallaCommunauté Urbaine de Lyon e dieci dal Conseil Général du Departe-ment du Rhône. La sua missione consiste specificamente nel:•rappresentare le due collettività locali che lo esprimono;•definire la politica di trasporto pubblico;• delegare l’attuazione di tale politica ad un soggetto privato e control-
larne i risultati;• assicurare la realizzazione degli investimenti infrastrutturali e in attrez-
zature e detenerne la proprietà.Nel complesso, le risorse a disposizione del Sytral ammontano a
circa 300 milioni di euro all’anno, e sono così articolate:•150 milioni di euro dal versement transport;•120 milioni dai trasferimenti erogati a suo favore dalle collettività terri-
toriali (Communauté Urbaine de Lyon e Conséil Général du Rhône);•la restante parte (circa 30 milioni) dalla vendita dei titoli di viaggio e
da altri ricavi commerciali.I futuri sviluppi promossi dal SYTRAL confermano la convinzione,
ormai radicata, della necessità di una accentuata multimodalità nel siste-ma cittadino di mobilità. In questa prospettiva si spiegano la creazionedi grandi poli di scambio tra autobus, ferrovia, trasporti extraurbani,metropolitana, auto private, tram, adeguando le tariffe dei parcheggi aquelle dei mezzi pubblici e utilizzando anche tariffe combinate parcheg-gi/mezzi pubblici.
Pianificazione degli investimentiLa pianificazione degli investimenti è svolta dagli Enti Locali di cui
il SYTRAL è espressione, cioè Communauté Urbaine de Lyon e ConseilGénéral du Departement du Rhône.
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
103
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
Gestione del finanziamento per investimentiIl SYTRAL gestisce i finanziamenti e realizza gli investimenti plu-
riennali. Le due linee di tram hanno richiesto risorse per 350 milioni dieuro, ma sono state realizzate in tempi ristrettissimi (la decisione è statapresa nel 1997, e l’apertura si è avuta nel 2001). Si sta anche proceden-do a prolungare di 2,4 km una delle linee della metropolitana, con uninvestimento di 150 milioni di euro. Entrambi i progetti hanno ricevutouna sovvenzione statale per il 15% dell’importo complessivo.
Programmazione dei servizi minimiIl SYTRAL definisce la quantità e la qualità dei servizi di trasporto
erogati dalla SLTC.
Definizione tariffe e supporto sviluppo dei sistemi tariffariIl SYTRAL definisce le tariffe praticate sulla rete di trasporto urba-
no di Lione.
Affidamento e gestione delle gare per i serviziIl SYTRAL gestisce le varie fasi della gara per la selezione dell’o-
peratore di trasporto incaricato dell’esercizio dell’impresa di trasporto.
Stipulazione dei contratti di servizioLa tipologia di contratto che lega il SYTRAL alla SLTC si inquadra
nella fattispecie della delegazione di servizio pubblico, e si pervienedunque alla sua stipulazione secondo la procedura prevista dalla legge.Nello specifico, si tratta di un contratto della durata di 6 anni, di régieinteressée, a remunerazione mista fissa-variabile. Il forfait è predetermi-nato e rivalutato ogni anno secondo parametri di indicizzazione moneta-ria. La parte variabile prevede un aggancio ai ricavi provenienti dallavendita dei titoli di viaggio: se l’obiettivo in termini di ricavi è raggiunto,scatta una remunerazione aggiuntiva (bonus), altrimenti il compenso cor-risposto viene ridotto (secondo una scala prestabilita) di un ammontareche non può però superare un determinato plafond. I pagamenti, deter-minati su base annuale, vengono erogati dal SYTRAL alla SLTC ognimese, per dodicesimi.
Il contratto è stato rinnovato da ultimo nel 1998, con scadenzafine 2004, ed è basato su:•un obiettivo ambizioso di sviluppo del traffico prodotto e un perfezio-
namento del sistema di interessamento ai ricavi per l’operatore chegestisce il servizio;
•un ammontare di remunerazione forfettaria fissato a 200 milioni dieuro;
•attribuzione di risorse ulteriori per il miglioramento della sicurezza;
L’organizzazione dell’agenzia per la mobilità a Lione
104
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
•un rinnovato impegno del SYTRAL per la realizzazione di investimentiinfrastrutturali.
Il SYTRAL delega all’impresa di trasporto anche la manutenzionecomune (pulizia dei veicoli e riparazioni leggere), mentre la manuten-zione ‘pesante’ (riconversione o riammodernamento dei mezzi) rientranell’attività di investimento e compete all’autorità organizzatrice.
Gli indicatori su cui si misura la performance dell’operatore (ilquale viene eventualmente sanzionato con specifiche penalità in caso diinsufficienza qualitativa dell’offerta erogata) sono stati stabiliti in:•regolarità del servizio;•buono stato dei mezzi e dei locali destinati ad ospitare il pubblico;•disponibilità giornaliera dei veicoli;•proporzione di controlli anti-frode sugli spostamenti prodotti.
In occasione dell’ultimo rinnovo contrattuale tre operatori hannopresentato la propria candidatura iniziale, sulla base dei parametririchiesti dal SYTRAL per partecipare alla procedura (essenzialmente sirichiedeva esperienza e competenza già dimostrata nella gestione disistemi di trasporto paragonabili a quello di Lione). Il solo gruppo VIAGTI-Cariane, oggi KEOLIS, è però arrivato alla fase della presentazionedi un’offerta vera e propria, il che ha impedito nella fase di negoziazio-ne al SYTRAL di poter disporre di un rilevante potere contrattuale.
Occorre rilevare, a questo proposito, che poiché sia le infrastruttu-re che il materiale rotabile sono di proprietà del SYTRAL, in caso dicambio del soggetto che gestisce il servizio l’unico problema in terminidi trasferibilità di risorse verso il nuovo operatore si porrebbe rispetto alpersonale dell’impresa subentrante. A tale riguardo, peraltro, l’art. L 122-12 del Codice del Lavoro francese prevede l’obbligo di ripresa dellemaestranze impiegate alle stesse condizioni praticate dal precedentedatore di lavoro: questo elemento funge spesso, in generale, da deter-rente per l’ingresso di nuovi operatori, che hanno grandi difficoltà nelvenire a conoscenza di tutti gli accordi sindacali in essere.
Gestione dei ricavi commerciali Il SYTRAL introita i ricavi commerciali incassati in prima istanza
dall’operatore SLTC.
Proprietà delle infrastrutture Il SYTRAL ha la proprietà delle infrastrutture relative alle tramvie,
alla metropolitana, agli autobus, ai trolleybus e alle funicolari.
Proprietà del materiale rotabileIl SYTRAL procede regolarmente al rinnovo del parco bus, di sua
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
105
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
proprietà, acquistandone circa 50 all’anno, in funzione della vita mediadei veicoli (stimata in 7 anni e mezzo).
Controllo attuazione contratto di servizio e controllo qualitàpercepita dai clienti
Il contratto di servizio a remunerazione forfetaria stipulato dalSytral con SLTC viene periodicamente monitorato per accertare la quali-tà del servizio e, in caso di scostamenti, applicare all’operatore eventualipenalità.
Altri servizi per la mobilitàIl SYTRAL approva espressamente il Piano di Mobilità Urbana
(PDU). Il piano relativo all’intero agglomerato urbano, approvato dalSytral il 14 ottobre 1997, in accordo con le previsioni della legge n°96-1236 che orienta il contenuto dei PDU, si basa su una serie di disposi-zioni dal chiaro indirizzo di fondo.•Misure volte a moderare l’uso dell’auto privata: cessazione dello svi-
luppo delle corsie a scorrimento rapido, rinuncia a costruire nuovi par-cheggi in centro e concomitante aumento delle tariffe dei parcheggiesistenti, riequilibrio tariffario tra autostrade e strade ferrate in direzio-ne di Lione.
•Misure volte a sviluppare i trasporti pubblici: piuttosto che ampliare larete della metropolitana verso zone periferiche a bassa densità abitati-va, si è deciso di sviluppare un’offerta di spostamenti in superficie affi-dabile e gradevole per l’utente, ricercando anche per questo insiemedi modalità un livello di servizio paragonabile a quello della rete sot-terranea, e sottraendo spazio e corsie alla circolazione stradale libera;sono state identificate undici linee ‘forti’, riprendendo in parte linee dibus già esistenti, attraversando il centro dell’agglomerazione e serven-do i principali poli urbanizzati della periferia; in parallelo, il piano pro-pone uno sforzo aggiuntivo sul servizio extraurbano, basato su dueazioni indipendenti: da un lato, il miglioramento della rete ferroviariaconvergente verso Lione (in termini di infrastrutture e modalità digestione), dall’altro, l’estensione dell’integrazione tariffaria tra reteurbana ed extraurbana.
•Misure in favore di modalità di trasporto non inquinanti, creando lepremesse per un maggior ricorso alle due ruote.
Una delle azioni guida del PDU è stata la creazione di undicidirettrici di grande rilevanza per quanto riguarda il trasporto comune disuperficie. Rispetto ad esse, una simulazione sulla clientela prospetticacondotta con il software TERESE della società di consulenza SEMALY
L’organizzazione dell’agenzia per la mobilità a Lione
106
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
107
aveva messo in evidenza che quattro linee presentavano caratteristiche(in termini di numero di viaggiatori giornalieri per chilometri di linea)simili alle principali linee di tram moderni esistenti in Francia (tra 4 e 6mila viaggiatori per chilometro). Tra queste, due (quelle a congiungi-mento della stazione ferroviaria centrale Lyon-Perrache con i due cam-pus universitari di Bron e Villeurbanne) sono state prescelte per la rea-lizzazione dell’infrastruttura tranviaria inaugurata nel 2001, in grado dirispettare i parametri di affidabilità attesa ritenuti minimi per offrire unservizio di qualità alla clientela (tempi di trasporto garantiti, velocitàmedia di 20 km/h), avvalendosi di:•sede propria continua, senza condivisione con altri veicoli (eccetto
quelli di emergenza);•priorità totale ai semafori.
In questo modo, da un lato, sottraendo spazio all’auto privata si ècontribuito al riequilibrio della concorrenza modale, dall’altro, conferen-do al tram gli stessi vantaggi della metropolitana, si è restituita al tra-sporto in comune di superficie una effettiva competitività.
La relazione tra gli attori del sistema di trasporto pubblico locale aLione è riassunta nella tavola 3.
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
L’organizzazione dell’agenzia per la mobilità a Lione
108
QU
AD
ER
NI
CE
SI
TTav. 3 La relazione tra gli attori del sistema di trasporto pubblico locale a Lione
di MARCELLO MARTINEZ
Una analisi comparativa dei ruoli e delle funzioni delle agenzieper la mobilità operative in Italia al settembre 2002 è presentata nel qua-dro sinottico finale.
Dall’osservazione del quadro è facilmente rilevabile infatti come inItalia vi siano delle differenze rilevanti in tema di processi critici asse-gnati alla responsabilità delle agenzie all’interno dell’assetto ai sistemi ditrasporto locale.
In uno sforzo di sintesi è possibile tuttavia identificare tre modelliorganizzativi di agenzie, idealmente collocabili lungo un continuum cheevidenzi il potere e la responsabilità dell’agenzia in tema di controllo inautonomia dei processi critici identificati. Il primo modello si può deno-minare agenzia di gestione, il secondo agenzia esecutiva, il terzo agen-zia di supporto. Il posizionamento delle agenzie italiane in relazione almodello e all’area territoriale di riferimento è presentato nella tavolaseguente.
Tav. 1 I modelli di agenzia per la mobilità in Italia
Il modello di classificazione proposto rappresenta uno strumentodi posizionamento delle agenzie che riflette le contingenze specifichedella realtà italiana. L’analisi del sistema di mobilità di Londra, Parigi eLione ha fatto peraltro emergere le peculiarità delle agenzie costituite in
TRE MODELLI DI AGENZIA: AGENZIE DI GESTIONE, ESECUTIVE E DI SUPPORTOQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
Competenza territoriale Agenzie di gestione Agenzie esecutive Agenzie di supportoRegione Agenzia regionale ACaM, Campania
Emilia Romagna AReMol, LazioAgenzia regionale Abruzzo
Provincia Cons. ATR; Forlì Cesena Consorzio di PiacenzaCons. TRAM, RiminiCons. ATC, Reggio EmiliaSocietà per la mobilitàe il trasporto, Parma
Area Metropolitana ATAC, Roma Cons. per l’area di Torino Agenzia Milanese MobilitàSTA, Roma e Ambiente
Authority di Genova
109
quelle città. È emerso infatti che TfL è una sorta di meta-agenzia, uncontenitore dove diversi soggetti gestiscono in modo differente le diver-se tipologie di trasporto.
Lo STIF di Parigi sembra collocarsi a metà strada tra agenzia digestione e esecutiva, poiché detiene la responsabilità della gestione dialcune delle infrastrutture di trasporto (le infrastrutture in sede fissa con-cesse in gestione a RATP), ma gestisce direttamente i flussi di finanzia-mento pubblico al sistema di mobilità, non gli asset.
Il SYTRAL di Lione può invece configurarsi come agenzia digestione, controllando direttamente gli asset del sistema di mobilità edelegando all’operatore privato esclusivamente l’erogazione del serviziodi trasporto.
Più precisamente infatti le agenzie di gestione sono caratterizzatedalla responsabilità loro conferita in termini di gestione degli asset(infrastrutture e/o veicoli) necessari per l’erogazione del servizio di tra-sporto. Si tratta di un modello coerente con le indicazioni dell’art. 35della legge finanziaria 2002 che è facile riconoscere nella forma di agen-zia costituita a Roma, a Forlì Cesena, a Rimini, a Parma, a Reggio Emilia.
Le agenzie di gestione si sono sviluppate per scorporazione dalleprecedenti aziende consortili o municipali cui era affidata la responsa-bilità dei servizi di trasporto pubblico locale. Di conseguenza assumo-no parte dell’organico di tali aziende, e in particolare impegnanoaddetti nelle attività di manutenzione delle reti, degli impianti e dei vei-coli o nella amministrazione dei processi di gestione degli stessi. Tipi-camente il controllo di tali agenzie è mantenuto, anche in forma asso-ciata, dagli enti locali (Province e Comuni) cui sono delegate dalla cor-rispondente legge regionale le funzioni di programmazione e ammini-strazione dei sistemi di trasporto e ad esse gli enti locali trasferisconoanche le responsabilità in tema di amministrazione delle procedure diaffidamento concorsuale e di stipulazione dei contratti di servizio. Seb-bene in una fase intermedia e transitoria alcune agenzie di gestioneancora controllano le imprese di trasporto che erogano il servizio (è ilcaso di Rimini, Forlì-Cesena) in genere si prevede che a regime il con-trollo proprietario delle imprese pubbliche che potranno parteciparealle gare sarà prevalentemente degli enti locali (come già avviene aRoma e a Parma).
La costituzione e la presenza di agenzie di gestione nei sistemi ditrasporto locale in Italia sembra agevolare il processo di introduzione dimeccanismi concorrenziali di affidamento del servizio da diversi punti divista, infatti:
Tre modelli di agenzia: agenzie di gestione, esecutive e di supporto
110
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
1) la costituzione di agenzie ha consentito la trasformazione societaria eorganizzativa delle aziende pubbliche di trasporto;
2) le agenzie di gestione hanno assorbito parte delle attività che avreb-bero potuto limitare la competitività delle imprese pubbliche di tra-sporto dal punto di vista della struttura dei costi e degli organici;
3) l’accentramento di personale nelle agenzie consente di salvaguardarel’occupazione del settore e di sviluppare conoscenze e competenzein termini di pianificazione e programmazione;
4) l’accentramento in società o consorzi pubblici degli asset (infrastrut-ture, impianti e a volte anche veicoli) può facilitare in linea teorica ilsubentro di imprese a seguito di procedure di affidamento concor-suale, in coerenza con le indicazioni della legge nazionale n°166 del2002;
5) il controllo pubblico degli asset affidati alla gestione dell’agenzia puòsalvaguardare la realizzazione e la gestione di investimenti in infra-strutture e veicoli.
È bene evidenziare che la costituzione di una agenzia di gestioneè facilitata se già in quel sistema di trasporto locale è presente una orga-nizzazione (azienda, consorzio) nella quale sono stati accentrati gliasset, proprio come si riscontra a Roma o in alcune Province dell’EmiliaRomagna. Laddove invece gli asset sono separati in diverse organizza-zioni, controllate magari da diversi enti locali o anche da privati, la defi-nizione di una agenzia di gestione potrebbe essere un risultato troppolungo e complicato da conseguire. In tali contesi, invece, potrebbe esse-re più facile sviluppare agenzie esecutive o di supporto.
Nel secondo modello, denominato agenzia esecutiva, infatti alleagenzie non è conferita la proprietà e la gestione degli asset, ma è affi-data solo la responsabilità dei processi amministrativi connessi alla rego-lazione, coordinamento, programmazione, affidamento e monitoraggiodell’erogazione dei servizi. Alle agenzie esecutive le Regioni e gli entilocali delegano solo poteri quali ad esempio la gestione delle proceduredi affidamento concorsuale e la stipulazione dei contratti di servizio.Tipicamente tale modello di agenzia si riconosce nell’Agenzia RegionaleTrasporti pubblici dell’Emilia Romagna e nel Consorzio per la mobilitànell’ambito metropolitano torinese, o probabilmente nel consorzio difunzioni della Provincia di Piacenza.
È stata infatti evidenziato, ad esempio, come nel primo caso l’a-genzia relativamente ai servizi ferroviari curi la programmazione dei ser-vizi minimi, gestisca le procedure di affidamento concorsuale, stipuli icontratti. Il consorzio piemontese invece si sostituisce agli enti che vi
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
111
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
partecipano relativamente alla gestione delle procedure di affidamentoconcorsuale e di stipulazione dei contratti di servizio per tutte le modali-tà di trasporto dell’area metropolitana torinese. Sembra infine che alconsorzio di Piacenza si trasferiscano solo i compiti di progettazione egestione delle procedure di affidamento concorsuale dei servizi, mentrela reti le infrastrutture sono ancora controllate direttamente dagli entilocali.
I principali vantaggi connessi alla costituzione di agenzie esecuti-ve sembrano essere i seguenti:1) le agenzie si sviluppano come un centro di competenze professionali
in grado di risolvere il problema della separazione fra livello decisio-nale politico e livello tecnico;
2) la costituzione di un unico centro di competenze su un territorioconsente di aggregare risorse professionali di più enti locali, svilup-pando economie di scala e di conoscenza;
3) la creazione di un agenzia separata dagli enti locali (anche se da essicontrollata) può velocizzare le modalità di amministrazione delle pro-cedure di programmazione, affidamento e contrattualizzazione deiservizi minimi;
4) non attribuire alle agenzie la proprietà e la gestione degli asset essen-ziali per l’erogazione ei servizi rende le agenzie snelle e flessibili,anche dal punto di vista occupazionale e dei costi di funzionamento;
5) tali agenzie possono essere utili per amministrare i rapporti con Tre-nitalia e RFI, dato che in questi casi la Regione non detiene né laproprietà delle rete né degli altri beni e impianti essenziali per l’ero-gazione dei servizi ferroviari;
6) tali agenzie possono essere necessarie quando gli asset essenziali perl’erogazione dei diversi servizi sono di proprietà di diversi soggettipubblici e privati e sarebbe difficile e complesso aggregarli in un’uni-ca società;
7) la agenzie consentono di coordinare e integrare le procedure diamministrazione dei servizi in un sistema di trasporto locale in cui leresponsabilità sono separate fra una molteplicità di enti.
La costituzione delle agenzie esecutive richiede che le Regioni egli enti locali deleghino parte dei loro poteri alla responsabilità dell’a-genzia. In molti casi tale delega non è realizzabile, sia per l’assenza diuna volontà politica di affidare tali funzioni all’esterno delle amministra-zioni esistenti, sia per la presenza di vincoli statutari, sia per la necessitàdi rendere la riforma graduale e non traumatica per l’assetto istituzionalee competitivo dei sistemi di trasporto. In questi casi si è rivelato tuttavia
Tre modelli di agenzia: agenzie di gestione, esecutive e di supporto
112
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
utile introdurre agenzie in grado di supportare le Regioni e gli enti localinell’attuazione della riforma. Le agenzie di supporto infatti, non sonotitolari né della proprietà e della gestione degli asset, né della responsa-bilità dei processi amministrativi legati alla pianificazione programma-zione affidamento e contrattualizzazione dei servizi. Il loro ruolo è dielaborare piani, programmi, contratti, procedure, per conto delle ammi-nistrazioni regionali, provinciali o comunali, le quali assumeranno inpieno con le loro strutture il compito di approvarli, attuarli, e renderlioperativi. Il modello delle agenzie di supporto si riscontra nell’AgenziaCampana per la Mobilità sostenibile, nell’Agenzia Regionale per la Mobi-lità del Lazio, nell’Agenzia Milanese per la mobilità e ambiente e nellafutura Authority del Comune di Genova.
I vantaggi principali di tale modello sono i seguenti:1) si costituisce con estrema rapidità e con limitato impatto sull’assetto
delle relazioni proprietarie e contrattuali fra i soggetti del sistema ditrasporto pubblico locale;
2) si tratta di strutture snelle, flessibili e da limitati costi di funziona-mento;
3) si tratta di centri di eccellenza che raccolgono e valorizzano, soprat-tutto mediante contratti e affidamenti a terzi, risorse professionali ecompetenze già presenti in enti, centri di ricerca, università presentisul territorio;
4) si tratta di centri di supporto alle decisioni dei policy maker, necessa-ri nella fase di avvio della riforma del trasporto locale in cui il ruolopolitico delle Regioni e degli enti locali è ancora fondamentale;
5) tali agenzie possono essere necessarie quando gli asset essenziali perl’erogazione dei diversi servizi sono di proprietà di diversi soggettipubblici e privati e sarebbe difficile e complesso aggregarli in un’uni-ca società;
6) tali agenzie consentono di coordinare e uniformare le procedure diamministrazione dei servizi in un sistema di trasporto locale in cui leresponsabilità sono separate fra una molteplicità di enti.
In conclusione, tutti e tre i modelli di agenzia per la mobilità pos-sono indubbiamente rappresentare una efficace risposta alla esigenza dirazionalizzazione dei diversi sistemi di trasporto locale in Italia. Tuttavia,posto che la loro collocazione naturale è “a metà” fra gli organi politicie le imprese di trasporto, appare che numerose e complesse sono leproblematiche che è necessario affrontare.
In particolare, nel caso di costituzione di un’agenzia di gestioneper scorporazione da una preesistente impresa o di un consorzio
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
113
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
responsabile del trasporto, appaiono cruciali almeno due questioni: l’at-tribuzione all’agenzia o all’impresa di trasporto della proprietà della rete(sia ferroviaria sia i depositi per i servizi filotranviari) e dei veicoli; e lalegittimità, in regime di affidamento concorsuale di responsabilità dell’a-genzia stessa, di un controllo proprietario esercitato dall’agenzia sulleimprese di trasporto.
Nel caso di costituzione di un’agenzia esecutiva per aggregazioneo associazione di più enti locali, invece, i problemi principali riguardanosia la modalità di costituzione della stessa (volontaria cioè mediantelibera associazione, o “imposta” dal legislatore regionale) sia la possibili-tà di assegnare alla agenzia la titolarità dei finanziamenti stanziati dallaRegione per i servizi minimi e dagli enti locali per i servizi aggiuntivi.
La presenza e la costituzione di agenzie esecutive e soprattutto diagenzie di supporto, poi, rappresenta di per sé il tentativo di aggregareo sviluppare nuove competenze e conoscenze utili per il miglioramentoe l’innovazione del trasporto pubblico. Occorre tuttavia evidenziarecome non manchino fattori di resistenza e di avversione alla loro intro-duzione soprattutto a causa di due problematiche.
In primo luogo, occorre evitare che la costituzione di una agenziadi supporto rappresenti una duplicazione delle esistenti strutture regio-nali o degli enti locali. Laddove gli assessorati ai trasporti sono già dotatidelle competenze tecniche e amministrative necessarie per gestire il pro-cesso di affidamento concorsuale dei servizi e la conseguente trasforma-zione del settore, è bene che la loro responsabilità vada sostenuta e raf-forzata, come già sperimentato in altre realtà europee.
In secondo luogo, anche laddove la costituzione di una agenzia disupporto rappresenti un’innovazione istituzionale necessaria e di utilitàper le motivazioni in precedenza evidenziate, occorre sicuramente valu-tare attentamente se è necessario costituire strutture “pesanti” sia dalpunto di vista dell’organico che dal quello dei sistemi di governance erappresentanza. Già altre agenzie create in settori delle public utilities edel welfare, hanno infatti dimostrato, proprio nell’ambito del processodi decentramento di compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali, glieffetti negativi e controproducenti di una eccessiva burocratizzazione epoliticizzazione attribuita ad organi, in realtà nati con funzioni di sup-porto tecnico.
Tre modelli di agenzia: agenzie di gestione, esecutive e di supporto
114
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativi
115
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
Caratteristiche generali
Forma giuridica Enti proprietari Addetti Budget(costi complessivi)
Agenzia Ufficio amministrativo - 30 n.d.Trasporti Pubblici della RegioneEmilia Romagna Emilia RomagnaAgenzia Consorzio Provincia di 60 n.d.per la mobilità Forlì-Cesena eForlì-Cesena i 29 comuni
del bacinoAgenzia TRAM Consorzio Provincia di Rimini 35 n.d.Rimini e i 25 comuni
del bacinoAgenzia S.p.a. Comune di Roma 270 STA STA 127 miliardiATAC-STA Roma 700 ATAC ATAC n.d.Agenzia Milanese S.r.l. Metropolitana 40 9 miliardiMobilità e Ambiente Milanese
Processi di pianificazione e implementazione degli investimenti
Pianificazione investimenti Gestione del finanziamento Controllo dell’attuazioneper investimenti degli investimenti
Agenzia L’Agenzia supporta la Giunta L’Agenzia amministra il L’Agenzia esercita ilTrasporti Pubblici Regionale nella definizione finanziamento degli investimenti controllo sugliEmilia Romagna degli Accordi di Programma sui beni e delle infrastrutture investimenti realizzati
ferroviarie, in concorso con il Demanio regionale, gestisce l’assegnazione dei contributi ed elabora proposte di criteri per la valutazione degli investimenti per i servizi autofilotranviari
Agenzia - L’Agenzia gestisce le risorse -per la mobilità finanziarie e i contributi perForlì-Cesena l’esercizio dei servizi
autofilotranviari e per i relativi investimenti
Agenzia TRAM - L’Agenzia è responsabile della -Rimini gestione delle risorse e dei
contributi per l’esercizio e per gli investimenti.
Agenzia - - ATAC S.p.a. si occupaATAC-STA di definire e attuare iRoma i piani di investimento
definiti nella Conferenza dei Servizi per lo sviluppodelle infrastrutture e dei mezzi del TPL
Agenzia Milanese L’Agenzia Milanese realizza - -Mobilità e per conto del Comune diAmbiente Milano il piano urbano
della mobilità
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
Tre modelli di agenzia: agenzie di gestione, esecutive e di supporto
116
Processi di programmazione e affidamento dei servizi minimi
Programmazione Affidamento e Stipulazione contratto Monitoraggio eservizi minimi gestione gare di servizio controllo attuazione
per i servizi minimi contratto di servizioAgenzia L’Agenzia supporta L’Agenzia cura lo L’Agenzia stipula L’Agenzia verificaTrasporti Pubblici la Giunta regionale svolgimento delle contratti di servizio l’adempimentoEmilia Romagna per l’attuazione procedure concorsuali per lo svolgimento dei contratti relativi
dell’attodi indirizzo per l’affidamento dei servizi ferroviari ai servizi ferroviaried effettua la del servizio di interesse regionaleprogrammazione dei ferroviario e per l’affidamentoservizi minimi ferroviari dell’infrastruttura
di proprietà regionaleAgenzia L’Agenzia è responsabile L’Agenzia provinciale L’agenzia stipula L’Agenzia verificaper la mobilità dell’attività di è responsabile per contratti di servizio con lo svolgimentoForlì-Cesena programmazione dei l’affidamento le imprese responsabili dei servizi rispetto
servizi di trasporto su dei servizi non affidati del servizio alle prestazionigomma nel bacino direttamente ad descritte nelprovinciale E-Bus e Setram. contratto di servizio
e agli standard della carte dei servizi
Agenzia TRAM L’Agenzia è responsabile All’Agenzia è affidata L’agenzia stipula L’Agenzia verificaRimini dell’attività di la responsabilità delle contratti di servizio lo svolgimento dei
programmazione dei procedure concorsuali con le imprese servizi rispetto alleservizi di trasporto su per l’affidamento responsabil prestazioni descrittegomma nel bacino dei servizi i del servizio nel contratto provinciale di servizio
Agenzia ATAC S.p.a. realizza L’agenzia ATAC STA ATAC S.p.a. definisce, ATAC S.p.a. realizzaATAC-STA la programmazione affiderà mediante negozia e stipula i il monitoraggio e ilRoma dei servizi di TPL gara tutti i servizi contratti di servizio controllo contrattuale
di TPL relativi con le imprese della qualità eall’area metropolitana affidatarie quantità dei servizidi Roma (oggi tale erogati dagliruolo è svolto operatoriparzialmente da ATAC S.p.a.).
Agenzia Milanese È responsabilità L’Agenzia fornisce al L’Agenzia fornisce un L’Agenzia fornisce Mobilità e dell’Agenzia la Comune un supporto supporto tecnico al un supporto tecnicoAmbiente redazione e tecnico predisponendo Comune predisponendo al Comune
l’aggiornamento del gli atti e i documenti i contratti di servizio partecipando alProgramma triennale per le procedure di da stipulare con le controllodei servizi affidamento aziende affidatarie dell’erogazione
concorsuale dei servizi dei servizi dei servizi
Processi di gestione degli asset
Proprietà asset Manutenzione veicoli Affidamento della gestione delle infrastrutture
AgenziaTrasporti - - L’Agenzia cura la gestionePubblici del processo affidamentoEmilia Romagna delle infrastrutture
ferroviarie diproprietà regionale
Agenzia L’Agenzia ha la proprietà L’Agenzia effettua la -per la mobilità di tutti gli asset, manutenzione degliForlì-Cesena compresi gli autobus autobus
117
Agenzia L’Agenzia è proprietaria delle - -TRAM infrastrutture per i serviziRimini autofilotranviari: impianti
filoviari, paline di fermata, pensiline, e il deposito
Agenzia A regime ATAC S.p.a. L’Agenzia effettua la -ATAC-STA avrà in dotazione tutte le manutenzione dei veicoliRoma infrastrutture e i veicoli per
il trasporto sia su gomma sia su ferro.
Agenzia Milanese - - -Mobilità e Ambiente
Processi commerciali
Definizione tariffe e gestione Monitoraggio e controllo Gestione Ricavi del sistema tariffario integrato qualità percepita dai clienti Commerciali
Agenzia L’Agenzia ha seguito L’Agenzia rileva la qualità -Trasporti Pubblici l’implementazione del percepita dagli utentiEmilia Romagna progetto STIMER in ambito regionaleAgenzia L’Agenzia è responsabile L’Agenzia controlla la L’Agenzia effettua laper la mobilità della formulazione di proposte qualità del servizio gestione dei ricaviForlì-Cesena ed attuazione della politica percepita dai clienti e commerciali
tariffaria e della zonizzazione realizza tutte le attivitàdel territorio ai fini tariffari necessarie per il
miglioramento del servizioAgenzia L’Agenzia è responsabile - L’Agenzia effettua laTRAM della progettazione e gestione gestione dei ricaviRimini della zonizzazione del territorio commerciali
ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell’eventuale attività di riparto qualora l’integrazione comprenda anche altri soggetti
Agenzia ATAC S.p.a. realizza la ATAC S.p.a. è responsabile ATAC acquisisce e gestisceATAC-STA gestione dell’integrazione del monitoraggio della i ricavi da traffico relativiRoma tariffaria, curando e qualità del servizio ai servizi di trasporto
sviluppando il sistema percepita dagli utenti erogati dalle impresetariffario integrato Metrebus affidatarie
Agenzia Milanese - Per il Comune di Milano, -Mobilità e l’Agenzia svolge ilAmbiente monitoraggio della customer
satisfaction, rilevando la qualità del servizio di trasporto percepita dai clienti.
Le agenzie di mobilità: assetto e processi organizzativiQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
capitolo
118
QU
AD
ER
NI
CE
SI
TProcessi aggiuntivi
Gestione banche dati Altri servizi per la mobilitàAgenzia Trasporti Pubblici L’Agenzia cura ed aggiorna L’Agenzia realizza indagini sui temiEmilia Romagna una serie di banche dati. della mobilità, gestisce il sistema
informativo di monitoraggio e promuove attività formative
Agenzia per la mobilità - L’agenzia effettua la gestione dellaForlì-Cesena sosta, e la gestione dei servizi scolasticiAgenziaTRAM - L’Agenzia è responsabile dellaRimini progettazione, organizzazione e
amministrazione dei servizi complementari per la mobilità
Agenzia STA ha al suo interno l’Osservatorio La nuova Agenzia ATAC-STA saràATAC-STA permanente sul traffico, un sistema responsabile anche delle attivitàRoma informativo su tutti i principali strumentali di pianificazione e
indicatori della mobilità gestione dei servizi della mobilitàattualmente svolte da STA
Agenzia Milanese L’Agenzia sarà responsabile della L’Agenzia è responsabile dellaMobilità e costituzione e gestione progettazione, organizzazione eAmbiente dell’osservatorio amministrazione dei servizi
del traffico e della banca dati complementari per la mobilità e la tutelae salvaguardia dell’ambiente
1 Fonti Annuario ASSTRA 2001; sono inclusi i dati delle ferrovie regionali. 2 Fonti Annuario ASSTRA 2001; non sono inclusi i dati Trenitalia. 3 Fonti Annuario ASSTRA 2001; sono inclusi i dati delle ferrovie regionali.4 Fonti Annuario ASSTRA 2001; non sono inclusi i dati Trenitalia.5 Le corone distano tra loro tra 4 e 7 chilometri. La distanza è variabile dal momento
che bisogna tener conto del fatto che le linee di separazione tra le corone devonocoincidere con i confini dei territori dei Comuni che partecipano al sistema SITAM.
6 In particolare, la validità temporale prevede 60’ per la prima zona, ai quali si aggiun-gono 15’ per ogni successiva zona coperta dal titolo di viaggio.
7 In particolare, la validità temporale prevede 90’ per l’area piccola, ai quali si aggiungo-no 15’ per ogni successiva semizona coperta dal titolo di viaggio.
8 I dati si riferiscono ai primi dieci mesi dell’anno 2002. 9 Transport for London (2000), Transport Statistics for London 2000, Transport for Lon-
don, London. 10 Esistono specifiche travel card con validità limitata al fine settimana. 11 Il sistema del trasporto pubblico locale francese si basa su una normativa che ha
conosciuto, a partire dal 1982, una progressiva tendenza al decentramento a beneficiodei tre livelli di aggregazione del potere amministrativo territoriale: (in ordine crescen-te di dimensioni) i comuni, i dipartimenti, le regioni. Mentre nella regione Ile-de-Fran-ce (vale a dire l’area che circonda Parigi, e che rappresenta un’unità amministrativaautonoma) l’organizzazione del trasporto pubblico assume un assetto particolare, nelresto della Francia il quadro di base è definito dalla LOTI, legge di orientamento deitrasporti interni (Loi 30 Décembre 1982 n°82-1153), che, combinandosi con un prece-dente provvedimento legislativo emesso nello stesso anno, ha abolito il controllo par-ziale dello Stato centrale sugli enti locali in materia di trasporti pubblici a rilevanzaurbana, extraurbana o regionale, stabilendo che, in generale, tutti i servizi pubblici nelsettore dei trasporti sono a carico dello Stato, degli enti locali e degli enti da questicostituiti, e possono essere forniti da aziende private o pubbliche.
12 Allo stato attuale il contratto di servizio tra STIF e altri operatori privati di reti di auto-bus (OPTILE) non è stato ancora stipulato. Tale contratto sarà riferito alla rete e nonalle singole linee, come avviene in quello con la RATP.
13 Fonte STIF (2000), Annual Report, STIF, Paris.14 È il primo centro al mondo per l’industria tessile di punta (fibre ad alta tecnologia), è
fra le principali regioni europee per l’industria chimica e farmaceutica, gode di rilevan-ti flussi turistici (è stata classificata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO per la ric-chezza di opere d’arte rinascimentali) ed è sede di grandi istituzioni mondiali (l’Inter-pol, Euronews).
NOTEQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
119
15 Il coordinamento e la guida delle attività di trasporto urbano in Francia rientra nellasfera di competenze delle Autorità Organizzatrici, agenzie per la mobilità istituite conla TPIL del 1979 (legge sul trasporto pubblico di interesse locale). Il ruolo dell’Autoritàorganizzatrice viene rivestito dal comune sul territorio del quale il servizio di trasportoviene effettuato, o dall’organismo pubblico locale creato all’uopo, su iniziativa deicomuni aventi interesse alla realizzazione del servizio di trasporto. Può trattarsi, inquesta seconda eventualità, di un sindacato di comuni dotato di quest’unica compe-tenza (c.d. SIVU), o di competenze multiple tra le quali rientra quella inerente al tra-sporto pubblico urbano (SIVOM), o ancora di un organismo pubblico di cooperazioneintercomunale a fiscalità propria, che annovera la competenza relativa al trasportopubblico urbano tra le sue prerogative obbligatorie (ad es. le comunità urbane – comea Bordeaux) o opzionali (nel caso dei distretti e delle comunità di comuni). Infine,può trattarsi di un sindacato misto (come nel caso del Sytral di Lione) quando l’organi-smo pubblico di cooperazione creato comprende soggetti appartenenti a categorie dif-ferenti (cioè comuni, gruppi di comuni, dipartimenti, ecc.).
Note
120
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T
AA.VV., (2001), TPL 2000 n°2, Monitoraggio dello sviluppo del trasporto pub-blico locale, Luglio.ATM, (2001), Carta della mobilità, Milano. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, (2001), Parere relativoalle distorsioni della concorrenza in tema di utilizzo dei contributi pubblici daparte delle società di trasporto pubblico locale, febbraio.Boitani A. e Cambini C., (2001), La riforma del trasporto pubblico locale inItalia: problemi e prospettive, work in progress. Commissione Europea, (1995), “La rete dei Cittadini”, Bollettino dell’UnioneEuropea, supplemento 4/95.Commissione Europea, (2000), Proposta di regolamento del Parlamento euro-peo e del Consiglio relativo all’azione degli stati membri in tema di obblighi diservizio pubblico e di aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel setto-re del trasporto di passeggeri per ferrovia, su strada e per via navigabile inter-na, Bruxelles, 26.7.2000, COM (2000) 7 definitivo, 2000/0212 (COD).Commissione Europea, (2001), White paper: European transport policy for2010: time to decide, Brussels, settembre, COM (2001) 370.De Vita P., Martinez M., (2001) “Flessibilità e performance dei sistemi dipublic utility”, in Costa G., (a cura di), Flessibilità e performance. L’organizza-zione aziendale tra old e new economy, ISEDI, Torino.Dobias G., (2001), “La contractualisation dans les transports publics en Ile deFrance”, Transports, n°405, janvier-fevrier.Garnier et al., (2000), “Du PDU au tramway: l’expérience lyonnaise”, Trasporten commun n°158, mars-avril.Isotope, (1998), Improved structure and organization for urban transport ope-rations of passengers in Europe, European Communities.Lecler S., (2001), “Taxes collected on employers: the French ‘versement trans-port’”, in Proceedings of the workshop “What public transport authorities forthe European metropolitan areas?”, Barcelona, 8 november.Martinez M., (1998), “La città di Londra”, (cap. 4) in Mercurio R., Consiglio S.,(a cura di), Coordinamento e competizione tra le aziende di trasporto pubblicourbano in Europa, CUEN, Napoli.Martinez M., (1999), “Modelli organizzativi per lo sviluppo del leasing nelmercato del materiale rotabile”, in IncontriCesit, n°1, giugno.Martinez M., (2000 a), “I modelli organizzativi e contrattuali per la pianifica-zione, regolazione costruzione e gestione dei sistemi di trasporto pubblico loca-
BIBLIOGRAFIAQ
UA
DE
RN
IC
ES
IT
121
le” (cap 1), in Cesit, Organizzazione e competizione nel trasporto locale inEuropa, Gangemi, RomaMartinez M., (2000 b), “Le potenzialità e gli effetti dei diversi modelli organiz-zativi e contrattuali” (cap 3), in Cesit, Organizzazione e competizione nel tra-sporto locale in Europa, Gangemi, Roma.Martinez M., (2002), “La differenziazione e la contendibilità dei mercati regio-nali e locali dei servizi di trasporto pubblico in Italia”, in “Ingegneria Ferrovia-ria”, n°8, agosto.Mercurio R., Consiglio S., (1998), (a cura di), Coordinamento e competizionetra le aziende di trasporto pubblico urbano in Europa, CUEN, Napoli.Mercurio R., Martinez M., (1999), Il trasporto ferroviario in Europa. Organiz-zazione e regolazione e del mercato, Gangemi, Roma.Ministero dei Trasporti e della Navigazione, (2001), “Il trasporto pubblicolocale”, in (cap. 10) Piano generale dei trasporti, Roma. Montanari L., Zara A., (2000), Il trasporto pubblico italiano come business, IlSole 24 ore Libri, Milano. Rezelman A., (2001), “Redefinition of the state and business interests organisa-tions: the case of transport’s policy in the Ile de France”, Proceedings of theconference “Area-based initiatives in contemporary urban policy”, EuropeanUrban Research Association, Copenhagen, 17-19 May. STIF, (2000), Annual Report 2000, Paris. STIF, (2002), Les transports en Ile de France - Mémento de statistiques, Paris.SYTRAL, (2000), Rapport d’activité, Lyon.Testa F., Franco M., (1998), “Il Trasporto”, (cap. 19), in Costa G., NacamulliR.C.D., (a cura di), Manuale di Organizzazione aziendale, Utet, Torino.Transport for London, (2000), Annual Report 1999 - 2000, London.Transport for London, (2000), Environmental Performance Report 2000, Lon-don.Transport for London, (2000), International Fares Comparisons: London - Paris- New York, London. Transport for London, (2000), Public Transport in London: Market Report2000, London. Transport for London, (2000), Transport Statistics for London 2000, London. Transport for London, (2001), Annual Business Plan 2000 - 2001, London.Van de Velde D.M., (1999), “Organizational forms and entrepreneurship inpublic transport”, Transport Policy, n°6.Vicari S., (a cura di), (2001), Trasporto pubblico urbano, Egea, Milano.World Bank, Department for International Development, (2000), Review ofUrban Public Transport Competition, Final Report, May.
Bibliografia
122
QU
AD
ER
NI
CE
SI
T