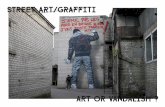Fortified Palaces in Early Modern Europe, 1400-1700 [EAHN 2014]
199) \tGentile da Fabriano anno 1400, in Contextos 1200 i 1400. Art de Catalunya i art de l’Europa...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 199) \tGentile da Fabriano anno 1400, in Contextos 1200 i 1400. Art de Catalunya i art de l’Europa...
49
Gentile da Fabriano anno 1400Andrea De Marchi
Se si mettono a confronto le iscrizioni col nome dell’artista in due opere capitali di Gentile da Fabriano, nel polittico di Valleromita, eseguito verso il 1410 per l’eremo di Santa Maria in Valdisasso dietro Fabriano su commissione di Chiavello Chiavelli, ora nella Pinacoteca di Brera a Milano (fig.1), e nella pala dell’Adorazione di magi, finita nel 1423 per Palla Strozzi, già nella sagrestia di Santa Trinita a Firenze e ora agli Uffizi (fig.2), non può non colpire l’enorme distanza della loro formulazione. Nel polittico di Valleromita la scritta «gentilis de fabriano pinxit» (fig.3) è vergata in minuscola littera textualis gotica, in oro, sopra il firmamento azzurro costellato di stelle, al di sotto dell’Incoronazione celeste della Vergine: l’andamento curvilineo asseconda quello della calotta dorata sul cui estradosso si dispongono gli angeli musicanti, suggerendo in tal modo una dimensione di infinito cosmico, tra il sole dorato e la luna argentata. Nella pala Strozzi due targhe blu sono alloggiate sul listello alla base del campo maggiore del trittico unificato e presentano una scritta sgraffita di modo da mettere in luce la lamina d’oro sottostante, che presenta in lettere capitali di tipo semi-umanistico la firma e la data di completamento dell’opera: «OPVS GENTILIS DE FABRIANO1/ MCCCCXXIII MENSIS MAII» (fig. 4). Le capitali semi-umanistiche sono molto simili a quelle usate da Lorenzo Ghiberti2, che era stato designato da Palla Strozzi come soprintendente dell’intera impresa della doppia sagrestia dei vallombrosani di Santa Trinita3, destinata
1. Gentile da Fabriano. Un viaggio nella pittura italiana alla fine del gotico, Milano 1992, è stata
riedita in formato economico (Milano 2006) e in traduzione francese (Paris 2009). Ho pubblicato
inoltre un fascicolo più divulgativo con la rivista ‘Arte e dossier’, nr.136 (Gentile da Fabriano,
Firenze 1998). Per alleggerire le note di questo intervento si riporta una silloge dei testi più im-
portanti cui fare riferimento: K. Christiansen, Gentile da Fabriano, Ithaca 1982; M. Ceriana
e E. Daffra (a cura di), Gentile da Fabriano. Il polittico di Valleromita, Milano 1993; A. Cecchi
(a cura di), Gentile da Fabriano agli Uffizi, Cinisello Balsamo 2005; M. Ciatti, C. Frosinini e R.
Bellucci (a cura di), Il Gentile risorto. Il Polittico dell’Intercessione di Gentile da Fabriano. Studi
e restauro, Firenze 2005; L. Laureati e L. Mochi Onori (a cura di), Gentile da Fabriano e l’altro
Rinascimento, catalogo della mostra di Fabriano, Milano 2006; A. De Marchi, L. Laureati e L.
Mochi Onori (a cura di), Gentile da Fabriano. Studi e ricerche, Milano 2006. Vorrei segnalare in-
fine una recensione molto impegnata alla mostra di Fabriano, di David Chambers, in Renaissan-
ce Studies, XXI, 2007, 2, pp. 274-277.
2. Si vedano la firma di Ghiberti sulla Porta Nord del Battistero, le scritte sul basamento del San
Giovanni Battista e sul libro del San Matteo di Orsanmichele, nella lastra tombale bronzea di
Leonardo Dati a Santa Maria Novella, sull’arca dei Santi Proto, Giacinto e Nemesio, etc.
3. Cfr. R. Jones, «Palla Strozzi e la sagrestia di Santa Trinita», in Rivista d’arte, ser. IV, XXXVII,
1984, pp. 9-106; A. De Marchi, Gentile…, 1992, pp. 135-136 e 185.
50
1. Gentile da Fabriano: polittico di Valleromita dell’Incoronazione della
Vergine. Milano, Brera (dall’eremo di Santa Maria in Valdisasso presso Fabriano).2. Gentile da Fabriano: Pala Strozzi dell’Adorazione dei magi (1423). Firenze, Uffizi (da Santa Trinita).
51
3. Gentile da Fabriano: polittico di Valleromita dell’Incoronazione della
Vergine, particolare della firma. Milano, Brera (dall’eremo di Santa Maria in Valdisasso presso Fabriano).4. Gentile da Fabriano: Pala Strozzi dell’Adorazione dei magi (1423), particolare della firma. Firenze, Uffizi (da Santa Trinita).
ad ospitare sull’altare principale la pala di Gentile. La formula dell’“opus” più genitivo era stata oggetto di un recupero colto ed antichizzante da parte di Giotto, che è stato commentato da Maria Monica Donato in uno studio di rara acutezza, ed puntualmente è ispirata alla firma di Ghiberti sulla Porta Nord del Battistero4. Entrambi questi elementi segnalano la volontà di Gentile di entrare in sintonia col milieu intellettuale fiorentino, segnato dai primordi dell’umanesimo in cerchie cui aderiva lo stesso Palla Strozzi, che per altro verso però non esitava ad ostentare ancora gli attributi della civiltà cavalleresca e che perciò trovò comunque in Gentile il suo artista ideale5. Questi indizi, per quanto apparentemente secondari, sono rivelatori di una vera e propria metamorfosi del pittore, che operando nella Firenze di Brunelleschi, di Nanni di Banco, di Ghiberti e dei giovani Masaccio e Angelico, affronta nuove sfide e rielabora la propria vocazione al contempo orafa e naturalistica nel confronto con una resa dello spazio e delle espressioni per lui del tutto nuova.
La nostra immagine di Gentile è affidata soprattutto ad opere dei suoi ultimissimi anni di vita, di questo magnetico momento toscano, ma l’artista marchigiano quando approdò a Firenze nel 1420 aveva alle spalle un’onorata e lunga carriera, che l’aveva visto affermarsi con prepotenza come primo pittore di Italia a partire dalle corti del Norditalia e da Venezia, non senza una significativa risonanza grazie alle opere spedite fra Umbria e Marche. Oltre a ciò la nostra immagine è distorta perché ci manca quasi del tutto la produzione di pittura murale, cioè il campo in cui Gentile eccelleva e in cui venne celebrato con più enfasi, come si evince dalla Vita che Bartolomeo Facio, umanista spezino, trasferitosi alla corte napoletana di Re Alfonso il Magnanimo, gli dedicò verso la metà del secolo, dove sono citati gli affreschi nella sala del Maggior Consiglio a Venezia, nella cappella di Pandolfo III Malatesta nel Broletto di Brescia, in piazza del Campo a Siena, nella basilica di San Giovanni in Laterano a Roma, sulla tomba del cardinale Alamanno Adimari in Santa Maria Nova a Roma, nel Duomo di Orvieto. In sostanza solo quest’ultima opera sopravvive, la Madonna col Bambino che ride affrescata sul muro sinistro
4. M. M. Donato, «Memorie degli artisti, memoria dell’antico. Intorno alle firme di Giotto, e di
altri», in A. C. Quintavalle (a cura di), Il tempo degli antichi, atti del convegno di Parma (2003),
Milano 2006, pp. 522-546.
5. Sulla cultura cavalleresca di Palla Strozzi: C. B. Strehlke, «Palla di Nofri Strozzi, “kavaliere” e
mecenate», in Gentile da Fabriano agli Uffizi..., pp. 41-58.
52
all’inizio della navata (fig. 5)6, mentre dei cicli di Brescia e di Roma sono riemersi esigui frammenti7. La rivalutazione della decorazione profana di palazzo Trinci a Foligno, alla luce dei documenti, noti dalla citazione in uno zibaldone erudito settecentesco, che ne attestano il pagamento a Gentile e ai suoi collaboratori
6. Cfr. in ultimo A. De Marchi, «Gentile da Fabriano per il Duomo di Orvieto, agosto – ottobre
1425», in Storia di Orvieto, vol. 3/2, Perugia 2010, pp. 403-411.
7. Per Brescia vedi L. Anelli, «Ricognizione sulla presenza bresciana di Gentile da Fabriano dal
1414 al 1419», in Arte lombarda, n.s., 1986, 76-77, pp. 31-54; A. De Marchi, Gentile..., 1992, pp.
97-110; R. Seccamani, «Dati e rilievi sui resti della cappella di San Giorgio al Broletto dipinta da
Gentile da Fabriano (1414/1419)», in Kermes, X, 1997, 29, pp. 28-40; L. Gnaccolini, «Presenze
di rilievo a Brescia nella prima metà del Quattrocento. Gentile da Fabriano e Jacopo Bellini», in
M. Rossi (a cura di), Lombardia gotica e tardogotica. Arte e architettura, Milano 2005, pp. 267-
275. Per Roma vedi A. De Marchi, «Gentile da Fabriano et Pisanello à Saint-Jean de Latran», in
Pisanello. Actes du colloque, Muséé du Louvre / 1996, Paris 1998, I, pp. 161-213.
5. Gentile da Fabriano: Madonna col
Bambino (1425), particolare. Orvieto, Duomo.
53
fra 1411 e 1412, permette di immaginare l’impatto complessivo, fra empirico impianto illusionistico e seduzioni visive del dettaglio, dei perduti cicli murali di Gentile, ma la qualità dell’esecuzione, demandata in toto agli allievi, fa sì che si tratti di un riflesso assai pallido e parziale8. Altri complessi murali, come quelli in Santa Caterina a Treviso9 o nella cappella Ricchieri nel duomo di Pordenone10, permettono di farsi un’idea di questa dimensione del linguaggio gentiliano, con riferimento sempre all’apice del suo successo veneziano, nel secondo decennio del secolo.
Nella monografia su Gentile che ho pubblicato nel 1992 mi sono impegnato soprattutto a recuperare questo pianeta sommerso, su almeno tre fronti: una restituzione archeologica dei grandi cicli perduti; la riappropriazione della prima facies, ancora in tutto e per tutto gotica, di Gentile, a partire dalla riverberazione del suo linguaggio nel contesto della pittura veneziana e veneta; un’ipotesi di interpretazione della sua formazione nell’alveo dell’arte lombarda della fine del Trecento, attorno alla corte di Gian Galeazzo Visconti e al cantiere internazionale del Duomo di Milano. La monografia su Gentile di Keith Christiansen, apparsa dieci anni prima (1982), assai brillante ed impegnata, era focalizzata soprattutto sugli ultimi anni della sua vita e sulla sua reazione all’ambiente fiorentino, e quindi incoraggiava ad affrontare l’artista da un punto di vista inverso, dall’inizio ancora abbastanza oscuro e non già dalla fine.
Dopo di allora c’è stato un intenso sviluppo degli studi, accompagnato anche da scoperte di opere e documenti e coronato dalla mostra promossa nella sua stessa città natale, Fabriano, nel 2006, grazie al munifico finanziamento di un industriale locale, Francesco Merloni. Gentile è pittore assai raro e alcune opere, la pala Strozzi in testa, sono capolavori inamovibili, per cui l’impianto della mostra, nella quale fu comunque possibile raccogliere un numero abbastanza incredibile di suoi dipinti, era spiccatamente polifonico. Attraverso Gentile si è voluto offrire uno spaccato di vari scenari del tardogotico in Italia centrale e settentrionale, dove la diversità del fabrianese spiccava come indice esemplare del suo tempo: in sette densissime sale sono state messe in scena sette stazioni di un viaggio ideale, “un viaggio nella pittura italiana alla fine del gotico”, come avevo sottotitolato il mio libro del 1992. Il dialogo con alcuni oggetti di oreficeria particolarmente scelti spero riuscisse a far scattare dei corto circuiti ermeneutici di immediata eloquenza visiva, aiutando a penetrare la specificità del modus operandi di questo grande artista: dopo Simone Martini, un pittore che concepiva le superfici come una stratificazione complessa, un gioco interferente di velature traslucide, incisioni, sgraffiti, rilievi, colore e metalli preziosi in continua contaminazione reciproca. La grande stagione dell’oreficeria parigina
8. Cfr. gli studi raccolti nel volume Il Palazzo Trinci di Foligno, a cura di G. Benazzi e F. F. Mancini,
Perugia 2001, ed inoltre A. De Marchi, «Gentile da Fabriano e la sua bottega», in Gentile da
Fabriano. Studi e ricerche…, pp. 9-53, speciatim 18-31; A. Caleca e B. Toscano (a cura di), Palazzo
Trinci. Nuovi studi sulla pittura tardogotica, atti del convegno di Foligno (2006), Livorno 2009.
9. Sugli affreschi gentiliani in Santa Caterina a Treviso vedi E. Cozzi, «Treviso», in La pittura
nel Veneto. Il Quattrocento, Milano 1989, pp. 102-124, speciatim 102-106; A. De Marchi, «Il
“podiolus” e il “pergulum” di Santa Caterina a Treviso. Cronologia e funzione delle pitture murali
in rapporto allo sviluppo della fabbrica architettonica», in A. C. Quintavalle (a cura di), Medioevo:
arte e storia, atti del convegno di Parma (2007), Milano 2008, pp. 385-407.
10. Sugli affreschi della cappella Ricchieri nel Duomo di Pordenone vedi E. Cozzi, «La decorazione
ad affresco del Trecento e dell’inizio del Quattrocento», in P. Goi (a cura di), San Marco di
Pordenone, Fiume Veneto 1993, I, pp. 183-223, speciatim 206-223. Un restauro condotto da
Giovanna Nevyjel e Claudia Ragazzoni sotto la guida di Elisabetta Francescutti, nel 2007-2008, ha
permesso di recuperare dati molto interessanti che spero verranno divulgati in una pubblicazione
adeguata (per intanto vedi E. Francescutti, «Alle estremità di un’epoca: analisi tecnica e vicende
conservative di due ciclo di affreschi del Friuli occidentale», in M. Buora (a cura di), Splendori del
gotico nel Patriarcato di Aquileia, catalogo della mostra, Udine 2008, pp. 69-82.
54
anno 1400, dei joyaux smaltati en ronde-bosse, era rappresentata da un capolavoro come il reliquiario di Montalto Marche: si poteva allora cogliere la profonda analogia tra le incisioni puntiformi dell’oro (oeuvre pointillé), grazie alle quali luccicano i serti vegetali sulla cornice (fig.6), e gli angeli graniti sul fondo della Madonna di Perugia di Gentile (fig.7), creature immateriali che fanno vibrare la piattezza della lamina dorata, o ancora fra le stesure traslucide sull’oro, il rouge-claire della Goldemailplastik (fig.8), e la lacca che vela con vario spessore la morbida veste di Dio Padre nell’Incoronazione di Valleromita (fig.9), tutta dipinta sull’oro, la cui luminosità traspare così per intermittenze cangianti.
Per avvicinarsi al mondo di Gentile, per carpirne l’essenza più intima è necessario – paradossalmente – farsi irretire dalla sua superficialità, addentrarsi nei dettagli più estrinseci. Un particolare come quello del copricapo del re mago più anziano, Gasparre, posato a terra nel primo piano della pala Strozzi (fig.10), sorta di elmo dorato cinto di corona gemmata e foderato di folta pelliccia, può essere come un emblema della vocazione orafa e al tempo stesso naturalistica, in ogni caso sperimentale, di Gentile. E’ un’invenzione incredibile. I rilievi in pastiglia sono modellati col pennello, con mano sensibile, e tutt’intorno la punta di un fine stiletto ha inciso rapidi tratteggi e tenui girali, con un’immediatezza che rasenta l’informalità. In origine ben più forti dovevano essere i tratteggi a vernice, sfilacciati e corruschi, che addensavano di ombre i profili: rimangono tracce nei solchi di alcune incisioni, ma è chiaro ad esempio che i gigli della corona si stagliavano contro aloni nerastri sfumati, con effetto altrimenti palpabile. Queste osservazioni introducono anche il problema dirimente della conservazione e dei restauri: anche di fronte ad un’opera come l’Adorazione dei magi per Palla Strozzi è necessario impegnarsi in un esercizio filologico di risarcimento mentale di materiali drasticamente depauperati ed alterati: e l’ultimo non felicissimo restauro, troppo spinto nella pulitura e troppo generoso di integrazioni, non ha reso tale compito più agevole.
Gentile sino alla fine rimase fedele alla sua vocazione di sensibilizzazione epidermica e luministica dei materiali preziosi. Non vi derogò neanche in un’opera così fortemente coinvolta nel dialogo con la corposità più soda e misurata dei novatori fiorentini, di Masaccio e Angelico, quale è il polittico Quaratesi per San Niccolò Oltrarno, finito nel giugno del 1425. Si prenda la Maddalena: incede con passo lento e grave, il volto tornito posto di tre quarti, che pare già quasi puntare su Masolino o su Sassetta, eppure le lacche rosse del manto facevano trasparire una lamina d’argento, ora scurita, nelle finte trecce del copricapo giocava l’oro sottostante, scoperto ed inciso a colpi di stiletto (fig.11), e al vertice del diadema un grosso rubino era finto colmando di vernice traslucida rossa la profonda concavità dovuta all’impressione di un grosso bollo circolare. Nel piviale di San Nicola i ricami con le storie della Vita di Cristo si animano in una sfavillante e quasi impressionistica vibrazione, dove si confondono i fili della broderie illusa e paillettes di luce vera, grazie all’incisione in punta di stiletto che rimette a luce l’oro sottostante nel vello ocraceo o nel manto viola del Battista, nei riccioli dei capelli o nelle onde capricciose del torrente, nel Battesimo di Cristo (fig.12). Anche qui la pittura ha uno spessore e una matericità che non sono quelle consuete dei pittori fiorentini, sempre più ‘mentali’. Anche qui Gentile tradisce il suo più profondo DNA, l’imprinting indelebile legato alla sua educazione fra Milano e Venezia, nel solco del naturalismo sensuale ed analitico della maggiore tradizione padana e lombarda.
Proprio sui primi tempi della carriera di Gentile le ultime ricerche, successive alla mostra del 2006 e alle pubblicazioni che l’hanno accompagnata, permettono di gettare qualche nuovo spiraglio, dimostrando come gli studi su questo grandissimo artista siano in continuo divenire. E’ bene riprendersi dal problema della data di nascita di Gentile. Purtroppo non disponiamo di dati certi. Io ho sostenuto che Gentile sia approdato alla corte di Gian Galeazzo Visconti, da
55
6. Orafo parigino circa 1400: Reliquiario detto di Sisto V, particolare. Montalto Marche, Museo sistino.7. Gentile da Fabriano: Madonna col
Bambino e angeli, particolare angelo granito. Perugia, Galleria nazionale dell’Umbria (da San Domenico).
8. Orafo parigino circa 1400: Reliquiario detto di Sisto V, particolare. Montalto Marche, Museo sistino.9. Gentile da Fabriano: polittico di Valleromita dell’Incoronazione della
Vergine, particolare di Dio Padre. Milano, Brera (dall’eremo di Santa Maria in Valdisasso presso Fabriano).
56
lui ritratto in un intenso disegno a punta metallica su pergamena del Louvre11, per la mediazione del suo primo mentore, il signore di Fabriano Chiavello Chiavelli, che nel 1395 era stato elevato a cavaliere dal despota milanese, cui era legatissimo al pari di altri signorotti fra Umbria e Marche, per difendersi dalla preponderanza della Repubblica fiorentina, principale rivale del Visconti. Questi morì nel 1402 ed allora Gentile dové lasciare la Lombardia. Un’attività del giovanissimo Gentile in Lombardia è attestata anche da una tavoletta della Pinacoteca Malaspina a Pavia, proveniente da Santa Chiara la Reale, convento di clarisse fondato nel 1380 dalla madre di Gian Galeazzo Visconti, Bianca Maria12. Perché l’esperienza lombarda abbia avuto un’incidenza e per scalare nel tempo le sue prime opere è necessario ipotizzare che Gentile vi sia giunto qualche anno prima del 1402 e che dunque la sua data di nascita vada posta non molto dopo il 1375, anno in cui la madre Franceschina di Giovanni di Bonanno Trasemundi, perugina, il 17 novembre ricevette formalmente la dote di 100 fiorini che il padre le aveva lasciato per testamento. Il padre, Niccolò di Giovanni, mercante di guarnelli (tessuti grezzi o guasti lavorati nelle gualcherie per la produzione della carta), rimase presto vedovo e nel 1386 si ritirò nel convento degli olivetani a Fabriano, Santa Caterina in Castelvecchio, dove prese i voti anche il fratello di Gentile, Ludovico13. Vale la pena sottolineare l’estrazione da una famiglia di agiata borghesia, che poté favorire l’espatrio verso lidi lontani, lungo le rotte familiari ai mercanti. Gentile si mosse a proprio agio fra la committenza signorile, cui non si legò mai in maniera duratura, a differenza del suo allievo veronese Pisanello, e quella mercantile. Ora abbiamo un’idea molto più ricca dello spettro variegato della sua committenza. Da una parte l’impressione è che il Chiavelli sia stato il suo mentore decisivo, grazie al quale è probabile che il signore di Foligno, Ugolino III Trinci, l’abbia ingaggiato mentre era lanciato più che mai nell’impegnativa piazza veneziana, verso il 1410, ed abbia così affidato ad un’équipe da lui diretta la decorazione interna
11. Cfr. M. Bollati, in Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento…, pp. 66-67, cat. I.2.
12. Cfr. M. Bollati, in Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento…, pp. 64-65, cat .I.1.
13. Sulla famiglia di Gentile vedi il saggio di Fabio Marcelli, «Fabriano: la famiglia di Gentile e i
frammenti della memoria», in Gentile da Fabriano. Studi e ricerche…, pp. 96-103.
10. Gentile da Fabriano: Pala Strozzi dell’Adorazione dei magi (1423), particolare del copricapo di Gasparre. Firenze, Uffizi (da Santa Trinita).11. Gentile da Fabriano: Santa Maria
Maddalena, polittico Quaratesi (1425), particolare del copricapo. Firenze, Uffizi (da San Niccolò Oltrarno).
57
del palazzo, sacrificando e ricoprendo quella che era stata iniziata nel cavalcavia verso il Duomo dal principale pittore locale, Giovanni di Corraduccio, con scelta indicativa della fama già allora travolgente del fabrianese. Dall’altra a Gentile si rivolsero in più occasioni homines novi, personaggi emergenti di estrazione borghese, come a Venezia le famiglie dei mercanti lucchesi, i Sandei e gli Amadi, ricchissimi ma esclusi dalla serrata del Maggior Consiglio14. Una delle sue primissime opere, la pala lunettata ora negli Staatliche Museen di Berlino (fig.13), proveniente da San Niccolò a Fabriano, venne commissionata da un mercante, che si fece ritrarre in maniera intensamente realistica, inginocchiato su di un prato fiorito, come accolto nel Paradiso terrestre ai piedi della Vergine col Bambino: lo dichiara il marchio di fondaco delineato in primo piano e reiterato nell’anellino che il donatore porta al dito.
L’abilità di Gentile nel destreggiarsi fra ricchi mercanti e signori è dimostrata, per indizi, anche da una vicenda che sta emergendo con crescente forza e che lo lega in un preciso frangente, circa 1404, alla città di Ferrara. Fino ad ora la prima documentazione nota che riguardasse Gentile era il pagamento del 27 luglio 1408, annotato in un libro di memorie, da parte di Francesco Amadi, mercante lucchese stabilito a Venezia, “per una ancona”15. Bisogna ricordare che dopo il regime ghibellino di Castruccio Castracani, negli anni venti del Trecento, alcune famiglie lucchesi erano esulate a Venezia e lì avevano trovato notevole fortuna, nel commercio della seta, dando vita ad una prospera colonia, di cui era espressione la cappella del Volto Santo presso la chiesa dei Servi di Maria, affrescata da Nicoletto Semitecolo ed ornata da una gigantesca pala d’altare lignea, datata 1371, includente una copia del famoso Crocefisso venerato a Lucca, ora distrutta.
14. Cfr. Anna Pizzati, «Venezia», in Gentile da Fabriano. Studi e ricerche…, pp. 104-115.
15. Cfr. M. Mazzalupi (a cura di), «Regesto», in Gentile da Fabriano. Studi e ricerche…, p. 68, doc. 1.
12. Gentile da Fabriano: San Nicola da
Bari, polittico Quaratesi (1425), particolare del Battesimo di Cristo ricamato sul piviale. Firenze, Uffizi (da San Niccolò Oltrarno).
58
13. Gentile da Fabriano: Madonna col
Bambino tra San Nicola, Santa Caterina
martire e donatore. Berlino, Staatliche Museen (da Fabriano, San Niccolò).
59
Grazie alle ricerche d’archivio di Debora Dameri e Achille Lodovisi è emersa una testimonianza che potrebbe permettere di intercettare Gentile quattro anni prima, in rapporto con Ferrara. L’identificazione non è sicura, perché purtroppo non si dice che il personaggio in questione, Gentile da Fabriano, fosse un pittore, nondimeno io la ritengo altamente probabile. Io avevo ipotizzato che coi torbidi che divamparono in Lombardia a seguito della morte improvvisa, nel settembre 1402, di Gian Galeazzo Visconti, Gentile al pari di tanti altri artisti e condottieri, si sia spostato verso Venezia, che profittò di quel momento per estendere i propri domini in terraferma, dilagando nel volgere di pochi anni fino a Brescia e Bergamo. E’ possibile che prima di insediarsi stabilmente a Venezia, dove si iscrisse alla Scuola di San Cristoforo dei mercanti, o più probabilmente da Venezia abbia cercato lavoro anche a Ferrara.
Il 26 luglio 1404, infatti, il marchese Niccolò III d’Este, signore di Ferrara, scrisse al suo vicario Uguccione de’ Contrari, rimasto famoso perché feudatario della rocca di Vignola, la cui cappella venne affrescata molto più tardi con un ciclo spettacolare, chiedendogli di esaminare le richieste di un certo Gentile da Fabriano16. Prima che venisse reso noto questo documento, nel saggio Gentile e la sua bottega, in un volume di studi che accompagnava il catalogo della
16. «Frater noster dilectissime. El ne sta presentada per Beninchà nostro famiglio una litera la quale
nuy mandemo ligada cum questo, perché nuy no intendemo quello chi voglia dire quello Zentile da
Fabriano, e dixe el dicto Beninchà che Galaoto e Pero da roma je la dè» (D. Dameri – A. Ludovisi, «La
Rocca e Uguccione Contrari», in D. Benati e V. Vandelli (a cura di), La cappella Contrari nella Rocca di
Vignola, Milano 2007, pp. 15-41 e 221-224, speciatim 32-33 e 223 nota 87; nello stesso volume si veda
il commento di Daniele Benati, «Il “Maestro di Vignola”», pp. 61-83, speciatim 73-74).
14 Gentile da Fabriano: Madonna col
Bambino. Ferrara, Pinacoteca Nazionale, lascito Vendeghini Baldi.
60
mostra del 2006, avevo dedicato un paragrafo alle commissioni di Gentile negli anni veneziani, oltre agli affreschi di Foligno, elencando quattro realtà con cui secondo me sarebbe stato in rapporto fra primo e secondo decennio: Treviso, Pordenone, Mantova e Ferrara. In quella sede avevo affermato che la «Ferrara di Niccolò III fu uno dei centri della Terraferma che recepirono con maggiore precocità qualcosa dell’arte del Gentile veneziano»17. Nella Pinacoteca nazionale di Ferrara si conserva una Madonna col Bambino di Gentile (fig.14), databile prima del polittico di Valleromita, sciupata ma assai bella, frammento riquadrato di una pala di ragguardevoli dimensioni, forse destinata alla chiesa dei Servi, dal momento che giunse nell’Ottocento nella collezione Vendeghini Baldi dalle Orsoline, che avevano raccolto il patrimonio dei Servi di Maria dopo le soppressioni18. Se a Ferrara quest’opera «non sopravvivesse dovremmo in ogni caso presupporre che Gentile vi avesse inviato delle opere e non va escluso che la sua rappresentanza vi fosse più consistente»19. Questa ipotesi era
17. A. De Marchi, Gentile e la sua bottega…, p. 36.
18. Cfr. C. Guerzi, in Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento…, pp. 136-139, cat. III.2. Sulla
chiesa dei Servi vedi F. Gobbo, «La chiesa ed il convento di Santa Maria dei Servi di Ferrara dalla
fondazione (1339) al 1424», in Studi storici dell’ordine dei Servi di Maria, XLVI, 1996, pp. 31-126.
19. A. De Marchi, Gentile e la sua bottega…, p. 36.
15. Michele de’ Carri: Resurrezione di
Cristo. Ferrara, oratorio dei battuti neri.
61
suggerita soprattutto dall’analisi della precoce interferenza di espliciti influssi gentiliani sui migliori pittori del tardogotico ferrarese, ben prima che vi si sovrapponessero le suggestioni di Pisanello, approdato verso il 1441-1442 a Ferrara come pittore di corte.
Un manifesto di questi influssi, innestati su di un solido plasticismo neogiottesco, eredità della tradizione del Trecento ferrarese, fra Altichiero e Jacopo Avanzi, è la notevole Resurrezione di Cristo (fig.15) affrescata per l’oratorio dei Battuti neri in un anno da precisare fra il 1410 e il 1419, per via della data mutila (“141.”) rimessa a nudo a seguito di un restauro recente. Quest’opera fa parte di un gruppo stilistico compatto, insieme alla Madonna di Pietro de’ Lardi del Metropolitan Museum e agli affreschi della Sagra di Carpi, già noto come ‘Maestro G.Z.’, e che può essere risolto nel nome storico di Michele di Jacopo de’ Carri o Michele dalla Frutta (documentato dal 1400 circa, morto nel 1441), come ha intuito Daniele Benati e come penso possa confermare l’incipit “MI…” (e non solo “M”, come si è ripetuto) di un’iscrizione posta sull’avello del Cristo risorto, riferibile alla firma dell’artefice e ben distinta da un’iscrizione sottostante che principia con la data summenzionata e proseguiva con probabili riferimenti alla committenza e al contenuto devozionale, visto che il rigo seguente contiene le lettere “MUN…” facilmente scioglibili, visto il contesto iconografico, in “Redemptor Mundi” o “Salvator Mundi”20. In questo affresco vari elementi parlano senza equivoco dell’avvenuta conoscenza dell’arte di Gentile: la carnosità rilasciata nella resa dei volti, specie di quello del massaro della confraternita committente (fig.15), e le ombrosità che si appiattano nei calanchi sinuosi delle rocce, fra folte macchie di arbusti, insieme a certe sottigliezze orafe nei decori dorati delle vesti e nelle incisioni delle lamine per le armature. Così si rinnovò la pittura ferrarese e non a caso anche dai documenti la figura di Michele de’ Carri, attivo pure a Bologna tra 1402 e 141921, emerge come quella di maggiore spicco nei primi decenni del secolo.
Una bella antologia della pittura ferrarese verso il 1400 è offerta dalle pitture murali nel cosiddetto palazzo del Paradiso, ora sede della Biblioteca civica Ariostea, fatto erigere da Alberto V d’Este, signore della città fra 1388 e 1393, come dono per il suocero Cabrino de’ Roberti, ma che nel 1400, per la caduta in disgrazia di questa famiglia, ritornò in possesso della camera marchionale e nel 1403 venne usato per ospitare il potente cardinale Baldassarre Cossa, legato apostolico a Bologna e di lì a poco eletto papa col nome di Giovanni XXIII22. Oltre ad una sala terrena con un ciclo delle storie di Ercole entro spettacolari finte architetture di retaggio altichieresco, si conservano al piano nobile, nella “chamara da li falchuni”, i frammenti di scene cortesi di preparazione per la caccia, con un giovane che sistema un falcone sopra la pertica orizzontale mentre
20. Sul problema e sulla figura di Michele de’ Carri vedi D. Benati, «L’affresco con la Resurrezione
e il suo autore», in M. Mazzei Traina (a cura di), L’Oratorio dell’Annunziata di Ferrara. Arte,
storia, devozione e restauri, Ferrara 2002, pp. 23-31, A. De Marchi, Gentile e la sua bottega…,
pp. 36-38; D. Benati, Il “Maestro di Vignola”… cit., pp. 69-75; infine la tesi di dottorato di Chiara
Guerzi, Pittori e cantieri della Ferrara tardogotica, da Alberto (1388-1393) a Nicolò III d’Este
(1393-1441), rel. prof. A. De Marchi, università di Udine, a.a. 2007-2008, pp. 37-100, che prepara
una pubblicazione sistematica sul pittore.
21. Cfr. F. Filippini – G. Zucchini, Miniatori e pittori a Bologna. Documenti del secolo XV, Roma
1968, pp. 121-122; R. Pini, Il mondo dei pittori a Bologna 1348-1430, Bologna 2005, pp. 80-83.
22. Cfr. G. A. Scalabrini, Memorie istoriche delle chiese di Ferrara e de’ suoi borghi, munite, ed
illustrate con antichi inediti monumenti, che ponno servire all’istoria sacra della suddetta città,
Ferrara 1773, pp. 396-397; A. M. Visser Travagli, «Le fasi costruttive», in Il Museo Civico
in Ferrara. Donazioni e restauri, Firenze 1985, pp. 194-200; M. T. Gulinelli – A. M. Visser
Travagli, «Palazzo del Paradiso», in Ferrara nel Medioevo. Topografia storica e archeologia
urbana, a cura di A. M. Visser Travagli, Casalecchio di Reno 1995, pp. 98-111; C. Guerzi, Pittori
e cantieri…, pp. 302-310.
62
un compagno sembra sussurrare parole dolci ad una fanciulla dall’aria trasognata (figg.17-19)23. In queste pitture assai frammentarie, ma che meriterebbero di essere meglio note, si nota il rapporto con la pittura neogiottesca ferrarese dei decenni precedenti (Maestro dell’Ascensione di Sant’Antonio in Polesine24, Maestro di casa Minerbi, Serafino de’ Serafini), nei volumi espansi e negli scorci acuti, ma nella resa delle carni c’è un intenerimento che è difficilmente pensabile senza un primo rapporto con l’arte di Gentile, assai tempestivo ancorché superficiale, assai plausibile se si ipotizza che queste decorazioni siano state eseguite verso il 1403, in vista dell’ospitalità concessa al legato apostolico.
Il tono lieve e sentimentale di questa figurazione, ariosamente scandita su di un fondo rosso, l’accomuna ad un ciclo profano che è stato fortunosamente scoperto negli scorsi anni a Mantova, in un palazzo che Francesco di Marsilio Gonzaga, imparentato coi signori della città, ottenne nel 1411 e fece decorare subito dopo. Il ciclo, di notevolissima qualità, rappresenta una delle maggiori scoperte degli ultimi tempi nell’ambito della pittura profana di età tardogotica, ed è stato studiato da Vincenzo Gheroldi25. Si tratta di due stanze, una su fondo rosso con giochi ed intrattenimenti di società contro una siepe arborea continua ed una seconda su fondo azzurro con scene di caccia nel bosco (figg.20-23). Le superfici erano impreziosite di dorature e rilievi, l’effetto doveva essere quello di arazzi avvolgenti e il continuum a 360 gradi, senza soluzione di continuità sugli angoli, doveva essere paragonabile a quello perseguito da Maestro Venceslao nella camera dei Mesi per il principe-vescovo di Trento Giorgio di Liechtenstein, di poco precedente. Sono composizioni ariose, con figure di notevole sodezza fisica, ancora nella tradizione del neogiottismo padano, ma al contempo un garbo e una morbidezza che sanno di Lombardia, arieggiando ormai al Weicher Stil di Michelino da Besozzo e del giovane Gentile. Per le nostre conoscenze sulla pittura mantovana prima dell’arrivo a corte di Pisanello, negli anni venti, è una sorpresa assoluta, anche per il tenore qualitativo così alto, ma almeno un’altra opera sopravvive dello stesso maestro, una Madonna allattante il Bambino
23. Del tutto inadeguato è il commento che ha riservato a queste pitture Ranieri Varese, «Palazzo
Paradiso. Gli affreschi», in Il Museo Civico in Ferrara…, pp. 186-193; Id., «Momenti pittorici a
Palazzo Paradiso», in A. Chiappini (a cura di), Palazzo Paradiso e la Biblioteca Ariostea, Ferrara
1993, pp. 81-113. Vedi C. Guerzi, Pittori e cantieri..., pp. 316-322.
24. Così va infatti ribattezzato il pittore denominato Maestro del Giudizio finale di Sant’Antonio
in Polesine da Ranieri Varese (Trecento ferrarese, Ferrara 1976, passim), sulla base di un
fraintendimento iconografico. Su queste pitture rimando ad un articolo di Chiara Guerzi di prossima
pubblicazione in Nuovi studi. Rivista di arte antica e moderna.
25. V. Gheroldi, «Giochi e cacce, per Francesco di Marsilio Gonzaga», in Una dimora di Francesco
di Marsilio Gonzaga, Mantova 2009, pp. 27-53. Per un inquadramento stilistico rimando a quanto
ho scritto in breve in A. De Marchi, «Introduzione», ivi, pp.2-3.
16. Michele de’ Carri: Resurrezione di
Cristo, particolare del ritratto del massaro della confraternita dei battuti neri. Ferrara, oratorio dei battuti neri.
63
17. Pittore ferrarese circa 1405: Giovani
si preparano per la caccia col falcone. Ferrara, Palazzo del Paradiso.18 Pittore ferrarese circa 1405: Giovani
si preparano per la caccia col falcone. Ferrara, Palazzo del Paradiso.19. Pittore ferrarese circa 1405: Giovani
si preparano per la caccia col falcone. Ferrara, Palazzo del Paradiso.
64
20. Maestro di Francesco di Marsilio Gonzaga: Giovani a caccia di uccelli. Mantova, palazzo di Marsilio Gonzaga.21. Maestro di Francesco di Marsilio Gonzaga: Giovani a caccia di uccelli, particolare. Mantova, palazzo di Marsilio Gonzaga.22. Maestro di Francesco di Marsilio Gonzaga: Gioco degli scacchi. Mantova, palazzo di Marsilio Gonzaga.23. Maestro di Francesco di Marsilio Gonzaga: Giochi signorili, particolare. Mantova, palazzo di Marsilio Gonzaga.
65
in un affresco strappato da palazzo Fiera, nlle collezioni del Palazzo Ducale di Mantova, che Pietro Toesca datava all’inizio del Quattrocento, notandovi «le tinte tenui e la soavità di modellato proprie ai pittori lombardi»26, opera di intensa naturalezza nell’illusione delle carni floride, fino al dettaglio del capezzolo da cui il Bambino sta per suggere il latte. Verso il 1410 c’è dunque un variegato contesto, fra Ferrara e Mantova, che sembra registrare in maniera non pedissequa, ai massimi livelli, la presenza di Gentile da Fabriano, quell’idea di delicata sensualità che pervade la sua giovanile paletta di Berlino (fig.13).
Tornando a Ferrara e all’eventualità che Gentile l’abbia frequentata verso il 1404 vale la pena di segnalare un possibile contesto di committenza per l’ancona dei Servi, da cui è ritagliata l’intensa seppur rovinata Madonna col Bambino Vendeghini Baldi. A Ferrara si era stabilito verso il 1387 Duccio Sandei, figlio di Enrico, facoltoso lucchese morto a Venezia nel 1394, e fratello di Francesco, “perfamosus mercator”, che nel 1406 fondò una cappella dedicata a San Paolo eremita e Sant’Antonio abate nella chiesa veneziana di Santa Sofia, per cui Gentile dipinse poco dopo l’ancona citata ancora in situ da Francesco Sansovino nel 1581, smantellata nel 1610, di cui sopravvive il frammento con il volto di San Paolo eremita in una collezione privata di San Francisco (Cal.)27 e quattro dei dodici apostoli inclusi nei contrafforti (il San Pietro e il San Giacomo maggiore della collezione Berenson a Villa I Tatti presso Settignano, il San Bartolomeo e il Sant’Andrea scoperti nei depositi della Pinacoteca nazionale di Bologna da Daniele Benati28), mentre un terzo fratello, Niccolò, rientrò a Lucca ed eresse una cappella in San Frediano, affrescata verso il 1400 probabilmente da Angelo Puccinelli. La sepoltura di famiglia a Venezia era nel chiostro della chiesa dei Servi, dove fu tumulato il padre Enrico. E’ suggestivo pensare che anche il figlio Duccio si sia legato a Ferrara ai Servi di Maria e che abbia dunque qualche responsabilità nella commissione a Gentile della pala per quella chiesa, in una data prossima al 1404, come anche i dati dello stile, più acerbo rispetto al polittico di Valleromita e vicino alla Madonna di San Domenico a Perugia, parrebbero confermare.
Verso il 1405 per la chiesa dei Servi Michele de’ Carri, il maggior pittore ferrarese tardogotico, affrescò due cappelle, quella di Antonio Pendaglia e quella di Ravagese Maranci da Savignano, come documentano le disposizioni del testamento di quest’ultimo, capitano del castello di Vignola, del 31 ottobre 1405, in cui si cita a modello la precedente, già affrescata29. Lo stesso maestro il 19 gennaio 1407 venne incaricato di affrescare con un Giudizio finale le pareti della cappella di Virgilio Silvestri in Cattedrale30, quale adeguato completamento del tabernacolo che doveva ospitare sull’altare, detto di Santa Maria Bianca, la bellissima Madonna col Bambino marmorea scolpita fra 1403 e 1406 da Jacopo della Quercia, presente all’atto (fig.24)31. In quegli anni Michele si divide fra
26. P. Toesca, La pittura e la miniatura nella Lombardia. Dai più antichi monumenti alla metà del
Quattrocento, Milano 1912, ed. Torino 1987, p. 174, fig. 356.
27. Cfr. M. Ceriana – E. Daffra, in Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento…, pp. 142-143,
cat. III.4. Come mi segnala Matteo Mazzalupi l’opera prima di appartenere a Charles Loeser fu
nella collezione Vittadini a Milano, dove la citò Adolfo Venturi (Storia dell’arte italiana, VII/1,
Milano 1911, p.201 nota 1), che l’attribuì già con decisione a Gentile da Fabriano.
28. Cfr. D. Benati, in J. Bentini, G. P . Cammarota e D. Scaglietti Kelescian (a cura di), Pinacoteca
Nazionale di Bologna. Catalogo generale. 1. Dal Duecento a Francesco Francia, Venezia 2004, pp.
180-181, cat. 62a-b; M. Ceriana – E. Daffra, in Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento…,
pp. 140-141, cat. III.3.
29. Cfr. A. Franceschini, Artisti a Ferrara in età umanistica e rinascimentale. Testimonianze
archivistiche. Parte I dal 1341 al 1471, Ferrara 1993, doc. 180; Dameri - Ludovisi, La Rocca…,
pp. 33 e 223 nota 94.
30. Cfr. A. Franceschini, Artisti a Ferrara…, p. 87, doc. 201.
31. Cfr. L. Cavazzini, in M. Seidel et alii (a cura di), Le arti a Siena nel primo Rinascimento,
66
24. Jacopo della Quercia: Madonna col
Bambino. Ferrara, Museo del Duomo (dalla cappella Silvestri).
Ferrara e Bologna, dove nel 1409 è socio del pittore Francesco Lola, e non si può non notare il parallelismo stretto con Jacopo della Quercia, che negli anni novanta era fuggito da Lucca a Bologna, salvo riprendere i rapporti con Lucca e, dal 1408, con la nativa Siena. Il 19 gennaio 1407 Jacopo risulta però ancora abitante a Ferrara e come tale è teste all’atto di commissione degli affreschi della cappella Silvestri32. Se Gentile frequentò la città estense in quegli anni, avendo così modo di influenzare Michele de’ Carri, è inevitabile che abbia conosciuto lo scultore senese, assiduamente presente in città fra 1403 e 1407.
Jacopo della Quercia e Gentile da Fabriano erano in sostanza coetanei, avevano storie molto diverse alle spalle, ma c’era un’affinità profonda che poté favorirne l’incontro. Se si accostano due opere in sostanza coeve come la Madonna Silvestri del primo e la Madonna di Perugia del secondo (fig.25)
catalogo della mostra di Siena, Milano 2010, pp. 32-33, cat. A.3.
32. Cfr. A. Franceschini, Artisti a Ferrara…, p. 87, doc. 201.
67
25. Gentile da Fabriano: Madonna col
Bambino e angeli. Perugia, Galleria nazionale dell’Umbria (da San Domenico).
68
26. Gentile da Fabriano: polittico di Valleromita dell’Incoronazione della
Vergine, particolare dell’Incoronazione
della Vergine. Milano, Brera (dall’eremo di Santa Maria in Valdisasso presso Fabriano).
69
nessun rapporto immediato parrebbe possibile. La scultura di Jacopo, pur così svelta ed elegante, persegue una monumentalità maggiore, che però è nutrita soprattutto del turgore fisico delle carni, denunciando la volontà di inverare in una fisicità pulsante i rifluenti stilemi di un goticismo sovrabbondante. Jacopo è uno scultore capace di sfruttare un lieve difetto del marmo, sulla guancia della Vergine, intenzionalmente, per fingere una verruca e rendere più umana ed individuale la sua creatura di bellezza così intatta e pura, universale. Gentile, con la sua pittura filamentosa e vibrante, conferisce una trasparenza setosa alla pelle, approfondisce le pieghe della carne. Entrambe sono Madonne della melagrana ed in entrambe le opere il frutto spaccato, simbolo del sacrificio di Cristo, è introdotto con disinvoltura, quasi accidentalmente stretto nella mano della Madonna di Jacopo, mentre quella di Gentile lo porge per il picciolo in punta di dita al Bambino, che lo stringe animosamente. A cercare dei fili sotterranei che possano accomunare la ricerca dei due artisti, ricerca strenua di animazione ed umanizzazione dall’interno di sigle ancora esasperatamente gotiche, al di là di stilizzazioni diverse e fonti formali distanti, si potrà evidenziare allora quel vitalismo incontenibile che percorre come un fremito le figure di Jacopo ed innerva a fior di pelle quelle, più sfuggenti e languide, di Gentile. Anche nella Madonna Vendeghini Baldi (fig.14) la ricerca di moto compulsivo del Bambino che si avvita su sé medesimo, precipitandosi di lato e verso il basso, mentre la Madre lo trattiene con le due mani incrociate sul petto, potrebbe dirsi quasi quercesca.
Queste osservazioni, suggerite dalla messa a fuoco della particolare congiuntura ferrarese verso il 1404 in cui i due artisti poterono conoscersi, sono ancor più incoraggiate da alcuni documenti senesi, recentemente scoperti da Gabriele Fattorini, che gettano luce sulla commissione della cosiddetta Madonna dei Banchetti, l’affresco perduto che Gentile realizzò per il tabernacolo dei notai in piazza del Campo fra 1424 e 1425, ma che gli fu in realtà commissionato fin dall’aprile del 1423, probabilmente per i buoni uffici proprio di Jacopo della Quercia33. In quegli anni lo scultore, che nel 1419 aveva finalmente concluso l’epica impresa della Fonte Gaia, si stava imponendo come regista e suggeritore delle imprese artistiche più importanti in città, in primis il Fonte battesimale, per cui dimostrò grande larghezza di vedute, divenendo artefice del coinvolgimento dello stesso Donatello34. Dal primo documento dell’8 aprile 1423 risultano gli stanziamenti dell’arte dei giudici e notai per l’acquisto dei materiali, oro e pigmenti, sottratti al computo del salario previsto per Gentile, e l’affidamento della policromia dell’edicola lapidea al pittore senese Vico di Luca, evidentemente un artista di statura minore adatto a simili incarichi. Dal documento si capisce che Vico era stato incaricato da Jacopo della Quercia in quanto rappresentante di Gentile, in quei giorni impegnato a Firenze per finire la pala Strozzi, «conducto a magistro Jacobo Pieri dela Guercia sculture comissario magistri Gentilis circa dicta ornamenta pingenda». Si può ipotizzare che Jacopo avesse sovrainteso anche all’opera architettonica del tabernacolo, ma soprattutto emerge con chiarezza che fungeva da fiduciario a Siena di Gentile per questa impresa. Vari fili si annodano intorno ai due, in questo frangente. Giovanni da Imola, fedele allievo e collaboratore di Jacopo nel lavoro del polittico Trenta in San Frediano a Lucca, è tra gli artisti pagati (12 fiorini, il 9 giugno) nel saldo finale della pala Strozzi, giugno 1423, a lato di Michele d’Ungheria, un suo aiuto poi ampiamente documentato a Ferrara, dal 1436 fino alla morte (1463-1464), ben affermato nella corte estense e noto come Michele Pannonio. Allo scultore quercesco può essere addebitato l’intaglio della cornice, assai turgido e traforato, del tutto atipico per un intagliatore fiorentino come
33. G. Fattorini, «Gentile da Fabriano, Jacopo della Quercia and Siena: the ‘Madonna dei
banchetti’», in The Burlington Magazine, CLII, 2010, pp. 152-161.
34. Vedi G. Fattorini, in Le arti a Siena…, pp. 182-185, cat. C.1.
70
Matteo Rondinelli, pure pagato nei registri di Palla Strozzi, e ben confrontabile invece con il polittico Trenta, cui contribuì Giovanni da Imola.
Un altro importante legame fra Gentile e Jacopo è dato dal legnaiolo che lavorò agli stalli della sagrestia maggiore di Santa Trinita, fra 1420 e 142335, in perfetta concomitanza con la confezione della pala d’altare dell’Adorazione dei magi: il 4 gennaio 1420 il lavoro venne allogato al modenese Arduino di Baiso36, che doveva usare i disegni del fiorentino Manno di Benincasa. Arduino, uno dei maggiori intagliatori italiani della prima metà del Quattrocento, crebbe a lato di Jacopo della Quercia: suo padre Tommasino, pure legnaiolo, fu il mallevadore del senese nel 1403 per la commissione della Madonna Silvestri a Ferrara; Arduino passò a lavorare a Lucca, alla corte di Paolo Guinigi, per il quale realizzò nel 1414 uno studiolo favoloso, che dopo la caduta del signore lucchese, nel 1430, Leonello d’Este volle assicurarsi per la delizia di Belfiore. E’ probabile che Jacopo della Quercia abbia avuto qualche responsabilità nell’attirare a Lucca verso il 1410 alcuni artisti del Norditalia, come l’orafo Vincenzo di Michele37 e appunto Arduino di Baiso, coinvolti nel mecenatismo di Paolo Guinigi e della sua piccola ma pretenziosa corte38. A queste solidarietà si aggiunge quella con Gentile, dal momento che il 1 aprile 1419 è identificabile un pagamento di 100 lire in suo favore, “super eius provixione”, nei registri contabili di Pandolfo III Malatesta39, che a sua volta cercava di dare forma ad un foyer cortese nella sua dimora bresciana, provocatoriamente innestata negli spazi del Broletto medioevale e comunale, e che aveva ottenuto i servigi di Gentile, residente a Brescia almeno dal 1415 al settembre del 1419, apposta per attendere alla decorazione della cappella palatina del signore. Un celebre documento del 18 settembre 1419, una richiesta di salvacondotto, ci presenta un vivido spaccato del tenore di vita agiato raggiunto da Gentile, che lasciava la città lombarda per andare a servire il nuovo papa finalmente eletto a Costanza due anni prima, Martino V, accompagnato da “octo persone et octo cavalli”40. In questo seguito è molto verosimile che ci fosse anche Arduino da Baiso. Il papa in quei mesi risiedeva infatti a Firenze, acquartierato presso i domenicani di Santa Maria Novella, in attesa di spostarsi nell’Urbe, e come ha suggerito Annamaria
35. Cfr. G. Poggi, La Cappella e la Tomba di Onofrio Strozzi nella chiesa di Santa Trinita, Firenze
1903, pp. 16-17.
36. Su Arduino vedi G. Manni, Mobili in Emilia, Modena 1986, pp. 22-45; P. L. Bagatin, La tarsia
rinascimentale a Ferrara. Il coro di Sant’Andrea, Firenze 1991, pp. 14-40.
37. Il piacentino Vincenzo di Michele è autore nel 1411 della cosiddetta Croce dei pisani, Croce
orafa da altare destinata alla cappella palatina del Guinigi, su cui vedi la scheda di L. Cavazzini, in
Le arti a Siena…, pp. 48-51, cat. A.11, che contesta l’idea che per le due figure dei Dolenti l’orafo
lombardo si sia appoggiato ad un disegno di Jacopo della Quercia, minimizzando l’eterogeneità
rispetto alle altre figure, che a me sembra invece evidente: le figure dei Profeti a mezzo busti e degli
angeli nei tabernacoli alle estremità della Croce hanno un’aria alla Giovannino de’ Grassi, così come
il Cristo si inserisce bene nel solco della tradizione lombarda tardo-trecentesca, mentre i panneggi
festonati con piglio energico e lo struggente patetismo gestuale della Vergine e di San Giovanni
sono difficilmente pensabili senza Jacopo della Quercia, pur traducendone i modelli in maniera
più lineare.
38. Sulla corte di Paolo Guinigi vedi C. Altavista, Lucca e Paolo Guinigi (1400-1430): la costruzione
di una corte rinascimentale, Pisa 2005; G. Donati, Lucca al tempo di Paolo Guinigi, Lucca 2008;
G. Fattorini, «L’area toscana», in M. Folin (a cura di), Corti italiane del Rinascimento. Arti,
cultura e politica, 1395-1530, Milano 2010, pp. 249-265, speciatim 250-256.
39. A. De Marchi, Gentile…, 1992, p. 107, nota 14, e 186, nota 20; sul mecenatismo bresciano
di Pandolfo vedi Anna Falcioni, «Brescia», in Gentile da Fabriano. Studi e ricerche…, pp. 121-
132; Ead., «Gli artisti alla corte bresciana di Pandolfo III Malatesti nelle fonti archivistiche (1404-
1421)», in A. De Marchi (a cura di), Nuovi studi sulla pittura tardogotica. Intorno a Gentile da
Fabriano, atti del convegno di Fabriano (2006), Livorno 2007, pp. 45-66.
40. M. Mazzalupi (a cura di), «Regesto», in Gentile da Fabriano. Studi e ricerche…, p. 77, doc. 66.
71
27. Veduta dell’eremo francescano zoccolante di Santa Maria in Valdisasso (Valleromita) presso Fabriano.
Bernacchioni è probabile che da Brescia Gentile si sia trasferito subito a Firenze, salvo ritornare a Fabriano nella primavera dell’anno successivo (documenti del marzo-aprile 1420) e nell’estate prendere a pigione una casa nella città gigliata41. E’ giocoforza pensare allora che la commissione prestigiosa dell’ancona per Palla Strozzi, in ultima analisi la ragione principale per cui il pittore ritardò il suo spostamento a Roma e si trattenne così a lungo a Firenze, sia giunta nei mesi immediatamente successivi, in perfetto parallelo con l’incarico degli stalli lignei ad Arduino, documentato come abbiamo detto nel gennaio del 1420. Da tutti questi indizi emerge allora uno scenario affascinante della diffusione del gusto internazionale, per cui una schiera di artisti di provenienze diverse si rivelano in stretto rapporto e fra secondo e terzo decennio si muovono di qua e di là dell’Appennino, sulle tracce di Jacopo della Quercia, in una complessa triangolazione da Ferrara a Lucca, da Brescia a Firenze, da Bologna a Siena.
Altri ritrovamenti in futuro permetteranno forse di circostanziare meglio i passaggi della vita di Gentile prima della sua affermazione a Venezia, dove io penso sia approdato molto presto, probabilmente a ridosso della crisi della signoria viscontea sopraggiunta con la morte di Gian Galeazzo Visconti nel 1402. La frequentazione ferrarese potrebbe già derivare dal trasferimento in laguna. Intanto, grazie alle ricerche di Maria Rita Silvestrelli, è possibile individuare il personaggio che dovette commissionargli un polittico per i domenicani di Perugia, probabilmente per l’altare della sagrestia, che aveva funzione anche di capitolo, vale a dire il perugino Matteo di Pietro Graziani, documentato dal 1384 al 1418, operaio della chiesa dei predicatori, maggiorente della città che rivestì incarichi politici importanti, fra cui due missioni presso Gian Galeazzo Visconti, cui il comune di Perugia si era dato, nel 1400 e nel 140242. Se è giusta l’ipotesi che Gentile fosse a Milano o a Pavia in quegli anni piacerebbe immaginare che lì il Graziani l’abbia contattato per l’importante commissione, di cui resta il centrale con la Madonna col Bambino, nella Galleria nazionale dell’Umbria (fig.25), e forse sei tavolette di un collegio apostolico destinato ai contrafforti, riemerse dal mercato antiquario43. Matteo di Pietro aveva commissionato gli affreschi della cappella maggiore di San Domenico, pure di suo patronato, all’orvietano Cola Petruccioli, morto a Perugia nel 1401. Il frangente della sua dipartita può avere giustificato la ricerca del giovane fabrianese, già lanciato in un agone sovra-regionale. La Madonna col Bambino di San Domenico era inserita in una cornice di sagoma mistilinea, coronata ad arco inflesso, concepibile solo a Venezia, e del resto vari dati tecnici del dipinto fanno pensare ad una prima intensa reazione di Gentile alle tradizioni della pittura veneziana del Trecento. E’ dunque probabile che l’opera sia stata dipinta ormai a Venezia e da lì spedita a Perugia, secondo un fenomeno che non deve sorprendere e che è attestato fin dal secolo precedente per grandiosi polittici, come quello che Lorenzo Veneziano dipinse per San Francesco a Rieti, nel 1372 (sopravvive il solo pannello centrale, al Louvre)44. La data di realizzazione dovrebbe allora cadere verso il 1404-1405 circa, proprio quando il pittore pare fosse in rapporto con Ferrara.
Il passaggio successivo, dal punto di vista dell’evoluzione stilistica e del radicamento dell’artista a Venezia, dove Gentile esercitò un’influenza vasta e capillare, è rappresentato in maniera paradigmatica dal famoso polittico di Valleromita (fig.1), un’opera che deve seguire il 1405, quando i francescani
41. Annamaria Bernacchioni, «Firenze», in Gentile da Fabriano. Studi e ricerche…, pp. 121-132.
42. M. R. Silvestrelli, «Perugia al tempo di Gentile. Artisti, botteghe, committenti», in A. De
Marchi (a cura di), Nuovi studi sulla pittura tardogotica. Intorno a Gentile da Fabriano, atti del
convegno di Fabriano (2006), Livorno 2007, pp. 169-186.
43. Cfr. A. De Marchi, «Ancona, porta della cultura adriatica. Una linea pittorica, da Andrea de’
Bruni a Nicola di maestro Antonio», in A. De Marchi e M. Mazzalupi (a cura di), Pittori ad Ancona
nel Quattrocento, Milano 2008, pp. 15-95, speciatim 50-53.
44. Cfr. C .Guarnieri, Lorenzo Veneziano, Cinisello Balsamo 2006, pp. 212-213, cat. 42.
72
zoccolanti si insediarono nell’eremo di val di Sasso, loro concesso per la liberalità di Chiavello Chiavelli, che vi si fece seppellire nel 141245. La datazione più probabile è verso il 1408, quando il Chiavelli era ancora in vita e militava come capitano di ventura al soldo della Serenissima e quando Gentile è documentato a Venezia, per un’anconetta richiestagli dal lucchese Francesco Amadi. L’opera è conservata quasi nella sua interezza nella Pinacoteca di Brera a Milano, a seguito delle soppressioni napoleoniche. Purtroppo ha perso la cornice originale, che dobbiamo immaginare florida di intagli, secondo la consuetudine di questi manufatti veneziani, e manca il pannello centrale superiore, una Crocefissione, che probabilmente non va identificata con quella riconosciuta come opera di Gentile da Everett Fahy, da me pubblicata nel libro del 1992 ed in seguito acquistata dallo stato italiano per Brera46. Io appoggiavo l’identificazione sulle strette affinità stilistiche, che restano valide, e sulla lettura di un’iscrizione in inglese sul retro, che la diceva proveniente dalla collezione del cardinale Giacomo Franzoni, vescovo di Camerino dal 1666 al 1693. Di recente Anna Maria Ambrosini, studiando i carteggi dei corrispondenti di Amico Ricci, in vista della sua opera pionieristica Memorie storiche delle arti e degli artisti della Marca di Ancona, edito nel 1834, ha ritrovato però una lettera dell’erudito fabrianese Carlo Rosei a Ricci, del 15 marzo 1828, da cui si evince che nel 1811, quando gli scomparti maggiori del polittico raggiunsero Milano e le quattro scene narrative rimasero in proprietà dello stesso Rosei, la Crocefissione era ancora a Fabriano e solo allora finì nelle mani di un greco che la comprò ad Ancona47, ciò che farebbe dunque escludere l’identità con la tavola appartenuta già nel sec.XVII al cardinal Franzoni.
L’idea di proiettare l’Incoronazione della Vergine (fig.26) in una dimensione puramente celeste e spirituale condusse Gentile ad abolire ogni allusione ad un trono e a fare sedere Cristo e la Vergine direttamente sui raggi di luce incisi sull’oro, con effetto quasi abbacinante, potenziato dall’instancabile operazione delle vesti, come sete fruscianti, conteste di incisioni su oro e argento, spolverature di minuti motivi dorati a missione, velature a vernice traslucida, etc. I versetti di inni mariani che emergono ad intermittenze sui bordi delle vesti, insieme agli angeli musicanti, costituiscono il basso continuo di questa folgorante rivelazione. I dipinti veneziani del Trecento con l’Incoronazione della Vergine inserivano nel trono stesso un’allusione simbolica al firmamento, qui invece il gruppo sacro si libra e quasi lievita alto sopra la volta dell’universo. Sui lati San Girolamo, San Francesco, San Domenico (scelto probabilmente perché i Chiavelli avevano la loro cappella di famiglia presso Santa Lucia, la chiesa cittadina dei domenicani) e Santa Maria Maddalena incedono sopra un tappeto fiorito, come se partecipassero della beatitudine del Paradiso terrestre e perciò
45. Cfr. M. Ceriana – E. Daffra (con la consulenza epigrafica ed innologica di Giampaolo Ermini),
in Gentile da Fabriano e l’altro Rinascimento…, pp. 128-135, cat. III.1.
46. A. De Marchi, Gentile…, 1992, pp. 56 e 90-91, nota 59.
47. «Del Gentile di Fabriano posso pertanto dirle che esisteva nella chiesa dei Minori Osservanti
di Valleromita, territorio di questa città, una bella pittura in tavola, che nella sua Istoria pittorica
ricorda il Lanzi. Il principal quadro ci fu tolto [nel 1811] da certo signor Boccolari, che nell’epoca
del Regno italico, per commissione del Governo si trasferì anche in queste nostre contrade, e
fece trasportare molte pitture a Milano, come le sarà noto. Restarono solo i cinque quadri che
lo circondavano. Uno rappresentante il Santissimo Crocifisso si apprese in quella circostanza da
un certo frate del detto ordine, e gli altri quattro restarono nel detto locale. Quindi ripristinati
i frati furono questi da me comprati, per cui io posseggo tali preziosi avanzi, rappresentanti San
Francesco, San Girolamo, San Pietro Martire, ed il quarto un frate seduto in atto di leggere un libro
che tiene in mani […] Il quadro poi preso dal suddetto frate fu venduto in Ancona ad un greco con
una memoria autentica, che si tolse all’archivio del convento, dalla quale si provava legalmente
la verità dell’opera derivante da sì famoso pennello.» (A. M. Ambrosini Massari, ‘Dotti amici’
Amico Ricci e la nascita della storia dell’arte nelle Marche, Ancona 2007, pp. 291-292 e 295).
73
fossero introdotti ad una vera e propria conversazione celeste. Al tempo stesso però sono figure di una fisicità pulsante che a Venezia dovette parere di una novità sconcertante.
Corporeità e spiritualità sono intrecciate in quest’opera in maniera inscindibile e paradossale. E’ il paradosso dell’arte di Gentile, ma anche quello di questa fondazione eremitica che fu depositaria di un ambizioso investimento da parte del Chiavelli. La volontà di non farsi seppellire in una cappella cittadina, come nella tradizione, ma di identificarsi in un convento francescano osservante, posto in un luogo aspro ed inospite in mezzo ai boschi (fig.27), era manifestazione di un proposito al fondo assai sofisticato, consapevolmente o inconsapevolmente emulo dello spirito elitario che aveva spinto ad esempio i duchi di Borgogna a farsi celebrare nel chiostro più appartato ed eletto, quello della Certosa di Champmol.
Un polittico sontuoso e complesso come quello di Gentile non rientrava nella norma, spiccava senz’altro nel panorama delle pale d’altare presenti nelle Marche interne in quel tempo: tanto più doveva impressionare in quanto destinato ad un luogo così solitario. Un’eco di tale sorpresa si può leggere ancora, fra le righe, nelle parole dell’umanista Flavio Biondo, che alla metà del Quattrocento ammirò l’opera e il convento che l’ospitava, tanto più incitato dal contrasto con l’isolamento e l’asperità del luogo48. Le sue parole, esaminate nel contesto, ci aiutano allora a recuperare una dimensione percettiva che è essenziale per capire un’opera simile.
L’opposizione fra il polittico di Valleromita e la pala Strozzi, da cui abbiamo preso le mosse, si colora così di una sfumatura in più, quella che contrappone il centro alla periferia, l’Italia delle capitali a quella dei municipi, il successo mondano di Gentile alla solitudine di una ricerca al fondo appartata e non imitabile.
48. «Est vero ad Esis fluvii dexteram sub ipsis appennini iugis qua validum Umbriae oppidum
petitur locus fratrum seraphici Francisci heremita dictus quo viso ut inquit poeta Ovidius potes
dicere numen inest: aedificiis certe quantum religiosis viris sat sit ea in locorum asperitate tam
commode istructus ut alia eiusdem ordinis Italiae urbium loca amoenitate superet servaturque picta
in eo tabula Gentilis fabrianensis opus caeteris quas viderimus praeferenda» (Flavio Biondi da
Forlì, Italia illustrata. Regio quinta Picenum sive Marchia anconitana, 1453, ed. Venezia 1510, p.
78r: «Sul lato destro del fiume Esino, ai piedi delle stesse catene appenniniche per cui si raggiungono
importanti città umbre, c’è un luogo dei frati del Beato Francesco chiamato l’Eremita, alla vista del
quale tu puoi esclamare, come dice il poeta Ovidio, che vi abita il divino: nelle costruzioni è certo
quanto basta per i religiosi, per essere in tanta asperità di luoghi è sistemato così comodamente
da superare per amenità altre sedi dello stesso ordine delle città italiane e lì si conserva una tavola
dipinta di Gentile da Fabriano, opera da anteporre alle altre sue che abbiamo visto»). Un secolo
dopo, Leandro Alberti, pur senza fare riferimento al polittico di Gentile, riecheggiò le parole del
Biondo nel sottolineare di nuovo il contrasto tra la bellezza del convento e il luogo desertico: «poscia
si vede […] sotto i gioghi dell’Appennino, la Heremita, monastero molto bello e vago di edifici, che
fa maravigliare ogn’uno che lo vede, considerando come sia possibile di fare tali edifici in questi
strani, aspri e rigidi luoghi» (Leandro Alberti, Descrittione di tutta Italia, Bologna 1550, p. 255v).


























![Fortified Palaces in Early Modern Europe, 1400-1700 [EAHN 2014]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6332577f576b626f850d5fce/fortified-palaces-in-early-modern-europe-1400-1700-eahn-2014.jpg)