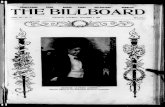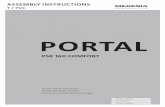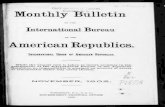160 - Margherita Guarducci (1902-1999)
Transcript of 160 - Margherita Guarducci (1902-1999)
In questo anno 2003 non cade soltanto il centenario della morte di Theodor Mommsen1, ma anche il centocinquantesimo anniversario della nascita del Corpus Inscriptionum Latinarum, l’impresa scien-tifi ca, fra le tante da lui ideate e realizzate, alla quale il suo nome è più intimamente associato. Nel 1853, anno destinato ad imprimere una svolta fondamentale, non solo negli studi epigrafi ci, ma nella vita stessa del Mommsen, l’Accademia di Berlino, alla quale già sei anni prima questi aveva presentato un suo piano per la realizzazione di quella raccolta generale delle iscrizioni latine di cui da tempo si sentiva l’esigenza2, decide, dopo aver sperimentato altre vie rivelatesi infruttuose, di accettare la sua proposta e di affi dare a lui la realizzazione di un Corpus Inscriptionum Latinarum berlinese da affi ancare al Corpus Inscriptionum Graecarum, già da qualche decennio in corso di realizzazione a cura di August Boeckh3.
L’idea di una tale raccolta non era nuova: progetti in tal senso erano già stati formulati, per ricordare soltanto i due più recenti ed importanti, dal danese Olaus Kellermann, che nel 1836 ne aveva presentato uno all’Accademia di Copenhagen4, e dalla commissione francese del Ministro Albert François Vil-lemain nel 18435. Nessuno dei due era però riuscito a decollare, l’uno per l’improvvisa morte del suo ideatore già nel 1838, l’altro principalmente per il malcontento ed i dissidi sviluppatisi dentro e fuori la commissione, con il risultato, fra l’altro, di disamorare quelli che avrebbero dovuto collaborare, tra cui il Mommsen.
VI,1 - QUO TEMPORE TITULI IMPRIMEBANTURMOMMSEN REVISORE DEI VOLUMI NON SUOI DEL CIL
* Theodor Mommsen e l’Italia (Atti Conv. Lincei, 207), Roma 2004, pp. 437-457.1 Su Mommsen (1817-1903) la bibliografi a è amplissima e si è ulteriormente accresciuta a ridosso del centenario della morte; mi limito a ricordare alcuni recenti lavori da cui sarà facile risalire ai precedenti, almeno ai principali, tra i quali vanno annoverate le ricerche biografi che di L. HARTMANN
(1908) A. WUCHER (1956; II ed. 1968), A. HEUSS (1956; II ed. 1996), L. WICKERT (1959-1980), I. BIGLER (1986), A. DE-MANDT (1997), S. REBENICH (1997), E. FLAIG (1998): S. REBE-NICH, Theodor Mommsen. Eine Biographie, München 2002; M. BUONOCORE, Theodor Mommsen e gli studi sul mondo antico. Dalle sue lettere conservate nella Biblioteca Aposto-lica Vaticana, Napoli 2003. Si vedano, naturalmente, anche gli altri contributi presentati in questo Convegno.2 TH. MOMMSEN, Über Plan und Ausführung eines Corpus Inscriptionum Latinarum (Januar 1847), in A. HARNACK, Ge-schichte der königlich Preussischen Akademie der Wissen-schaften zu Berlin, Berlin 1900, II, pp. 522-540.3 Su A. Boeckh (1785-1867): K.B. STARK, in Allgem. Deut.Biogr., 2, 1875, pp. 770-783; M. HOFFMANN, August Boeckh,Lebenschreibung und Auswahl aus seinem wissenschaftli-chen Briefwechsel, Leipzig 1901; W. WETTER, in Neue Deut.
Biogr., 2, 1955, pp. 366-367; E. CONTIADES TSITSONI, Ein Bei-trag zur Geschichte der Epigraphik (Briefe Böckhs an Ran-gabis), in Zeitschr. Pap. Ep., 72, 1988, pp. 219-233. In ge-nerale sullo studioso vd. anche i contributi di A. HORSTMANN e G. CAMBIANO, in L’antichità nell’Ottocento in Italia e in Germania, Bologna-Berlino 1988, pp. 39-98. Sulle vicende che portarono infi ne ad accettare la proposta del Mommsen scartando quella di A.W. Zumpt (1815-1877): J.P. WALTZING, Le recueil général des inscriptions latines (Corpus Inscrip-tionum Latinarum) et l’épigraphie latine depuis 50 ans, Louvain 1892, pp. 49-55.4 Il progetto di O. Kellermann (1805-1838) si può leggere anche presso J. IRMSCHER, in Akten des IV.Akten des IV.Akten des IV Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik,Wien 1962, Wien 1964, pp. 157-173.5 J. SCHEID, Le projet français d’un recueil général des inscriptions latines, in Bartolomeo Borghesi. Scienza e li-bertà, Bologna 1982, pp. 337-353. Per gli antecedenti vd. anche: V. SANGARNÉ, Les tentatives françaises d’édition d’un recueil des inscriptions latines (CIL): la guerre des comités (1935-1839), in Cah. Hist. (Lyon), 44, 1999, pp. 105-126 (segnalazione di Silvia Orlandi).
<437>
<438>
1528 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
Non vi è dubbio che decisiva nell’indurre l’Accademia di Berlino (originariamente orientata di-versamente) a riconsiderare il progetto del Mommsen, sia stata la pubblicazione, l’anno prima, delle Inscriptiones Regni Neapolitani Latinae, opera che aveva il vantaggio, sia di far vedere in concreto come l’auspicato Corpus avrebbe potuto essere, sia di identifi care nel suo autore lo studioso che meglio di ogni altro avrebbe potuto realizzarlo6. Inutile dire che la scelta, anche se tardiva, risultò illuminata, come fu del pari felice l’idea di associargli nell’impresa altri due studiosi come Wilhelm Henzen7 e Gio-van Battista de Rossi8, il cui apporto nell’impianto dell’opera non tardò a rivelarsi, sia pure per motivi diversi, fondamentale.
Nel 1853 Theodor Mommsen aveva 36 anni ed insegnava diritto romano all’Università di Zurigo, avendo dovuto lasciare la cattedra di Lipsia tre anni prima per ragioni politiche; Wilhelm Henzen ave-va 37 anni ed era Secondo Segretario dell’Istituto di Corrispondenza Archeologica a Roma (diventerà Primo Segretario poco dopo); Giovan | Battista De Rossi, il più giovane dei tre, aveva 31 anni ed era uf-fi cialmente scriptor Latinus della Biblioteca Vaticana, anche se larga parte della sua attività era effettiva-mente consacrata a ricerche di archeologia ed epigrafi a cristiana. Tutti e tre, il Mommsen in particolare, si rifacevano al magistero ideale di Bartolomeo Borghesi, allora settantaduenne9, che della creazione di un Corpus Inscriptionum Latinarum era stato tra i più caldi sostenitori fi n dai tempi del Kellermann. È tanto nota quanto signifi cativa, e quindi degna di ricordo anche in questa sede, la dedica Bartholomaeo Borghesio magistro patrono amico delle Inscriptiones Regni Neapolitani Latinae, ripetuta tal quale da Mommsen più di trent’anni dopo (quando il Borghesi era già morto da più di un ventennio), in fronte-spizio, sia di CIL, IX, sia di CIL, X10.
Iniziava dunque nel 1853 un’avventura esaltante che, se anche il numero dei partecipanti si sarebbe col tempo necessariamente ampliato, ciascuno con un suo personale e rilevante apporto, avrebbe avuto per cinquant’anni nel Mommsen il suo indiscusso protagonista, sia come realizzatore, sia come infati-cabile propulsore e guida.
In quei cinquant’anni riuscì all’Accademia di Berlino ed al gruppo di lavoro, peraltro non numero-sissimo, coordinato dal Mommsen, non solo di realizzare quel Corpus Inscriptionum Latinarum che altri
6 E certo dovette pesare anche il lusinghiero giudizio espresso dal Borghesi al suo apparire: “Con molta ragione si ha dunque da salutare coi più sinceri applausi l’edizione di quest’opera elaboratissima, che se fra le passate collezioni cede soltanto alla gruteriana ed alla muratoriana nel numero dei monumenti, le vince però tutte di gran lunga in critica e diligenza” (Bull. Inst., 1852, p. 122).7 Su W. Henzen (1816-1887): E. PETERSEN, in Allgem. Deut.Biogr., 50, 1905, pp. 207-215; H.-G. KOLBE, Wilhelm Hen-zen und das Institut auf dem Kapitol. Eine Auswahl seiner Briefe an Eduard Gerhard, Mainz 1984.8 Su Giovan Battista de Rossi (1822-1894), tra i lavori più recenti, oltre al contributo di M. BUONOCORE citato sopra (nt. 1), in cui si pubblicano 138 lettere del Mommsen a questo studioso, si vedano almeno: N. PARISE, in Diz. Biogr. It., 39, 1991, pp. 201-205; A. BARUFFA, Giovan Battista de Rossi.L’archeologo delle catacombe, Città del Vaticano 1994; P. , Città del Vaticano 1994; P. , Città del Vaticano 1994; PSAINT-ROCH, Correspondance de Giovanni Battista de Rossi et de Louis Duchesne (1873-1894), Roma 1995; ST. REBE-
NICH, Giovanni Battista de Rossi und Theodor Mommsen, in R. STUPPERICH, Lebendige Antike. Rezeptionen der Antike in Politik, Kunst und Wissenschaft der Neuzeit, Mannheim 1995, pp. 176-186; S. FRASCATI, La collezione epigrafi ca di Giovanni Battista de Rossi presso il Pontifi cio Istituto di Ar-cheologia Cristiana, Città del Vaticano 1997, pp. 17-41.9 Su B. Borghesi (1781-1860), oltre a A. CAMPANA, in Diz.Biogr. It., 12, 1970, pp. 624-643, si vedano almeno i saggi rac-colti in Bartolomeo Borghesi, cit. (nt. 5); ivi altra bibliografi a.10 Fra i molti che hanno scritto sul valore ed il signifi cato profondo di questa dedica, si vedano almeno: A. FRASCHET-TI, B. Borghesi, Th. Mommsen e il metodo combinatorio (in margine alle parentele di Seiano), in Helikon, 15-16, 1975-76, pp. 253-265; A. CAMPANA, Duecento anni di fama del Borghesi, in Bartolomeo Borghesi, cit. (nt. 5), pp. 24-26; C. FERONE, Teodoro Mommsen e la tradizione antiquaria meri-dionale: considerazioni su alcuni punti dell’Epistula a Bar-tolomeo Borghesi premessa alle IRNL, in Capys, 34, 2001, pp. 43-61.
<439>
1 - QUO TEMPORE TITULI IMPRIMEBANTUR 1529
avevano soltanto saputo sognare, ma anche di farlo con una novità d’impostazione e con uno standard di rigore scientifi co, di completezza e d’inquadramento storico quali non si erano mai visti prima. Si trattò di una realizzazione incredibile, di un capolavoro assoluto, che ancor oggi non può che destare ammirazione in tutti, ed in particolare nelle persone che, trovandosi ad essere indegne continuatrici di quell’opera, da un lato ben ne conoscono pregi e diffi coltà, dall’altro hanno dovuto procedere oltre sulle vie del metodo per adeguarlo alle nuove esigenze maturate nel tempo, non senza ricadute sull’impegno necessario11.
Non mi soffermerò tuttavia sulla novità scientifi ca del Corpus mommseniano, illustrata del resto più volte ed anche in questa sede da altri. Piuttosto mi sembra utile esaminare, | con l’aiuto di una tabella (fi g. 1), quale sia stato il cammino del CIL tra la sua fondazione (1853) e la morte del Mommsen (1903).CIL tra la sua fondazione (1853) e la morte del Mommsen (1903).CIL
L’inizio è naturalmente lento, per le necessità del primo impianto e per la stampa non facile. Il pri-mo volume, dedicato alle antiquissimae nonché agli elogia, ai fasti ed ai | calendari, esce così nel 1863 ed il secondo, che raccoglie le iscrizioni della Spagna, è del 1869. Ma poi il ritmo diventa sempre più accelerato: sette tomi appaiono negli anni ’70; 11 negli anni ’80, altri 11 negli anni ’90 e tre ancora tra 1901 e 1902.
Prima della morte del Mommsen, non solo è stata realizzata tutta la prevista copertura dell’Italia e dell’Impero, ma di un volume (CIL, I) si è già curata in parte una seconda edizione e per altri cinque (II, III, IV, VI, VIII) si dispone ormai di uno o più supplementi di aggiornamento (ben quattro per CIL,III). Complessivamente fi no a quel punto le iscrizioni pubblicate con proprio numero sono 135.713, di cui 13.838 tra le falsae.
Dei 35 tomi complessivi, 2 sono tematici (quelli di CIL, I), 18 riguardano l’Italia (otto dei quali Roma), i rimanenti 15 il complesso delle province. Mommsen ne pubblica da solo 8 e, in collaborazio-ne, altri quattro (cioè più di un terzo). Complessivamente gli autori, ripartiti tra collectores ed edito-res, tra autori in proprio e coautori, sono soltanto 14 e precisamente, in ordine alfabetico: Eugen Bor-mann12, René Cagnat13, Giovan Battista de Rossi14, Hermann Dessau15, Alfred von Domaszewski16, Heinrich Dressel17, Wilhelm Henzen18, Otto Hirschfeld19, Emil Hübner20, Christian Hülsen21, Johann
11 Sugli sviluppi dell’epigrafi a nella seconda metà del seco-lo scorso e sulle sue necessità per il futuro: G. SUSINI, Dieci congressi più uno. Il cammino dell’epigrafi a, in XI Congres-so Internazionale di Epigrafi a Greca e Latina, Roma 1997,Atti, I, Roma 1999, pp. 75-85; G. ALFÖLDY, Il futuro del-l’epigrafi a, ibid., pp. 87-102. In particolare sui cambiamenti che questo rinnovamento ha comportato anche nei criteri di edizione del CIL: S. PANCIERA – G. ALFÖLDY, Praefationes a CIL, VI, Pars octava, fasciculus alter, Berolini 1996, pp. VII-XIII; M. SCHMIDT, Epigraphische Methode und editori-sche Konzeption, in Corpus Inscriptionum Latinarum, Ber-lin 2001, pp. 13-17.12 Su E. Bormann (1842-1917): A. BETZ, in Neue Deut. Bio-gr., 2, 1955, p. 465; E. WEBER, L’impresa epigrafi ca di Eu-gen Bormnann, in G.A. MANSUELLI – G. SUSINI (a cura di), Il contributo dell’Università di Bologna alla storia della città: l’evo antico, Bologna 1989, pp. 333-342.13 Su R. Cagnat (1852-1937): Le second siècle de l’Insti-tut de France 1895-1995. Recueil biographique et biblio-graphique des membres, associés étrangers, correspondants
français et étrangers des cinq académies I, Membres et as-sociés étrangers (A-k), sous la direction de J. LECLANT, Paris 1999, pp. 222-223.14 Su G.B. de Rossi, vd. sopra nt. 8.15 Su H. Dessau (1856-1931): P.R. FRANKE, in Neue Deut.Biogr., 3, 1957, p. 615.16 Su A. von Domaszewski (1856-1927): H. HOFMANN, in Jahresb. Fortschr. Klass. Alt., 160, 1935, pp. 115-143.17 Su H. Dressel (1845-1920): P.R. FRANKE, in Neue Deut.Biogr., 4, 1959, pp. 111-112.18 Su W. Henzen, vd. sopra nt. 7.19 Su O. Hirschfeld (1843-1922): A. BETZ, in Oester. Biogr.Lex., 2, 1959, pp. 332-333.20 Su E. Hübner (1834-1901): P. LE ROUX, E. Hübner ou le métier d’epigraphiste, in Épigraphie hispanique, Problè-mes de méthode et d’édition, Paris 1984, pp. 17-31; A.U. STYLOW, Von Emil Hübner zur Neuaufl age von CIL, II, in Mitt. Deutsch. Arch. Inst. (Madrid), 36, 1995, pp. 17-25.Madrid), 36, 1995, pp. 17-25.Madrid21 Su Chr. Hülsen (1858-1935): CHR. BÖRKER, in Neue Deut.Biogr., 9, 1972, p. 736.
<440>
<441>
1530 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
Schmidt22, Richard Schoene23, | Gustav Wilmanns24, Karl Zangemeister25. Di alcuni va detto che presta-rono solo una collaborazione limitata, come nel caso di Richard Schoene. Altri invece curarono l’edizio-ne di più tomi e spesso non dei più facili.
Fu chiaro fi n dall’inizio che la costituzione del triumvirato Mommsen, Henzen, de Rossi, doveva intendersi piuttosto fi nalizzata ad una razionale ripartizione di compiti all’interno del CIL (si pensi CIL (si pensi CILalle possibilità di Henzen, che aveva alle sue spalle l’Istituto di Corrispondenza Archeologica, ed alle straordinarie competenze di de Rossi in tema di codici epigrafi ci e di iscrizioni cristiane), che ad una suddivisione delle responsabilità direttive dell’opera, le quali, invece, rimasero tutte saldamente nelle mani del Mommsen26. Suo era il progetto, sua l’impostazione scientifi ca, sua la rappresentanza generale nei confronti dell’Accademia e delle altre istituzioni, sua in larga parte la scelta dei collaboratori, sua la revisione del prodotto fi no alla stampa.
Grandi responsabilità, grande onore, ma anche lavoro tremendamente impegnativo e faticoso. Tan-to più se si pensa che non fu certo l’unico di quegli anni. Solo un alto senso di responsabilità dà al Mommsen la forza di affrontarlo, non senza frustrazioni, stanchezze o addirittura sconforti che egli non nasconde fi n dal primo volume27.
L’incarico dell’Accademia, pur se sollecitato, è vissuto come una chiamata alle armi, un ordine (parui(parui( iusso), al quale non poteva sottrarsi, perché l’alternativa sarebbe stata la perdita di un’occasione forse irripetibile, non solo per lui personalmente, ma per l’intera comunità scientifi ca: Magnopere enim verendum fuit … si hoc quoque academiae nostrae inceptum frustra fuisset, ne talis syllogae spes in perpetuum abicienda esset.
Ma cogliere questa occasione non era senza pesanti costi personali perché obbedire all’ordine, comportava che fossero messi da parte altri suoi impegni di studio che, nisi utiliora per gli altri, erano almeno per lui iucundiora.
Inoltre, dirigere un Corpus non signifi cava soltanto stabilirne le leggi, ma anche sottomettersi ad esse e tanto più quanto meno queste fossero gradite. Ad esempio, egli non avrebbe voluto cominciare
22 Su J. Schmidt, che ebbe parte anche nella preparazione della sezione sarda di CIL, X, si veda qui stesso il contributo di A. MASTINO.23 Su R. Schoene (1840-1922): L. PALLAT, Richard Schoene.Generaldirektor der Königlichen Museen in Berlin, Berlin 1959; M. BARBANERA, L’archeologia degli italiani. Storia,metodi e orientamenti dell’archeologia classica in Italia, Roma 1998, p. 200 nt. 128.24 Su G. Wilmanns (1845-1878): C. BARDT, in Allgem. Deut.Biogr., 43, 1898, pp. 304-306; J. IRMSCHER, Genesi del CIL,VIII: Inscriptiones Africae Latinae, in L’Africa romana, 4, 1987, pp. 324-325. Vd. anche sotto con nt. 39.25 Su K. Zangemeister (1837-1902): J. WILLE, Karl Zange-meister. Gedächnitsrede gehalten bei der Akad. Trauerfeier am 11 Juni 1902 in der Aula der Universität zu Heidelberg, Heidelberg 1902; G. PACHNICKE, Gothaer Bibliothekare – dreissig Kurzbiographien in chronologischer Folge, Gotha 1958, pp. 25 sg. (ringrazio M. Schmidt di queste informa-zioni bibliografi che).26 Questo nonostante si fosse parlato all’inizio di una dire-zione a tre su un piano di perfetta parità. Su questo e sulla
ripartizione interna dei compiti sono fondamentali le lette-re del Mommsen a de Rossi del 6 agosto 1853 (alla vigilia della nascita del CIL) e del 5 febbraio 1862 (nell’imminenza dell’uscita del primo volume). Le lettere sono ora in BUONO-CORE, op. cit. (nt. 1) a pp. 105-107 nr. 22 ed a pp. 119-121 nr. 3. Peraltro ciò non incrinò affatto i rapporti fra i tre che rimasero improntati ad altissima stima ed a grande affetto sino alla fi ne. Particolarmente signifi cative le lettere che de Rossi e Mommsen si scambiano nel gennaio 1887, in occa-sione della morte di Henzen (vd. BUONOCORE, op. cit., pp. 241-243 con nt. 718). Si vedano anche le lettere del de Rossi al Duchesne in rapporto allo stesso avvenimento, edite in P. SAINT-ROCH, op. cit. (nt. 8), pp. 503-504.27 CIL, I. Inscriptiones Latinae antiquissimae ad C. Cae-saris mortem. Ed. THEODORUS MOMMSEN. Accedunt elogia clarorum virorum, Fasti anni Iuliani ed. ab eodem; Fasti consulares ad a. u. c. DCCLXVI et acta triumphorum ed. aGUILELMO HENZEN, Berolini 1863. La prefazione (pp. I-IV) è datata 30 dicembre 1862. Di qui sono tratte le citazioni che seguono. La stessa prefazione è premessa alla pars prior della editio altera di CIL, I, Berolini 1893, pp. I-IV.
<442>
<443>
1 - QUO TEMPORE TITULI IMPRIMEBANTUR 1531
con CIL, I perché gli pareva che non esistessero ancora condizioni idonee per una raccolta generale delle iscrizioni latine anteriori alla morte di Cesare. Ma poiché questo era stato deciso, egli si sobbarca. Non tutto però va secondo i suoi disegni. Per dare almeno un più saldo fondamento scientifi co alla raccolta aveva preso accordi con Friedrich Ritschl28 perché facesse uscire insieme ad essa due supplementi, uno di facsimili ed uno di commenti paleografi ci e linguistici. Ma soltanto le tavole erano poi state appron-tate29.
Mommsen non nasconde la sua doppia delusione: per il mancato rispetto dei patti che urta con la sua idea del dovere, e per il venir meno di un ausilio scientifi co che aveva considerato indispensabile … Si tertia operis pars ita ut proposueramus non prodibit societasque illa hodie invenitur esse ante disiun-cta quam inceptum opus peregit, eius rei culpam neque meam esse neque academiae sciunt ii qui de ea re acta norunt, reliqui mihi credent.
In conclusione, il libro esce perché le regole, piacciano o non piacciano, vanno rispettate anche dai capi, ma l’autore non ne è contento. Ipsum librum pervelim reputare eos, quorum de hac re iudicium suspicio, non sponte mea fecisse, sed coactus operis lege, cui aut in hac re parendum fuit aut corporis universi spes abicienda. Lo ha fatto e lo ha dato alle stampe controvoglia. Il volume imperfectus enim est non solo per la inevitabile fallacia umana sed propter causas eas, quae evitari potuerunt re melius distributa et ordinata.
Su questi temi del dovere, dei progetti non sempre realizzati come si era pensato, dello scontento per il prodotto fi nito ed insieme sulla gravosità degli impegni assunti e sul loro costo anche in termini puramente personali egli ritorna più volte30.
Licenziando la prima parte di CIL, III, dieci anni dopo (sono passati 20 anni dall’inizio | dell’impre-sa)31 scrive: Ut volumen crevit, ita vita decrevit, et iam cum multorum annorum opus tandem aliquando e manibus mitto, molesto labore magis mihi liberatus esse videor, quam felici successu potitus. Dopo tante fatiche essenzialmente due sono le cose che l’autore ritiene di aver capito: di aver consumato (o meglio perduto, sprecato, i suoi anni migliori) bonos annos se consumpsisse e tutto ciò per produrre an-cora una volta un libro imperfetto et librum se edere parum perfectum. Un giudice giusto, ammesso che ci sia, dovrebbe tuttavia apprezzare – egli pensa – se non il libro almeno il lavoro che è costato (aequi iudices si qui erunt, non opus at fortasse operam laudabunt). E del resto ciò che lo ha sorretto e guidato negli anni non è stata la ricerca di gloria, ma la coscienza di dover far fronte ad un impegno preso, anche quando gli sembrasse sterile e gravoso (sed laudibus ego non studui, suffi citque mihi id quod supra lau-dem est, quod ipse mihi conscius sum negotio mihi commisso, licet ingrato et iniucundo, ita me functum esse, ut oportet virum strenuum et offi cii memorem).
28 Su F. Ritschl (1806-1876): L. MULLER, Friedrick Ritschl,eine wissenschaftliche Biographie, Berlin 1877 (II ed. 1878); O. RIBBECK, Friedrick Wilhelm Ritschl; ein Beitrag zur Geschichte der Philologie, Leipzig 1879-1881; ID., in Allgem. Deut. Biogr., 28, 1889, pp. 653-661.29 Priscae latinitatis monumenta epigraphica ad archetypo-rum fi dem exemplis lithographis repraesentata. Tabulae li-tographae. Ed. F. RITSCHL, Berolini 1862.30 Fin nel testamento (das schmerzliche Gefühl der Un-zulänglichkeit meiner Leistungen, mehr zu scheinen, als zu sein, hat mich durch mein Leben nie verlassen). Su questo importante documento, reso noto soltanto nel 1948, si ve-dano, tra gli altri, i commenti di: G. PASQUALI, Il testamento
di Teodoro Mommsen, in Riv. Stor. Ital., 61, 1949, pp. 337-350 (poi in ID., Pagine stravaganti di un fi lologo2, II, Firen-ze 1994, pp. 383-396); A. HEUSS, Theodor Mommsen über sich selbst. Zu Testamentklausen von 1899, in Ant. Abend., 6 1957, pp. 105-117 (Gesammelte Schriften, III, Stuttgart 1995, pp. 1717-1729); J. MALITZ, “Ich wünschte ein Bürger zu sein”. Theodor Mommsen im wilhelminischen Reich, in L’antichità, cit. (nt. 3), pp. 321-359.31 CIL, III, Pars Prior. Inscriptiones Aegypti et Asiae. In-scriptiones provinciarum Europae Graecarum. Inscriptio-nes Illyrici partes I-V, Berlin 1873. La prefazione (pp. V-nes Illyrici partes I-V, Berlin 1873. La prefazione (pp. V-nes Illyrici partes I-VVIII) è datata dicembre 1872. Di qui sono tratte le citazioni che seguono.
<444>
1532 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
Quattro anni dopo, nella prefazione alla seconda parte di CIL, V32, ammette apertamente di aver spesso dubitato di riuscire a portare a termine un lavoro che, intrapreso con spensierata baldanza (laeta temeritate), si concludeva infi ne non sine aliqua tristitia et paene dixerim paenitentia. Ma ancora una volta la scontentezza si mescola, da un lato con la speranza di aver reso un servizio utile, dall’altro con un respiro di sollievo: Sed tamen quoquo modo syllogen absolvi laborique ut mihi molesto et gravi, ita aliis fortasse utili et grato aliquem certe fi nem imposui (taccio in questa sede delle importanti conside-razioni che egli aggiunge sull’Italia del tempo e degli anni precedenti).
Passano altri cinque anni ed arriviamo al 1883: sono passati trent’anni dall’inizio dei lavori del CIL; Mommsen ha ormai 67 anni, si sente vecchio e vuole lasciare. La prefazione comune ai volumi IX e X (preceduta dalla ristampa della famosa lettera dedicatoria al Borghesi delle Inscriptiones Regni Neapolitani)33 gli offre l’opportunità per un ultimo bilancio prima di ritirarsi (Gubernaculum quod per triginta annos tenui, usus tempestatibus bonis malisque aequo animo in utraque fortuna navigator an-tequam depono)34. Per una volta l’insoddisfazione sembra respinta in secondo piano per far spazio non, per carità, ad una qualsiasi forma di trionfalismo, ma alla pacata constatazione che l’opera sulla quale aveva scommesso tutto se stesso poteva dirsi infi ne praticamente compiuta e toccava ormai ad altri, sia di esprimere un giudizio su di essa, sia di assicurarne la continuazione ed il | miglioramento exactum cum vita opus iis qui post me venient trado aestimandum sive in bonam sive in malam partem, sed ante omnia emendandum et continuandum. Non si poteva dire che l’impegno assunto non fosse stato mantenuto come conveniva ad un vir strenuus et offi cii memor e di questo era certamente soddisfatto. Poco importa che il congedo non sia poi stato veramente tale e che il Mommsen abbia continuato ad occuparsi in qualche modo del CIL per altri vent’anni, arrivando a salutare l’uscita di altri venti volumi, quattro dei quali lo avevano come coeditore. Ho tratto queste parole da alcune sue prefazioni perché credo che esprimano al meglio con quale spirito il Mommsen abbia vissuto il suo più diretto impegno nel CIL.
Ma il Corpus non fu soltanto opera sua: abbiamo ricordato sopra gli altri 14 studiosi che nel cin-quantennio 1853-1903 assunsero responsabilità direttive al suo fi anco per un volume o un altro. A parte Henzen e de Rossi, la cui collaborazione, determinante, va considerata a parte anche perché esplicata a un livello più alto ed entro un duraturo rapporto di stima e di amicizia, ci si può chiedere che rapporto intercorresse tra Mommsen e gli altri collaboratori. Qui credo che vada sfatata una diceria abbastanza diffusa che vuole il Mommsen sfruttatore almeno in parte di lavoro altrui. Chiara la sua origine nella sconfi nata produzione di questo studioso35 che per taluno, incapace di riconoscere l’eccezionale statura dello studioso, non poteva dipendere che da apporti esterni. Nulla di meno vero se si guarda al Corpus. Il suo fondatore ha ben chiaro che, considerata la situazione tutt’altro che soddisfacente degli studi e visto il risultato che si propone, l’impresa avviata non potrà essere realizzata senza che all’opera dei curatori dei singoli volumi si affi anchi il contributo, logistico o scientifi co, esperto o inesperto, di altre centinaia di persone. Non solo egli lo dichiara apertamente più volte in termini generali, ma è poi anche attentissimo a riconoscere concretamente e nominalmente ogni benché minimo aiuto ricevuto, sia da
32 CIL, V, pars II. Inscriptiones regionum Italiae undeci-mae et nonae, Berolini 1877. La prefazione (p. V), da cui traggo le citazioni che seguono, porta la data del 25 aprile dello stesso anno.33 Su cui vd. sopra nt. 10.34 CIL, IX. Inscriptiones Calabriae, Apuliae, Samnii, Sa-binorum, Piceni Latinae, Berolini 1883; CIL, X, Pars I.
Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae, Campaniae, Berolini 1883; In entrambi i volumi la ristampa della lettera al Bor-ghesi è alle pp. V-XVI, la Praefatio alle pp. XVII-XVIII35 Theodor Mommsen als Schriftsteller. Ein Verzeichis seiner Schriften, von Karl Zangemeister. Im Auftrage der Königlichen Bibliothek bearbeitet und fortgesetz von Emil Jacobs. Neu bearbeitet von ST. REBENICH, Hildesheim 2000.
<445>
1 - QUO TEMPORE TITULI IMPRIMEBANTUR 1533
collaboratori interni al CIL sia da esterniCIL sia da esterniCIL 36. E come sapeva essere assai duro nelle sue critiche, così era poi largo nei suoi apprezzamenti per chiunque avesse agito in spirito di collaborazione per l’interesse comune. Non che in questa occasione celebrativa ci si proponga di beatifi care il Mommsen. La sua correttezza nel riconoscere tutti i debiti contratti nei confronti di grandi e piccoli, risulta peraltro troppo evidente nel Corpus ad ogni piè sospinto perché l’idea di un sistematico ricorso ad appropriazioni inde-bite possa essere avallata.
Al contrario abbiamo ampie e sicure prove di una generosità non comune. Si veda il caso di CIL, VIII, la cui cura era stata affi data nel 1871 a Gustav Wilmanns, uno dei suoi | scolari37. Soltanto sette anni dopo questi moriva all’età di 32 anni lasciando l’opera largamente incompleta. Il Mommsen, as-sumendo infelicis iuvenis tristem hereditatem, completa il volume avvalendosi dell’aiuto di Hermann Dessau, che del Wilmanns era allievo, e lo porta a pubblicazione nel 1881 senza però aggiungere nel frontespizio né il nome suo né quello del Dessau, anzi dichiarando nella prefazione: In his quae dixi si quid erratum est vel si qua sunt quae quem offendant, mecum res agitur; Wilmannsi autem debebitur quidquid hoc volumen boni et novi habet, nomenque auctoris cum ipso volumine in honore manebit38.
Del resto un costante aiuto del Mommsen agli altri curatori del CIL era reso pressoché indispensa-CIL era reso pressoché indispensa-CILbile dalla giovane, addirittura giovanissima, età della maggior parte di essi. Alcuni, come Dessau, Do-maszewski e Hülsen, non erano ancora nati quando il Corpus fu fondato. Altri, come Cagnat, Dressel, Wilmanns, Hirschfeld, Bormann, Schoene e Zangemeister erano bambini piccoli o poco più. Soltanto Hübner era ventenne e fu preso a lavorare per il CIL a 24 anni; Hülsen fu associato al CIL a 24 anni; Hülsen fu associato al CIL Corpus a 19 anni, Dessau a 22, Bormann a 25, Wilmanns a 27, ma aveva già lavorato a Roma con Henzen. Anche gli altri cominciarono per lo più i loro volumi in età molto giovanile.
In queste condizioni è naturale che, nonostante lo straordinario fi uto del Mommsen per la scelta di giovani di grandi potenzialità, essi avessero bisogno di una guida sperimentata, sia nella fase d’impianto, anche logistico, sia durante lo sviluppo delle ricerche, sia nella fase conclusiva. E che Mommsen fosse largo di aiuti a tutti in ciascuna di queste fasi è detto esplicitamente nelle prefazioni ai singoli volumi.
Nel primo volume non suo della raccolta, il II di Emil Hübner, apparso nel 1869, l’autore, che vi aveva consacrato dieci anni di lavoro intraprendendolo appena ventiseienne, dichiara che in tutto quel tempo auxilium pene continuum praestitit Mommseni indefessa ingenii alacritas, doctrinae profunditas,rerum epigraphicarum scientia a nullo unquam aequata39. Più avanti si apprende che l’aiuto si era este-so concretamente fi no alla correzione delle bozze (paginae impressaeso concretamente fi no alla correzione delle bozze (paginae impressaeso concretamente fi no alla correzione delle bozze ( ).
36 Per un’ampia esemplifi cazione di questo comportamento si vedano qui stesso, in particolare: M. BUONOCORE, Theo-dor Mommsen e la costruzione del volume IX del CIL e A. MARCONE, I collaboratori italiani del Mommsen. Su qual-che aspetto delle inevitabili polemiche si veda ora anche A. RUSSI, Saggi di storia della storiografi a meridionale, Roma 2004, pp. 105-146 (ripresa aggiornata di uno studio del 1968).37 Su di lui vd. sopra nt. 24.38 CIL, VIII, pars I. Inscriptiones Africae Proconsularis et Numidiae; pars II. Inscriptiones Mauretaniae. Berolini 1881. La praefatio è del marzo 1881. In realtà delle 714 pagine che costituiscono il volume soltanto le prime 408 erano state in qualche modo rifi nite da Wilmanns. Il comportamento è tan-
to più apprezzabile in quanto il Mommsen aveva sull’auto-re, con motivi di apprezzamento, anche riserve non piccole, come risulta da una lettera al de Rossi del 12 agosto 1878 in cui si legge: “Lo so purtroppo che il lavoro del Wilmanns lascia molto a desiderare. Era un uomo di una fi bra rara, di un coraggio grandissimo ed un ottimo viaggiatore, ma non era né dotto, né paziente. Ora siccome non l’abbiamo più faremo ciò che è possibile perché abbia quest’onorato ricordo che per molti e molti riguardi pure merita”. La lettera è in M. BUO-NOCORE, op. cit. (nt. 1), pp. 157-159; vd. anche pp. 160, 164 sg., 172 sg., 179-183; ivi anche (nt. 455) sul contributo del de Rossi al lavoro di revisione e completamento.39 CIL, II. Inscriptiones Hispaniae Latinae, Berolini 1869, p. XXVI.
<446>
1534 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
Naturalmente poiché fi t fabricando faber ecco che due anni dopo è lo stesso Hübner ad | essere rin-fi t fabricando faber ecco che due anni dopo è lo stesso Hübner ad | essere rin-fi t fabricando fabergraziato con Mommsen da Zangemeister nella prefazione a CIL, IV in quanto uterque cum aliis de me meoque opere tum eo bene meritus est, quod mihi in hac sylloge distribuenda, concinnanda, elaboranda consilio suo aderant (segue riferimento alle bozze: plagulae typis descriptae)40.
Non diversamente Henzen, che pure faceva parte del triumvirato direttivo del CIL ed è più che ses-CIL ed è più che ses-CILsantenne nel 1876 quando fi rma la prefazione al primo tomo di CIL, VI (Roma). Parlando anche a nome del Bormann, coeditore, e delle altre persone che avevano collaborato, tra cui Hübner, Detlefsen, Kies-sling, Nissen, Zangemeister, Hirschfeld, scrive duce autem et adiutore usi sumus Mommseno, qui cum ab initio operis viam mihi monstravit, tum quo tempore tituli imprimebantur (sottolineo l’espressione che ho assunto come titolo di questo contributo) in omnibus et singulis rebus Bormannum consultantem et consilio et opera adiuvit41et consilio et opera adiuvit41et consilio et opera adiuvit .
E che dice il trentaduenne Dessau licenziando nel 1887 CIL, XIV, dopo averne assunto la respon-sabilità ancora adulescens. Non vuole ripetere ancora una volta quali siano i meriti del Mommsen nei confronti del Corpus in genere perché questi sono a tutti ben noti, né vuole ricordare quante e quali dimostrazioni di perizia ed acume abbia dato nel leggere le varie prove di stampa – fecit enim hoc atten-tissime sicut et in reliquis voluminibus – sente piuttosto il dovere e il piacere di dichiarare pubblicamente et amicis et ignotis, quam indefessus et fi delis mihi fuerit in edendo hoc volumine, cum una essemus,adiutor e quante volte, vedendolo scoraggiato per la vastità e la diffi coltà dell’impegno assunto adiutor e quante volte, vedendolo scoraggiato per la vastità e la diffi coltà dell’impegno assunto adiutor paene iacentem animum mihi erexerit, quotiens viam mihi per invia monstraverit, vel etiam immiserit42 vel etiam immiserit42 vel etiam immiserit .
L’anno seguente Hirschfeld, suo allievo prediletto, già quarantaseienne, nella prefazione a CIL, XII dichiara che il Mommsen si è mostrato nei confronti totius operis validissimum benignissimumque adiu-torem vel potius patronum in modo tale che si iuste eius in me librumque meum merita prosequi vellem,praefandi fi nem non invenirem43.
E per fi nire ancora due citazioni, rispettivamente dalla prefazione di Zangemeister al primo sup-plemento a CIL, IV (1898) e di Hülsen ai primi additamenta a CIL, VI (1902). Il primo ringrazia il Mommsen quod plagulas prelum exspectantes perlegit et eximiis, quae suis locis adnotavi, inventis exornavit, uomo straordinario che si continua ad ammirare sia per la giovanile forza intellettuale con cui porta avanti il CIL sia a considerare giustamente guida per eccellenza CIL sia a considerare giustamente guida per eccellenza CIL in his antiquitatis Romanae mo-numentis interpretandis44. Il secondo, e siamo, si badi, nel 1902 scrive: Magis denique ceteris omnibus me et operam meam benefi ciis | suis obstrinxit Theodorus Mommsen, qui huic quoque syllogae urbanae numquam defuit, consiliis largus, adiumento indefessus, cui magna ex parte deberi si hoc sylloges ur-banae corollarium non indignum videatur eis quae ipse cum Henzeno et Rossio ante hos quinquanginta annos inchoaverat, gratus ac libens profi teor45.
Se mi sono dilungato su questo punto, e me ne scuso, è stato perché fosse evidente l’assoluta con-cordia di tutti i collaboratori del CIL nel riconoscere un grande debito di gratitudine nei confronti del CIL nel riconoscere un grande debito di gratitudine nei confronti del CILMommsen per gli aiuti materiali e morali ricevuti nell’adempimento del loro incarico46.
40 CIL, IV. Inscriptiones parietariae Pompeianae, Hercu-lanenses, Stabianae; accedunt vasorum fi ctilium, Berolini 1871, p. XII. La prefazione è datata al 13 maggio 1870.41 CIL, VI. Inscriptiones urbis Romae Latinae. Pars I. Col-legerunt GUILELMUS HENZEN et IOHANNES BAPTISTA DE ROSSI. Ediderunt EUGENIUS BORMANN et GUILELMUS HENZEN, Beroli-ni 1876, p. VI.42 CIL, XIV. Inscriptiones Latii veteris Latinae. Edidit H. DESSAU, Berolini 1887, p. VII.
43 CIL, XII. Inscriptiones Galliae Narbonensis Latinae. Edidit O. HIRSCHFELD, Berolini 1888, p. V.44 CIL, IV. Supplementi pars I. Tabulae ceratae Pompeiis repertae. Edidit C. ZANGEMEISTER, Berolini 1898, p. 280.45 CIL, VI. Pars IV, fasciculus II. additamenta. Collegit et edidit CHRISTIANUS HUELSEN, Berolini 1902, p. VI.46 Una eccezione degna di nota, che non so se abbia una spiegazione particolare, è costituita da E. Hübner che nel-la prefazione a CIL, VII. Inscriptiones Britanniae Latinae,
<447>
<448>
1 - QUO TEMPORE TITULI IMPRIMEBANTUR 1535
Naturalmente si potrebbe sospettare che questo non fosse che un topos retorico, un rito da ripetere ed un pedaggio da pagare all’uscita di ogni nuovo volume. Ma non credo che si sarebbe nel giusto. Ho già rilevato sopra che giovani inesperti, poco più che ventenni, diffi cilmente, per quanto dotati, avreb-bero potuto far fronte ai diffi cilissimi compiti loro assegnati senza una guida esperta, un parafulmine di prestigio, una persona capace d’infondere fi ducia e coraggio nei momenti di diffi coltà. Evidentemente Mommsen è stato tutto questo e le prefazioni non fanno che registrare questa realtà. Sarà stato magari anche altro, ma l’una cosa non esclude l’altra.
Le prefazioni sono concordi anche su un altro punto: Mommsen non si limitava a scrivere i suoi volumi ad a seguire la realizzazione degli altri (per ognuno dei quali era mediamente necessaria una die-cina di anni), ma alla fi ne leggeva anche attentissimamente tutto ciò che era stato scritto, correggendolo e postillandolo minuziosamente. Ne abbiamo la riprova nelle adnotationes non paucae adscriptae ab eo singulis quibusdam huius syllogae titulis, come scrive Hübner47, ovvero nelle aggiunte che egli era solito fare ai commenti apposti dai curatori ai vari testi. È con un esame campione di questo aspetto della sua attività che vorrei concludere.
Per la verità le sue correzioni e annotazioni dovettero essere assai di più di quelle che fi gurano sotto il suo nome nei volumi stampati48. Scrive lo stesso Henzen di aver limitato | la citazione del Mommsen ai soli contributi più rilevanti, perché praticarla sempre sarebbe risultato, da un lato impossibile, dall’al-tro, al limite, addirittura fastidioso: plurima enim eaque gravissima eiusmodi erant ut quae ei deberentur indicare aut non aut cum molestia possemus49.
Dunque le postille del Mommsen riprodotte nel CIL, tra parentesi, quadre e con le sue sigle, o co-munque citando il suo nome, non sono che una piccola parte di quelle da lui aggiunte ai testi altrui al momento della loro revisione. Ma questa piccola parte a quanto ammonta? Ho voluto fare una verifi ca sul primo tomo di CIL, VI, anzi su una parte di esso, quella relativa alle iscrizioni sacre, imperiali, se-natorie ed equestri: 1801 in tutto. Ebbene in questa sezione mi sono risultati non meno di 104 interventi momseniani su altrettante iscrizioni (e il conteggio pecca probabilmente per difetto) il che vuol dire che un segno della lettura del Mommsen è di fatto riscontrabile in quasi il 7% delle epigrafi registrate in questo tomo.
In 63 casi, questi interventi sono costituiti da aggiunte di varia estensione ed importanza, per lo più poste (tra parentesi quadre e siglate TH.M.) alla fi ne della scheda redatta da Henzen50; negli altri casi è invece Henzen stesso a riportare nella sua scheda suggerimenti o pareri del revisore con formule del tipo: Mommsenus intellegit, cogitavit, coniecit; mavult, praefert, proposuit, putat, suspicatur oppure suspicatur oppure suspicatur
Berolini 1873, a differenza di quanto aveva fatto licenziando CIL, II (vd. sopra), non ringrazia né il Mommsen né alcun altro. Nella prefazione a CIL, II, Supplementum, Berolini 1892, pp. LXI-LXII, Hübner ringrazia, dei compatrioti, sol-tanto F. Bücheler aggiungendo che reliquorum nomina suis quodque locis adnotata sunt. Non hanno alcuna prefazio-ne i volumi XI (1888, Bormann), VIII Suppl., pars I (1891, Cagnat, Schmidt), XV, 1 (1891, Dressel), XV, 2, 1 (1899, Dressel).47 CIL, II, p. XXVI. Ancora nel 1909 A. Mau scrive nel-la sua Praefatio a CIL, IV, Supplementum, pars II (p. VI): usque ad n. 6600 folia priusque prelo traderentur legerunt Mommsen et Zangemeister. Utroque morte abrepto ceteros solus absolvi.
48 Da notare che annotazioni siglate di tal genere non si tro-vano soltanto nei volumi non suoi del CIL, ma anche nei supplementi dell’Ephemeris epigraphica (fondata nel 1872) e nei Supplementa Italica (Additamenta ad CIL, V) di E. PAIS, pubblicati con data 1884 (in realtà 1888).49 CIL, VI, pars I, p. VI: Eius nomen in volumine cum non attulerimus, nisi ubi singulare aliquid protulit, pro eis quae fecit raro commemoratur, plurima enim…50 CIL, VI 42/44, 76, 107, 112, 114, 130, 168, 212/13, 221, 231, 250, 266, 267, 276, 277, 282, 337, 346, 353, 357, 360, 385/6, 412/13, 460, 488, 500, 507, 537, 647, 820, 830, 879, 882, 884, 886, 887, 907, 948, 1016, 1111, 1154, 1156, 1159, 1164, 1207, 1222, 1353, 1434, 1455/56, 1480/81, 1495/96, 1548, 1565, 1569, 1611, 1615, 1632, 1640, 1641, 1735, 1793, 1797.
<449>
1536 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
supplementa sunt Mommseni, Mommsenus restituit, explevit, supplementa suppeditavit Mommsenus e altre ancora51.
Dalle prefazioni che ho citato sopra si ricava l’impressione che questi interventi il Mommsen li facesse sulle bozze, cioè a testo già composto sotto la responsabilità del curatore del volume. È da dire però che se pure ve ne furono certamente anche in questa fase (si è visto che è ringraziato anche per il contributo dato alla correzione delle bozze), per quel che posso giudicare, non fu questa la prassi pre-valente, almeno per quanto riguarda CIL, VI, di cui si conservano fortunatamente a Berlino le schede originali che servirono per la stampa. Ne ho potuto prendere visione nell’archivio dell’Accademia grazie alla cortesia dell’attuale Segretario del CIL, Manfred Schmidt, il quale mi ha anche fatto fotocopiare la parte relativa alla sacrae. Sono documenti del massimo interesse per la storia dell’opera e, in particolare, per valutare il contributo del Mommsen ai volumi sottoposti alla sua revisione fi nale.
Da esse, e dal loro confronto con il testo edito nel CIL, risulta certo che al Mommsen il lavoro veniva sottoposto già prima e non dopo la stampa e che la quasi totalità dei suoi interventi avveniva in questa fase e non dopo. Solo raramente troviamo nell’edizione a stampa qualcosa che non c’era nella scheda consegnata per la stessa e | che, quindi, sarà verosimilmente frutto di un intervento sulle bozze52. Per lo più scheda manoscritta e scheda a stampa sono esattamente corrispondenti e non si può non espri-mere ammirazione per come i tipografi dell’epoca (oggi sarebbe inimmaginabile) seppero trasformare in stampa nitida e correttissima testi latini assai diffi cili, spesso colmi di ripensamenti, correzioni, aggiunte e redatti per di più con grafi e diverse, neppur molto accurate.
Sarebbe molto interessante commentare direttamente sugli originali la parte avuta dal Mommsen nella laboriosa defi nizione di tante schede prima della loro stampa. Devo però limitare l’esemplifi ca-zione a sole quattro schede (suffi cientemente eloquenti però) traendole dalla sezione delle iscrizioni sa-crae, che occupano i primi 871 numeri del primo tomo di CIL, VI. In ciascun caso mostrerò in parallelo l’edizione a stampa e la scheda redatta per essa. Fortunatamente la grafi a di Henzen (più grande) e di Mommsen (assai più minuta) sono perfettamente distinguibili.
CIL, VI 337 (fi g. 2). Dedica a Ercole Pugile nota da tradizione manoscritta. Henzen non ha sospetti. Mommsen pensa che possa essere un falso. Si veda l’aggiunta mommseniana tra parentesi quadre debi-tamente siglata; ma va anche notato che tutto il lemma iniziale con la storia del testo è stato completa-mente riscritto dal Mommsen in maniera molto più estesa53.
CIL, VI 582 (fi g. 3). Dedica al dio Silvano, nota anche questa solo da tradizione manoscritta. Crea problemi l’abbreviazione conser. alla r. 4. Henzen scrive un suo commento. Mommsen aggiunge prima una serie di considerazioni (in basso) poi un’altra (a lato). Risultato: Henzen cassa tutto il suo commento e introduce la seconda spiegazione di Mommsen con l’espressione Explicandum cum Mommseno54.
51 Vd. ad esempio CIL, VI 220, 379, 406, 455, 478, 562, 564, 582, 590, 627, 631/2, 642, 722, 726, 793, 810, 900, 912, 920, 964, 970, 984, 1022, 1064, 1079, 1080, 1087, 1089, 1300, 1493, 1546.52 Ad es. in CIL, VI 346, 385/6, 647, 830. C’è anche il caso inverso di osservazioni che fi gurano nelle schede e risultano soppresse nell’edizione; ad es. in CIL, VI 213 la notazione 2 Cru(stumina) pro solita forma Clu(stumina) probe notan-dum, nam haud scio num alibi in titulis reperiatur risulta nam haud scio num alibi in titulis reperiatur risulta nam haud scio num alibi in titulis reperiaturcassata nell’edizione evidentemente perché nel frattempo ci si è resi conto che la forma Cru. pro Clu. era tutt’altro che rara.
53 Nei primi additamenta (CIL, VI 3004) Chr. Hülsen po-stilla: titulum in suspicionem vocavit Mommsenus fortasse immerito, cum et auctoritas Sabini optima sit, et titulum a muliere Herculi dicatum habeamus supra n. 286. L’epiteto di pugile non è del resto disadatto ad Ercole.54 Il primo dei due dedicanti (P. Aelius Philetus) è vero-similmente lo stesso che compie un’altra dedica a Silvano ed ai Lari Penati trovata negli scavi per le fondazioni del-la Galleria Colonna (L. CANTARELLI, in Bull. Comm. Arch.Roma, 43, 1915, p. 222 = AE 1916, 108; AE 1916, 108; AE F. FORNARI, in Not.Sc., 41, 1915, p. 241; ID., in Not. Sc., 43, 1917, p. 24). L̓ Or-to Theofi li, in cui l’iscrizione fu vista, si trovava nell’area
<450>
1 - QUO TEMPORE TITULI IMPRIMEBANTUR 1537
CIL, VI 266 (fi g. 4). Testo noto con il nome di lis fullonum perché riporta, sotto ad una dedica a Ercole, tutta una serie di sentenze emesse a vantaggio di fullones da più Prefetti dei Vigili. Si vede che tutta la trascrizione interpretata del testo non è di Henzen, ma di | Mommsen, al quale peraltro è attri-buito tra parentesi quadre solo il lunghissimo commento giuridico che segue (sette pagine come quella riprodotta nella fi g. 5)55.
CIL, VI 507 (fi g. 6). L’iscrizione, nota dal solo Ciriaco, si apre con una data espressa mediante il terzo consolato di Costantino e Massimino. Henzen, trattandosi dell’anno 313, si meraviglia che al secondo posto fi guri il nome di Massimino invece che di Licinio e sospetta un errore di Ciriaco, anche se non sa spiegarsene l’origine. Mommsen pensa invece che l’iscrizione sia, non solo corretta, ma im-portante in quanto mostra che fi no alla sconfi tta di Massimino ad Adrianopoli coppia consolare regolare fu considerata a Roma proprio quella costituita da Costantino e Massimino e soltanto in seguito sia subentrato Licinio. Henzen, convinto, elimina i suoi dubbi ed incorpora l’interpretazione di Mommsen introducendola con le parole sed, ut iure Mommsenus monuit56 ut iure Mommsenus monuit56 ut iure Mommsenus monuit .
Si potrebbe continuare con molti altri esempi altrettanto interessanti, ma questi penso siano suffi -cienti a mostrare, sia come si costituiva il CIL, sia che la riconoscenza dimostrata dai vari curatori nei confronti del loro revisore non era né immeritata, né probabilmente insincera.
Come si è visto, il Mommsen rifà lemmi, propone scioglimenti, integrazioni, spiegazioni, ripara ad errori, dota testi importanti e diffi cili di amplissimi commenti che altrimenti sarebbero mancati del tutto. Naturalmente non tutti gli interventi sono dello stesso impegno, ma sempre tali da arricchire il commen-to e da migliorare l’intendimento storico dei testi considerati.
Ci si può anche chiedere quanti di questi suoi interventi abbiano retto al trascorrere del tempo, alle nuove scoperte, all’avanzamento degli studi. Non tutti, naturalmente: alcune proposte di lettura, recu-perato e controllato il monumento, sono cadute57; sospetti di falsifi cazione non sono più condivisi58; questioni che erano allora incerte (istituzionali, prosopografi che o antiquarie, ad esempio) o hanno avuto altra soluzione o continuano | ancor oggi a restare incerte59. Ma è impressionante il numero dei casi in
dell’Ospedale Militare del Celio (R. LANCIANI, Forma Urbis Romae, tav. 36). A.M. COLINI, Storia e topografi a del Celio nell’antichità (Mem. Pont. Ac. Arch., 7), Roma 1944, p. 280 nt. 136 sospetta che vi sia stata portata con altre da una vi-gna sull’Appia. Una dislocazione è possibile, ma perché non piuttosto dall’area della Galleria Colonna?55 Su questo documento (Suppl. It., Imagines, Roma 1, p. 110 nr. 168), la bibliografi a successiva è amplissima. In CIL, VI vd. anche p. 3004. Alcuni recenti contributi riepilogativi della questione: D.A. MUSCA, Lis fullonum de pensione non solvenda, in Labeo, 16, 1970, pp. 279-326; F. DE ROBERTIS, Lis fullonum, CIL, VI 266. Nota-zioni critiche e ricostruttive, in Stud. Doc. Hist. Iur., 43, 1977, pp. 113-166; L. GASPERINI, in Il Lapidario Zeri di Mentana, I, Roma 1982, pp. 32-34; F. DE ROBERTIS, Lis fullonum (CIL, VI 266). Oggetto della lite e causa peten-di, in ANRW, 2, 14, 1982, pp. 791-799; R. SABLAYROLLES, Libertinus miles. Les cohortes de vigiles, Roma 1996, pp. 113-120 e passim.56 Sui consoli del 313, vd. ora: T.D. BARNES, The New Empire of Diocletian and Constantine, Cambridge Mass.
1982, p. 95 con nt. 19; R. BAGNALL et ALII, Consules of the Later Roman Empire, Atlanta 1987, pp. 160 sg.57 È il caso di quelle avanzate, ad esempio, per CIL, VI 107 (cfr. 5683a e 30693 da lettura dello stesso Mommsen; vd. ora anche L. BIVONA, Iscrizioni latine lapidarie del Museo di Palermo, Palermo 1970, p. 107 nr. 100 con foto); 168 (cfr. ILLRP 98 e L. CHIOFFI, Caro. Il mercato della carne nel-l’Occidente romano, Roma 1999, pp. 11 sg. nr. 2, con foto); 460 (cfr. G. SUSINI, Il lapidario greco e romano di Bologna, Bologna 1960, p. 57 nr. 47, tav. II).58 Vd. sopra nt. 53 e, per CIL, VI 14, cfr. 30695 (anche D. PALOMBI, in Lex. Top. Urb. Romae, 2, 1995, p. 7 con la bibl. ivi citata).59 Vd. ad es. CIL, VI 130, in cui si legge ora ord(inatus) e non ord(inarius) (sulla qualifi ca F. GILLIAM, Trans. Proc.Am. Philol. Ass., 71, 1940, pp. 127 sgg., in part. pp. 147 sg. = Roman Army Papers, Amsterdam 1986, p. 20); 266/267 (cfr. bibl. cit. sopra in nt. 55); 282 (cfr. S. PANCIERA, in Scritti storico-epigrafi ci in memoria di M.storico-epigrafi ci in memoria di M.storico-epigrafi ci in memoria di M Zambelli, Roma 1978, pp. 315-320); 346 (cfr. H. CHANTRAINE, Freigelassene und Sklaven im Dienst der römischen Kaiser, Wiesbaden 1967,
<451>
<452>
1538 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
cui le sue proposte interpretative sono ancor oggi considerate valide (si vedano anche nei nuovi supple-menti a CIL, VI i tanti casi di sine dubie recte, recte, haud dubie recte, certe recte riferite a Mommsen)60
o rimangono comunque, a distanza di tanti anni, le sole avanzate.Resta soprattutto che, a centocinquant’anni dalla sua nascita, il Corpus Inscriptionum Latinarum
che, ripeto, rappresenta solo una parte della complessa personalità e dell’impressionante opera del Mommsen, continua ad essere allo stesso tempo insostituibile e fondamentale strumento di conoscenza e monumento imperituro a chi (genio o non genio, l’etichetta mi sembra francamente irrilevante) con straordinaria lungimiranza, forza intellettuale, dottrina e tenacia ha saputo non solo idearlo, ma anche realizzarlo.
p. 23); 357 (cfr. CIL, I2 361 con pp. 720 e 875); 882 (cfr. p. 4302); 884 (cfr. 40361); 1111 (cfr. 40705); 1154 (cfr. p. 4330); 1159 (cfr. p. 4330); 1222 (cfr. p. 4336); 1353 (cfr. 41068); 1616 (cfr. p. 4720).60 CIL, VI 212 (l’idea di un testo originario deformato da una serie di aggiunte, in parte fuori posto, è tuttora ritenuta valida vd. ad es. J. KORPELA, Das medizinalpersonal in an-tiken Rom, Helsinki 1987, p. 200 nr. 254); 231 (per aedilis = aedituus, vd. ora AE 1980, 48); 353 (per l’identifi cazione di AE 1980, 48); 353 (per l’identifi cazione di AEAedia Servilia: M.-TH. RAEPSAET-CHARLIER, Prosopographie
des femmes de l’ordre sénatorial (IerIerI -IIe-IIe-II s.), I, Lovanii 1987, p. 30 nr. 6); 360 (nascita di Lucilla: RAEPSAET-CHARLIER, op.cit., p. 140 nr. 133, cfr. G. BIANCHI, in Misc. Gr. Rom., 13, 1988, p. 133; 385/386 e 488 (le interpretazioni proposte sono ormai universalmente accolte); 500 (cfr. R. MELLOR, in ANRW, 2, 17, 2, Berlin-New York 1981, p. 1023 nt. 403); ANRW, 2, 17, 2, Berlin-New York 1981, p. 1023 nt. 403); ANRW726 (cfr. AE 1936, 212); 879 (cfr. 40315); 886 (cfr. 40372); AE 1936, 212); 879 (cfr. 40315); 886 (cfr. 40372); AE1156 (cfr. p. 4330); 1548 (cfr. p. 4711); 1565 (cfr. p. 4713); 1569 (cfr. 41216); 1611 (cfr. p. 4719); 1632 (cfr. p. 4723); 1640 (cfr. 41185); 1641 (cfr. p. 4724).
3 - CIL, VI 582: scheda a stampa e manoscritta.
2 - CIL, VI 337: scheda a stampa e manoscritta.
1540 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
5 - CIL, VI 266: commento mommseniano nella scheda a stampa e manoscritta.
1 - QUO TEMPORE TITULI IMPRIMEBANTUR 1541
4 - CIL, VI 266: scheda a stampa e manoscritta.
Il I° giugno 1969 è deceduto a Roma, nel suo ottantaduesimo anno, Attilio Degrassi, una delle fi -gure di massimo rilievo nel campo degli studi di epigrafi a e | antichità romane non soltanto italiani, ma europei ed extraeuropei dell’ultimo cinquantennio.
Le vicende della sua vita di studioso furono estremamente semplici e lineari, specchio fedele del-l’intima coerenza morale e del temperamento di un uomo che non considerò mai l’attività di ricerca come mezzo di affermazione personale o come fonte di privato soddisfacimento, ma come un servizio da rendere.
Tenuto conto di questa disposizione spirituale, che lo teneva lontano da brighe e da adeguamenti di comodo, non ci si meraviglia purtroppo se giunse alla cattedra universitaria soltanto molto tardi, a 62 anni (1949), quando fu chiamato all’insegnamento della storia antica nell’Università di Padova. Tale insegnamento esercitò fi no al 1956. Soltanto per un anno (1956/1957) poté insegnare epigrafi a latina nella Facoltà di Lettere dell’Università di Roma e per altri cinque (1957/1958-1961/1962) ebbe modo di tenere lo stesso insegnamento nella Scuola Nazionale di Archeologia di cui fu anche Direttore.
Insegnò dunque per pochi anni e, se si pensa a quanto seppe fare in questo breve tempo per una reviviscenza degli studi storico-antiquari in Italia, con la creazione di una propria scuola, ma anche atti-rando a sé giovani di altra formazione, fomentando interessi, sostenendo con il proprio incoraggiamento e consiglio chiunque dimostrasse di voler intraprendere con serietà d’intenti, studi e ricerche nel campo dell’epigrafi a, delle antichità, delle istituzioni romane, non si può fare a meno di sottolineare anzitutto, ricordandolo, quale perdita abbia rappresentato per gli studi classici in genere il suo ritardato inserimen-to nell’Università italiana. E tanto più il rammarico ha ragione di essere in quanto il D. ebbe, oltre alla dottrina, molte di quelle doti che caratterizzano un autentico maestro: una salda fi ducia, anzitutto, nella possibilità di istituire un aperto dialogo con i giovani sul piano dell’intelligenza, un grande rispetto per la loro personalità, generosità quasi illimitata nel donare tempo e suggerimenti preziosi, indulgenza per gli errori che non nascessero da improntitudine o faciloneria, comprensione per i loro problemi, anche pratici ed economici. Di quest’ultimi egli aveva del resto esperienza diretta per essere la famiglia da cui proveniva in condizioni assai modeste.
Nato a Trieste nel 1887, da genitori d’Isola d’Istria, trascorse la fanciullezza in questa località, se-guendo però il ginnasio inferiore a Pisino e quello superiore a Trieste. Compì infi ne gli studi universitari a Vienna, tra il 1907 ed il 1911, avendo tra i maestri Eugenio Bormann, di cui soprattutto si sentì disce-polo e che ricordò sempre con venerazione.
Dopo la fi ne degli studi universitari, per oltre vent’anni, dal 1912/1913 al 1932/1933, esercitò l’in-segnamento nei ginnasi-licei di Trieste senza smettere mai tuttavia di approfondire e di affi nare le sue già larghe conoscenze epigrafi che e storico-antiquarie utilizzando in modo paziente, ma soprattutto in-telligente, le non grandi possibilità che gli erano offerte dal luogo e dalle circostanze. Testimoniano
* Gnomon, 43, 1971, pp. 733-736.
VI,2 - ATTILIO DEGRASSI (1887-1969)*
<733><734>
1544 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
questa ininterrotta attività di studio le pubblicazioni, poco meno di quaranta, che risalgono a tale periodo (bibliografi a completa in A. DEGRASSI, Scritti vari di antichità, I, Roma 1962, pp. IX-XVII; III, Venezia-Trieste 1967, pp. VII-IX; IV, in corso di stampa [Trieste 1971]).
Cadde, per le vicende della prima guerra mondiale, la pubblicazione integrale della sua dissertazio-ne di laurea sui diplomi militari (il manoscritto si rivela ancor oggi di utile consultazione), ma la compe-tenza acquisita in questo particolare campo degli studi servì al D. per esordire assai felicemente nel 1913 con un articolo appunto sui diplomi militari o per ritornare più volte in seguito (1925, 1929, 1934, 1947) sull’argomento. Bastano i primi lavori a mettere in luce le qualità non comuni dello studioso: solidità di preparazione, dominio delle fonti antiche e degli studi moderni, vivo interesse per i problemi storici ed istituzionali, acutezza di giudizio, rigore di metodo.
Insieme con gli interessi per le istituzioni militari, nel periodo triestino si rafforzano anche, al con-tatto con i problemi posti dalla storia dei centri romani dell’Istria, gli interessi del D. per la storia e gli istituti municipali. Da essi traggono origine, oltre ad una serie di articoli di quegli anni (testimoni tra l’al-tro di una metodica perlustrazione della regione e di una ponderata rifl essione su problemi di topografi a e geografi a antica) e a due volumi delle | Inscriptiones Italiae, rispettivamente del 1934 e del 1936 (X, 2 Parentium e X, 3 Histria Septemtrionalis), anche tutta una serie di scritti posteriori riguardanti problemi generali o particolari di storia cittadina in età romana, che sono senz’altro da annoverare tra i più vivi ed importanti della produzione di questo studioso (su di essi tornava ancora, magistralmente, in uno dei suoi ultimi scritti trattando della data, presillana, del santuario prenestino della Fortuna Primigenia).
Nel 1933 fu comandato alla Soprintendenza alle Antichità di Trieste, ma vi rimase soltanto per poco più di un anno. Vista la perizia con cui aveva affrontato la redazione dei fascicoli istriani affi datigli, nel 1934 fu infatti trasferito alla Soprintendenza alle Antichità di Roma con l’incarico di curare il volume XIII, Fasti et Elogia, delle Inscriptiones Italiae.
Comincia allora per il D., e si protrae fi no al 1949, un secondo fecondissimo periodo di attività scientifi ca. Libero da obblighi di insegnamento e con a disposizione ben maggiori possibilità di studio, egli non abbandona i temi della sua precedente ricerca, ma ad essi altri ne affi anca, suggeriti dai lavori connessi al nuovo compito affi datogli e dalla sua presenza a Roma. Così, se nel 1936 giunge a stampa il sopra ricordato fascicolo X, 3 (Histria Septemtrionalis) delle Inscriptiones Italiae, già nel 1937 appare, dello stesso corpus il fascicolo XIII, 3 dedicato agli Elogia, ed intanto vari articoli, tra cui memorabile quello che stabilisce l’appartenenza dei Fasti Capitolini all’arco di Augusto nel Foro anzi che alla Regia, testimoniano il fervore con cui progrediscono i lavori per l’edizione dei fasti consolari e trionfali. Né, per questo, il D. trascura i problemi di storia municipale, ai quali anzi dedica articoli esemplari come quello sui Problemi cronologici delle colonie di Luceria, Aquileia, Teanum Sidicinum (1938) e l’altro su Quattuorviri in colonie romane e municipi retti da duoviri (1949), o i prediletti studi istriani: Le iscrizioni di Tarsatica. Origine e sito del municipio romano (1942); La data della fondazione della co-lonia romana di Pola (1943); Parenzo municipio romano (1946). Pubblica inoltre, o ripubblica, singole iscrizioni e complessi epigrafi ci di rilevante interesse e prende variamente posizione, attraverso articoli, rassegne, recensioni, su questioni controverse di carattere epigrafi co, antiquario, storico, che ricevono dal suo intervento sempre una chiarifi cazione, spesso una soluzione. Sono oltre sessanta le pubblicazioni del D. in questo periodo e tra esse più d’una, in particolare il monumentale fascicolo XIII 1 (Fasti con-sulares et triumphales) delle Inscriptiones Italiae, apparso nel 1947 con qualche anno di ritardo per le vicende della seconda guerra mondiale, è tale che da sola basterebbe ad assicurare al suo autore meritata e lunga fama.
Venne poi il tempo dell’insegnamento dalla cattedra. Delle sue qualità di maestro si è già detto. Scrupoloso com’era nell’adempimento dei suoi doveri, dedicò anche a questa attività molto tempo e
<735>
2 - ATTILIO DEGRASSI (1887-1969) 1545
gran parte delle sue energie (nonostante le condizioni di salute poco buone, talora addirittura precarie) fornendo la misura migliore di sé quando potè impartire le lezioni come preferiva: riunendo piccoli gruppi di studenti attorno ad un tavolo, sollecitandoli tutti a partecipare alla lettura, all’interpretazione, alla discussione dei testi che veniva loro sottoponendo ed intervenendo quando occorreva per suggerire o correggere. Lo studente ne ricavava invariabilmente, se mi è lecito un ricordo personale, una preziosa lezione di metodo, di cautela, di misura congetturale ed interpretativa che s’insinuava in lui e fruttifi cava senza quasi se ne accorgesse.
Parallelamente continuava instancabile anche in questo periodo, come nel successivo, dopo la fi ne dell’insegnamento universitario e sino a pochi mesi dalla morte, l’attività di ricerca e di pubblicazione. Vennero così altre opere destinate a restare a lungo: nel 1952 pubblicò i Fasti consolari dell’Impero Romano dal 30 a.Cr. al 613 d.Cr., nel 1954 i vari studi dell’argomento istriano, rivisti e coordinati, con-fl uirono nel volume Il confi ne nord-orientale dell’Italia romana, nel 1957 usciva il primo volume delle Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae, seguito nel 1963 dal secondo e nel 1965 da un’edizione riveduta ed ampliata del primo volume; sempre nel 1963 giungeva a compimento la mirabile trilogia del volume XIII delle Inscriptiones Italiae con la pubblicazione del fascicolo II (Fasti anni Numani et Iuliani) ed aveva inizio la serie di scritti | miscellanei raggruppati sotto il titolo di Epigraphica (I 1963; II 1965; III 1967; IV 1969); nel 1965 usciva, per le sue cure, un Auctarium fotografi co a CIL, I, destinato a rendere utilissimi servigi a tutti gli studiosi di storia repubblicana.
Si sono così ricordate soltanto le opere di maggior mole pubblicate nell’ultimo periodo; per ave-re un quadro completo dell’attività del D. negli anni dal 1949 al 1969 bisogna aggiungere ad esse un altro centinaio di scritti, la cui importanza è spesso tutt’altro che secondaria, e si devono ricordare le opere che usciranno postume: l’importante supplemento a CIL, I, il cui manoscritto aveva consegnato all’Accademia di Berlino circa un anno prima della morte [pubblicato nel 1986], ed una nuova edizione riveduta ed ampliata delle ILLRP attorno a cui stava lavorando negli ultimi mesi di vita.
In conclusione, l’operosità scientifi ca del D. appare caratterizzata da un continuo crescendo che ha dello stupefacente e tuttavia non stupisce chi, avendo avuto modo di conoscerlo, sappia come sempre fossero presenti e vive in lui, con una lucida intelligenza, la sete di apprendere, la gioia di lavorare, la coscienza delle responsabilità morali che gravano su ogni studioso. In questo senso, è possibile dire che non soltanto la sua produzione scientifi ca, ma la sua stessa vita assume per chi resta il valore di un esempio da meditare e da far proprio.
Il D. fu prima Segretario (dal 1937) e poi Presidente della Commissione per le Inscriptiones Italiaepresso l’Unione Accademica Nazionale, Presidente (dal 1953) della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Presidente (dal 1963) dell’Associazione Internazionale di Epigrafi a Latina. Fu inoltre socio di numerose istituzioni culturali italiane e straniere, tra cui: la Deputazione di Storia Patria per le Venezie (1926), l’Istituto Archeologico Germanico (1941), la Pontifi cia Accademia Romana di Archeo-logia (1942), l’Accademia Nazionale dei Lincei (1948), l’Accademia di Archeologia Lettere e Belle Arti di Napoli (1958), l’American Philosophical Society (1958), la British Academy (1958).
<736>
Per solito, commemorazioni come questa sono pronunciate da persone che hanno avuto uno stretto rapporto di discepolanza e collaborazione con lo studioso che si intende ricordare1. Ed è giusto che sia così perché non tutto lo studioso ‘passa’ nelle pagine che scrive e vi sono aspetti della sua personalità, non solo umana, ma anche di ricercatore, che nessuno conosce meglio e può aiutare gli altri a capire meglio, di chi ha tratto benefi cio dal suo insegnamento e gli è stato a fi anco, sia nel lavoro quotidiano, sia nelle pause frammiste ad esso; in queste ultime soprattutto, quando anche le personalità più riservate – lasciando affi orare, di tanto in tanto, le convinzioni profonde ed i sentimenti che ne regolano la vita e l’opera – sottraggono esplicitamente il quadro della loro esperienza intellettuale (che è un momento e solo un momento della vita, anche se importantissimo) ad un isolamento negativo quando non addirit-tura falsifi cante.
A dimostrare quanto benefi cio la valutazione di una personalità di studioso possa trarre da questa particolare angolazione visuale, basterebbe scorrere, senza cercare altrove, le belle rievocazioni di sto-rici italiani dell’antichità nel centenario | della nascita di Gaetano De Sanctis, che, raccolte da Franco Sartori, restituiscono fi gure a tutto tondo di De Sanctis a cura di Silvio Accame, di Fraccaro, visto dal Tibiletti, di Luigi Pareti, rievocato da Ettore Lepore e di Attilio Degrassi, nei ricordi vivi e recenti dello stesso Sartori2.
A Fulvio Grosso la sorte non è stata benevola. Strappandolo alla vita a 49 anni, dopo vicende diffi cili che lo avevano visto orfano di padre a vent’anni, chiamato al servizio militare nel ’41 quando aveva appena messo piede all’Università, confi nato in un sanatorio per cinque anni e quindi impegnato a rincorrere ed a conquistare quello che altri avevano ricevuto, si può dire, in dono, essa l’ha privato, tra l’altro, della possibilità di formare una propria scuola. E non si può che rammaricarsene perché la natura e le esperienze di vita gli avevano date molte delle qualità che fanno di un rapporto con gli allievi un rapporto felice, prima tra tutte una disponibilità ad ascoltare con rispetto e comprensione, oltre che a comunicare i propri interessi, che in Grosso erano d’altronde sempre vivaci e veri, non superfi ciali cioè, né accademicamente furbeschi.
Se il compito di parlarne (non potendo questo essere assunto, come sarebbe stato bello e giusto, da uno scolaro o da un suo stretto collaboratore) è stato affi dato a me, la ragione va ricercata, come credo, anzi ne sono certo, nello stretto rapporto che ci legò entrambi al magistero di Attilio Degrassi: immigrati entrambi a Roma, pressoché contemporaneamente, nel ’56 lui, ed io nel ’57.
VI,3 - FULVIO GROSSO (1921-1970)*
* An. Fac. Lett. Macerata, 17, 1984, pp. 467-486.1 Si affi dano alla stampa, senza sostanziali modifi che, le parole pronunciate a Macerata il 19 novembre 1982 in occasione della presentazione del volume Scritti sul mon-do antico in memoria di Fulvio Grosso a cura di Lidio Ga-sperini (Università di Macerata. Pubblicaz. Della Facoltà di Lettere e Filosofi a, 9), Roma 1981. Ivi, alle pp. XI-XIV, una
bibliografi a dell’amico scomparso, cui si aggiunga: Equites singulares Augusti, in Latomus, 25, 1966, pp. 900-909. Ad essa si rinvia per una più precisa individuazione degli scritti citati nel testo.2 Praelectiones patavinae raccolte da Franco Sartori (Uni-versità degli Studi di Padova. Pubblicazioni dell’Istituto di Storia Antica, 9), Roma 1972, pp. 9-87.
<467>
<468>
1548 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
Io ero scolaro degli anni padovani di Degrassi, lui (di una dozzina di anni più anziano e con tutt’al-tra provenienza: | Genova prima, poi Milano), non lo era: suoi maestri erano stati, a Genova, soprattutto Quintino Cataudella, con cui si era laureato in Letteratura Greca ed Ugo Enrico Paoli, che vi insegnò Letteratura Latina fi no al 19443; di Francesco Della Corte, successore del Paoli, fu per qualche tempo assistente volontario come, a Milano, di Mario Attilio Levi, dal quale ricevette incoraggiamento a se-guire l’inclinazione storica.
L’essere (e soprattutto il sentirsi, nella sua fi ne sensibilità) non uno scolaro diretto del Degrassi, ma uno acquisito, un po’ lo disturbava perché – credo di poterlo testimoniare – se anche, giustamente, egli non rinnegò mai la sua precedente formazione, ed anche se sono evidenti in tutta la sua opera debiti ideali contratti in vari momenti nei confronti di altri maestri, in particolare verso la scuola desanctisia-na, negli anni romani egli volle diventare ed essere soprattutto uno scolaro di Degrassi (“il mio amato maestro” della prefazione al Commodo), entrare nella sua scuola, sentirsi accettato in essa, assorbirne gli interessi e la metodologia.
Nei confronti del maestro acquisito, che quando egli lo conobbe era già prossimo ad uscire dal servizio universitario di ruolo ed era inoltre di fatto, oltre che per scelta, quasi del tutto privo di potere accademico, egli sviluppò una devozione profonda e disinteressata, cui si unì, con il passare degli anni, un affetto quasi fi liale. Tutti lo ricordiamo affrontare, | puntuale, ogni sabato mezzogiorno le fredde ire di una bibliotecaria romana per portare a casa Degrassi – che per ragioni di salute non usciva che di rado – libri e riviste in prestito legittimo sino a lunedì mattina, quando egli stesso provvedeva a restituirli. E si può dire che il mio più vivo ricordo di lui appartenga proprio agli ultimi mesi di vita di Degrassi, sulle cui scale di casa, o vicino al cui letto, mi era facile incontrarlo in una tenace quanto modesta testi-monianza di un affetto del resto fedelmente, anche se riservatamente – come era nella natura dell’uomo – ricambiato.
Aveva vinto il concorso universitario tre anni prima ed insegnava, allora, nell’Università di Mace-rata dopo due anni accademici a Palermo. Si erano già manifestate le prime avvisaglie del male che, otto mesi dopo il maestro, avrebbe condotto a morte anche lui nella lontana Göteborg, il 4 febbraio 1970.
Ho detto che la sorte non è stata benevola con Fulvio Grosso, ma forse non è del tutto vero. O meglio, se anche fu così, da questa sorte maligna è certo che egli aveva saputo trarre molto di buono, non facendosene piegare prima di tutto, ed anzi sviluppando qualità non comuni di umanità sensibile e buona, un po’ triste all’esterno, lieta, mi dicono, nella cerchia familiare.
Si potrebbe sostenere che sono, questi, aspetti della personalità che non riguardano e non toccano lo studioso. Eppure io sono convinto del contrario e non credo che sarebbe stato giusto passar a de-lineare sia pure cursoriamente le vicende di Fulvio Grosso, storico, senza farne almeno un cenno da aggiungere a quanto fu già detto da altri in questa stessa sede poco dopo la sua morte4. Né credo del resto che una | netta divisione sarebbe piaciuta neppure a lui se è vero che in tutta la sua opera è dato cogliere un costante rifi uto del tecnicismo inteso, per l’appunto, come separazione tra vita e mestiere.
3 Per quanto concerne il settore antichistico, il suo curri-culum universitario comprende anche esami con Luca De Regibus (Storia Romana e Greca), Ernesto Curotto (Anti-chità Greche e Romane) e Carlo Ceschi (Archeologia). Altri suoi docenti furono: Achille Pellizzari (Letteratura Italiana), Paolo Revelli (Geografi a), Michele Federico Sciacca (Storia della Filosofi a). Desumo questi dati dal foglio matricolare dell’Università di Genova relativo a Fulvio Grosso (matr.
2168), per mio desiderio resomi disponibile in fotocopia dalle cure del dott. Giovanni Mennella, che anche qui pub-blicamente ringrazio.4 S. ACCAME, Ricordo di Fulvio Grosso, in An. Fac. Lett. Macerata, 3-4, 1970-71, pp. 817-830. Vd. Anche G. GULLINI GROSSO, Fulvio Grosso: nota biografi ca e bibliografi ca, in Scritti sul mondo antico, cit. (nt. 1), pp. IX-X.
<469>
<470>
<471>
3 - FULVIO GROSSO (1921-1970) 1549
Trattando di uomini – egli sembra dire – lo storico non deve mai dimenticare la sua umanità, ne deve vergognarsi di manifestarla. “Una solenne austera tristezza domina il vociare dei bimbi della parrocchia che giocano a pallone; pare che il tempo si sia fermato a quando il Piranesi effi giava la scena in una sua celebre acquaforte. A sinistra del prato, da una piccola porta di ferro, si entra nelle catacombe dei SS. Marcellino e Pietro… Testimonianze pagane e testimonianze cristiane [vi] coesistono, si confondono nel fl uire dei secoli, nei bui corridoi giacciono, accatastati insieme, frustuli di epigrafi in onore e di chi a suo tempo scortò l’imperatore e di chi, forse, dallo stesso imperatore venne perseguitato e ucciso”. Non è una pagina di diario, ma l’introduzione ad un austero e tecnicissimo articolo scritto nel ’66, che dice molto sul modo in cui Grosso concepisce il fare storia5. L’umanità non è un ostacolo a capire; lo è se mai la passione, lo scegliere un eroe o una parte e sposarne la causa. In questo modo va interpretato il consenso con cui, in una nota del suo lavoro su Commodo, Grosso introduce questa citazione di We-stermann: “If one must choose in historical writing between rhetorical passion and cold cynicism, give me cynicism. It is the safer guide in the direction toward truth”6. In realtà Grosso non volle mai essere cinico, | ma neppur emotivo o ingenuo. Una componente del suo carattere, che non era aliena da slanci di entusiasmo, aveva bisogno di essere imbrigliata e controllata nel lavoro storiografi co; egli era altresì consapevole della necessità di affi nare, moltiplicare e scaltrire i suoi strumenti critici per dominare le fonti, antiche e moderne, e non esserne dominato. Tutta la sua formazione di storico è tesa, si può dire, al raggiungimento di questi due obiettivi.
Di preparazione iniziale eminentemente fi lologica, vocazione di storico egli manifesta peraltro fi n dai suoi primi lavori, nella scelta degli autori su cui esercitare l’analisi critica e nella problematica che è subito di fonti, della tradizione che sta dietro ad esse, della loro attendibilità. Per circostanze esterne (salute, altri impegni, concorsi, insegnamento medio), Grosso non è autore precoce. Il suo primo articolo è pubblicato nel ’51 quand’egli, cioè, ha 30 anni. Vi si studiano le fonti di Livio nella sua descrizione degli assedi di Locri del 208 e del 205. L’articolo seguente, pubblicato nel ’52 in due puntate, è stretta-mente legato al precedente nella problematica (le fonti di Livio) e nel periodo storico, poiché vi si studia il caso del processo e della morte del legato di Scipione, Pleminio, accusato di misfatti compiuti a danno dei Locresi nel secondo degli assedi ricordati sopra. Si sente che Grosso sta cercando la sua strada. Ha lasciato il greco per il latino, o meglio il mondo greco per il mondo romano indugiando per il momento su questioni di età repubblicana. Alla scelta romana – se non si contano l’importante saggio su Ermo-crate e un altro paio di contributi minori – egli sostanzialmente non verrà più meno, anche se troverà egualmente modo di mettere a profi tto la precedente esperienza tributando particolare attenzione, nella ricerca successiva, alle fonti di questo periodo in lingua greca. Non troveranno invece seguito gli inte-ressi repubblicani, interamente soppiantati, | negli anni seguenti, da altri, vivissimi, per l’età imperiale. Ne è dimostrazione già la Vita di Apollonio di Tiana come fonte storica, ampia memoria del ’54, molto signifi cativa nella formazione di Grosso storico, anche da vari altri punti di vista. Il passaggio nell’età imperiale avviene mediante lo studio della biografi a del sapiente/mago del I sec. scritta da Filostrato nel III, servendosi tra l’altro, come egli afferma, delle Memorie di tale Damide, un discepolo del fi losofo.
È ancora un problema di fonti, e dei più complessi, che deve essere inquadrato in più di due secoli di tradizione storiografi ca. La maturazione rispetto ai lavori precedenti è evidente. Maggiore la padro-nanza del problema; più chiara la fi nalizzazione storica della ricerca. Non sarà fuori luogo ricordare che
5 Tertulliano e l’uccisione di Pertinace, in Rend. Ac. Linc., ser. 8, 21, 1966, p. 140.6 La lotta politica al tempo di Commodo, Torino 1964, p.
640 continuazione di nt. 7 alla pagina precedente. La cita-zione è tratta da Am. Journ. Philol., 58, 1937, p. 481.
<472>
<473>
1550 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
apparve negli Annali della Facoltà di Filosofi a e Lettere dell’Università Statale di Milano lo stesso anno in cui, sempre continuando l’insegnamento nei Licei, lasciava l’assistentato volontario di Letteratura Latina a Genova, per assumere quello di Storia Antica a Milano. Più che per le conclusioni (favorevoli all’autenticità delle Memorie di Damide, e quindi, almeno in parte, anche all’attendibilità della Vita di Filostrato7) l’opera è importante nella produzione del Grosso perché vi si trovano, in nuce, gran parte dei temi che saranno al centro della sua rifl essione posteriore. Essi possono essere sostanzialmente raccolti sotto le seguenti rubriche:
I) L’età fl avia.II) Gli imperatori e le province orientali dell’Impero.III) Il valore storico di Cassio Dione. Nel saggio sulla Vita di Apollonio, quest’ultimo punto è toccato soltanto in brevi, ma felici pagine,
laddove viene segnalata per la prima volta la coincidenza tra la versione di Filostrato e quella di Cas-sio Dione a proposito dello straordinario caso di Apollonio, il quale, ad Efeso, nella stessa ora in cui Domiziano veniva ucciso, avrebbe assistito telepaticamente allo svolgimento della congiura. Il Grosso ne ricava la conseguenza di una dipendenza, in questo punto, di Dione da Filostrato con conseguenze sulla cronologia della stesura della sua Storia Romana. Ma negli anni successivi Dione sarà uno degli storici più studiati da Grosso, tra i cui progetti, quando morì, vi era, non a caso, una nuova edizione con traduzione e commento dello storico di Nicea. Se Dione, per sua stessa affermazione, impiegò dieci anni nella raccolta del materiale e dodici nella stesura della sua opera, si può ben dire che Grosso abbia trascorso con essa e il suo autore gli ultimi quindici anni della sua vita pervenendo ad una comprensione non comune dell’una e dell’altro: dell’opera, attraverso le diffi coltà ampiamente riconosciute, di risalire all’originale attraverso l’epitome e gli excerpta; del personaggio, con una valutazione rispettosa, non soltanto del suo lavoro di storico, ma anche delle sue vicende di politico pateticamente concluse con un ritorno in patria, che egli stesso, alla fi ne della sua Storia, paragona al salvataggio operato da Zeus, a favore di Ettore “dalla polvere, dalla strage, dal sangue e dal tumulto”. “Ma Ettore – scrive Grosso – era poi morto da eroe, pur difendendo invano la sua Ilio. Lui invece rientrava in Bitinia vecchio, malato, deluso, in balia di una fede che non sapeva superare la superstizione”8.
La parte culminante della vita di Apollonio di Tiana cadeva tra il regno di Nerone e la dinastia Flavia, per la | storia della quale la Vita di Filostrato andava, a giudizio di Grosso, rivalutata, sia pure con prudenza. Si spiega così il precipuo interesse sviluppato da lui, negli anni ’50, per questo periodo storico. Inoltre parte delle vicende del Tianeo avevano come cornice o premessa l’Oriente, fi no all’an-tica Ninive e all’India. Di qui, come credo, la nascita del versante orientale degli studi di Grosso, poi sempre coltivato e culminato, nel ’65, con la relazione tenuta al Convegno Linceo “La Persia e il mondo greco-romano” intitolata Roma e i Parti a fi ne I inizio II sec. d.C. attraverso le fonti cinesi. Con pazien-te indagine, che gli faceva replicare a un tecnico intervenuto nella discussione “Ho dichiarato di non essere un sinologo, non di non essermi informato… com’era mio dovere” egli credeva d’individuare, nella situazione politica dell’epoca considerata, esigenze di propaganda interna tali da rendere altamente improbabile la versione cinese secondo cui una missione, partita nel 97 per cercar di stabilire relazioni dirette con Roma, sarebbe giunta sino in Mesene. Secondo Grosso, essa dovette fermarsi molto prima, forse a Barbaricum nella valle dell’Indo; la stessa incertezza che si riscontra nelle fonti cinesi dell’epoca
7 Su questi problemi, si veda di recente, con diverse valu-tazioni ed amplissima bibliografi a, E.L. BOWIE, Apollonius of Tyana: Tradition and Reality, in ANRW, 2, 16, 2, Berlin-ANRW, 2, 16, 2, Berlin-ANRW
New York 1978, pp. 1652-1699. 8 Cassio Dione Cocceiano, in Cultura e Scuola, 22, 1967, p. 88.
<474>
<475>
3 - FULVIO GROSSO (1921-1970) 1551
sulla Grande Cina, cioè su Roma e il suo impero, poteva essere d’altronde assunta come prova dell’ine-sistenza di concreti rapporti tra i due paesi al di là di contatti commerciali esercitati con la mediazione di altri popoli. Diversa, invece, la conoscenza dei Parti sui quali le fonti cinesi non mancano di fornire informazioni fededegne9.
Ulteriore testimonianza dei suoi interessi per l’epoca dei Flavi, sono l’articolo sulla morte di Tito del ’56 e l’ampio saggio sulla tendenziosità dell’Agricola del ’54. Il titolo di | quest’ultimo contributo dice da solo quale sia la posizione di Grosso di fronte alla rappresentazione tacitiana del famoso gene-rale. Egli crede che Tacito abbia volutamente deformato gli eventi per nobilitare la fi gura del suocero e prendere le distanze, per mezzo suo (in un’epoca in cui era giovevole farlo) da Domiziano. La questione non è di quelle che si possono risolvere una volta per tutte; all’impostazione del Grosso non sono però mancate importanti adesioni ed inoltre si può parlare ormai di un largo accordo sull’opportunità di un ri-dimensionamento della fi gura di Agricola (senza che questo signifi chi di necessità svilirla) e di prudenza nel valutare il quadro tacitiano dei suoi rapporti con Domiziano10.
Nel fi lone orientale, talora intrecciantesi con il precedente, devono essere fatti rientrare invece: Gli aspetti della politica orientale di Domiziano (in due puntate del ’54 e del ’55), La Media Atropatene e la politica di Augusto del ’57, Mosè di Corene e Corbulone, dello stesso anno e Gli Eretriesi deportati in Persia del ’58.
Non mi soffermerò ad esporre minutamente il contenuto di tutti questi contributi, anche se di note-vole interesse. In questa sede, mi sembra più interessante rilevare che è proprio in essi che per la prima volta s’incontra un uso non puramente sussidiario dell’epigrafi a da parte di Grosso. Occasionali citazio-ni di epigrafi ricorrono, naturalmente, anche in suoi lavori precedenti, ma è negli Aspetti della politicaorientale di Domiziano che per la prima volta documenti epigrafi ci, come un’iscrizione su roccia del-l’Arzebagian o un diploma militare della Tracia, vengono introdotti per la loro specifi ca problematica e, per così dire, nella loro stessa fi sicità (richiamata | attraverso foto e facsimili), a fondamento della ricostruzione storica. Similmente, è un miliario della via da Palmira a Sura, posto nel 75 che costituisce il punto di partenza per le considerazioni sul governatorato di Siria di Traiano padre. Come si è ricor-dato sopra, il primo contributo è pubblicato nel 54/55, il secondo nel ’57. È chiaro che la formazione di Grosso storico è a una seconda svolta ed è sintomatico trovare che anche a questa (come alla prima, che si è visto situata a cavallo del passaggio da Genova a Milano) si accompagna un nuovo cambiamento di sede: da Milano a Roma, questa volta. La venuta a Roma non fu casuale: egli chiese – mi dicono – ed ottenne il suo trasferimento dal liceo di Pavia, in cui insegnava, al liceo Dante e poi al Virgilio di Roma. È sicuro che questo mutamento di sede non fu richiesto ed attuato dal Grosso soltanto nella prospettiva di una maggiore facilità di lavoro attraverso la ricchezza delle biblioteche romane, bensì anche entro un programma di ampliamento dei suoi strumenti euristici, comprendente, tra l’altro, come credo, la ricerca di un miglior possesso dell’epigrafi a. È un fatto che, appena giunto a Roma, lo troviamo frequentare con particolar cura la cerchia degli epigrafi sti. Nell’introdurre il suo studio del ’59 sull’epigrafe di Ippona e la vita di Svetonio, riconosce che l’idea di un riesame dell’intera questione gli era stata suggerita dalla partecipazione ad un’esercitazione del Degrassi, sull’argomento, alla Scuola Nazionale di Archeologia,
9 Su tutta questa intricata problematica vd. ora: M.G. RASCHKE, New Studies in Roman Commerce with the East, in ANRW, 2, 9, 2, 1978, pp. 604-1361, in particolare pp. 618 ANRW, 2, 9, 2, 1978, pp. 604-1361, in particolare pp. 618 ANRWsg., 645, 854, nt. 849. 10 Fra le adesioni, rilevante quella di R. SYME, Tacitus, I,
Oxford 1958, p. 123. Per una veloce rassegna di successive prese di posizione sul tema: R. HANSLIK, Tacitus 1939-1972, in Lustrum, 16, 1971-72 [1974], pp. 204-228, vd. anche 17, 1973-74 [1976], pp. 180-184.
<476>
<477>
1552 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
nel gennaio del ’57. A 36 anni, dunque, egli non aveva esitato a rifarsi scolaro, sia pure negli apertissimi ed informali seminari del Degrassi (che, a fi anco degli studenti regolari, ammettevano chiunque altro aveva voglia di partecipare), per imparare più in fretta e più sicuramente sotto la guida di un grande maestro dal quale non si sarebbe staccato più.
Nel settembre dello stesso anno, il ’57, lo vediamo partecipare | al III Congresso Internazionale di Epigrafi a Greca e Romana, che si teneva a Roma (credo di aver incontrato Fulvio Grosso per la prima volta in quell’occasione), con una comunicazione illustrante una nuova epigrafe ostiense dei Gamala. È la prima volta che Grosso si fa editore di un’iscrizione. Nella prima nota, egli ringrazia pubblicamente il prof. Guido Barbieri, che gli ha dato notizia dell’epigrafe e il prof. Attilio Degrassi, che gli ha elargito utilissimi consigli.
L’edizione del testo è sobria e nello stesso tempo articolata. Il personaggio, un P. Lucilius P.f(f(f ilius) P. n(epos), P. pron(epos) Gamala, aedilis, trib(unus) milit(um), dec(urio) adlec(tus) ex d(ecreto)d(ecurionum) grateis, (duo)vir ((quartum)), onorato dec(urionum) decr(eto) publice, quod is causam coloniae publicam egit in senatu, viene inquadrato all’interno della famiglia ostiense facendo ricorso ad ogni tipo di considerazioni possibile: i dati di scavo, il materiale, la tipologia, la paleografi a, gli aspetti linguistici, il confronto con gli altri Gamalae noti da epigrafi e da una lettera di Cicerone del 45; inoltre attraverso lo studio onomastico, per il quale, subodorando un’origine semitica nel cognomen, si rivolge al Levi della Vida ricevendo ampia e dettagliata conferma alla sua supposizione. Conclusione dello studio è che questo P. Lucilius Gamala duovir quartum possa identifi carsi con l’omonimo documentato nei Fasti Ostiensi come duovir iterum nel 19 d.C. e, forse, come duovir quartum (il numero d’iterazione è caduto in lacuna) nel 33. Di tale identifi cazione ha in seguito dubitato taluno, propenso a rialzare di un po’ la cronologia del personaggio; altri ha invece ritenuto di dover mantenere, come più probabile e funzionante, l’inquadramento cronologico proposto dal Grosso11. Come si vede, era in ogni modo un esordio solido ed autorevole.
L’articolo epigrafi co successivo, nel ’59, non affronta l’edizione di un testo nuovo, bensì, come si è ricordato, il riesame della ben nota iscrizione di Hippo Regius in onore dello storico Svetonio, pubblicata sette anni prima. Gli editori ne avevano ricavato la tesi di una sua origine africana. Il Gros-so, cambiando l’integrazione del Pfl aum [pso, cambiando l’integrazione del Pfl aum [pso, cambiando l’integrazione del Pfl aum [ ]on[t(ifi ci)] Volca[nal]i in [p in [p in [ ]on[t(ifi ci) Volca[n]i (carica sacerdotale a vita caratteristica di personaggi ostiensi) controproponeva la tesi, sostenuta anche con altre argomentazioni, di un’origine ostiense dello storico. L’articolo comprendeva tutta una serie di considerazioni sulla biografi a e la cronologia di Svetonio nonché un’appendice in cui si redigeva una lista completa dei pontefi ci di Vulcano a Ostia sino allora conosciuti. È chiaro il taglio prosopografi co che prelude all’impianto del volume dell’età commodiana, la cui idea a quel tempo doveva essere già nata. Le argomentazioni acute e stringenti del Grosso sono state accolte e hanno avuto seguito presso studiosi di prestigio sin quando scoperte successive hanno dimostrato impossibile che Sveto-nio potesse essere pontifex Volcani ad Ostia nel periodo che lo avrebbe richiesto12. Ciò ha rilanciato la questione dell’origine dello storico per la quale si è nuovamente pensato, tra l’altro, all’Africa, non in maniera del tutto persuasiva, peraltro, poiché la presenza di un’iscrizione onoraria ad Ippona, potrebbe avere anche altra spiegazione se si considerano gli incarichi e l’infl uenza che Svetonio ebbe a corte. Né è stata ancora soddisfacentemente risolta la questione del pontifi cato di Vulcano o Volca-
11 Da ultimo, L. VIDMAN, Fasti Ostienses, Praga 1982, pp. 62 sg., con ampia bibliografi a.
12 F. ZEVI, Nuovi documenti epigrafi ci sugli Egrilii Ostiensi, in Mél. Éc. Fr. Rome, 82, 1970, pp. 301-303.
<478>
<479>
3 - FULVIO GROSSO (1921-1970) 1553
nale, per il primo dei quali manca qualsiasi attestazione fuori di Ostia, mentre il secondo è ancora del tutto ignoto13.
Il ’58 è l’ultimo anno di insegnamento liceale di Grosso. Nel ’59 ottiene un distacco presso l’Unio-ne Accademica Nazionale con l’incarico di occuparsi della pubblicazione dei Fontes ad topographiam urbis Romae curati dal Lugli, prima, e delle Inscriptiones Italiae, poi; ciò che egli fa scrupolosamente come dimostrano la pubblicazione del volume delle fonti topografi che dell’XI regione di Roma nel ’62 e l’aiuto prestato a Degrassi nella preparazione per la stampa del volume delle Inscriptiones Italiae de-dicato ai Fasti anni Numani et Iuliani. Contemporaneamente viene elaborando la sua opera maggiore, il volume sulla Lotta politica al tempo di Commodo, ottocento pagine fi tte che saranno pubblicate a Torino nel ’64. Anche considerando la maggior disponibilità di tempo acquisita con l’esonero dall’insegnamen-to liceale (ma si è visto che questo non aveva comportato libertà totale), non si può non restare ammirati dall’enorme mole di lavoro svolto in tempo relativamente breve (sei anni circa) per la raccolta del ma-teriale a la stesura di questo volume. È stato osservato che vi è in esso qualcosa di troppo, di eccessivo; in particolare l’ampia sezione dedicata alla storia delle singole province durante il regno di Commodo. Il rilievo, che riguarda anche altre parti del lavoro, è probabilmente giustifi cato, soprattutto se rapporta-to al titolo che avrebbe potuto essere meno restrittivo; e penso che lo stesso Grosso fosse propenso ad ammetterlo. Nella stesura egli avrebbe dovuto, forse, operare una maggior selezione sul materiale rac-colto. Resta però ch’egli l’aveva raccolto, non solo, ma vagliato criticamente, secondo una prospettiva amplissima che nulla voleva lasciar fuori di quanto potesse risultar utile all’intendimento dell’età com-modiana. Suo proposito – lo | dichiara nella prefazione – non era stato di esaminare l’attendibilità di una sola fonte (come aveva fatto lo Heer con la vita di Commodo nell’Historia Augusta), ma d’interpretare e ricostruire le vicende della lotta politica del periodo prescelto attraverso l’analisi sistematica di tutte le fonti. L’impegno è mantenuto: all’esame minuto di tutta la tradizione letteraria, si affi anca quello delle testimonianze epigrafi che, papirologiche (un tipo di fonti alle quali dedicherà particolare attenzione an-che in seguito), numismatiche, con un’ampiezza d’informazione ed un’indipendenza di giudizio che non cessano di stupire e che furono ampiamente riconosciuti anche in sede di recensione. “Il est diffi cile de n’ètre pas saisi… d’un sentiment d’admiratio devant un ouvrage d’une telle dimension, dont la rédac-tion témoigne pour que le lit avec attention, d’une aussi écrasante erudition” scrive un insospettabile recensore14 ed il giudizio riecheggia, si può dire, in tutti gli altri, anche nei più critici15.
In effetti il libro, prescindendo dal quadro generale, si raccomanda in primo luogo per il pullulare ininterrotto, nel testo e nelle note, di discussioni e spunti critici sulle fonti e sugli studi antecedenti. Un elenco, anche selettivo, di contributi critici originali potrebbe essere lunghissimo coinvolgendo ad esempio questioni di attendibilità di fonti (come Erodiano, verifi cato sulla base di epigrafi ateniesi e ro-mane e degli atti dei martiri pagani), la loro cronologia (ad esempio quella dell’Onomastico di Polluce) o altri problemi cronologici | (come quelli della prefettura del pretorio e della morte di Cleandro, il dies imperii di Commodo, la prima apparizione della leggenda Providentia Deorum nella monetazione). Per un esempio di questioni d’altro tipo affrontate nel volume con risultati nuovi, ricordo la composizione
13 Per una chiara messa a punto dei problemi, si rinvia, tra i contributi più recenti, a: B. BALDWIN, Suetonius, Amsterdam 1983, pp. 28-35, 59-61; A. WALLACE-HADRILL, Suetonius, The Scholar and his Caesar, London 1983, p. 5. 14 P. JAL, in Latomus, 25, 1966, p. 174.15 Si segnalano per la loro ampiezza ed interesse, oltre a
quella già citata di P. P. P JAL, le recensioni di: F. CASSOLA, in Labeo, 13, 1967, pp. 119-123; D. KIENAST, in Gnomon, 38, 1966, pp. 596-606; F. MILLAR, in Journ. Rom. Stud., 56, 1966, pp. 243-245; J.H. OLIVER, in Am. Journ. Philol., 87, 1966, pp. 382-383; S.I. OOST, in Class. Philol., 61, 1966, pp. 119-121.
<480>
<481>
<482>
1554 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
del consilium principis di Commodo, la ricostruzione del processo annonario del 190 o il riesame di un cospicuo numero di carriere.
Grosso vede il regno di Commodo diviso in tre parti, con il primo e il secondo quinquennio rispet-tivamente dominati da Perenne e da Cleandro, all’analisi delle cui fi gure viene dedicato ampio spazio, e gli ultimi anni manifestanti una tendenza dell’imperatore a muoversi verso una concezione teocratica (orientale o ellenistica) del potere. Quest’ultimo punto non è stato condiviso da tutti, come anche altre tesi del volume, il che è ben naturale in un’opera di tale vastità e con un’impegno così costante ad assu-mere una posizione personale di fronte a tutte le questioni trattate. A mio avviso, il libro su Commodo, nella storia intellettuale di Grosso, va visto però soprattutto come prova in grande di quel metodo di utilizzazione globale delle fonti, nella ricostruzione della storia di un periodo, al quale egli era venuto sempre più tendendo e preparandosi. “Le fonti – egli ebbe a scrivere – non valgono soltanto per quanto esplicitamente affermano… ma anche per quanto se ne ricava in concomitanza con altri testi, per tutte le interpretazioni, anche indiziarie, di cui sono suscettibili”16. Il confronto incrociato salva anche da po-sizioni unilaterali e aprioristiche ostacolando eccessive adesioni ad una fonte o ad un personaggio. Così di fronte a Commodo egli intende porsi soprattutto senza preconcetti ed armato invece delle maggiori possibilità di controllo possibili. Se alla | fi ne il suo giudizio, pur riconoscendo l’importanza di questo imperatore per capire l’evoluzione dell’impero nel III sec., è negativo, può interessare vederne il motivo principale. Perché il suo regno “costituisce – scrive Grosso – una deviazione dalle linee tradizionali sino allora felicemente seguite dagli Antonini. Costoro, sia pure non senza incertezze e manchevolezze, tra le diffi coltà dei tempi e delle debolezze umane, avevano consentito una sopravvivenza, per quanto sem-pre più precaria, degli ideali politici di libertà, come si potevano concepire allora; Commodo invece, in contrasto con ogni tradizione del passato, sia pure su un iniziale ed episodico spunto di provocazione, infi erì contro di essi irreparabilmente”17.
Il passo mi sembra importante perché credo che l’idea di libertà come metro di giudizio storico possa essere indicata come un’altra costante del pensiero di Fulvio Grosso. Essa appare nel giudizio su Agricola, verso il quale, eliminate le deformazioni retoriche tacitiane, il Grosso manifesta complessiva-mente simpatia umana e tuttavia questa non gli impedisce di scrivere: “Certo un testamento a favore di Domiziano, per quanto lo storico non manchi di giustifi care il gesto servile del suocero, sarebbe per noi inconcepibile se sottoscritto dal padre Grecino e neppure la madre Procilla lo avrebbe approvato”18. Il tema della libertà è addirittura centrale nello studio su Ermocrate, del quale personaggio egli dissolve la rappresentazione idealizzata di parte della storiografi a moderna mettendone in luce i sogni di potere e la minacciosa vicinanza alla tirannide19. Ritorna infi ne ancora | in uno degli ultimi contributi in cui, para-gonando la descrizione di due assedii, rispettivamente di Siracusa e di Bisanzio, non può fare a meno di rilevare con amarezza la differenza tra un Tucidide che aveva animato il racconto dell’assedio di Siracu-sa del diritto di quel popolo alla libertà e un Cassio Dione che, pur essendo infl uenzato dal grande storico greco nel narrare l’assedio di Bisanzio, non intende le ragioni degli attaccati ed anzi le nega20.
16 La carriera di Q. Aurelio Polo Terenziano, in Athenaeum, n.s., 45, 1967, p. 354 nt. 33.17 Op. cit. (nt. 6), p. 654.18 Tendenziosità dell’Agricola, in In memoriam Achillis Beltrami Miscellanea Philologica, Genova 1954, p. 145. 19 Sullo stesso tema sembra giusto ricordare almeno, per la sede in cui sono comparsi ed il fi tto colloquio che istituisco-
no con lo studio del GROSSO, i contributi di: M.J. FONTANA, Alcune considerazioni su Ermocrate siracusano, in Scritti cit. (nt. 1), pp. 151-165; M. SORDI, Ermocrate in Siracusa: demagogo e tiranno mancato, ibid., pp. 595-600.20 Gli assedi di Siracusa e di Bisanzio, in Kokalos, 14-15, 1968-69, p. 261.
<483>
<484>
3 - FULVIO GROSSO (1921-1970) 1555
L’uscita del volume su Commodo coincide con l’inizio dell’insegnamento universitario di Grosso, come incaricato, dapprima a Padova ed a Macerata, quindi come straordinario, dopo il successo nel concorso del ’66, a Palermo per due anni, quindi di nuovo a Macerata sino alla morte.
Sono ancora anni di intensa attività scientifi ca suddivisa tra il ritorno al mondo greco con il saggio su Ermocrate, le ricerche epigrafi che e letterarie sui corporis custodes e gli equites singulares, quelle prosopografi che su Claudio Giuliano prefetto d’Egitto dal 203 al 206 e sul papiro di Ossirinco 1565 utilizzato al fi ne di ricostruire avvenimenti importanti degli anni 222/224. Ad esse si aggiungono: ricer-che giuridiche, come lo studio sul Praetium servi ex forma censoria; prosopografi che, ad esempio, sul console designato Aurelio Aureliano in un miliario di Bostra; su storici come Cassio Dione ed Erodiano; ed i già ricordati studi sulle fonti cinesi. Non potendo soffermarmi su ciascun lavoro, segnalerei come esempio particolarmente felice dell’attività di Grosso in questo periodo e come indizio di quelli che avrebbero potuto essere gli sviluppi | futuri delle sue indagini le ricerche su Plauziano ed il suo tempo apparse nel ’68, ricche di importanti acquisizioni nuove ormai saldamente entrate a far parte del patri-monio di conoscenze sull’epoca, come si può facilmente vedere analizzando quanto delle sue conclusio-ni sia passato negli studi posteriori21.
È chiaro che Grosso è ormai in saldo possesso di tutti gli strumenti il cui dominio aveva lungamente cercato. Si muove con tranquillità tra fonti letterarie, epigrafi che, numismatiche, papirologiche e rivela la tendenza ad espandersi nel settore del diritto, sia pubblico, sia privato. Ha un’invidiabile conoscenza dei primi tre secoli della storia imperiale e in particolare del periodo che va dalla metà del II ai primi decenni del III. La rigida disciplina che si è imposta nell’apprendimento e nella pratica dei nuovi stru-menti si è tradotta anche in un maggior controllo su se stesso al momento di scegliere, circoscrivere ed affrontare i suoi argomenti.
Conoscendo Fulvio Grosso, sarebbe tuttavia erroneo pensarlo pacifi cato e soddisfatto di sé. At-traverso un lungo cammino era venuto, è vero, sempre più precisando a se stesso la sua vocazione e si può dire che questa, almeno, gli fosse defi nitivamente chiara. Era però anche una vocazione che non ammetteva soste e riposi. L’intensa attività degli anni posteriori al suo ingresso nei ruoli universitari ed i programmi che aveva, tra cui, oltre all’edizione di Cassio Dione, l’aggiornamento dei Fasti consolari dell’impero Romano lasciatigli in eredità, ideale e concreta, dal Degrassi, non lasciano dubbi in propo-sito.
Egli avrebbe continuato a lavorare, alternando analisi e sintesi, ed avrebbe insegnato a lavorare se non altro con l’esempio che è sempre la forza educativa migliore e più trascinante. Possiamo anche dire con quale spirito e con quale prospettiva l’avrebbe fatto. Alieno da enunciazioni di metodo, in una nota ad un suo lavoro apparso nel 1967, egli scriveva tuttavia in replica ad un suo recensore: “Indubbiamente io non concepisco la storia imperiale… dominata dal ‘superuomo’ del momento, l’imperatore; o meglio, concepisco la potenza dell’imperatore come un aspetto politico da accertarsi volta per volta in rapporto alle capacità dell’uomo, senza anacronistici rispetti o infatuazioni. Più che prosopografi sta, mi sento un umile indagatore di testimonianze su uomini e cose, reciprocamente, inevitabilmente condizionati… Più protagonisti riesco a rintracciare e più mi pare di rivivere l’antichità, che poi è il precedente nel bene e nel male dei nostri giorni, si tratti di Commodo o di Hitler”22.
21 Si vedano, ad esempio: A. BIRLEY, Septimius Severus. The African Emperor, London 1971, pp. 294-296 e G. ALFÖLDY, Un’iscrizione di Patavium e la titolatura di C. Fulvio Plau-
ziano, in Aq. N., 50, 1979, coll. 125-152.22 Art. cit. (nt. 16), pp. 353 sg. nt. 33.
<485>
<486>
Tanti sono gli anni in cui Aquileia è stata indissolubilmente legata con il nome e la fi gura di Gio-vanni Brusin che risulterà diffi cile pensare ora a questa città senza di lui. Giovanni Brusin è morto nella sua Aquileia il 30 dicembre scorso all’età di 93 anni, dopo una breve malattia.
Egli non è così riuscito a veder stampata l’opera alla quale con maggior impegno ed amore aveva lavorato negli ultimi anni, quel fascicolo aquileiese delle Inscriptiones Italiae, che – egli ne era consa-pevole – avrebbe dovuto coronare il lavoro di tutta una vita e che sapeva altresì lungamente aspettato da tanti studiosi di tutto il mondo. Nella sua redazione di massima, il fascicolo era in realtà concluso già da qualche anno, ma la parte introduttiva, i completamenti e le revisioni delle singole sezioni richiedevano altro tempo, troppo tempo. Egli ne era profondamente angustiato e rattristato. Il destino ha voluto che la morte lo cogliesse proprio quando mancavano pochi giorni al passaggio in tipografi a della prima parte dell’opera, comprendente l’introduzione storica, gli auctores, le carte e tutte le iscrizioni repubblicane, che ad Aquileia superano le duecento. Il fascicolo andrà in stampa ora, senza ch’egli possa rivederlo e riceverlo, a cura della Commissione per le Inscriptiones Italiae presso l’Unione Accademica Nazionale e ad esso altri terranno dietro sino al completamento dell’opera. È un impegno che la Commissione deve alla memoria dell’Autore ed agli studiosi tutti che, senza la sistematica raccolta delle iscrizioni di Aquileia dallo stesso approntata, resterebbero privati | chissà ancora per quanto tempo della piena disponibilità di un materiale di eccezionale ricchezza e valore.
Ad Aquileia il Brusin era nato il 7 ottobre 1883. A Gorizia, a Vienna, ad Innsbruck, a Graz, e poi ancora a Vienna, egli aveva compiuto i suoi studi, seguendo fra l’altro i corsi di Eugen Bormann, alla cui scuola si erano formati, o venivano formandosi, altri studiosi italiani ai quali l’epigrafi a deve molto, in primis Pietro Sticotti ed Attilio Degrassi. Abilitatosi all’insegnamento, lo esercitò dal 1908 al 1920 nel Liceo-Ginnasio comunale di Trieste. Passò quindi al Museo Archeologico di Aquileia, di cui fu Di-rettore dal 1922 al 1936, quando fu promosso, prima a reggere la Soprintendenza alle Opere di Antichità e d’Arte per il Friuli, la Venezia Giulia e l’Istria con sede a Trieste, quindi, lo stesso anno, la Soprinten-denza alle Antichità di Padova con giurisdizione vastissima, comprendente, fi no al 1939, le Tre Venezie e la Lombardia, poi le Tre Venezie, il Friuli e l’Istria. In tale incarico egli rimase sino al pensionamento, avvenuto nel 1952. Nel 1953, quando un gruppo di amici volle festeggiare i suoi 70 anni con i ben noti Studi Aquileiesi, la sua bibliografi a, premessa ai saggi raccolti nel volume, diceva meglio di qualsiasi elogio quanto l’archeologia veneta, ma in modo precipuo Aquileia, dovessero alla sua attività di scava-tore e di studioso. Fu in realtà negli anni della sua direzione del Museo, della sua soprintendenza e del suo segretariato nell’Associazione Nazionale per Aquileia che questa città assurse al livello di uno dei principali centri archeologici d’Italia. La sua attività in favore di Aquileia, nella quale tornò a stabilirsi dopo il congedo, continuò instancabile anche in seguito, come è provato, oltre che dalla raccolta delle iscrizioni aquileiesi di cui si è detto, dall’elenco supplementare di pubblicazioni che correda la sua nota
VI,4 - GIOVANNI BRUSIN (1883-1976)*
* Epigraphica, 39, 1977, pp. 179-180.
<179>
<180>
1558 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
biografi ca nel recentissimo volume di Biografi e e Bibliografi e degli Accademici Lincei, Roma 1976, pp. 793-795.
È estraneo alla fi nalità ed ai limiti imposti a questa breve nota dar conto in dettaglio dell’opera e della personalità di Giovanni Brusin, nonché dei riconoscimenti che l’una e l’altra gli meritarono. Un aspetto tuttavia, parlando di lui, non può assolutamente essere taciuto, anche se è ben noto a chiunque l’abbia conosciuto, ed è lo straordinario attaccamento ed amore che questo studioso ha avuto per la sua città e la sua terra. Ad essa, ai tanti monumenti ch’egli vi ha tratto in luce ed illustrato, alle migliaia d’iscrizioni, che ha raccolto e commentato e tra poco cominceranno ad essere pubblicate, il suo nome – si può essere certi – resterà ora duraturamente legato.
Quando la morte lo colse, il 6 gennaio 1985, Guido Barbieri era da 7 anni Direttore della Scuola Nazionale di Archeologia (ora Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di Roma – La Sapienza). Della stessa era entrato a far parte come docente di Epigrafi a e Antichità Romane nell’anno accademico 1964-1965. Globalmente la Scuola potè dunque avvalersi del suo magistero (sino al 1981 reso in parallelo con quello di Antichità Greche e Romane dell’Università di Napoli) per oltre un ven-tennio. Un lungo periodo in cui (in condizioni personali particolarmente diffi cili e dolorose per la lunga malattia che infi ne condusse a morte l’amato fi glio Federico) egli assicurò alla Scuola, ai perfezionandi ed alla disciplina una continuità didattica tanto più importante dopo che, con il suo trasferimento da Pa-dova a Roma nel 1956, e con il suo insegnamento nella Scuola fi no al 1962, Attilio Degrassi aveva posto le basi per un rilancio dell’Epigrafi a Latina come insegnamento autonomo in Italia.
Nella consapevolezza di questo, a Francesco Panvini Rosati, che gli è succeduto nella Direzione, ed all’intero collegio dei docenti è sembrato non solo giusto, ma doveroso, assumere un’iniziativa che fosse idonea ad esprimere la gratitudine di tutti per il servizio da lui reso ed insieme atta ad onorarne la memoria e la fi gura di studioso insigne. La scelta è caduta sulla riproposizione, in questo volume, di una parte sostanziale dei suoi scritti, corredata da ampi indici analitici, che ne facilitassero e rendessero più profi cua la consultazione, ed integrata da una sua completa bibliografi a. Quest’ultima e gli indici sono opera di Elvira Leone e Antonio Licordari, due allievi e stretti collaboratori del Barbieri, ai quali va la più viva gratitudine per il loro prezioso apporto. La selezione degli scritti sparsi da ripresentare all’at-tenzione in sede unitaria è opera di Luigi Moretti e mia.
Non potendo, per ragioni editoriali, riprendere l’intera produzione, il criterio guida che si è adottato nella scelta è stato di riunire in due sezioni specifi che tutti gli studi rapportantisi a due fi loni essenziali nella ricerca di Guido Barbieri – rispettivamente quello giovanile relativo alla Historia Augusta e l’al-tro, dai più vasti e frastagliati contorni, costituito dalle indagini condotte nell’arco di un cinquantennio sulla problematica storica dei secoli III e IV – e di presentare in una terza, nutrita, sezione un campione signifi cativo dei rimanenti scritti cosiddetti minori. Per garantire spazio alla varietà, si sono omessi, oltre a tutte le voci, anche importanti, del Dizionario Epigrafi co, alcuni contributi di maggior mole, come quelli sull’epigrafi a sepolcrale ostiense (1958) e le ricerche sugli acrostici (1975, 1977), nonché altri costituenti parte di pubblicazioni collettive recenti, come quelle sulle collezioni epigrafi che Zeri (1982) e Iaia (1983). Anche altre minori omissioni si sono rese necessarie.
Pur con i suoi limiti, ritengo tuttavia che la raccolta che qui si presenta sia in grado di fornire – naturalmente insieme con l’opera maggiore – un’immagine sostanzialmente fedele di Guido Barbieri studioso dell’antichità, illuminandone la preparazione, gli interessi, il metodo ed insieme evidenziando i rilevanti contributi che la sua produzione ha dato agli studi, in particolare di storia romana.
VI,5 - GUIDO BARBIERI (1911-1985)
* Prefazione a: G. BARBIERI, Scritti minori. Raccolti per iniziativa della Scuola di Specializzazione in Archeologia
dell’Università di Roma - La Sapienza (Vetera, 3), Roma 1988, pp. IX-XIII.
<IX>
1560 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
In un certo senso l’opera di uno studioso racchiude in sé tutto quanto è indispensabile, e suffi ciente, per interpretarla e giudicarla. E tuttavia anche i dati biografi ci risultano spesso di grande utilità per me-glio intendere come una personalità scientifi ca si sia venuta formando ed evolvendo. Di natura cordiale, ma anche per certi aspetti schiva e riservata, Guido Barbieri non era solito parlar molto di sé. Così non meraviglia constatare che anche le persone che gli erano più vicine non sapevano poi molto di lui, in particolare delle sue origini e della sua formazione remota.
Nato a Modena il 31 gennaio 1911 da famiglia di agiata borghesia (il padre fu ingegnere; il fratello della madre, una Vicini, senatore del Regno), dopo aver compiuto gli studi liceali nella sua città, entrò per concorso, non ancora diciottenne, sullo scorcio del 1928, nella Scuola Normale Superiore di Pisa, iscrivendosi nel contempo alla Facoltà di Lettere e Filosofi a di quell’Università.
Una curiosità: in base a quali prove il giovane modenese entra a far parte, come alunno interno, della prestigiosa Scuola? Due i temi proposti in alternativa ai candidati: 1) La lettura dei classici e la mia formazione mentale e spirituale; 2) Esposizione critica dell’ultima lirica del Leopardi “Il tramonto della luna”. Non so quale dei due temi (forse il primo?) il Barbieri abbia svolto, né risulta quale fosse la Com-missione giudicatrice. Egli rientra comunque nella rosa dei vincitori insieme con, tra gli altri, Michele Maccarrone, futuro Monsignore, medievista e storico della Chiesa, che divenne allora suo amico e tale gli rimase per il resto della vita. In quegli stessi anni entravano nella Normale altri giovani destinati a diventare fi lologi classici, come Giovanni Pascucci ed Adelmo Barigazzi, storici dell’Umanesimo come Alessandro Perosa, italianisti come Walter Binni e Vittore Branca, storici dell’arte come Carlo Ludovico Ragghianti.
Regio Commissario della Scuola (1928-1932), dopo la direzione di Luigi Bianchi (1918-1928), era il fi losofo Giovanni Gentile che ne divenne poi Direttore dal 1932 al 1936. Vicedirettore e Professore interno il latinista Francesco Arnaldi. Professori di discipline classiche nell’Università: Cesare Giarra-tano (Letteratura Latina), Augusto Mancini (Letteratura Greca); volgeva al termine il quasi trentennale insegnamento di Storia Antica (in realtà soprattutto Greca) di Vincenzo Costanzi la cui cattedra, dopo la morte del titolare avvenuta nel 1929, rimase vacante sino al 1935; instabile la copertura d’insegnamenti come Archeologia Classica (1928-1930: Biagio Pace; 1930-1931: Ranuccio Bianchi Bandinelli; 1931-1932: Silvio Ferri) o Antichità Classiche ed Epigrafi a (1928-1931: Aldo Neppi Modona; 1931-1932: Evaristo Breccia).
Nella Scuola, oltre a corsi di lingua tedesca e francese, il Barbieri segue seminari integrativi sulla storiografi a greca di Gaetano De Sanctis, da poco chiamato a tenere l’insegnamento di Storia Antica nel-l’Università di Roma, e di Giorgio Pasquali, che veniva allora preparando la sua Storia della tradizione e critica del testo.
Nella Facoltà, sceglie come materia principale Letteratura Latina, tradendo però vocazione di sto-rico quando indirizza la sua specifi ca attenzione sulla Historia Augusta e si laurea nel 1932 sotto la guida del Giarratano, editore fra l’altro di Livio e di Tacito, con una tesi dal titolo Studi sulle fonti della Historia Augusta.
Subito dopo, nel 1933 e 1934, tale vocazione risulta confermata dalla scelta di usufruire di una borsa di studio per seguire presso l’Università di Francoforte i corsi del grande studioso della nobilitasrepubblicana ed imperiale Matthias Gelzer e di un ancor giovane Franz Altheim.
Al suo rientro in Italia partecipa ad un concorso per abilitazione a 28 cattedre di Lettere Classiche bandito con decreto ministeriale del 18 gennaio 1936, risultando abilitato con 67/75 (secondo in gradua-toria) e vincitore della cattedra con 81/100 (settimo in graduatoria) (Boll. Min. | Educ. Naz., 1935, parte II, p. 4292). In conseguenza di ciò diventa professore di ruolo di Lettere Latine e Greche nel Ginnasio-Liceo Cesare Balbo di Chieri (Torino) esercitandovi l’insegnamento sino all’inizio del 1940.
<X>
<XI>
5 - GUIDO BARBIERI (1911-1985) 1561
Si attua a questo punto una svolta fondamentale nella sua vita di studioso. Risultato vincitore del concorso per un ‘comando’ triennale presso la scuola annessa all’Istituto Italiano per la Storia Antica, al tempo presieduto da Giuseppe Cardinali, egli si trasferisce a Roma dove prende residenza stabile per il resto della sua vita. Il comando avrebbe dovuto scadere nel marzo del 1943, ma i turbinosi avvenimenti di quel periodo (tra l’altro dall’agosto al dicembre del ’43 egli non fu a Roma, ma in Italia Settentriona-le) determinarono, dapprima una proroga di fatto sino al dicembre 1944, quindi un’autorizzazione del Provveditorato agli Studi (9 dicembre 1944) a non rientrare nella sede di servizio (che nel frattempo era divenuta il Liceo-Ginnasio di Carmagnola [Torino]; nel ’44/’45 fu anche assistente straordinario di Storia Greca a fi anco di Gaetano De Sanctis); infi ne una nuova proroga ottiene su richiesta dello stesso De Sanctis (17 ottobre 1945) nel frattempo divenuto Presidente dell’Istituto.
Di fatto il Barbieri resta nell’Istituzione di via Milano sino al luglio 1947, quando (nominalmente divenuto nel frattempo ordinario nel Ginnasio-Liceo Michelangelo di Firenze [1946] e quindi nel Gin-nasio-Liceo Augusto di Roma [1947]) viene dal Ministero della Pubblica Istruzione distaccato presso la Soprintendenza alle Antichità di Roma III (Scavi di Ostia) “per lo studio e l’ordinamento delle iscrizioni antiche”. In quella sede e in quella veste resterà fi no al 31 gennaio 1956, schedando e studiando, sia i materiali nuovi emersi dagli scavi del ’39 e ’40, soltanto in parte editi, sia quelli di scoperta anteriore non sempre visti però da Lothar Wickert quando veniva preparando il suo Supplementum Ostiense a CIL, XIV edito nel 1930.
Egli aveva intanto ottenuto la libera docenza in Storia Romana nel 1948 (Commissari: Alfredo Passerini, Giulio Giannelli, Luca De Regibus), aveva onorevolmente partecipato, pur senza vincere, al concorso di Storia Greca e Romana del ’54 (Commissari: Plinio Fraccaro, Roberto Andreotti, Silvio Accame, Giulio Giannelli, Attilio Degrassi; pubblicazioni dei risultati in Boll. Min. Pubbl. Istr., 1954, parte II, pp. 2324-2329), era invece risultato vincitore nel concorso sempre di Storia Greca e Romana dell’anno successivo (Commissari: Bacchisio Raimondo Motzo, Luca De Regibus, Silvio Accame, Eu-genio Manni, Giovanni Pugliese Carratelli; pubblicazione dei risultati in Boll. Min. Pubbl. Istr., 1956, parte II, pp. 814-818).
Il 1° febbraio 1956 viene chiamato a coprire la cattedra di Storia Greca e Romana nella Facoltà di Lettere dell’Università di Messina. Dopo tre anni, conseguito l’ordinariato, passa nella Facoltà di Let-tere e Filosofi a dell’Università di Napoli per impartirvi l’insegnamento di Antichità Greche e Romane fi no al collocamento fuori ruolo per limiti d’età nel 1981.
È suffi ciente mettere a raffronto questi scarni dati biografi ci di Guido Barbieri con la sua bibliogra-fi a qui di seguito pubblicata perché risultino subito evidenti alcuni fatti ed alcune signifi cative coinci-denze.
Risulta in primo luogo chiaro che, per quello che fu, a ragione, considerato uno dei migliori epigra-fi sti della sua generazione, l’Epigrafi a Latina non fu un punto di partenza, ma un punto d’arrivo al quale pervenne per gradi e relativamente tardi. Se anche precedute da studi in cui fonti epigrafi che sono am-piamente usate e discusse, le prime pubblicazioni di Barbieri come epigrafi sta militante non sono infatti anteriori al ’53, quando egli aveva già superato i 40 anni. Risulta altresì evidente, per il loro argomento e per la necessaria incubazione, che la scelta epigrafi ca del Barbieri è da porre in stretto rapporto con il suo distacco ad Ostia (nel ’47) e con l’assidua frequentazione, mai venuta meno in seguito, con le iscrizioni antiche di quella città.
Del resto si è visto che, probabilmente più per la situazione che aveva trovato a Pisa (dove proprio in quegli anni veniva meno l’insegnamento di Storia Antica) che non per scelta precisa, la sua formazio-ne giovanile era stata eminentemente fi lologica, anche se fi n dall’inizio si nota che il giovane studioso tende a rendere tale formazione funzionale ad una ricerca di tipo storico. La sua prima pubblicazione,
<XII>
1562 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
a 21 anni, è una recensione molto matura nonostante l’età, ad un’edizione italiana della Ciris. L’anno successivo comincia però la pubblicazione di una serie di contributi riguardanti in vario modo l’Historia Augusta, le cui fonti avevano costituito l’argomento della sua tesi di laurea.
Sarebbe interessante stabilire in che misura i due anni trascorsi a Francoforte alla scuola di Gelzer, oltre a rafforzare l’orientamento storico del giovane studioso, abbiano potuto infl uire sugli interessi che egli manifesta in seguito per l’ordo senatorius. Certo è che quando nel ’40 viene a Roma nell’Istituto Italiano per la Storia Antica, tali interessi sembrano già sviluppati: sono dello stesso anno e del prece-dente due ampie recensioni (38 pagine) a La composition du sènat romain di Lambrechts ed è allora che prende forma il progetto dell’Albo senatorio da Settimio Severo a Carino al quale attenderà per oltre un decennio, per diffi coltà intrinseche e per sua incontentabilità (75 pagine di aggiunte e correzioni), con disperazione ed irritazione del De Sanctis che tale opera aveva incoraggiato, ma che anche riteneva il libro già fi nito nel ’45.
D’altronde i 7 anni trascorsi nell’Istituto offrirono al Barbieri anche una possibilità di studio altri-menti insperata in una città ed in un ambiente stimolanti. Come si è detto, al suo arrivo la Presidenza dell’Istituto era di Giuseppe Cardinali, cui succedette Gaetano De Sanctis. Erano gravitati o gravitavano su di esso in quegli anni, tra gli altri, Silvio Accame, Santo Mazzarino, Eugenio Manni, Albino Gar-zetti e Giovanni Vitucci. Segretario ed animatore dell’istituzione era Gastone Massimiliano Bersanetti Romanorum historiae acerrimus investigator, immatura morte praereptus (come dalla dedica delle Ta-vole di conguaglio fra il C.I.L. e le I.L.S. di H. Dessau pubblicate nel 1950), allievo del Cardinali ed autore di un volume di Studi sull’impero di Massimino il Trace pubblicato a Roma proprio nel 1940. In particolare con alcuni di questi studiosi e con altri che vennero dopo, i quali durante il loro soggiorno romano vissero a casa sua, come Albino Garzetti, Gianfranco Tibiletti e Giovanni Forni, strinse allora cordiale e duratura amicizia. Infl usso scientifi co su di lui in quegli anni credo abbiano avuto soprattutto il Bersanetti, di cui si è detto, ed il Degrassi che attendeva in generale alle Inscriptiones Italiae e stava preparando in proprio, allo stesso tempo, i Fasti consulares et triumphales (1947) ed i Fasti consolari dell’Impero romano (1952), opera quest’ultima che, uscita insieme con l’Albo senatorio del Barbieri, attesta un intenso scambio d’informazioni tra i due studiosi (per i rapporti con Bersanetti e Degrassi si veda anche la prefazione all’Albo, pp. VIII sg.).
Gli anni nell’Istituto signifi carono per il Barbieri anche un progressivo accostamento ed immedesi-mamento negli studi epigrafi ci. Non ancora come editore di testi, ma perché ineluttabilmente portatovi dalle ricerche prosopografi che e come revisore ed autore di voci di quel Dizionario Epigrafi co del De Ruggiero di cui poi sempre più con il passare degli anni sarebbe venuto assumendo la pesante respon-sabilità.
Venne poi il periodo ostiense che, come si è detto, segnò una svolta decisiva in senso epigrafi co nel-le ricerche del Barbieri, con la pubblicazione delle fi stole acquarie, di nuovi frammenti di Fasti Ostiensi, dell’iscrizione di Settimio Nestore (tutte nel ’53) e con le ricerche, pubblicate più tardi, sul cursus eque-stre attribuito a Plauziano e sulle iscrizioni di età repubblicana ed augustea nelle necropoli della città. Seguì infi ne il periodo dell’insegnamento universitario.
È da dire che, se anche giunge relativamente tardi all’epigrafi a, è in essa che lo studioso sembra | infi ne trovare il suo approdo più naturale se è vero che in seguito non se stacca più. Praticamente tutta la produzione del Barbieri nell’ultimo trentennio è spiccatamente epigrafi ca e tale da mostrarlo perfetta-mente a suo agio tra questi documenti, e le problematiche che essi evocano, anche in virtù delle ben più ampie competenze fi lologiche e storiche accumulate in precedenza. Lo spunto è offerto di volta in volta da iscrizioni siciliane, campane, romane e ancora ostiensi, delle quali ultime ebbe a lungo in animo di redigere un nuovo supplemento al CIL senza poi riuscire, sfortunatamente, a dar corpo al progetto.CIL senza poi riuscire, sfortunatamente, a dar corpo al progetto.CIL
<XIII>
5 - GUIDO BARBIERI (1911-1985) 1563
Per quanto concerne l’attività didattica, che svolse con impegno e serietà fi n che le forze fi siche e morali glielo consentirono, ricorderò soltanto che nel suo insegnamento napoletano si formarono Paolo Cavuoto, Giuseppe Guadagno, Angelo Russi, Raffaele Palmieri, Angelo Pellegrino, Antonio Varone ed Elvira Leone. A Roma ebbe particolarmente vicini la stessa Leone ed Antonio Licordari, ma mol-to numerosi furono gli allievi della Scuola che frequentarono i suoi corsi e che pubblicarono in varia sede i risultati delle esercitazioni su epigrafi inedite svolte sotto la sua guida. E si può dire che attività didattica abbia svolto anche nell’Istituto Italiano per la Storia Antica, coordinando la schedatura per il Dizionario Epigrafi co, rivedendo le voci dei più giovani collaboratori e colloquiando con i ‘comandati’, parecchi dei quali da lui stesso ricercati e sollecitati a partecipare al concorso di ammissione. Per tre anni (1976/77 - 1978/79) fu anche Direttore della Scuola annessa all’Istituto del cui Consiglio direttivo entrò a far parte con decreto del Presidente della Repubblica del 21 giugno 1968.
Riproponendo una parte ampia e signifi cativa della sua produzione, intrinsecamente valida ed im-portante anche per l’esemplare carica di autentico interesse nei confronti dei problemi di volta in volta prescelti e trattati, questo volume intende rendere un servizio alla scienza ed omaggio allo studioso scomparso.
Ma v’è di più. Membro del Comitato Internazionale di Epigrafi a Greca e Latina, del Comitato di redazione della Prosopographia Imperii Romani, della Commissione per le Inscriptiones Italiae, socio della Pontifi cia Accademia Romana di Archeologia e dell’Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Na-poli, il Barbieri, che non era solito darsi eccessiva importanza, conservò inalterati attraverso gli anni, fi no alla morte, spiccati caratteri di spontaneità, anticonvenzionalità, semplicità al limite di un’ingenuità disarmante, che ne fecero una fi gura singolare attorno alla quale fi orì, sin dagli anni universitari, una ricca, sorridente ed affettuosa anedottica. È anche con questi peculiari e umani aspetti del suo carattere che questo volume vorrebbe affi dare al futuro la memoria di Guido Barbieri**.
** Per avermi procurato notizie utili a questo breve profi lo desidero ringraziare le seguenti persone e istituzioni: Silvio Accame, Silvana Bortolin, Nadia Di Cesare Pontesilli, Gio-vanni Forni, Antonio Licordari, Michele Maccarrone, Mau-ro Moggi, Luigi Moretti, Alessandro Perosa, Angelo Russi,
Simonetta Segenni, Maria Floriani Squarciapino; la Scuola Normale Superiore di Pisa, l’Università degli Studi di Pisa, l’Istituto Italiano per la Storia Antica e la Soprintendenza Archeologica di Ostia.
Stefano Priuli è morto ad appena 44 anni il 3 settembre 1990. Crediamo che la sua perdita non sia stata solo di valore circoscritto, non fosse altro perché il Priuli ha avuto la capacità di dare propri impor-tanti contributi ad una ricerca storica sul mondo antico concepita in modo non angusto. Ma è chiaro che per noi, che ben l’abbiamo conosciuto ed apprezzato e che a lui siamo stati legati da profondi vincoli d’affetto, la perdita è stata particolarmente amara e crudele1.
Egli si laureò a Roma nel 1970 con una tesi sull’onomastica personale romana, un tema di ricerca rimasto poi sempre vivo nei suoi interessi, del quale divenne presto un riconosciuto specialista. Sono particolare testimonianza di questa sua specializzazione una serie di note di onomastica epigrafi ca pubblicate tra il ’73 e il ’74 [2, 3, 4], un libro edito a Bruxelles nel 1975 su questioni di onomastica petroniana [5] ed il contributo presentato al Colloquio internazionale sull’onomastica latina di Parigi del 1975 in cui affrontò il problema del rapporto, a Roma, tra nomi di persona reali e nomi di persona letterari [7]. Conta però soprattutto lo sviluppo nel Priuli di quegli stessi anno di quell’acuta sensibilità per tutte le valenze (storiche, fi lologiche, giuridiche, sociali, culturali) insite nel nome romano che egli porterà anche in tutti gli altri suoi studi e che trasmetterà, tramite lezioni e seminari, a centinaia di studenti.
Attività didattica egli ha svolto invero presso l’insegnamento di Epigrafi a e Antichità Romane del-l’Università di Roma fi n dalla laurea, dapprima come esercitatore e borsista, poi come contrattista, infi ne come ricercatore, sempre con gran seguito di studenti, ai quali ha sempre cercato di comunicare non solo il metodo, ma anche il senso ed il gusto di una ricerca che fosse insieme criticamente approfondita e condotta sul fi lo sottile di un’eleganza formale e intellettuale intesa come elemento non accessorio, ma necessario per accedere all’essenza delle cose, dei fatti, delle idee.
La sua formazione postlaurea comprende un soggiorno di studio a Cambridge nel 1972 per lavorare nel campo della storia militare romana. Giovanni Forni, il maestro indiscusso di queste ricerche, ebbe più volte a dirmi il suo apprezzamento per lo studio che il Priuli aveva dedicato alla probatio militum ed al computo del servizio militare nelle coorti pretorie [1].
Successivamente i suoi interessi si spostano su questioni di prosopografi a imperiale, equestre, senato-ria. Fra i contributi maggiori sono da annoverare quello che, con stringente ed ampia argomentazione, porta a riconoscere nel Feriale di Spello, poco prima edito, i dies natales (e non depositionis) di Druso Maggiore e di Gaio e Lucio Cesari [11] e l’altro che porta a recuperare, ed a inserire in una fi tta rete di parentele, il senatore, per l’innanzi ignoto, L. Valerius Messalla Thrasea Poplicola Helvidius Priscus [14].
Inizia anche lo studio sistematico dell’epigrafi a dell’Anfi teatro Flavio, sui cui sviluppi densi di no-vità (testi inediti, nuove letture e ricomposizioni, nuove interpretazioni e proposte cronologiche) dà tutta
VI,6 - STEFANO PRIULI (1946-1990)*
* Introduzione a: Iscrizioni greche e latine del Foro Roma-no e del Palatino. Inventario generale, inediti, revisioni, a cura di S. PANCIERA (Tituli, 7), Roma 1996, pp. 16-19.1 I numeri tra parentesi quadre che si troveranno qui di se-
guito si riferiscono alla nota bibliografi ca con l’elenco ge-nerale delle pubblicazioni di Stefano Priuli data alla fi ne di questo ricordo.
<16>
<17>
<18>
1566 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
una serie di anticipazioni del massimo interesse sia per la storia dell’edifi cio, sia per la proposografi a tardo-antica [12, 21, 23, 27, 32].
Tralasciando vari contributi minori, nei quali pure sono identifi cabili altri fi loni d’interesse (tecni-ca offi cinale, ad esempio, [19], museografi a e didattica [17, 34]), o il frutto delle tante collaborazioni prestate ai vari organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico romano [8, 10, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 33], voglio ricordare come esemplari di questa personalità ricca e complessa, ancora due ricerche. La prima, edita nell’88, sui dati epigrafi ci del Tesoro di Arcisate, studiato da Paola Piana Agostinetti, segnalantesi per densità di osservazioni sulle iscrizioni stesse, sull’origine dei perso-naggi, sul loro stato giuridico e sulla loro attività, sul formulario in relazione a funzione pratica e desti-nazione d’uso e sulla metrologia [26]. L’altra, ancora in corso di stampa al momento della morte, che, muovendo dalla riedizione dell’epigrafe di un commerciante di carne bovina qui plura maluit emereri quam consumere, si allarga ad una sottile analisi dell’ideologia del ceto mercantile romano tra fi ne della Repubblica ed inizio dell’Impero [29].
Stefano Priuli, non è stato poi soltanto uno studioso acuto e sensibile ed un ottimo docente. È stato anche un uomo schivo e riservato, alieno da ogni pensiero od atto che potesse essere esibizione di sé, tanto più se a danno altrui. È stato un buon compagno di strada. La protratta attesa di una morte annun-ciata nel fi ore della vita è un severo banco di prova; e può anche essere la summa di un’esistenza. Egli ha affrontato questa dura esperienza con straordinaria lucidità e consapevolezza, nonché con quella dignità e compostezza che sono state caratteristiche precipue della sua personalità. Progressivamente, silenzio-samente, si è ritirato dal mondo che per tanti anni era stato il suo, sottraendosi dapprima al contatto con gli studenti, ai quali soprattutto – com’egli disse – voleva risparmiare il triste spettacolo di una giovane vita declinante, quindi a quello con colleghi ed amici, quasi volesse farsi dimenticare. E nel raccogli-mento così conseguito si è preparato a morire con una pacata rifl essione sulla vita – e sulla sua vita – che ha nutrito anche il nostro ultimo colloquio pochi giorni prima della fi ne. Entrato dapprima nella nostra stima, quindi nel nostro affetto, se ne è andato, infi ne, con la nostra ammirazione. Non saremo in pochi, credo, a conservarne viva la memoria.
Bibliografi a di Stefano Priuli:
1. La probatio militum e il computo del servizio militare nelle coorti pretorie, in Rend. Ac. Linc., ser. 8, 26, 1971, pp. 1-22;
2. Note di onomastica epigrafi ca. I – Emendamenti di letture, in Rend. Ac. Linc., ser. 8, 28, 1973, pp. 265-294;
3. Note di onomastica epigrafi ca. II – Emendamenti di letture, in Rend. Ac. Linc., ser. 8, 29, 1974, pp. 399-430;
4. Note di onomastica epigrafi ca. III – Emendamenti di letture, in Rend. Ac. Linc., ser. 8, 29, 1974, pp. 497-520;
5. Ascyltus. Note di onomastica petroniana (Coll. Latomus, 140), Bruxelles 1975, pp. 66;6. Recensione del volume Le | iscrizioni della necropoli dell’Autoparco Vaticano, edito sotto la dire-
zione di V. Väänänen, Roma 1973, in Arch. Class., 27, 1975 [1977], pp. 144-148;7. Di alcune questioni riguardanti i rapporti tra nomi di persona reali e nomi di persona letterari a
Roma, in L’Onomastique Latine (Colloq. Intern. C.N.R.S., 564), Paris 1977, pp. 221-234; 8. Appendice epigrafi ca, presso E. LISSI CARONNA, Tempio c.d. della Fortuna Virile. Scavi e restauri,
in Not. Sc., 31, 1977, pp. 326-341;
<19>
6 - STEFANO PRIULI (1946-1990) 1567
9. Recensione del volume di E. Wistrand, The so-called Laudatio Turiae, Lund 1976, in Riv. Filol.Istr. Class., 106, 1978, pp. 466-470;
10. Appendice epigrafi ca, presso E. LISSI CARONNA, Resti di costruzioni in via della Dataria, nella salita di Montecavallo e all’interno di Palazzo Antonelli (Via 24 Maggio, ang. Via 4 Novembre), in Not.Sc., 33, 1979, pp. 328-345;
11. Osservazioni sul feriale di Spello, in Miscellanea (Tituli, 2), Roma 1980, pp. 47-80;12. Nuove attestazioni senatorie nell’Anfi teatro Flavio, in Epigrafi a e Ordine Senatorio, I (Tituli, 4),
Roma 1982, pp. 575-589;13. Ti. Iulius Ferox, in Epigrafi a e Ordine Senatorio I (Tituli, 4), Roma 1982, pp. 617-620;14. L. Valerius Messala Thrasea Poplicola Helvidius Priscus, in Epigrafi a e Ordine Senatorio, I (Tituli,
4), Roma 1982, pp. 620-625;15. Schede epigrafi che in Museo Nazionale Romano. Le sculture. I, 7, parte I, Roma 1984, pp. 3, 5-6,
32-34, 48-50, 53, 72-73, 80-83, 107-108, 111-113, 115-119, 126, 138, 145-146, 149-150, 152-155, 180-181, 190, 195, 207, 220-221;
16. Schede epigrafi che in Museo Nazionale Romano. Le sculture. I, 7, parte II, Roma 1984, pp. 248-249, 482-486, 506, 562-563;
17. Alcuni possibili impieghi della videoregistrazione in epigrafi a, in Il Museo Epigrafi co (Epigrafi a e Antichità, 7), Faenza 1984, pp. 145-151;
18. La Soprintendenza Archeologica di Roma: stato presente del materiale epigrafi co, in Il Museo Epi-grafi co (Epigrafi a e Antichità, 7), Faenza 1984, pp. 551-562;
19. Una lapide sepolcrale di Roma con iscrizione incisa nel recto e minuta dello stesso testo graffi ta nel verso, in Epigraphica, 46, 1984, pp. 49-63;
20. Recensione del volume di J.C. MANN, Legionary Recruitment and Veteran Settlement during the Principate, London 1983, in Riv. Filol. Istr. Class., 112, 1984, pp. 219-227;
21. Epigrafi dell’Anfi teatro Flavio, in Roma. Archeologia nel centro (Lavori e Studi di Archeologia pubblicati dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, 6), I, Roma 1985, pp. 138-146;
22. Le iscrizioni sulle fi stulae, in Il trionfo dell’acqua. Acque e acquedotti a Roma (IV sec. a.C.-XX sec.), Roma 1986, pp. 187-195;
23. Le testimonianze epigrafi che, in Il Colosseo (Archeo dossier, 21), Roma 1986, pp. 31-37;24. Lingua e documentazione, in Roma repubblicana dal 270 a.C. all’età augustea, Roma 1987, pp.
113-146;25. Schede epigrafi che, in La collezione epigrafi ca dei Musei Capitolini (Tituli, 6), Roma 1987, pp. 42-
44, 108-109, 113-115, 119-120, 130-131, 143-146, 155-157, 169-171, 174, 186-188, 197-198, 202, 205, 207-208, 210-212, 224-234;
26. Il tesoro di Arcisate. I dati epigrafi ci, in Arch. Class., 37, 1985 [1988], pp. 182-237;27. Anfi teatro Flavio. Epigrafe di Rufi us Caecina Felix Lampadius, in Bull. Comm. Arch. Roma, 91,
1986 [1988], pp. 324-339;28. Schede epigrafi che, in Roma. Via Portuense, angolo via G. Belluzzo. Indagini su alcuni resti di
monumenti sepolcrali, in Not. Sc., 40-41, 1986-87 [1990], pp. 128-130, 135-144;29. Schede epigrafi che, in Epigrafi a. Actes du colloque en mémoire de Attilio Degrassi (CEFR, 143),
Rome 1991, pp. 288-299;30. Appendice epigrafi ca presso E. LISSI CARONNA, Roma. Via Vittorio Villavecchia (Tiburtina antica),
angolo via Stanislao Cannizzaro. Rinvenimento di una stele e di un cippo, in Not. Sc., 42-43, 1988-89 [1992], pp. 283-298;
1568 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
31. Schede epigrafi che, in Iscrizioni greche e latine del Foro Romano e Palatino, Roma 1995, nrr. 87, 106, 169;
32. Roma, Anfi teatro Flavio: alcune novità sulle epigrafi senatorie della serie più recente, in Tre arene:Pola, Verona, Roma (Atti del I Convegno Scientifi co Internazionale) Pola 1988 [Historia antiqua, 9, 2003, pp. 149-161];
33. Roma: per un Dipartimento epigrafi co nel Museo Nazionale Romano, in Atti dell’VIII Congresso Internazionale di Epigrafi a Greca e Latina, Atene 1987 (non pubblicati);Atene 1987 (non pubblicati);Atene 1987
34. Saggio eseguito su alcune iscrizioni dei Musei Capitolini, programma audiovisivo sperimentale (durata 20’), presentato nel corso del Colloquio AIEGL “Il Museo Epigrafi co”, 1983, realizzato, d’intesa con la Sezione Epigrafi ca dei Musei Capitolini, dalla Coop. Archeoluce - Opere scientifi -che di Roma.
I
Eccoci ancora una volta riuniti per prendere congedo da una persona che per titoli diversi ci è stata cara: studioso, collega, amico, marito, padre, maestro. Nel momento del commiato da un morto, sen-tiamo il desiderio, quasi l’esigenza, di rievocarne, sia pure per tratti sommari, la fi gura, l’immagine, in modo da imprimercela meglio nella mente e custodirla nel cuore, così che non ci lasci e ci accompagni nel tempo a venire. Per farlo potrei prendere a riferimento qualcuna delle specifi che fi gure che ho ricor-dato: studioso, collega, amico, maestro, ognuna delle quali, come a molti di voi, mi è stata ben familiare. Preferisco tuttavia rievocare l’immagine di Luigi Moretti attraverso il ricordo di tre qualità che, ai miei occhi, hanno peculiarmente caratterizzato ogni aspetto del suo agire ed improntato tutta la sua inconfon-dibile personalità umana.
La prima mi sembra esser stata la sua avversione totale ed irriducibile per tutto ciò che fosse ines-senziale, o che almeno egli considerasse tale, e questo in tutto: nel pensare, nel dire, nello scrivere, nel cercare, fi n nel desiderare. Era un atteggiamento mentale di fondo, che lo poneva personalmente al di fuori di ogni alchimia e vanità, ma lo portava anche a scoprire con fi uto infallibile ogni fumisteria, ce-dimento alla moda, ambizione coperta, mistifi cazione, ipocrisia grande o piccola ed a prenderne, se del caso, le debite distanze con una benevola, franca mordacità, di cui già nei mesi scorsi non abbiamo tar-dato a sentire la mancanza. Per le stesse ragioni, non amava la retorica in qualsiasi forma si presentasse e se ne teneva personalmente lontano con un costante esercizio di autocritica ironica, che inevitabilmente diventava un modello per le più sensibili tra le persone che gli stavano vicino. Il nostro ambiente (ma non solo il nostro) ha spesso bisogno di forti richiami all’essenzialità, che vuol dire anche alla trasparen-za, alla misura, al ridimensionamento autoironico. A tutto ciò Luigi Moretti ha indubbiamente contribui-to in misura non piccola, con la forza dell’esempio, in ogni aspetto della sua vita.
Per effetto della retorica, le idee non diventano più grandi e magnifi che; se mai si contaminano, diventano confuse, perdono vigore. Nemico della retorica, Luigi Moretti (ed è la sua seconda qualità che vorrei ricordare) era invece uomo di idee e convinzioni nitide e profondamente radicate, che fornivano un orientamento sicuro al suo quotidiano operare, senza che per ciò si sentisse in diritto di cercar di im-porle ad altri. Di discutere, se mai, nella distinzione delle posizioni, ma anche nel rispetto delle opinioni altrui e conservando intatta la stima nei confronti delle persone da cui dissentiva, come l’ho visto fare tante volte in Facoltà con studenti e colleghi, che l’hanno in genere ricambiato riconoscendo l’eccezio-nale probità intellettuale e morale di quest’uomo. Del resto bastava guardare anche superfi cialmente alla sua attività di studioso e docente per capire che essa non era soltano l’espressione di un mestiere, sia pure nobilmente esercitato. Dietro a quel che faceva c’era molto più di un mestiere sicuramente padro-
VI,7 - LUIGI MORETTI (1922-1991)*
* Parole di commemorazione pronunciate rispettivamente in occasione della cerimonia funebre (8/9/91) e di un successi-
vo Consiglio di Facoltà (25/9/91). Inedito.
1570 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
neggiato; c’era un’idea alta e diffi cile di quel che dovesse essere uno studioso e un maestro. Credo che siamo stati in molti a percepire questo tratto essenziale della sua personalità, tra cui, molti, i giovani che, ovunque abbia insegnato, lo hanno ammirato ed amato.
Da ultimo: i sentimenti. Saldo nei suoi principi, razionale, lucido, Luigi Moretti non fu però, come ognuno sa, un uomo freddo o incapace di abbandoni. Al contrario c’era in lui una ricchezza di senti-menti che, se pure contenuta e quasi frenata da una sorta di pudore che gli imponeva misura anche in questo, si manifestava tuttavia in modi e forme diverse: la devozione durata una vita per il suo maestro, tanto più reale e sincera, quanto meno dichiarata, il vivo senso di un’amicizia franca, leale, allegra che molti abbiamo goduto in un sereno fi ducioso abbandono, la luce d’orgoglio che gli brillava negli occhi quando parlava dei fi gli, il palpabile vincolo d’affetto profondo che lo univa alla moglie; il calore umano che poneva nei rapporti con gli studenti e gli allievi. Anche per questa ricchezza vogliamo ricordarlo e rimpiangerlo.
Non molto tempo fa (ma quanto lontano ci sembra ora quel momento felice), dopo aver fatto un’ami-chevole irruzione nell’aula in cui stava insegnando per consegnargli, fresco di stampa, un volume in cui avevamo raccolto una scelta di suoi scritti, e dopo aver scherzato con lui, alla presenza degli studenti, sulla sua vita, non sempre facile, di studioso di epigrafi , o, come si diceva in famiglia di “epigrafette”, modifi cando di poco un’iscrizione romana che avevo pubblicato anni addietro, formulai a nome di tutti il voto che ci fosse conservato a lungo un tale collega ed amico.
In questo periodo terribile, che ci ha privati in rapida, tragica, crudele, successione, di allievi, colle-ghi, familiari ed amici, era evidentemente un auspicio che non poteva essere accolto. Così, non tardi, ma presto siamo stati privati di un sodalis che avremmo voluto avere ancora a lungo al nostro fi anco.
Quando ero bambino i morti non c’erano. Poi sono stati presenze intermittenti, fuggevoli. Da qual-che tempo ormai costituiscono una presenza stabile, un gruppo, sempre più folto che mi assiste e mi ac-compagna ovunque. Forse è così anche per una parte di voi. Di questo gruppo, entra ora a far parte anche il nostro Gigi Moretti per continuare, in questo modo, a starci vicino, confortandoci con la continuità della sua presenza e mostrandoci di tanto in tanto con il suo esempio, depurato ormai dalle inevitabili incertezze e dalle debolezze di questa vita, qualche via per affrontare i momenti diffi cili e continuare a vivere, se vogliamo, con una parte almeno di quella dignità che fu sua.
II
Nel giorno della separazione mi è sembrato giusto evocare la fi gura di Luigi Moretti, non tanto come studioso e maestro, quanto per alcune qualità che peculiarmente lo caratterizzarono.
Consuetudine vuole che in questa sede l’attenzione si appunti invece principalmente sui meriti scientifi ci, didattici, accademici del collega che ci ha lasciato. Ed allora diciamo subito che, con la morte di Luigi Moretti, l’epigrafi a greca ha perso uno dei suoi maggiori cultori, agli studenti romani è stato sot-tratto un grande maestro, la nostra Facoltà ha perduto una preziosa coscienza critica, vigile ed assidua, unita ad una grande lealtà ed a un forte spirito di servizio.
Nacque a Roma nel ‘22. Allievo ed assistente di Gaetano De Sanctis (dopo la guerra che lo aveva visto mulattiere con le truppe alleate); supplente dello stesso De Sanctis dal ‘52 al ‘57 e quindi, dopo la morte del maestro, incaricato di Storia Greca fi no al ‘64, Luigi Moretti era tornato nella nostra Univer-sità nel ‘73, dopo dieci anni di assenza, trascorsi dapprima come ordinario di Storia Antica a Palermo ed a Bari, quindi come ordinario di Epigrafi a Greca nell’Università di Napoli.
Storico, sia per formazione ad una scuola illustre, sia per etichetta accademica, sia, soprattutto, per vocazione, Luigi Moretti amava tuttavia dirsi epigrafi sta, una defi nizione che non gli sembrava in alcun
7 - LUIGI MORETTI (1922-1991) 1571
modo riduttiva. Dovendo dare un titolo ad una recente raccolta dei suoi scritti minori, ne aveva scelto uno, Tra epigrafi a e storia, che fotografava appieno la posizione di uno studioso che dava il meglio di sé come storico proprio richiamandosi alla concretezza, ma anche alla complessità del documento epi-grafi co.
Vari aspetti del mondo antico avevano specialmente attirato la sua attenzione. Uno spiccato interes-se manifestò, fi n dai primi scritti, per l’agonistica, un’espressione umana che, strettamente connessa nel-l’antichità con la vita politica e religiosa, si presentava, ad un’indagine, complessa ed articolata proiet-tandosi ben oltre il puro fatto sportivo. Del ‘53 sono le Iscrizioni agonistiche greche, la prima raccolta sistematica di questo tipo di documenti che, attraverso l’apparente laconicità e linearità dei commenti ai singoli testi, compone in realtà una piccola enciclopedia del settore. A quest’opera si affi ancava nel ‘57 il volume sui vincitori degli agoni olimpici tra l’VIII a.C. e il IV d.C., in cui la lista viene costruita utilizzando insieme fonti epigrafi che e letterarie, numismatiche e papirologiche e quindi inserita in un ricco panorama storico.
Dalla storia in senso proprio, come si è detto, egli del resto aveva preso le mosse con alcuni studi su Sparta arcaica che fi gurano all’inizio della sua bibliografi a e rimontano al ‘46 ed al ‘48. Seguirono le Ri-cerche sulle leghe greche del 1962 nelle quali la lega peloponnesiaca costituiva una parte fondamentale. In seguito i suoi interessi si indirizzarono sempre più verso il mondo ellenistico, indagato in vari saggi, sotto vari aspetti (evergetismo, epidòseis, rapporto tra cittadino e polis, tra città e regni). I due volumi delle Iscrizioni storiche ellenistiche del ‘67 e del ‘76 sono ormai considerati dei classici, esemplari per come i testi, raccolti e tradotti, sono resi eloquenti da un commento che, nella sua sobrietà, risponde a tutti i possibili interrogativi del lettore.
Un altro fecondo campo d’indagine scientifi ca fu lo studio delle iscrizioni greche di Roma (e non solo greche vorrei aggiungere, perché è sua anche l’edizione di importantissimi testi latini), concretizza-tosi in una monumentale opera in quattro volumi, la cui stesura ha richiesto molti anni di lavoro: il primo volume è del ‘68, il quarto ed ultimo dello scorso anno. Le oltre 1700 iscrizioni della raccolta, introdotte da lemmi fi lologicamente perfetti ed accompagnati da un essenziale commento latino, consentono di acquisire (attraverso lo studio dell’onomastica, dei culti, del linguaggio prosastico e poetico) importanti dati sull’origine etnica, sul livello culturale e sulla posizione sociale dei grecofoni presenti nell’Urbe.
Impossibile ed inutile ricordare, della sua ricerca, tanti altri fi loni che si sono aggiunti senza fargli dimenticare i temi originari. È recente un aggiornamento della lista dei vincitori dei giochi olimpici. Stava lavorando, quando si è ammalato, per un supplemento delle Iscrizioni agonistiche greche.
Profonda dottrina, chiarezza di idee, rigore logico, senso dell’essenziale contraddistinguono tutta l’opera di Luigi Moretti, compresa l’attività di recensore e quella svolta nell’ambito dell’Istituto del-l’Enciclopedia Italiana.
La grande stima di cui godeva anche all’estero lo avevano portato a far parte del ristretto gruppo di studiosi alla cui cura si deve l’annuale rassegna del Supplementum epigraphicum Graecum.
Sua l’idea di realizzare un rifacimento totale del vecchio corpus delle iscrizioni greche d’Italia risalente alla fi ne dell’800. Ne sono usciti un paio di volumi ad a questo progetto stanno attualmente lavorando vari ex allievi e collaboratori. È motivo di conforto. Luigi Moretti non è stato soltanto un uomo ed uno studioso di non comuni qualità. È stato anche un maestro grande e generoso; per questo molto seguito ed amato. Se soltanto una parte del suo insegnamento non andrà dispersa, egli continuerà a vivere, oltre che nelle sue opere e nel nostro ricordo, nell’attività dei suoi allievi.
Patrizia Sabbatini Tumolesi si è iscritta alla Facoltà di Lettere e Filosofi a dell’Università di Roma - La Sapienza nell’anno accademico 1963/1964.
Per molte matricole dell’indirizzo classico era consuetudine inserire nel piano di studio del primo anno la frequenza del corso di Epigrafi a e Antichità Romane. Così fu anche per lei che diventò dunque subito mia allieva. Il nostro sodalizio intellettuale rimonta pertanto, nei suoi inizi, esattamente a trentuno anni fa.
Come ho ricordato nel momento in cui ci siamo congedati da lei, è stato un trentennio di rapporto sereno ed equilibrato. In tanti anni di cooperazione scientifi ca e didattica con personalità tra le più di-verse, occasioni di attrito o anche di scontro, sia di collaboratori con me, sia di collaboratori tra loro, non sono naturalmente mancate. Patrizia non vi è stata mai coinvolta non perché non avesse una propria opinione da far valere, ma perché ha sempre ritenuto che i valori della tolleranza, della comprensione, nonché, se possibile, dell’amicizia e degli affetti, dovessero venir prima di altro e guidare il comporta-mento anche nelle circostanze più diffi cili. Voglio ricordare un episodio perché mi sembra esemplare. Quando riuscì vincitrice nel concorso a cattedra, fu naturalmente lieta del successo, ma con un cruccio che mi esternò più volte: che lo stesso non fosse arriso anche a Stefano Priuli (voglio accomunarli nel ricordo), collega ed amico che considerava di lei non meno, se non più, degno, e comunque, psicologi-camente, più bisognoso di riconoscimento.
Il nostro non è un ambiente facile e qualità come queste non sono all’ordine del giorno. Da sole non fanno uno studioso, ma se | combinate con intelligenza e costante, silenziosa ricerca, rendono uno studioso meno disumano e più degno di rispetto. Tale per l’appunto fu ai miei occhi Patrizia Sabbatini.
Dopo la laurea, fi no al suo trasferimento ad Arezzo, continuò la sua formazione ed il suo progres-sivo affi namento sempre alla Sapienza, dove servì ininterrottamente, prima nell’Istituto di Epigrafi a e Antichità Greche e Romane e poi nel Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche ed Antropologi-che dell’Antichità, come borsista, esercitatrice e ricercatrice.
Portò nella didattica le stesse doti di saggia e pacata umanità che improntarono, oltre ai suoi rapporti con gli studiosi a lei più vicini, anche quelli con gli altri colleghi universitari e con i colleghi delle varie Soprintendenze archeologiche romane con cui ha a lungo e profi cuamente collaborato.
Agli studi si è dedicata con impegno costante ed appartato, com’era nella sua natura, pervenendo a frutti non effi meri in vari settori della ricerca.
Tutti sappiamo che al centro dei suoi interessi fu il mondo gladiatorio, al quale si è accostata sin dagli anni universitari; un interesse a lungo coltivato e trasmesso anche ad altri, che le ha permesso di dare un suo fondamentale ed anticipatore contributo all’ormai ampio dibattito in corso su questo impor-tante fenomeno del mondo romano [1-5, 7, 14-17, 20, 21, 24, 26, 31, 33]. Questo punto sarà ampiamente illustrato da chi parlerà dopo di me.
VI,8 - PATRIZIA SABBATINI TUMOLESI (1945-1995)*
* Per Patrizia Sabbatini Tumolesi: in memoriam (Facoltà di Lettere di Arezzo - Università degli Studi di Siena) [Siena
1997], pp. 15-21; 55-57.
<15>
<16>
1574 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
Ma questa predominanza d’interessi non deve far dimenticare gli altri suoi, non pochi, meriti scien-tifi ci.
Nel campo dell’epigrafi a di Roma anzitutto, collaborando sin dagli anni universitari ai lavori pre-paratori per un nuovo supplemento al volume VI (Roma) del Corpus Inscriptionum Latinarum, al riordinamento delle collezioni statali e comunali, ai seminari sull’epigrafi a urbana, pubblicando e ri-pubblicando molto in proprio, ad esempio nel Catalogo delle Sculture del Museo Nazionale Romano e altrove [6, 8, 11, 12, 16, 19, 27, 32]. Ma le pubblicazioni non restituiscono che un’immagine largamente incompleta dell’impegno profuso in questo settore. Sue sono, ad esempio, le schede e le fotografi e ine-dite di gran parte del materiale censito (diverse migliaia di iscrizioni) nel Museo Nazionale Romano e nei sotterranei del Palazzo delle Esposizioni in via Nazionale alla fi ne degli anni Sessanta e negli anni Settanta.
Suoi alcuni lavori preparatori per la realizzazione di un Dipartimento epigrafi co del Museo delle Terme e per la catalogazione | e sistemazione dei reperti del Foro di Traiano e dei Mercati Traianei [9, 13, 14].
Molto importante, al di là delle schede da lei personalmente redatte (alcune peraltro eccellenti), anche il suo apporto a tutti i seminari epigrafi ci cui ha partecipato con funzione tutoriale, da quello sui Campi Flegrei a quello su via Imperiale, dallo studio delle iscrizioni senatorie di Roma e dintorni a quello della collezione epigrafi ca dei Musei Capitolini all’altro, ancora inedito, delle iscrizioni latine e greche del Foro Romano e Palatino.
Né va dimenticato quello che spesso, com’è nella buona tradizione del lavoro epigrafi co, ha saputo ricavare da documenti di varia provenienza solo occasionalmente caduti sotto la sua attenzione o volu-tamente sottoposti ad essa. Voglio brevemente soffermarmi su tre casi fra i più recenti.
Nel 1989 la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale intraprese una campagna di scavo in località Piano della Carlotta a pochi chilometri dal Sasso di Furbara (Cerveteri), campagna che portò alla luce due ambienti di un estesissimo complesso termale ivi esistente. Una serie di indagini di superfi cie precedettero lo scavo vero e proprio, nel corso delle quali furono recuperate una colonnina ed una mensa marmorea, entrambe iscritte. Patrizia Sabbatini fu chiamata a studiarle dall’ispettrice di zona, dott.ssa Rita Cosentino, ed i documenti si rilevarono subito d’importanza fondamentale per la soluzione di un travagliato problema topografi co. Da fonti antiche, tra cui Livio, Strabone e Valerio Massimo, era nota l’esistenza nei pressi di Caere di un grande impianto termale denominato Aquae Caerites o Cae-retanae, la cui esatta ubicazione era però ignota. Ipotesi furono avanzate sin dal XVII sec., puntando soprattutto sulla località Casale dei Bagni o su altri settori del vastissimo comprensorio di Pian della Carlotta, ma una precisa localizzazione era risultata impossibile. Orbene, le due iscrizioni studiate dalla Sabbatini, provenienti dall’area che fu poi scavata, risultarono commemorare, l’una un’offerta a Iuppitered al Fons delle Aquae Caeretanae, da parte di uno schiavo imperiale di nome Florentinus, l’altra l’of-ferta di una mensa allo stesso Fons Aquarum Caeretanarum (la denominazione, in gran parte perduta, è stata integrata dalla Sabbatini sulla scorta dell’altro documento) da parte di un uffi ciale con il titolo di signifer, verosimilmente di una coorte pretoriana o urbana, di nome L(ucius) Pontilius L(uci) f( f( f ilius)Duurus.
Importanti le conseguenze. Era in primo luogo fi nalmente risolto | il problema della precisa loca-lizzazione delle Aquae Caeretanae, almeno di quelle di età romana, come prudentemente aggiunge la Sabbatini. L’analisi paleografi ca, linguistica (notevole la geminazione della U nel cognomen Duurus del dedicante), tipologica (confronti con altri esemplari di tavoli pompeiani ad un piede ugualmente decorati sul bordo con protomi leonine) e storico-antiquaria, le consentiva di datare la mensa circa alla prima metà del I sec. d.C. Datazione simile era assegnabile anche alla dedica di Florentinus. Lo splendido
<17>
<18>
8 - PATRIZIA SABBATINI TUMOLESI (1945-1995) 1575
impianto termale, che poi lo scavo ha rimesso in luce, risultava effettivamente collocabile, come ritiene la Cosentino, nell’ambito della prima età imperiale, con una frequentazione che arriva fi no a tutto il III sec. Ma v’è di più: la tutela delle acque termali in Etruria pare affi data in primo luogo ad Ercole e ad Apollo. Livio sembra mettere in qualche modo in connessione le stesse Aquae Caeretanae con un fons Herculis. Ma nelle nuove iscrizioni i fedeli venerano in prima posizione Iuppiter e subordinatamente Iuppiter e subordinatamente IuppiterFons. Non sfuggono alla Sabbatini le implicazioni storico-religiose di questo cambiamento, come quelle della prima attestazione di uno specifi co fons Aquarum Caeretanarum, e ne trae la conclusione che Livio rifl etta ancora una tradizione etrusca mentre le iscrizioni, e forse lo stesso Strabone, si riferirebbero ad una realtà altoimperiale ormai profondamente mutata, quando il sistema etrusco con una serie di fontessparsi, tra i quali il più noto era dedicato ad Ercole, era stato sostituito da un effi ciente ed affollato im-pianto termale unitario. Una basetta iscritta trovata in seguito mostrava che, comunque, Ercole non era stato del tutto soppiantato se fi gurava come destinatario, sia pure in subordine (Iovi et Herculi Aquarum Caeretanarum), di un’altra dedica posta da un centurione dei vigili. Si tratta, com’è chiaro, di conclu-sioni che vanno ben al di là di quelle che sarebbero consentite da una pura e semplice lettura dei testi, al di fuori di precise domande d’ordine storico [22, 23, 28, 29, 35].
Nel 1990 uno studente le faceva conoscere una tavola di bronzo iscritta di origine pestana con-servata a Roma in proprietà privata. Il suo studio rivelava trattarsi di un documento di grande impor-tanza rientrante nella categoria delle cosiddette tabulae patronatus, ovvero di quelle iscrizioni che registravano il | conferimento del patronato su una città a determinati infl uenti personaggi. In questo caso esso, datato con i consoli Vulcacio Rufi no e Flavio Eusebio al 1° di agosto del 347 d.C., è relativo al conferimento del patronato della città di Paestum a tale Aquilius Aper, fi glio di Aquilius Nestoriusmembro di una famiglia che si era resa particolarmente benemerita nei confronti della città. Il testo, di 23 fi ttissime righe, d’interpretazione tutt’altro che facile per la struttura linguistica particolarmente involuta e talora anche scorretta, suona nella traduzione della Sabbatini come segue: “Riunitisi nume-rosi i cittadini della colonia di Paestum e tenuta seduta, così proposero: poiché dalla casata di Aquilio Nestore, probo giovane, promanano tanti, così grandi e generosi benefi ci che adornano la nostra colonia e precipuamente stanno negli occhi e nel cuore di noi cittadini – sicché ovunque ci volgiamo abbiamo davanti agli occhi opere da loro costruite – rendenti così decoroso l’aspetto della città, che il popolo si è determinato a mostrarsi riconoscente nei confronti delle grandi prestazioni della loro domus e verso le altre gloriose munifi cenze – riconosciamo i suoi benefi ci: i munera populi, e siamo per il momento appagati. Ci congratuliamo con lui di questo munus del fl aminato che per generale consenso doveva essere offerto e (che) ormai i cittadini desideravano. Avendo Aquilius Nestorius, in considerazione del reciproco onore, per la sua condiscendenza, uno straordinario affetto per noi e accingendosi anche Aquilius Aper, suo fi glio, a dimostrare altrettanto affetto, i cittadini deliberarono altresì che a quest’ul-timo sia offerto il patronato della città, cosicché, sostenuto dal patrocinio di entrambi, il nostro popolo possa aver conseguito più onore di quel che ha dato. Così deliberarono sulla proposta in discussione. Buona fortuna”. Anche da questo documento, la Sabbatini ha avuto il merito di saper ricavare conse-guenze di grande importanza, da un lato per la storia di Paestum in età tardoantica dall’altro per quella del patrocinium della stessa epoca, e ancora del processo di pubblicazione delle tabulae patronatus. Impossibile esporre qui l’articolarsi del suo fi ttissimo commento, poggiante fra l’altro sul recupero e la riedizione di un altro documento pestano, con la stessa identica data, inciso sul retro di una tabula patronatus leggermente anteriore, e precisamente del 337. Non v’è dubbio tuttavia che le sue pagine approdano alla delineazione di uno spaccato del massimo interesse delle strutture politiche, ammini-strative, sociali e religiose della città di Paestum (e per confronto di altre consimili città) nell’età dei costantinidi [25].
<19>
1576 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
Da ultimo qualche breve nota su uno studio ancora più recente, pubblicato nel 1993, ed a me particolarmente caro perché | offertomi in occasione del mio sessantesimo compleanno quando già le sue condizioni di salute avevano cominciato a sottoporla a dure prove. L’alabarchia è un’istituzione dell’Egitto romano che ha generato molte discussioni fra gli studiosi. C’è chi l’ha ritenuta non diversa dall’arabarchia e quindi vi ha visto una struttura addetta al controllo dei traffi ci con il distretto dell’Ara-bia, lungo le vie carovaniere e nei porti del Mar Rosso, e chi invece, ritenendo l’alabarchia cosa affatto diversa dall’arabarchia, ha considerato la prima come struttura della comunità giudaica di Alessandria di cui l’alabarches sarebbe stato un esponente di spicco, dal punto di vista sia sociale sia religioso. Que-sta tesi è stata sostenuta con vigore anche di recente. Con questo studio, che prende lo spunto dalla pub-blicazione di un frammento di ara sepolcrale trovato qualche tempo fa nei pressi di Zagarolo, vicino a Roma, la Sabbatini ha potuto dimostrare che l’interpretazione ‘giudaica’ andava assolutamente esclusa e che nell’alabarchia doveva piuttosto vedersi un dazio doganale che era riscosso in varie sedi, tra cui nel porto di Pelusium, importantissimo snodo egiziano sul Mediterraneo del commercio siriano ed arabo. Il testo non è esente da diffi coltà interpretative di vario genere, ma è certo che il personaggio menzionato nell’ara sepolcrale, un cittadino romano di nascita libera e di origine verosimilmente laziale, dopo altri incarichi tecnico-amministrativi, prima di ritirarsi e morire nei pressi di Zagarolo svolse, come pare, la mansione di aiutante in un uffi cio che è denominato procuratio alabarchiae Pelusi. Il contesto, che non offre il minimo appiglio ad un’interpretazione ‘giudaica’, per la carriera del personaggio ed il termine procuratio, che qui compare per la prima volta associato all’alabarchia, ben si presta invece all’altra interpretazione di cui si è detto. L’alabarchia o arabarchia, istituzione rimontante ai re Lagidi avente per oggetto il controllo del commercio con l’Arabia, senza troppi mutamenti, divenne in età imperiale – sostiene la Sabbatini, credo a ragione – un uffi cio amministrativo affi dato ad un procurator di rango procurator di rango procuratorequestre, uffi cio che aveva la sua sede principale, o almeno una sede importante, nel porto di Pelusium. Da notare che il personaggio, la cui morte e verosimilmente da collocare intorno alla metà del II sec. d.C., forse non a caso aveva ricoperto prima le mansioni di architetto navale. Onde la Sabbatini si chiede se anche queste non siano state svolte a Pelusio e se il complesso della carriera non debba essere messo in relazione, da un lato con l’attestata presenza di Adriano in questa città | nel 130 (dove tra l’altro onorò e restaurò la tomba di Pompeo) dall’altro con la riapertura, sempre ad opera di Adriano del canale traia-neo scavato per agevolare le comunicazioni tra Mar Rosso e Mediterraneo [30].
Dico spesso ai miei allievi, con un piccolo paradosso, che il vero compito dell’epigrafi sta non è di studiare le iscrizioni, ma il mondo che le ha prodotte. Lo stesso vale – è chiaro – anche per ogni altra disciplina documentale quale che sia la natura, scritta o non scritta, dei ‘documenti’ studiati. Come si vede, Patrizia Sabbatini Tumolesi aveva ben capito la lezione e non si fermava mai al documento, ma cercava di capire cosa c’era dietro.
Il suo carattere schivo ed anche – credo – la sua volontà di non privare troppo la famiglia delle sue cure, fecero sì che non fosse frequentatrice abituale di quei convegni e congressi dai quali dipende spesso la notorietà di un ricercatore. Ciò non di meno la sua fama di studiosa seria, preparata ed anche – come ci è stato detto di recente – di carattere molto gradevole, era andata progressivamente allargan-dosi. I curatori dei convegni di Lattes sulle varie forme di spettacolo nel mondo antico, appresa la notizia della sua morte, hanno deciso di dedicarle il volume di Atti in procinto di uscire. Altri riconoscimenti non le sono mancati. Da ultimo, il 27 maggio del 1993 era stata eletta socio corrispondente della presti-giosa Pontifi cia Accademia Romana di Archeologia. Avrebbe dovuto ritirare il diploma che le spettava, con il tempietto detto di Vesta disegnato dal Valadier e l’espressione oraziana in apricum proferet (proferet (proferet Epod. 1, 6, 24), scelti come emblema e motto dell’Accademia nel 1810. Ma sembrava non esserci fretta. Così il diploma è rimasto in sede, al Palazzo della Cancelleria. In qualità di Segretario dell’Accademia stessa,
<20>
<21>
8 - PATRIZIA SABBATINI TUMOLESI (1945-1995) 1577
che l’ha commemorata nella seduta di giovedì scorso, lo consegno ora ai familiari a ricordo e segno della stima che ha meritato nella sua troppo breve vita. Personalmente lo consegno anche con tutto l’affetto che ho avuto per lei e che ora trasferisco su di loro come piccolo risarcimento della grande perdita che hanno dovuto subire.
Bibliografi a di P. Sabbatini Tumolesi
1. Pyrricharii, in Par. Pass., 134, 1970, pp. 328-338.2. Gladiatoria I, in Rend. Ac. Linc., 26, 1971, pp. 735-746.3. Gladiatoria II, in Rend. Ac. Linc., 27, 1973, pp. 485-495.4. Documenti gladiatorii dell’Occidente romano (I. Iscrizioni dell’età repubblicana), in Rend. Ac.
Linc., 29, 1974, pp. 283-292.5. A proposito di alcune iscrizioni gladiatorie veronesi, in Atti Ist. Ven., 133, 1975, pp. 435-446.6. Due iscrizioni inedite di Roma, in Epigraphica, 38, 1976, pp. 37-50.7. Gladiatorum paria. Annunci di spettacoli gladiatorii a Pompei (Tituli, 1), Roma 1980.8. N. 15 schede epigrafi che in Museo Nazionale Romano. Le sculture, I, 2, Roma 1981, pp. 49; 68-69;
162; 176-177; 220-222; 223-224; 225; 228; 238-239; 254; 255; 259-260; 263; 264; 265.9. Recensione a J.L. FRANKLIN JR., Pompeii: the Electoral Pro grammata, Campaigns and Politics,
A.D. 71-79, Roma 1980, in Riv. Filol. Class., 110, 1982, pp. 467-470.10. Iscrizioni senatorie di Roma e dintorni, in Epigra fi a e ordine senatorio, I (Tituli, 4), Roma 1982, pp.
652-655; 661-662.11. N. 44 schede epigafi che in Museo Nazionale Romano. Le sculture. 1 7, 1-2, Roma 1984, pp. 8-9;
14; 16; 17; 18; 19; 30; 31-32; 40; 41; 42-43; 51; 54-55; 55-56; 57; 61; 64-65; 66-68; 68-70; 79-80; 102; 103-104; 105; 106; 109-110; 121-122; 123-124; 128; 129; 132; 135-136; 137; 139-140; 148; 193; 199-200; 216; 224; 229; 230-231; 250-251; 319-320; 347; 490.
12. La Soprintendenza Archeologica di Roma: lavori preliminari ed ipotesi per un Dipartimento Epi-grafi co, in Il Museo Epi grafi co, Faenza 1984, pp. 563-565.
13. Progetto di sistemazione e catalogazione dei reperti epigra fi ci dei Fori imperiali: Foro di Traiano e Mercati Traianei, in Il Museo Epigrafi co, Faenza 1984, pp. 587-589.
14. Recensione a G. VILLE, La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien (BEFR, 245), Rome 1981, in Riv. Filol. Istr. Class., 112, 1984, pp. 100-111.
15. A proposito di CIL, VI 31917 da Praeneste (?), in Bull. Comm. Arch. Roma, 89, 1984, pp. 29-34.16. Corpus inscriptionum ad res amphitheatrales pertinentium (C.I.A.R.A.P.), in Epigraphica, 46, 1984,
pp. 266-267.17. Recensione a Du châtiment dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique
(CEFR, 79), Rome 1984, in Riv. Filol. Istr. Class., 114, 1986, pp. 219-224.18. Roma: per un Dipartimento Epigrafi co nel Museo Nazionale Ro mano, in Atti VIII Congr. Intern.
Epigr. Gr. Lat. (Atene, 1982), Atene 1987, pp. 141-143.19. N. 10 schede epigrafi che in La collezione epigrafi ca dei Musei Capitolini. Inediti, revisioni, contri-
buti al riordino (Tituli, 6), Roma 1987, pp. 96-98; 132-133; 147-152; 158-159; 180; 226-227; 280; 297-298; 316-324; 339-340.
20 Gli spettacoli anfi teatrali alla luce di alcune testimo nianze epigrafi che, in L’anfi teatro Flavio(Quad. Sopr. Arch. Roma, 4), Roma 1988, pp. 91-99.
21. Epigrafi a anfi teatrale dell’Occidente romano I. Roma (Vetera, 2), Roma 1988.
<55>
<56>
1578 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
22. Aquae Caeretanae. Le terme ritrovate. La certezza della sco perta, in Archeologia Viva, fasc. 7, sett.-ott. 1989, pp. 65-66.
23. L’edifi cio termale delle Aquae Caeretanae, in Miscel lanea Caeretana (Quad. Arch. Etr. Ital., 17), Roma 1989, pp. 105-112.
24. Epigrafi a anfi teatrale dell’Occidente romano. Propositi e struttura dell’opera, in Spectacula I. Gla-diateurs et am phitéâtres (Act. Coll. Toulouse et Lattes 26-29 mai 1987), Lattes26-29 mai 1987), Lattes26-29 mai 1987 1990, pp. 199-201.
25. Una nuova tabula patronatus da Paestum, in Misc. Gr. Rom., 15, Roma 1990, pp. 235-256.26. Per una nuova lettura del c.d. Mosaico Borghese, in Nikephoros, 3, 1991, pp. 195-203.27. N. 3 schede epigrafi che in Epigrafi a. Actes du Colloque en mémoire de Attilio Degrassi, Rome
1991, pp. 310-311; 314-315; 405-407.28. Novità epigrafi che dalle Aquae Caeretanae, in Boll. Ar ch., 7, 1991, pp. 80-82.29. Novità epigrafi che dalle Aquae Caeretanae, in Papers of the Fourth Conference of Italian Archae-
logy, 4, 1992, pp. 21-22.30. Un inedito dazio doganale: l’alabarchia Pelusi, in Mél. Éc. Fr. Rome, Ant., 105 1, 1993, pp.
55-61.31. Voce Gladiatore, in Enc. Art. Ant., Suppl. II, Roma 1994, pp. 790-795.32. N. 6 schede epigrafi che in Iscrizioni del Foro Romano e Palatino (Tituli, 7), Roma 1996, pp. 229-
231; 280-281; 293-294; 299-300; 324-326; 327-329.33. Gladiatori nel circo?, in Le cirque romain et ses spectacles (Act. Coll., Lattes 1990) [gli Atti non
sono ancora stati pubblicati ma vd. Gladiatori nei circhi?, in Arch. Class., 51, 1999-2000, pp. 427-437 con G.L. Gregori].
34. Voci: Emilio Lepido; Gladiatura; Bacchio, Bito, Castore, Docile, Fulvio, Gallina, Rutuba, Paci-deiano, Veianio, in Enc. Oraz., I, 1996, p. 718; II, 1997, pp. 182-183; I, 1996, p. 658; p. 663; p. 674; p 715; p. 743; p. 747; p. 837; p. 885; pp. 930-931. Per Auctoratus e Samnites vd. II, 1997, pp. 182-183 all’interno della voce Gladiatura.
35. Sulle Aquae Caeretanae recentemente ritrovate, in VIIIeVIIIeVIII Renc. franco-ital. épigr. mond. rom. (Roma-Viterbo 1993) [gli Atti non sono ancora usciti].
<57>
Il 2 settembre scorso è morto a Parigi all’età di 76 anni André Chastagnol. Era uno dei soci stranieri più prestigiosi della nostra Accademia. Entrato a farne parte nel 1970, era stato promosso nel 1993 nella categoria dei soci onorari.
Come tutti sappiamo, la fama di André Chastagnol è legata in primo luogo all’epoca tardo-antica, il cui studio egli, con pochi altri (e come pochi altri), contribuì a rilanciare, ed in qualche modo anche a rifondare, nel secondo cinquantennio di questo secolo. Il suo primo libro, del 1960, fu un fondamentale studio della prefettura urbana nel Basso Impero; il secondo (nato in parallelo con il precedente e pub-blicato nel 1962) raccolse i fasti della medesima magistratura per lo stesso periodo; il terzo del 1966, sul senato romano sotto il regno di Odoacre, nacque da nuove ricerche ed interpretazioni concernenti l’epigrafi a del Colosseo, un tema sul quale bisognerà tornare.
Seguono: nel 1970 le ricerche sull’Historia Augusta; nel 1978 il libro sull’Album municipale di Timgad; nel 1985 un volume sull’evoluzione politica sociale ed economica del mondo romano da Dio-cleziano a Giuliano. Del 1994 è una notevole e godibilissima edizione (con ampia prefazione, traduzione e commento) della Historia Augusta. Se ai volumi sopra indicati se ne sommano altri tre, con i quali l’autore ha voluto raccogliere, tradurre e commentare alcuni dei testi antichi più importanti del Basso Impero (1969; II ed. 1981) ed inoltre proporre ampie scelte di suoi articoli su vari aspetti di storia am-ministrativa, politica e sociale del medesimo periodo concernenti l’Italia e le province (1987, 1994), si può ben capire come diffi cilmente sia rimasto un problema della storia romana dal III al V sec. che non sia stato da lui ristudiato o studiato ex novo, spesso con novità di risultati, sempre con visione personale sulle fonti, gli uomini, i fatti, le istituzioni..
Tutto ciò sarebbe di per sé suffi ciente ad evidenziare la non comune statura di questo studioso. Ma non sarebbe giusto ignorare, sia pure nel breve spazio consentito a questo ricordo, almeno altri tre fi loni importanti della sua attività di ricerca. Il primo riguarda la storia del senato dell’età imperiale (in tutta l’età imperiale), alla quale ha dedicato una cospicua serie di articoli ed un volume complessivo nel 1992. Il secondo è costituito dalla sua attività di epigrafi sta militante esplicatasi nell’edizione di molti docu-menti sparsi di varia provenienza, attività culminata con la pubblicazione nel 1992 di un grosso volume delle Inscriptions latines de Narbonnaise e nella lunga attività di redattore dell’Année épigraphique. Il terzo fi lone, al quale lo Chastagnol si è dedicato con particolare lena negli ultimi anni, concerne la Gallia romana ed il diritto latino: 22 saggi suoi su questo tema sono stati raccolti in un volume del ’95, altri due sono apparsi nel frattempo ed altri certamente sarebbero seguiti.
Come si vede, egli non fu soltanto uno specialista del Basso Impero, ma anche personalità poliedri-ca che ha dato importanti contributi nei più diversi settori della scienza storica.
Fu anche persona di straordinaria umanità, qualità che gli fu universalmente riconosciuta da amici, colleghi ed allievi, che ebbe, questi ultimi, numerosi e fedeli.
VI,9 - ANDRÉ CHASTAGNOL (1920-1996)*
* Rend. Pont. Ac. Arch., 69, 1996-97, pp. 343-344.
<343>
<344>
Il giorno prima di ricoverarsi in clinica per un secondo intervento chirurgico, circa tre mesi prima della sua fi ne, egli mi scrisse una lunga lettera scusandosi, fra l’altro, di essere assente da Roma da più di un anno. Essa si concludeva con un saluto “a mes amis romains, que je n’oublie pas”. Sono molti gli amici romani che non lo dimenticheranno.
Per una bibliografi a pressoché completa dell’insigne studioso si vedano, dello stesso, L’Italie et l’Afrique au Bas Empire. Scripta varia, 1, Lille 1987, pp. 11-21; Aspects de l’Antiquité Tardive. Scripta varia, 2, Roma 1994, pp. 7-8; La Gaule romaine et le droit latin, Lyon 1995, pp. 8-9.
È con tristezza che per la prima volta dalla nascita di questa collana, mi accingo a scrivere la pre-sentazione di un nuovo volume dei Supplementa Italica senza poter contare su una revisione da parte di Margherita Guarducci, che ha fi rmato con me tutte le precedenti. Negli ultimi tempi, non potendo farlo personalmente, se le faceva leggere e poi mi comunicava le sue proposte di aggiustamento, che invariabilmente accoglievo con piacere, improntate com’erano, sempre, a spirito di equilibrio e chiarez-za, com’era nel suo stile. Prendendone il posto alla presidenza della Commissione per le Inscriptiones Italiae so già che queste revisioni e l’affettuosa approvazione del lavoro svolto che le accompagnava, mi mancheranno molto.
Della Commissione, Margherita Guarducci è stata Presidente per trent’anni (gli stessi in cui vi ho svolto la funzione di Segretario) succedendo nel 1969 ad Attilio Degrassi. Non era un buon momento. Le Inscriptiones Italiae erano entrate in crisi già da tempo. L’ultimo fascicolo cittadino, quello di Pisae, era uscito nel 1953 (dunque più di 15 anni prima) e l’ultimo volume della memorabile serie degrassiana dei Fasti et Elogia (quello dei Calendari) era uscito nel 1963. Bisognava tentarne un rilancio, non facile, come risultò chiaro anche in seguito. Nel ’74 si riuscì a portare a stampa il volume relativo alle Civitates vallium Silari et Tanagri del Bracco, cui fece seguito nel 1981 quello relativo a Salernum dello stesso autore. Rispettivamente nell’ ’84, ’85, ’86 videro poi la luce gli ottimi fascicoli di Brixia, di Albino Garzetti. Ma risultava sempre più evidente la diffi coltà di dare un seguito alla collana. Non si è riusciti, ad esempio, a portare a stampa il grande volume di Aquileia del Brusin. Per questo già prima dell’ ’80, su mia proposta, si cominciò a parlare dei Supplementa Italica come soluzione alternativa e la nuova collana fu varata con il primo volume del 1981. Nell’ ’84, su proposta di Luigi Moretti, si aggiunsero le Iscrizioni Greche d’Italia e negli anni ’90 fu approvata l’iniziativa della nuova collana di Supplementa Italica-Imagines, il cui primo volume è del ’99.
Intanto le Inscriptiones Italiae erano ormai entrate in stasi completa, anche se non se ne è mai volu-to decretare la fi ne, nella speranza che una qualche ripresa, almeno sporadica, sia sempre possibile. Ma intanto erano usciti 17 volumi di Supplementa Italica, 3 di Iscrizioni Greche d’Italia e 1 di Supplementa Italica – Imagines.
In questa evoluzione, Margherita Guarducci ha avuto un ruolo per più versi determinante. Anzitutto assicurando alla Commissione per le Inscriptiones Italiae un trentennio di conduzione serena ed equi-librata. Quindi accettando e promuovendo senza riserve le nuove iniziative. Infi ne impegnando tutte le sue energie e il suo considerevole prestigio ogni qualvolta si dovessero superare momenti di crisi, prin-cipalmente nei rapporti con gli enti fi nanziatori e con gli editori.
Credo che, per tutto questo, la sua fi gura, che è indiscutibilmente quella di una grande studiosa, me-riti di restare nella memoria anche in associazione con quanto di buono la nostra Commissione ha saputo e potuto fare nell’ultimo trentennio. Certamente resterà nel ricordo nostro, con gratitudine, insieme con quella, parimenti indimenticabile, del suo predecessore.
VI,10 - MARGHERITA GUARDUCCI (1902-1999)*
* Dalla Presentazione di Suppl. It., n.s. 18, Roma 2000, pp. 5-6.
<5>
<6>
Sono convinto che Giancarlo Susini (divenuto socio di questa Accademia nel 1963; su proposta – voglio ricordarlo – di Margherita Guarducci, Giuseppe Lugli, Ferdinando Castagnoli e Gisela Richter) sia stato uno degli epigrafi sti di maggior spicco e di più originale personalità che l’Italia abbia avuto nella seconda metà del secolo che si è appena concluso. Nell’adempiere con molta tristezza il compito di commemorarlo a soli tre mesi dalla morte, sopravvenuta per i più in maniera inattesa, mi propongo di esporre (brevemente come è nel costume dell’Accademia) le principali ragioni di questa convinzione.
Credo vada ricordato, in primo luogo, il forte contributo che questo studioso ha saputo dare al rin-novamento degli stessi fondamenti teorici della disciplina da lui professata.
In occasione dell’ultimo Congresso Internazionale di Epigrafi a, svoltosi qui a Roma nel 1997, egli ha aperto le relazioni scientifi che con una prolusione: Dieci congressi più uno. Il cammino dell’epigra-fi a. In essa egli si è proposto di mostrare le vie e le tappe lungo le quali, con l’apporto di tanti maestri, un continuo, profondo e benefi co rinnovamento si è attuato in questi studi già dal 1938, ma ancor di più, e con movimento più accelerato, dal 1957. La sua persona non è mai esplicitamente evocata. Al più, si accenna, in qualche luogo e quasi di sfuggita, a qualche apporto di quella che egli chiama la Scuola Bolognese. Tuttavia, quando tra i segni di un rinnovato modo di intendere e di fare epigrafi a si indicano, ad esempio: - il fatto che le iscrizioni, anzi i monumenti epigrafi ci, da considerare in unità indissolubile con l’am-
biente in cui furono collocati, siano ormai sentiti sempre più come veicoli di una comunicazione umana dotata di suoi specifi ci caratteri, che bisogna saper riconoscere ed interpretare;
- la crescita di interesse per il momento offi cinale, inteso come “grembo germinale” della comunica-zione epigrafi ca;
- che il patrimonio epigrafi co di una provincia possa essere assunto come specchio del processo di ac-culturazione che la riguardò (dalla sua prima alfabetizzazione all’assorbimento di modelli culturali e politici);
oppure quando ancora si rifl ette:- sul crescente interesse che viene tributato, non meno al lettore che allo scrivente;- sull’importanza che le iscrizioni continuano ad avere anche dopo il tramonto delle civiltà che le
hanno prodotte;- sui criteri della sistemazione dei monumenti epigrafi ci all’aperto o nei musei; quando si pone mente a tutto questo, è impossibile non rendersi conto che, se è vero che ad ognuno di questi punti corrispondono effettivamente importanti sviluppi teorici dell’epigrafi a nell’ultimo cinquan-tennio, è anche vero che nei confronti di ciascuno di essi il ruolo giocato da Giancarlo Susini è stato sempre importante, talora addirittura determinante.
In ogni caso mi sembra innegabile che libri come Il lapicida romano (del 1966, tradotto in inglese nel 1973), o quello intitolato Epigrafi a romana (del 1982), il cui obiettivo da lui stesso dichiarato è di
VI,11 - GIANCARLO SUSINI (1927-2000)*
* Rend. Pont. Ac. Arch., 73, 2000-01, pp. 335-338.
<335>
<336>
1584 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
“esporre alcuni dei problemi ed un profi lo dei valori che l’epigrafi a restituisce come storia della comu-nicazione umana nell’età dei romani”, come anche numerosi dei suoi scritti non meno importanti ora ristampati in Epigraphica dilapidata (del 1997) abbiano lasciato un’orma profonda negli studi epigrafi ci della seconda metà del Novecento ed abbiano contribuito, come pochi altri, alla nascita ed alla forma-zione di un nuovo tipo di epigrafi sta assai più cosciente delle diffi coltà del suo lavoro, non solo per la somma di conoscenze e di saperi ch’esso richiede, ma anche per la complessità dei fatti culturali, non sempre immediatamente percepibili, con i quali egli deve misurarsi.
Basterebbe questo per giustifi care il giudizio espresso all’inizio. Ma non mancano varie altre ra-gioni che lo sostengono. Sulla produzione scientifi ca non teorica del Susini dirò qualcosa più avanti. Prima ritengo però che si debba accennare ad un altro motivo per cui l’epigrafi a dell’ultimo cinquan-tennio gli deve molto: alludo all’instancabile ed appassionata attività che egli ha dedicato per decenni alla promozione ed alla diffusione di questa disciplina negli ambiti ed ai livelli più diversi. Dall’ambito strettamente locale, a quello regionale, nazionale, internazionale, dal livello altamente specialistico | ed universitario, a quello popolare, raggiunto attraverso la stampa quotidiana ed ogni altro mezzo di co-municazione di massa. Indicative le cure che ha dedicato a tante storie ed a tanti lapidari locali, come a quelli di Brescello, Bologna, Cesena, Forlì, Imola, Mevaniola, Parma, Sarsina ed altri, la partecipazione al Comitato Regionale per i Beni Culturali dell’Emilia Romagna, alla Società di Studi Romagnoli, di cui è stato Presidente dal 1963 al 1978, alla Deputazione di Storia Patria per la Romagna, di cui fu Pre-sidente dal 1992. A lui si deve la sopravvivenza ed il potenziamento di Epigraphica, fondata da Aristide Calderini nel 1939 e passata sotto la sua direzione nel 1970: la prima ed a lungo unica rivista di epigrafi a in Italia e nel mondo, nella quale si può dire che abbiano trovato accoglienza e mosso i primi passi prati-camente tutti gli epigrafi sti di questo paese. Sua è altresì la creazione della Rivista Storica dell’Antichità, della collana Epigrafi a e Antichità, del Centro di ricerca sulle offi cine epigrafi che Bartolomeo Borghesi. È stato parte attiva nella fondazione dell’Associazione Internazionale di Epigrafi a Greca e Latina, man-tenendo in essa a lungo posizioni direttive di prestigio. Si è fatto promotore con i colleghi bolognesi, di convegni internazionali importanti, tra cui mi piace ricordare almeno quelli di alto profi lo scientifi co, su Il museo epigrafi co (dell’83), sulla Terza età dell’epigrafi a (dell’86), sull’Epigrafi a del villaggio (del 1990): non è diffi cile vedere come tutto questo abbia potentemente contribuito a far uscire l’epigrafi a dal ghetto in cui in parte si era o era stata confi nata in Italia fra gli anni ’30 e ’50 ed a riaccreditarla come disciplina degna del più alto rispetto.
Restano da considerare le sue altre personali ricerche, al di fuori dei contributi generali e particolari già ricordati. Una notazione preliminare mi sembra importante. Tutti conosciamo il suo forte radica-mento, come studioso, nella Cisalpina, nell’area umbro-cispadana, nelle regioni augustee VI e VIII dell’Italia romana. In effetti, in questa zona le sue ricerche sono state, da un lato capillari e minuziose, dall’altro proiettate alla ricostruzione dell’ambiente in ogni suo aspetto, da quello della formazione della presenza umana, alle vicende del paesaggio, ai fenomeni di alfabetizzazione ed acculturazione nei rapporti città, villaggi e territori, con particolare attenzione alla funzione dei santuari, alle indagini sulle offi cine lapidarie e sui processi di elaborazione testuale degli apparati monumentali, alle funzioni dell’epigrafi a come comunicazione pubblica. Tuttavia non va dimenticato che, fi n dall’inizio, la sua vocazione è stata per un panorama di studi assai più ampio, comprendente non solo altre aree dell’Italia (come il Salento ed i luoghi della guerra annibalica, ad esempio), ma anche l’Egeo, dove ha compiuto tra il ’60 ed il ’64 missioni di studio nel Dodecaneso, ed un po’ tutte le province occidentali dell’impero (che conosceva assai bene) con particolare riguardo alla Germania | ed alla Dacia, cui ha dedicato studi particolari, ed all’odierna Bulgaria, dove ha a lungo diretto una missione di studio nella città traianea sul Danubio di Ratiaria. Del resto basta leggere i suoi lavori per vedere come spesso essi siano intinti di
<337>
<338>
11 - GIANCARLO SUSINI (1927-2000) 1585
ricordi, riferimenti che rinviano ad esperienze “altre” rispetto a quella che è in quel momento in gioco. Una peculiarità dello studioso che, in linea con la sua concezione dell’epigrafi a, alla visione diretta dei monumenti, o addirittura alla loro percezione tattile, ed alla conoscenza dell’ambiente, attribuì sempre un’importanza fondamentale. Impossibile entrare qui nel dettaglio.
Per i meriti acquisiti con questo complesso di attività non sono mancati al Susini importanti rico-noscimenti. Nell’Università di Bologna, dove entrò come docente nel 1968, fu Preside della Facoltà di Lettere per ben 17 anni (dal 1971 al 1988). Oltre che membro della nostra Accademia e delle istituzioni culturali ricordate sopra, egli è stato, in Italia, socio nazionale dell’Accademia dei Lincei (diventando anche membro del Consiglio di Presidenza), Presidente dell’Unione Accademica Nazionale e socio del-l’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna; fuori dall’Italia, fu socio dell’Accademia Belga e di quella di Barcellona. Ha ricevuto lauree honoris causa a Bordeaux, Sofi a, Montpellier. Ha ricevuto la medaglia per la cultura della città di Parigi e la commenda dell’Ordine delle Palme Accademiche.
Una personalità ricca ed affascinante che potrà ancora insegnare molto, solo che le nuove genera-zioni ne sappiano cogliere e adottare, oltre alle espressioni ultime del pensiero, anche quella larga som-ma di esperienze che le fu caratteristica e che di quel pensiero costituì salda base e nutrimento.
Per una bibliografi a completissima dello studioso fi no al 1997: G. SUSINI, Bibliografi a, a cura di Daniela Rigato (Epigrafi a e Antichità, 16), Faenza 1997, pp. 126.
Ho già sinteticamente esposto altrove le ragioni per cui sono convinto che Giancarlo Susini sia sta-to uno degli epigrafi sti di maggior spicco e di più originale personalità che l’Italia abbia prodotto nella seconda metà del secolo che si è da poco concluso1. Non mi ripeterò qui e del resto il compito che mi sono assunto in questa occasione è altro, ovvero quello d’individuare e di seguire il percorso formativo di questo studioso fi no alla sua maturazione. Il che pone subito un problema.
Diffi cile dire quando si possa considerare completata la formazione di uno studioso. Mai forse. Cer-to non esiste una regola valida per tutti. Vorrei richiamare a questo proposito quello che dice di sé, in una lettera del 1822, Bartolomeo Borghesi (raffi gurato tra parentesi sul soffi tto di una sala della biblioteca di questo stesso Palazzo Corsini, tra gli eroi del pensiero umano)2: “Io sono – dice – in quell’età in cui si è fi nito di imparare e si comincia a scrivere”. Aveva 41 anni. Ricorre a questo argomento per rifi utare un impegno che lo distrarrebbe appunto dallo scrivere. “Tormi due anni in questo tempo” sarebbe – egli dice – “tormi il modo di farmi onore”3. Per il Borghesi, dunque, il periodo della formazione fi nisce quan-do, superato l’apprendistato, senti dentro di te la capacità e l’urgenza, non già di scrivere in assoluto, ma di scrivere qualcosa che sia veramente tuo. Mi sembra, nella sua fl essibilità, un buon criterio dirimente. Applicato a Giancarlo Susini, direi che ci porti circa alla metà degli anni ’60, per intenderci tra la fi ne, nel ’64, delle sue missioni nel Dodecaneso, e Il lapicida romano, che è del 1966, quand’egli, nato nel 1927, è alle soglie del suo quarantesimo anno. Limiterò dunque il mio discorso al periodo antecedente, il che vuol dire in sostanza agli anni del Liceo-Ginnasio, dell’Università e delle altre fondamentali espe-rienze del decennio successivo, o poco più. Le fonti di cui mi servirò saranno | essenzialmente, oltre a quelle offerte da un personale rapporto di stima rimontante al 1957 (sarei tentato di dire anche di stretta amicizia se questa non comportasse un’assiduità di frequentazione che di fatto non si è realizzata tra di noi che nei primi anni), una serie di documenti diversi4, varie annotazioni autobiografi che, soprattutto
VI,12 - GIANCARLO SUSINI: LA FORMAZIONE*
* Rend. Ac. Linc., ser. 9, 14, 2003, pp. 131-141.1 Rend. Pont. Ac. Arch., 73, 2001-02, pp. 335-338.2 Tra le 14 personalità prescelte, Borghesi rappresenta con Tito Livio, la storia; l’immagine è accompagnata dalla se-guente didascalia tratta da Cicerone (Div., 1, 87): Quis au-tem est quem non moveat clariss(imis) monum(entis) testata consignataq(ue) antiquitas [?]. 3 Su questa lettera: C. BUSCARINI, Aspetti della presenza del Borghesi nella vita pubblica Sammarinese, in Bartolomeo Borghesi. Scienza e libertà (Coll. Intern. AIEGL, 1981), Bo-logna, 1982, p. 246.4 Tra di essi: 1) certifi cato di maturità classica con indica-zioni dei voti riportati (25 ag. 1946); 2) copia del libretto universitario con registrazione dei corsi seguiti e degli esami sostenuti negli anni accademici 1946/47-1949/50; 3) lettera di Luciano Laurenzi con proposta di nomina ad assistente
straordinario alla cattedra di Archeologia (7 marzo 1951; 4) verbali dei Consigli della Facoltà di Lettere e Filosofi a dell’Università di Bologna in data 28 ott. 1968 e 17 nov. 1971; 5) Verbale del Consiglio della Facoltà di Magistero della stessa Università in data 10 nov. 1971; 6) Giudizio per la promozione a professore ordinario, 21 aprile 1972 (com-missari giudicanti: Albino Garzetti, Emilio Gabba, Giuseppe Nenci); 7) Certifi cato dei servizi resi all’Università di Bolo-gna e degli insegnamenti impartiti nella Facoltà di Lettere e Filosofi a e di Magistero nonché nella Scuola di Specializza-zione in Archeologia tra il 1961 e il 2000 (10 luglio 2002); 8) Vari curricula accademico-scientifi ci, per lo più redatti da lui stesso, tra il 1951 e il 1999; 9) Proposte di nomina a socio corrispondente della Pontifi cia Accademia Romana di Archeologia in data 25 nov. e 5 dic. 1962 (Guarducci, Richter, Lugli, Castagnoli); 10) Proposte di nomina a socio
<131>
<132>
1588 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
recenti5, qualche testimonianza di persone che lo conobbero da vicino6 e, naturalmente, il complesso della sua opera e delle sue relazioni culturali, per quanto da me attingibili.
Susini stesso nega ogni precoce vocazione agli studi classici in generale e tanto più a quelli che ha poi specifi camente coltivato. Finiti gli studi elementari, avrebbe preferito frequentare una scuola di avviamento professionale “per lavorare il legno, le pelli, i metalli”, – com’egli dice –, ma ciò gli fu impedito “anche a scappellotti” dalla famiglia che, entrando allora nella piccola borghesia (padre ferroviere, madre casalinga, entrambi trasferiti a Bologna dalla campagna), aspirava ad avere un fi glio dottore7. Sembra quasi di avvertire in queste parole, scritte tanti anni dopo, un’ombra di risentimento, come per una violenza subita, ombra che ritorna, si direbbe, anche nel modo in cui rievoca il giorno della sua laurea: “Nessun festeggiamento, poi. A casa la stessa sera mi fu chiesto di telefonare a un uffi cio, col quale pendeva una questione, annunciando che parlava il ‘dottor’ | Susini”8. Ma anche il padre sarà poi tra i partecipanti alla prima lezione di Epigrafi a Greca che Susini terrà poco dopo come assistente straordinario, il 7 aprile del 1951.
Neanche quando, obbligato, si trova a frequentare fra il ’38/’39 e il ’45/’46 il Liceo-Ginnasio Gal-vani di Bologna, peraltro con grande successo (media fi nale di ciascun anno fra l’8 e il 9), sembra ma-nifestarsi in lui uno specifi co interesse per il mondo classico; se mai la vocazione che emerge è un’altra, non tuttavia così separata, come risulterà subito chiaro, dai successivi sviluppi della sua personalità: “Ero per lo più un Pierino – dice di sé – la fi gura curiosa del primo della classe. Leggevo sempre, tan-tissimo, non sempre (o quasi mai) facevo i compiti, cercavo parole sui vocabolari, disegnavo – e qui sottolineo le sue parole – carte geografi che e storiche, mappe d’ogni tipo: ero convinto che quella fosse la mia vocazione”9. Convinzione senza dubbio sbagliata poiché non produsse, come ci si sarebbe potuto attendere, un cartografo o un geografo, ma neppure tanto infondata se si pone mente al vivissimo inte-resse che si riscontrerà poi in tutta la sua produzione scientifi ca per l’ambiente geografi co (non dubito che anche altri vorranno evidenziare, magari con maggior ampiezza, questo aspetto fondamentale della sua personalità). In ogni caso non ci stupiamo, nell’apprendere una ventina di anni dopo, dalla prefazio-ne di Lily Ross Taylor ad un suo famoso libro (siamo nel ’60), che le carte dell’Italia tributim discriptaallegate all’opera sono state approntate proprio da lui e con un apporto personale che l’autrice stessa non esita a dichiarare ‘invaluable’10.
Come ben sa chi li ha in qualsiasi misura sperimentati, quegli anni di sconvolgimento mondiale, di negazione della libertà e di occupazione straniera, di contrapposizioni violente, di bombardamenti, eccidi e rappresaglie furono tutt’altro che propizi ad una giovinezza felice, meno che mai per coloro sui quali incombeva, oltretutto, lo spettro della chiamata alle armi. Se anche certamente non sereni, furono tuttavia a loro modo anni crudelmente formativi perché invitarono a porsi, prima e dopo la fi ne
corrispondente (1981) e nazionale (1993) dell’Accademia dei Lincei. Devo la maggior parte di questa documenta-zione ad Angela Donati, che ringrazio per aver attivamen-te e cortesemente soddisfatto le mie richieste al riguardo. 5 In particolare: Mitteleuropea 1953, in G. SUSINI, La cortec-cia del gatto, Ravenna 1983, pp. 95-100; Le mie isole, ibid., pp. 101-110; Settembre 1944, il momento della verità?, in I quaderni del Galvani, 1, 1993-94, pp. 33-34; Alma Mater e civiltà latina: briciole di memoria dopo cinquant’anni, in Il Carrobbio, 26, 2000, pp. 7-15.6 Segnalo ad esempio: A. DONATI, Giancarlo Susini (1927-2000), un maestro che non si può dimenticare, Il Carrobbio,
27, 2001, pp. 7-13; R. ETIENNE, Giancarlo Susini (10 octo-bre 1927 - 23 octobre 2000), in Rev. Étud. Anc., 103, 2001, pp. 325-327; F. SARTORI, Giancarlo Susini, in Gnomon, 74, 2002, pp. 379-382; A. MASTINO, Ricordo di Giancarlo Su-sini, in L’Africa Romana, 14, Lo spazio marittimo del Me-diterraneo occidentale: geografi a storica ed economica, Roma 2002, pp. 47-51.7 Alma mater, cit. (nt. 5), p. 9.8 Ibid., p. 15.9 Settembre, cit. (nt. 5), p. 33.10 L.R. TAYLOR, The Voting Districts of the Roman Repub-blic, Rome 1960, p. X.
<133>
12 - GIANCARLO SUSINI: LA FORMAZIONE 1589
del confl itto, domande non superfi ciali e ad operare scelte di campo, spesso destinate a durare per tutta la vita11. Vedremo il rifl esso e la prosecuzione di tutto questo negli anni universitari di Susini.
Intanto prendiamo atto che il 29 luglio 1946, a degna conclusione di un brillante corso di studi, egli consegue il diploma di maturità classica con nove in tutte le discipline tranne in Educazione Fisica, dove gli viene assegnato un otto, evidentemente per non abbassare la media, considerato che (cito quel che egli dice ironizzando sulle sue scarse attitudini in questo campo, e mi par di vedere il lampo che gli guizzava negli occhi quando si divertiva a raccontare cose come questa): “Riuscivo a salire la pertica sino a mezzo metro dal suolo, la fune no perché mi si attorcigliava subito, saltavo 0,27”12.
Neppure la scelta della Facoltà di Lettere per la prosecuzione degli studi (indirizzo classico, gruppo storico) lo vede in un primo tempo entusiasta. “Frequentavo Lettere senza troppa convinzione” – scrive – aggiungendo che la sua scelta era stata determinata più che altro da alcuni professori del suo Liceo (evidentemente non privi d’intuizione), tra cui il grecista Dario Arfelli, che insegnava anche all’Uni-versità13 (ne seguì per un biennio i corsi di Letteratura Greca prima che a coprire quella cattedra fosse chiamato Carlo Del Grande). Se l’inizio fu poco entusiastico, non s’immagini tuttavia un Susini pigro e svogliato, né si sottovaluti la caratteristica dell’understatement che fu spiccatamente presente in lui. Dal understatement che fu spiccatamente presente in lui. Dal understatementsuo libretto universitario risulta che nel solo anno 1946/47, primo di corso, egli frequentò, ricevendone regolare attestato, otto corsi uffi ciali, più tre lettorati nella sua Facoltà e tre corsi uffi ciali nella Facoltà di Giurisprudenza. E il ritmo non rallenta negli anni seguenti: dieci corsi uffi ciali più quattro lettorati a Lettere e due corsi uffi ciali a Giurisprudenza nel ’47/’48; sette corsi più un lettorato e la prova scritta di Latino a Lettere e due a Giurisprudenza nel ’49/’50, quarto ed ultimo anno di corso. Si laureerà il 20 febbraio del 1951. Credo che i corsi frequentati, almeno saltuariamente, e quindi senza prendere la fi rma, siano stati in realtà anche di più. Nella maggioranza degli esami riporta la votazione di 30 e lode; nessuna è inferiore a 30.
Chi insegna in quegli anni all’Università di Bologna? Con riferimento a Lettere, mi limito per il momento ai docenti con cui ha sostenuto l’esame. Troviamo sul libretto le fi rme di Carlo Calcaterra (per Letteratura Italiana), Giovan Battista Pighi (per Letteratura Latina e Grammatica Greco-Latina), Dario Arfelli (per Letteratura Greca), Arturo Solari (per Storia Romana e Topografi a dell’Italia Antica), Antonio Renato Toniolo (per Geografi a), Felice Battaglia (per Filosofi a Morale e Filosofi a del Diritto), Luciano Laurenzi (per Archeologia, Paletnologia ed Etruscologia), Gino Bottiglioni (per Glottologia), Paolo Enrico Arias (per Storia Romana e Storia Greca), Giovanni Natali (per Storia del Risorgimento). Con riferimento a Giurisprudenza, trovo le fi rme di Ferruccio Pergolesi (per Diritto Costituzionale e Diritto del Lavoro), Bruno Brunello (Storia delle Dottrine Politiche), Giancarlo Venturini (Diritto Inter-nazionale), Ugo Brasiello (Istituzioni di Diritto Romano), Edoardo Volterra (Diritto Romano e Papiro-logia Giuridica), | Giuseppe Branca (Storia del Diritto Romano). Due soli esami poterono però essere sostenuti fuori Facoltà – e furono quelli di Diritto Costituzionale e di Storia delle Dottrine Politiche.
11 Molto signifi cative e di straordinaria forza rappresen-tativa le amare considerazioni su quegli anni con le quali, molto tempo dopo, si concludono le sue Chiose sulla cul-tura del Ventennio a Bologna, in Riv. Stor. Ant., 21, 1991, p. 239 (Bononia/Bologna. Scritti di Giancarlo Susini, Bologna 2001, p. 382): “Tutti hanno conosciuto in quegli anni professori col mugugno facile, talvolta subitamente trasferiti … professori conformisti e spesso affogati in di-squisizioni prepartitiche, professori entusiasti d’una parte
e dell’altra, professori indipendenti e malinconici, profes-sori trascinati in giudizio dopo il confl itto per colpe mai commesse, ma accusati da testimoni pilotati, nonché presi-di pronti a declinare il nome della democrazia dal ribrezzo alla convinzione. Ed abbiamo conosciuto anche studenti rigorosi accesi da ideali, o invece fatti ipocriti, o avventati, o indifferenti”.12 Settembre, cit. (nt. 5), p. 34.13 Alma mater, cit. (nt. 5), p. 8.
<134>
<135>
1590 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
Salta agli occhi l’anomalia di questo studente con un piede a Lettere ed un altro a Giurisprudenza, anomalia non senza esiti di rilievo negli interessi che verrà sviluppando in seguito.
Naturalmente, nel rapporto con tutti questi docenti, non sempre s’innesta quel misterioso processo che nella mente dell’allievo fa assurgere il professore all’altezza di un maestro. È da dire che, a distanza di tempo, il Susini mostra un atteggiamento complessivamente benevolo e grato nei confronti dei suoi professori, ai quali in ogni caso sembra riconoscere la necessaria competenza. Ma questo non signifi ca che non abbia preferenze, che sono anzi esplicitamente dichiarate e motivate, talora distinguendo tra apparenza e sostanza, come nel caso dell’italianista Carlo Calcaterra (“al primo approccio sembrava un retore, poi il messaggio del suo insegnamento penetrava tacitamente nella coscienza critica degli ascoltatori”), o del docente di Filosofi a Morale, nonché Preside e infi ne Rettore, Felice Battaglia (“le sue lezioni apparivano di primo acchito pianamente ripetitive e propedeutiche, ma si comprendeva poi come in realtà il suo insegnamento costituisse nella preparazione di ciascuno una sicura struttura cultu-rale”)14.
Dei professori di Giurisprudenza lo affascina in modo particolare Edoardo Volterra. Anche altri sono ricordati con stima ed umana simpatia come Carlo Del Grande, Antonio Renato Toniolo, Eugenio Dupré Theseider e Giorgio Cencetti (di questi due ultimi seguì i corsi senza sostenere l’esame)15. Ma qui si scivola sul piano dei numerosi altri infl ussi (di cui dirò qualcosa tra poco) che egli riceve anche al di fuori del suo uffi ciale curriculum universitario, dentro e fuori l’Università. Un caso speciale in que-sto contesto è costituito da Paolo Enrico Arias, con cui pure formalmente si laureò quando era insieme soprintendente archeologo e professore incaricato, in vacanza di cattedra, di Storia Greca e Romana, ma che non può certo dirsi il suo maestro di Storia Antica. Sui casi di minor simpatia, tra i quali – se capisco bene – va collocato il latinista Giovan Battista Pighi, in genere preferisce sorvolare. Ma anche i silenzi – si sa – sono eloquenti.
Non tace invece Susini su quelli che considera i suoi maestri per eccellenza: l’archeologo Luciano Laurenzi e lo storico Arturo Solari. Il triestino Luciano Laurenzi (“l’incanto delle sue lezioni – rievoca Susini – dall’esegesi di un’opera d’arte ricavava i lineamenti della cultura del tempo e dell’area nei quali l’opera d’arte era stata concepita”)16 approda a Bologna come ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte Greca e Romana nell’anno stesso, il 1946, in cui il Susini si | iscrive all’Università. Novello studente, ne segue subito un corso di Paletnologia, seguito nei tre anni seguenti da un altro corso di Paletnologia, due di Etruscologia ed uno specifi catamente di Archeologia. Per Laurenzi si trattava di un ritorno a Bologna, dove aveva studiato dopo la prima Guerra Mondiale, laureandosi nel 1924 con Pericle Ducati, un maestro dal quale in seguito si era peraltro per più versi staccato. Era stato poi allievo della Scuola Archeologica Italiana ad Atene, ispettore e poi soprintendente nell’Egeo fi no al 1938, fondatore e direttore della Soprintendenza Archeologica della Lombardia, direttore della Scuola di Atene durante la prima parte della Seconda Guerra Mondiale e professore ordinario di Archeologia a Pisa (concorso 1939). Tornando a Bologna, quarantaquattrenne, a prendere il posto che era stato del suo maestro, ferito a morte dai partigiani il 28 gennaio 1944 per rappresaglia e per le sue compromissioni con il fascismo17, egli portava dunque con sé nella nuova sede, oltre a specifi che competenze di archeologo e di storico dell’arte antica (in particolare ellenistica), una non comune somma di esperienze. A Bologna egli ri-
14 Ibid., p. 12. Vd. anche Diz. Biogr. It., 16, 1973, pp. 509-512 (P. TREVES su Calcaterra) e I Suppl., 1988, pp. 311-315 (F. POLATO su Battaglia).15 Diz. Biogr. It., 23, 1979, pp. 508-510 (M. MIGLIO su Cen-cetti) e 42, 1993, pp. 63-71 (S. BOESCH GAIANO su Dupré
Theseider).16 Alma Mater, cit. (nt. 5), p. 13.17 Sul Ducati: N. PARISE, in Diz. Biogr. It., 41, 1992, pp. 727-730.
<136>
12 - GIANCARLO SUSINI: LA FORMAZIONE 1591
prende il fi lone degli studi paletnologici sulla regione, che era stato fondato dal Brizio e continuato dal Gherardini e, sia pure con diversa intonazione, dal Ducati.
Il giovane Susini è conquistato dall’insegnamento e dalla personalità di questo maestro, portato già dalla sua origine triestina a capire le culture di confi ne, capace di muoversi dalla civiltà greca a quella romana, a quella preromana, sensibile non solo ai valori formali ed estetici, ma anche a quelli, etici da un lato e strumentali dall’altro, del reperto archeologico, attento all’ambiente, infaticabile organizzatore di imprese e di istituti culturali, innamorato di scavi e di musei18.
Non è chi non veda come ciascuna di queste caratteristiche trovi esatta corrispondenza, sia pure con personali elaborazioni, nel Susini più maturo, segno della traccia profonda lasciata dall’incontro, che si protrasse sino alla morte prematura (nel 1966), con questo Maestro cui riteneva andasse oltre tutto il merito di aver dato alla scuola bolognese, con l’apertura al Levante, “il vantaggio di una nuova dimen-sione luminosa ed aperta”19.
L’altro maestro dichiarato di Susini è Arturo Solari. A differenza di Laurenzi, che è appena arrivato ed ancora piuttosto giovane quando Susini arriva all’Università, il Solari è allora ormai prossimo alla fi ne del suo insegnamento20. Nato nel 1874, andrà infatti in pensione nel ’48 e morirà nel ’51. Lo stu-dioso di maggior rilievo che aveva tenuto cattedra di Storia Antica a Bologna prima di lui era stato Giu-seppe Cardinali, allievo di Beloch, che vi era rimasto dal 1912 al 1917 prima di trasferirsi a Roma, dap-prima come ordinario di Antichità ed Epigrafi a | Romana, poi, dal 1928, come titolare di Storia Romana succedendo a Ettore Pais21. Vi aveva portato i suoi interessi per Creta ellenistica, il Regno pergameno e per la vita interna di Roma, rifl essi questi ultimi negli Studi graccani, che sono appunto del 1912: Arturo Solari non gli successe direttamente, ma approdò a Bologna nell’anno accademico 1923/24, dopo che per qualche anno l’insegnamento era stato impartito da Vittorio Puntoni (fi lologo, paleografo ed epigra-fi sta eminente, con il quale proprio nel 1924 si laureò Margherita Guarducci) e dall’archeologo Pericle Ducati. Nato a Taranto, ma da famiglia genovese stabilitasi a Livorno, era stato allievo della Scuola Nor-male Superiore di Pisa, nella cui Università si era laureato con il Pais. Dopo aver insegnato nel Liceo, era diventato vice direttore della Scuola Normale, aveva conseguito nel 1905 la libera docenza e nel 1922 era risultato vincitore in un travagliato concorso a cattedra di Storia Antica insieme con Adolfo Omodeo, il futuro storico della Chiesa e del Risorgimento, che andò ad insegnare a Catania, e con Aldo Ferrabino, che pervenne invece a Padova. Quando giunse a Bologna, le sue opere maggiori erano uno studio su La navarchia a Sparta e la lista dei navarchi (1899) ed i quattro volumi della Topografi a storica dell’Etru-ria pubblicati tra il 1914 e il 1918. Seguirono il libro sulla Vita pubblica e privata degli Etruschi (1931), i tre tomi su La crisi dell’Impero romano, seguita da Giuliano a Odoacre (1933-1935), in parte riscritti con il titolo signifi cativamente mutato di Il rinnovamento dell’Impero romano in due volumi pubblicati fra il ’38 e il ’43 ed i quattro volumi de l’Impero romano tra Augusto e Giuliano editi fra il ’41 e il ’47. A Bologna, non impartì soltanto l’insegnamento di Storia Antica, ma assecondando interessi già prece-dentemente coltivati, anche quello, da lui appositamente fatto istituire nel ’37, di Topografi a dell’Italia Antica, con particolare riferimento all’Emilia-Romagna, ai cui insediamenti antichi dedicò dopo il ’24 una ventina di scritti.
18 La fi gura di Laurenzi è rievocata dal Susini, oltre che negli scritti autobiografi ci, nei necrologi che ne scrisse in Stud. Romagn., 15, 1964 [1966], pp. 127-128; Arch. Class., 19, 1967, pp. 354-356; Rend. Pont. Ac. Arch., 40, 1967/68, pp. 13-20.19 Stud. Romagn., cit. (nt. 8), p. 128.20 Sull’insegnamento del Solari a Bologna: C.A. BALDUC-
CI, Ricordo di Arturo Solari, in Stud. Romagn., 3, 1952, pp. 341-348.21 G. SUSINI, Giuseppe Cardinali, in Atti Dep. Stor. Patr.Romagna, n.s., 7, 1955-56, pp. 363-366 (ripubblic. con omiss. della bibliografi a in Bononia / Bologna. Scritti di Giancarlo Susini, Bologna 2001, pp. 351 sg.).
<137>
1592 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
Susini ne seguì i corsi di Storia Romana nel ’46/’47 e poi di Storia Greca e di Topografi a dell’Italia Antica nel ’47/’48, quando il maestro aveva già 73 e 74 anni.
Si trattava di una fi gura in qualche modo anomala per il tempo. Nel ’25 era stato tra i primi fi rmatari del Manifesto degli intellettuali antifascisti redatto da Benedetto Croce22. Successivamente aveva tenuto una posizione defi lata rispetto al regime collocandosi, dopo il ’45, nella sfera della sinistra militante.
I temi da lui prediletti risultano, da un lato quelli dei grandi scontri, che sono anche confl itti ideali, fra impero e barbarismo, occidente ed oriente, paganesimo e cristianesimo, vertice e base, conservazio-ne e rinnovamento, dall’altro, quasi per correzione di una tendenza all’astrattezza, quelli assai concreti e circoscritti dell’ambiente, delle antichità locali, del vivere quotidiano.
A quel che risulta da vari accenni contenuti nei suoi scritti, Susini fu conquistato, oltre che dal rigore della ricerca dell’anziano maestro e dal paterno interesse da lui mostrato nei suoi confronti, da questa inusuale mescolanza tra spiritualità e concretezza, fra discorso sul ruolo civile di Roma, inteso “non tanto e non già in prospettiva egemonica, ma come magistero ecumenico spirituale” (sono parole del Susini)23, e inveramento della storia delle realtà locali e nelle tradizioni antiche e moderne svilup-patesi su di esse. “Solari – dice Susini – trovò in me una straordinaria contentezza di questo modo di ragionare”24. Non stupisce se molti anni dopo sarà proprio da queste lontane radici che Susini farà discendere alcune delle idee portanti della sua ricerca più matura. “Per quel che concerne chi scrive, che fu di Arturo Solari l’ultimo scolaro – egli dirà – devo segnalare che il germe lontano della ricerca sugli orizzonti scrittori e delle offi cine epigrafi che va ravvisato nella capacità del Maestro di indicare i luoghi comuni dello scrivere, quindi – per mio conto – le isoipse culturali del linguaggio delle pietre”25. Altrove egli afferma che è nell’inquieto discorso solariano su crisi e rinnovamento della romanità che va individuato l’archetipo concettuale del colloquio internazionale da lui organizzato (1986) su La terza età dell’Epigrafi a, ovvero sulla dissoluzione, la sopravvivenza ed il riproporsi del linguaggio epigrafi co tra tarda antichità e l’alto medioevo26. E ancora è all’insegnamento del Solari che egli fa rimontare i concetti teorizzati dal Mansuelli ed a lui particolarmente congeniali, di alterità, subalternità, periferia e provincia27. Un’impronta davvero notevole, che tanto più colpisce se si considera la brevità del rapporto che fu possibile fra maestro ed allievo.
Si è detto del Mansuelli. Con questo archeologo di undici anni più anziano entriamo nella sfera di coloro ai quali, pur non essendo stati suoi docenti, il Susini riconosceva di dovere una qualche parte del-la sua formazione negli anni giovanili. Oltre a lui ci limitiamo a ricordare il romanista Giuseppe Ignazio Luzzatto (giunto a Bologna subito dopo la laurea del Susini nel ’51) per i suoi innovativi studi, appunto con il Mansuelli, sulle culture periferiche e provinciali, e il già famoso | umanista Augusto Campana,
22 Sulla ‘guerra dei manifesti Gentile/Croce’: G. BOATTI, Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si oppo-sero a Mussolini, Torino 2001, pp. 31-45 (devo questa se-gnalazione al collega Angelo Russi, che ringrazio). Anche il Momigliano, che pure ne dà un giudizio riduttivo, ammette che il Solari fu tra quelli che, nello scrivere di storia romana, rifuggirono dal panegirico d’ispirazione fascista: A. MOMI-GLIANO, Gli studi italiani di Storia greca e romana dal 1895 al 1939, in ID., Contributo alla storia degli studi classici, Roma 1955, p. 295. Solo un fugace accenno, con riferimento al periodo in cui era stato vicedirettore, in P. SIMONCELLI, La Normale di Pisa, tensioni e consenso (1928-1938), Milano 1998, p. 51 nt. 65.
23 Chiose, cit. (nt. 11), p. 236 (ripubbl. in Bononia / Bolo-gna, cit. [nt. 21], p. 380).24 Alma mater, cit. (nt. 5), p. 13.25 Sull’orma di Arturo Solari, storico a Bologna, in Il con-tributo dell’Università di Bologna alla storia della città: l’Evo Antico, Bologna 1989, p. 348 (ripubbl. in Bononia / Bologna, cit. [nt. 21], p. 356).26 Antico, classico e archeologia: gli studi a Bologna nel-l’ultimo secolo, in Lo studio e la città, a cura di Walter Tega, Bologna 1987, p. 404 (ripubbl. in Bononia / Bologna, cit. [nt. 21], p. 348).27 Sull’orma, cit. (nt. 25) p. 348 (356).
<138>
<139>
12 - GIANCARLO SUSINI: LA FORMAZIONE 1593
fondatore nel 1949 della Società di Studi Romagnoli. Da ricordare tra i compagni di studio di quegli anni almeno il futuro fi lologo classico Attilio Roveri ed i futuri archeologi Giorgio Gualandi e Maria Teresa Marabini, poi Moevs.
Ma anche altre esperienze, che non possono essere ignorate, costituiscono parte integrante della formazione del Susini negli anni universitari. Sono: i viaggi, l’attività giornalistica per la sede bolognese della RAI, l’impegno nelle elezioni per l’organismo rappresentativo universitario.
I viaggi, favoriti – com’egli riconosce – dalle facilitazioni che gli spettavano in quanto familiare di dipendente delle Ferrovie dello Stato, vengono incontro al suo caratteristico, insaziabile, desiderio di conoscenza personale di luoghi, culture, scavi, musei.
L’attività giornalistica, sviluppatasi tra il ’49 e il ’51, nell’ambito di una specifi ca trasmissione, de-nominata Alma mater e dedicata alla vita universitaria, fa emergere quella vocazione, che non lo lascerà Alma mater e dedicata alla vita universitaria, fa emergere quella vocazione, che non lo lascerà Alma matermai, alla comunicazione ed alla divulgazione nelle sedi più diverse e con gli strumenti di volta in volta più idonei28.
L’esperienza delle elezioni universitarie porta a galla un altro aspetto della sua personalità, quello dell’impegno civile e politico, che pure si manterrà vivo nel Susini per tutta la vita. È interessante notare che in questa prima prova (siamo nella primavera del ’49) il non ancora ventiduenne Susini non si limita a presentare la sua candidatura entro uno dei due principali schieramenti contrapposti (siamo – si ricordi – nel clima incandescente dell’immediato dopoguerra), ma fonda un suo movimento, laico di centro, di cui fanno parte, con lui capofi la, altri 59 candidati tra cui, io non bolognese, individuo Alessandro Bertoni, studente di medicina, suo compagno di avventura alla RAI, Pierluigi (Pilù) Contessi, poi tra i promotori del Mulino, e il già ricordato Attilio Roveri29. Il programma con cui la lista si presenta, andrebbe letto per intero. Notevole il nome prescelto (Civiltà Latina) e il fatto che le richieste rivolte all’istituzione universitaria (riguardanti fra l’altro le attività musicali e teatrali, l’apertura dei piani di studio, l’incremento della cultura contemporanea, l’incentivazione della ricerca interdisciplinare) sia preceduto da una premessa, che suona per me assolutamente susiniana e solariana insieme, al cui inizio si legge: “È grave constatare come nessuna altra lista, nei programmi passati e recenti, abbia accennato alla necessità di difendere, nell’ambito universitario, quel carattere di cultura civile, ossia di educazione, motivo germinale della formazione storica”, e si conclude con l’incitamento a che l’universitario “si ponga alla testa della nostra rinascita spirituale”. Susini fu eletto con altri due, ma né lui né la lista si ripresentarono alle elezioni successive.
Era giunto intanto alla fi ne dei suoi studi universitari. Come si è già ricordato, si laurea il 20 feb-braio 1951; argomento della tesi, non ripreso in studi posteriori, la composizione del senato fra Tiberio Gracco e Sulpicio Rufo.
Iniziava un nuovo cammino le cui tappe principali nel decennio successivo, che rievocherò rapi-damente perché variamente toccate in questa sede anche da altri, sono: l’assistentato straordinario alla cattedra di Laurenzi a pochi giorni dalla laurea30, il perfezionamento presso la Scuola Archeologica di
28 I temi dell’attività giornalistica radiofonica negli anni ’49-’51 sono registrati in G. SUSINI, Bibliografi a sino al 1997, a cura di D. RIGATO, Faenza 1997, pp. 9-10.29 Un ricordo di questa esperienza in Alma mater, cit. (nt. 5), p. 14. Ivi anche (p. 11) la riproduzione del manifesto elet-torale (con la presentazione della lista, le linee programma-tiche essenziali, e l’elenco dei candidati) da cui attingo per quel che segue.
30 Con buona lungimiranza, il Laurenzi così conclude la let-tera del 7 marzo ’51 con cui propone la nomina del Susini ad assistente: “Allego il curriculum degli studi, veramente brillante, e aggiungo che il dott. Susini presenta elementi di giudizio suffi cienti perché si possa prevedere, con buona sicurezza, lo svolgimento di una onorevole carriera universi-taria come assistente e, in seguito, come docente”.
<140>
1594 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
Atene nel ’52/’53, la borsa Fulbright presso l’Accademia Americana a Roma nel ’54/’55, due borse di studio a Innsbruck ed a Montpellier nel ’56/’57. Nel ’57 comincia le ricognizioni epigrafi che nel Sa-lento; nel ’58 è capo della segreteria organizzativa dell’VIII Congresso Internazionale di Archeologia Classica che si tiene a Roma, dei cui atti cura la pubblicazione. Vengono poi le libere docenze in Storia Greca e Romana e in Antichità Greche e Romane rispettivamente nel ’58 e nel ’59, i primi incarichi d’in-segnamento di Antichità e Storia a Trieste (1958-1961) ed a Bologna (1959-1968) e la serie di missioni di ricerca epigrafi ca nelle isole minori del Dodecaneso dal 1960 al 1964.
Ognuna di queste esperienze contribuisce in maniera signifi cativa ad ulteriormente arricchire ed a raffi nare la formazione dello studioso che ormai ha chiaramente individuato la sua strada. L’assistentato universitario rafforza i suoi rapporti con Laurenzi e gli fa muovere i primi passi della didattica che, curio-samente, è prima di epigrafi a greca (o addirittura micenea) che di epigrafi a latina31. Il perfezionamento ad Atene nella Scuola allora retta da Doro Levi lo porta, sulle orme del maestro, ad un più diretto contatto con la Grecia e l’Oriente32. La permanenza all’Accademia Americana (in cui fu borsista con Emilio Gabba e con il medievista e musicologo Cesare Vecchi), oltre a metterlo in rapporto di collaborazione con una maestra d’eccezione (a cui anch’io devo molto) come Lily Ross Taylor, e a fargli conoscere altri studiosi di livello internazionale, agevolò i suoi contatti con l’ambiente romano, in primo luogo con Margherita Guarducci e più tardi con Attilio Degrassi. Le borse all’estero ampliano ulteriormente la sua esperienza internazionale alimentata anche dai viaggi di cui si è detto. Le ricognizioni33, ed i primi incarichi d’inse-gnamento (gli anni triestini gli erano particolarmente | cari) costituiscono banco di prova delle sue capacità che, ben presto si rivelano eccezionali, di ideatore, organizzatore e realizzatore di didattica e ricerca.
Le pubblicazioni mostrano quale sia stato parallelamente il cammino scientifi co del Susini nel de-cennio o poco più dopo la laurea oltre il quale mi sono proposto di non andare. Il referente epigrafi co, che compare già nel primo articolo del ’53, diventa subito dominante e, con esso, quello storico-topo-grafi co. A parte il gruppo di contributi collegato all’esperienza ateniese (iscrizioni di Lemno, Megiste, Licia, Coo, Egina), e più tardi quello connesso con le missioni nell’Egeo, l’attenzione è rivolta preva-lentemente alla produzione epigrafi ca dei vari centri di Emilia, Romagna, Piceno, non solo però per una prima edizione, o per la riedizione, dei testi, ma per utilizzarla, insieme con tutti gli altri dati disponibili, nella ricostruzione delle vicende, sia storico-istituzionali, sia, più latamente storico-culturali, delle sin-gole comunità prese in esame e di più ampi comprensori34. Per le singole voci sulle province romane
31 Nell’a.a. 1953/54 tiene lezioni, con pubblicazione delle relative dispense, su Origine e diffusione dell’alfabeto greco; decreti attici; il discorso di Nerone ai Corinzi. Nel 1954/55 sul Deciframento del linguaggio miceneo. Nel 1955/56 su Testimonianze epigrafi che di vita romana.32 Vincitore quale primo nel 1952 del concorso nazionale per allievo della Scuola (Antichità Greche e Romane), si diploma il 31 marzo 1953 dopo aver scavato a Creta ed a Lemno ed aver studiato in particolare le iscrizioni di Me-giste e della Licia. Tra i suoi colleghi della Scuola ci sono Giuseppe Bovini e Luigi Polacco. Ricordi di questi anni in Mitteleuropea 1953, cit. (nt. 5).33 Sulle missioni nel Dodecaneso si veda in particolare Le mie isole, cit. (nt. 5).34 Ha probabilmente ragione Emilio Gabba a inquadrare, nel suo intervento conclusivo, questo aspetto della persona-
lità scientifi ca di Susini piuttosto nella tradizione di studi che fa capo alle locali Deputazioni di Storia Patria che in una diretta discendenza dal magistero, alto, ma diversamente orientato, di Bartolomeo Borghesi. Forse un punto di salda-tura tra i due fi loni potrebbe vedersi nella fi gura del savigna-nese Francesco Rocchi, che del Borghesi fu allievo diretto e che su designazione di questi occupò nel 1847 la cattedra bolognese di Archeologia, in realtà essenzialmente di Epi-grafi a, Antiquaria e Storia. È notevole che a lui, che collabo-rò al progetto francese del Corpus, il Borghesi, destinato alla cattedra, abbia rivolto l’invito innovatore a realizzare una raccolta epigrafi ca delle regioni V, VI e VIII, che non fosse più tematica, ma sistematica. Sulla posizione del Rocchi fra la tradizione di Gaetano Marini e Bartolomeo Borghesi e la successiva scuola bolognese di Brizio, Ghirardini e Ducati: SUSINI, Antico, cit. (nt. 26), p. 343.
<141>
12 - GIANCARLO SUSINI: LA FORMAZIONE 1595
per l’Enciclopedia dell’Arte Antica Classica e Orientale rimando all’intervento in questa stessa sede del collega Mastino e per gli studi annibalici a quello di Giovanni Brizzi. In progresso di tempo si fanno strada poi anche altri interessi: per i problemi teorici e pratici dell’ordinamento dei lapidari, per la storia della scrittura, per l’epigrafi a extraurbana e dei santuari. Omettendo molto altro (rimando all’intervento di Angela Donati), noto che del ’60 sono il Lapidario greco e romano di Bologna e il contributo sul Santuario di Feronia e delle divinità salutari a Bagnacavallo. Nel ’62 Offi cine epigrafi che e ceti socia-li. Contributo alla storia del Salento romano. Del ’65 sono Le offi cine lapidarie romane di Ravenna e L’offi cina lapidaria di Urbino. Siamo, com’è evidente alla vigilia de Il lapicida romano. Gli anni della formazione sono ormai fi niti e il passo, il respiro, il piglio di Susini sono diventati ormai quelli di un maestro35.
35 Nel ’68, ternato nel concorso a cattedra di Storia Romana con esercitazioni di Epigrafi a Romana bandito dall’Univer-sità di Torino, viene chiamato come professore straordinario in soprannumero della stessa disciplina nella Facoltà di Let-tere dell’Università di Bologna sulla base di una dettaglia-ta relazione dell’ordinaria Marta Sordi in cui si sottolinea,
fra l’altro, “l’affi namento progressivo di un metodo storico estremamente rigoroso e, nello stesso tempo, profondamen-te moderno” del Susini, la cui indagine “muove dal dato archeologico e topografi co e perviene alla caratterizzazione sociale, economica, politica, culturale e religiosa di un am-biente storico”.
Il 13 ottobre scorso l’Accademia ha dovuto registrare la perdita del socio corrispondente (dal 1985) Franco Sartori, professore emerito di Storia Greca e Romana nell’Università di Padova. In ragione del-la frequentazione più che cinquantennale che ho avuto con lui (il nostro primo incontro risale al 1951 quando lui era neoassistente ordinario di Attilio Degrassi a Padova ed io neoallievo dello stesso) grava ora su di me la responsabilità di redigerne, in breve, un ricordo che non risulti troppo inadeguato.
Compito non facile perché quella del Sartori è stata una personalità complessa, la cui produzione scientifi ca ha toccato campi assai diversi (fu tra l’altro, signifi cativamente, uno degli ultimi professori dell’Università italiana che siano stati titolari insieme di Storia Greca e Romana). Egli ha fatto ricorso inoltre a metodologie diverse (archeologia, fi lologia, storia, epigrafi a) traendo profi tto dall’insegna-mento ricevuto da maestri molto differenti tra loro come Carlo Anti, Manara Valgimigli, Carlo Diano, Aldo Ferrabino, Paola Zancan ed Attilio Degrassi. Oltre a ciò, ha svolto, in proprio e per conto della sua università, un’intensa attività di promotore di cultura e di relazioni internazionali.
Sono in qualche modo agevolato nel mio compito da alcune iniziative assunte recentemente (fra il 2002 e il 2003) per festeggiare i suoi ottant’anni.
Anzitutto dalla pubblicazione da parte dell’Università di Boemia Sud, a cura di Igor Lisový e di Ian Burian, di un volume contenente un dettagliatissimo curriculum didattico-scientifi co ed accademico del Sartori insieme con una sua completissima bibliografi a di 1160 voci (segnalazioni bibliografi che comprese) che mi esonera da elenchi, tanto lunghi quanto destinati cionondimeno | a restare largamente incompleti, di funzioni, pubblici riconoscimenti e pubblicazioni1.
Poi da due raccolte di scritti in suo onore: una promossa dalla Società di Studi Trentini di Scienze Storiche, che gli ha dedicato un fascicolo della sua rivista2, l’altra, realizzata dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Padova3. Poiché entrambe ospitano ampi e informativi contributi sul-l’infaticabile opera di questo studioso, non solo come storico dell’antichità, ma anche, più in generale, come uomo di cultura, posso rimandare ad esse per quanto qui non sarà possibile dire. Intendo infatti ac-cennare, per ricordarlo, soltanto a quattro sue caratteristiche che mi sembrano più rilevanti e personali.
La prima è quella di un suo spiccato interesse per tutto ciò che avesse a che fare con incontri tra culture diverse. Che l’attenzione per ‘gli altri’, sia una costante della rifl essione storica del Sartori non è osservazione solo mia. Di volta in volta ‘gli altri’ possono essere, nella colonizzazione greca in Italia meridionale e in Sicilia, le popolazioni indigene, i Punici, gli Etruschi, i sovrani ellenistici o anche i Romani, oppure, muovendo dal processo di espansione romana, le popolazioni non latine (greche, osco-sannitiche, lucane, bruzzie) dell’Italia meridionale, o celtiche, retiche, venete dell’Italia
* Rend. Pont. Ac. Arch., 77, 2004-05, pp. 461-464.1 Professoris Dr. Franco Sartori vita et bibliographia,Igor Lisový edendum curavit, Jan Burian recensuit, České Budějovice 2002, pp. 97.
2 Studi Trentini di Scienze Storiche, 82, 1, 2003.3 ERKOS. Studi in onore di Franco Sartori, Padova 2003; a pp. I-XXVI curriculum e pubblicazioni dell’onorato (con omissione delle segnalazioni bibliografi che).
VI,13 - FRANCO SARTORI (1922-2004)*
<461>
<462>
1598 VI - MAGISTRI, SODALES, ITINERIS COMITES
settentrionale4. Come non crede ad una visione ellenocentrica così il Sartori rifi uta ogni visione roma-nocentrica della storia. La storia che più lo stimola è quella che vede nascere dai complessi fenomeni di azione e reazione che s’innescano nell’incontro, o anche scontro, tra culture diverse. Di qui lo studio delle costituzioni, non viste staticamente, ma come organismi che adeguano tradizioni e forme al mutare delle situazioni. Fondamentale al riguardo il volume ormai classico (se ne condividano o meno tutte le conclusioni sulle diverse situazioni esaminate) dal titolo Problemi di storia costituzionale italiota(Padova 1953), il cui scopo – a detta dell’autore stesso (p. 12) – è di “tentare di stabilire, dove è possi-bile, se e quali forme costituzionali greche siano persistite in età romana e con quale spirito il governo romano si sia posto loro di fronte, se le abbia accolte o respinte, o gradualmente annullate”. Ma non va dimenticato che a quel volume, i cui temi sono stati | più volte ripresi dall’autore in saggi successivi, si affi ancano altre numerose ricerche sulla storia, sia della Magna Grecia e della Sicilia, sia del Veneto, in cui l’attenzione per le trasformazioni istituzionali e culturali è del pari vivissima.
Caratteristica seconda. Un altro centro d’interesse del Sartori, non del tutto separato dal precedente, risiede nella storia del pensiero politico (di Aristotele e di Platone soprattutto) e delle forme assunte dalla lotta tra fazioni nell’Atene del VI e del V sec. a.C. Ne sono testimonianza eloquente sia le ripetute edizioni (con introduzione, traduzione e note) del Clitofonte e della Repubblica in forma completa o antologica (Bari 1956-2001), sia il suo primo volume su La crisi del 411 a.C. nell’Athenaion Politeia di Aristotele (Padova 1951), sia, ancor più, il successivo Le eterie nella vita politica ateniese del VI e del V sec. (Padova 1957), ove particolare attenzione viene dedicata ai metodi di lotta occulta ed illegale che, nello scontro tra democratici ed oligarchi, si affi ancano a quelli dell’opposizione aperta.
Sartori ha poi fermamente creduto (punto terzo) nell’importanza della storia locale nella sua acce-zione più vasta, il che vuol dire conoscenza minuta del territorio, ricerca e valorizzazione di ogni fonte, anche la più modesta, equilibrio tra particolare e generale, senso della tradizione e della costruzione culturale dall’antico fi no alla contemporaneità. Per questo ha dedicato tanto tempo, non solo a studi specialistici sulla regione in cui era nato, ma anche ad una attiva partecipazione alla vita di tutte le istituzioni locali (Università, Deputazioni, Accademie, Associazioni, Società, Istituti) che sul territorio agissero, ovunque portando un personale contributo di rigore metodico (si pensi all’effi cacia educativa delle centinaia di schede con cui, senza esimersi da giudizi, ha diffuso la conoscenza di studi d’interesse locale) e di costruzione, organizzazione e miglioramento di rapporti, si trattasse dell’Alto Adige, regione con la quale, partendo da momenti diffi cili, ha intessuto un dialogo più che ventennale, o dell’Austria, della Germania o della Francia, della Polonia o delle repubbliche Ceca o Slovacca, Croata, Slovena o Jugoslava. Molti dei riconoscimenti ricevuti sono legati, giustamente, a questa incessante e meritoria attività. Mi riguarda da vicino il prezioso apporto che ha dato alla Commissione per le Inscriptiones Italiae e, parlando di riconoscimenti, voglio almeno ricordare quello, squisitamente scientifi co, che gli fu attribuito nel 1994, con il premio linceo per la Storia.
Venendo al quarto ed ultimo punto mi piace infi ne ricordare un’altra dote che, in linea con questo senso della continuità e dell’importanza delle relazioni umane, mi pare abbia caratterizzato in modo peculiare Franco Sartori come persona ed è quella di una straordinaria fedeltà alla memoria dei suoi maestri, a quella di Attilio Degrassi in particolare. Per questo maestro, | acquisito dopo la laurea, Sartori ebbe non solo grande ammirazione e riconoscenza, ma anche profondo affetto, di cui sono stato testimo-ne e che non esito a defi nire autenticamente fi liale. Non è certamente un caso se l’ultimo articolo che ho
4 Quarantaquattro saggi concernenti la storia preromana e romana dell’Italia e della Sicilia, sono raccolti in: F. SARTORI,
Dall’Italía all’Italia, a cura di M. CAPOZZA – L. BRACCESI – E. BUCHI, Padova 1993, 2 voll., pp. 934.
<463>
<464>
13 - FRANCO SARTORI 1599
ricevuto da lui, poco prima della sua scomparsa, è consacrato ancora una volta alla fi gura del Degrassi (a 35 anni dalla morte)5 e se vi ha aggiunto la dedica: “A Silvio, in ricordo di un maestro comune e sempre rimpianto”. Il rimpianto è ora nostro nei suoi confronti ed inoltre, insieme con i familiari, dei suoi molti allievi, tra cui pongo in parte anche me stesso, e dei tanti che lo ebbero a lungo come leale collega ed amico.
5 Attilio Degrassi maestro nell’Università di Padova, in Relationes Budvicenses. Miscellanea philologiae classicae,
4-5, 2003-04 (Ioanni Burian LXXV), 2004, pp. 131-137.