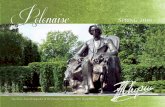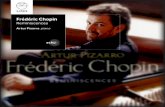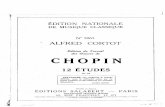- "Pauline Viardot Garcia e la “poesia del sentimento” nelle mazurche di Chopin", in «Grandeur...
Transcript of - "Pauline Viardot Garcia e la “poesia del sentimento” nelle mazurche di Chopin", in «Grandeur...
Pauline Viardot-Garcia e la poetica della chanson populaire nelle
trascrizioni per voce delle Mazurche di Chopin
Mariacarla De Giorgi (Lecce)
Pauline Viardot Garcia rappresenta una tra le figure di interprete e compositrice più emblematiche della vita musicale e culturale della Parigi romantica, non solo per la sua straordinaria attività di pianista e cantante di successo, volta anche al recupero
storico dei repertori di musica strumentale e vocale dal barocco al classicismo, ma perché la sua concezione estetico-compositiva concretizza realmente un ponte di collegamento ideale tra il virtuosismo esecutivo di Liszt, suo maestro negli anni della formazione (1830-1832), e la poetica intimistica di Chopin, consigliere e amico negli anni della sua affermazione come artista (1840-1848)1. Questo rapporto esclusivo della Viardot con i due maestri ben si
1. Per gli aspetti biografici e gli anni della formazione musicale e del successo professionale cfr. Torrigi-Heiroth, Lidie. ‘Mme Pauline Viardot-Garcia: sa biographie, ses compositions, son enseignement’, in: Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran, n. 1 (1977), pp. 43-70; FitzLyon, April. The Price of Genius: A Biography of Pauline Viardot, Londra, John Calder, 1964; Ead. ‘Pauline Viardot: A 150th Anniversary Tribute’, in: Opera, xxii/7 (1971), pp. 582-588; Kendall-Davies, Barbara. The Life and Work of Pauline Viardot Garcia. Volume 1: The Years of Fame, 1836-1863, Amersham, Cambridge Scholars Press, 22004; Borchard, Beatrix. ‘Jeux d’esprit: Pauline Viardot-Garcia’, in: Klangwelten, Lebenswelten: Komponistinnen in Südwestdeutschland. Ausstellungskatalog der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, a cura di Martina Rebmann e Rainer Naegele, Stoccarda, Württembergische Landesbibliothek, 2004, pp. 91-124. L’attività di recupero dei repertori musicali del passato e la promozione dei nuovi artisti nel salotto Viardot a Parigi, in Rue de Douai, è ben documentata dal figlio Paul in: Viardot, Paul. Souvenirs d’un artiste, Parigi, Librairie Fischbacher, 1910, pp. 47-48; cfr. anche Viardot, Pierrette Jeanne. ‘Le Jeudis de Pauline Viardot’, in: Revue international de musique française, viii/6 (1982), p. 95. Sui rapporti di relazione della Viardot con i suoi maestri cfr. Rozanov, Aleksandr Semenovic. ‘Pauline Viardot pianiste’, in: Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran, n. 4 (1980), pp. 80-85; Hamburger, Klara. ‘Liszt et Pauline Viardot-Garcia (dans l’optique de sept lettres inédites)’, in: Studia musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, xxxiv/1-2 (1993), pp. 187-202; Eigeldinger, Jean-Jeacques. Chopin Pianist and Teacher as Seen by His Pupils, traduzione inglese di Naomi Shohet con Kryzsia Osostowicz e Roy Howat, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, pp. 186-188; Marek, G. - Gordon-Smith, M. ‘Pauline Viardot and Frédéric Chopin’, in: About the House: The Magazine of the Friends of Covent Garden, v/7 (1978), pp. 28-31. Merita una menzione particolare il progetto di ricerca
2
Mariacarla De Giorgi
rivela dall’analisi delle trascrizioni per voce delle 12 Mazurche di Chopin, da lei elaborate e pubblicate a Parigi, presso Gérard & Cie, in due successivi cicli da sei, rispettivamente nel 1864 e 1865, su testi poetici di Louis Pomey2.
Tavola 1: Sono qui riportati i titoli delle 12 Mazurche per canto e pianoforte, pubblicate dalla Viardot in due successive raccolte da sei brani. Le rispettive Mazurche di Chopin, da cui sono tratte le trascrizioni, sono indicate con il numero d’opus e l’anno di pubblicazione corrispondente.
Six mazourkes de Frédéric Chopin, arrangées pour la voix par Mme Pauline Viardot,paroles de Louis Pomey, Parigi, E. Gérard & Cie, 1864
Trascrizioni di P. Viardot Mazurche di F. Chopin Data di pubblicazione delle Mazurche di F. Chopin
1. Seize ans Op. 50/2 1842
2. Aime-moi Op. 33/2 1838
3. Plainte d’amour Op. 6/1 1832
4. Coquette Op. 7/1 1832
5. L’oiselet Op. 68/2 1855
6. Séparation (Duo) Op. 24/1 1836
Six mazourkes de Frédéric Chopin, pour chant et piano, paroles de Louis Pomey,arrangées par Mme Pauline Viardot, deuxième série, Parigi, E. Gérard & Cie, 1865
Trascrizioni di P. Viardot Mazurche di F. Chopin Data di pubblicazione delle Mazurche di F. Chopin
1. La Fête Op. 6/4 1832
2. Faible coeur Op. 7/3 1832
3. La jeune fille Op. 24/2 1836
Orte und Wege europäischer Kulturvermittlung durch Musik. Die Sängerin und Komponistin Pauline Viardot, partito nel 2007 sotto la direzione di Beatrix Borchard presso la Hochschule für Musik und Theater Hamburg, e che dovrebbe produrre una serie di importanti pubblicazioni sulla figura e l’opera della Viardot, insieme a una ricatalogazione completa delle opere della compositrice. Le pubblicazioni previste sono consultabili su <http://viardot.hfmt-hamburg.de>.
2. Six mazourkes de Frédéric Chopin, arrangées pour la voix par Mme Pauline Viardot, paroles de Louis Pomey, Parigi, E. Gérard & Cie, 1864; Six mazourkes de Frédéric Chopin, arrangées pour chant et piano, paroles de Louis Pomey, arrangées par Mme Pauline Viardot, deuxième série, Parigi, E. Gérard & Cie, 1865. Per le successive edizioni in lingua polacca, tedesca e russa delle mazurche per canto della Viardot si veda Waddington, Patrick. The Musical Works of Pauline Viardot-Garcia (1821-1910): A Chronological Catalogue with an Index of Titles & a List of Writers Set and Composers Arranged, Pinehaven (NZ), Whirinaki Press, 2001, pp. 11-25. Le trascrizioni delle mazurche sono state riedite in Chopin-Viardot, 12 Mazurkas for Voice and Piano, a cura di Jerome Rose, New York, International Music Company, 1988.
3
Pauline Viardot-Garcia e la poetica della chanson populaire…
4. Berceuse Op. 33/3 1838
5. La danse Op. 50/1 1842
6. La Beauté (Duo) Op. 67/1 1855
Qui la Viardot, secondo la recensione delle sue trascrizioni fatta da Saint-Saëns nell’elogio pubblicato su êcole buissonière (1913) «dà nuova forma e contenuto alla musica strumentale delle Mazurche chopiniane attraverso il mezzo espressivo della sua voce»3, servendosi così della mazurca — un genere centrale nell’opera pianistica del compositore polacco — per dare libera voce a tutti i sentimenti e le suggestioni insite nella musica del maestro. Questa concezione è più volte ribadita nelle opere di George Sand che, in Consuelo — il romanzo in 3 voll. (1842-1844) dedicato proprio alla figura di Pauline Viardot —, esprime la sua estetica della musica, alludendo chiaramente al potere generativo d’immagini poetiche posseduto esclusivamente da quest’arte, l’unica in grado di sublimare la realtà attraverso il sentimento4. D’altra parte il genere della mazurca (e in particolare le sue melodie) cattura l’ascoltatore sia pur nella forma compatta dei singoli brani pianistici ‘souvenirs dell’anima popolare polacca’5, come si può dedurre dai sopratitoli dell’edizione londinese delle Mazurche Opp. 6 e 7, pubblicata nel 1833 dall’editore inglese Wessel, come Souvenirs de Varsovie, e seguita dai successivi cicli di Mazurche Op. 24, 41 e 50, pubblicati rispettivamente nel 1836, 1840 e 1842, che compaiono sempre nell’edizione londinese di Wessel quali Souvenirs de la Pologne: tutti numeri d’opera, eccetto l’Op. 41, da cui la Viardot sceglierà le mazurche per le sue trascrizioni vocali6. George Sand fa più volte
3. Saint-Saëns, Charles-Camille. Ecole buissonnière, Parigi, Pierre Lafitte, 1913, pp. 217-23; Id. ‘Pauline Viardot: Necrologio’, in: L’Echo de Paris, 5 febbraio 1911, riportato in Id. Musikalische Reminiszenzen. Mit einer Studie von Romain Rolland: Camille Saint-Saëns, a cura di Reiner Zimmerman, Lipsia, Philipp Reclam jun., 1978, pp. 120-125.
4. Sand, George. Consuelo, vol. ii (1861), cap. lv, pp. 380-381, nell’edizione di Léon Guichard, Parigi, Garnier, 1959: «On a dit avec raison que le but de la musique, c’était l’émotion. Aucun autre art ne réveillera d’une manière aussi sublime le sentiment humain dans les entrailles de l’homme; aucun autre art ne peindra aux yeux de l’âme, et les splendeurs de la nature, et les délices de la contemplation, et le caractère des peuples, et le tumulte de leurs passions, et les langueurs de leurs souffrances […] la musique nous le donne et nous le reprend, au gré de son génie et selon toute la portée du nôtre. Elle crée même l’aspect des choses, et, sans tomber dans les puérilités des effets de sonorité, ni dans l’étroite imitation des bruits réels, elle nous fait voir, à travers un voile vaporeux qui les agrandit et les divinise, les objets extérieurs où elle transporte notre imagination».
5. Cfr. Lenz, Wilhelm von. Die Grossen Pianoforte-Virtuosen unserer Zeit aus persönlicher Bekanntschaft, Berlino, Behr, 1872, p. 86; Ganche, Edouard. Dans le souvenir de Frédéric Chopin, Parigi, Mercure de France, 1925, pp. 85-87; Windakiewicz, Helena. Wzory ludowej muzyki polskiej w Mazurkach Fryderyka Chopina, Cracovia, Akademia Umiej�tno�ci, 1926 (Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU, 61/7); Lissa, Zofia. ‘Le style national des œuvres de Chopin’, in: Annales Chopin, ii (1958), pp. 100-178; Belotti, Gastone. Chopin, Torino, EdT, 1984 (Biblioteca di cultura musicale. Autori e opere), pp. 190-256.
6. Chopin, Fryderyk. Souvenirs de Varsovie: 1st and 2nd Set of Mazurkas, Op. 6 and 7, Londra, Wessel & Co., 1833; Id. Souvenirs de la Pologne: 4th Set of Mazurkas, Op. 24, Londra, Wessel & Co., 1836; Id. Souvenirs
4
Mariacarla De Giorgi
espresso riferimento alla musica di Chopin quale fonte ispiratrice di suggestioni poetiche, come emerge in Entretiens Journaliers del 1837, in cui la scrittrice esamina la musica nelle composizioni del «grand maître»:
Le composizioni musicali dei grandi maestri hanno tutte un senso che si trasmette al pensiero, perché tutte sono state ispirate dal sentimento. […] i potenti effetti di queste combinazioni armoniche si possono attribuire a dei rapporti puramente immaginari tra i suoni e le immagini pensate. Queste (immagini) diventano così reali, così palpabili, per così dire, che non è per niente impossibile coglierle, notarle per l’orecchio dell’artista, e perfino spiegarle e tradurle nella lingua comune, per farle comprendere al pubblico. Ma questo richiederebbe tutta una vita di musicista e di poeta7.
Questa citazione districa un nodo centrale in riferimento al valore della trascrizione per voce delle Mazurche chopiniane sulla base di una reale facoltà evocativa d’immagini poetiche, connaturata alla stessa musica del maestro. In effetti la mazurca che, proprio in virtù delle sue stesse radici quale danza popolare, era divenuta con Chopin simbolo nel mondo della nazione polacca, acquisisce nella trascrizione per canto della Viardot una dimensione sovranazionale, facendosi veicolo di comunicazione dei sentimenti più autentici della poesia popolare romantica. Se è vero che le Mazurche di Chopin sotto l’aspetto formale e strutturale risultano indissolubilmente legate a elementi coreutici e poetico-testuali propriamente polacchi, che ne caratterizzano l’andamento ritmico e l’organizzazione armonico-tonale della forma, è vero anche che nella trascrizione per voce della Viardot l’elemento virtuosistico e improvvisativo, con cui la compositrice trascende il modello nella sua rigorosa suddivisione formale, evidenzia un chiaro intento a superare l’elemento nazionale, estrapolandone lo spirito popolare, quale tratto comune di ogni nazione romantica, che trova l’espressione più genuina e sincera nella poesia e nel bel canto. Con la trascrizione delle Mazurche chopiniane da parte della Viardot entriamo nel cuore del dibattito culturale del romanticismo francese sulla musica popolare, intesa come un tutt’uno con la poesia, il cui canto in lingua originaria assurge a un ruolo di assoluta
de la Pologne: 4th Set of Mazurkas, Op. 41, Londra, Wessel & Co., 1840; Id. Souvenirs de la Pologne: 8th Set of Mazurkas, Op. 50, Londra, Wessel & Co., 1842.
7. La traduzione italiana di questo e altri passi è di chi scrive. «Les compositions musicales des grands maîtres ont toutes un sens traduisible à la pensée, car toutes ont été inspirées par des sentiments. […] et d’attribuer les puissants effets de ces combinaisons harmoniques à des rapports purement imaginaires entre les sons et les images. Il y en a de si réels, de si palpables, pour ainsi dire, qu’il n’est pas impossible de les saisir, de les noter pour l’oreille de l’artiste, et même de les expliquer, de les traduire en langue vulgaire, de les faire comprendre au public. Mais ceci demanderait toute une vie de musicien el de poète»; Sand, George. Entretiens Journaliers, in: Id. Œuvres autobiographiques, a cura di Georges Lubin, 2 voll., Parigi, Gallimard, 1970-1983 (Bibliothèque de la Pléiade), vol. ii, pp. 359-360. Cfr. in proposito Marix-Spire, Thérèse. Les Romantiques et la Musique. Le cas George Sand (1804-1838), Parigi, Nouvelles Editions Latines, 1954.
5
Pauline Viardot-Garcia e la poetica della chanson populaire…
centralità. In tal senso non stupisce il fatto che la Viardot abbia usato prima la sua lingua nazionale, lo spagnolo, per la versione vocale delle Mazurche, questo almeno fino al 18588, come vedremo dalle testimonianze della critica, e solo successivamente il francese nella versione di Pomey9, poeta minore per scelta programmatica, versione questa poi diffusa con rispettiva traduzione in tutti quei paesi in cui la riscoperta delle tradizioni nazionali era assai forte, come Russia, Germania, Polonia, Stati Uniti, spostando in tal senso l’asse d’attrazione della mazurca da un nazionalismo popolare dai tratti tipicamente polacchi a un più cosmopolita popolarismo romantico d’impronta socialista-borghese. Non bisogna dimenticare d’altra parte l’impostazione politico-culturale della famiglia Viardot. Nel 1841 Louis Viardot e George Sand avevano infatti fondato insieme con Pierre Leroux, di cui condividevano decisamente il socialismo umanitario, La Revue indépendante dove la Sand avrebbe poi pubblicato i romanzi Horace, Consuelo, La Comtesse de Rudolstadt e così via, mentre Viardot avrebbe seguito la sua vena culturale e politico-letteraria ispanica, pubblicando una serie d’importanti contributi, tra cui l’Étude sur l’histoire des institutions, de la littérature, du théâtre et des beaux-arts en Espagne, in cui affrontava anche l’aspetto della musica popolare spagnola10.
Se Herder e poi Goethe sostenevano il concetto di Volks- und Nationalpoesie, secondo cui ogni popolo aveva la sua poesia nazionale, diversa per forma e lingua dalle altre11, la Parigi cosmopolita cercava nelle chansons populaires di ogni nazione, sia pur nelle differenti peculiarità etnico-musicali e culturali, valori universali, comuni a tutti i popoli, che il vero artista potesse cogliere nella verità dei suoi sentimenti per comunicarla agli altri de cœur a cœur. Questa concezione, che secondo George Sand era condivisa da Chopin (come lei stessa afferma in un passo dell’Histoire de ma vie12), è ‘personificata’ dalla Viardot nel
8. Cfr. Hamburger, Klara. Op. cit. (si veda nota 1), p. 197. 9. Louis Pomey (1835-1901), conosciuto principalmente come pittore e ritrattista, lo incontriamo a Baden-
Baden, dove si era trasferita la famiglia Viardot nel 1863, come attore e baritono dilettante in due delle operette scritte dalla Viardot su testi di Ivan Turgenev, forse legato al Pomey da vincoli di parentela, cfr. Zvinguilsky, Alexandre. ‘Un frère français de Tourguéniev: Louis Pomey?’, in: Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran, n. 7 (1983), pp. 139-159; Stegemann, Michael. ‘Pauline Viardot a Baden-Baden’, in: Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran, n. 9 (1995), pp. 91-101. Tuttavia Pomey compare, sempre nel 1863, anche come curatore degli affari della famiglia Viardot in Francia, in occasione della vendita di una delle proprietà, la fattoria di Champmoulin; cfr. Waddington, Patrick. ‘The Strange History of Dr F. and the Dismantling of Courtavenel’, in: The Modern Language Review, lxv/2 (1970), pp. 333-354: 342-343.
10. Cfr. Gisbert, Rafael. ‘Louis Viardot et le compositeur espagnol José Melchor Gomis: Une amitié de jeunesse’, in: Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran, n. 12 (1988), pp. 99-106.
11. Herder, Johann Gottfried. Über die neuere deutsche Literatur. Zwote Sammlung von Fragmenten, in: Id. Sämtliche Werke, a cura di Bernhard Suphan, 33 voll., Berlin, Weidmann, 1877-1913, vol. i, pp. 241-356; Goethe, Wolfgang von. Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit, in: Id. Sämtliche Werke. Briefe, Tagebuecher und Gespraeche, a cura di Friedmar Apel, 40 voll., Francoforte sul Meno, Hendrick Birus, 1986-1999, vol. xiv, i sez., p. 445.
12. Sand, George. Histoire de ma vie, in: Œuvres autobiographiques, op. cit. (si veda nota 7), vol. ii, p. 421.
6
Mariacarla De Giorgi
celebre ‘Bildungsroman’ Consuelo13, ambientato nella cultura musicale mitteleuropea del Settecento, in cui la Sand fa esprimere alla protagonista la sua idea di chanson populaire, legandola alla musica dei canti popolari degli antichi hussiti, preservata nella memoria nazionale dei boemi14. Interessante a questo proposito è il confronto tra la consapevolezza storica delle proprie tradizioni popolari in paesi come Germania, Polonia, Boemia, Russia, e la differente situazione in Francia, laddove si avverte a partire dagli anni Trenta l’urgenza di recuperare e conservare i propri patrimoni popolari. Questo confronto trova ampio spazio nell’Histoire du Lied ou La chanson populaire en Allemagne, pubblicata da Edouard Schuré a Parigi negli anni ’6015, anni importanti in cui si raccolgono già in parte i risultati dei lunghi studi attuati ormai da un ventennio sulla musica popolare e la sua trascrizione, come dimostra la pubblicazione da parte di Champfleury delle Chansons populaires des provinces de France, incoraggiata dalla Sand e pubblicata con l’accompagnamento del pianoforte a opera di Wekerlin, nel 186016, ossia nello stesso periodo di pubblicazione delle trascrizioni vocali delle Mazurche di Pauline Viardot. Il testo dello Schuré è fondamentale per contestualizzare culturalmente l’opera attuata dalla Viardot nelle sue trascrizioni e la concezione estetica che ne è alla base.
Lo Schuré sottolinea la necessità di rinnovare la poesia, attingendo a quella primitiva, in cui è preservata nella sua meravigliosa vitalità la voce eterna dell’anima popolare17. Tale poesia, legata strettamente alla musica, è posta in netta contrapposizione con la poesia d’arte, puramente letteraria, accademica, d’élite. La poesia popolare ha infatti una funzione sociale, è un trait d’union tra tutte le classi sociali e personifica pertanto non l’ideale dell’arte per l’arte, ma l’ideale dell’arte umana per l’umanità. In questa concezione il canto colto ha un ruolo centrale in quanto, se vivificato da le cœur du peuple, trasfigura in puro ideale i contenuti della chanson populaire. In tal senso la Viardot rappresenta la personificazione ideale dell’artista, la femme du monde che grazie al suo canto trasporta le energie primitive del popolo dalla stanza solitaria del poeta alla dance du village, facendo dell’opera del maestro e, nel caso specifico, della mazurca il simbolo della festa di tutto un popolo, immagine questa che si concretizza, come vedremo, nella trascrizione per voce n. 7, dal titolo Fête, che, proprio sulle note della Mazurca Op. 6 n. 4 di Chopin, inneggia alla mazurca quale anima della Fête du village.
D’altra parte il filone della trascrizione per voce percorre ininterrottamente la copiosa produzione della Viardot, sia in composizioni pianistiche legate a danze di
13. Marix-Spire, Thérése. Lettres inédites de George Sand et de Pauline Viardot (1839-49), Parigi, Nouvelles Editions Latines, 1954.
14. Sand, George. Consuelo, vol. ii (1861), cap. lv, p. 380, nell’edizione citata a nota 4. 15. Schuré, Edouard. Histoire du Lied ou La chanson populaire en Allemagne avec une centaine de traductions
en vers et sept mélodies, Parigi, A. Lacroix, 1868, pp. 13-15, 86-87.16. Champfleury, Jules. Chansons populaires des provinces de France, Notices par J. F. F. Champfleury,
accompagnement de piano par J. B. Wekerlin, Parigi, Boudiliat, 1860.17. Schuré, Edouard. Op. cit. (si veda nota 15), pp. 13-15, 86-87.
7
Pauline Viardot-Garcia e la poetica della chanson populaire…
carattere nazionale — basti qui ricordare le trascrizioni dei valzer di Schubert, Trois valses de Franz Schubert, 1875, e delle danze ungheresi di Brahms, Les Bohémiennes e Les Cavaliers. Duo d’après les Danses hongroises de Johannes Brahms, 1886 — sia nel filone più consistente delle trascrizioni per voce e pianoforte di canzoni popolari rappresentative dei patrimoni nazionali di diversi paesi, come Francia, Spagna, Italia, Russia e Germania18.
George Sand, la quale ebbe parte attiva nell’opera di recupero delle canzoni popolari francesi, particolarmente quelle della provincia del Berry, come si evince dalla pubblicazione di Julien Tiersot, La chanson populaire et les ecrivains romantiques19, ci riferisce nella sua Correspondance come Chopin e la Viardot nell’estate del 1840 avessero stretto un legame esclusivo tra loro grazie ad alcune affinità musicali, quali «la passione per Bach e Mozart, l’amore per il bel canto, ma soprattutto la loro passione per la musica popolare, in particolare le canzoni popolari spagnole e i canti popolari del Berry»20.
È proprio il salotto di Nohant, dove nelle estati dal 1840 al 1845 la Viardot figura come ospite fissa21, che diviene a tutti gli effetti una fucina d’idee, laboratorio attivo di trascrizioni di musiche popolari, secondo la testimonianza di Champfleury, il quale, nell’introduzione alla pubblicazione Chansons populaires poc’anzi citata, riporta alcune annotazioni riferite dalla Sand come «utiles du point de vue musical», secondo cui Chopin e la Viardot sarebbero stati per ore intenti a studiare e trascrivere le frasi melodiche dei cantori popolari francesi22. Certamente è da Nohant e dalla collaborazione stretta tra Chopin e la Viardot che nasce l’idea di adattare alle mazurche dei testi poetici sullo stile popolare della chanson23. La prima testimonianza dell’avvenuta realizzazione di questo ‘esperimento musicale’ la troviamo nella critica inglese, che recensisce un «Grand Concert» tenutosi al Covent Garden di Londra il 12 maggio 1848, in cui la Viardot figura come cantante e pianista nelle sue trascrizioni delle Mazurche di Chopin. L’articolo riporta in modo molto dettagliato l’intero programma e indica le Mazurche tra le novità più interessanti del concerto. Su The Musical World (domenica, 13 maggio, 1848) si legge:
18. Waddington, Patrick. The Musical Works […], op. cit. (si veda nota 2), pp. 11-25.19. Tiersot, Julien. La chanson populaire et les écrivains romantiques, Parigi, Plon, 1931.20. Sand, George. Correspondance, a cura di Georges Lubin, 26 voll., Paris, Garnier, 1964-1987, vol.
ix???, pp. 839 e 840 nota 1; vol. xii???, p. 264.21. Poupet, Michel. ‘Pauline Viardot à Nohant’, in: Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria
Malibran, n. 12 (1988), pp. 163-167.22. Tiersot, Julien. Op. cit. (si veda nota 19), p. 160. Cfr. Vierne, Simone. ‘George Sand, Pauline
Viardot, et la chanson populaire’, in: Hommage à George Sand: pour le 175e anniversaire de sa naissance 1804-1979, (Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran, n. 3 [1979]), pp. 42-55.
23. Kobyla�ska, Krystyna. ‘Transkrypcje Mazurköw Chopina’, in: Zycie Spiewacze, voll. v-vi (1951), p. 8. Shuster, Carolyn Jean. ‘Six mazurkas de Frederic Chopin transcrits pour chant et piano par Pauline Viardot’, in: Revue de Musicologie, lxxv/2 (1989), pp. 265-283.
8
Mariacarla De Giorgi
Delle Mazurche non possiamo parlare con entusiasmo, sebbene per l’ultima sia stato richiesto il bis. Mad. Viardot ha scelto quella in Sol diesis minore e quella in Si bemolle, l’una triste e l’altra allegra, (presumo) entrambe tratte dall’Op. 6, e le ha cantate con grande esprit e con eccezionale delicatezza di sentimenti, dimostrandosi pianista dotata e abile nello stile in cui ha eseguito l’accompagnamento. Tuttavia non possiamo credere che la voce umana sia più del pianoforte lo strumento espressivo in grado di rendere bella e interessante della musica brutta e leziosa, e mentre ammiriamo Mad. Viardot per l’intelligenza con cui ha saputo tirar fuori qualcosa da sì fiacca materia, dobbiamo rimproverarne il gusto nell’averla scelta24.
La critica è nell’insieme positiva nei confronti della trascrizione della Viardot, ma decisamente negativa nei confronti delle Mazurche di Chopin. Questo è un fatto assai rilevante perché lo stesso Chopin attesta più volte nella sua corrispondenza l’incomprensione del pubblico inglese nei confronti della sua musica. Abbiamo più lettere, datate tra il 13 maggio e il 7 giugno del 184825, in cui Chopin parla della consuetudine della Viardot di cantare le sue Mazurche in concerto. In una di queste lettere, datata al 30 giugno 1848 e indirizzata a M.lle de Rozières26, Chopin lamenta l’ingiustizia della critica inglese nei suoi confronti, sottolineando il fatto che nei programmi da concerto della Viardot ormai non risulta più scritto «Mazurche di Chopin», ma semplicemente «Mazurche arrangiate da Mme Viardot», e giustificandolo con la volontà della giovane interprete di avere successo, spaventata da alcuni giornali inglesi che non amano affatto le composizioni chopiniane. E scrive:
Nei programmi non figura più la menzione «Mazourkas de Chopin», ma solamente «Mazourkas arrangés par Mme Viardot», che sembra andar meglio. Per me è lo stesso, ma c’è meschinità dietro questa affermazione. Un giornale riferisce che lei ha cantato la musica di un certo M. Chopin, che nessuno conosce e che farebbe meglio a cantare qualcos’altro27.
24. Si riporta il testo originale: «Of the Mazourkas we cannot speak so warmly, although the last was encored. Mad. Viardot selected the G sharp minor, and the B flat, one tristful the other gay, both (we believe) from the 6th book. She sang these with great esprit and the utmost delicacy of sentiment, and proved herself a ready and skilful pianist by the style in which she executed the accompaniments. But we cannot allow that the human voice can be the medium of making ugly and affected music pretty and engaging any more than the pianoforte, and while admiring Mad. Viardot’s cleverness in making anything out of such dull matters, we must arraign her taste for selecting them»; Kendall-Davies, Barbara. ‘Pauline Viardot Garcia en Angleterre’, in: Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran, n. 22 (2000), pp. 58-79.
25. Correspondance de Frédéric Chopin, edita e tradotta da Edward Bronisław Sydow, 3 voll., Parigi, Richard-Masse, 1953-1960, vol. iii: La gloire, 1840-1849, pp. 343, 346-347.
26. Chopin, Fryderyk. Selected Correspondence, scelta e annotata da Edward Bronisław Sydow, tradotta e curata da Arthur Hedley, Londra, Heinemann, 1962, p. 322. Cfr. Eigeldinger, Jean-Jeacques. Op. cit. (si veda nota 1), p. 188.
27. Correspondance de Frédéric Chopin, op. cit. (si veda nota 25), vol. iii, La gloire, 1840-1849, p. 355.
9
Pauline Viardot-Garcia e la poetica della chanson populaire…
Infine, in una lettera indirizzata ad Albert Grzymalà dell’8 luglio 1848, Chopin parla di un suo concerto realizzato insieme con la Viardot presso Lord Falmouth il 7 luglio, in cui «la Viardot, ha cantato puntualmente le mie Mazurche»28. I testi di queste prime trascrizioni sono spagnoli come si può dedurre da una recensione su Revue de deux mondes sempre del 1848, in cui si legge «la Viardot ha trascritto per voce le Mazurche di Chopin e scritto le parole in spagnolo»29. È certo che dal ’48 in poi le «Mazurche nell’arrangiamento di Mme Viardot» si diffondono rapidamente nei salotti parigini, come dimostra il programma di una Matinée di beneficenza, organizzata da Madame Scribe il 3 maggio 1849, conservato presso il Musée de Dieppe, in cui le Mazurche figurano nel repertorio accanto alle arie spagnole, poste in ‘posizione strategica’ a conclusione della prima e della seconda parte musicale del concerto, proprio grazie all’entusiastica approvazione del pubblico parigino, e non solo30 (Ill. 1).
Ill. 1: Copia del programma di una Matinée di beneficenza, organizzata da Madame Scribe nel suo salotto parigino, il 3 maggio 1849, conservata in Cliché Collections del Musée de Dieppe, corredata da una trascrizione, che ne permetta una più agevole lettura.
28. Ibidem. Cfr. Shuster, Carolyn Jean. Op. cit. (si veda nota 23), p. 270.29. Revue de deux mondes, i (1848), pp. 406-415.30. Delacroix, Eugène. Journal, a cura di André Joubin, 3 voll., Parigi, Plon, 1932, vol. ii, p. 316.
10
Mariacarla De Giorgi
Una testimonianza assai importante riguardo ai testi spagnoli delle trascrizioni è quella di Ferdinand Hiller, che, nel primo capitolo «Vierzehn Tage in Paris (1851)» tratto da Aus dem Tonleben unserer Zeit (1868)31, racconta di una Matinèe presso la Salle Herz nell’estate 1851, in cui «Mad.me Viardot ha cantato alcune deliziose Mazurche di Chopin, da lei corredate da testi spagnoli, con arte davvero geniale». Hiller pone in evidenza il legame sentimentale tra le culture popolari slave e latine, sottolineando come «le melodie del poetico artista polacco» formino «una meravigliosa unione armonica con le parole spagnole» e la straordinaria vivacità meridionale della declamazione propria della famosa cantante, testimoniando in questa forma, quanto maggiore sia la vicinanza tra spirito slavo e latino, che non tra quello slavo e germanico32.
Il legame originario delle trascrizioni con il testo spagnolo è dunque bene attestato fino al 1858, come testimonia anche la stampa ungherese di Hölgyfutàr33 e del Pest-Ofner Zeitung del 19 novembre 185834 in occasione di un concerto tenuto dalla Viardot insieme con Clara Schumann presso la Salle Europe di Pest, di cui i giornali riportano il programma, che presenta, accanto ad alcuni Phantasiestücke di Schumann e alle Danze ungheresi di Brahms, una Mazurca di Chopin «nella trascrizione per canto di Pauline Viardot, testo spagnolo», sottolineandone il grande successo di pubblico, quale brano più acclamato dell’intero concerto35. D’altra parte la stessa Viardot attesta nel suo epistolario con Julius Rietz, in una lettera del 23 dicembre 1858, l’esecuzione delle sue trascrizioni delle Mazurche a Weimar, presso la residenza di Altenburg alla presenza di Liszt e della principessa di Wittgenstein, in occasione di una Soirèe in suo onore organizzata il giorno precedente, riferendo: «poi
31. Hiller, Ferdinand. Aus dem Tonleben unserer Zeit, 2 voll., Lipsia, H. Mendelssohn, 1868. 32. Ibidem, vol. i, p. 54: «Madame Viardot-Garcia sang einige jener reizenden Mazourkas von Chopin,
welchen sie mit wahrhaft genialer Kunst spanischen Text untergelegt hat. Die Melodien des poetischen Polen bilden ein wunderbar harmonisches Ensemble mit den tönenden spanischen Worten und der südlichen Lebendigkeit des Vortrages der gefeierten Sängerin, und legen in dieser Gestalt ein Zeugniß ab, wie viel mehr verwandtschaftliche Elemente zwischen Slawen- und Romanen-, als zwischen Slawen- und Germanenthum». Un errore palese della Shuster nella traduzione di Hiller crea nel suo contributo sulle trascrizioni delle Mazurche un forte equivoco sulla cronologia dei testi delle trascrizioni, «écrits d’abord en français» dal Pomey (che nel 1851, data del concerto menzionato da Hiller, avrebbe avuto solo 16 anni!). Convinta che sia Hiller a sbagliare e che mai sia esistita una versione in spagnolo, scrive: «Pauline Viardot a chanté ces Mazurkas avec un texte espagnol écrit par un poète polonais [sic, Hiller specifica chiaramente il nome di Chopin in riferimento alle Mazurche e lo definisce poeta polacco in riferimento alle melodie e non certo al testo, attribuito chiaramente all’arte geniale della Viardot, che era d’origine spagnola]. Malgré cette description, le veritable auteur de ce texte, Louis Pomey, était français. F. Hiller a sûrement confondu ces Mazurkas avec Les chansons espagnoles composée par Pauline Viardot»; Shuster, Carolyn Jean. Op. cit. (si veda nota 23), p. 271.
33. Hölgyfutàr, ix/273 (1858), p. 1091, cfr. Pándi, Marianne. Száz esztendö magyar zenekritikája, Budapest, Zenemükiadó Vállalat, 1967, p. 93.
34. Pest-Ofner Zeitung, no. 274 (1858), cfr. Hamburger, Klara. Op. cit. (si veda nota 1), pp. 197-198.35. La stampa di Pest menziona la Viardot come allieva di Liszt e riferisce della Mazurka di Chopin in
programma: «Chopin: Mazurka dans la transcription pour chant de Pauline Viardot, texte en espagnol (pièce qui eut le plus grand succès, elle fut bissée)».
11
Pauline Viardot-Garcia e la poetica della chanson populaire…
ho concluso con le Mazurche che hanno fatto saltare Liszt dalla sedia»36. Tutte queste testimonianze supportano l’ipotesi di una prima fase delle trascrizioni, legate alla lingua spagnola fino alla fine degli anni ’50, e di una definitiva versione in lingua francese, pubblicata del 1864, in collaborazione con Louis Pomey quale autore dei testi poetici in francese. Il Pomey d’altra parte non avrebbe potuto scrivere la sua versione francese negli anni precedenti, considerata la sua giovane età (era nato nel 1835 a Parigi). Inoltre, è solo dal 1863 che lo troviamo in contatto con la famiglia Viardot trasferitasi a Baden-Baden dopo il ritiro dalla scena di Pauline, che nella città tedesca, dove rimarrà fino al 1870, si dedica all’insegnamento e alla composizione37. In questo periodo nascono una serie di importanti trascrizioni per canto, tutte su testi francesi di Pomey, e le operette su testo di Turgenev, alla cui versione francese probabilmente collabora anche Pomey, come risulta dagli epistolari38, operette come L’ogre (1865), Trop de femmes (1866) e Le dernier sorcier (1867), rappresentate poi presso il teatro privato dei Viardot, detto ‘Le théâtre de Tiergarden’. E proprio in Le dernier sorcier del 27 settembre 1867 troviamo Pomey attivo come baritono nel ruolo di Krakamiche, l’ultimo mago. Pomey, oltre che buon ‘facitore di versi’ e cantante amatore, è anche un bravo pittore, ritrattista, miniaturista della scuola di Gleyre, particolare questo importante in riferimento alle Mazurche, considerate nella loro recezione come «tableaux de chevalet», secondo la definizione di Liszt nel suo Chopin39. L’interpretazione di Liszt è supportata poi anche da Lenz, suo allievo, nell’articolo pubblicato su Neue Berliner Musikzeitung del 187240, dove si parla delle Mazurche come «quadri a pastello», per l’amore verso il dettaglio rivelato da Chopin, che riversa tutte le sue energie in un «Gesangstyl», proprio dell’articolazione melodica dei temi. Lenz considera le Mazurche di Chopin come il «diario di viaggio della sua anima attraverso l’amata Polonia», il cui sentimento nazionale si irradia in forma musicale nei salotti di Parigi, visti dal compositore quale podio ideale, «piattaforma politica» del suo patriottismo.
In quest’ottica della mazurca quale bozzetto poetico-musicale del folklore nazionale polacco, interessante è comprendere quale sia stato l’approccio stilistico-formale della Viardot nelle sue trascrizioni41. La forma adottata dalla compositrice resta fedele alla
36. Nell’articolo di Baker, Theodore. ‘Pauline Viardot Garcia to Julius Rietz (Letters of Friendship)’, in: The Musical Quarterly, i/3 (1915), pp. 350-380: 363 è riportato il passo della lettera a Rietz, in cui la Viardot riferisce: «puis j’ai terminé par les Mazourkas qui ont fait sauter Liszt sur sa chaise».
37. Stegemann, Michael. Op. cit. (si veda nota 9), pp. 91-101; Draheim, Joachim. ‘Pauline Viardot-Garcia: Eine universelle Musikerin’, in: Pauline Viardot in Baden-Baden und Karlsruhe, a cura di Ute Lange-Brachmann e Joachim Draheim, Baden-Baden, Nomos, 1999 (Baden-Badener Beiträge zur Musikgeschichte, 4), pp. 18-21.
38. Bumiller, Lambert. ‘«Bonjour, meine liebste, theuerste Freundinn!» Pauline Viardot-Garcia und Iwan Sergejewitsch Turgenjew im Spiegel ihrer Briefe’, in: ibidem, pp. 123-156.
39. Liszt, Franz. F. Chopin, Lipsia, Breitkopf & Härtel, 61923, p. 68.40. Lenz, Wilhelm von. Op. cit. (si veda nota 5), p. 86. 41. Power, David, ‘Musical-Literary Intertextuality: George Sand and Franz Liszt’, in: Correspondances.
Studies in Literature, History, and the Arts in Nineteenth-Century France. Selected Proceedings of the Sixteenth
12
Mariacarla De Giorgi
versione di Chopin, a parte il fatto che la Viardot tralascia le riprese a più parti di alcune sezioni delle Mazurche chopiniane, facendo tuttavia ampio uso di cadenze virtuosistiche, che sottolineano qui la funzione del canto, quale libera espressione del sentimento. Per comprendere meglio il rapporto Viardot-Chopin, prenderò in considerazione, come validi esempi dell’approccio individuale della compositrice al modello del maestro, due trascrizioni, che rispondono al n. 3 del primo ciclo da 6 Mazurche, pubblicato nel 1864, e al n. 7 del secondo ciclo, pubblicato l’anno successivo nel 1865. Il n. 3 Plainte d’amour, trascrizione della Mazurca Op. 6 n. 1, rispecchia quello che è l’atteggiamento dominante
Colloquium in Nineteenth-Century French Studies, the University of Oklahoma, Norman, October 11th-13th, 1990, a cura di Keith Busby, Amsterdam-Atlanta (GA), Rodopi, 1992 (Faux titre, 63), pp. 165-176.
Es. 1a: Chopin, Mazurca Op. 6 n. 1 in Fa# minore.
13
Pauline Viardot-Garcia e la poetica della chanson populaire…
nelle 12 Mazurche, ossia il rispetto della forma originaria, che qui si presenta in forma tripartita ampliata, da rondeau, nell’articolazione A-B-A-C-A, pur se ornata da abbellimenti e delimitata nell’articolazione formale interna da cadenze (Es. 1).
Il testo struttura il ritornello sulla sezione A, restando nella versificazione fedele all’accentuazione ritmica del modello, qui caratterizzato dall’accento sul terzo tempo di battuta, mentre le sezioni B e C lasciano maggior spazio all’espressività del canto e all’improvvisazione, prendendo così la funzione di episodi (Es. 2). D’altra parte la Consuelo della Sand aveva ben definito il ruolo dell’improvvisazione nell’estetica della chanson populaire, considerandola come simbolo della libertà d’espressione del sentimento poetico, che grazie a essa si trasmette dall’anima dell’artista alle labbra del cantante e sulle punte delle dita dell’esecutore42.
42. Sand, George. Consuelo, vol. ii (1861), cap. ???, pp. 50-51, nell’edizione citata a nota 4: «Essayez-vous à improviser, tantôt sur le violon, tantôt avec la voix. C’est ainsi que l’âme vient sur les lèvres et au bout
Es. 1b: Chopin-Viardot, Mazurca n. 3, Plainte d’amour in Fa minore.
14
Mariacarla De Giorgi
La Mazurca successiva intitolata La Féte esce fuori dal gruppo, rappresentando uno dei brani in assoluto più significativi della raccolta, perché ben testimonia la concezione estetica individuale della trascrizione per voce della Mazurca. Qui la Viardot cambia il colore del brano, spostando la tonalità originaria di un semitono più in alto, conferendo ai temi melodici un colore più chiaro, dovuto al passaggio dal Mib minore con i suoi sei bemolli in chiave, al Mi minore con il solo fa# nella versione vocale. Pur rimanendo fedele al modello, La Fête mette in evidenza l’apporto individuale della Viardot in relazione al modello stringato, conciso del maestro, che restituisce in questo brano la mazurca nella sua quintessenza di danza popolare. Lo schema formale nella composizione di Chopin è
des doigts». Powell, David A. While the Music Lasts. The Representation of Music in the Works of George Sand, Lewisburg-Londra, Bucknell University Press-Associated University Presses, 2001, pp. 73-75.
Es. 2: Si riporta il testo poetico di Louis Pomey, accompagnato dalla stuttura formale, seguita dalla Viardot nella sua trascrizione della mazurca di Chopin.
Plainte d’amour
Chère âme, sans toi j’expire, Pourquoi taire ma douleur? Mes lèvres veulent sourire Mes yeux disent mon malheur. Hèlas! Loin de toi j’expire, Pourquoi taire… Que ma cruelle peine, de ton âme hautaine Désarme la rigueur. Hèlas! Loin de toi j’expire, Pourquoi taire… Cette nuit dans un rêve, je croyais te voir; Ah, soudain la nuit s’achève, Et s’enfuit l’espoir. Ah! Chère âme, sans toi j’expire, Pourquoi …
Hèlas! Loin de toi j’expire, Pourquoi … Je veux sourire Hèlas! La mort, la mort est dans mon coeur.
A (sezione principale -tema della mazurca)
A1 (ripresa variata del tema della mazurca)
B (primo episodio della mazurca)
A (ripresa del tema)
C (secondo episodio della mazurca)
A (ripresa del tema)
A1 (ripresa variata del tema della mazurca)
15
Pauline Viardot-Garcia e la poetica della chanson populaire…
breve ed essenziale, riprendendo la semplice forma tripartita A-B-A propria del Volkslied. Il riferimento nella trascrizione per canto alla dimensione popolare di festa del villaggio è reso immediato nell’introduzione pianistica al brano, che ripropone il tema della Mazurca all’unisono, per poi intonare il ritornello, qui costituito dall’intera Mazurca nell’articolazione delle sue tre sezioni A-B-A — ritornello che assicura quanto piacerà al ‘suo maestro di mazurca’ questo semplice ‘fiore novello’, che abbellisce e dà grazia alla danza (Es. 3).
Segue una nuova sezione C della Viardot, inesistente nel modello, che nell’andamento cantabile della melodia e dell’accompagnamento lascia spazio all’espressione dei sentimenti suscitati dalla mazurca che «da lontano comincia» come segnala la semplice intonazione musicale (‘la, la, la, la, la’) con cui la cantante introduce i primi due versi indicando l’inizio solitario del maestro, ancora senza parole, quale maestro indiscusso della mazurca (‘senza di me, lui la danza, lui che nessuno supera in questo ballo’). Si ripete poi il ritornello, preludio di una nuova sezione articolata in D-D
1-E, come la precedente C inesistente nel modello,
in cui la musica, resa indipendente dalla forma, esprime nel canto l’ebbrezza delle emozioni
Es. 3a: Chopin, Mazurca Op. 6 n. 4 in Mib minore.
16
Mariacarla De Giorgi
Es. 3b: Chopin-Viardot, Mazurca n. 7, La Fête in Mi minore.
suscitate da questa danza, che come in un sogno d’amore tiene unita la coppia dei ballerini, consapevoli della fugacità dell’istante felice, che ‘s’avanza troppo presto’, nonostante la raccomandazione del maestro nella sua mazurca, connotata da Chopin con l’indicazione di tempo Presto, ma non troppo (Es. 4). Il testo evidenzia ripetutamente non solo un chiaro collegamento alla mazurca, ma anche alle differenti sfere emozionali suggerite dalla danza, come la gioia dell’attesa per la festa del villaggio, annunciata in lontananza dalle note di danza, poi il momento appassionato del ballo, vissuto in tutta la sua intensità seduttiva come in una dimensione da sogno, che permane indelebile nel ricordo, quando alla fine della festa si ritorna a casa. E mentre i canti di danza si concludono in cadenza, la mazurca, ormai nel cuore dei suoi esecutori, è ripresa per l’ultima volta, quasi nel desiderio di portarla con sé anche in sogno, insieme ad alcuni suoi frammenti, simbolizzati con la stessa intonazione vocale dell’inizio (‘la, la, la, la’), che ritorna come reminiscenza a simboleggiare il nucleo puramente melodico della danza.
17
Pauline Viardot-Garcia e la poetica della chanson populaire…
Es. 4: Il testo poetico di Louis Pomey è riportanto insieme all’articolazione formale, in cui la Viardot struttura la sua trascrizione della Mazurca Op. 6 n. 4 in Mib minore, ampliandone decisamente le dimensioni.
La Fête Le village est tout en fête, À danser chacun s’apprête, Cette rose à mon corsage Va lui plaire, je le gage, Cette simple fleur nouvelle À ses yeux va me rendre belle. Le village est tout en fête, Vite, il faut que je m’apprête. La la la la. La mazourke au loin commence, La la la la. Et sans moi, voilà qu’il danse! Qu’il est beau, qu’il a de grâce! Nul au bal le surpasse. Le village est tout en fête, … Quelle charme, quelle ivresse! Lorsqu’avec tendresse, Dans ses bras il me presse! Le plus doux rêve, tous deux unis, Au monde nous enlève. Quelle charme, quelle ivresse Lorsqu’avec tendresse, Dans ses bras il me presse, Je respire à peine Quand au logis, le soir, il me ramène. La nuit trop tôt s’avance, Hèlas! trop tôt s’avance, Et les airs de danse expirent en cadence Le bien-aimé soupire, Lorsqu’au logis il vient me conduire! Ah! Mais Dieu sait à quoi je rêve! La mazourke, hèlas, s’achève, Ah! Du bonheur l’instant s’avance, Ne songeons plus qu’à la danse, La la la la la la!
A (sezione principale -tema della mazurca)
B (1° episodio della mazurca)
A (ripresa del tema)
C (2° episodio inesistente nella mazurca)
A-B-A (ripresa della mazurca)
D (3° episodio non presente nella mazurca)
D1 (ripresa variata del 3° episodio)
E (nuovo episodio non presente nella mazurca e con cadenza finale)
A-B1-c-d (ripresa variata di mazurca ed episodi )
18
Mariacarla De Giorgi
Da questa analisi emerge in tutta la sua profondità la concezione estetica della trascrizione, in cui la musica del maestro nella sua forza evocativa prende corpo nel canto attraverso la poesia, che trascolora le melodie in pitture del sentimento, secondo il modello romantico della perfetta simbiosi tra le arti. Questo ci permette di condividere le parole di Liszt, che nel famoso articolo sulla compositrice, pubblicato nel 1859 sulla rivista Neue Zeitschrift für Musik, parla di una «Stylerhöhung» propriamente attuata dalla Viardot con l’esaltazione del lirismo nella trascrizione delle opere del maestro, sublimate, in tutte le loro più sottili sfumature di colore, dal suo straordinario virtuosismo, che ne rivela la dimensione di artista sovranazionale, capace di comprendere le emozioni più segrete dei grandi compositori, di indagarne le forme nella loro essenza e nei loro caratteri nazionali, e di trasmettere attraverso il canto quella poesia del sentimento comune a tutti i popoli e le nazioni43.
43. Liszt, Franz. ‘Pauline Viardot-Garcia’ (1859), in: Neue Zeitschrift für Musik, l/5 (28 gennaio 1859), pp. 49-54. Si veda anche Id. ‘Pauline Viardot-Garcia’, in: Cahiers Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot, Maria Malibran, n. 10 (1986), pp. 88-98.