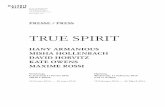The Cult of True Womanhood
Transcript of The Cult of True Womanhood
The cult of true womanhood
Relatrice Eva Brozzetti
Docente Bruna Bianchi
Matricola 850882
Corso di Laurea in Storia dal medioevo all’età contemporanea
1
PREMESSA
Il cuore dell’approfondimento che è l’oggetto della presente relazione, ruota intorno
alle vite di quelle donne che nell’America dei decenni che precedettero la guerra civile,
attraverso il loro variegato contributo alla causa abolizionista, contribuirono a minare la
saldezza della visione, allora dominante, del ruolo della donna nella società. In un arco
di tempo relativamente breve, che va dagli anni Trenta dell’Ottocento allo scoppio
della guerra civile, vennero gettate le basi non solo della futura emancipazione del
popolo afroamericano ma anche della strumentazione pratica e concettuale di tutti i
successivi movimenti di disobbedienza civile. Concetti e pratiche quali non violenza,
resistenza passiva, consumo critico, boicottaggio videro in quella fase una elaborazione
precoce. Anche, ove non soprattutto, in ambiti e contesti di donne.
Quel culto che le voleva relegate nel ruolo di angeli del focolare domestico e prevedeva
la separazione delle sfere d’azione tra i due universi di genere era diffuso
trasversalmente, anche all’interno dei circoli abolizionisti, e fu proprio la controversia
sul ruolo delle donne nel movimento a sancire, nel 1840, la scissione dell’ American
Anti-Slavery Society. Sostenute dal fervore religioso e dalla fede nella giustizia della
causa per la liberazione dalle catene della schiavitù, molte di queste attiviste trovarono
la forza di battersi contro i tabù, i giudizi sociali, le idealizzazioni che vietavano loro, ad
esempio, di prendere parola in pubblico.
Il nodo che mi interessa sviluppare è quello delle connessioni, nel pensiero politico
delle protagoniste di questa vicenda, tra le due lotte: quella del femminismo in nuce e
quella, trainante, per la liberazione di un popolo oppresso. A partire da che punto i due
percorsi si sovrappongono, dove, invece, confliggono; in quale grado emerge, negli
scritti e nelle testimonianze prese in considerazione, la consapevolezza che l’ingiustizia
che afflige il popolo di schiavi è la stessa che nega l’uguaglianza tra i generi; la
consapevolezza dell’essere «bound with them in chains1». In che misura questa
comunanza d’orizzonti abbia reso più o meno intenso l’apporto delle donne alla causa
abolizionista resta da valutare caso per caso: difficile ridurre ad un’unica interpretazione
1� Prendo qui in prestito il titolo di una monografia sulla storia del movimento abolizionista edita nel 1972,
di Jane H. Pease e William H.Pease citata in Ellen Ginzburg Migliorino, Donne contro la schiavitù. Le abolizioniste americane prima della Guerra Civile, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita, 2002, p.50.
2
la complessa stratificazione di sensibilità e approcci che ognuna delle partecipanti ha
sperimentato. Diversissime per grado di istruzione, ceto sociale di appartenenza e,
fattore ancor più discriminante, per colore della pelle, le donne, le cui storie andiamo ad
indagare, alla luce di uno sguardo retrospettivo, possono dirsi accomunate dall’aver
ampliato e rivoluzionato, con il loro esempio, il significato della locuzione «true
womanhood2».
Per lo spazio concessomi in questa sede ho ritenuto opportuno dopo una veloce
disamina dell’apporto femminile alla causa su vasta scala 3 concentrarmi sull’analisi dei
nessi sopracitati all’interno di due opere in particolare. Mi riferisco ad «Appeal to the
Christian Women of the South» di Angelina Emily Grimké ed alle «Letters on the
Equality of the Sexes» di Sarah Moore Grimké. Il percorso di vita nonché del pensiero
delle due sorelle della South Carolina mi è apparso particolarmente significativo
nell’ambito del quadro generale e delle connessioni fra abolizionismo e nascente
identità di genere.
L’occasione di questo approfondimento mi è stata fornita da un primo incontro,
maturato nel periodo delle lezioni, con il saggio introduttivo al pensiero della non-
violenza4 della professoressa Bianchi, presentato nell’arco delle stesse. La questione di
come il tema dell’emancipazione femminile sia emerso, già alla fine degli anni Trenta,
rappresenta uno degli aspetti trattati, teso a sottolineare la rilevanza dell’apporto delle
donne all’interno delle fila del movimento fondato da William Lyoyd Garrison che,
seppur non ottenne l’abolizione della schiavitù, di certo segnò un inizio molto
2� Il titolo del presente lavoro fa riferimento ad una monografia di Barbara Welter, The Cult of TrueWomanhood 1820- 1860 vedi Barbara Welter, American Quarterly, Vol. 18, No. 2, Part 1 (Summer, 1966),pp. 151-174,The Johns Hopkins University Press, http://www.jstor.org/stable/2711179. Il culto delle «donnevere», per come è presentato dall’autrice, le vuole ancorate a quattro virtù cardinali: devozione, purezza,docilità e attaccamento alla vita familiare. L’autrice argomenta che alla metà del diciannovesimo secolo,nello stravolgimento esistenziale prodotto dalla rivoluzione industriale e dalle sue conseguenze sulla vitasociale, il culto della donna come madre, relegata all’ambiente domestico, svolgeva il ruolo di punto fermoin una società, per altri aspetti, in continuo mutamento.
3� Il riferimento d’obbligo è ai percorsi tracciati da Ellen Ginzburg Migliorino in Donne contro la schiavitù,
cit.
4� Bruna Bianchi, Introduzione al pensiero della non violenza (1830-1968) in Agire la nonviolenza.
Pensiero e politiche. Prospettive di liberazione nella globalizzazione , atti del Convegno tenutosi a San Servolo (Venezia) nel febbraio2004, Punto Rosso, Roma 2004, pp. 13-71.
3
promettente nella definizione delle modalità di lotta e nella radicalità della loro
applicazione.
Un contributo esteso all’inquadramento storico nonché alla definizione dei principali
nodi problematici nel lungo percorso di emancipazione degli afroamericani, con
particolare attenzione al periodo anteriore alla guerra civile, è dato dalla studiosa italo-
americana Ellen Ginzburg Migliorino, il cui lavoro, che riporto dettagliatamente in
bibliografia, rappresenta una tappa imprescindibile, nell’orizzonte nazionale, per
chiunque desideri accostarsi all’argomento. Merito della studiosa è, anche, quello di
aver evidenziato come all’interno del movimento abolizionista sia maturata la definitiva
presa di consapevolezza delle donne rispetto alla loro condizione di inferiorità nel
decennio che va dalla prima Antislavery Convention of American Women di New York
del 1837 alla Seneca Falls Convention del 1848, pietra miliare del movimento per i
diritti civili delle donne negli Stati Uniti d’America. Il riferimento a Migliorino è
d’obbligo per la definizione della bibliografia essenziale sul tema5che rimane,
principalmente, in lingua inglese.
In lingua italiana un apporto più recente anche se meno circoscritto è quello della
studiosa Silvia Benussi che dedica alle donne abolizioniste un capitolo della monografia
in cui prende in esame nel medio periodo, l’apporto femminile al movimento per i diritti
civili, arrivando a comprendere gli anni Novanta del secolo scorso6.
L’utilizzo della rete, nell’affrontare un tema i cui documenti 7 sono depositati presso
istituzioni statunitensi si è rivelato indispensabile nonché formativo. Il motore di ricerca
«Internet Archive» mette a disposizione un vastissima mole di documenti digitali, tra
cui patrimonio appartenente alle collezioni delle maggiori biblioteche universitarie
americane e canadesi fornendo facile e libero accesso a manoscritti originali e alla
5� Mi riferisco in particolare a Ellen Ginzburg Migliorino,L’emancipazione degli afroamericani. Il dibattito
negli Stati Uniti prima della guerra civile, Milano, FrancoAngeli, 1989, pp. 174-176. E ID., Donne contro la schiavitù, cit., pp. 141-148.
6� Silvia Benussi, Le donne afroamericane negli Stati Uniti. La lunga lotta per i diritti civili, Milano,
FrancoAngeli, 2007, pp.25-30.
7� Faccio riferimentoalle memorie epistolari intercorse tra i vari protagonisti della vicenda, agli Atti dei
Convegni e agli Appelli che furono redatti dalle sorelle Grimké.
4
digitalizzazione delle stampe relative all’epoca e all’argomento che in questa sede ci
interessa. Per un’approfondimento sullo stato della riflessione accademica in materia,
negli Stati Uniti, mi sono avvalsa della possibiltà di consultare la collezione digitale
«JSTOR» offerta dall’Università Ca’Foscari. Infine, il sito della Biblioteca del
Congresso mette a disposizione una vasta gamma di materiali tra cui ho rinvenuto i
verbali delle sedute della seconda Anti-Slavery Convention of American Women,
tenutasi a Philadelphia nel maggio del 18388. Nel complesso il catalogo online della
Biblioteca del Congresso rappresenta un modello ineguagliato di impegno nella
condivisione del patrimonio storico-culturale di una nazione. L’istituzione fu fondata
nel 1800 da John Adams, secondo presidente degli Stati Uniti d’America, marito di
quella Abigail Adams che già alla fine del Settecento denunciava l’ingiustizia
dell’esclusione delle donne e degli schiavi dal godimento dei diritti sanciti dalla
Costituzione9.
8� In Library of Congress, Rare Book and Special Collection Division, Votes for Women. Selections from the
National American Woman SuffrageAssociation Collection, 1848-1921, Anti-Slavery Convention of American Women, Philadelphia 1838.
9� Come riporta Ellen Ginzburg Migliorino, Donne contro la schiavitù, cit.,p.16.
5
TERRITORI CONFLITTUALI
Nella definizione del territorio come spazio attraverso il quale questa vicenda si
dispiega ho ritenuto opportuno prendere le mosse dall’immagine che ritrae la situazione
conflittuale degli Stati Uniti all’alba della guerra di secessione. Innanzitutto per chiarire
le dimensioni non solo fisiche ma anche politiche del contendere: gli stati schiavisti
segnano una compatta unità geografica disposti come sono in tutta l’area sud orientale
del paese. Tale conflittualità aveva radici ideologiche e culturali di lungo periodo che si
legavano alla tipologia e all’estrazione dei primi gruppi che colonizzarono la costa
orientale degli Stati Uniti11e che, alla metà del diciannovesimo secolo si era
10� Da Treccani.it, Enciclopedia italiana online
URLhttp://images.treccani.it/enc/media/share/images/orig//system/galleries/NPT/VOL_9/IMMAGINI/StatiUnitidxAmerica_04.jpg
11� Confronta Raimondo Luraghi, Storia della guerra civile americana, Torino, Einaudi, 1966, pp. 20-41.
6
istituzionalizzata in una profonda scissione di natura economica, tra un Nord proiettato
verso l’industrializzazione ed un sud prevalentemente agricolo, dove le grandi
piantagioni di cotone e tabacco dominavano il paesaggio e l’assetto produttivo. E, di
natura politica, tra un Nord tendenzialmente federalista, convinto della necessità di un
forte governo centrale e improntato su un etica calvinista del lavoro e un Sud
autonomista, dove il senso della collettività, anche in virtù dell’abbondanza di spazio e
della tipologia d’insediamento sparso ed isolato, era sacrificato ai valori di un
individualismo spiccato.
L’esperimento democratico americano12 arriva, con l’elezione di Lincoln a presidente
dell’Unione, a confrontarsi con la sua prima grande sfida a meno di cento anni dalla
rivoluzione indipendentista che ne aveva decretato l’inizio. Non è questa la sede per
affrontare nel dettaglio la complessità delle ragioni e degli esiti di questo scontro
interno a quella che, in ogni caso, nell’epoca in cui si svolsero i fatti, rimaneva una
società ad alto tasso di democrazia, almeno in germe13. Senz’altro il tema della schiavitù
e della sua abolizione costituisce uno dei fattori esacerbanti del conflitto, se non quello
portante. La condanna di quest’istituto tanto iniquo quanto antico nelle società umane,
era iniziata a maturare già da lungo tempo all’interno delle coscienze di uomini e donne
che vissero quella stagione: i più illuminati pensatori che condannarono la schiavitù,
appartenevano a quel Sud che dalla schiavitù era dipendente; entrambi virginiani, erano
essi stessi grandi proprietari oltre ad essere due dei Founding Fathers della nazione. Sia
Washington che Jefferson si erano pubblicamente pronunciati contro la schiavitù 14, pur
prevendone un’abolizione graduale.
La genesi e lo sviluppo del movimento abolizionista corre anch’essa il rischio di esser
meglio compresa, qualora costantemente riferita ai territori che ne furono lo scenario.
Occorre innanzitutto precisare che è negli stati del Nord del paese, dove la schiavitù era
già stata abolita, per fattori contingenti, non di certo per una questione di moralità, che
12� Così definito in Arthur M.Schlesinger Jr, I cicli della Storia americana, trad. it. di [Isabella Casabianca],
Pordenone, Studio Tesi, 1991.
13� Alexis De Toqueville, De la démocratie en Amérique, douzième édition, Paris 1848, 4 volumi; vol. I,
p.35.
14� Raimondo Luraghi, Storia della guerra civile americana,cit., pp.70-71.
7
nasce l’abolizionismo militante intorno alla figura di William Lloyd Garrison,
intellettuale new-englander, figlio di un capitano di mare, che nel 1831 dà alle stampe il
primo numero di «The Liberator» a Boston, nel Massachussets 15. Verso il miraggio di
un Nord portatore di libertà si dispiegano quelle ferrovie, «sotterranee» e non, lungo cui
corsero gli schiavi fuggiaschi ma anche gli oratori e le oratrici itineranti, che fecero
della moral suasion forse l’arma più affilata nella loro crociata per il risveglio delle
coscienze e il rifiuto dell’obbedienza a leggi considerate moralmente ingiuste. La
cornice spirituale e di revivalismo religioso fu l’alveo all’interno del quale le donne
mossero i primi passi verso la presa di coscienza del loro ruolo nella società.
Appartenenti alla setta quacchera della Society of Friends erano tutte le donne che
parteciparono il 4 dicembre del 1833 alla fondazione dell’ American Anti-Slavery
Society a Philadelphia16. Ma le chiese furono , in seguito all’irrigidimento dei Ministri
di culto il luogo dove le donne si scontrarono contro il pregiudizio che le voleva
inadatte a prender parola in pubblico17.
È proprio questo uno dei temi ricorrenti, in diverse forme e gradi, in tutta questa
vicenda: come all’interno di una comunità ispirata formalmente ai principi
dell’uguaglianza, della democrazia, della libertà e dei diritti inalienabili, si annidassero
nella realtà concreta dei fatti i germi di quella contraddizione che questi stessi diritti
negava a intere categorie di esseri umani. Fu proprio nello scontro con questa «realtà
dei fatti» che il pensiero abolizionista maturò la sua radicalità: nel rifiuto dei piani di
«deportazione» dei neri liberi per un ritorno in Africa18; nella rivendicazione per
un’emancipazione «immediata» lontana da qualsiasi forma compromissoria che ne
ritardasse l’attuazione in un incerto futuro; nella comprensione da parte di alcune delle
donne ( e degli uomini) del movimento che la tendenza ad escluderle dalla sfera della
15� Ivi, pp.73-77.
16� Ellen Ginzburg Migliorino, Donne contro la schiavitù, cit.,p.22-23.
17� Vedi la Pastoral Letter della General Association of Congretional Ministers of Massachussets del luglio
1837 che riporto in appendice.
18� Questo il piano dell’American Colonization Society fondata nel 1817 che prevedeva di insediare una
colonia di neri americani liberi in Africa in alternativa all’emancipazione negli Stati Uniti. Nel 1822 la Society fondò sulla costa occidentale africana la colonia che nel 1847 divenne la nazione indipendente della Liberia. Dal sito della Biblioteca del Congresso, sezione Mostre, Il Mosaico Afro-Americano, Colonizzazione http://www.loc.gov/exhibits/african/afam002.html
8
partecipazione politica attiva andava combattuta con altrettanta tenacia che quella di
considerare gli esseri umani dal diverso colore della pelle al pari di oggetti.
PAROLE e IDENTITÀ PUBBLICHE
Sulla retorica di genere, e sul suo utilizzo discrezionale, da parte degli abolizionisti
garrisoniani, Kristin Hoganson ha pubblicato un articolo che aiuta a comprendere come
la categoria di genere, e tutte le sue conseguenze sul piano della legittimazione politica,
siano a tal punto connesse con la questione della schiavitù, da divenire una delle
argomentazioni portanti su cui sia fautori che abolizionisti costruiscono il loro
discorso19. La legittimazione della causa abolizionista passa, in alcuni casi, per la
riaffermazione di quel regime di sfere separate e del culto del vero uomo e della vera
donna, valori fondamentali della società dell’epoca, della stabilità e dell’ordine morale,
contro i quali lo schiavo e la schiava nera e le loro annullate differenze di genere,
rappresentano un attentato molto più grave di quello portato dalle «femmine parlanti»
del movimento abolizionista20. Nell’America di metà Ottocento, culturalmente
impostata su una morale vittoriana e su una rigida separazione dei poteri e dei diritti,
che nella realtà dei fatti vedeva nell’uomo bianco e possidente, l’unico vero possibile
detentore della sovranità politica, le istanze egualitarie, sia per quanto attiene alla razza
che al genere, si affacciano sulla scena pubblica non senza controversie e
contraddizioni, a partire da un dato di fatto politico ed incontrovertibile: donne bianche,
donne nere e uomini neri (soggetti politicamente deboli e delegittimati) presero parola,
per via scritta e per via orale, in pubblico.
19� Kristin Hoganson, Garrisonian Abolitionists and the Rhetoric of Gender, 1850-1860, « American Quarterly», Vol. 45, No. 4 (Dec., 1993), pp. 558-595,The John Hopkins University Press, URL http://www.jstor.org/stable/2713309 .
20� Da segnalare che il dibattito a cui fa riferimento Hoganson ebbe luogo nel decennio 1850-1860, ben oltre
la data del 1840 che segna la spaccatura tra Garrisoniani e non all’interno del movimento abolizionista, sul ruolo ivi assegnato alle donne e che diede vita alla American and Foreign Anti-Slavery Society, con a capo Arthur Tappan e con idee molto più conservatrici sul ruolo da assegnare alle donne e soprattutto sulla rilevanza delle istanze femministe.
9
LA PARTECIPAZIONE FEMMINILE ALLA CAUSA ABOLIZIONISTA
Alla riunione del 4 dicembre 1833 che a Philadelphia vide la nascita dell’American
Anti-Slavery Society e la sottoscrizione di quella Declaration of Sentiments che ne
enunciava gli intenti, parteciparono sette delegati afro-americani e ben quattro donne su
un totale di sessantadue21. Neri e femmine conservavano il ruolo di minoranze anche
all’interno di questo contesto amichevole che li voleva protagonisti attivi. Financo
all’interno dei movimenti abolizionisti la discrimazione nei confronti dei neri e delle
donne rimane la nota di fondo dominante. Senza andare a scomodare teorie
psicanalitiche ingombranti, che in questa sede non ho il tempo di indagare, mi pare
possibile affermare che nella società dell’epoca, il solo fatto di vedere un nero seduto
accanto ad un bianco o una donna fuori dal posto unanimemente assegnatole
dall’immaginario collettivo, era in grado di suscitare reazioni violente sulla scorta di
incubi di promiscuità, di fusione delle razze che attentavano, anche nell’inconscio del
bianco più avveduto, ai valori morali fondanti della società corrente. Quasi che la
schiavitù fosse solo la punta dell’iceberg di un intero sistema di credenze che sia i neri
che le donne, in qualità di minoranze oppresse, dovettero continuare e continuano a
combattere ben oltre i limiti temporali che segnano l’oggetto di questa indagine, in una
ricerca di identità che è il sostrato comune e la meta di questa lunga marcia immobile
che accomuna i due gruppi. La via della separazione che tanto caratterizzerà le battaglie
del secolo successivo è tracciata fin dagli albori e testimoniata dalla creazione di
società, Conventions, società letterarie di soli neri o sole donne22.
In ambito femminile la necessità di questi spazi separati non era fermamente condivisa
da tutte come testimoniano le parole di Lydia Maria Child pubblicate sul Liberator di
Garrison del 6 settembre 1839, «È bene non parlare dei nostri diritti, andare
semplicemente avanti e fare quello che riteniamo sia nostro dovere. Occupandoci della
libertà degli altri, troveremo la nostra »23.
21� Ellen Ginzburg Migliorino, La marcia immobile. Storia dei neri americani dal 1770 al 1970, Milano,
Selene, 1994, p.60.
22� Ivi ,pp. 63-72.
23� Ivi, p.42.
10
La posizione di Child rappresenta l’esito di una riflessione di lungo periodo in merito ai
dubbi sull’utilità di conferenze per sole donne che essa aveva già espresso nel 1833 e
che portarono alla sua rinuncia a partecipare alle Anti-Slavery Convention of American
Women che seguirono quella di New York del maggio 1837, nello specifico a
Philadelphia nel maggio dei due anni successivi. Presa di posizione che non può
senz’altro essere interpretata come sintomo dell’inconsapevolezza di Child rispetto al
problema della condizione femminile, che essa affrontò dettagliatamente nella sua
monografia «History of the Condition of Women, in Various Ages and Nations»24,
quanto piuttosto della consapevole e ponderata scelta di dedicarsi ad altro. Non senza
una vena polemica nei confronti di chi attorno all’esclusione delle donne dal
movimento aveva sostanziato la scissione dell’ Aass, nel maggio 1840, almeno
formalmente a seguito dell’elezione di una donna, Abby Kelley, nella Committee of
Business dell’associazione25.
Della piena utilità degli incontri femminili rimase invece sempre convinta Lucretia
Mott, altra affermata abolizionista, una delle quattro partecipanti al momento fondativo
dell’ associazione di Garrison, che riteneva questi incontri un’occasione per le donne di
acquisire maggiore consapevolezza rispetto al proprio potere. Originaria del
Massachussets, Mott fu una delle delegate americane alla World Anti-Slavery
Convention di Londra nel giugno 1840. Forte dell’esperienza ivi maturata, in occasione
del diniego da parte del comitato organizzativo alla partecipazione delle donne ai lavori,
in quanto «non conforme alle regole e alle usanze della società inglese», Mott, al ritorno
in patria, avendo rafforzato i legami tra donne, nonché uomini intimamente convinti
dell’ingiustizia di questa esclusione, tra i quali Elizabeth Cady Stanton e lo stesso
Garrison, diede una spinta decisiva alla nascità del movimento per i diritti delle donne,
24� Ivi,p.56.
25� Mi riferisco alla lettera di Child indirizzata a Garrison (e pubblicata in versione integrale nell’appendice
di Ellen Ginzburg Migliorino, Donne contro la schiavitù, cit.,pp. 127-129) in cui l’autrice segnala l’attegiamento perlomeno contraddittorio di Mr.Tappan ,ora a capo della cellula secessionista del movimento denominata American and Foreign Anti-Slavery Society che solo qualche anno prima la implorava di prender parola in una Convention dove si era ritrovato a corto di oratori efficaci. Arrivando, davanti al rifiuto di Child a prender parola, ad esortare il di lei marito a persuaderla di parlare e sentendosi rispondere che egli preferiva lasciarla agire in piena libertà.
11
con l’organizzazione nel luglio del 1848 della Convention di Seneca Falls nello stato di
New York, e la redazione della relativa Declaration of Sentiments. Questo l’incipit.
Quando, nel corso degli eventi della storia umana, diviene necessario per una porzionedell’umana famiglia di assumere una posizione diversa da quella, fino a quel momento,occupata in mezzo agli altri, ma una posizione alla quale le leggi della natura e la natura diDio la chiamano, la decenza dovuta e il rispetto delle umane opinioni richiedono che dettaporzione dichiari davanti agli altri i motivi che la obbligano a tale risoluzione26.
26� La traduzione di questo breve estratto è mia. Per la consultazione dell’originale in lingua inglese rinvio
al sito della Biblioteca del Congresso, Divisione Libri Rari e Collezioni Speciali, I quaderni del Suffragio diMiller Nawsa,1897-1911, quaderno 6, pp. 68 consultabile presso http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/D?rbcmillerbib:4:./temp/~ammem_Z9Oo::
1
LE SORELLE GRIMKÉ
Il contributo affatto particolare che le sorelle Grimké apportarono alla causa fu in primo
luogo sancito dal fatto di essere due donne del Sud; per nascita proprietarie di schiavi.
Sarah and Angelina Grimké were born in Charleston, South Carolina; Sarah, Nov. 26, 1792,Angelina Feb. 20, 1805. They were daughters of the Hon. John Faucherau Grimké, a colonelin the revolutionary war, and judge of the Supreme Court of South Carolina. His ancestorswere German on the father’s side, French on the mother’s; the Fauchereau family having leftFrance in consequence of the revocation of the Edict of Nantes in 168527.
Che le due sorelle avessero ereditato geneticamente le qualità intellettuali e l’istintiva
indipendenza di pensiero dagli avi ugonotti in fuga da una Francia in cui Luigi XIV
aveva restaurato l’intolleranza religiosa, rimane una suggestiva congettura a posteriori.
Resta il fatto che fu proprio davanti alla loro famiglia e alle sue istituzioni che le due si
ribellarono rigettando una condizione di vita agiata in cambio della lotta per una causa
che avrebbe corroso le fondamenta della struttura sociale che le aveva viste nascere. Il
percorso che le accomuna nel prendere le distanze dalla casa paterna, guidato da Sarah,
di dodici anni più grande, e, in seguito, intrapreso da Angelina è segnato da delle tappe
precise: la dipartita da Charleston alla volta di Philadelphia; l’abbandono della chiesa
episcopale, sui banchi della quale erano state allevate, e l’adesione alla quacchera
27� Catherine H.Birney, The Grimké Sisters. Sarah and Angelina Grimké, the first American women
advocates of abolition and woman’s rights, Boston, Lee and Shepard, New York, C.T. Dillingham, 1885 in Internet Archive, Boston Library Consortium, Wellesley College Library, https://archive.org/details/grimksisterssara00birn
2
Society of Friends; infine la dedizione alla causa abolizionista e al movimento fondato
da William Lloyd Garrison. Il resoconto della Birney, peraltro, tramite un accurata
indagine delle esigue memorie epistolari pervenuteci28 e dei diari delle due sorelle
rintraccia nei primi anni di vita la gestazione dello stravolgimento interiore che porterà
le due coscienze a quel «risveglio» morale, etico, religioso che sottende alle rispettive
scelte di vita e che a partire da una posizione di accettazione, intimamente sofferta,
dell’istituto della schiavitù come dato di fatto ne fece due delle più intransigenti
oppositrici. Tra le due non intercorse sempre un’uniformità di vedute: nonostante la
maggiore Sarah avesse aperto la strada, l’indole e la disposizione interiore la portarono,
in un primo momento, a disapprovare l’audacia della più giovane. Nei lunghi anni che
videro maturare le loro convinzioni interiori, sotto l’egida di quella Society of Friends
che divenne per loro una seconda famiglia, soprattutto Sarah visse in maniera
travagliata la situazione di perenne conflitto tra le istanze maturate in un dialogo tutto
interiore con la propria coscienza e una condizione esterna di sostanziale
delegittimazione rispetto a prese di posizione reputate troppo radicali dal contesto di
appartenenza. A prender la parola in pubblico, scatenando la ferma opposizione della
Society e della sorella, fu, per prima Angelina. Peraltro in maniera del tutto involontaria.
L’occasione fu data dalla pubblicazione da parte di Garrison sul «Liberator» di una
lettera inviatagli privatamente da Angelina a sostegno delle sue posizioni 29. Questo
progressivo allontanamento, da parte di Angelina, dagli scopi e dalle posizioni della
Society, fu accompagnato da un interrogativo costante e ricorrente: «What am i to
do?30». Nel 1836, la risposta le arrivò come un ‘illuminazione divina, quando intraprese
la redazione di quel «Appeal to the Christian Women of the South» la cui
pubblicazione, a cura dell’American Anty-Slavery Society, rappresenta assieme alla
serie di lettere pubblicate dalla sorella dal titolo «Letters On The Equality of the Sexes
and the Condition of the Women» la testimonianza dell’incisività e della radicalità delle
argomentazioni portate avanti dalle due sorelle in una lotta per l’emancipazione e la
28� Come risulta dallo studio di Birney fu per volere della stessa Sarah che la maggior parte delle lettere sia
andata distrutta. Ivi, p.34.
29� Ivi, pp. 126-131.
30� «Che cosa posso fare?»
3
libertà che le vide protagoniste e che a tutti gli effetti si concluse nel 1838 con il loro
ritiro dalla scena politica31.
I documenti.
Prima di affrontare nel vivo i due documenti che qui propongo di esaminare mi preme
puntualizzare un’osservazione scaturita dall’analisi delle fonti su cui ci basiamo e a cui
fanno riferimento tutti i successivi studi sulla vita e le opere delle sorelle Grimké,
ovvero la biografia edita dalla Birney nel 1885 e il memoriale redatto da Theodore
Dwight Weld nel 1880 per ricordare la moglie appena deceduta32.Sono entrambe fonti
molto vicine nel tempo e nell'emotività di scrive all'oggetto dei loro resoconti.
Conservano, pertanto, pregi e difetti di tali tipi di fonti, rasentando per certi versi
l'intento agiografico, colmano i vuoti e le lacune di una distanza nel tempo, che
garantisca ampiezza visuale, con l'estrema e dettagliata precisione di chi determinati
eventi, oltre a raccontarli, li ha effettivamente vissuti.
Alla luce dei due secoli trascorsi, quello che appariva come un ritardo di Sarah nei
confronti di Angelina, unmaggior grado di esitazione, un'incertezza quasi al limite della
mancanza di coraggio nei confronti della spregiudicatezza dell'altra, oggi,
miracolosamente ci appare, quasi all'inverso, con la potenza e l'ampiezza di parole che
anticipano i tempi e, proprio per questo, all'interno del loro proprio tempo, faticano
maggiormente durante il travaglio che le mette al mondo. Questo senza voler mettere in
una sterile competizione i due testi ma semplicemente sottolineando come
l'elaborazione di Sarah rispetto alla condizione di comune passività che lega il popolo
dei neri all'universo femminile risulti maggiormente compiuta.
31� Gerda Lerner, The Grimke Sisters and the Struggle Against Race Prejudice, in «The Journal of Negro History», Vol. 48, No. 4 (Oct., 1963), p.289. Vedi anche il resoconto delle motivazioni personali esposto dal marito di Angelina, Theodore Weld, immediatamente dopo la sua morte, nel Memorial Sketch utilizzato sia da Lerner che da Katherine Du Pre Lumpkin come fonte nelle loro ricerche sulle sorelle come riportato in Marshall Foletta, Angelina Grimké: Asceticism, Millenarianism, and Reform,in «The New England Quarterly», Vol. 80, No. 2 (Jun., 2007), pp. 179-217, URL http://www.jstor.org/stable/20474532.
32� Theodore Dwight Weld, In Memory: Angelina Grimké Weld, Boston, George H.Ellis, 1880, consultabile
presso https://archive.org/details/inmemoryangelin00weldgoog
4
L'Appello risale al 1836 mentre la compilazione del corpo di Lettere risale a un periodo
compreso tra luglio ed ottobre del 1837. Ambedue i testi fanno ricorso alla
reinterpretazione delle Sacre Scritture e ai principi enunciati nella Dichiarazione
d'Indipendenza degli Stati Uniti per confutare le tesi dei rispettivi oppositori.
Angelina mantiene il fuoco della propria dissertazione attorno al nodo dell'illegittimità,
davanti a Dio, del dominio dell'uomo sull'uomo, Sarah lo sposta sull'altrettanto
infondata pretesa di dominio dell'uomo sulla donna. Tutta la prima parte
dell'argomentazione di Angelina è volta a smontare la tesi secondo cui la legittimità
della schiavitù in America si fonda sull'esistenza dell'istituto della servitù nell'era
patriarcale e sotto le leggi di Mosè, infatti « Le leggi di Mosè sulla servitù proteggevano
i servi ed i loro diritti di uomini e donne, li tutelavano dall'oppressione e li difendevano
dall'errore33». In seconda istanza, Angelina chiarisce la motivazione del suo riferirsi alle
donne, ammettendo che non sono esse a poter promulgare le leggi ma ribadendo che
esse sono le mogli, le madri, le sorelle e le figlie di coloro che lo fanno. E possono,
pertanto, esercitare il loro potere di persuasione. Possono informarsi e leggere in merito,
possono pregare, possono parlare e possono, infine, agire. Un passaggio rilevante del
testo considera il comportamento da tenere nei
confronti di leggi ritenute ingiuste, « […] certe leggi malvagie non possono
rappresentare un ostacolo34».
Nell'ottica dell'autrice la legge di Dio come si evince dalla Bibbia e come emerge da un
dialogo serrato con la propria coscienza, prevale sempre sulla legge dell'uomo. Esorta
altresì a non preoccuparsi delle conseguenze; compito degli abolizionisti è quello di
togliere la pietra dell'ignoranza che ha seppellito i propri fratelli neri per oltre 400 anni,
così come Marta e Maria scoperchiarono la tomba del fratello Lazzaro prima che Dio ne
operasse la risurrezione. Infine dopo aver difeso il movimento abolizionista dalle accuse
di insurrezionalismo chiude rivendicando la necessità dell'emancipazione immediata
contro le ipotesi gradualiste.
33� Angelina Emily Grimké, Appeal to the Christian Women of the South, NewYork, Aass, 1836, p.11. Consultabile in https://archive.org/details/appealtochristia1836grim
34� Ivi,p.18.
5
Nelle Lettere della maggiore delle sorelle Grimké, in tutto quindici, indirizzate a Mary
Parker, presidentessa della Boston Female Anti-Slavery Society, emerge lo stesso
schema probatorio, dove il riferimento costante ai Sacri Testi è teso a svincolarsi dalla
lettura e dalla traduzione che ne è stata, fino a quel momento, data in chiave prettamente
maschile35. « Sono incline a pensare che quando avremo accesso all'onore dello studio
del greco e dell'ebraico antico, potremo produrre delle interpretazioni della Bibbia
leggermente differenti da quelle che conosciamo36». Il pungente sarcasmo di Sarah
rinvia ad un dato della sua biografia: il rancore mai sopito di fronte alla negazione delle
sue aspirazioni allo studio, considerate unwomanly37.
E, in effetti, gran parte della riflessione di Sarah ruota attorno alla possibilità di
smontare l'interpretazione dei passi della Genesi che condannano la donna come l'unica
usurpatrice del dono concessole dalla grazia divina, fonte della tentazione nei confronti
della sua controparte maschile e simbolo di debolezza ed immoralità.
Nella visione di Sarah, l'uomo conserva altrettante responsabilità della donna nell'atto
che ha determinato la caduta dall'idillica e incolpevole condizione di innocenza
originaria. Al contrario, sarebbe la responsabilità dell'uomo quella di aver recluso,
attraverso secoli di usurpazione di un diritto non concessogli da Dio, la componente
femminile in uno spazio dove femminilità diviene sinonimo di sensualità e la donna
viene privata della possibilità stessa di esercitare quella natura, di essere moralmente ed
intellettualmente elevato, che, per diritto divino, le appartiene, al pari dell'uomo. « […]
egli ha offerto incenso alla di lei vanità, l'ha resa lo strumento delle sue egoistiche
gratificazioni, un giocattolo atto a procurare piacere alla sua vista ed a intrattenerlo nei
suoi momenti di svago38». Sulla scorta di affermazioni di tale natura, Sarah si domanda
35� Sarah Moore Grimké, Letters on the Equality of the Sexes and the Condition of Woman, Boston, Isaac
Knapp, 1838,p.4. Consultabile presso https://archive.org/details/lettersonequalit00grimrich.
36� Ivi, p.16.
37� Catherine H.Birney, The Grimké Sisters,cit., p.18. Vedi https://archive.org/details/grimksisterssara00birn
38� Sarah Moore Grimké, Letters on the Equality of the Sexes, cit.,p.17.
6
su quali basi gli illuminati ministri del culto pretendano di arrogarsi il ruolo di unici
intermediari ed intercessori della parola divina. Bibbia alla mano, Sarah sposta le
rivendicazioni di Lutero di oltre tre secoli e su un piano di genere.
Nella Lettera intitolata «Rapporti sociali tra i sessi», la sua invettiva si dirige contro
quel culto della vera femminilità che legava la figura della madre, della moglie, della
donna ad una presunta delicatezza d'animo che, sempre nella visione maschile, le
impedirebbe di predicare, di prender parola, di ostentare la propria intima essenza
davanti al mondo pena una scomunica irrevocabile. Che le impediva, in sostanza, quel
«confronto» che è la radice di ogni ricerca di identità. È l'identità negata, dunque, il
fulcro della rivendicazione della maggiore delle Grimkè, come più di un secolo dopo lo
sarà nelle parole di quel Malcolm X che nella lettera del suo cognome, porterà
testimonianza del furto d'identità perpetrato dall'uomo bianco a danno e a dannazione
dell'uomo nero.
La disamina etnologica delle condizioni della donna in diverse culture, età e continenti
la porta a constatare che la presunta debolezza fisica della donna non ha impedito che
nella divisione funzionale del lavoro, all'interno di predette società, essa assumesse
compiti gravosi e fisicamente impegnativi. In quanto «schiave» o «bambole», nell'arco
della storia dell'umanità, le donne hanno condiviso con i fratelli neri, e forse in misura
più imponente, l'oltraggio della compravendita. Nessuna «grande cultura» del passato è
risparmiata dallo sferzante giudizio in merito agli usi, le consuetudini ed i costumi del
trattamento della donna. Quando passa ad analizzare la situazione negli Stati Uniti
d'America, il suo giudizio non si fa certo meno dissacrante:
[...] nella maggior parte delle famiglie risulta considerevolmente più grave disturbare unagiovane nelle proprie attività mentre sta preparando una torta o un pudding piuttosto chementre si trova indaffarata nei suoi studi. Tale metodo di educazione, inevitabilmente esalta,nell'ottica delle giovani, la loro natura animale anziché quella spirituale ed intellettuale, edinsegna alle donne a raffigurarsi come una sorta di macchinario progettato per tenere inordine e far funzionare l'economia domestica, ma di scarso valore in quanto compagnadell'uomo, nel pieno delle sue facoltà di intendere e di ragionare39.
39� Ivi, p.48.
7
Paradossalmente il medioevo definito epoca oscura, da un punto di vista illuministico,
risulta come un «filamento d'oro che attraversa le epoche di oscurità40» per quanto
concerne la possibilità per le donne di studiare ed attivare le proprie facoltà morali ed
intellettuali.
La Lettera dodicesima è interamente spesa a sanzionare gle menomazioni dal punto di
vista legislativo e del diritto della categoria, vere e proprie «disabilità legali» delle
donne.
Eccezion fatta per la possibilità di presentare petizioni al corpo legislativo, la donnarappresenta una nullità nella nazione; o, se non propriamente così, essa è, insieme ai suoifratelli schiavi del sud, un numero che contribuisce a ingrossare le fila dei rappresentantieletti per lo Stato a cui essa appartiene; rappresentanti che terrano in scarso conto i suoiinteressi, al momento di promulgare le leggi, a meno che il bene di lei non coincida conquello di loro stessi41
L'ignoranza della propria condizione legale, a cui la donna è costretta, determina, al pari
della stessa
( durante il matrimonio la donna nella maggior parte degli Stati dell'Unione non
possiede personalità giuridica scissa da quella del marito), quella condizione di
inferiorità legalmente sancita,
così ben descritta dalle sue parole:
[…] I nostri premurosi protettori hanno legiferato in merito a quasi tutti i nostri diritti, e inpieno spirito di ingiustizia ed oppessione, ci hanno tenuto all'oscuro di quelle stesse leggi dacui siamo governate. Ci hanno persuaso che non abbiamo il diritto di informarci su tali leggie che, in ogni caso, non le comprenderemmo42.
Gli abusi più evidenti riguardano il regime di separazione dei beni e delle reciproche
obbligazioni all'interno del matrimonio, nettamente favorevoli al marito/padrone.
Il dogma dell'inferiorità della donna di fronte all'uomo viene, quindi smascherato e
confutato seguendo due direttrici: il disvelamento della parzialità delle leggi umane,
40� Ivi, p.63.
41� Ivi, p.74.
42� Ivi, p.75.
8
scritte da uomini, e la reinterpretazione dei passaggi degli scrittori ispirati su cui gli
uomini, erroneamente, hanno costruito il loro dominio e rivela, ancora una volta,
l'irriducibile autonomia intellettuale di Sarah
[…] l'autorità delle opinioni basate sulla cattiva interpretazione di alcuni passi, non detienealcun peso per me: sono opinioni di giudici interessati, e non gli porto nessun tipo diossequioso rispetto, semplicemente perché sono stati venerati di generazione in generazione.Al contrario, esamino qualsiasi posizione, espressa nei secoli dei secoli, con la stessa libertàed accuratezza che dedicherei a un'opinione di ieri. Sono stata educata a pensare per mestessa, e questo è un privilegio il cui esercizio intendo rivendicare43.
Non trovo modo migliore di chiudere questa breve rassegna sul pensiero di Sarah
Moore Grimké, che certo merita se non ossequioso rispetto, perlomeno il
riconoscimento del peso che le sue parole hanno nella coscienza di chi legge, con la
formula da lei stessa adoperata a conclusione di ogni lettera.
Thine in the bonds of womanhood.
Tua nel comune vincolo dell'esser donna.
43� Ivi, p.91.
9
CONCLUSIONI
Per quanto concerne i sentieri che si dischiudono alla ricerca in quest'ambito mi
piacerebbe indagare le continuità, celate dietro apparenti soluzioni e fratture, che si
riallacciano tra questi due secoli così pieni e determinanti della storia americana,della
storia dei neri e della storia delle donne che sono stati il diciannovesimo e il ventesimo.
Prendo spunto da una suggestione ricevuta nella lettura della prefazione di Nicola
Gallerano al testo di Ginzburg Migliorino, La marcia immobile, che affronta la storia
dei neri d'America su un arco temporale che arriva agli anni Settanta del secolo scorso,
egli afferma la specificità americana di questa vicenda. Al tempo stesso, proprio in virtù
di tale specificità, delinea l'universalità di una storia che «[...] parla anche a chi, come
noi, appare o si ritiene estraneo o lontano geograficamente e culturalmente dai conflitti
che in questo volume vengono raccontati44».
Ecco, alla stessa universalità mi sembra appartengano le vicende e i tumulti interiori
delle protagoniste di questa vicenda. Parlano a chi, come noi, vive in una società dove
la stratificazione della complessità incarcera sempre più l'individuo, donna, uomo o
animale che sia, all'interno di logiche ad esso estranee. Esortano a dare ascolto a
quell'intimo grido di libertà che soggiace irrequieto all'oppressione dei nostri tempi. Ci
chiama all'autodeterminazione e alla presa di consapevolezza del potere che abbiamo di
esprimerci in pensieri, parole ed atti. Ci vuole protagonisti del tratto, a noi riservato, in
questa staffetta che è la lunga marcia immobile dell'umanità su questo pianeta.
44� Ellen Ginzburg Migliorino, La marcia immobile, cit., p.8
10
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE
Monografie• Ellen Ginzburg Migliorino, Donne contro la schiavitù. Le abolizioniste americaneprimadella Guerra Civile, Manduria-Bari-Roma, Piero Lacaita, 2002.• Ellen Ginzburg Migliorino,L’emancipazione degli afroamericani. Il dibattito negliStatiUniti prima della guerra civile, Milano, FrancoAngeli, 1989.• Ellen Ginzburg Migliorino, La marcia immobile. Storia dei neri americani dal 1770al1970, Milano, Selene, 1994.• Catherine H.Birney, The Grimké Sisters. Sarah and Angelina Grimké, the firstAmericanwomen advocates of abolition and woman’s rights, Boston, Lee and Shepard, NewYork,C.T. Dillingham, 1885.Articoli• Bruna Bianchi, Introduzione al pensiero della non violenza (1830-1968) in Agire lanonviolenza. Pensiero e politiche. Prospettive di liberazione nella globalizzazione , attidelConvegno tenutosi a San Servolo (Venezia) nel febbraio2004, Punto Rosso, Roma2004.• Kristin Hoganson, Garrisonian Abolitionists and the Rhetoric of Gender, 1850-1860,«American Quarterly», Vol. 45, No. 4 (Dec., 1993).• Gerda Lerner, The Grimke Sisters and the Struggle Against Race Prejudice, in «TheJournalof Negro History», Vol. 48, No. 4 (Oct., 1963).
11


























![Cult Poetry in Archaic Greece [2012]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6317a4a0bc8291e22e0e59eb/cult-poetry-in-archaic-greece-2012.jpg)