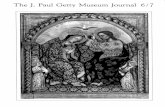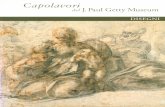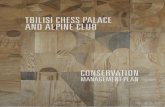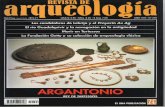Sull’Amor omnia vincit del J. Paul Getty Museum e la fortuna delle allegorie d’amore a Roma...
Transcript of Sull’Amor omnia vincit del J. Paul Getty Museum e la fortuna delle allegorie d’amore a Roma...
Nel 1972 il J.P. Getty Museum di Los Angeles siaggiudicò all’asta un ‘Amor omnia vincit’ allora attri-buito a Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino(fig. 1).1) Il dipinto, pubblicato l’anno successivo nelcatalogo della mostra Baroque Masters from The J. PaulGetty Museum, è stato in seguito più volte riferito aduna mano fiamminga.2) Nel 1981 Burton Fredericksenha rilevato la dipendenza del dipinto dall’affresco raf-figurante ‘Ercole nuota nel lago di Vico’ eseguito daFederico Zuccari al centro della volta della Sala diErcole nel Palazzo Farnese di Caprarola (1568–1569;
fig. 2).3) L’attribuzione dell’‘Amor omnia vincit’ allostesso Zuccari è stata però respinta da Diane DeGra-zia, che ancora una volta ha suggerito come possibileautore un pittore fiammingo attivo a Roma intorno al1600.4) Il dipinto Getty è infatti inquadrabile senz’al-tro all’interno della breve ma eccezionale fortuna che itemi strettamente legati dell’‘Amor omnia vincit’ edella ‘Contesa di Eros e Anteros’ ebbero a Roma neglianni a cavallo tra Cinque e Seicento. Sebbene non siaancora possibile proporre una paternità e una datazio-ne certa per l’‘Amor omnia vincit’ di Los Angeles, la
63
STEFANO PIERGUIDI
SULL’‘AMOR OMNIA VINCIT’ DEL J. P. GETTY MUSEUM E LA FORTUNADELLE ALLEGORIE D’AMORE A ROMA INTORNO AL 1600
1 – LOS ANGELES, THE J. PAUL GETTY MUSEUM – PITTORE FIAMMINGO ATTIVO A ROMA (?): AMOR OMNIA VINCIT
Estratto del BOLLETTINO D’ARTE del Ministero per i Beni e le Attività CulturaliFascicolo n° 137-138 Luglio-Dicembre anno 2006
sua analisi è l’occasione per ritornare sul significatoiconografico di due fondamentali cicli ad affrescoromani degli stessi anni incentrati su questi temi:quello del Cavalier d’Arpino nella Loggia Orsini equello di Annibale e Agostino Carracci nella Galleriadi Palazzo Farnese.
È bene sottolineare prima di tutto che l’autore deldipinto Getty, a differenza di quanto fin qui creduto,non si rifece direttamente all’‘Ercole nuota nel lago diVico’ di Caprarola, bensì a un disegno dello Zuccariperduto o non ancora identificato. A dimostrarlo è ilconfronto con uno studio di Federico relativo al grup-po di destra dell’affresco del Palazzo Farnese (Firenze,Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe; fig. 3):5)
l’uomo col cappello che indica verso il centro dellacomposizione, il cui volto emerge appena al di sopradel braccio della figura in primo piano, ritorna infattiidentico nel disegno degli Uffizi e nel dipinto di LosAngeles, mentre è assente nell’affresco di Caprarola.La medesima figura doveva essere presente in unostudio d’insieme approntato da Federico, al quale evi-dentemente si rifece l’autore dell’‘Amor omnia vincit’.Anche il soggetto al centro del dipinto Getty è ricolle-gabile allo Zuccari: questi potrebbe aver raffigurato il
tema dell’‘Amor omnia vincit’ in uno studio relativo alciclo della Loggia Orsini (oggi Palazzetto del PioSodalizio dei Piceni), la cui esecuzione sarebbe statapoi affidata al Cavalier d’Aprino. Nel suo SchilderBoeck del 1604 Karel van Mander scriveva infatti:«Giuseppe [Cesari], fra le altre cose ha dipinto unaloggia a fresco per un gentiluomo a Roma. Il lavoroera stato affidato a Federico Zuccari con patto didoverlo eseguire personalmente. Ma il signore venen-do un giorno sull’impalcatura e trovandovi un garzo-ne impegnato a dipingere cose senza pregio, s’adirò,fece raschiare tutto, pagò Federico, e volle, malgradotutto quello che gli si disse, affidare il lavoro a Giusep-pe. In questa loggia, fra le altre cose, era rappresenta-to Cupido che atterra Pane, per dimostrare che l’amo-re vince la natura; composizione che si può vedere instampa incisa da Giacopo Mathan».6) L’incisione (fig.4), in controparte, è molto fedele all’affresco dellaLoggia Orsini.7) Il “signore” ricordato genericamenteda Van Mander è identificabile con Corradino Orsini,nel cui palazzo il Cavalier d’Arpino, secondo quantoriportato da Giovanni Baglione, «colorì di fresco laloggetta con diversi fatti d’Ercole effigiati, con figurenude di diverse donne molto graziose».8) Herwarth
64
2 – CAPRAROLA, PALAZZO FARNESE, SALA DI ERCOLE, VOLTA – FEDERICO ZUCCARI: ERCOLE NUOTA NEL LAGO DI VICO
Röttgen ha ricollegato il programma iconografico delciclo, culminante nell’‘Amor omnia vincit’ citato daVan Mander, al matrimonio celebrato nel 1589 tra Vir-ginio Orsini e Flavia Peretti, i cui nomi compaiono nelfregio di una delle stanze dietro alla loggia.9) I due,però, non erano i proprietari del palazzo, acquistatonel 1593 da Corradino. Secondo Röttgen il Cavalierd’Arpino avrebbe eseguito la decorazione intorno al1594/95, attenendosi tuttavia ad un programmamesso a punto dallo Zuccari intorno, presumibilmen-te, al febbraio 1589, quando il matrimonio venne fis-sato per contratto.10) In quel momento, però, Federicoera ancora in Spagna: l’artista avrebbe dato notizia delsuo ritorno in Italia al suo signore, il Duca FrancescoMaria II della Rovere, solo il 14 aprile del 1589.11) Amaggio il pittore era ancora a Napoli,12) e il primodocumento che attesti la presenza dello Zuccari aRoma risale al 18 aprile 1590, poichè l’acquisto di unacasa a Roma dagli eredi di Giovanni Maria de Vallerisale al 6 luglio 1590, e non al 19 luglio 1589 comeriportato da Bertolotti e da tutta la critica successiva.13)
65
3 – FIRENZE, UFFIZI, GABINETTO DEI DISEGNI E DELLE STAMPEFEDERICO ZUCCARI: DISEGNO PREPARATORIO PER IL GRUPPOA DESTRA DI ERCOLE CHE NUOTA NEL LAGO DI VICO
4 – ROMA, ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFICAGABINETTO NAZIONALE DEI DISEGNI E DELLE STAMPE
JACOB MATHAM DA GIUSEPPE CESARI: AMOR OMNIA VINCIT, INCISIONE
Secondo il puntuale racconto di Van Mander, infatti,dopo il licenziamento dello Zuccari venne subito con-tattato il Cavalier d’Arpino. La commissione a Federi-co doveva quindi risalire al 1593 /’94, all’epoca in cuiil pittore dava avvio alla decorazione della sua fastosaresidenza sul Pincio: non desta nessuna sorpresa,quindi, che l’artista avesse trascurato il cantiere affida-togli da Corradino Orsini.14)
Il racconto del Van Mander non fornisce nessun ele-mento utile a stabilire se il soggetto del ciclo venissemodificato o meno nel momento in cui la commissio-ne passava dallo Zuccari al Cavalier d’Arpino, e pro-prio a questo proposito l’‘Amor omnia vincit’ di LosAngeles riveste una grande importanza. È sintomaticoinfatti che lo stesso tema compaia al centro degli affre-schi della Loggia Orsini e nel dipinto Getty, esemplatosu un’altra invenzione dello stesso Zuccari. Amore chesottomette Pan, traduzione figurativa del celebre versovirgiliano «Amor vincit omnia et nos cedamus amori»(Ecloghe X, 69), negli anni Novanta del Cinquecento, aRoma, era ancora un’allegoria quasi del tutto inedita.
Solo nel 1599, infatti, con la diffusione di una fortuna-ta incisione di Agostino Carracci, l’‘Amor omnia vincit’sarebbe divenuto un soggetto popolare. Per quanto è amia conoscenza, prima di allora questo tema anticoera stato raffigurato solo in pochissime occasioni e incontesti non proprio privilegiati. La prima ripresa diepoca rinascimentale è individuabile in un piccoloaffresco della volta della stufetta del cardinale Bernar-do Dovizi da Bibbiena in Vaticano (1516). Questostraordinario capolavoro era praticamente inaccessibi-le già nel Cinquecento: non a caso Raffaello avevadeciso di diffondere la composizione e l’iconografia disei delle otto scene parietali attraverso una serie diincisioni opera di Marcantonio Raimondi e della suascuola. Solo nel 1804 l’‘Amor omnia vincit’ della voltavenne inciso da Tommaso Piroli: questi, non potendorealizzare la riproduzione integrale di tutte le ottoscene maggiori della stufetta a causa della totale perdi-ta di uno degli episodi, decise di completare la seriecon uno degli scomparti della volta.15) La primaimportante raffigurazione del tema dell’‘Amor omniavincit’ è quindi quella dell’emblema LXXV delle Sym-bolicae Quaestiones di Achille Bocchi (Bologna 1555;fig. 5).16) Chiamato a ritoccare le incisioni dell’opera diBocchi per l’edizione del 1574, Agostino Carracci siappassionò a questo tema, che in seguito raffigurò adaffresco in uno dei camini di Palazzo Magnani a Bolo-gna (1591). Passato a Roma per aiutare il fratello nel-l’esecuzione della decorazione della Galleria di Palaz-zo Farnese, Agostino portò con sè il tema dell’‘Amoromnia vincit’, che ricompare infatti in uno dei mono-cromi della celebre volta (fig. 6). Nel 1599, quando contutta probabilità era ancora a Roma, lo stesso Agostinorealizzò l’incisione già citata.17) L’interesse dello Zucca-ri per l’‘Amor omnia vincit’ non può essere messo inrelazione con la fortuna incontrata da questo tema nel-l’opera di Agostino Carracci, ma è facilmente ricondu-cibile alla stessa fonte, le Symbolicae Quaestiones. Nel1566 Federico aveva affrescato in un gabinetto diPalazzo Farnese a Caprarola l’immagine dell’‘Her-mathena’, immediatamente associabile all’Accademiafondata a Bologna da Bocchi, detta appunto Her-mathena, di cui Alessandro Farnese era stato un gran-de sostenitore:18) considerata la sua grande passioneper le invenzioni allegoriche in genere, e quelle diamore in particolare,19) non è certo sorprendente chenel 1593/94 lo Zuccari avesse attinto nuovamente, peril ciclo Orsini, ad una delle incisioni delle SymbolicaeQuaestiones. A questo prototipo si rifece poi il Cavalierd’Arpino, artista assai meno interessato dello Zuccarial linguaggio allegorico: Röttgen ha infatti dimostratola dipendenza dell’affresco del Cesari dalla suddettaincisione delle Symbolicae Quaestiones.20)
È ben noto che Federico, come prima di lui Salviatie Vasari,21) si sia più volte autocitato, recuperando sin-gole figure o intere soluzioni compositive dai propridisegni.22) Per una commissione affidata alla sua botte-ga, la decorazione di due volte in Palazzo Corsini(1585 circa), egli procedette, o acconsentì, al sistemati-co saccheggio di invenzioni che risalivano a un perio-
66
5 – GIULIO BONASONE: AMOR OMNIA VINCIT, INCISIONE(da ACHILLE BOCCHI, Symbolicae Quaestiones, Bologna 1555)
do compreso tra il 1567 e il 1583.23) È quindi possibileche Federico stesso avesse realizzato un disegno raffi-gurante l’‘Amor omnia vincit’ in una cornice di figuredesunta dall’‘Ercole nuota nel lago di Vico’, ma èimprobabile che un artista del talento dello Zuccariarrivasse a copiarsi così pedissequamente, nè l’associa-zione tra le due invenzioni sembra particolarmentefelice: nelle raffigurazioni della lotta di Amore e Pannormalmente assistono poche figure, ninfe o divinità,non una folla variopinta quale si vede nel dipintoGetty. Una composizione del genere, inoltre, nonpoteva essere stata pensata per la volta della LoggiaOrsini, che per le sue dimensioni e la sua strutturaarchitettonica non avrebbe potuto accogliere unascena centrale tanto vasta ed affollata. Sembrerebbequindi più probabile che l’inserimento dell’‘Amoromnia vincit’ all’interno di un’altra composizione zuc-caresca sia attribuibile all’anonimo autore della tela diLos Angeles.
Alla luce della nuova datazione qui proposta perl’intervento dello Zuccari nella Loggia Orsini è oppor-tuno domandarsi se sia davvero necessario leggere l’i-conografia degli affreschi poi eseguiti dal Cavalierd’Arpino in relazione al matrimonio di Virginio Orsinie Flavia Peretti.24) Secondo Röttgen «L’idea del Omniavincit Amor è intesa qui [nella Loggia Orsini] conintento moralistico, come vittoria dell’amore coniuga-le sugli istinti sfrenati».25) Per Van Mander, però,“Cupido che atterra Pane” significava solo “l’amore[che] vince la natura”, senza nessun riferimento allasensualità che caratterizzava i satiri. Se veramente loZuccari e il suo committente avessero voluto alludereal contrasto tra l’amore virtuoso e quello carnale, per-chè non raffigurare lo scontro di Eros e Anteros con ilsignificato ancora corrente di Amor sacro e Amor pro-fano? È ben noto, infatti, che il significato della figuradi Anteros, ovvero l’Amore reciproco, venne spessofrainteso nel Rinascimento, che vide in Eros l’Amore
67
6 – ROMA, PALAZZO FARNESE, GALLERIA – ANNIBALE CARRACCI: MEDAGLIONE CON AMOR OMNIA VINCIT
profano e in Anteros quello sacro (si veda, ad esempio,l’Emblematum Liber di Andrea Alciati, Parigi 1531).26)
Sebbene già Vincenzo Cartari, descrivendo l’immagi-ne classica di Eros e Anteros che si contendono unapalma nelle sue Immagini degli dèi (Venezia 1556),avesse restaurato il significato classico della figura diAnteros,27) il tema dello scontro fisico di Eros e Ante-ros, allegoria dell’Amor sacro che sottomette quelloprofano, non cessò affatto di essere raffigurato. Char-les Dempsey ha infatti sottolineato come AgostinoCarracci, pur a conoscenza del significato classico deltema di Eros e Anteros attraverso un dipinto di PaoloFiammingo (Vienna, Kunsthistorisches Museum) cheegli aveva riprodotto in una nota incisione, eseguì undisegno (Vienna, Albertina) in cui Eros è bendato elegato ad un albero mentre Anteros ne brucia learmi.28) E, soprattutto, lo stesso Federico Zuccari, checertamente doveva conoscere bene il trattato di Carta-ri, a cui si era ampiamente rifatto Annibal Caro per ilprogramma iconografico della Sala dell’Aurora nelPalazzo Farnese di Caprarola affrescata dal fratelloTaddeo nel 1562–1563,29) nella decorazione della suacasa sul Pincio inserì la raffigurazione di ‘Anteros chesottomette Eros’ (fig. 7).30) Quest’affresco, come giàaccennato, deve essere stato realizzato poco dopo il1593: è possibile quindi, che risalga allo stesso identi-co momento in cui Federico proponeva a CorradinoOrsini di raffigurare l’‘Amor omnia vincit’ nella sualoggia.31) Un artista come lo Zuccari non sceglievacerto i suoi soggetti senza riflettere a fondo, ed è quin-di evidente che egli attribuisse al tema dell’‘Amoromnia vincit’ un significato diverso rispetto a quello di‘Anteros che sottomette Eros’.
Lo stesso discorso è in fondo valido anche per gliaffreschi dei Carracci nella volta della Galleria di Palaz-zo Farnese. Per questi già da tempo Roberto Zapperi haescluso ogni possibile relazione con il matrimonio diRanuccio Farnese con Margherita Aldobrandini,32) eanche nel ciclo dei Carracci non è presente nessunintento moralistico. Come è ampiamente noto, Belloriinterpretò il significato degli affreschi della volta a par-tire dagli «Amori dipinti ne’ quattro lati della Gale-ria...da cui dipende tutto il concetto, ed allegoria dell’o-pera. Volle figurare il pittore con vari emblemi laguerra, e la pace tra’l celeste, e’l vulgare Amore».33) Inun famoso articolo del 1968 che prendeva il titolo dallaseconda parte del celebre verso virgiliano delle Ecloghe(«Et nos cedamus amori...»), Dempsey propose inveceche il tema degli affreschi della galleria fosse la celebra-zione del potere dell’amore, frainteso, se non propriocensurato, dalla lettura belloriana.34) La questione èstata assai dibattuta dalla critica,35) che però non ha sot-tolineato come anche per gli affreschi di Agostino Car-racci nel Palazzo del Giardino di Parma (1600–1602circa), in cui erano protagonisti ancora una volta unaserie di amorini, Bellori abbia proposto un’interpreta-zione di tono moraleggiante del tutto infondata. Il ciclodi Agostino avrebbe dovuto articolarsi in quattro sceneprincipali dedicate alle storie di Peleo e Teti intorno alriquadro centrale con tre amorini che giocano nel giar-dino di Venere, ma la decorazione non venne portata atermine dall’artista. Nonostante ciò Bellori, che moltoprobabilmente non aveva visto gli affreschi di Parma dipersona, lesse nelle tre scene narrative (delle quali nonriportò correttamente nemmeno il soggetto) un pro-gramma iconografico già concluso: «... le favole corri-
68
7 – ROMA, PALAZZETTO ZUCCARIFEDERICO ZUCCARI: ANTEROS SOTTOMETTE EROS
spondono all’Amore honesto, utile e dilettevole, ò sianol’Amore della virtù, l’Amore lascivio, e l’Amore venaledell’oro».36) In realtà il ciclo di Agostino, proprio comequello della Galleria Farnese, era dedicato alla celebra-zione del potere dell’amore, e nei tre amorini al centrodella volta è stato letto un riferimento al temadell’‘Amor omnia vincit’. Quest’ultimo, non a caso,venne raffigurato in seguito da Carlo Cignani in unodegli affreschi delle pareti con un esplicito richiamoalla composizione che Agostino aveva lasciato nel cami-no di Palazzo Magnani.37) Bellori, invece, riapplicò ilmedesimo schema interpretativo già impiegato per ladescrizione della Galleria Farnese, con l’aggiunta, deci-samente sintomatica, dell’«Amore venale dell’oro».Intorno al 1590–1595, infatti, Agostino aveva realizzatouna celebre incisione in forma di rebus dal titolo ‘Ognicosa vince l’Oro’ (fig. 8).38) Si trattava di un’altra varia-zione sul tema dell’‘Amor omnia vincit’, derivata forsedall’emblema intitolato ‘Amour vaincu par argent’ dellaraccolta Hecatomgraphie di Gilles Corrozet (Parigi1540),39) che al pari delle Symbolicae Quaestiones potevaaver stimolato la curiosità di Agostino. L’incisione nonha però nessun rapporto con il ciclo farnesiano diParma, nel quale, proprio come nella galleria romana,gli amorini giocavano un ruolo da protagonisti sullascia prima di tutto di una tradizione pittorica squisita-mente emiliana, che dai Dossi fino almeno a FrancescoAlbani e a Giovanni Francesco Grimaldi, assegnò sem-pre un ruolo da protagonisti a questi festanti compagnidi Venere.40) Sia a Parma che a Roma era presenteanche l’‘Amore Letheo’ (impegnato a spegnere la fiam-ma delle passioni), che proprio come la ‘Contesa diEros e Anteros’ e lo stesso ‘Amor omnia vincit’ era cer-tamente un tema caro prima di tutto ad Agostino.41) Lacritica ha infatti sempre attribuito al maggiore dei Car-racci un ruolo da protagonista nell’invenzione del cicloFarnese,42) e l’idea stessa di collocare coppie di amorini«ne’ quattro lati della galleria» deve essere con tuttaprobabilità ricondotta proprio ad Agostino. Questi,come è noto, nutriva una grande ammirazione perVeronese, come testimonia una celebre lettera inviatada Venezia ad Annibale databile al 1586/87 circa. Giànel 1582 Agostino aveva trascorso qualche tempo inlaguna, impegnato soprattutto ad incidere opere notis-sime del Caliari, che sarebbe morto solo nel 1588:43)
non può quindi essere solo una coincidenza che pro-prio in un ciclo del Veronese si possa individuare il piùsignificativo precedente agli amorini dei Carracci dellagalleria romana. Nel soffitto del salone di Palazzo Trevi-san a Murano (1557 circa) il Caliari aveva collocatonelle due volticelle angolari, in una collocazione similequindi a quelle dei loro “cugini” della volta Farnese,Eros e Anteros che lottano per la palma e due amoriniche con l’acqua del fiume Lete spengono la fiamma diuna torcia (figg. 9–12).44) Non è certo possibile leggerein questi due affreschi una contrapposizione tra amorsacro e amor profano, ed è probabile che Agostinoabbia semplicemente pensato ad altre due variazioni suimedesimi temi per arrivare ad avere quattro motivi dainserire agli angoli della volta.
L’incisione raffigurante ‘Ogni cosa vince l’Oro’, incui giustamente Maurizio Calvesi ha riconosciutouna delle fonti compositive, e in qualche modoanche iconografiche, dell’‘Amore vincitore’ di Cara-vaggio (1601–1602; Berlino, Gemäldegalerie),45) èstata sempre associata al celebre ciclo delle incisionidi Agostino note come “Lascivie”.46) Ora è piuttostodifficile che l’autore di queste composizioni erotiche,nello stesso giro di anni, potesse vedere nel temadell’‘Amor omnia vincit’ una «vicenda in cui la spintadei sensi viene domata “contro gl’irragionevoli appe-titi” dall’Amor sacro»:47) più verosimile che il signifi-cato di questa allegoria fosse sempre, nelle intenzionidei Carracci, la celebrazione del potere di amore.Stesso discorso per il già citato ‘Amore vincitore’ com-missionato a Caravaggio da Vincenzo Giustiniani,descritto nell’inventario della collezione del 1638come «un’Amore ridente in atto di disprezzare ilMondo»: il dipinto era evidentemente un’altra varia-zione sul tema dell’‘Amor vincit omnia’.48) Nell’Icono-logia di Cesare Ripa (Roma 1593), infatti, il Mondo èraffigurato come il dio Pan:49) in questo, come neglialtri casi esaminati, non vi era quindi nessun associa-zione tra Pan e gli istinti sensuali tipici dei satiri. Aldipinto di Berlino avrebbe risposto Baglione con la
69
8 – ROMA, ISTITUTO NAZIONALE PER LA GRAFICAGABINETTO NAZIONALE DEI DISEGNI E DELLE STAMPE
AGOSTINO CARRACCI: OGNI COSA VINCE L’ORO, INCISIONE
70
9 – MURANO, PALAZZO TREVISAN, SALONE – PAOLO VERONESE:EROS E ANTEROS IN LOTTA
(PARTICOLARE DELLA VOLTA)
10 – MURANO, PALAZZO TREVISAN, SALONE – PAOLO VERONESE:EROS E ANTEROS ROVESCIANO L’ACQUA DEL FIUME LETE
(PARTICOLARE DELLA VOLTA)
11 – VENEZIA, MUSEO CORRER – ANTONIO MARIA ZANETTIDA PAOLO VERONESE: EROS E ANTEROS IN LOTTA
INCISIONE
12 – VENEZIA, MUSEO CORRER – ANTONIO MARIA ZANETTIDA PAOLO VERONESE: EROS E ANTEROS ROVESCIANO
L’ACQUA DEL FIUME LETE, INCISIONE
moralistica contrapposizione dell’‘Amor sacro e Amorprofano’ dipinto per Benedetto Giustiniani (1602;noto nelle due versioni autografe della Gemäldegale-rie di Berlino e della Galleria Nazionale d’Arte Anticadi Palazzo Barberini a Roma, fig. 13),50) che anchecompositivamente è molto vicino all’‘Eros e Anteros’dello Zuccari, un affresco sicuramente ben noto alBaglione.51) Questi, peraltro, si era forse rifatto ancheall’«Amore divino, che sottomette il profano» che,secondo lo stesso Baglione, Caravaggio aveva esegui-to per Francesco Maria del Monte (intorno, presumi-bilmente, al 1595).52) Una sorta di fusione dei duetemi dell’‘Amor vincit omnia’ e dell’‘Amor sacro eAmor profano’ sarebbe stata operata da Nicolas Pous-sin più avanti, intorno al 1630, nel ‘Venere e Mercu-rio’ della Dulwich Picture Gallery di Londra, in cui unamorino alato atterra un piccolo satiro privo di ali econ gambe caprine.53)
Nel giro di pochissimi anni, quindi, i maggiori arti-sti attivi sulla scena romana nello scorcio del Cinque-cento (Federico Zuccari, il Cavalier d’Arpino, i Car-racci, Caravaggio e Baglione) si confrontarono con itemi dell’‘Amor omnia vincit’ e della ‘Contesa traEros e Anteros’ (quest’ultimo, si intende, secondoentrambi i suoi significati). Tutto questo, se riconfer-ma la tradizionale datazione e provenienza del dipin-to Getty, che infatti intorno al 1900 si trovava certa-mente ancora a Roma,54) non aiuta a risolvere laquestione della sua paternità. L’attribuzione ad unapossibile mano fiamminga è suggerita prima di tuttodal sapore nordicheggiante di alcuni passaggi, a par-tire dall’allungamento delle proporzioni delle figure,in particolare quelle del giovane in primo piano adestra. Anche alcune considerazioni di carattere ico-nografico, inoltre, indicano nella stessa direzione. Èben nota la grande fortuna delle allegorie d’amorenell’emblematica fiamminga e olandese di primo Sei-cento, basti pensare agli Amorum Emblemata di Ottovan Veen (Anversa 1608), che nel corso del suo sog-giorno italiano del 1575–1580 aveva forse frequenta-to la bottega di Federico Zuccari.55) Inoltre proprionegli anni in cui a Roma il tema dell’‘Amor omniavincit’ conosceva un grande successo, al Nord Hen-drick Goltzius creava quello, forse anche più fortuna-to, del ‘Sine Cerere et Baccho Venus friget’, raffigura-to dall’artista in numerosi disegni e in un’incisionedatabile al 1590 circa. Se il primo era la traduzionefigurativa di un verso di Virgilio, il secondo lo era diun verso di Terenzio, ed il rapporto che legava le dueinvenzioni venne confermato a posteriori da AgostinoCarracci, che riprese in una sua incisione, databilesempre intorno al 1599, l’invenzione di Goltzius .56)
Karel van Mander, nel 1600 circa, dipinse un origina-lissimo ‘Amor omnibus idem’ (Duchcov, WallensteinCollection), ispirato a un verso delle Georgiche di Vir-gilio (che egli stesso aveva tradotto) 57) e Bartholo-meus Spranger, tra il 1602 e il 1605 circa, eseguì unperduto ‘Cupido che sottomette Mercurio alla pre-senza di Venere’ (noto attraverso un’incisione diLukas Kilian) che costituiva evidentemente una varia-
zione sul tema dell’‘Amor omnia vincit’.58) Intorno al1600, quindi, la passione per l’allegoria e l’emblema-tica che accomunava in qualche modo Agostino Car-racci a Federico Zuccari era in fondo più comune tragli artisti fiamminghi che tra quelli italiani. Tenendosempre a mente la sua probabile provenienza roma-na, è però improbabile che il dipinto di Los Angelessia opera di Karel van Mander, il cui soggiorno italia-no era già terminato nel 1577; lo stesso discorso èvalido per Bartholomeus Spranger, a Roma tra il1566 e il 1575. Improponibile sembra anche l’attribu-zione a Hendrick Goltzius, a Roma nel 1590/91, i cuidipinti monumentali, eseguiti soprattutto a partiredal 1600, sono molto lontani dall’‘Amor omnia vincit’del Getty. Il dipinto di Los Angeles sembrerebbe peròparlare la stessa lingua e la stessa cultura di questiartisti.59)
Più che alla celebre incisione di Agostino Carrac-ci del 1599, il dipinto Getty si lega forse a quellache Jacob Matham trasse dalla Loggia Orsini. Fuprobabilmente Goltzius, che aveva conosciuto Fede-
71
13 – ROMA, GALLERIA NAZIONALE D’ARTE ANTICAGIOVANNI BAGLIONE: AMOR SACRO E AMOR PROFANO
rico a Roma,60) a suggerire al suo figlio adottivoJacob Matham, in partenza per l’Italia nel 1593/94,di studiare approfonditamente l’opera dello Zucca-ri. La prima incisione romana di Matham è infattiproprio quella tratta dall’‘Amor omnia vincit’ delCavalier d’Arpino, menzionata come abbiamo vistodallo stesso Van Mander, e stampata da Goltzius adHaarlem nel 1597. Matham giunse probabilmente aRoma proprio poco prima che l’opera venisse toltaa Federico ed assegnata al Cesari: fu certamente lui,una volta tornato in patria nel 1597, a raccontare aVan Mander l’episodio del licenziamento dello Zuc-cari.61) Nel corso del suo soggiorno romanoMatham riprodusse alcune opere di Taddeo e Fede-rico, senza dubbio su richiesta di quest’ultimo,attentissimo al mezzo della stampa come strumentodi diffusione delle sue invenzioni.62) Prima ancoradi recarsi in Italia, Matham aveva già inciso la palaorvietana dello Zuccari con ‘Cristo resuscita il figliodella vedova di Nain’ rifacendosi a un disegno pre-paratorio di Federico (oggi ad Amsterdam) cheGoltzius aveva riportato in patria dopo il suo sog-giorno del 1590–1591.63) Lo stesso Goltzius, nel1589, aveva a sua volta inciso il celebre ‘GrandeErcole’ per cui la critica ha individuato il probabilemodello nell’‘Ercole’ affrescato dallo Zuccari in unodei riquadri minori della volta della Sala di Ercolenel Palazzo Farnese di Caprarola.64) Fino ad ogginon è stato possibile spiegare come Goltzius potesseconoscere quell’affresco ancora prima di recarsi inItalia, e la risposta a questo quesito potrebbe veniredal solito Van Mander, che affermava di aver lascia-to l’Italia nel 1577 con molti disegni tratti da bellis-simi modelli a Roma e altrove.65) Spranger, amico diVan Mander, nel 1570 aveva affrescato alcuni pae-saggi nel Palazzo Farnese di Caprarola,66) e MauriceVaes ipotizzò che lo stesso Van Mander avesse lavo-rato per qualche tempo in quel cantiere.67) Certa-mente poteva averlo visitato e averne tratto deidisegni, e proprio come Goltzius qualche annodopo, anche Van Mander avrebbe potuto otteneredisegni originali da Federico in persona, che ebbemodo di conoscere a Firenze durante il suo viaggiodi ritorno verso i Paesi Bassi.68) Non è forse solo unacoincidenza che sia il dipinto Getty che il ‘GrandeErcole’ di Goltzius siano in relazione ad affreschidella medesima sala del Palazzo Farnese: disegni diFederico relativi a quel ciclo potevano ancora circo-lare nell’ambiente dei fiamminghi attivi a Roma allafine del secolo. È certo più difficile, comunque,immaginare un artista italiano riprendere quasipedissequamente, trent’anni dopo circa, un disegnodi Federico per il ciclo di Caprarola. Lo spiccatointeresse che gli artisti nordici nutrivano per l’ope-ra dello Zuccari era d’altronde ampiamente ricam-biato: Cristina Acidini Luchinat ha infatti giusta-mente indicato in Federico «il più fiammingo tratutti i pittori italiani»,69) e l’‘Amor omnia vincit’ delGetty è la conferma più clamorosa a questa defini-zione.
Desidero ringraziare il J.Paul Getty Museum di LosAngeles, che mi ha gentilmente concesso di pubblicare ildipinto raffigurante l’‘Amor Omnia Vincit’, e Ann T. Wool-lett, con la quale ho potuto discutere i temi qui trattati.
1) Christie’s London, 24 marzo 1972, lot. 52.
2) Baroque Masters from The J. Paul Getty Museum, LosAngeles 1973, pp. 7 e 8: già in questa prima scheda si parla-va di un «certain Northern feeling (Bloeamaert, Spran-ger?)». Il dossier del Getty relativo all’‘Amor omnia vincit’registra un’attribuzione a Joseph Heinz (Ellis Waterhouse;1975) e a Paolo Fiammingo (un’annotazione anonima esenza data suggerisce un rapporto con la ‘Predica di SanGiovanni Battista’ della Gemäldegalerie di Kassel che,declassata ad opera della bottega di Paolo Fiammingo, nonpresenta in realtà un confronto stringente con il dipintoGetty, cfr. B. SCHNACKENBURG, Gemäldegalerie der Alte Mei-ster Gesamkatalog, I, Mainz am Rhein 1996, p. 119).
Sulla faretra al centro del dipinto sono riportate le lettere“D. COPP”: potrebbe trattarsi della firma dell’autore, mafino ad oggi non è stato individuato un artista dal nomericonducibile all’iscrizione.
3) B. FREDERICKSEN, Summary of Zuccaro attribution,1981, dattiloscritto allegato al dossier Getty.
4) D. DEGRAZIA, Bertoia, Mirola and the Farnese Court,Bologna 1991, p. 74, nota 17; il parere della DeGrazia èriportato in C. ACIDINI LUCHINAT, Taddeo e Federico Zuccarifratelli pittori del Cinquecento, Milano–Roma 1998–1999, II,p. 41, nota 60.
5) Il disegno è stato pubblicato in Federico Zuccari eDante, catalogo della mostra, a cura di C. GIZZI, Milano1993, pp. 252 e 324. L. PARTRIDGE (Federico Zuccari atCaprarola, 1561–1569. The graphic evidence, in DerMaler Federico Zuccari. Ein römisches Virtuoso von europäi-schen Ruhm, supplemento a Römisches Jahrbuch derBibliotheca Hertziana, 32, 1997–1998, p. 179) ha per primoricollegato il disegno all’affresco di Caprarola.
6) Il passo è tradotto in H. RÖTTGEN, Il Cavalier Giusep-pe Cesari d’Arpino. Un grande pittore nello splendore dellafama e nell’incostanza della fortuna, Roma 2002, pp. 277 e278, ed è riportato, in lingua originale, in H. NOË, Carelvan Mander en Italië, The Hague 1954, p. 284.
7) RÖTTGEN, op. cit., 2002, p. 277.
8) G. BAGLIONE, Le vite de’ pittori scultori et architetti. Dalpontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a’ tempi diPapa Urbano VIII nel 1642, Roma 1642, p. 254.
9) Questi affreschi sono stati attribuiti in passato a PietroVeri (S. CORRADINI, in Roma di Sisto V, a cura di M. L.MADONNA, Roma 1993, pp. 288 e 289) sulla scorta di unalettera in cui il pittore menzionava affreschi eseguiti inrealtà nel Palazzo di Montegiordano, cfr. L. SICKEL, PietroVeri. Ein Florentiner Künstler in Diensten der Herzogs vonBracciano, Virginio Orsini, in Marburger Jahrbuch fürKunstwissenschaft, 30, 2003, pp. 183–209.
10) Virginio Orsini, nel 1589 appena diciasettenne, risie-deva a Firenze, e giunse a Roma solo nell’aprile di quell’an-no, cfr. V. CELLETTI, Gli Orsini di Bracciano, Roma 1963, p.135; RÖTTGEN, op. cit., 2002, p. 278. La datazione al 1594circa degli affreschi del D’Arpino è stata riconfermata da L.
72
SICKEL, The Collection of Corradino Orsini, in The Burling-ton Magazine, CXLVI, 2004, p. 459.
11) Nel dicembre del 1589 lo Zuccari, secondo le paroledi Bernardo Maschi, era «stato consolato dal Re di poterse-ne tornare a casa sua», ma evidentemente l’artista si tratten-ne in Spagna per qualche tempo ancora, cfr. G. GRONAU,Documenti artistici urbinati, Firenze 1936, p. 222; ACIDINILUCHINAT, op. cit., 1999, pp. 166 e 176, nota 47. La letteradello Zuccari al Duca di Urbino è andata perduta, ma adessa faceva riferimento lo stesso Duca nella sua risposta del19 aprile, cfr. GRONAU, op. cit., p. 223.
12) GRONAU, op. cit., p. 223; ACIDINI LUCHINAT, op. cit.,1999, p. 178.
13) Archivio di Stato di Roma, 30 Notai Capitolini, Uffi-cio 19, vol. 23, notaio Martino Trucca, cc. 15r–15v. Il docu-mento è citato, con una data e una collocazione archivisticaimprecisa, in A. BERTOLOTTI, Artisti urbinati in Roma primadel secolo XVIII, Urbino 1881, p. 20. Cfr. anche W. KÖRTE,Der Palazzo Zuccari in Rom. Sein Freskenschmuck undseine Geschichte, Leipzig 1935, p. 77; B. MÜLLER, Casa Zuc-cari a Firenze e Palazzo Zuccari a Roma. Casa d’artista ecasa dell’arte, in Case d’artista dal Rinascimento a oggi, acura di E. HÜTTINGER, Torino 1992, p. 102; ACIDINI LUCHI-NAT, op. cit., 1999, p. 227, nota 7 (in cui, per un refuso, èriportato il 1588 al posto del 1589). Il 18 aprile 1590 Zucca-ri acquistò il terreno sul quale avrebbe costruito il PalazzoZuccari (KÖRTE, op. cit., pp. 79–81).
14) Un episodio simile, peraltro, era già stato alla basedel licenziamento di Federico dal cantiere del Palazzo Farne-se di Caprarola nel 1569, cfr. ACIDINI LUCHINAT, op. cit.,1999, p. 29.
15) H. DOLLMAYR (Lo stanzino da bagno del cardinalBibiena, in Archivio Storico per l’Arte, III, 1890, p. 278),tratto in inganno dall’incisione di Piroli, riteneva che unadelle scene perdute sulle pareti raffigurasse la lotta di Pan eAmore. L’errore è stato riportato più volte (cfr. ad esempioA. GNANN, in Roma e lo stile classico di Raffaello 1515–27,catalogo della mostra, a cura di K. OBERHUBER, Milano1999, p. 109), ma è altamente improbabile che l’‘Amoromnia vincit’ fosse raffigurato due volte nello stesso ambien-te, cfr. N.E. EDWARDS, The Renaissance “Stufetta” in Rome:the Circle of Raphael and the recreation of the Antique,Ph.D. University of Minnesota, Ann Arbor 1982, pp. 20 e23; H. MALME, La “stufetta” del Cardinal Bibbiena e l’icono-grafia dei suoi affreschi principali, in Quando gli Dei si spo-gliano. Il bagno di Clemente VII a Castel Sant’Angelo e lealtre stufe romane del primo Cinquecento, Roma 1984, p. 50;di opinione diversa F. RUFFINI, Commedia e festa nel Rina-scimento. La “Calandria” alla corte di Urbino, Bologna1986, p. 57. Non ci sono dubbi, comunque, che Piroli incisel’affresco della volta, cfr. J. D. PASSAVANT, Raffaello d’Urbinoe il padre suo Giovanni Santi (Londra 1860), Firenze 1889,II, pp. 262 e 267. La scena con l’‘Amor omnia vincit’ sullavolta è ancora in parte distinguibile, cfr. D. REDIG DE CAM-POS, La stufetta del Cardinal Bibbiena in Vaticano e il suorestauro, in Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte, XX,1983, p. 237, fig. 27. È certo che per la sua serie di riprodu-zioni Piroli si rifece in gran parte agli affreschi della LoggiaStati sul Palatino (oggi all’Ermitage di San Pietroburgo), aloro volta esemplati sulle incisioni di Raimondi e della suascuola (A. FORCELLINO, La decorazione della Loggia Stati sulPalatino, in Storia dell’arte, 51, 1984, p. 123), ma per ripro-
durre gli episodi della ‘Nascita di Erittonio’ e dell’‘Amoromnia vincit’ egli dovette necessariamente avere una cono-scenza diretta degli affreschi della Stufetta in Vaticano, allaquale ebbe forse accesso tra il 1798 e il 1799, quando Romavenne sconvolta dall’invasione napoleonica; cfr. F. SPESSO,Tommaso Piroli, incisore romano (1750–1824): proposte perun catalogo, in Nuovi Annali della scuola speciale per archi-visti e bibliotecari, IX, 1995, pp. 89–91.
Negli amorini che portano come trofei gli attributi deglidèi dell’Olimpo raffigurati nelle lunette della Loggia di Psi-che alla Farnesina è individuabile un riferimento all’adagiodell’‘Amor omnia vincit’, cfr. S. CAVICCHIOLI, Le metamorfosidi Psiche. L’iconografia della favola di Apuleio, Venezia2002, p. 74.
16) Amore, Pan e Venere vennero raffigurati insieme inun piccolo riquadro decorativo della volta della Sala dellaBiblioteca in Castel Sant’Angelo, opera di Luzio Romano(1546; Gli affreschi di Paolo III a Castel Sant’Angelo. Pro-getto ed esecuzione 1543–1548, II, Disegni, cat. dellamostra a cura di F.M. ALIBERTI GAUDIOSO, E. GAUDIOSO,Roma 1981, p. 18), ma la composizione non costituisce unvero e proprio ‘Amor omnia vincit’. Nel 1565 circa LucaCambiaso raffigurò un ‘Amor omnia vincit’ in un affrescoperduto in Palazzo Meridiani a Genova che venne descrittodal Ratti e per il quale si conserva un disegno preparatorioa Princeton, cfr. W. SUIDA, B. SUIDA MANNING, Luca Cam-biaso. La vita e le opere, Milano 1958, pp. 19, 92 e 275. L’o-pera, isolata, non poteva essere nota a Roma e a Bologna,città in cui il tema conobbe grande fortuna alla fine delsecolo.
17) R. WITTKOWER, The Drawings of the Carracci in theCollection of Her Majesty the Queen at Windsor Castle, Lon-don 1952, pp. 111 e 112; D. DEGRAZIA, Le stampe dei Car-racci, edizione italiana a cura di A. BOSCHETTO, Bologna1984, pp. 46 e 190–192; C. ROBERTSON, Ars Vincit Omnia:the Farnese gallery and Cinquecento Ideas about Art, inMélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditer-ranée, 102, 1990, p. 21; R. WILLIAMSON, “Omnia vincitamor”: un dipinto di Agostino Carracci, in Atti e Memorie.Accademia Clementina, 30–31, 1992, pp. 111–150; B. BOHN,Agostino Carracci, in The Illustrated Bartsch, 39, Part 1,New York 1995, pp. 5 e 359–361.
Un disegno di Oxford raffigurante l’‘Amor omnia vincit’già attribuito a Correggio, è ora giudicato una copia di Wat-teau da una composizione perduta riferibile ai Carracci, cfr.A. PIGLER, Barockthemen, II, Budapest 1974, p. 19; A.E.POPHAM, Correggio’s Drawings, London 1957, p. 189, A92.
18) ACIDINI LUCHINAT, op. cit., 1999, pp. 22–24. Cfr.anche E.S. WATSON, Achille Bocchi and the Emblem Book asSymbolic Form, Cambridge 1993, pp. 143–147.
19) Sull’interesse dello Zuccari per l’invenzione allegoricain genere cfr. soprattutto J.M. MASSING, Du texte a l’image.La “Calomnie d’Apelle” et son iconographie, Strasbourb1990, pp. 197–211 e A.F. DONI, Pitture del Doni AcademicoPellegrino, a cura di S. MAFFEI, Napoli 2004, pp. 53–60. LoZuccari eseguì anche il disegno preparatorio per una delleincisioni della celebre edizione del 1640 dei Documenti d’a-more di Francesco da Barberino, cfr. F. BARBERINI, FrancescoBarberini e l’edizione seicentesca dei “Documenti d’amore”,in Xenia Antiqua, II, 1993, pp. 132 e 145, nota 37.
20) RÖTTGEN, op. cit., 2002, p. 281.
73
21) A. NOVA, Salviati, Vasari, and the reuse of drawings intheir working practice, in Master Drawings, XXX, 1992, pp.83–108.
22) ACIDINI LUCHINAT, op. cit., 1999, pp. 38, 39 e 181.
23) ACIDINI LUCHINAT, op. cit., 1999, pp.143–148.
24) Proprio per voler leggere gli affreschi del Cavalierd’Arpino in strettissima relazione con quel matrimonio, B.GILONE (Omnia vincit amor: la loggia del Cavalier d’Arpinonel Palazzetto di Sisto V in Parione, Roma 2000, p. 66) èarrivata a indicare in Virginio Orsini, piuttosto che in Corra-dino, il committente del ciclo, anticipandone la datazione al1589 circa. Ma oltre a Baglione, anche G. MANCINI (Conside-razioni sulla pittura, edizione a cura di A. MARRUCHI e L.SALERNO, Roma 1956, I, p. 238) indica precisamente il nomedi Corradino Orsini.
25) RÖTTGEN, op. cit., 2002, p. 278. Sul possibile pro-gramma iconografico che sarebbe stato elaborato da Tassoper gli affreschi della Loggia Orsini cfr. soprattutto H.RÖTTGEN, Giuseppe Cesaris Fresken in der Loggia Orsini.Eine Hochzeitsallegorie aus dem Geist Torquato Tassos, inStoria dell’arte, 3, 1969, pp. 279–295; cfr. anche S. PIERGUI-DI, Roma. Palazzetto del Pio Sodalizio dei Piceni, in C. CIERIVIA, L’arte delle Metamorfosi. Decorazioni mitologiche nelCinquecento, Roma 2003, pp. 272–274. Già R. ZAPPERI (Erose Controriforma. Preistoria della Galleria Farnese, Torino1994, pp. 110–112; Per la storia della Galleria Farnese.Nuove ricerche e precisazioni documentarie, in Bollettinod’arte, LXXXIV, 1999, 109–110, p. 98) ha più volte sottoli-neato, invece, come nella Roma di Clemente VIII il cicloOrsini sia, insieme a quello carracceso della Galleria Farne-se, l’unico di soggetto erotico–mitologico.
26) E. PANOFSKY, Studi di Iconologia (New York 1939),Torino 1975, pp. 177 e 178.
27) G. DE TERVARENT, Eros and Anteros or ReciprocalLove in Ancient and Renaissance Art, in Journal of the War-burg and Courtauld Institutes, XXVIII, 1965, pp. 205–208.La piu’ importante trattazione rinascimentale della figura diAnteros si deve all’umanista CELIO CALCAGNINI, Anteros sivede mutuo amore, Basilea 1544, cfr. R. V. MERRILL, Eros andAnteros, in Speculum, XIX, 1944, pp. 244–247.
28) Al disegno di Agostino si rifece poi Guido Reni in undipinto oggi a Genova, Galleria di Palazzo Spinola, cfr. C.DEMPSEY, “Et nos cedamus amori”: Observations on the Far-nese Gallery, in The Art Bulletin, L, 1968, pp. 364 e 365.Cfr. anche BOHN, op. cit. 1995, pp. 266–270.
All’iconografia di Eros e Anteros, nel loro significato diAmor sacro e Amor profano, si ricollega anche la ‘Venere esatiro con due amorini’ di Annibale (1589–1590 circa; Firen-ze, Uffizi), in cui però i due Cupidi non sono in lotta traloro. Il gesto con il quale Anteros tiene a bada il satiro èperaltro lo stesso impiegato in molte raffigurazionidell’‘Amor omnia vincit’. È a volte difficile distinguere un‘Amor omnia vincit’ dalla raffigurazione di un Amore chedifende Venere dall’assalto di un satiro: in due disegni simi-li di Nicolas Poussin a Windsor, ad esempio, compare unavolta Pan (identificabile dalla siringa e dal bastone;1625–1627 circa) e un’altra un semplice satiro (1636–1639circa) cfr. B. WIND, Annibale Carracci’s “Venus, Satyr andtwo Cupids” reconsidered, in Storia dell’arte, 51, 1984, pp.127–130; M. CLAYTON, Poussin: works on paper. Drawingsfrom the collection of Her Majesty Queen Elizabeth II, cata-
logo della mostra, Londra 1995, pp. 46–47 e 142–143; A.BROGI, in Annibale Carracci, catalogo della mostra a cura diD. BENATI, E. RICCOMINI, Milano 2006, pp. 198 e 199. Cfr.anche nota 51.
29) C. ROBERTSON, Annibal Caro as iconographer: Sourcesand Method, in Journal of the Warburg and CourtauldInstitutes, XLV, 1982, pp. 160–181.
30) PANOFSKY, op. cit., 1975, p. 178, nota 87; K. HERR-MANN FIORE, Die fresken Federico Zuccaris in sinem römi-schen künstlerhaus, in Römisches Jahrbuch für Kunstgeschi-chte, 18, 1979, pp. 62 e 63; ACIDINI LUCHINAT, op. cit., 1999,p. 211, fig. 66.
31) Non a caso la loggia affrescata poi dal Cavalier d’Ar-pino avrebbe accolto nelle lunette un ciclo delle ‘Fatiched’Ercole’, tema presente anche nella decorazione del Palaz-zetto Zuccari, cfr. ACIDINI LUCHINAT, op. cit., 1999, pp.205–207.
32) Cfr. da ultimo ZAPPERI, op. cit., 1999, pp. 87–102.
33) G. P. BELLORI, Le vite de’ pittori, scultori et architettimoderni, Roma 1672, pp. 47 e 48. A questi gruppi si rifeceforse Alessandro Turchi nella sua complessa ‘Allegoria delpotere dell’Amore’ (1625 circa; Apeldoorn, Paleis Het Loo),cfr. D. SCAGLIETTI KELESCIAN, in Alessandro Turchi dettol’Orbetto 1578–1649, catalogo della mostra, Milano 1999,p. 128.
34) DEMPSEY, op. cit., 1968 (lo studioso ha più volte ripre-so la sua lettura, cfr. in particolare C. DEMPSEY, Annibal Car-rache au Palais Farnèse, in Le Palais Farnèse, Roma 1981,pp. 288–292). L’articolo del 1968 venne pubblicato a treanni di distanza dalla monografia di J.R. MARTIN (The Far-nese Gallery, Princeton 1965, cfr. in particolare pp. 87–89),in cui veniva riconfermata la tradizionale lettura bellorianadelle quattro coppie di amorini.
35) Sulla questione è intervenuta recentemente, in piùoccasioni, S. GINZBURG CARIGNANI (Annibale Carracci aRoma. Gli affreschi di Palazzo Farnese, Roma 2000, pp. 136,137 e 142; Sulla datazione e sul significato degli affreschidella Galleria Farnese, in Studi di Storia dell’Arte in onoredi Denis Mahon, a cura di M.G. BERNARDINI, S. DANESISQUARZINA, C. STRINATI, Milano 2000, pp. 95–101; Annibalein palazzo Farnese a Roma, in Annibale Carracci ..., cit.,pp. 455 e 456), che ha riconfermato il legame tra la decora-zione della galleria e il matrimonio di Ranuccio Farnese eMargherita Aldobrandini. Secondo la studiosa Bellori nonavrebbe affatto “censurato” il significato degli affreschi, poi-ché, come già sottolineato da DEMPSEY (op. cit.,1968, p.288), egli aveva capito perfettamente che l’‘Anteros’ affresca-to nella Galleria Farnese doveva essere inteso nel suo signifi-cato classico di amore corrisposto. E questo è stato riconfer-mato in P. SABBATINO, “La guerra e la pace tra ‘l celeste e ‘lvulgare Amore”. Il poema pittorico di Annibale Carracci el’ecfrasi di Bellori (1657 e 1672), in Ecfrasi. Modelli pitto-rici ed esempi fra Medioevo e Rinascimento, a cura di G.VENTURI, M. FARNETTI, Roma 2004, II, pp. 500 e 501. Ma sideve pure ammettere che secondo Bellori le altre tre coppieraffigurerebbero «la guerra, e la pace tra’l celeste, e’l vulgareAmore», mentre la presenza della palma (elemento chiavedella contesa tra Eros e Anteros nell’iconografia classica)accantonata alla base di un altro dei pennacchi angolari(DEMPSEY, op. cit., 1968, p. 364) non lascia dubbi sul fattoche almeno un’altra delle coppie fosse una semplice varia-
74
zione sul tema dell’Eros e Anteros nel suo significato corret-to. In un altro dei pennacchi, come è noto, comparel’‘Amore Letheo’, anch’esso derivato da Cartari e già raffigu-rato da Bartolomeo Cesi in uno dei camini di PalazzoMagnani (ROBERTSON, op. cit., 1990, p. 21). EvidentementeAgostino fece ricorso a tutto il suo bagaglio di conoscenze diiconografia classica, ed è quindi probabile che gran partedella responsabilità dell’invenzione spettasse al maggioredei Carracci. Questi, sebbene piuttosto colto, difficilmenteavrebbe potuto elaborare un programma tanto complessocome quello che la GINZBURG CARIGNANI (op. cit., 2000, pp.102–105) ha individuato nella Galleria Farnese (per avereun verosimile termine di paragone si legga, ad esempio, lacelebre lettera del 1601 di Silvio Antoniano a Pietro Aldo-brandini in merito ai temi da raffigurare nella sua villa diFrascati, cfr. C. ROBERTSON, Silvio Antoniano and the Pain-ted Decoration of the Villa Belvedere at Frascati, in Römi-sches Jahrbuch für Kunstgeschichte, 35, 2003/2004, pp.415–430). D’altronde è noto che le quattro coppie di amori-ni non erano previste nelle prime fasi della progettazionedel ciclo, e non è lecito vedervi la chiave di volta dell’interoprogramma (ROBERTSON, op. cit., 1990, p. 18). Cfr. anche S.COLONNA, Arte e letteratura. La civiltà dell’emblema in Emi-lia nel Cinquecento, in La pittura in Emilia e in Romagna.Il Cinquecento, I, Bologna 1995, p. 120.
36) BELLORI, op. cit., p. 111; J. ANDERSON, The “Sala diAgostino Carracci” in the Palazzo del Giardino, in The ArtBulletin, LII, 1970, pp. 42 e 43. Cfr. anche F. BAROCELLI,Agostino Carracci e gli “Amori” di Ranuccio Farnese, inAurea Parma, LXXIX, 1995, pp. 15–57.
37) ANDERSON, op. cit., pp. 44, 47 e 48.
38) DEGRAZIA, op. cit., p. 176.
39) Sull’emblema del Corrozet cfr. M. PRAZ, Studies inSeventeenth–Century Imagery, London 1939, p. 91. Sultema cfr. anche R. BONNEFOIT, “Aurum omnia vincit”. Lo“Studiolo della ricchezza” dell’umanista romano Antoniodegli Effetti, in Dialoghi di storia dell’arte, 4/5, 1997, p. 77.
40) V. VON FLEMMING, Arma Amoris. Sprachbild und Bild-sprache der Liebe. Kardinal Scipione Borghese und dieGemäldeszyklen Francesco Albani, Mainz 1996; S. PIERGUIDI,Gli affreschi del salone Peretti: il tema dei quattro elementi ela cultura alchemica, in Storia dell’Arte, 103, 2002, pp. 47 e48; S. PIERGUIDI, Some iconographic motifs in sixteenth– andseventeenth–century emilian mythological painting, in Sour-ce, XXII, 2003, 2, pp. 29–35.
41) Cfr. nota 35.
42) GINZBURG CARIGNANI, op. cit., 2000, p. 102; cfr. anchenota 35.
43) D.S. PEPPER, Agostino Carracci and Venice. A briefaccount of his relationship, in Per l’arte. Da Venezia all’Eu-ropa. Studi in onore di Giuseppe Maria Pilo, a cura di M.PIANTONI, L. DE ROSSI, I, Venezia 2001, pp. 247–251. Cfr.anche J. MEYER ZUR CAPELLEN, Paolo Veronese e i giovaniCarracci, in Accademia Clementina. Atti e Memorie, 32,1993, pp. 143–151.
44) T. PIGNATTI, F. PEDROCCO, Veronese, Milano 1995, pp.115–117. Cfr. anche C. HOPE, Veronese and the VenetianTradition of Allegory, in Proceedings of the British Academy,LXXI, 1985, p. 415. Gli affreschi del Palazzo Trevisan sonomolto rovinati, e sono quindi meglio giudicabili attraverso le
incisioni settecentesche dello Zanetti (figg. 11 e 12), cfr. P.TICOZZI, Le incisioni da opere del Veronese nel Museo Correr,in Bollettino dei Musei Civici Veneziani, XX, 1975, 3–4, p.34, nn. 87–88. Sul tema di Eros e Anteros nell’opera di Vero-nese cfr. PIGNATTI, PEDROCCO, op. cit., p. 240 e A. GENTILI,Miti e allegorie d’amore, in Veronese. La pittura profana,Art/Dossier, 209, marzo 2005, pp. 10–15.
45) M. CALVESI, Le realtà del Caravaggio, Torino 1990,pp. 5 e 25.
46) Su queste incisioni cfr. BOHN, op. cit., pp. 310 e 311.
47) Così, secondo la GINZBURG CARIGNANI (op. cit., 2000,p. 101), andrebbe letto il medaglione bronzeo con l’‘Amoromnia vincit’ della Galleria Farnese.
48) S. DANESI SQUARZINA, in Caravaggio e i Giustiniani.Toccar con mano una collezione del Seicento, catalogo dellamostra a cura di S. DANESI SQUARZINA, Milano 2001, pp.282–286 (con ampia bibliografia precedente). Sulla fortunadel tema dell’‘Amore vincitore’ in ambito caravaggesco cfr.B. NICHOLSON, Caravaggism in Europe, I, Torino 1989, pp.88, 116 e 163 e R. VODRET, in Caravaggio e i suoi. Percorsicaravaggeschi in Palazzo Barberini, catalogo della mostra acura di C. STRINATI, R. VODRET, Roma–Napoli 1999, p. 76.
49) E. MANDOWSKY, Ricerche intorno all’Iconologia delRipa, in La Bibliofilia, XLI, 1939, pp. 122 e 123.
50) DANESI SQUARZINA, op. cit., pp. 298–301 (con biblio-grafia precedente).
51) Baglione, figura di primo piano a Roma in queglianni, dovette certamente visitare il Palazzo Zuccari, che ter-minato nel 1593 venne decorato dallo Zuccari a partire daquell’anno, e sarebbe stato in seguito descritto dallo stessoBaglione nelle sue Vite, cfr. ACIDINI LUCHINAT, op. cit., 1999,pp. 199 e 203.
In questo contesto è opportuno ricordare il dipinto diBaglione conservato al Museo di Valencia in cui è raffigura-to un Amorino che trattiene un satiro che si dirige verso unafigura femminile nuda. Sebbene anche in questo caso la for-mula figurativa dell’Amorino che tiene per i capelli il satirosia quella classica dell’‘Amor omnia vincit’, il dipinto ha cer-tamente un significato di carattere moraleggiante, cfr. F.ZERI, Giovanni Baglione pittore erotico, in Antologia di BelleArti, I, 1977, pp. 339–341; H. RÖTTGEN, Quel diavolo èCaravaggio. Giovanni Baglione e la sua denuncia satiricadell’ “Amore terreno”, in Storia dell’arte, 79, 1993, p. 335;R.W. BISSELL, Artemisia Gentileschi and the Authority of Art,University Park 1999, pp. 299–301. Un soggetto similevenne raffigurato dal Cavalier d’Arpino in un disegno oggiin collezione privata, cfr. RÖTTGEN, op. cit., 2002, pp. 87 e88. Cfr. anche nota 28.
52) BAGLIONE, op. cit., p. 136. Il dipinto doveva essere cer-tamente lo stesso indicato come lo «Sdegnio che si è messosotto i piedi Amore con tutte le sue armi» in una lettera del1613 di Giulio Mancini, che lo ricordava nella collezionedello stesso Del Monte. In considerazione prima di tutto diquesta descrizione piuttosto precisa, è impossibile accoglierela proposta di M. MARINI (Caravaggio. Michelangelo Merisida Caravaggio “pictor praestantissimus”, Roma 1987, pp.132–133 e 384–385) di identificare in un dipinto di collezio-ne privata a Firenze, in cui un Amor sacro stranamente privodi ali lega le braccia dietro la schiena all’Amor profano, unacopia del perduto quadro di Caravaggio. Lo stesso Mancini,
75
per conto di Agostino Chigi, commissionò a BartolomeoManfredi una replica libera dello stesso dipinto, identificabi-le con il ‘Marte punisce Amore alla presenza di Venere’ (Chi-cago, Art Institute), cfr. M. MACCHERINI, Caravaggio nel car-teggio familiare di Giulio Mancini, in Prospettiva, 86, 1997,p. 71 e M. MACCHERINI, Novità su Bartolomeo Manfredi nelcarteggio familiare di Giulio Mancini: lo “Sdegnio” e i qua-dri di Cosimo II Granduca di Toscana, in Prospettiva, 93–94,1999, pp. 131–133. Nella collezione di Agostino Chigi eraanche un ‘Amor sacro e Amor profano’ dipinto a Roma intor-no al 1603 da Francesco Vanni (Gerusalemme, IsraelMuseum), e un ‘Amore vincitore’ di Astolfo Petrazzi (Roma,Galleria Nazionale d’Arte Antica), cfr. MACCHERINI, op. cit.,1997, p. 88, nota 11 e B. SANI, in Alessandro VII Chigi(1599–1667). Il Papa Senese di Roma Moderna, catalogodella mostra, Siena 2000, pp. 74–75 e 83–84.
53) A Poussin si deve anche un ‘Amor omnia vincit’ dipoco precedente (1626–1627 circa; Cleveland, The Cleve-land Museum of Art), cfr. D. MAHON, Gli esordi di NicolasPoussin pittore: lavori dei suoi primi anni a Roma, in Nico-las Poussin. I primi anni romani, catalogo della mostra,Milano 1998, p. 72; C. VOLPI, I temi di Poussin romano, ibi-dem, p. 123. Cfr. anche nota 28.
54) Una targhetta sul retro del dipinto, apparentementedel 1900 circa, riporta il nome del corniciaio romano LuigiDella Marra.
55) C. VAN DE VELDE, Veen, Otto van, in The Dictionary ofArt, 32, London 1996, pp. 114 e 115. Sui libri di emblemicfr. il classico studio di PRAZ, op. cit. Negli Emblemata ama-toria di David Hensius (Leida 1608) e negli stessi AmorumEmblemata, peraltro, la massima virgiliana dell’‘Amor omniavincit’ era raffigurata da un cupido a cavallo di un leone,immagine derivata dall’Emblematum Liber dell’Alciati, cfr.O. VAENIUS, Amorum Emblemata, ed. cons. con introduzionedi K. PORTEMAN, Aldershot 1996, pp. 90 e 91; PRAZ, op. cit.,pp. 80 e 95. La formula figurativa di Amore che sottomettePan, rinata in Italia, sarebbe arrivata al Nord solo più tardi(si può qui citare un dipinto, sempre al Getty, attribuitoall’ambito di Jacob Jordaens, cfr. Baroque Masters ..., cit.,pp. 15 e 16). Anche questo elemento suggerisce che l’‘Amoromnia vincit’ di Los Angeles sia stato dipinto a Roma.
56) DEGRAZIA, op. cit., pp. 45, 46 e 192.
57) L’artista–biografo olandese aveva una solida prepara-zione umanistica: egli tradusse sia le Ecloghe che le Georgi-che di Virgilio, oltre alle Immagini degli dei di Cartari, edisegnò anche diverse imprese ed emblemi, incise poi dal
Matham, cfr. M. LEESBERG, Karel van Mander as a painter,in Simiolus, 22, 1993/94, pp. 38 e 44.
58) T. DACOSTA KAUFMANN, The School of Prague. Pain-ting at the Court of Rudulfus II, Chicago 1988, p. 274.
59) Solo la componente paesaggistica, sicuramente moltosignificativa nel dipinto Getty, non sembra riconducibile agliartisti appena menzionati, e farebbe piuttosto pensare ai pit-tori stranieri attivi a Roma nei primi anni del Seicento vicinia Adam Elsheimer e a Carlo Saraceni, sui quali cfr. A. OTTA-NI CAVINA, Carlo Saraceni, Milano 1968, pp. 16–20. Sullapittura di paesaggio a Roma a cavallo tra i secoli XVI e XVIIcfr. soprattutto F. CAPPELLETTI, Paul Bril e la pittura di pae-saggio a Roma 1580 – 1630, Roma 2006.
60) È probabile che il fiammingo abbia ritratto lo Zuccariin un disegno oggi a Berlino, cfr. C. VAN TUYLL VAN SEROO-SKERKEN, in Fiamminghi a Roma 1508–1608, catalogodella mostra, Milano 1995, pp. 167 e 168.
61) L. WIDERKEHR, Jacob Matham and the Diffusion ofRecent developments in Roman Art in Northern Europe, inFiamminghi a Roma 1508–1608, atti del convegno (Utre-cht 1995), Firenze 1999, pp. 94–98.
62) ACIDINI LUCHINAT, op. cit., 1998, pp. 278 e 279; C.ACIDINI LUCHINAT, Federico Zuccari e la divulgazione, inFederico Zuccari. Le idee, gli scritti, a cura di B. CLERI, Mila-no 1999, p. 178.
63) WIDERKEHR, op. cit., p. 93.
64) L’affresco in questione venne terminato da Jacopo Ber-toja dopo il licenziamento dello Zuccari, cfr. ACIDINI LUCHI-NAT, op. cit., 1999, p. 29; E. SPRANGER, in Hendrick Goltzius(1558–1617). Drawings, Prints and Paintings, catalogodella mostra (Amsterdam–New York–Toledo 2003–2004),Zwolle 2003, pp. 106–108.
65) LEESBERG, op. cit., p. 18.
66) V. BÜCKEN, Deux flamands dans l’atelier de JacopoBertoja: Joos van Winghe et Bartholomäus Spranger, inLelio Orsi e la cultura del suo tempo, atti del convegnointernazionale di studi (Reggio Emilia – Novellara 1988),Bologna 1990, pp. 49 e 50.
67) M. VAES, Les séjour de Carel van Mander en Italie1573–77, in Hommage à Dom Ursmer Berlière, Bruxelles1931, p. 236.
68) VAES, op. cit., p. 229.
69) ACIDINI LUCHINAT, op. cit., 1999, p. 175.
76