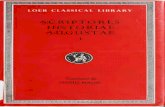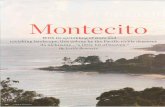Proprietà di Augustae a Roma e nel Latium vetus, in A. Kolb (a cura di) Augustae. Machtbewusste...
Transcript of Proprietà di Augustae a Roma e nel Latium vetus, in A. Kolb (a cura di) Augustae. Machtbewusste...
Proprietà di Augustae a Roma e
nel Latium vetus
Maria Grazia Granino Cecere
Nur selten und fl üchtig werden in den literarischen Quellen Güter oder Anwesen in Rom oder Latium vetus erwähnt, die ausdrücklich als Eigentum einer Augusta bezeichnet werden. Es sind vielmehr die epigraphischen Quellen – manchmal unterstützt durch archäologische Befunde und Toponyme –, die es uns erlauben, ein Bild – wenn auch ein lückenhaftes – im Hinblick auf diese Fragestellung zu skiz-zieren.
Solo rari e fugaci passi tra le fonti letterarie rivelano l’esistenza di proprietà e luoghi di residenza espres-samente indicati come appartenenti alle Augustae sia nell’Urbe che nelle località del Latium vetus. Sono piuttosto i documenti epigrafici, che talvolta hanno trovato riscontro anche nei rinvenimenti archeologici e particolari toponimi prediali, a consentire di tracciare un quadro, seppur lacunoso, delle attuali conoscenze in merito.
Literary sources unfortunately only rarely testify the existence of estates or residence places belonging to Augustae. This is true for Rome as well as for other centres of Latium vetus. Rather it is the epigraphic evidence – sometimes in combination with archaeological and toponymic findings – which allows us to paint a broader, if still incomplete, picture of the situation.
Quello della proprietà imperiale è argomento particolarmente sentito, di frequente aff rontato e tema anche di un recente convegno, di cui sono stati appena pubblicati gli atti.1 Ma parlare delle proprietà delle imperatrici è altra cosa che parlare della proprietà imperiale, anche se si tratta di un argomento a questo contiguo, per una serie di motiva-zioni di ordine metodologico, storico e, naturalmente, economico.
Di certo le donne della casa imperiale non hanno la stessa « visibilità » degli uomini e le fonti a nostra disposizione sono di gran lunga meno numerose. A maggior ragione in merito all’argomento in esame, perché spesso le proprietà delle donne della casa imperiale sono confl uite in modo più o meno diretto nel patrimonio imperiale e della loro presenza si perde presto traccia nella documentazione.
Pur nella esiguità, del resto relativa, delle fonti, è tuttavia possibile proporre un qua-dro generale, privilegiando argomenti che riguardano aspetti forniti essenzialmente dalla documentazione epigrafi ca; ma ciò solo se si accolgono limiti geografi ci e cronologici ben
1 Pupillo 2007. L’argomento meritava una sistematica rifl essione, poiché ancora punto di riferimento si proponeva l’accurato ma datato lavoro di Hirschfeld 1913.
06_Granino_1U.indd 11106_Granino_1U.indd 111 13.12.2009 16:13:2613.12.2009 16:13:26
Maria Grazia Granino Cecere112
defi niti. E’ per questo che il presente, breve contributo s’incentra esclusivamente sulle atte-stazioni che riguardano l’Urbe e il Latium vetus, e per il periodo che va dall’età di Augusto a quella dei Severi, quando il mutare profondo della realtà politica ha avuto ampi rifl essi anche nell’ambito preso in esame.
Ancora una premessa necessaria: nel trattare di proprietà s’intende far riferimento non solo a praedia, villae, horti, domus, ma anche a strutture di carattere esclusivamente eco-nomico e commerciale, strutture che talvolta risultano diffi cilmente defi nibili attraverso la fonte a disposizione; ciò vale in particolare per l’uso al presente fi ne delle fi stule, come hanno ampiamente dimostrato gli studi di Eck e soprattutto di Bruun.2
E’ chiaro che non verranno prese in considerazione le donne della casa imperiale quali dominae fi glinarum, argomento di particolare interesse, per il quale si veda il contributo di Chausson e Buonopane in questi stessi atti; allo stesso modo riguardo alle proprietà di Matidia minor mi soff ermerò solo per quelle presenti nell’area in esame,3 poiché ad una visione d’insieme attende l’intervento di Bruun.
Le fonti letterarie ci informano certo dell’esistenza di proprietà, di ville, di residenze, di horti, ma è di norma il dato epigrafi co quello che consente di localizzarli nel territorio. Solo in rari casi alle fonti letterarie ha fatto riscontro il mero dato archeologico, senza l’apporto di quello epigrafi co, come è accaduto per la villa suburbana di Livia ad Gallinas Albas:4 la precisa collocazione al IX miglio della Flaminia off erta dalle fonti5 fu suffi ciente al Guattani e al Nibby per riconoscere nelle imponenti sostruzioni da sempre visibili sul fi anco della collina dominante la valle del Tevere la villa di Livia,6 attribuzione confermata in seguito dal rinvenimento in essa della ben nota statua loricata di Augusto di Prima Porta, ora nei Musei Vaticani.
Ma già per la domus della donna sul Palatino, l’attribuzione dell’abitazione di carat-tere privato situata sul Germalus tra il supercilium scalarum Caci e la domus Tiberiana è
2 Tra quelli più signifi cativi: Eck 1998a; Bruun 1991; Bruun 1995; Bruun 1997a; Bruun 1997b; Bruun 2000.
3 Si prende in considerazione Matidia minor, che non ebbe il titolo di Augusta, perché è parso oppor-tuno ampliare l’indagine anche su altre donne appartenenti alla domus imperiale, che non ottennero tale titolo, ma che di certo ebbero un ruolo signifi cativo nella vita politica ed economica.
4 Un quadro d’insieme con relativa bibliografi a sull’argomento, è tracciato da Carrara 2005; una trattazione sistematica del complesso era stata in precedenza curata da Messineo 2001.
5 Plin. nat. 15,136–137, nel narrare il noto evento che aveva visto un’aquila, passando a volo, far cadere nel grembo di Livia una gallina bianca recante un ramoscello d’alloro nel becco, cui aveva fatto segu-ito la decisione della donna di allevare la gallina e di piantare il ramoscello, che avrebbe dato luogo ad un boschetto di allori, precisa: quod factum est in villa Caesarum fl uvio Tiberi inposita iuxta nonum lapidem Flaminiae viae, quae ob id vocatur Ad Gallinas.
6 Già nel 1828 Guattani 1828, 24 attribuiva con certezza alla proprietà di Livia le imponenti sostru-zioni sulla via Tiberina, appena dopo il bivio di Prima Porta e nel 1837 Nibby 1837, 39 sottolineava l’evidente rispondenza della tecnica costruttiva in opus reticulatum tra quella usata nel mausoleo di Augusto e quella della villa ad Gallinas Albas.
06_Granino_1U.indd 11206_Granino_1U.indd 112 13.12.2009 16:13:3813.12.2009 16:13:38
113Proprietà di Augustae a Roma e nel Latium vetus
stata indotta,7 seppur con non poche incertezze, dall’associazione del passo di Suetonio8 al bollo Iuliae Aug(ustae) impresso quattro volte su di un lungo tratto di fi stula rinvenuto in un corridoio sul retro della casa.9
Così le fi stulae con il nome di Matidia minor10 – è di lei che si tratta e non di sua madre, perché ella nella denominazione « abbreviata » ama sempre defi nirsi Augustae fi lia – hanno favorito gli scavi nella località Le Cappellette, dove erano state rinvenute, e hanno rivelato probabilmente il nome del proprietario del vasto complesso edilizio che sta venendo alla luce nell’area dell’Osservatorio di Monteporzio Catone.11 Forse questa era la residenza in cui Matidia aveva ospitato le fi glie, ancor piccole, di Antonino Pio, come l’imperatore ricorda in una sua lettera a Frontone.12
Per quanto riguarda le fonti epigrafi che, problema centrale per l’individuazione delle proprietà delle donne della domus imperiale ne è un uso corretto. E’ noto che, per così dire, fossili guida per ravvisare proprietà al di fuori dell’ Urbe sono le iscrizioni di schiavi e liberti; ma da queste non bisogna trarre conclusioni fuorvianti. La presenza di un liberto da sola, senza altri elementi, non è indicativa: potrebbe attestare una sua residenza, che
7 Iacopi 1995. 8 Suet. Tib. 5: Ut plures certioresque tradunt, natus est Romae in Palatio. 9 CIL XV 7264. La fi stula fu rinvenuta nel 1869 nel corso degli scavi condotti da Pietro Rosa (Per-
rot 1875, 74–79) lungo un corridoio sotterraneo che si dirigeva dal retro della casa verso quella di Augusto; prima del suo interramento sotto l’area della domus Flavia, o meglio prima della sua interru-zione in corrispondenza di quella, presentava una diramazione sulla destra con il bollo CIL XV 7285 recante il nome di Domiziano (Tomei 2000, 17–20; Krause 2002, 85–86); sul versante opposto, sotto il pavimento del peristilio, alla fi stula si saldava un’altra con il bollo CIL XV 7265: L. Pescennius Eros // [aedes?] Caesarum. Come osserva correttamente Dressel, in CIL, ad nrr. la forma delle lettere di CIL XV 7264 ben si addice alla prima età imperiale e, anche in considerazione dell’intervento do-mizianeo, mirante a conservare l’adduzione d’acqua allorché il corridoio venne troncato dalla domus Flavia, ragionevolmente si deve riconoscere nella domina aquarum Livia dopo la morte di Augusto e non Iulia fi glia di Tito, come pure da molti proposto (ad es. R. Lanciani, CIL ad nr. e Lugli 1946, 459); le medesime caratteristiche paleografi che si riscontrano nel bollo CIL XV 7265, per il quale certo è da escludere un riferimento all’età severiana proposta da Lanciani 1880 ad nr. 156), in base al gentilizio del plumbarius Pescennius (cfr. Tomei 1999, 422–423). Per una possibile identifi cazione dell’area relativa all’aedes Caesarum, cui tale fi stola potrebbe riferirsi, vd. Krause 2002, 96–97.
10 CIL XV 7822α (cfr. Granino Cecere 2005, 308–309 nr. 389): Matidiae Aug(ustae) fi l(iae) LXX-XII; 7822β: Matidiae Aug(ustae) fi l(iae) ((palma)); 7822γ: Salon(ius) Epictetus f(ecit). Lo stesso plum-barius, Salonius Epictetus, compare in una fi stula, col sigillo di Marco Aurelio e Lucio Vero e la data zione consolare del 164, rinvenuta a Roma, nell’area di Villa Patrizi presso la via Nomentana (Friggeri 1977–1978, 151–152. Fino a pochi anni orsono le fi stule erano conservate nel Museo an-nesso all’abbazia di S. Nilo a Grottaferrata; ora la più completa è stata trasportata presso l’Osservatorio Astronomico di Monte Porzio Catone.
11 Andermahr 1998, 333. Della villa sono state fi nora individuate e scavate due distinte aree, l’una relativa ad un ampio peristilio, l’altra ad un impianto termale: Bonanno / Ghini 2004; Iorio 2006; Bonanno Aravantinos 2008.
12 Fronto, ad Antoninum imp. 4,1 (p. 105 van den Hout2): Nam parvolae nostrae nunc apud Matidiam in oppido hospitantur: igitur vespera ad me ventitare non possunt propter aurae rigorem (la lettera si data al 161 d. C.).
06_Granino_1U.indd 11306_Granino_1U.indd 113 13.12.2009 16:13:3813.12.2009 16:13:38
Maria Grazia Granino Cecere114
aveva avuto la possibilità di realizzare per sé quando era ancora in attività o nella quale si era ritirato al termine del servizio.
Di certo più signifi cativa è la presenza di schiavi, in particolare quando si tratta di vilici, dispensatores, actores o di liberti procuratores.
Qualche esempio.Presso Castell’Arcione, nella regione pianeggiante ai piedi di Tibur, è stata rinvenuta
l’ara sepolcrale del procurator summarum della già ricordata Matidia minore, L. Mindius Damaleus.13 Egli reca il gentilizio Mindius, quello che sembra possa essere accolto per la sorella di Vibia Sabina, anche se non si condividesse l’ipotesi attualmente prevalente che fa delle due donne le fi glie di due diversi matrimoni di Matidia maggiore.14 Il sepolcro del liberto di per sé non rivela una proprietà della sua patrona. Ma siamo vicini a Villa Adriana, l’amata residenza dell’imperatore, in prossimità di un vasto possedimento dei Vibii Varii,15 nei quali si potrebbero individuare connessioni parentali con Vibia Sabina, siamo a breve distanza da Tibur, dove in un luogo pubblico, forse il foro, era affi sso il testo della laudatio funebris16 che Adriano aveva pronunciato per sua suocera, a testimonianza dei vivi rapporti tra il luogo e la casa imperiale. E’ un insieme di altri elementi, accanto all’ara del procuratore, che invita dunque a localizzare in quest’area una delle numerose proprietà di Matidia minore.
Per quanto riguarda la presenza di schiavi, desidero qui presentare una migliore lettura di un un testo epigrafi co conservato in Roma, ma rinvenuto, a quanto sembra, nel 1860 in una località dell’ager Tusculanus, Le Cisternole, nella proprietà di Antonio Benedetti17 a nord dell’odierna Frascati. Il documento è stato letto solo in parte a suo tempo dal Dessau
13 Solin 1975, 66–69 nr. 112, cfr. AE 1983, 161: D(is) M(anibus) / L(uci) Mindi Damalei / Matidiae Aug(ustae) fi l(iae) lib(erti), / proc(uratoris) sum(marum). Cfr. l’iscrizione urbana CIL VI 9021: Mindio Secundo proc(uratori) Matidiae Aug(ustae) f(iliae).
14 Non si può escludere, vd. da ultimo Chausson 2007, 133, che il padre di Vibia Sabina e di Matidia la giovane recasse una polionimia che abbia determinato una diversità di gentilizio tra le due fi glie di Salonia Matidia. Tuttavia, dopo la pubblicazione dell’ara di Damaleus ad opera di Solin 1975, 66–69, ha prevalso l’opinione che fa delle due donne le fi glie di due diversi matrimoni della fi glia di Marciana, cfr. PIR2 M 368; Raepsaet Charlier 1987, 446–447 nr. 533; Reggiani 2004, 15–17 e Camodeca 2007, 154; e una serie di motivazioni, che in questa sede non possono trovare spazio adeguato, mi inducono ad accoglierla.
15 Si tratta della villa di Colli Santo Stefano, un pianoro contiguo a quello su cui sorge Villa Adriana. Vd. Mari 1991, 237–244 nr. 157; Adembri 2002, 145–147; Mari 2007, 61–63.
16 CIL XIV 3579; cfr. IIt IV 1 nr. 77. Ritengo non si debba trascurare anche il rinvenimento sempre nell’area tiburtina, di un sigillo bronzeo con il nome di un Mindius Anicetus (Sciarretta 1995, 177 nr. 2).
17 Questa è l’indicazione fornita da Benedetto Grandi, che aff erma di averla acquistata dal Benedetti (cfr. ad CIL XIV 2751). Sull’area di rinvenimento vd. Valenti 2003, 129 nr. 110 e Valenti 2008, 64–65, secondo il quale, dal momento che dalla medesima località sembra provenire anche una fi stula con il nome di Vespasiano (CIL XV 7272), si potrebbe supporre un successivo passaggio nella proprietà imperiale.
06_Granino_1U.indd 11406_Granino_1U.indd 114 13.12.2009 16:13:3913.12.2009 16:13:39
115Proprietà di Augustae a Roma e nel Latium vetus
per le cattive condizioni della superfi cie della lastra.18 Ci rivela un vilicus, servus di Messalina (fi g. 1):
D(is) M(anibus). Eutyche, Messalinae [s]er(vo) vilico,5 [– – –]ilia Char = [mo]syne con = [iug]i bene [mer]enti19.
Non possiamo esser del tutto certi del luogo di rinvenimento, non essendo sempre attendibili le dichiarazioni di Benedetto Grandi,20 che aveva acqui-stato la lastra trasportandola poi nella sua abitazione romana, dove è tuttora conservata21. Ma sappiamo da un passo di Tibullo22 che al console del 31 a. C., M. Valerius Messalla Corvinus, gli abitanti di Alba e di Tusculum dovevano esser grati per aver egli realizzato una strada che toc-cava i due centri, strada che doveva cor-rispondere per ampi tratti all’attuale trac-ciato della via Cavona. Il suo agire non era
18 CIL XIV 2751 = VI 30598,2; cfr. Granino Cecere 2005, 290–291 nr. 368. Il Dessau legge soltanto D(is) M(anibus) / Tyche / Messalinae / vilico.
19 Tutta la parte sinistra della lastra presenta una superfi cie assai corrosa, sulla quale alcune lettere (come la D di Dis o la M di Messalinae) sono state reincise con un rozzo solco.
20 Sottolineate anche da Hermann Dessau in CIL XIV, p. XV e 237; cfr. Parca 1995, 18 e 111–112 nt. 8.21 In Via Bocca di Leone, 32 (attuale palazzo della principessa Aldobrandini), vd. Granino Cecere
2005.22 Tib. 1,7,57–62 (elegia che si presenta come un ampio elogio delle doti militari e non di M. Valerius
Messalla Corvinus, scritta appena dopo il suo trionfo dell’ottobre del 27 a. C.): Nec taceat monumenta viae, quem Tuscula tellus / candidaque antiquo detinet Alba Lare;/ namque opibus congesta tuis hic glarea dura / sternitur, hic apta iungitur arte silex; / te canit agricola, a magna cum venerit urbe / serus, inoff ensum rettuleritque pedem.
Fig. 1 Roma, via Bocca di Leone, 32: iscrizione sepolcrale di un vilicus di Messa-lina (CIL XIV 2751).
06_Granino_1U.indd 11506_Granino_1U.indd 115 13.12.2009 16:13:3913.12.2009 16:13:39
Maria Grazia Granino Cecere116
disinteressato: una strada effi ciente gli consentiva di curare meglio i suoi possedimenti nella regione. Le parole del poeta sembrano trovare riscontro in una fi stula23 rinvenuta nell’area con il nome di un Valerius Messala,24 fi stula che, forse non casualmente, faceva parte della stessa raccolta di Grandi.
Quella nell’ager Tusculanus forse non era l’unica proprietà nel Lazio a noi nota di Mes-salina. Una fi stula,25 in cui a detta di Carlo Fea26 sembra fosse presente il suo nome, si rinvenne nel 1794 presso Ostia, a Portus, sul lembo della penisola che separa il porto di Claudio dal bacino interno di Traiano, nel luogo in cui in seguito Traiano stesso o Adriano realizzarono quel grande palazzo che venne denominato « dalle cento colonne ». Meiggs,27 grande conoscitore della realtà ostiense, non esita ad accogliere l’ipotesi di un possedi-mento della moglie di Claudio, ma i dati in nostro possesso appaiono troppo fragili per poterlo seguire senza incertezze.28
Altro elemento di individuazione di una proprietà di Augustae può fornire il rinveni-mento di iscrizioni erette in loro onore, di carattere pubblico o privato; ma anche questo non resta che un indizio, se non si hanno a disposizione altri dati a sostegno.
Un caso da prendere in considerazione appare quello di Domitia Longina a Gabii. In questo centro del Lazio lungo la via Prenestina,29 che aveva ripreso vigore nei primi decenni del II secolo, come gli scavi fortunati del Visconti del 1792 hanno dimostrato riportando alla luce un’area forense ricca di monumenti,30 due suoi liberti, Domitius
23 CIL XIV 2435a = XV 7849: Valeri Messalae. Venne dal Grandi acquistata nel 1861 insieme ad un certo numero di iscrizioni presenti (perché in parte almeno riutilizzate nel pavimento di una villa) nella proprietà di un tal Domenico Zoffoli, presso Marino, in località Marco Andreola o Muro de’ Francesi. E’ attualmente conservata nel Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, magaz-zino fi stulae, vd. Granino Cecere 2005, 210–211 nr. 239.
24 In assenza di elementi onomastici dirimenti purtroppo non è possibile neppure defi nire a quale ramo dei Valerii Messallae possa essere appartenuto il personaggio in questione. Sulle proprietà dei Valerii Messallae esamina le fonti Andermahr 1998, 464–466 nr. 547.
25 CIL XIV 2008 = XV 7759; cfr. Eph. Epigr. IX, p. 404. Vd. Bruun 1991, 289.26 Fea 1802, 39: « in cinque mila libre di un condotto di piombo, capace di sei once d’acqua, coll’iscrizione
di Messalina, trovatosi nella stessa occasione [nell’anno 1794] in uno scavo fatto nel sito a mano manca fra il Trajanello ed il Tempio, con molte ramifi cazioni, e sotto terra a poca profondità, in mezzo alla sabbia in qualche parte, che pareva indicasse giardino, e camerette, fa credere, che quella Imperatrice … vi avesse fabbricata qualche delizia ».
27 Meiggs 1973, 159.28 E del resto lo stesso Dressel (CIL XV ad nr.) esprime il dubbio che possa ad es. anche trattarsi di
Statilia Messalina, che sposò Nerone nell’anno 65 (Raepsaet-Charlier 1987, 579–580 nr. 730); cfr. anche Spurza 2002, 131.
29 Presso l’attuale km. 18 della via, dove ancora s’innalzano imponenti i resti del noto santuario di Giunone.
30 L’antico municipio appariva quasi spopolato sul fi nire della repubblica e ai primi tempi del prin-cipato, secondo quanto leggiamo in Cic. Planc. 23 (nisi forte te Labicana aut Gabina aut Bovillana vicinitas adiuvabat, quibus e municipiis vix iam qui carnem Latinis petant reperiuntur) o in Dion. Hal. ant. 4,53, ma anche in Hor. epist. 1,11,7; Prop. 4,1,34; Lucan. 7, 392; Iuv. 3,191–192; la sua ripresa economica, ma forse più apparente che reale, nel corso della prima metà del II secolo d. C.
06_Granino_1U.indd 11606_Granino_1U.indd 116 13.12.2009 16:13:3913.12.2009 16:13:39
117Proprietà di Augustae a Roma e nel Latium vetus
Polycarpus e sua moglie Europe, nel 140 d. C. fecero innalzare un’aedes in honorem memo-riae domus Domitiae Augustae Cn(aei) Domiti Corbulonis fi l(iae).31 Si tratta di un edifi cio di non grandi dimensioni, secondo quanto desumibile dall’ampiezza dell’epistilio ionico, unica parte attualmente conservata, che reca l’iscrizione, racchiusa in una tabella ansata.32 Ma non solo a questo si era limitato l’omaggio: dal lungo testo epigrafi co sappiamo che i due liberti avevano anche chiesto e ottenuto dal senato locale, di cui è riportato il decreto, di poter celebrare annualmente il dies natalis della loro patrona33 e a tal fi ne avevano isti-tuito una fondazione.
Ora tali iniziative per la fi glia di Corbulone (come l’Augusta è chiamata, ovviamente senza riferimenti a Domiziano), iniziative di cui si era curata la « visibilità » erigendo l’aedes presso il foro del municipio, sarebbero davvero inspiegabili senza una diretta con-nessione di Domizia con Gabii. Sembra opportuno, dunque, supporre la presenza di una sua proprietà nell’ager del municipio, proprietà in cui Polycarpus e sua moglie dovevano aver svolto un ruolo signifi cativo.34
Credo inoltre che sia da percorrere almeno un’altra via per individuare una proprietà: l’esistenza di particolari toponimi prediali, che possano connettersi a nomi di donne della casa imperiale. Per quanto riguarda l’antico Lazio ritengo che possa esserne preso in con-siderazione almeno uno.
Si tratta della Valle Marciana, denominazione di un’area a occidente dell’attuale Grotta-ferrata, sulla destra della via Latina uscendo da Roma, tra il X e l’XI miglio, non lontano sia dall’abbazia di S. Nilo, che è costruita in gran parte sui resti di una villa databile nel primo impianto al I secolo a. C.,35 sia dalla località Bagnara, dove sorgeva in età severiana la residenza degli Iulii Aspri.36 Il toponimo Valle Marciana è antico, poiché si trova già in
sembra trovare testimonianza nei numerosi rinvenimenti relativi agli scavi Hamilton del 1792 presso il cd. foro, che si apriva sul tracciato della via Prenestina, e di cui off re valida rassegna Visconti 1797.
31 CIL XIV 2795 = ILS 272. L’epistilio è attualmente conservato nel Museo del Louvre, come molti docu-menti non solo epigrafi ci rinvenuti nel corso degli scavi del 1792, poiché vennero ceduti nel 1807 da Camillo Borghese alla Francia (Decroux 1975, 26 nr. 81); presenta una larghezza di cm. 355, ovvero di 12 piedi e un’altezza di cm. 78, poco più di 2 piedi e mezzo. Vd. anche Raepsaet-Charlier 1987, 287–288 nr. 327.
32 Granino Cecere 2005, 342–345 nr. 439. Sul luogo in cui doveva elevarsi l’edifi cio, vd. Ashby 1902, 185–186, riferendosi alla descrizione e alla pianta off erta dal Visconti.
33 Così conosciamo il suo giorno di nascita, l’11 febbraio, anche se non l’anno. L’iniziativa da parte dei suoi liberti consente anche di collocare cronologicamente la sua morte prima del 140, quando si data il documento gabino.
34 Una tale opinione, pur se con riserva, è espressa anche da Andermahr 1998, 255.35 Valenti 2003, 326–331.36 Sulla proprietà di tale importante famiglia presso l’XI miglio della via Latina, i cui proprietari sono
stati individuati grazie al rinvenimento di una serie di iscrizioni per lo più onorarie (CIL XIV 2505–2513), vd. Neudecker 1988, 160–161; Granino Cecere 1990; Dietz 1997; Andermahr 1998, 298–299 nr. 263 e Valenti 2003, 76 e 309–314 nrr. 661–662.
06_Granino_1U.indd 11706_Granino_1U.indd 117 13.12.2009 16:13:3913.12.2009 16:13:39
Maria Grazia Granino Cecere118
documenti del IX–X secolo;37 ma ciò che induce a ipotizzare nella regione una proprietà dell’Augusta sorella di Traiano è il fatto che nei pressi, al X miglio della via Latina, agli inizi del ‘900 si rinvenne un documento epigrafi co, che menziona un’Ulpia Sophe, liberta appunto di Marciana.38 Non c’è da stupirsi se la sorella dell’imperatore, come tanti altri illustri personaggi prima e dopo di lei, abbia scelto questo luogo, che ancor oggi si fa am-mirare per la dolcezza del paesaggio.
Ritengo si possa interpretare nella stessa ottica anche il nome di Grotta Mammosa, relativo ad una cisterna, che sorgeva in località I Casali, presso Labico, nell’antico ager Praenestinus.39 Proprio in questo luogo tra resti di edifi ci d’incerta destinazione40 si rin-vennero infatti vari tratti di una fi stula recante il nome di Iulia Mamaea (fi g.2).41
37 Un fundus Marcianus al X miglio della via Latina è menzionato nel Regesto Sublacense in un docu-mento, il nr. 29, forse risalente al IX secolo (Allodo / Levi 1885, 69–70; cfr. Tomassetti 1976, 321; Del Lungo 1996, I, 213).
38 EE IX 682, cfr. Granino Cecere 2005, 220–221, nr. 253: Ulpia Sophe / Marcianae Aug(ustae) l(iberta) / consecravit. La lastra, frammentaria, è attualmente conservata nel Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano.Venne rinvenuta nella vigna allora di proprietà Gentilini, presso il bivio al X miglio della via Latina, laddove questa s’intersecava con la via di Cavona, forse nell’ambito stesso di quella che doveva essere un’edicola dedicata ai Lares Augusti nel vicus Angusculanus (Lanciani 1905, 136; cfr. Tomassetti 1976, 157).
39 La località I Casali si estende sulla destra della via in uscita dall’Urbe (de’ Ficoroni 1748, 32–33). 40 de’ Ficoroni 1748, 33–34 descrive la Grotta Mammosa come « un solido edifi cio per conserva
d’acqua ad uso delle terme, di cui restano laceri avanzi in quella vicinanza » e ne off re anche un di-segno, in cui appare una cisterna con cinque arcate (allegato alla p. 33: « di quella conserva d’acqua di grosse mura e di tutta conservazione, non essendoci la compagna in questi contorni, n’espongo in questo luogo un piccolo disegno »); Del Lungo 1996, II, 123 osserva come la tradizione della presenza nel luogo di una donna della casa imperiale abbia determinato l’aff ermazione del nome Regina che si trova attribuito nei pressi al Colle della Regina (a ca. 2700 m. a NO del Km. 10,300 della via Ariana). Di certo non può riferirsi a questa struttura il lavacrum Mamaeae ricordato da Amm. 28,4,19.
41 CIL XV 7880: Iuliae Mamiae matris Aug(usti) n(ostri). Della fi stula furono rinvenuti più tratti con il bollo: uno era un tempo conservato nel museo Kircheriano, ma attualmente non più reperibile nel Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, due sono forse ancora presenti a Bologna, nel Museo civico (CIL XI 104*,9) e un altro esemplare di certo a Cortona, nel Museo dell’Accademia Etrusca (lungh. 40; diam.4); una scheda di quest’ultimo è off erta da Donati 1967, 112 nr. 176a e Tav.
Fig. 2- Cortona, Museo dell’Accademia Etrusca: fi stula con bollo di Iulia Mamaea dall’ager Praenestinus (CIL XV 7880)
06_Granino_1U.indd 11806_Granino_1U.indd 118 13.12.2009 16:13:3913.12.2009 16:13:39
119Proprietà di Augustae a Roma e nel Latium vetus
Della madre di Severo Alessandro abbiamo anche l’attestazione di una proprietà nell’Urbe: in questo caso la prova è off erta solo da una fi stula rinvenuta a occidente del chio-stro della basilica di S. Giovanni in Laterano.42 Non desta però certo meraviglia la proprietà di una donna dei Severi in un’area in cui il loro intervento fu notevole, con la realizzazione dei castra nova degli equites singulares Augusti da parte di Settimio Severo tra il 193 e il 196. Per attuare un tale progetto si dovette certo procedere con espropri signifi cativi, ben oltre l’area poi utilizzata, se lo stesso Severo poté far dono a T. Sextius Lateranus di una domus, che sorgeva nella zona,43 di prestigio tale da determinarne la toponomastica.44
Poco lontano, proprio nell’area sotto l’attuale Ospedale di S. Giovanni, si estendevano gli horti di Domitia Lucilla.45 Non si hanno elementi suffi cienti per defi nire con certezza se debbano essere attribuiti a Domitia Lucilla maggiore o alla sua omonima fi glia, ma, se-guendo l’opinione di Paolo Liverani,46 che sottolinea la presenza nelle strutture rinvenute di una consistente fase edilizia della Lucilla minore, appare preferibile pensare alla madre di Marco Aurelio.47
Diffi cile è anche stabilire quale fosse l’esatta estensione di questi horti. Il rinvenimento di tre fi stule48 con il nome della donna nell’area non possono che off rire un’indicazione di massima. Si estendevano certo sotto l’attuale ospedale, poiché qui è stata rinvenuta la pars rustica del complesso, confi navano ad occidente con la domus dei Quintilii49 e dovevano essere racchiusi verso nord dall’acquedotto neroniano. In quanto horti, e quindi
XXI. Appare alquanto improbabile attribuire a questa proprietà, confl uita eventualmente nel patri-monio imperiale, il Verecundus Aug(usti) lib(ertus) proc(urator), che costruì il sepolcro per la moglie Tutia Marcia sulla via che da Palestrina portava a Labico (CIL XIV 2938); infatti il liberto può essere stato procuratore dei vasti possedimenti imperiali a Praeneste.
42 CIL XV 7336: D(ominae) n(ostrae) Iuliae Mamaeae A[ug(ustae)]; sulla parte opposta il nome del plumbarius: [Po]lychronius Aug(usti- ugustae?) lib(ertus) fec(it), Bruun 1991, 27. La fi stula risulta al momento irreperibile nei Musei Vaticani, come cortesemente mi comunica il dottor Giorgio Filippi.
43 (Ps.-)Aur. Vict. epit. Caes. 20, 6: In amicos inimicosque pariter vehemens, quippe qui Lateranum, Cilonem, Anullinum, Bassum, ceterosque alios ditaret aedibus quoque memoratu dignis, quarum praecipuas videmus, Parthorum quae dicuntur ac Laterani.
44 Liverani 2004, 20–22.45 Liverani 1996/1999. 46 Liverani 2004, 34–43.47 Soreastra di Adriano secondo Di Vita Evrard 1999, che ha voluto dimostrare come Adriano sia
nato, insieme a Domitia Paulina, da un primo matrimonio di Domitia Lucilla maggiore con P. Aelius Hadrianus Afer; Domitia Lucilla minore dal secondo matrimonio della donna con P(ublius) Calvisius Tullus Ruso. Vd. anche Chausson 2007, 132–133, 135, 145.
48 AE 1901, 182, rinvenuta a Piazza S. Giovanni, presso la facciata dell’omonimo ospedale; altri due esemplari (AE 1995, 221), di cui uno con il nome impresso tre volte su due sezioni collegate da una saldatura ed uno frammentario, rinvenuti sotto il corpo centrale della nuova ala dell’ospedale stesso: Domitiae Lucillae (palma).
49 L’estendersi della domus dei due fratelli Sex. Quintilius Condianus e Sex. Quintilius Valerius Maximus, consoli entrambi nel 151 ed uccisi da Commodo nel 183, in questa zona del Celio è documentata dal rinvenimento della fi stula AE 1995, 219: Quintiliorum / Condiani et Maximi (Liverani 1995). Sulla dif-fi coltà nel determinare i confi ni della proprietà di Domitia Lucilla vd. anche Gregori 2008, 1078–1079.
06_Granino_1U.indd 11906_Granino_1U.indd 119 13.12.2009 16:13:3913.12.2009 16:13:39
Maria Grazia Granino Cecere120
caratterizzati da spazi aperti e strutture edilizie di varia fi nalità in un’ampia area, potevano estendersi verso ovest a cavallo della via Tuscolana e ciò perché al di là della via è stata rinvenuta un’altra fi stula recante il nome del padre di Domitia Lucilla minore, P. Calvisius Tullus, console nel 109.50 La donna aveva probabilmente ereditato da lui almeno una parte della proprietà.51
Può essere interessante a questo punto soff ermarsi sulle modalità con cui le donne della casa imperiale entravano in possesso delle loro proprietà.
E’ chiaro che nella maggior parte dei casi ereditavano dai genitori o dal marito nell’eventualità di una vedovanza. Le prove non mancano, anche per via epigrafi ca.
Passando da una realtà urbana ai colli intorno alla città, incontriamo Agrippina mi-nore molto probabilmente proprietaria di una villa, di notevoli proporzioni e ricchezza, quella sulla quale sorse nel medioevo l’odierno centro di Frascati.52 Ancora una volta è una fi stula a indicare la possibile appartenenza del grande complesso, di cui sono ancora ben visibili tante strutture. Sembra infatti preferibile leggere il nome della moglie di Clau-dio sul frammento di un tubo di piombo oggi purtroppo irreperibile,53 rispetto a quelli pure ipotizzati di una Asinia o di una Vipsania Agrippina. E ciò per una serie di motivi. L’indica zione off erta dalla fi stula può infatti trovare riscontro in un passo di Tacito,54 in cui si fa riferimento al ritirarsi della donna in hortos aut Tusculanum vel Antiatem in agrum; tale indicazione trova corrispondenza in un passo di Plinio, il quale ricorda che nel territorio di Tusculum aveva una proprietà C. Passienus Crispus, il secondo marito di Agrippina:55 da ciò è agevolmente desumibile che alla morte di questi la futura Augusta
50 Rinvenuta nel corso degli scavi condotti da Enrico Josi nel 1939 (vd. Santa Maria Scrinari 1991, 10 nr. 63): P(ubli) Calvisi Tulli ((palma)), attualmente conservata nei Musei Vaticani, settore fi stule, inv. 18606. Su P(ublius) Calvisius Tullus Ruso, console suff eto nel 79 e poi ordinario nel 109, vd. Di Vita-Evrard 1989; per la studiosa (169) gli horti Domitiae, sui quali fu innalzato il mausoleo di Adriano, devono essere attribuiti a Domitia Lucilla maior, madre dell’imperatore, e non a Domitia Longina moglie di Domiziano o a Domitia zia di Nerone (vd. nt. 58).
51 Certamente per via paterna, e quindi forse dal nonno, console nel 21 a. C. erano pervenute grandi ric-chezze (Plin. nat. 9,117–118) a Lollia Paullina (Raepsaet-Charlier 1987, 429–431 nr. 504), moglie per breve tempo di Caligola nel 38–39: tra queste forse possono essere annoverati gli horti Lolliani (Papi 1996) e gli horrea Lolliana (Coarelli, 1996), in considerazione del fatto che un’iscrizione funeraria menziona un Q(uintus) Lollius Lolliae / l(ibertus) Hilarus / horrea(ius) (CIL VI 9467); gli uni e gli altri passarono nella proprietà imperiale, forse durante il principato di Claudio, dopo l’esilio e la morte di Lollia voluta da Agrippina nel 49 (Tac. ann. 14,12,4).
52 Valenti 2003, 76 e 248–249 nr. 468.53 CIL XV 7853: qui prima nel nome Agrippina erano visibili le tracce di due lettere, purtroppo non
individuabili con certezza.54 Tac. ann. 14,3.55 Plin. nat. 16,242: Est in suburbano Tusculani agri colle, qui Corne appellatur, lucus antiqua religione
Dianae sacratus a Latio, velut arte tonsili coma fagei nemoris. In hoc arborem eximiam aetate nostra amavit Passienus Crispus bis cos., orator, Agrippinae matrimonio et Nerone privigno clarior postea, osculari complectique eam solitus, non modo cubare sub ea vinumque illi adfundere … L’antico bosco, come sottolinea anche Ampolo 1993, 164–166, doveva essere in stretta relazione con una proprietà di Passienus nel Tuscolano.
06_Granino_1U.indd 12006_Granino_1U.indd 120 13.12.2009 16:13:3913.12.2009 16:13:39
121Proprietà di Augustae a Roma e nel Latium vetus
l’abbia ricevuta in eredità. Da lei dovette passare al fi glio Nerone per entrare defi nitiva-mente nel patrimonio imperiale. E questo può trovare conferma nel fatto che proprio in una medesima zona dell’attuale Frascati, quella tra l’attuale Largo Pentini e Via di Porta Granara, siano state trovate accanto alla fi stula in esame, anche una di Nerone56 e una di Domiziano57, che sembrano scandire i diversi passaggi di proprietà.
Forse non diversamente dal marito Germanico aveva ereditato Agrippina maggiore i suoi horti,58 che si estendevano sulla sponda destra del Tevere, nella piana del Vaticano, separati dalla riva del fi ume da un terrazzo sistemato a giardino e da un portico e dotati di almeno un edifi cio di rappresentanza al loro interno, come sappiamo da Seneca59 e da Filone60. Il nome della donna sembra legato anche agli horrea Agrippiana / Agrippiniana,61 che ella, secondo un’ipotesi di Carandini, insieme al marito aveva fatto costruire nella loro proprietà situata nel Velabrum presso il vicus Tuscus.62
Ma, pur se indirettamente, la proprietà fondiaria delle imperatrici andò accrescendosi anche grazie ad eredità per così dire « esterne » e a confi sche, come, in misura ben più si-gnifi cativa, avveniva per quella dell’imperatore.
In un passo degli Annali Tacito63 ricorda come Nerone, divorziando da Ottavia, l’ab-bia allontanata verso l’esilio in Campania dandole in appannaggio, come in un semplice divorzio, domum Burri e praedia Plauti. Non sappiamo se Afranio Burro avesse nominato
56 CIL XV 7817: Neronis Claudi Caesaris, rinvenuta nel 1891 nell’attuale via D. Seghetti, di fronte al palazzo Sterbini e attualmente conservata nell’Antiquario dell’Abbazia di Grottaferrata, vd. Granino Cecere 2005, 306–307 nr. 387.
57 CIL XIV 2657 = XV 7818: Imp(eratoris) Domitiani Caes(aris) Aug(usti); sub cura / Alypi l(iberti) proc(uratoris) fec(it) Abascantus ser(vus) Atime(tianus), rinvenuta, come quella menzionante Agrip-pina, nello scavare le fondazioni di Palazzo Sturbinetti, nell’attuale via XX settembre, di fronte al Tor-rione Granara, e attualmente conservata a Roma, nell’Antiquario Comunale, cassa 452, inv. 23674; cfr. Granino Cecere 2005, 306–307 nr. 388.
58 Tomei 2001. Gli horti di Agrippina almeno fi no all’età neroniana sono stati ben distinti da quelli di Domitia, che si estendevano più a nord, dove in seguito Adriano costruirà il suo mausoleo. Incerta permane ancora l’attribuzione di questi horti a Domitia Longina, moglie di Domiziano o a Domitia (Raepsaet-Charlier 1987, 280–281 nr. 319), zia di Nerone e moglie, prima di Agrippina, di C. Sallustius Passienus Crispus, come evidenzia Tomei 2004; ma per una recente attribuzione a Domitia Lucilla maior, vd. nt. 50.
59 Sen. dial. 5,18,4.60 Phil. Legatio ad Gaium 181 (p. 572).61 Un vestiarius de horreis Agrippinianis è noto da un’iscrizione rinvenuta presso Nomentum (CIL XIV
3958, cfr. Granino Cecere 2005, 776–777 nr. 1019), se non si tratta di un errore del lapicida per Agrippianis; horrea Germaniciana et Agrippiana sono attestati nella Notitia Urbis regionum XIV, se non si deve riconoscervi due edifi ci distinti.
62 Carandini 1988, 386 nt. 94, cfr. Astolfi 1996.63 Tac. ann. 14,60, 4: Movetur tamen primo civilis discidii specie domumque Burri, praedia Plauti in-
fausta dona accipit.
06_Granino_1U.indd 12106_Granino_1U.indd 121 13.12.2009 16:13:3913.12.2009 16:13:39
Maria Grazia Granino Cecere122
suo erede l’imperatore;64 certo è invece che Rubellio Plauto, esiliato in Asia e lì assassinato per volontà di Nerone, aveva subito con l’espulsione dal senato anche la confi sca dei beni.65 Infausta dona, come li defi nisce Tacito, per Ottavia, un funesto presagio per la morte che di lì a poco le sarebbe stata data.
Per concludere, appare opportuno presentare nel modo più stringato possibile alcune attestazioni epigrafi che, che consentono di documentare l’esistenza di altre proprietà di Augustae nell’area in esame. Si tratta per lo più di fi stule che, se da un lato, per l’essenzia-lità del messaggio, spesso non consentono di conoscere con sicurezza il tipo di edifi cio, struttura o attività per cui l’acqua era addotta, presentano però il vantaggio, se ne è nota la provenienza, di localizzarla almeno orientativamente.
Un consistente gruppo di fi stule, 16 complessivamente, recanti il bollo Iulia Aug(usti) f(ilia)66 (fi g.3) sono state rinvenute sulla riva destra del Tevere, ad oriente del palazzo di Giustizia, all’altezza dell’attuale Ponte Cavour, in un ambito di ca. 200 m.67
Bruun,68 credo a ragione, preferisce vedere nella donna la Iulia fi glia di Tito e non la fi glia di Augusto, in considerazione del fatto che la seconda ipotesi comporterebbe una
64 Incerta la causa della sua morte per Tac. ann. 14,51–52, dovuta al veleno per Cass. Dio 62,13,3 e Suet. Nero 35,5.
65 PIR2 R 115.66 CIL XV 7275. Ben 15 di tali tratti di fi stule, di media portata (diam. interno di 6 cm.) sono attu-
almente conservati nei magazzini del Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano (invv. 50961–50975); un altro esemplare è edito da Pietrangeli 1951, 18 nr. 5 (il diam. di 7,6 riportato deve intendersi esterno, dal momento che il testo è identico così come l’altezza delle lettere di cm.2).
67 FUR, tav. 8; Tomei / Liverani 2005, 84 nr. 110b (4 frammenti rinvenuti nei lavori del 1890–1891 presso Ponte Cavour), p. 107 nr. 147 (rinvenimento di alcuni frammenti nel 1892 presso la sponda del Tevere; tra questi uno con la nota numerale CXXX); p. 127 nr. 185a (rinvenimento nel 1890 di altri due esemplari sul lungotevere Prati); tutti i frammenti di cui è noto il luogo di provenienza sono stati ritrovati tra l’incrocio di via P. Mercuri con il lungotevere Prati e l’incrocio di via M. Dionigi con il lungotevere dei Mellini.
68 Bruun 2005b, 98.
Fig. 3 Roma, Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano: fi stula con bollo di Iulia Aug(usti) f(ilia) (CIL XV 7275).
06_Granino_1U.indd 12206_Granino_1U.indd 122 13.12.2009 16:13:3913.12.2009 16:13:39
123Proprietà di Augustae a Roma e nel Latium vetus
datazione assai alta: le fi stulae in questione sarebbero tra le più antiche, se non le più anti-che in assoluto, dovendo essere datate prima del 2 a. C.
Ma lungo la medesima riva del fi ume, a ca. 800 metri più a sud-ovest, precisamente a Piazza Pia, laddove si conclude via della Conciliazione verso il Tevere, probabilmente nel 1924 sono stati trovati altri cinque frammenti di fi stule, di sezione ben più ampia, con lo stampo Iuliae Augustae.69 Sia per la lontananza dei luoghi che per la diversità del bollo non dovrebbero riferirsi a una stessa proprietà. Diffi cile determinare se anche in queste ultime fi stule sia da riconoscere il nome di (Flavia) Iulia o piuttosto di Livia. A ciò si aggiunga che erano già note al Dressel due fi stule con il medesimo testo, Iuliae Augustae, l’una d’ignota provenienza, l’altra in più esemplari, di cui uno rinvenuto sul Palatino,70 ma entrambe di diversa foggia (nel primo il nome è preceduto da una palma) e di diversa capacità71 rispetto ai frammenti rinvenuti a Piazza Pia. La provenienza dal Palatino di un esemplare con il timbro Iuliae Augustae ha di volta in volta rimesso in discussione presso gli studiosi anche il bollo, ancora diverso, tuttavia, perché presente Aug(ustae) abbreviato alle prime tre lettere, in base al quale è stata individuata l’abitazione di Livia sul colle, di cui si è trat-tato in precedenza: alcuni, tra i quali Lanciani e Lugli, infatti, hanno preferito vedervi il nome di Giulia, fi glia di Tito.72 Tuttavia un attento esame del contesto di rinvenimento di quest’ultima nel corso degli scavi diretti da Pietro Rosa per Napoleone III nel 1869 e la paleografi a del bollo inducono a leggere con suffi ciente certezza il nome di Livia.73
Di certo la voluta omonimia della fi glia di Tito con la moglie di Augusto non consente, almeno per il momento, di pronunciarsi con sicurezza sul secondo gruppo di fi stule tran-stiberine menzionanti Iulia Augusta e solo forse un attento riesame complessivo dei bolli potrà permettere di dire qualcosa di defi nitivo in merito.
All’inizio della Nomentana, sulla destra della via, nella parte dell’ex villa Patrizi che si aff accia sull’angolo nord-est dei castra praetoria si rinvenne una cassetta idraulica, sulla quale era la stampigliatura, erosa nelle prime cinque lettere, che il Dressel propose di
69 AE 1948, 72 = Pietrangeli 1941, 190 nr. 22, il quale precisa che il rinvenimento dei cinque fram-menti di fi stula, tutti con lo stesso sigillo e del diametro « verticale » di 15 cm. e conservati al tempo nell’Antiquarium comunale, avvenne nello sterro del collettore. Egli ritiene si riferiscano a Giulia di Tito, che avrebbe avuto proprietà nell’ager Vaticanus; cfr. Tomei / Liverani 2005, 250 nr. 323b e 257 nr.333f, ove si suppone che il rinvenimento sia avvenuto prima del 1941, forse nel 1924. Almeno quattro di tali frammenti sono tuttora conservati nelle Collezioni comunali (Antiquarium) con i nrr. di inventario 23768, 23782, 23817, 23783 (ma indicati solo come genericamente provenienti dal mercato antiquario), come cortesemente mi informa la Dott.ssa Daniela Velestino.
70 CIL XV 7276a, b.71 Forse un esemplare di quest’ultima (CIL XV 7276b), di piccolo modulo, è attualmente conservato
nell’Antiquario Comunale con inv. 23687, con provenienza dal mercato antiquario. Potrebbe trattarsi dell’esemplare di cui il Dressel ricorda l’acquisto Iandolo del 1886.
72 Vd. nt. 9.73 Non si pronuncia espressamente in merito Royo 1999, 79, 273, 306, mentre a favore di un’appartenenza
a Livia sembrano esprimersi Tomei 2000, 18–20 e Krause 2002, 85–96, anche se non in modo espli-cito.
06_Granino_1U.indd 12306_Granino_1U.indd 123 13.12.2009 16:13:4013.12.2009 16:13:40
Maria Grazia Granino Cecere124
integrare in [[Domus]] Domitiae Augustae.74 Una residenza di Domitia Longina potrebbe dunque essere ipotizzata nella zona, in un’area in cui sono attestate numerose strutture abitative, e di alto livello, tra le quali, quella, che doveva essere forse confi nante, di Antonia Caenis.75
Del ruolo in ambito sia politico, sia soprattutto economico, che le donne della casa imperiale vengono ad assumere sin dall’età fl avia, ma in particolare dal tempo di Traiano, abbiamo indubbie attestazioni.76 Conosciamo la Plotina proprietaria di fi glinae, ma una fi stula rinvenuta nell’area della Marmorata77 suggerisce anche una sua presenza in que-sta zona della città.78 Un’altra fi stula con il timbro Saloniae Matidiae Aug(usti) sor(oris) f(iliae)79 attesta la lesistenza di una domus o di horti o di una qualche attività nell’Urbe anche della fi glia di Marciana; di questa non è noto il luogo di rinvenimento, ma non può escludersi la possibilità di collocare una proprietà della donna accanto a quella di una della sue due fi glie,80 che entrambe, a quanto sembra, avevano possedimenti nella regio V: una fi stula con il bollo Sabinae Aug(ustae)81 (fi g.4) venne rinvenuta infatti presso Piazza
74 CIL XV 7293: la fi stula, rinvenuta presso il Castellaccio della Villa, è attualmente irreperibile. Nella zona si rinvennero altre fi stule con sigilli imperiali (vd. Friggeri 1977–1978) e ciò induce a propen-dere per un passaggio nella proprietà imperiale.
75 Friggeri 1977–1978 e da ultimo Nonnis 2009, 405.76 Temporini 1978, passim e Mari 2004.77 CIL XV 7305: Plotinae Aug(ustae), attualmente irreperibile. Il luogo di rinvenimento venne indicato
dall’antiquario Palombi, presso il quale venne vista, secondo quanto aff ermano Lanciani e Henzen (CIL, ad nr.).
78 Molto problematica, invece, resta un’eventuale attribuzione a Plotina di una proprietà presso Aricia, laddove, in località Vallericcia, nel corso di scavi voluti dal cardinale Despuig nel 1789 si rinvenne una dedica in onore dell’imperatrice posta da un Agathyrsus Aug(usti? - ustae?) l(ibertus). L’epigrafe, CIL XIV 2161, sembra doversi riferire ad uno dei busti rinvenuti nello stesso scavo (tra di essi, è detto esplicitamente da Lucidi 1796, 207, ve ne era uno di Plotina), facente parte di una galleria di ritratti imperiali, che costituiva l’ornato della residenza. In Agathyrsus, si è ritenuto di poter riconoscere un liberto di Plotina; e non un liberto qualsiasi, ma il ricco proprietario dei praedia Quintanensia (CIL XV 461–470), che avrebbe ereditato dalla stessa Plotina. Ma Bloch 1947–1948, 30 osserva che Plotina possedeva le fi glinae Quintianae e non i praedia Quintanensia, situati sulla Labicana, ad Quintanas, che in un certo periodo furono di proprietà di un Agathyrsus, nel quale forse si potrebbe anche identifi care l’autore della dedica, ma che certo non fu erede di Plotina. Resta il dubbio se l’iscrizione (e il busto ad esso relativo) fu posta in una residenza appartenente alla casa imperiale (e certo non è detto sia stata di Plotina), in particolare per il tono poco uffi ciale della dedica, dal mo-mento l’imperatrice è detta Plotinae / Aug(ustae) / n(ostrae), o se si tratta piuttosto di una proprietà del liberto imperiale.
79 AE 1954, 62 (Pietrangeli 1951, 18–19 nr. 7, che preferisce vedere in Salonia una sorella di Matidia maggiore). Vd. Eck 1995.
80 Che fossero o meno fi glie di due diversi mariti, cfr. Raepsaet-Charlier 1987, 446–447 nr. 533 e 546–547 nr. 681 e nt. 14. Incertezza sulla tipologia di edifi cio cui tali fi stule possono far riferimento sottolinea Bruun 2003, 495 nt. 30.
81 CIL XV 7313α: Sabinae Aug(ustae) ((palma)), conservata nei magazzini del Museo Nazionale Ro-mano alle Terme di Diocleziano, inv. 65222. Nello stesso luogo è conservata (inv. 65223) anche 7313β, inv. 65222: Sabinae Aug(ustae), d’ignota provenienza. Si tratta di due esemplari di modulo
06_Granino_1U.indd 12406_Granino_1U.indd 124 13.12.2009 16:13:4013.12.2009 16:13:40
125Proprietà di Augustae a Roma e nel Latium vetus
Vittorio, tra la chiesa di S. Eusebio e via Napoleone III; un’altra, con il bollo Matidiae Aug(ustae) f(iliae),82 con il nome di Matidia minore, dunque, fu rinvenuta, secondo ver-sioni un po’ contrastanti dello stesso Lanciani nella vicina via Giovanni Lanza o presso la stessa Piazza Vittorio. Questi documenti epigrafi ci possono trovare riscontro nel ritrova-mento in questa stessa area di due ritratti di notevoli dimensioni di Adriano e di Sabina83 e di un altro molto probabilmente attribuibile a Salonia Matidia.84
Di Matidia minore si avverte invece tangibilmente la presenza nella colonia di Ostia, attraverso una fi stula recante il suo nome85 rinvenuta nella parte a destinazione termale del cosiddetto palazzo imperiale; ma è soprattutto l’area di Porto, che ella sembra aver pri-vilegiato. Il suo nome è legato al ponte che passava sulla fossa Traiana, l’attuale canale di
diverso (l’uno del diam. 7,1 e lett. 3–3,2, l’altro del diam. 6 e lett. 3,7), che presentano anche un mar-chio con lettere dissimili, pertinenti a due diverse condutture; alla pertinenza ad un’unica proprietà sembra riferirsi Papi 1995.
82 CIL XV 7306: Matidiae Aug(ustae) fi l(iae) (palma). Sulle indicazioni non sempre univoche date da Lanciani sul luogo di rinvenimento si soff erma Rodriguez Almeida 1995, il quale rimane incerto se attribuire la proprietà a Matidia maggiore o a sua fi glia.
83 I due busti (Pettinau 1995, 46–47 e 102–104 con fi gg. 51–54 (Adriano) e 14 (Sabina)), attualmente conservati nei Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori, inv. nr. 890 e 848, furono ritrovati in un muro d’età tarda in via Filippo Turati, presso Piazza Manfredo Fanti, nell’ambito dei precedenti nel tempo horti Calyclani, presso il confi ne di questi con gli horti Tauriani e a non più di un centinaio di metri dal ritratto attribuibile a Matidia (vd. nt. seguente), in prossimità di via Napoleone III (Cima 2008, 95).
84 Si tratta del ritratto attualmente conservato nei Musei Capitolini, Centrale Montemartini, inv. 889, rinvenuto preso l’incrocio tra via Giolitti e via Rattazzi (Pettinau 1995, 48, 98–100 e Talamo 2004, 90–92). Se appare assai arduo cercare di determinare il progressivo passaggio di proprietà di tanti horti dell’Esquilino da privati all’imperatore nel corso del I secolo d. C., ben più diffi cile è seguire la situazione nei secoli successivi, anche per carenza di documentazione.
85 CIL XV 7737 = XIV 1978: Matidiae Aug(ustae) f(iliae) e in altra parte della medesima tubatura Q(uintus) Publi(cius) Secundus fec(it) ((palma)), attualmente conservata nei Musei Vaticani, settore fi stule, invv. 10764 e 10772, cfr. CIL XIV 2005; sul sontuoso complesso termale in cui la tubatura è stata rinvenuta vd. Spurza 2002, 123–134, 127–128, che ipotizza una proprietà di Matidia, senza escludere un suo intervento evergetico.
Fig. 4 Roma, Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano: fi stula con bollo di Vibia Sabina dall’Esquilino (CIL XV 7313a).
06_Granino_1U.indd 12506_Granino_1U.indd 125 13.12.2009 16:13:4013.12.2009 16:13:40
Maria Grazia Granino Cecere126
Fiumicino, restaurato ad opera di Onorio e Teodosio,86 dopo la morte di Arcadio nel 408; ma la sua presenza può esser letta nel gentilizio Mindius del plumbarius Anoptes,87 che forse ha realizzato fi stule per lei e in due iscrizioni sepolcrali dell’Isola sacra, una eretta da un suo schiavo di nome Olympus,88 l’altra relativa a un L. Mindius Dioga rinvenute, forse non casualmente, in due tombe poste l’una di fronte all’altra.89
Per le due fi glie di Marco Aurelio Cornifi cia e Vibia Aurelia Sabina si possono indivi-duare due distinte proprietà, l’una ad Ostia, l’altra nell’Urbe.90
Il fatto che nella documentazione epigrafi ca non si trovino i nomi di altre donne della domus imperiale, come ad es. le due Faustine, di cui invece per altra via conosciamo le in-dubbie ricchezze, non vuol dire che non avessero proprietà: è questo un limite di tale tipo di documentazione e si deve tener conto delle distorsioni che può comportare.
Se volgiamo uno sguardo d’insieme al Lazio antico, la regione che vede Frascati al cen-tro e che si estende a ovest oltre Grottaferrata e a est verso Monteporzio Catone sembra rivelarsi come il luogo più amato dalle Augustae. A NNE dell’attuale centro di Frascati, in località Cocciano,91 sorgeva una proprietà di Livia e di Tiberio: ancora una volta è rivelatrice una fi stula, che ricorda i loro nomi al genitivo, Ti(iberi) Caesaris Aug(usti) et
86 AE 1975, 137. La realizzazione del ponte fa supporre che le proprietà di Matidia si estendessero sui due lati della fossa Traiana (Cébeillac / Caldelli / Zevi 2006, 133–134).
87 CIL XV 7764 = XIV 1998: [–]? Mindius Anoptes fecit. 88 Helttula 2007, 101–102 nr. 87 (rinvenuta nel corso degli scavi del 1930 in situ nella tomba 75: D(is)
M(anibus). / Urbicae suae fecit / Olympus Matidiae / Aug(ustae) f(iliae) ser(vus), cum qua vix(it) / anno I, m(ensibus) VIII, d(iebus) XXII, h(oris) III; / quae decessit ann(orum) XIIII, m(ensium) XI.
89 Helttula 2007, 92–93, nr. 80, anche questa rinvenuta nel corso degli stessi scavi del 1930: D(is) M(anibus). / L. Mindio Diogae / Iulia Zoe coniugi / b(ene) m(erenti) f(aciendum) c(uravit) et sibi / et suis posteris/q(ue) eorum. Si trova ancora in situ nella tomba 73, posta di fronte alla tomba 75. Per uno sguardo d’insieme sulle notevoli proprietà di Matidia minore in Italia, vd. Andermahr 1998, 332–336 nr. 331.
90 Cornifi cia (Raepsaet-Charlier 1987, 261–263 nr. 294) e Vibia Aurelia Sabina (Raepsaet- Charlier 1987, 622–623 nr. 800) hanno lasciato il loro nome su due fi stule, l’una di Ostia, l’altra di Roma. Se nella prima potrebbe anche essere individuato un atto energetico (AE 1954, 171 cfr. Geremia Nucci 2000), nella seconda si rivela con certezza una proprietà, e precisamente il comp-lesso di strutture, o almeno una parte di esso, che si elevava nell’area oggi occupata dalla Stazione Ter-mini (Paris 1996a, 61 e Paris 1996b, 125); sono da riferire invece a un suo liberto, L(ucius) Aurelius Agaclytus, CIL XV 7401 e 7402 (vd. Geremia Nucci 2000, 394). Gli urbani horrea Cornifi c(iana), attestati in un’iscrizione di Amphipolis (AE 1946, 230, dove è menzionato un L(ucius) Pompilius Eros, negotiator ab Roma ex horreis Cornifi c(ianis?)) potrebbero essere appartenuti alla sorella di Marco Aurelio, Annia Cornifi cia Faustina (Raepsaet-Charlier 1987, 73–74 nr. 57), vd. Papi 1996a. Invece alla sorella di Lucio Vero, Ceionia Fabia (Raepsaet-Charlier 1987, 91–192 nr. 204) possono essere attribuiti gli horti Ceioniae Fabiae, la cui localizzazione permane dubbia (Guidobaldi 1996).
91 Valenti 2003, 170 nr. 214; Valenti 2008, 61–62: nell’area sono ancora ben visibili verso valle 36 ambienti sostruttivi del livello sul quale si elevava la villa.
06_Granino_1U.indd 12606_Granino_1U.indd 126 13.12.2009 16:13:4013.12.2009 16:13:40
127Proprietà di Augustae a Roma e nel Latium vetus
Iuliae Augustae.92 Forse si tratta della proprietà nel territorio tuscolano in cui Tiberio sog-giornò nel 34 d. C., secondo la testimonianza di Cassio Dione93. Nella regione vi erano le proprietà, come abbiamo visto, di Messalina, di Agrippina, probabilmente di Marciana e quella di Matidia.
Le proprietà, imperiali e non, dovevano avere una fi nalità produttiva, ma è chiaro che non era questa la vocazione precipua di quelle che sorgevano in quest’area del Lazio. Ne fa fede, accanto alla mancanza nelle fonti di riferimenti alla qualità di particolari produ-zioni agricole, pure diff use, la descrizione che già in età augustea Strabone off re dell’ager Tusculanus:94 « una corona di giardini circonda il centro urbano, – egli dice – giardini che si distendono su poggi fertili e ben irrigati, costellati di edifi ci di regale splendore ». Quasi una vocazione questa, che tante donne della casa imperiale, scegliendo i Colli Albani, avrebbero reso nel tempo attuale.
92 CIL XV 7814: [T]i(beri) Caesaris et Iuliae Augu[stae]. La fi stula rivela attraverso l’onomastica di Livia come l’impianto idrico debba datarsi dopo la morte di Augusto; per l’onomastica « abbreviata » di Tiberio, ben giustifi cabile in una fi stula, vd. ad es. CIL XI 3303 = ILS 154. Sarà questa una delle nu-merose ville di proprietà imperiali che sorgeranno nel territorio tuscolano, come attesta la presenza di un procurator villarum Tusculanarum databile circa un secolo dopo (CIL XIV 2608, rinvenuta a Tusculum: Diis Manibus / Gaviae / Helpidi / uxori sanctissimae / T(itus) Flavius Aug(usti) l(ibertus) / Epaphra / proc(urator) villarum / Tusculanarum).
93 Cass. Dio 58,24; potrebbe trattarsi della stessa cui fa riferimento Ios. ant. Iud. 18,6,6.94 Strab. 5,3,12.
06_Granino_1U.indd 12706_Granino_1U.indd 127 13.12.2009 16:13:4013.12.2009 16:13:40