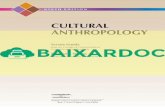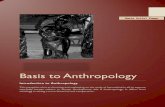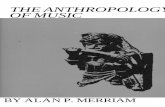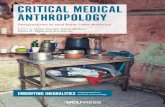Philosophical Anthropology
Transcript of Philosophical Anthropology
Contenuto dell’Antropologia filosofica
• Dal greco anthropos = uomo, logos = ragione, studio. Quindi studio dell’uomo dal punto di vista filosofico.
• Risponde alla domanda “Che cos’è l’uomo?” (Kant).• Non si tratta di questo individuo in quanto tale, ma dell’uomo in genere.
• Non si tratta di una visione esauriente dell’uomo che solo Dio potrebbe avere. Di qui l’interesse permanente per le rivelazioni religiose.
• L’interesse per questa disciplina è favorito oggi dalla rivoluzione scientifica e tecnologica come pure dal pluralismo culturale (favorito dalla globalizzazione) che incidono sulla concezione dell’uomo e che sollecitano a chiedersi: chi è l’uomo? Esiste una comune natura umana?
Storia dell’antropologia filosofica
• La disciplina è presente di fatto in classici della filosofia come Aristotele, Agostino, Tommaso, Kant, Hegel.
• Con questo nome la disciplina come riflessione filosofica sull’uomo sorge nel Novecento in Germania per reazione allo sviluppo e all'assolutizzazione delle scienze biologiche e umane (cfr., in particolare M. Scheler, H. Plessner, A. Gehlen).
• Ma la sua storia è assai più antica: risale almeno ad Aristotele. Cfr. i libri Sull’anima.
Momenti della storia dell’antropologia filosofica
• Dualismo anima-corpo (Platone, Cartesio). • Unione anima-corpo - Ilemorfismo: L’anima come forma del corpo Aristotele, Tommaso d’Aquino.
• In Tommaso l’atto d’essere attua e compie il composto anima-corpo, l’essenza del sinolo uomo. Ritornare alla sua essenza (riflettere su di sé) significa per la realtà capace di ciò sussistere in se stessa.
• Materialismo scientista riduzionista: la mente coincide con il cervello (Hobbes, naturalismo contemporaneo).
• Oggi la nozione di forma viene nuovamente valorizzata grazie alla nozione di informazione che non è riducibile alla materia. Così la mente non è riducibile al cervello.
Il metodo dell’Antropologia filosofica
• Sinergia fra • la conoscenza dell’uomo fornita dalle scienze in continua evoluzione
• e la riflessione filosofica ottenuta riflettendo sull’uomo a partire dalle sue azioni.
• Tommaso d'Aquino: a partire dalle opere e dalle azioni dell’uomo si risale alle sue facoltà e, quindi, all'anima quale principio unificante. L'ermeneutica oggi sottolinea questo aspetto, insistendo sull’interpretazione delle opere umane al fine di comprendere la natura dell’uomo.
Tommaso d’Aquino• L’intelletto umano conosce per primo l’oggetto (l’essenza della cosa materiale); e in secondo luogo conosce l’atto stesso con cui si conosce l’oggetto; e, grazie all’atto, conosce lo stesso intelletto, la cui perfezione consiste nel conoscere (Tommaso d’Aquino, Summa theologiae I, 87, 3). Cfr. pure Quaestiones disputatae de veritate, 1999, X, 8: «Da questo ciascuno capisce di avere un’anima, di esistere e di vivere – dal fatto che è consapevole di sentire, d’intendere e di compiere altre simili attività”.
Il sapere delle scienze• Procede attraverso la formulazione d’ipotesi che sono confermate o falsificate da fatti.
• È in continuo sviluppo. • Rischio dell’ideologia scientista quando si assume dogmaticamente una metafisica implicita come se fosse esito della ricerca scientifica.
• I filosofi e gli scienziati sono chiamati a distinguere ciò che è scientifico da ciò che è ideologico quando si tratta dell’uomo.
Discipline antropologiche
• Antropologia fisica: si interessa dell’uomo sotto il profilo fisico e biologico.
• Antropologia culturale: si interessa dell’uomo in quanto capace di dar luogo a diverse culture storiche.
• Antropologia filosofica: • a differenza delle scienze si interessa dell’uomo nella sua totalità e nell’orizzonte della totalità dell’essere. Si chiede, quindi, quale sia la natura e il fine (senso) dell’uomo.
• perviene classicamente alle cause prime e non si ferma alle cause seconde.
La vita• L'uomo e un vivente. Che cos'è la vita?• In quanto vivere esprime l’atto d’essere dei viventi (dai vegetali agli enti spirituali).
• Viventi materiali sono quegli organismi che conservano attraverso il tempo e il succedersi delle generazioni una loro continuità genetica (conservazione della specie mediante il succedersi delle generazioni degli individui).
• Ricorrono allo scambio con l’ambiente circostante (metabolismo e scambio d’informazioni).
• Vivere è un’azione immanente in quanto permane, comincia e termina nel soggetto e permette di determinare (in modo parziale o totale) il proprio comportamento
• Vivere è capacità di autodeterminazione a diversi livelli.
Autodeterminazione • Rispetto all’esecuzione dell’azione – possono compierla o non compierla in base alla loro natura o al proprio corredo genetico (vegetali) .
• Rispetto alla forma che è principio dell’azione e che acquisiscono da se stessi grazie ai sensi (animali).
• Rispetto al fine che determinano da loro stessi (uomo).
Differenza fra viventi e macchine
• Nella macchina l’unità formale e il finalismo sono accidentali. Essi sono estrinseci rispetto alle parti materiali che la costituiscono e imposti dall’esterno. Il vivente, invece, possiede un principio interno di unità (la forma sostanziale).
Aristotele• “Vivere è atto primo di un corpo che ha la vita in potenza”(De anima). Non, quindi, di qualunque corpo, ma di un corpo dotato di organi e in grado di essere informato dal principio vitale o forma. Si attua così un’unità fra anima e corpo che si disgrega con la morte del composto.
Tipi di azione• Azione transitiva è quella che non termina nel soggetto agente, ma determina qualcosa al di là del soggetto. Es. bruciare qualcosa.
• Azione immanente è quella che termina nel soggetto agente (es. vivere, conoscere). Si tratta di un processo circolare.
Specificità dell’uomo• L’uomo è unità • di psiche e corporeità.• di sensibilità e razionalità• di tendenza e razionalità.• è capace di libertà.• è un essere temporale tra passato e futuro.
• Tra maschio e femmina.
Unità dell’uomo• Per Tommaso d’Aquino l’atto
d’essere attua l’unica anima o principio-forma del vivente, la quale dà ragione nell’uomo della vita, della sua unità e delle funzioni superiori (ragione, autocoscienza, libertà).
Razionalità e tendenza• L’uomo non si comprende nella sua specificità né
• come mera razionalità• né come mera tendenza cieca• ma solo come intima unità di razionalità e tendenza.
La conoscenzaAssimilazione nutritiva: l’oggetto viene assimilato alla forma del soggetto.Assimilazione conoscitiva (sensibile o intellettuale): il soggetto assimila se stesso alla forma dell’oggetto.
Sensibilità• I sensi, a differenza della ragione, colgono l’individuale. Ma quando conosciamo e nominiamo questo individuo siamo già nella dimensione universale dei concetti e della razionalità.
• Sensi esterni: tatto, gusto, olfatto, udito, vista (non sbagliano - Aristotele).
• Sensi interni: senso comune, memoria, cogitativa (possono sbagliare - Aristotele).
• I sensi interni mediano fra sensibilità e razionalità, permettendo una prima unificazione dei dati sensibili che anticipa il concetto o significato universale.
La dimensione conativo - emotiva
• Appetito sensibile o bisogni (es. fame, sete).
• Appetito intellettuale o Inclinazioni che coinvolgono la ragione (es. tendenza ad autoconservarsi, a comunicare la vita, a sviluppare la razionalità).
• Desideri in atto che attuano le inclinazioni.
• Emozioni (essere mossi da) es. paura.• Passioni sono più stabili delle emozioni (es. iracondia).
Bisogno e desiderio- Il bisogno (per es. la fame) è connesso alla dimensione biologico-animale e si esaurisce momentaneamente quando è saziato.
- Il desiderio, in quanto informato dall’apertura infinita della ragione, non è a rigore esauribile. Esperienze come la delusione e la noia lo manifestano.
- Per lo più il bisogno è unito al desiderio. Per questo, per esempio, l’atto di mangiare assume un significato simbolico oltre che biologico.
Cibo e sessualità• Rappresentano due bisogni fondamentali segno dell’animalità dell’uomo.
• Questi bisogni sono risignificati nel desiderio ed assumono una dimensione propriamente umana.
• L’uomo non è pensabile senza queste dimensioni che contraddistinguono il suo rapporto con la realtà.
Valori•L’ uomo è in grado di riflettere su se stesso e suoi suoi desideri.
•Quindi di giudicare i suoi desideri come buoni o cattivi in base a un ordine di valori che è capace di riconoscere.
Articolazioni della ragione
• La ragione come capacità di apertura alla realtà (quodammodo omnia, in certo qual modo tutte le cose) e non solo come capacità di connettere fra loro i concetti (ragione discorsiva) è una e si articola a seconda dell’uso in:
• speculativa (in quanto tende alla conoscenza in quanto tale).
• pratica, in quanto tende a fare-produrre (arte, tecnica) o ad agire (morale, politica). Anche quando è pratica la ragione conosce la realtà.
Intenzionalità• L’uomo è capace di intenzionalità
• In quanto è in grado di conoscere e di desiderare qualcosa d’altro in quanto tale (ciò che conosciamo e desideriamo non è una affezione di noi stessi).
Apertura trascendentale dell’uomo
• Nel pensiero medioevale i trascendentali sono quelle proprietà che trascendono e comprendono le categorie (sostanza, accidente).
• I trascendentali sono l’ente, l’uno (come unità dell’ente in se stesso), il bene (come perfezione e appetibilità dell’ente), il vero (come intelligibilità dell’ente).
• L’uomo grazie alla ragione è capace di aprirsi all’essere e al bene nella loro trascendentalità.
Affezioni tipicamente umane che non si ritrovano negli animali • Denunciano la capacità dell’uomo di trascendere grazie alla ragione il proprio corpo e di decentrarsi, ovvero di guardarsi da altri punti di vista.
• Esempi:• Riso-pianto.• Pudore (percezione di non essere definiti dalla propria corporeità).
• Noia (come segno dell’apertura all’infinito).• Ironia (come segno della capacità della ragione di decentrarsi).
Razionalità speculativa• Articolazioni: significato (concetto - es. uomo), giudizio, discorso. Ruolo centrale del linguaggio umano.
• Nel giudizio è presente la dimensione della verità (e della falsità). Es. “Questo è un uomo”.
• Nel giudizio l’uomo diventa cosciente di sé. • In prima battuta l’intelletto comprende di comprendere altro da sé (coscienza).
• In seconda battuta, in quanto capace di aprirsi alla realtà nella sua alterità, egli è capace di comprendere di comprendere - autocoscienza (reditio completa).
Volontà• Desiderio come appetito razionale. Nell’uomo la tendenza che lo accomuna agli altri animali è informata dalla ragione e diventa desiderio.
• Il desiderio diventa atto volontario nella adesione consapevole al bene, in cui “si prende in mano” la propria vita.
• La volontà qualifica gli atti umani. Diamo più importanza alle azioni intenzionali in cui si manifesta il volere in atto. Es. degli studenti che seguono una lezione. Questo atto li qualifica.
• L’agire volontario non è fatto solo di scelte puntuali fra alternative, ma di atti di adesione, di consenso.
La libertà
• L’uomo è capace di libertà. Due dimensioni della libertà non si possono separare.
• A) Libertà di scelta o libero arbitrio fra azioni alternative (libertas minor).
• B) Libertà di compimento (libertas maior) come tendenza volontaria al proprio compimento (fioritura umana), partecipando a qualcosa di più grande. Più ci si compie, più si è veramente liberi.
• Entrambe sono rese possibili dalla razionalità ovvero dalla capacità dell’uomo di aprirsi all'essere nella sua trascendentalita-totalità e, quindi, di riflettere sui propri atti conoscitivi e volitivi con la ragione e con la volontà, distaccandosi da loro - Voglio conoscere, conosco di volere ecc.
• L’uomo può anche sacrificare le sue tendenze biologiche.
• Più l’uomo sceglie un oggetto adeguato all’estensione del suo desiderio, più la libertà matura.
Critiche alla libertà di scelta
• Il fatto che i neuroni si attivino prima che la scelta sia compiuta consapevolmente non costituisce una critica alla libertà di scelta.
• Il fenomeno della libertà è più complesso. Affermare il libero arbitrio non significa che vi siano eventi privi di causa, ma che vi sono circostanze, tra le quali l’agente può scegliere, alle quali attribuire priorità decisiva.
• Dio non è di ostacolo alla libertà umana. Secondo Tommaso la Causa prima che comunica l’essere (actus essendi) fonda l’autonomia delle cause seconde e, in particolare, dell’uomo.
Il desiderio di felicità
• L'uomo tende sempre alla felicità, anche quando non pensa alla felicità. Classicamente tendere alla felicità non è un dato meramente psicologico, ma ontologico: tendere al compimento, alla fioritura umana.
• Da quale esperienza si parte? Da esperienze contemplative a tutti possibili come il guardare, il vivere, il percepirsi amati, l’amare.
• Fra gli enti solo la persona è in grado di alimentare il desiderio, in quanto come noi aperta all’infinito. Gli uomini cercano di dare e ricevere riconoscimento e amore.
• L’altra persona può, tuttavia, venire meno e deludere. Di qui la permanenza della domanda religiosa. Il desiderio di felicità tende di fatto a un compimento insieme conoscitivo e affettivo.
Natura e cultura• L’uomo manifesta la sua natura di animale
razionale capace di decentrarsi, che accomuna tutti gli individui della specie uomo sempre attraverso una certa cultura (“seconda natura”).
• Classicamente la natura umana si radica nella dimensione biologica, ma non si riduce ad essa.
• Grazie alla cultura (abitudini, istituzioni ecc.) ci si esonera da certi compiti e si possono approfondire altri.
• L’unità della natura umana permette la comunicazione fra le diverse culture.
Intersoggettività e legami affettivi
• Solo l’intersoggettività permette di dire io (Mead). L’uomo diventa pienamente tale, attuando le sue potenzialità, grazie al rapporto con gli altri uomini e non solo grazie all’evoluzione biologica e al rapporto con gli oggetti. Ma ciò è possibile solo a quell’essere che ha le caratteristiche irriducibili della persona umana.
• Forme dei legami affettivi: affetto-amicizia-eros-carità.
• L’innamoramento non dipende da me.• L’amore, invece, richiede un lavoro.• L’esito è la famiglia, cellula della società.
L’uomo tra maschio e femmina
• Maschile e femminile sono una polarità costitutiva dell’umano radicata nella biologia, ma che non si riduce ad essa. Questa differenza non si può ridurre neppure a un fattore meramente culturale (gender) a motivo del suo radicamento biologico.
• La differenza sessuale è segno di finitezza e di bisogno di completamento.
• L’unità fra uomo e donna non costituisce una fusione totale, ma una polarità che lascia spazio al figlio in cui questa unità si attua.
Dimensioni dell’umano• L’uomo matura nel rapporto con la realtà, in particolare con gli altri e con l’Infinito. Dimensioni fondamentali:
• Estetica-Arte. • Lavoro-tecnica-economia. L’uomo ha bisogno di trasformare la realtà per mantenersi in vita (dimensione oggettiva del lavoro) e per crescere in umanità (dimensione soggettiva del lavoro.
• Diritto• Morale: Risposta alla domanda di senso. Gli esiti dell'agire sono imprevedibili.
• Dimensione religiosa: senso religioso, religioni storiche. Risposta alla domanda radicale di senso o di salvezza.
Unificazione e articolazione dell’uomo
• Solo svolgendo la dimensione più elevata (cercando di rispondere alla domanda radicale di senso) l’uomo può unificarsi e insieme articolarsi armoniosamente nelle sue varie dimensioni.
• “Distinguere nell’unito” come condizione per “distinguere per unire” (Maritain).
Estetica e arte• La dimensione estetica si trova all’inizio e alla fine di ogni esperienza di cui costituisce il fascino e il completamento (cfr. espressioni comunissime come “che bello!” o “che brutto!”).
• La dimensione artistica. Alla sua base c’è una esperienza preconscia, non pienamente concettualizzabile, che deve perciò manifestarsi all’esterno in un’opera.
Dal problema mente-corpo all’unità e dignità dell’uomo
• La capacità dell’uomo di cogliere i significati o concetti universali, quindi di aprirsi all’essere e di riflettere su di sé è classicamente segno dell’immaterialità dell’anima spirituale.
• Questa capacità fonda la sua libertà e moralità.
• Essa è fondamento della sua dignità che, in quanto tipica della specie umana, permane anche quando queste capacità non sono ancora sviluppate o vengono meno. Non esistono persone potenziali.
Irriducibilità della mente al cervello
• 1) il linguaggio interiore possiede un’esistenza meramente intenzionale. È la persona che comprende, parla, ode e pensa; queste non sono operazioni di qualche interiore parte di sé, ma della persona nel suo complesso. L’intenzionalità, che coinvolge tutto l’uomo, contraddice il riduzionismo. Se gli atti del pensare vengono ridotti, si riduce anche quella conoscenza del mondo che è alla base della scienza e del riduzionismo.
• 2) l’uso di significati o concetti generali richiede un principio, causa formativa od operazione che non funzioni in virtù di qualche isomorfismo materiale. Cioè tali concetti universali non funzionano in virtù di qualche somiglianza di struttura esistente fra una determinata capacità esercitata nell’utilizzarli e gli oggetti, le nature, i fatti conosciuti che sono sempre individuali.
• 3) la comprensione e l’espressione del linguaggio parlato richiedono una flessibilità tale che non può richiedere un correlato materiale (pensiamo, per esempio, alla difficoltà di comprendere fenomeni come l’ironia).
• 4) la capacità linguistica esige un soggetto che giudica e, in esso, delle strutture autoriflessive e riflessive sulle procedure per giungere ai giudizi. L’enorme complessità e articolazione di questo processo critico non può essere spiegata su base materialistica.
La persona• Origine teatrale (da maschera, per-sonare) e poi teologica del termine (le persone della Trinità).
• Rationalis naturae individua substantia (Boezio) e Subsistens in rationali natura (Tommaso).
• Persona significa sostanzialità e, insieme, costitutiva relazione ad altro.
• L’Irriducibilità (o incomunicabilità) della persona umana nella sua originale individualità (non riducibile al contesto biologico e socio-culturale in cui si situa e da cui pure è condizionata) è il fondamento della sua capacità di comunicare (intersoggettività).
• La persona è l’essere capace di scegliere chi essere, quindi naturalmente dotato di dignità (fine in sé).
Contro il riduzionismo
• Al fine di spiegare le azioni umane nella loro specificità non si può ricorrere a livelli inferiori di complessità (studiati dalla fisica, dalla biologia ecc.).
• La genesi non dà ragione della validità. Così la genesi della matematica non dà ragione della validità della matematica, la genesi della morale non dà ragione della validità della morale.
Ontologia e metafisica dell’uomo
• L’uomo è sostanza individuale di natura razionale, quindi aperto ad altro, in relazione ad altro. Egli è un ente finito, mutevole e temporale, bisognoso di completamento, in quanto in lui l’atto d’essere è partecipato da una determinata essenza individuale. Tale dimensione individuale si manifesta, per es., nella presenza del sistema immunitario. Sussiste un nesso fra sistema immunitario e sistema nervoso in quanto identificano quel singolo individuo umano.
• L’uomo è unità nello spazio e nel tempo (unità narrativa).
• La concezione dell’uomo è influenzata dal contesto metafisico in cui l'uomo si inquadra.
Tra monismo e creazionismo
• Monismo = esiste una sola realtà comunque la s’intenda.
• Creazionismo: Dio crea il mondo dal nulla. Esistono due realtà radicalmente diverse, ma in intimo rapporto fra loro.
• Il creazionismo, a differenza del monismo, salvaguarda la specificità dell’uomo che non è pensato come mera parte del tutto, ma è voluto e creato “ad immagine” di Dio.
Evoluzionismo • L’evoluzione dei viventi è un dato di fatto che va interpretato.
• Evoluzionismo lamarckiano (adattamento all’ambiente).
• Evoluzionismo darwiniano (mutazione casuale e selezione ambientale).
• Limiti dell’ideologia evoluzionistica
Limiti dell’evoluzionismo darwiniano
• Casualità non significa assenza di cause. Non poter prevedere gli effetti, non significa che non vi siano cause determinate e che non vi sia un fine dell’evoluzione.
• Se si vuole a priori evitare la soluzione finalistica, sarebbe necessario un tempo indefinitamente lungo perché la mutazione giusta compaia (mutazioni sbagliate possono sempre ripresentarsi, mancando ogni regola) e sarebbe necessaria una qualche memoria di tutte le mutazioni precedenti per non ripercorrere ogni volta strade sbagliate.
• Sul piano filosofico: l'affermazione di verità da parte dell'uomo non può essere frutto dell'adattamento alla realtà.
In principio c’è il Caos o il Verbo?
• Può l’uomo, la sua ragione che cerca un senso non essere esito, in ultima analisi, di un finalismo, essere cioè esito del Caos? In realtà, anche il pensiero del non senso del tutto, in quanto negazione del senso, implica che la nozione di senso, di fine, di ordine, sia costitutiva della struttura stessa della nostra ragione, della vita intima della ragione e del desiderio, della nostra vita biologica e, quindi, dell’evoluzione stessa dell’universo che ha condotto fino a noi e fino alla nostra comprensione di esso.
Post-human• Si tratta di un potenziamento (enhancement), in prospettiva di una modificazione radicale della struttura dell’uomo che sarebbe possibile grazie alla tecnologia.
• Ma questo è veramente possibile? Possiamo immaginare un uomo migliore che non sia uomo, cioè che non abbia classicamente la forma uomo (che cioè non contempli e non armonizzi in se stesso le caratteristiche proprie dell’uomo)?