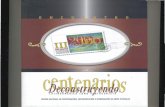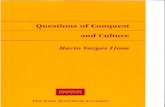Geodinámica Córdoba SIGISMONDI Mario E FANTIN Fernando A 2014 CGA
Mario Pani
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Mario Pani
© 2011 - Edipuglia srl, via Dalmazia 22/b - 70127 Bari-S. Spiritotel. 080. 5333056-5333057 (fax) - http://www.edipuglia.it - e-mail: [email protected]
Redazione: Valentina NataliCopertina: Paolo Azzella
ISBN 978-88-7228-652-4
PREFAZIONE
Ogni uomo fa parte con la sua vita della storia ein ognuno si concentra in qualche modo la storia deipropri tempi. Ho inteso in questa prospettiva racco‑gliere qui medaglioni della vita di mio padre che hapercorso quasi tutto il ventesimo secolo, svolgendoanche una funzione pubblica in una carriera prefet‑tizia. Non si tratta di eventi clamorosi delle varieepoche, pur drammatiche, né di ricostruzioni o ri‑flessioni su strutture ed accadimenti, bensì di fattiminori e quotidiani, materiale frutto di ricordi epi‑sodici ed eterogenei di mio padre stesso o, in piccolaparte, di mia madre, Gilda Veccia, o miei o di miofratello Egidio, o di mia sorella, Anna Maria. In essiperò, mi pare, le grandi tematiche, i grandi eventi re‑stano lo stesso da sfondo o fanno capolino, in modo,direi, allusivo o simbolico, e sono quindi original‑mente rivissuti.
Anche se di tutti noi bisognerebbe, nel senso in‑dicato, far storia, devo dire che non mi sarei proba‑bilmente spinto alla pur modica impresa, neppureper il semplice affetto o la devozione verso il padre,se mio padre non fosse stato, per il resto, persona diassoluta singolarità per quel che riguarda la conce‑
5
zione della condizione umana e il modo di sentirla.Questo aspetto diventa ricordevole, ancor più chedal punto di vista storico (dove pure ha ruolo), dalpunto di vista metastorico ed esistenziale, ma nonper questo meno di coinvolgimento e interesse co‑mune. Per questo vorrei fare conoscere ora miopadre ad altre persone, insieme al ricordo dei tempiin cui visse, perché magari altre persone lo aminocome si ama il personaggio di un romanzo. Sarebbeanche bello se magari trovasse ancora qualche amicovirtuale per affinità elettiva.
Non ho indugiato comunque nei ricordi ed epi‑sodi di carattere più strettamente personale e fami‑liare meno generalizzabili.
Lascio il materiale esposto nella maniera occasio‑nale in cui si è formato, sperando così almeno in unalettura “leggera” e piacevole.
6
La casa dell’Italietta
Peppino P. nacque nel 1902 a Caserta, in un pa‑lazzo alla fine di via San Carlo, a pochi passi dallacampagna. La Caserta di allora era piccola e gentile,sotto l’aurea della Reggia vanvitelliana, impiegati‑zia, contadina e militare. Suo padre era professoredi italiano presso un Istituto tecnico, finito nel na‑poletano dalla lontana Sassari per le occasioni di la‑voro che l’insegnamento offriva nella regione a fine‘800. In quella casa di inizi secolo v’era un arredomodesto a quanto noi oggi giudichiamo, ma digni‑toso e onesto, accurato e lindo. Immaginiamoci unacasa dell’Italietta giollittiana. Mio padre ricordava –ora che viveva in una casa con tre bagni attrezzati –il bagno della casa della sua infanzia: di poco più diun metro quadro, col solo vaso e non riusciva a ca‑pacitarsi di come a quei tempi si potesse essere tanto“fetenti”. Da qualche punto della casa sbucavano itopi. Peppino P. dava loro la caccia: l’attività di miopadre per me più sorprendente. Non mancava peròl’altro aspetto: il salotto buono lucido, gozzaniano,ordinatissimo, con le statuette di marmo, il lume adolio, i vasi opachi, l’orologio dorato, la coppa di ma‑iolica: resti che avrei conosciuto, ancora ben tenutidalla zia. Nella casa tutto portava al solotto e nel sa‑
9
lotto tutto portava al pianoforte, una specie di altaredi famiglia, al quale si avvicendavano instancabil‑mente mia nonna, correndo fra lo straccio della pol‑vere o i fornelli, le due figlie e mio padre. Perinderogabile disposizione della nonna dal salottobuono, blasone per le “grandi occasioni”, non si po‑teva passare. Sicché mio padre, per circolare percasa, dalla sua stanzetta doveva passare per il bal‑cone, anche d’inverno. Già che anche nella suastanza dalle fessure entrava il vento, il famoso ventocasertano. Peppino P. lo sentiva passare fra i capellimentre studiava. Col freddo gli si gelavano le manie i piedi. La soluzione per il riscaldamento era eco‑logica: Peppino scendeva in strada, si faceva dibuona lena o un po’ di corsa una lunga passeggiata,poi, di nuovo al tavolino col fiato che fumava caldo.
Nel grande cortile del palazzo era, al centro, ilpozzo, dove gli inquilini attingevano l’acqua; poi unalbero secolare dove si posteggiavano i cavalli. Ognimattina, da un cancelletto della strada adiacente alportone che dava nella campagna, venivano i conta‑dini con due grandi vacche e si piazzavano nei pressiper la mungitura. Dal palazzo e anche da case vicinele donne scendevano allora nel cortile a comprare illatte che si beveva poi, munto com’era.
La rivoluzione industriale
Ma la “rivoluzione industriale” non mancò difarsi sentire nelle quiete stanze. Fu un giorno magicoquando arrivò la luce. Una donna che faceva le pu‑lizie, al primo scatto dell’interruttore, fuggì via gri‑
10
dando agli spiriti. In casa funzionavano comune‑mente lampadine di cinque candele. In occasione diricorrenze, “feste”, “ricevimenti” si accendevanoquelle di dieci.
Il papà Egidio e la vita come sacro dovere
Mio nonno, sardo, professore, poi preside all’Isti‑tuto tecnico, era persona insieme umanissima e rigi‑dissima, fortissima e mite, di saldi principi come dicandida purezza, facile alle lacrime, di grande fedecristiana. Recentemente mio padre aveva ritrovatoper caso, trafficando nella nostra piccola biblioteca,un libro di Luigi Capuana, regalatogli dal padre nel1912, per una sua promozione: Scurpiddu (raccontoillustrato per ragazzi. Libro raccomandato dal Mini‑stero della pubblica istruzione). Sui bordi del fron‑tespizio era scritta in bellissime lettere la dedica,un’abitudine che mio padre avrebbe ereditato. Di‑ceva: “Carissimo figlio, altissima, intensa fu la gioiache provasti quando ricevesti questo libro come pre‑mio al tuo studio (…) È inutile che ti nasconda che lavita è sacro dovere (…) studia e spera, lotta e vinci,ama e sappi soffrire! Credi in Dio e Dio sempre ti ac‑compagni (…) e se talvolta la bufera infernale vorràtravolgerti nelle sue spire e inabissarti pensa al po‑vero Scurpiddu; dalla sua infelicità, forse, attingeraiforza per lottare, per vincere ed anche sorridere allavita, come sorridesti di gioia pura nell’animo tuo,quando ricevesti il premio!”. Ed io provavo ad im‑maginare il sorriso lieto di mio padre bambino(qualcosa forse gliene era rimasto) quando ebbe il
11
dono (anzi, il premio) e, a vederlo, quello del nonnosoddisfatto.
Nel libro, che mio padre, dopo aver ritrovato, te‑neva ormai sempre accanto a sé, con pochi altri, neisuoi ultimi mesi di vita, era conservata una cartolinascritta con grafia bella e minutissima del nonno allanonna, Letizia, una signora minuta (per quanto ilnonno era alto e massiccio), dolce e curiosetta, colnasino a punta e le gambe arcuatelle, che era inbreve vacanza a Procida, datata 1908. Il nonno davaalla moglie alcuni consigli (quelli dietologici sareb‑bero oggi probabilmente fatali…). “Cercherai difarti, la mattina, delle belle passeggiate; di sera peròno: l’umido potrebbe nuocere a te e ai figli. Come stal’Elena cara (la prima figlia)? E l’adorato Peppino?Baciali, baciali nuovamente, baciali ancora, ancora,ancora! Non dimenticare di fare ai figli l’infusionedella corallina. Se puoi compra dei frutti di mare el’acqua contenuta la farai bere ai bimbi; tale acqua famolto bene anche a te. Se puoi, mangia spesso delleostriche, queste ti rinvigoriscono (…). Tuo affettuo‑sissimo per la vita”.
Mio padre ammirava quel calore e, al confronto,credo si rimproverasse di non essere stato un maritoed un padre altrettanto espansivo nel proprio af‑fetto, altrettanto interessato delle piccole cose quoti‑diane della famiglia. Lui faceva fare tutto a miomadre; del resto capiva poco delle cose pratichedella casa e aveva, in generale, eccessivo ritegno.Probabilmente però in questo aspetto del suo carat‑tere aveva influito proprio l’educazione paterna, to‑talizzante e possessiva, troppo premurosa e rigida.
12
Fino alla terza elementare Peppino P. era stato pre‑parato nello studio, a casa, dal padre. Da questaprima educazione avrebbe ereditato un suo qualcerto aristocratico distacco, che era in conflitto conun temperamento passionale.
Per il resto il nonno non seguiva certo una psico‑logia educativa avanzata. Un pomeriggio portò tuttala famiglia a teatro. Era un evento straordinario. I ra‑gazzini erano tutti felici ed emozionati. Alla fine delprimo atto però il nonno si alzò e si riportò in ordinetutti casa. A Letizia che per strada gli chiedeva il mo‑tivo di quel la improvvisa decisione, ma, s’intende,senza discuterla, spiegava che era ormai chiaro nelsecondo atto sarebbero successe cose poco belle.Così mio padre rimase per tutta la vita col desideriodi vedere il secondo atto di “Giovannina o la morte”,e con l’angoscia di ciò che in quel seguito sarebbe do‑vuto succedere.
Quell’uomo mite ed integerrimo, fervido catto‑lico, era un acceso nazionalista risorgimentale. Eraquindi un convinto interventista, favorevole allaguerra perché si liberassero Trento e Triste. Scrisseanche una tragedia contro Francesco Giuseppedella quale lessi un veemente, ingiallito fram‑mento conservatosi fra le sue carte. Un giorno ar‑rivò fino alle lacrime vedendo dalla finestra unaschiera di giovani che partivano per il fronte, laleva del ‘99. Alla moglie che lo guardava d’accantoe meravigliata e gli chiedeva cosa avesse mai con‑fessò la sua commozione ed il suo rammarico per‑ché il figlio non aveva l’età “per unirsi a quei
13
valorosi”. Quella volta nonna Letizia reagì moltonapoletanamente.
Mio nonno era chiamato spesso per gli elogi fu‑nebri. Suo alunno era un valentissimo e prometten‑tissimo giovane, di nome Ottorino. Anche lui partìper la guerra, con l’ultima leva: era un ragazzo del‘99. “Professore, morto sì, prigioniero mai !” fu il sa‑luto al suo maestro. E fu fra i tanti che non torna‑rono. Mio nonno ne recitò un classicistico (e direisplendido) elogio funebre in una bella giornata disole: “Te beato Ottorino! Tu fosti eroe sui banchidella scuola, sei stato eroe sulle trincee della patria!”.Mio padre ricordava spesso questa invocazione, conla mano nervosa protesa, vibrante in alto, “Te beatoOttorino!”; e l’accompagnava con un misto di am‑mirazione, rispetto verso il padre, ma anche indefi‑nibile ed impalpabile ironia: erano i sentimentipropri di un uomo che si era trovato a vivere in am‑bienti e tempi in cui confluivano istanze diverse e inmutamento. E ogni volta che in scritti o alla televi‑sione si riparlava in qualche modo della Grandeguerra o del Sacrario sterminato di Redipuglia, miopadre, che quei morti non considerava giustificati danulla, ogni volta, d’un tratto, si metteva ad evocarecon trasporto, come se volesse anche recuperare,senza crederci, dei valori sprecati o delle spiegazioniimpossibili o illusioni come tali, con un indecifrabilesospiro, vibrando in alto la mano nervosa: “Te beatoOttorino...!”.
Ad un certo punto mio nonno cominciò ad av‑vertire i fastidi della vista che lo avrebbero portato
14
alla cecità. Il medico lo avvisò subito. Naturalmenteegli non disse nulla in famiglia, tenendo per sé il suotriste segreto fin quando poté. Dopo che perse deltutto la vista, il figlio passava molto tempo a legger‑gli libri. Le preferenze del nonno erano per la nar ra‑tiva; il suo romanzo I promessi sposi. E ancora doposposato e trasferito a Cosenza, mio padre, quandoandava a Napoli a trovarlo, riprendeva la vecchiaconsuetudine come se non l’avessero mai interrotta.Gli si metteva accanto a leggergli libri; e ancora Ipromessi sposi. E il nonno seguiva, mentre le la‑crime lentamente scendevano a solcare quel grandevolto rugoso, grave e solenne, segnato dalla cecità,che io conobbi dalle fotografie. Intanto mio fratelloEgidio, bambino terribile, siamo negli anni 30, im‑pazzava per le stanze, il salotto buono, e l’eterea edolce nonna Letizia – più che mai custode gelosis‑sima della casa – mentre gli correva appresso dap‑pertutto, tirava fuori tutta la sua napoletanitàgridando a mia madre: “portallo fora a sburrià, por‑tallo a sburrià”.
Quando il nonno morì, mio padre ne fu avvisatoper telefono mentre era in prefettura a Cosenza. Ri‑prese a lavorare, senza dir nulla. Ad un collega chesi accorse del suo turbamento e gli chiese cosa maiavesse, rispose: “mio padre ...mio padre non stamolto bene”. “E perché – chiesi io – non gli dicesticosa era successo?”. E lui: “Avrei dovuto parlare conlui di mio padre? E che cosa avrebbe capito?”.
15
Lo zio Eugenio e la belle époque
Se mio nonno fremeva per la giusta causa dellaguerra e la vittoria sullo straniero invasore, c’era ac‑canto a lui, chi seguiva la vicenda della guerra inmaniera diversa, fin troppo disincantata, lo zio Eu‑genio, fratello della nonna.
Rientrando, in qualche modo, certa sua attivitànella catena delle forniture di guerra, lo zio Eugenio,era fra quelli che qualcosa guadagnavano dal con‑flitto e lo guardava comunque con distacco e suffi‑cienza. Né si tratteneva dal prendere in giro lo stessoardore patriottardo del nonno: “Gli eroi del Mezzo‑giorno!” esclamava di soppiatto, senza farsi natu‑ralmente sentire dal nonno, beffeggiando tutti,mentre quello, fra gli sguardi ammirati dei suoi,esaltava le grandi imprese dei soldati e l’etica dei co‑muni sacrifici.
Nell’atmosfera morigerata, un po’ gozzaniana, unpo’ deamicisiana della casa di mio padre, lo zio Eu‑genio introduceva, a parte il mancato eroismo na‑zionalistico, una nota di raffinata vo luttuositàdannunziana. Sempre elegante e ricercato come inun’atmosfera da Belle époque, non si sapeva comeviveva e come guadagnava. Giocava in borsa e allecorse dei cavalli. Andava spesso in Inghilterra; co‑nosceva quindi alla perfezione l’inglese, cosa natu‑ralmente rarissima ai tempi. Girava in calessino, avolte con qualche bella signora in piume che susci‑tava i mormorii del parentado. Quando mangiava acasa di mio padre, amava far suonare al piano la ni‑pote, durante il pranzo, sacrificandola così a quella
16
che gli pareva una finezza. Ostentava la sua culturascolastica in maniera peraltro banale, suscitando lui,a sua volta, l’ironia di mio padre e della cuginaGilda, come quando indirizzava le sue lettere scri‑vendo “Fuori dal gregge” invece di “Egregio”: op‑pure quando in un epitafio fece scrivere “Ebbe gioiadell’urna” parafrasando il famoso verso dei “Sepol‑cri” del Foscolo: “Sol chi non lascia eredità di affetti,poca gioia ha dell’urna”.
Per quanto mio padre lo criticasse ancora amabil‑mente quando me ne raccontava, per il suo avven‑turismo, il suo esibizionismo, non poteva nonsentire, e lo si capiva da quanto spesso lo citavadopo tanti anni, anche il fascino di una persona cheportava con sé tanta esperienza diversa da quellaalla quale a casa sua erano abituati e che frantumavacon una battuta, un sottile sorriso beffardo quelmondo di valori, spesso artificioso, nel quale miopadre era stato educato. Certo da questa linea fami‑liare mio padre ereditò quella vena beffeggiatrice delprossimo e, a volte, anche dissacratice, di rottura chesi accompagnava nel suo carattere, in un complessocircuito, alle grandi certezze da custodire e al senti‑mento del “sacro dovere” che gli venivano dalpadre: una composita formazione che si riproducevanel suo microcosmo privato da quelli che erano lefratture, le antinomie, le contraddizioni, che sareb‑bero stati dati caratteristici specie della prima partedel secolo.
17
La domestica e la Prima Guerra Mondiale
Nel nostro piccolo quadro sociale, altra visioneancora, fra i sentimenti diffusi verso la GrandeGuerra, da registrare quella della domestica, che aiu‑tava la nonna nelle faccende di casa (quella a suotempo fuggita di fronte alle prime lampadine ac‑cese). La buona donna aveva il figlio in guerra e, nonsapendo naturalmente scrivere, dettava a mio padrele lettere per lui al fronte. “Ogni volta – raccontavamio padre – era la stessa scena. Io chiedevo: Cosavolete che gli scriva? e lei, dopo averci pensato unpo’, prendendo a roteare le mani e le braccia e al‑zando le spalle con fare accomodante: “Scrivite...scrivite ca sperammo ca finisce tutto cose e isso tornaa casa soia”.
La scuola
Dopo l’affettuosa e rigida tutela paterna, PeppinoP. cominciò a frequentare le elementari nell’atmo‑sfera enfatica conseguente. Aveva quindi una veravenerazione per il Direttore che, con la sua aria so‑stenuta ed austera, gli sembrava “il Padreterno interra” “ed era” – ricordava ora mio padre costernato– “l’uomo più ridicolo del mondo”. Fra l’altro, usavaannunciare in piccoli manifesti il suo andare in va‑canza ed il luogo.
Poi il liceo. Il suo rammarico per i cattivi profes‑sori. Il professore di Italiano era un prete. “Un prete”– osservava mio padre, che pure era cattolico – “non
18
può essere professore di Italiano al Liceo”. Restavail ricordo delle burle a questi professori poco stimati.Di mira era particolarmente preso il professore di fi‑losofia, che parlava in dialetto. Aveva un sistematutto suo di ricercare l’efficacia. Quando si trattava dispiegare le sensazioni, l’olfatto (allora si studiavanoelementi di filosofia teorica, più che storia della filo‑sofia) così esemplificava ai ragazzi: “Vui trasite int’a nu cessu puzzolente... a puzza !” e si tappava ilnaso. E mio padre: “Ma non poteva dire, che so ?:«Voi entrate a primavera in un giardino fiorito... ilprofumo» e qui un bel respiro”. C’è da dire però cheil vecchio professore, come i suoi alunni, avevanoprobabilmente più familiari gli odori sgradevoli diquelli soavi. Quando poi il professore spiegava contrasporto i principi universali, un alunno burlone sicontorceva sul banco con la testa fra le mani, impu‑nemente, come tormentato dalla complessità e dallaprofondità delle parole del professore che l’osser‑vava compiaciuto. Mio padre ritrovò questo compa‑gno di scuola quarant’anni dopo in un’alta funzioneministeriale. Gli ricordò l’episodio. “Quanti esseri cisono in noi !” commentò con malinconia il sagaceamico. Una volta, ancora, poiché il professore avevadetto, qualche lezione prima, di aver conosciutoMommsen, esprimendo anche ai suoi alunni qual‑che rispettosa osservazione su di lui per questioninazionalistiche, un alunno si alzò e gli chiese can‑dido: “Professò è overo che vui avite rate nu pac‑cherone a Mommsen?”. E il buon, ingenuovegliardo, che restava a modo suo un uomo discienza, tutto compreso: “Guaglio’ ne’ ma tu che
20
dice? E comme? Io reve nu paccarone a Mommsen?Ma quello era un uomo venerando”.
A causa della guerra la generazione di mio padrenon sostenne gli esami di stato per la licenza liceale.E fino a tarda età Peppino P. continuò ad essere per‑seguitato da un sogno: che dovesse sostenere ancoraun esame prima di entrare nella vita.
La giovinezza
E venne l’età della giovinezza, dell’università.Mio padre sorprendentemente non ricordava sem‑pre con piacere quegli anni (il dopo Grande Guerra).Su diverse cose gli sembrava di non poter esseresoddisfatto. Con una certa commiserazione per quelse stesso lontano, pur ambiguamente mista all’ine‑vitabile nostalgia, ricordava di aver passeggiato peril corso di Caserta con il bastoncino di bambù e ilcolletto duro (rimpiangeva di quegli abbigliamentisolo la paglietta e, per le donne, il ventaglio e gli om‑brellini da sole).
Io, pur cercando di capire il motivo della suascontentezza, non gli chiesi mai notizie sui loroorientamenti, le sensazioni politiche dei giovani ca‑sertani di quegli anni. Non glielo chiesi perché te‑mevo di metterlo in imbarazzo. Semplicementecredo che lui e i suoi amici non ne avessero di de‑terminati, a parte una generico amore, alquantospinto, per la libertà. I movimenti operai, il bienniorosso del 1919/20, il seguente biennio nero e i primimoti fascisti, l’organizzazione politica cattolica na‑
21
scente: temo che non ne fossero toccati, almeno nonal punto da aver costituito un patrimonio di ricordi.E mio padre si rimproverava, in effetti, certa legge‑rezza, certa frivolezza di quei tempi; la scarsa cono‑scenza e consapevolezza dei problemi sociali, dellelinee politiche in gioco e anche la parzialità e pro‑vincialità della cultura. In effetti si ha la sensazioneche essi non avessero piena coscienza di ciò che ac‑cadeva attorno a loro. Si richiedono certo delle spie‑gazioni di ciò e c’è da riandare alla depoliticizza‑zione, credo, diffusa ancora di quegli anni. Ricor‑diamo che il suffragio universale maschile si eraavuto solo nel 1912, sette anni primi dell’inizio del‑l’università per la generazione di mio padre. Solonel 1919 si era poi passati al sistema elettorale pro‑porzionale, e quindi allo strumento di una larga po‑liticizzazione sociale con la nascita dei grandi partitidi massa. Solo da allora il “partito” politico comin‑ciava a prendere il ruolo dell’individualismo libe‑rale che aveva retto il sistema nella prima Italia. Masiamo agli inizi. D’altra parte le informazioni eranopoche allora. Bisogna immaginarsi in quel clima,specie in provincia. La radio mancava. Comparvenei pieni anni ‘20; i giornali erano incompleti e, co‑munque, poco diffusi. Ma, soprattutto, ricordiamo,c’era stata la guerra; i giovani avevano visto i lorofratelli, cugini, amici, poco più grandi, partire per ilfronte e non li avevano rivisti più tornare, o magaritornare gravemente invalidati, pur se sorridenti;avevano vissuto con i loro genitori, parenti, amicil’angoscia di quei terribili elenchi dei caduti al fronteche si ascoltavano dai nunzi nella piazza; avevanopatito le privazioni di ogni cosa, e non si era parlato
22
di altro. Si poteva non capire, dopo tutto ciò, unaqualche leggerezza; un certo disincanto per la poli‑tica che poteva significare soltanto guerra o pace,roba da reduci? Infine i moti di sinistra e di destracoinvolgevano, come è noto, specialmente l’Italiacentro settentrionale; molto più episodici i moti alsud, come a Napoli. Cosa arrivava di tutto ciò allamedia borghesia di una provincia meridionale? “Al‑lora si rideva per poco”, ricordava mio padre e ci‑tava alcune battute semplici con gli amici (fra i qualisi distingueva l’amico del cuore, Renato Jaselli; lo ri‑vide per caso, nella chiesa della patrona Sant’Anna,in una nostra visita a Caserta negli anni ‘60, e il vec‑chio amico ebbe anche allora la battuta pronta “San‑t’Anna m’ha fatta a grazia!”). Delle preparazioni(“sciocche”) per una recita teatrale scespiriana, sco‑perta da una vecchia foto, mio padre non volevaperò assolutamente che gli si chiedesse niente.
Intanto una ragazzina di nome Gilda aveva co‑minciato a frequentare la casa di mio padre, pren‑dendo lezioni di piano dalla sorella Elena, che erauna concertista ormai: era mia madre, che mentre ilnonno Egidio trepidava orgoglioso per i suoi alunniche riconquistavano Trento e Trieste, aveva fatto dabambina la sua parte quando a scuola le scolarettecucivano, con le dite pieni di geloni, per i soldati alfronte (permettetimi un inciso: ripenso spesso anonno Egidio, al beato Ottorino, al figlio della do‑mestica, a mia madre che cuce da bambina a scuolaper i soldati al fronte, quando parla l’attuale LegaNord). Ora dunque Gilda diventava amica di Pep‑pino P.
24
Parte preponderante nelle giornate per loro avevanaturalmente lo studio: mio padre si laureò in Let‑tere e poi in Giurisprudenza. Affascinato dallo stu‑dio e dagli studiosi, ricordo il suo entusiasmo peralcuni professori d’Università e la devozione perD’Ovidio che “sembrava il vicepadreterno”. Eraviva anche la passione per i grandi avvocati, di cui igiovani andavano a sentire appositamente le arrin‑ghe. Uno di questi dedicava un suo volume alla mo‑glie “àncora ed ala”, un’espressione che trascinavamio padre (una debolezza?). In genere, le etichettedi “retorica” in senso negativo, sentivo, lo infastidi‑vano; “retorica… è retorica… ma si vergognasserodi ben altre cose!”.
E c’era poi, vero sottofondo continuo della vita dimio padre, dalla giovinezza, la musica: l’opera e ilcontinuo via vai dei melomani fra Caserta e il log‑gione del San Carlo: Bellini, Verdi, il nuovo astro,Puccini, e l’indicibile fascino dell’operetta, La ve‑dova allegra, Cin Cin Là, che lo avrebbero com‑mosso fino agli ultimi anni (ma allora c’era appuntoil ricordo della giovinezza e l’operetta pare fatta ap‑posta per ricordare una giovinezza perduta): quindila musica concertistica più alta: Beethoven, Wagner.Mio padre, oltre che suonare il piano, cominciava adappassionarsi al romantico violino, mentre miamadre si diplomava in pianoforte al prestigioso con‑servatorio di San Pietro in Majella di Napoli. Per ilresto gli spartiti della musica erano il mercato abi‑tuale; leggere e suonare la musica era spesso l’unicoitinerario per ascoltarla. E questo valeva anche per lamusica leggera che mio padre non disdegnava af‑
25
fatto, quando di qualità, accompagnandola alla mu‑sica “seria”: le romanze, le canzoni napoletane; lenovità quindi delle canzonette: mio padre ricordavaAbajour, la vera frenesia che suscitò alla sua uscita:tutto un correre a comprare lo spartito e poi a suo‑narla al pianoforte.
Accanto alla musica la lettura; erano in voga al‑lora i romanzi; più trascurata rispetto ad ora in ge‑nere la saggistica. Nella biblioteca di mio padrefacevano bella mostra intanto i libri di scuola e diuniversità che il nonno aveva fatto preziosamente ri‑legare in verde e in rosso mattone e dove si trovanodiverse piccole rarità; fuori da questa collezione,c’era pressoché tutto De Sanctis, compresi il Viaggioelettorale del 1920 e, un po’ più tarde, le Lettere aVirginia del 1926: di De Sanctis mio padre adorava,oltre, naturalmente la Storia, un altro capolavoro as‑soluto, il Petrarca. C’era anche parecchio Croce deiprimi anni ’20: Poesia e non poesia, l’Estetica, Lapoesia di Dante, il Carducci; si sarebbero aggiuntedopo le opere storiche. Dei classici, erano presentispecie quelli recenti, una strepitosa edizione zani‑chelliana di tutte le poesie di Carducci del 1924, con“ritratti” e facsimili; pressoché tutto, credo, Pascoli,compresi Sotto il velame e i Carmi latini, sempre inpreziose edizioni di questi anni. V’era poi moltoD’annunzio con teatro, in fantasmagoriche edizioni,e romanzi; tutte le Laudi si sarebbero aggiunte dopo;così come si sarebbe aggiunto negli anni ‘30 tutto Pi‑randello, l’autore del cuore di mio padre più maturo.In generale, in quegli anni, con i suoi amici e le sueamiche, tanto tempo si dedicava però ai romanzi alla
26
moda: oltre ancora a D’annunzio o alla Grazia De‑ledda, al dignitoso Rosso di San Secondo (Ho sco‑perto il vero Dio), i minori come Luciano Zuccoli (Lafreccia nel fianco), Lucio D’ambra, ma anche la più“scandalosa” Sibilla Aleramo (Una donna; Amo,dunque sono), della quale si condividevano del restogli spiriti libertari; magari sdraiati d’estate nella reg‑gia di Caserta. Gli stranieri latitavano (ricordo soloCervantes, Flaubert, Dostoevskij). Mio padre ricor‑dava le sue letture di romanzi con l’autoironia, mistaal rimpianto, che gli era propria in questi casi. Masu questo fronte era più comprensivo ora e si per‑donava qualche “debolezza” comune.
Studio, musica, amicizia, amore, letture, ironia.
In generale, nel caso di mio padre, la leggerezza,che a volte si rimproverava, non era sempre fine asé stessa; per i suoi studi, il suo particolare sentire,essa era spesso, in realtà, la patina di una vera venaintellettuale, come fuga in una certa tenue romanti‑cheria (il suo violino), anche, al momento, scapi‑gliata, bohémien, il mito dell’artista, persona fuoridal comune (e fuori dal mondo? anche qui un di‑stacco dal padre?), figura che credo fosse il modelloper mio padre ventenne, come vedo da alcune suefotografie un po’ in posa, con gli abbondanti capellial vento e gli occhi vivacissimi e sognanti.
Ho pensato spesso a come allegramente questagioventù vivace e passionale, ingenua e pura, riccadi speranze in un mondo dove regnasse il culto del‑l’arte, del talento, del merito e della libertà e si vi‑vesse anche con letizia e sana ironia, si dirigeva
27
28
verso il fascismo che avrebbe umiliato tanta partedella loro vita e del loro ingegno. Ma erano tempi fe‑lici per loro: era la loro giovinezza, che passa unavolta soltanto e sotto qualsiasi regime. Anche se a ri‑cordarla, nel tempo, col senno di poi, lasciava qual‑che insoddisfazione.
Toh! Il Fascio
Un primo impatto con il Fascio Peppino P. lo ebbea metà degli anni ‘20 a Caserta, incocciando in unamanifestazione squadrista. Era un brusco risvegliodall’educazione domestica deamicisiana e giolittianae dall’atmosfera disimpegnata, “borghesemente” bo‑hémien giovanile. Qualche boss gli intimò di to‑gliersi il cappello davanti alle insegne; egli si rifiutò.Peppino P. difendeva la sua libertà. Fu punito perquesto: nel ricordo di mia madre gli fu impedito perun anno di partecipare a concorsi pubblici.
1.A Cosenza
La prefettura e Cosenza
Nella scelta della carriera mio padre privilegiò lasua laurea in giurisprudenza, piuttosto che quella inlettere, nonostante che avesse poi preso l’abilitazioneall’insegnamento di Italiano e Latino. Forse dellacarriera di professore non amava il contatto troppocontinuo e assillante con studenti non sempre docili;non attirava del resto una retribuzione che, comel’esperienza della sua pur dignitosa famiglia dimo‑strava, non permetteva certo una vita senza pro‑blemi, anche se non vigeva allora l’attuale ideologiadell’agio. Ma soprattutto Peppino P., pur nel suo in‑dividualismo, aveva un grande senso dello Stato elo affascinava mettersi al suo servizio: servizio chesignificava per lui incidere, nel suo piccolo settore,per la pratica di un retto agire, per la buona ammi‑nistrazione, il bene comune.
Avrebbe voluto indirizzarsi verso il concorso peril Ministero degli Esteri, ma alla fine degli anni ’20,per far carriera di ambasciatore, bisognava avere al‑
31
meno tre quarti di nobiltà. Affari interni allora. Leprefetture, a quel tempo, erano l’espressione piùalta dello Stato, più ricca di simboli; l’approdo dicarriera per un giovane brillante. Sì c’erano i fascistial potere, ma ancora non se ne erano visti gli esiti“definitivi” e un giovane poteva pensare che sareb‑bero durati poco ed anzi poteva essere utile intantouna macchina amministrativa sana con qualchetesta pensante. Vinse dunque il concorso ed entròin Prefettura. Sarebbe stato un burocrate sui generis,un burocrate umanista. Dopo un breve primo inca‑rico a Taranto, per far posto al figlio di un gerarcalocale, venne trasferito a Cosenza. Cosenza era unmondo immobile in una realtà ad economia essen‑zialmente rurale e piccolo‑pastorale latifondistica,con le stesse risorse forestali ancora poco sfruttate,un artigianato da scambi ristretti in un retroterrapovero e problemi ancora ambientali legati anchealla persistenza di zone malariche. I calabresi eranoperò accoglienti e generosi, e non mancavano sac‑che culturali abbastanza vive, se pure individuali‑stiche. Siamo nel 1932: mio padre vi giunse con lafresca sposa Gilda.
La divisa, le marce, l’OVRA e la voce del Duce
Sotto il fascismo mio padre era agli inizi della suacarriera; non ci ha lasciato dunque molti ricordi. Gliimpiegati portavano la divisa: un segno certo di uni‑formità anonima e di inquadramento, ma devo direche in essa vedo un perverso fascino quando osservouna foto di mio padre in austera divisa nera mentre
32
accompagna la mia sorellina piccola piccola con uncappottino rosso nella grande villa cosentina pienadi neve. Forse una qualche attrazione per una soli‑darietà ideologica, da me non sperimentata, nel‑l’idea di un servizio comune?
Era il periodo delle continue celebrazioni, lemarce alle quali il partito chiamava anche i funzio‑nari. E su queste, un classico nella mitologia dei rac‑conti di quest’epoca: mio padre partecipava al corteocon un amico d’ufficio; alla prima occasione buonasi eclissavano, si nascondevano, con tutta la divisaideologica, in qualche portone e poi via! nella cam‑pagna dell’amico a mangiare noci e fichi secchi ebere un buon vinello frizzante di casa.
L’OVRA (l’Opera di Vigilanza e Repressione del‑l’Antifascismo) era ancora un’ossessione nei ricordidi mia madre (“allora c’era l’OVRA!”). Natural‑mente mio padre, essendo un impiegato statale,non poteva fare dell’antifascismo; ma era uno spi‑rito libero, aveva un animo critico. Si dice che in Ita‑lia si vivesse allora, prima della guerra, tuttosommato, nel consenso; io non lo so, ma certamentesi viveva con angoscia. Un giorno mio zio materno,Armando, un moderato di sinistra, che abitava inun piccolo paese del Liri, chiamò mio padre per te‑lefono. Gli intimò di raggiungerlo subito a Casertaperché doveva dirgli una cosa urgente, importan‑tissima. Non poteva assolutamente parlare per te‑lefono. Mio padre andò: era una occasione perrivedere Caserta. Appena lo zio Armando lo in‑contrò, potè finalmente dargli il suo messaggio:
33
“Devi stare attento. Abbiamo saputo che negli Uf‑fici statali c’è l’OVRA”, “E tu m’hai fatto venire finqua… e che? io u’ nnu saccio?”, rispose mio padredivertito.
Quanto a Mussolini, Peppino P. riconosceva unaqualche efficacia nella sua voce e questo forse era iltributo a certa educazione retorica della sua genera‑zione ed io la devo registrare. Una volta poi che lo ri‑cevettero in visita a Cosenza, rimase colpito dai suoiocchi eccezionalmente decisi. Ma mio padre era unodei pochi, a quanto pare, che coglieva, al di là deldramma, il senso del comico del regime. I famosi“Giornali Luce” cinematografici sui “valorosi legio‑nari del Duce”, diceva, li vedeva come se assistessead una farsa e come se da un momento all’altro do‑vesse uscire qualcuno per dire: “v’è piaciuto loscherzo ?” (me ne ricordai vedendo il film di Benigni“La vita è bella”).
Per fortuna, come funzionario di prefettura, Pep‑pino P. non fu chiamato per nessuna guerra. Non sa‑prei immaginarlo proprio con il fucile in mano. Selo sarebbe fatto cadere sui piedi.
Il feroce Saladino
Negli anni ‘30, mentre andavamo alla conquistadi un impero in Africa, nella prefettura di Cosenzaun collega di mio padre combatteva la sua battagliapersonale con “il feroce Saladino”. Egli non eccel‑leva in produttività. Così, era solito far sparire le pra‑tiche che doveva evadere. Le nascondeva in un
34
cassetto di cui lui solo aveva la chiave e che non ve‑niva mai aperto. Non per niente v’era scritto sopra:“Emergenza. Piano di mobilitazione generale”. Il no‑stro personaggio era impegnato piuttosto a cercare“il feroce Saladino”, la figurina a premi collegata adun programma radiofonico di grande successo: “Itre moschettieri” (che in effetti per anni avrei sentitoancora evocare). Per questo non faceva che mangiarecioccolatini, dove erano le figurine. L’uomo eraanche appassionato di teatro. Aveva una filodram‑matica di dilettanti. Spesso, mentre si combatteva inAfrica, lui premeva perché mio padre andasse a ve‑dere una sua attrice della quale magnificava le qua‑lità: “Può mettersi a piangere con lacrimoni appenaglielo chiedi, in qualsiasi momento”. Ma mio padrenon aveva voglia di chiederglielo.
Quando dopo la guerra, ristrutturando l’ufficio,venne aperto anche il famoso cassetto sul “Piano dimobilitazione generale”, vennero infine alla luce lepratiche annose. Ricordava mio padre: “Per la mag‑gior parte di esse non c’era più niente da fare. Leaveva evase il tempo”.
La guerra, i funzionari e il vetturino
Ascoltato, trasecolati, in ufficio il tristemente sto‑rico discorso di Mussolini, nel gennaio del ’40, cheannunziava l’entrata in guerra dell’Italia, mio padreed un suo collega restarono con un senso di oppres‑sione. Ebbero allora un’idea apparentemente bal‑zana: scendere a farsi una bella passeggiata incarrozzella fino al vicino paesino medievale di
35
Rende, dove sarebbe poi sorta l’Università e che al‑lora era collegato a Cosenza da un gran vialone. Eraforse una maniera per andare a recuperare, riassa‑porare e quasi custodirsi un po’ di vita normale, se‑rena, che si sapeva in pericolo; riscoprire econservare, per quanto si poteva ancora, la gioia delquotidiano. E in quel lungo tragitto senza meta, lui,l’amico e il vetturino, che si voltava continuamenteconcitato, commentavano quelle parole gravi e alto‑sonanti che li chiamava ad un destino che tutti lorosentivano estraneo.
La città vuota
Durante la guerra, la Calabria e Cosenza non sitrovarono certo al centro della bufera, però nel fati‑
36
Con la famiglia sfollata a Cerisano.
dico 1943, gli angloamericani, sbarcati in Sicilia,mossero verso Nord nella penisola e si facevanostrada a suon di bombardamenti; i militaridell’“Asse” italotedesco si ritiravano. A margine, ri‑cordo come lo zio Armando mi raccontava che, at‑torno il fiume Liri (dove aveva creato una forza diinterposizione di tre persone…), dovette andare pe‑ricolosamente incontro agli Americani per dire:“basta! Venite! non c’è più nessuno”.
Anche a Cosenza e nelle vicinanze vi furono al‑meno due “leggeri” bombardamenti: bersagli prin‑cipali erano le ferrovie. Siamo nel settembre del ‘43,essendo gli angloamericani passati a Reggio Cala‑bria all’inizio del mese. Una delle due volte miopadre si trovava proprio in stazione per le sue mis‑sioni frequenti nei paesi circostanti, ma non la cen‑trarono.
Nel periodo più rischioso anche i cosentini sfol‑larono dalla città. Noi ci trasferimmo in un paesinodi campagna, Cerisano, a 10 km. da Cosenza. A Ce‑risano vi erano tante altre coppie giovani sfollate,sicché a stare tutti insieme ci si divertiva anche:“Paure e risate” così descriveva mia madre la nostravita a Cerisano.
In effetti, mio fratello, poco più grande di me, ri‑corda che una mattina a Cerisano stesso improvvi‑samente comparve un tedesco in moto. Ci fu unagrande apprensione, pensandosi che ne precedessealtri, ma era solo e sperduto e chiese soltanto la viaper Napoli.
Da Cerisano Peppino P. raggiungeva la città apiedi per andare in prefettura, dove il prefetto era
37
rimasto al suo posto. La città era vuota. “Chi nonl’ha provato” – diceva mio padre – “non può mai ca‑pire il sentimento di angoscia e di paura che tiprende nel camminare in una città vuota”. Cammi‑nava rasentando le mure delle case e spiava dagli an‑goli ogni volta che incrociava una strada (unracconto che, per la verità, ho sentito fare anche daaltri). Una volta, ricordava mia madre, il pericolovenne però nel percorso di campagna; Peppino av‑vertì da lontano una pattuglia motorizzata di tede‑schi in ritirata; la scampò riparando fra le siepi.Poiché mio padre non era un amante di libri o di filmd’avventura gli si poteva ben credere. Non era, d’al‑tra parte, una figura che si adattasse a tali immagini.
Probabilmente in quelle “passeggiate” mio padre,oltre ai gonfiori alla gambe, rischiò, nel caso peg‑giore, la deportazione in Germania, in quello mi‑nore, qualche rapina (ma aveva ben poco addosso,per quanto a quei tempi anche un orologio potevafar gola). “Vostro padre ha sempre dovuto salvarel’Italia” faceva mia madre. Ma erano tempi anche dipiccoli eroi, eroi per forza, di chi soltanto voleva fareil proprio dovere.
Il commissario di polizia
E, in effetti, anche in Calabria non mancaronodegli sviluppi drammatici, sia pure isolati. Miopadre aveva ritrovato a Cosenza un suo vecchiocompagno di scuola, commissario di polizia; ungiorno era andato a fargli visita, prima della guerra,con mia madre e mio fratello, Egidio. Egidio, come
38
sempre tumultuoso, trafficava con una raffinatatazza di tè finché questa gli cadde e si ruppe. Miopadre imbarazzato non trovò di meglio che dire:“Uh ! S’è rotta!”. E quello implacabile: “E allora un serumpeva…”.
Mio padre, dopo che ne ridemmo, quando glichiesi che ne fu del suo amico, si intristì e prese a ri‑cordare con raccapriccio qualcosa che sembravaavesse voluto rimuovere: quel commissario, strap‑pato violentemente alla sua vita, ai suoi cari e allesue belle tazze da tè, finì fucilato nel ‘43 dai tedeschi.
Il prefetto fascista
Peppino P. andava da Cerisano a Cosenza per as‑sistere il prefetto fascista e tutt’e due, fra l’altro, an‑davano a portare viveri a delle famiglie della cittàvecchia che, durante un bombardamento, si eranorifugiate sotto il grande ponte di San Francesco sulCrati e non volevano più venirne fuori (certo stavanoalmeno più larghe che in certe case di una solastanza dove dormivano in sette o otto persone): sfol‑lati così a modo loro. Mio padre stimava molto quelprefetto dalla grande dedizione: era Enrico Endrich,un sardo (la patria del nonno) che era un noto intel‑lettuale fascista avendo scritto libri negli anni ’30 suldiritto al lavoro e su partiti, sindacati, corporazioni;inoltre era un collezionista e critico d’arte. Rimasepoi noto in città per quella sua azione, mi disse miamadre, come “il prefetto che portava il pane”. Trovaiconfermata questa definizione da un necrologico diun giornale locale degli anni ’60, che alla morte del
39
vecchio prefetto ne ricordava la figura: “Cosenzanon dimentica il prefetto che portava il pane”. Lasua uscita di scena per la verità era stata meno ri‑guardosa. Alla caduta del fascismo la prefettura fupresa d’assalto e qualcuno sbatté al prefetto un qua‑dro (forse uno della sua collezione) in testa, fra l’inu‑tile difesa indignata di mio padre.
Endrich si sarebbe poi iscritto al MSI e fu elettodeputato, ma della sua dirittura morale è indice unanotizia che mi segnala mio fratello dal quotidiano“Italia oggi “del 12 agosto 2011, in piena polemicain Italia sui costi spropositati della politica: “Sarà ap‑pena il caso di ricordare un esempio rimasto unico.Il deputato Enrico Endrich si dimise, nel 1955,quando fu introdotto l’assegno vitalizio per prote‑stare contro “il principio della professionalità dellafunzione parlamentare”. E nel 2007 la figlia del de‑funto parlamentare sottolineava che i familiari re‑spinsero sia gli arretrati della pensione e rifiutaronola reversibilità” .
Gli indiani a Cosenza
Quando gli alleati passarono dal Cosentino, nelsettembre del ’43, mio padre ebbe un incarico alquale veniva attribuita la più grande importanza.V’era un reparto di indiani fra i soldati statunitensi.Mio padre fu dunque incaricato di “procurare i bo‑vini agli indiani”. Peppino P. ricordava questo casoper mostrare la stranezza della sorte e l’imprevedi‑bilità della vita e il sovvertimento dei tempi. “Chi mi
40
avrebbe mai potuto dire che io un giorno avrei do‑vuto procurare i bovini agli indiani!”.
Il grano
Durante la guerra e dopo, la fame era di casa. Inun paese della pre‑Sila dove era stato mandato comeCommissario prefettizio, con pieni poteri, mio padredovette, fra l’altro, sorvegliare e gestire un fitto ap‑provvigionamento di grano destinato alle truppe al‑leate. Il grano era accortamente custodito e parevacome se fosse oro, diceva mio padre che ben cono‑sceva l’indigenza per ogni dove nella Calabria. Unaltro responsabile, non se collega o dei vertici delpaese, frivolamente come per scherzare, gli proposedi prendersi insieme un po’ di quel grano: dopotuttosarebbe stato per le proprie famiglie. Mio padre ri‑mase esterefatto: “Io mettere mano a quel grano? Maio non osavo neppure guardarlo”. “E che credi ? Ciringrazieranno?” – premeva quello diventando serio– “diranno di noi soltanto: ma che fessi!”. Questaideologia acquisitiva illegale e furbesca, autogiusti‑ficativa, evidentemente cominciava a porre le suebasi per tempo.
Rischiò grosso invece mio padre per tutt’altro: di‑spose che buona parte di quel grano venisse distri‑buito proprio alla popolazione affamata. IlComando militare alleato lo accusò di tradimento(ciò che comportava la fucilazione) e mancò pocoche non prendesse provvedimenti molto seri, nonfosse stato per il rumoreggiare della folla. Il Co‑mando preferì il quieto vivere con i locali.
41
La caduta del fascismo
Della caduta del fascismo Peppino P. ricordava es‑senzialmente un momento semplice di vera gioia:quella di andare a comprare i giornali; una sensa‑zione indefinibile. “Chi non l’ha provato non lo puòcapire”, ripeteva mio padre. “Andare in edicola e ve‑dere esposti tanti diversi giornali che esprimevanotitoli diversi e contrapposti: il pluralismo. Era respi‑rare; era come recuperare una propria consistenza,una propria dignità”.
“L’uomo qualunque”
Naturalmente in questo quadro delle edicolenon poteva non suscitare la curiosità di mio padrela prosa dissacrante del periodico degli “stufi ditutto”, che cominciò ad uscire a Roma, con clamo‑roso successo, dalla fine del ‘44, “L’uomo qualun‑que”, di Guglielmo Giannini un brillanteliberale‑anarcoide. Essenzialmente anticomunista,Giannini finì, pure, con attirare attorno a sé no‑stalgici del fascio, che evidentemente gli erano, inrealtà, molto lontani. Dal periodico nacque addi‑rittura un movimento politico, rappresentato nel‑l’assemblea costituente del ’46, ma che, osteggiatoanche dai “moderati”, si andò esaurendo nel ’48.Mio padre dunque quando acquistava però il pe‑riodico, ricorda mio fratello Egidio allora 12/13‑enne e che leggeva di tutto, lo riponeva ben in altosui mobili o glielo nascondeva, perché lui non loleggesse.
42
Il prefetto socialista
Gli angloamericani, spinti anche dai moti popo‑lari promossi dagli antifascisti (che ora aumenta‑vano a dismisura…), destituirono dunque il prefettofascista e posero al suo posto un socialista: Mancinipadre (più famoso, ma più avventurista il figlio Gia‑como, che fu poi segretario del partito socialista):una persona che mio padre stimava molto. Miopadre ricordava con bonomia, e anche con una certasimpatia, come nel periodo della reggenza Mancinil’austero ed esclusivo ufficio del prefetto fosse di‑ventato, diceva, ritrovo anche di vagabondi, se nondecisamente piccoli delinquenti comuni della città edei paesi vicini, schedati dalla questura e conosciuticome tali anche dalla prefettura. Ma persone co‑munque della più varie provenienza, democratici eopportunisti, persone impegnate, faccendieri e sfac‑cendati, uomini di buona volontà affollavano quellastanza che era sempre piena di gente vociante, nelpiù grande caos. Quando faceva freddo, nella con‑fusione, di soppiatto, Peppino P. entrava nella saladel prefetto (l’unica riscaldata), senza bussare esenza essere notato, andava a scaldarsi un po’ vicinoal grande camino acceso e poi se andava così comeera entrato e tornava al suo posto per un lavoro,ormai moltiplicatosi. Prima e dopo, mentre i regimipassavano e le atmosfere mutavano, continuavanoalcuni burocrati ad essere col loro costante lavoropunti di riferimento sicuri e stabili della vita ammi‑nistrativa del paese. Anche su questi uomini forse,anche se meno riconosciuti, si sarebbe costruita la ri‑presa.
43
La prefettura centro politico
Era però una fase estremamente delicata e di coin‑volgimento politico per la prefettura, perché in tuttala regione i sindaci fascisti al potere erano spodestatie la prefettura doveva intervenire spesso nominandoCommissari, naturalmente per lo più del postostesso. Il prefetto Mancini pare seppe gestire la cosacon abilità, scegliendo come Commissari personemoderate. Certamente non ci fu da noi niente di pa‑ragonabile agli scontri del Nord. Ma la transizionedemocratica avveniva non del tutto senza sommosseo disordini. Nei racconti di mia madre, mio padrevenne inviato spesso in vari paesini i subbuglio, manon so se gli episodi annotati si riferiscono a questoperiodo 43/44 o al successivo difficile dopoguerra.Ne parlerò appresso perché certo i problemi conti‑nuarono a lungo, intrecciati naturalmente con le dif‑ficoltà economiche e le rivendicazioni sociali.
La commissione epuratrice
Costituitasi anche a Cosenza una sezione del Co‑mitato di Liberazione Nazionale, Peppino P. fu chia‑mato a far parte di una commissione che aveval’incarico di indagare sull’attività fascista di funzio‑nari o, comunque, di uomini pubblici per i provve‑dimenti punitivi del caso. Mio padre si rendevaconto del grado di vacuità, ipocrisia, forse anchescarsa legittimazione di un’operazione del genere.Persone che fino a poco tempo prima avevano do‑vuto dichiarare, volenti o nolenti, fedeltà al Duce ora
44
dovevano formare una commissione che denun‑ziasse i seguaci del Duce. A meno che non ci si vo‑lesse divertire a vendicarsi di qualche piccolo bulloo sbruffone locale del regime, ma ne valeva la pena?Così mio padre, in generale, salvo particolarissimicasi isolati di gerarchi effettivamente accanitisi con‑tro sporadici oppositori antifascisti, era, e lo disse,per una sanatoria. “Ma allora che cosa siamo staticonvocati a fare?” osservò un commissario. “Niente”rispose semplicemente mio padre “siamo stati con‑vocati per non fare niente!”.
Per un personaggio, per la verità, le cose eranoserie e le accuse si addensavano. Peppino P., chepure non ne conosceva in realtà le varie attività,prese a tentarne una difesa appassionata, a spingersiarditamente ad assicurarne le qualità morali. I col‑leghi commissari si meravigliarono molto per lastima di mio padre, che non era di solito tenero neisuoi giudizi etici, per quell’uomo e cercavano dimetterlo sull’avviso: alla fine Peppino P. dovette ar‑rendersi di fronte alla documentazione delle male‑fatte. Ma quale era stato il motivo che lo avevaindotto a difendere tanto il reprobo ? In effetti lui loconosceva solo da contatti estivi, ma gli sembravache bastassero. Era un farmacista di Fuscaldo ched’estate sulla spiaggia, per quel poco che mio padresi concedeva di vacanze, gli leggeva le sue poesie(una delle principali attività sussidiarie di miopadre: ascoltare o leggere le composizioni poeticheche gli venivano portate). A Peppino P. alcune pia‑cevano molto. Me ne citava una che cominciava condei versi che ricordava ancora con l’aria rapita e gli
45
occhi rossi: “Sono partite le rondini stamane ! Sonopartite. E quanta pena in cielo!”.
Il referendum
Finita la guerra, al momento del referendum Pep‑pino P. votò per la monarchia. Me ne parlò solo negliultimi anni, come per togliersi un peso, fustigandosicon l’acredine con cui usava fustigare anche sé comegli altri quando si indignava. “Ignorante, retro‑gado!”. E a me che, superata la prima sorpresa, cer‑cavo scolasticamente di confortarlo: “Non possiamogiudicare con i nostri occhi di adesso; dobbiamo ri‑farci alle condizione del tempo”, ribatteva veemente:“E finiscila tu col tuo voler sempre giustificare tuttoe tutti, ero un imbecille… oihmé… «il salto nelbuio»”. E ripeteva lo slogan che aveva avuto tantoeffetto su alcuni “tradizionalisti”.
Non ho pensato di tacere su questo episodio dellavita di mio padre perché bisogna prendere atto diquesta piccola testimonianza. Una persona colta, digrande rettitudine e sensibilità umana, di originesardo/napoletana, funzionario di prefettura a Co‑senza votò per la monarchia (come, del resto, noto‑riamente, la maggioranza del 67,4% al Sud, su unamedia nazionale del 45,7%). Era una generazionemeridionale (specie di ambiente napoletano) edu‑cata a scuole essenzialmente patriottarde e dai cuischemi mentali, dal cui immaginario la monarchiacome emblema della nazione e dello Stato non facil‑mente poteva essere eliminata (immagino il re per ilnonno sardo!). D’altra parte, i funzionari dello Stato
46
avevano giurato fedeltà alla monarchia. La loro ca‑ratteristica è, direi, costituzionalmente conservatricedal punto di vista istituzionale, essendo organici alloStato vigente.
Quando si seppe della vittoria della repubblica,non so il prefetto Robles, ma mio padre con qualchealtro funzionario vagarono perplessi e preoccupatinel lussuoso palazzo della prefettura di Cosenza, di‑venuto d’improvviso troppo grande, e meditavanosu come far fronte a quello che ora sarebbe potutoaccadere. “Il salto nel buio” era stato fatto.
“Quei buffoni, pagliacci, jaquielli (gente daniente, in napoletano), ed io che voto per loro! Chececità! E tu stai zitto; col tuo sempre giustificare tuttoe tutti; non voglio sentire le tue argomentazioni”. Invecchiaia mio padre era diventato quanto mai inte‑gerrimo, ma mi dispiaceva quando vedevo che que‑sto lo portava a volte ad essere sconfortato anche suse stesso per qualcosa. Mi sembrava ingiusto.
Le elezioni del ’48
Nelle elezioni del ‘48 con la grande vittoria dellaD.C., quasi tutti i candidati presentati da quel partitofurono eletti. “Furono eletti cani e porci…” chiosavaimpietosamente mio padre. Era stato fatto presen‑tare per il senato anche un nobilotto locale, contan‑dosi sul suo nome conosciuto: un uomo buono, mamodesto che non si era mai interessato di politica odi problemi amministrativi o sociali, né aveva com‑petenza in nulla; naturalmente fu eletto. Dopo l’ele‑zione si pavoneggiava tutto dandosi l’aria di uomo
47
di Stato, ricordava sarcastico mio padre, ed andavadicendo tutto impettito: “E pensare che io mi erosempre sottovalutato…”.
Il difficile dopoguerra
La ripresa dopo la guerra, come si sa, fu dura perle gravi tensioni sociali che, non essendoci gli statutiregionali, si riversavano tutte sulle prefetture, le rap‑presentanze dello Stato e, nello stesso tempo, consi‑derate anche rappresentanze del governo, unadicotomia irrisolta. Furono anni straordinari in cuila capillare struttura amministrativa della burocra‑zia statale resse, di fatto, il paese, dimostrandosi perlo più all’altezza della difficile situazione. Fu peròun breve periodo: una sorta di suo canto del cigno.Presto l’invadenza politica sarebbe diventata dinuovo intrusiva, certo in maniera ben diversa dal‑l’età precedente, ma molesta.
Socialmente erano gli anni dell’occupazionedelle terre nel Mezzogiorno. Siamo prima della ri‑forma agraria del ‘50/51. In una società basata quasiessenzialmente sulla grande proprietà rurale esten‑siva e su contadini per lo più non proprietari, ma ditipi affittuario o colonico o su pastori subordinati,con una manovalanza, date altre scarse attività,spesso disoccupata, fra impoveriti e reduci dguerra; il malessere esplodeva ed il partito comu‑nista, con parte dei socialisti, dava organicità allerivolte che avevano già di per sé un moto sponta‑neo dal basso, giocando in questa lotta una impor‑tante carta politica: puntava così ad unire i
48
lavoratori della terra con gli altri lavoratori e ag‑ganciare strati di ceti medi. In attesa della riformae della sua attuazione la situazione era complessaper un amministratore statale/(governativo), pre‑fetti e questori, che si trovavano nel mezzo delloscontro sociale e politico, nonostante che vi fossegià un corposo intervento centrale nel ‘47 con lalegge per la valorizzazione della Sila, che nel tempoavrebbe fatto molto per quella regione. Da unaparte dunque i bisogni reali di ceti diseredati, dal‑l’altro il rispetto della legalità e dell’ordine pub‑blico. Era difficile, in effetti, sottrarsi alla polemicapolitica più strumentale e demagogica contro i fun‑zionari dello Stato; mio padre ne fu vittima peropera del socialista Mancini figlio (per quanto inbuona armonia era stato con il padre), che lo at‑taccò duramente su pretesi irrigidimenti legalitaridella prefettura, con una interrogazione parlamen‑tare, in modo “da far male”: per fortuna Peppino P.trovò molti difensori anche dalla parte politica delMancini, socialisti e anche comunisti come il leaderGullo, che premettevano il rispetto della personaalla strumentalizzazione politica, ma mio padrenon gliel’avrebbe mai più perdonato, per quanto ilMancini nel seguito degli anni ebbe verso di lui poitoni distesi e più rispettosi.
Bisognava comunque dare alle popolazioni,spesso esasperate per la mancanza di lavoro, unsenso nuovo della pubblica amministrazione e dellasua presenza. Mio padre aveva il suo da fare a giraresotto e sopra per il Cosentino, dalla Sila al mare, dalTirreno allo Jonio, raggiungendo paesi anche a
49
dorso di mulo. A volte era chiamato d’improvvisoperché in qualche paese era scoppiata una “rivolu‑zione”: mia madre ricordava il rumore dei passi delmarito di ancora notte sul selciato della strada, che siallontanavano. Come ricordavo sopra, alcune diqueste escursioni si riferiranno al periodo ‘43/44. Dialcune visite, comunque, mio padre conservava al‑cune medagliette ricordo delle amministrazioni co‑munali (certamente non c’erano certo nelleprefetture rimborsi di missioni…).
Una volta in una riunione tumultuosa di un paesesi presentarono un gruppo di cittadini particolar‑mente eccitati. Ad un certo punto un esagitato tiròfuori una bomba a mano, qualche residuato bellico,suscitando il panico e un fuggi fuggi tutt’intorno; unufficiale dei carabinieri aveva già messo mano allapistola. Mio padre calmò tutti; si avvicinò all’indivi‑duo ed, in perfetto stile di film americano (ancorauna volta doveva fare l’eroe per forza), si fece con‑segnare la bomba. Non era solo coraggio (magariquello della disperazione). Mio padre conosceva lasua gente; sapeva che quell’uomo la bomba nonl’avrebbe mai gettata: cercava solo chi gliela togliessedi mano. Certo la validità di questa interpretazionesi poteva avere solo a fatti avvenuti: qualche bic‑chiere di vino in più.
Dovunque Peppino P. incontrava situazioni diffi‑cili, ma una bella mangiata di capretto con buonvino rosso i Comuni di solito trovavano modo dinon fargliela mancare: per i calabresi l’ospitalità èsempre in prima fila e, a riguardo, le risorse della pa‑storizia, pur modeste, soccorrevano.
50
Ma spesso i tumulti avvenivano in città e l’ob‑biettivo era sempre la prefettura. Mio padre, capo digabinetto del prefetto, fu proprio l’anima della pre‑fettura di Cosenza. La sua conoscenza capillare dellasocietà cosentina, la sua apertura culturale, la sua di‑sponibilità disinteressata creavano attorno a luiun’atmosfera di rispetto trasversale e gli davano lapossibilità di essere in buoni rapporti, di dialogo sidirebbe oggi, anche con alcuni veementi capipopolo.Una volta la folla, per gran parte lavoratori dellaterra scesa dai Casali vicini e disoccupati, si accalcòin piazza della prefettura attorno al palazzo parti‑colarmente ammassata ed esagitata e prese a pre‑mere pesantemente contro il portone, avendo fattosaltare ormai e il servizio d’ordine della manifesta‑zione, e il cordone di protezione della polizia. Il pre‑fetto, un nobile napoletano si affidava a mio padre.“E mo’ ca avimma fa ? Gesù. Gesù, Gesù, guardeloco!”. Mio padre ebbe una risorsa. Scese giù; con‑
51
Doni di Natale a Cosenza nel dopoguerra.
trattò un po’ con i sindacalisti e capipopolo sfusi,quindi fece entrare nella prefettura uno dei capi checonosceva, lo fece salire e parlare dalla finestra cen‑trale della prefettura: “Compagni! La prefettura ènelle nostre mani. Ora metteremo alle strette il pre‑fetto”. Così, con grande entusiasmo di tutti, anchese alla fine probabilmente purtroppo con pochifrutti, furono almeno evitati incidenti seri, mentre ilGoverno venne almeno allertato della situazioni gra‑vissima nel cosentino. La “Legge Sila”, sopra ricor‑data, e poi adattata la riforma agraria con l’espropriodei latifondi nacque anche da giorni come quelli.
Il prefetto, barone napoletano
Ma non solo drammi. In questo periodo di fortitensioni sociali era prefetto di Cosenza questo ba‑rone napoletano, D. S., personaggio, secondo miopadre di comicità rara, sotto il quale Peppino P. sifece le sue migliori risate. Ricordo purtroppo solopochi episodi. La moglie Rosellina era corteggiatada un caro amico di mio padre, Minervini, musico‑logo e custode della musica popolare calabrese. Unavolta questo le scrisse una lettera, certo non com‑promettente. Il prefetto ne parlò poi con mio padrea modo suo: “Ma comme! quillo scrive na lettera aRosellina e indirizza: Signora Rosellina D. S.? E vo’mettere «Baronessa»?”.
Qualche sera, dopo il lavoro, il prefetto voleva chePeppino P. andasse con lui a cinema. Per mio padreera abituale andare a cinema ed andarsene dopo unquarto d’ora se il film non gli piaceva: ciò che acca‑
52
deva quasi sempre. Era una sofferenza per lui re‑stare tutto il tempo. Al prefetto naturalmente andavabene tutto e partecipava a tutte le vicende sulloschermo commentando a voce alta. “Uvì loco! Gesù,Gesù! Mo’ vidi che arriv’isso” (l’amante, lo sceriffobuono…).
Il questore
Diversamente simpatico invece il questore, purenapoletano (questa burocrazia meridionale deltempo!), che poiché non sopportava le lunghe ceri‑monie religiose, quando si doveva assistere a qual‑che Messa, ad un certo punto si faceva chiamare daun agente trafelato che gli sussurrava qualcosa nel‑l’orecchio, al che lui saltava sulla sedia e con un “Matu che dici? Overamente?” e l’immancabile “Gesù,Gesù…”, se ne scappava e raggiungeva infine vero‑similmente qualche caffè appartato.
La politica
In queste piccole storie non si parlerà dellagrande politica: degli interventi statali nel Mezzo‑giorno; del filtro delle prefetture; dei dibattiti edelle lotte. Non c’erano del resto localmente grandipersonalità che si imponessero. Certo Peppino P.aveva da funzionario sulle questioni sociali l’ideaabbastanza utopica che lo Stato avrebbe dovuto ri‑solverle da sé senza subire le pressioni della piazza,ma evidentemente pensava ad uno Stato etico che
53
non esiste. Molto stretta e funzionale era comun‑que la collaborazione con il Comune: intorno aglianni ‘50 era sindaco un suo carissimo e stimatoamico, Arnaldo Clausi Schettini, chirurgo rino‑mato, mentre anche con il questore la collabora‑zione, ricordo anche dalla loro familiarietà, eracontinua ed efficace. Al barone napoletano successeintanto nel ‘48 il prefetto Marfisa, una persona diprim’ordine, senza famiglia, tutto dedito all’ufficioche avrebbe avuto poi un ulteriore brillantissimacarriera: con mio padre facevano proprio una bellacoppia; stavano sempre là. Un solo difetto: fumavacontinuamente: qualcosa che lo portò ad una morteprecoce.
Quanto alle posizioni politiche di massima, unburocrate di prefettura, specialmente in quegli anni,in un sistema politico di fatto bloccato, difficilmentepoteva evitare di essere “governativo”, essendo as‑
54
In prefettura a Cosenza nel 1958 col prefetto Marfisa al centro e il sin‑daco Clausi Schettini alla sua destra.
sunte e spesso ponendosi di fatto, in mancanza del‑l’istituto regionale, in definitiva, le prefetture comerappresentanti del governo centrale sul posto. Nondovrebbe certo essere così, ma per quel fenomenocui abbiamo accennato, nelle prefetture finivano perconfondersi lo Stato e il governo. Il ministro degli in‑terni in carica, del resto, era una sorta di diretto su‑periore del prefetto e quindi dei suoi dipendenti: silavorava insieme perché la macchina dello Stato fun‑zionasse, dunque perché le cose andassero nel mi‑gliore dei modi. Non è un mistero del resto che lafortuna della carriera agli alti livelli dipendeva dalMinistero degli Interni. La sorte dunque di un mini‑stro degli Interni poteva così essere legata a quelladei funzionari e viceversa. Mancando gli statuti re‑gionali, la prefettura, si dai tempi di Giolitti, venivain pieno responsabilizzata nel campo politico: cosìle elezioni potevano diventare un segnale se sei proo contro le prefetture. Così, se il partito, la coali‑zione, al governo aveva successo in una città, man‑cando appunto ancora gli Enti regionali, voleva direanche che la prefettura, la squadra, con la questura,del ministro degli interni, per parte sua aveva ope‑rato bene: che i cittadini erano contenti della pub‑blica amministrazione. Se c’era una sonora sconfitta,si poteva aver diritto anche di pensare che gli am‑ministratori statali locali, i funzionari prefettizi perprimi, erano stati dei buoni a nulla. Per questo sen‑tii dire a mio padre, a torto o a ragione, una volta elo registro, quando aveva vinto la coalizione al go‑verno, che le elezioni “erano andate bene”. D’altraparte, in modo corrispondente, l’opposizione, il par‑tito comunista e, in parte quello socialista, attacca‑
55
vano sconsideratamente, in linea di principio e indi‑scriminatamente, i funzionari dello Stato, non solocome “governativi”, ma avvicinandoli ai “padroni”(peraltro su vecchie basi teoriche) e premendo sullascissione sociale: atteggiamento di rottura che fu frale cause probabilmente dei loro insuccessi. Comun‑que ora si riconosce tutti che la scelta democristianain quegli anni era quella meno traumatica per il
56
A Bari. Giornata del decorato nel ‘62.
paese, considerati anche i blocchi di alleanze inter‑nazionali (le sinistre in Italia allora erano contrari alPatto atlantico del 1949), mentre un forte partito co‑munista (che certo sarebbe stato meglio se fosse statopiù “diverso” già da allora, ma non lo era; certo nona Cosenza) dall’opposizione ebbe comunque il me‑rito di aver ampliato gli spazi della democrazia espinto lentamente tutto il quadro politico a sinistra.
Per il resto Peppino P., in effetti, si può dire chefosse in un certo senso “anticomunista”, ma ap‑punto dei comunisti di fine anni ’40, inizi ‘50 (lo po‑trei forse definire, supponendo che avrei un suosorriso per questo: un borbone, come diceva ironi‑camente un suo amico burocrate, e lui me lo dicevaridendo, ma liberale e, per di più, cattolico demo‑cratico). Non era “anticomunista” perché difen‑desse la proprietà privata, la logica assoluta delmercato, la confindustria, o anche fosse contro lostatalismo. Né credeva che Togliatti avrebbe tolto lalibertà in Italia. Il suo anticomunismo non era poli‑tico, ma esistenziale. Non sopportava l’ostentatoateismo (meno ancora l’ateismo militante di Statodell’URSS) e le concezioni per lo più rozzamente“materialiste” dei comunisti di allora, specie natu‑ralmente in ambiente provinciale, dove era più ar‑retrato e d’accatto, una certa chiusura mentale chequeste spesso comportavano, se intese volgarmente:una teoria che era posta comunque, non dimenti‑chiamo, come presupposto della prassi. Erano glianni in cui mio padre vide allibito un deputato co‑munista rifiutarsi di entrare in chiesa il giorno delmatrimonio della figlia e non poteva passarci sopra.
57
Ammirava però i comunisti in genere per la loro se‑rietà, la loro affidabilità e ne riconosceva natural‑mente lo stimolo essenziale verso le politichesociali, anche se, a volte, ne prendeva anche in girouna certa abituale cupezza, il sopracciglio semprecorrucciato anche caratteristica dei comunisti diquegli anni. Osservava: i comunisti non sanno sor‑ridere. In una commissione a volte cercò invano distrappare qualche sorriso al rappresentante comu‑nista, che proseguiva invece a restare sempre serioe preoccupato (inquadratamente “vigile”). Alla finePeppino P., ad un ennesimo stimolo di humour nonraccolto, suscitando qualche meraviglia negliastanti, gli sbottò con l’espressione che Greta Garboin un famoso film rivolgeva appunto ad un diri‑gente sovietico: “E ridi!”.
La società
Il rapporto con la gente, specie umile, era per ilresto vissuto quotidianamente da Peppino P. nellapratica. Furono molti i paesi e le persone da lui be‑neficate in quegli anni, certo nel corso del suo do‑vere, ma con cura e determinazione. Quelle personeci riempivano poi la casa a Natale e Pasqua di coscedi capretti, salami (sopressate fatte in casa), provo‑loni, fichi secchi (a crocette col miele o in palloni, ifichi ristretti in una palla tenuta da foglie), prodottidei loro campicelli. Mio padre a volte lasciava di‑sposizione tassative a non ricevere regali da qual‑che persona, ma i più, cose modeste, si prendevano:per un calabrese sarebbe stata l’offesa più grande ri‑
59
fiutare un suo dono. Nelle feste di Natale poi ci ve‑niva organizzata dal popolino del quartiere, gui‑dato da qualche “cliente”, davanti alla porta di casacon tutta un’orchestrina, la “strina”, la strenna, unasorta di cantilena di auguri ai singoli componentidella famiglia, che si concludeva poi con un ricevi‑mento in casa nostra di tutti partecipanti al “con‑certino” con dolcetti e bicchierini di liquore:qualcosa che alla fine la “strina” stessa evocava(“sientu lu struscio di la scala a pennino, di la scalaa pennino e la padrona ca porta li bicchierini e la pa‑drona ca porta li bicchierini”). Il testo era cantatodal più famoso vagabondo de “Lo Spirito Santo”, ilnostro quartiere, adiacente a Cosenza vecchia, Ri‑zieri, che aveva una voce armoniosa. Di solito, per ilresto, questo eterno ragazzo in età faceva il rivolu‑zionario e, ricordo, indicava a me bambino unavolta con la mano dalla villa, dove soggiornavaquasi sempre, tutti i possessi di un famoso nobilottocosentino, che andavano da una collina ad altre col‑line (allora la ricchezza, almeno in Calabria, l’ho ac‑cennato, si misurava ancora con l’estensione dellaterra) e mi illustrava i suoi piani di occupazione diquelle tenute; in realtà però poi stava sempre lì cion‑dolone e si lasciava andare a cantare a richiesta “Laluna rossa” perché nessuno come lui sapeva imitarenei ghirigori finali del “ca’ nun ci sta nisciuno”l’ugola di Claudio Villa.
Sapemmo poi a Bari che era morto improvvisa‑mente, a cinquant’anni, a Trieste dove faceva il po‑liziotto!, questo eterno ragazzo eversivo e canterinoche nessuno aveva insegnato a crescere e che sottoNatale veniva a cantare la “strina” alla famiglia del
60
capo di gabinetto del prefetto aspettando i “bic‑chierini”.
L’usciere e il gioco del lotto
Una volta Peppino P. trovò modo di esercitare inufficio la sua vena etica e beffeggiatrice insieme. Unusciere della prefettura teneva affidata una certasomma di danaro per le piccole spese. Ad un certopunto si notò che si accumulavano consistenti am‑manchi. Fu facile risalire alla causa. L’usciere queisoldi se li giocava al lotto. Né la fortuna, evidente‑mente, era dalla sua; sicché i soldi non tornavano incassa come avrebbe voluto. Mio padre non pensònaturalmente di denunziare il povero uomo o diprocuragli comunque guai che potessero mettere arischio il suo posto o costargli quello che nonavrebbe potuto dare. Decise però che una lezione civoleva. Istituì allora in prefettura un finto tribunale,dove tenere un processo con tanto di corte, mentrel’usciere era convocato in veste di imputato. Si pre‑parò la scena. L’imputato fu fatto entrare. “Entra lacorte!” – tuonò d’improvviso una voce. Si presenta‑rono compunti mio padre, con tunica scura, in vestedi Presidente ed alcuni altri funzionari; l’imputatosi alzò con un inchino. Il Presidente sbattè rumoro‑samente sul tavolo davanti al reo un volumone, cheavevamo a casa, con su scritto a caratteri cubitali“ITALICA LEX”, che si era portato appositamentenonostante pesasse un quintale. Furono esposti icapi di accusa. “Sono innocente” dichiarò in lacrimel’imputato. L’avvocato d’ufficio, che gli era stato be‑
61
62
nevolmente assegnato, si appellò alla clemenza dellacorte. Alla fine il reo fu condannato ad una multacon la condizionale (ma naturalmente non gli furonoaffidati più soldi), nonché giuramento solenne sullaBibbia (portata da casa…) che non avrebbe più gio‑cato al lotto. Ma quel processo, c’è da giurarci, saràstato un formidabile spunto per la “smorfia napole‑tana” che dà i numeri da giocare.
Le illegalità
Peppino P. “vantava” invece spesso le “illegalità”che aveva compiuto durante la sua carriera in tantepiccole battaglie. Per quanto fosse concettualmentestatalista (dello Stato etico), i suo spirito intima‑mente liberale, ripudiava un’amministrazione buro‑cratica puramente formalistica che arrivasse amettere da parte elementi di comune umanità, digiustizia sostanziale o di semplice buon senso,quella che i giuristi romani chiamavano aequitas, aldi là del ius civile.
Una volta presiedeva una commissione che do‑veva assegnare delle case popolari. La commissionedopo varie riunioni, esami di carteggi e sopralluo‑ghi, terminò i suoi lavori ed assegnò gli apparta‑menti nel modo che gli parve più equo. I lavorifurono dunque dichiarati chiusi; i verbali completatie firmati e la commissione sciolta. A questo puntoPeppino P. ricevette la visita di una donna che gli il‑lustrò la situazione della sua famiglia. Mio padrenon mancò di sincerarsi ancora della cosa; operò unsopralluogo da solo nel tugurio dove abitava quella
donna; tutto vero: disoccupazione, malattie serie,casa dove pioveva dentro, servizi igienici pratica‑mente inesistenti. Peppino P. riconvocò la commis‑sione e presentò la situazione dicendo che bisognavaassolutamente assegnare un appartamento a quelladonna. I commissari strabuzzarono gli occhi: i ver‑bali erano chiusi, con data e firme. Ma niente da fare.Mio padre per quanto era tenero e duttile in variecircostanze, in altre era irremovibile. “Mi assumo iotutte le responsabilità!”, esclamava, sapendo ancheche era una fictio. In conclusione, si impose: fu an‑nullato il verbale e rifatto tutto e la famiglia delladonna ebbe la sua casetta.
Un’altra volta Peppino P. dovette vedersela conun “vincitore di concorsi” professionista. Que‑st’uomo, molto preparato, si presentava ai concorsiper medici condotti e, siccome era bravo ed esperto,li vinceva. Quindi rinunziava a favore del secondoclassificato facendosi pagare. Mio padre era man‑dato e presiedere spesso tali tipo di concorsi. Non losopportò. Un giorno convocò nel suo ufficio questopersonaggio, che si presentava all’ennesimo con‑corso, e gli intimò di ritirare la sua domanda e nonpresentarsi più ad alcun concorso. L’uomo, nonsprovveduto, rispose che partecipare ai concorsi eraun suo diritto; così poi decidere del suo futuro; cheun funzionario non avrebbe mai dovuto fargli unaproposta del genere; poiché mio padre insisteva, ar‑rivò al punto di minacciare di denunziarlo per abusod’ufficio e quant’altro. Peppino P. pensò fosse venutoil momento di rischiare: “Faccia pure” – disse – “an‑diamo in tribunale”, e avvicinandosi ad un suo cas‑
63
setto della scrivania: “così potrò far vedere le provedei suoi raggiri che ho in questo cassetto”. Per for‑tuna al tribunale non si arrivò. L’uomo se ne andòinveendo e minacciando. Non ritirò la domanda. Maneppure si presentò a quel concorso, né lo si videpiù. Naturalmente in quel cassetto c’erano tutt’altrecose.
Chimenti
Alcune persone di umili condizioni che miopadre aveva aiutato a trovare un lavoro gli restaronofedelissime. Fra queste si distingueva, devotissimo,Umberto Chimenti, un uomo forte e sanguigno,quanto semplice e generoso, reduce della guerra inAfrica, quindi senza arte né parte, già anche capo‑popolo di più manifestazioni sotto la prefettura, di‑soccupato, a cui mio padre aveva procurato un postoal Comune. Mio padre se ne serviva anche come suopersonale “agente speciale” con sua iniziativa pri‑vata, a volte “infiltrato” nelle manifestazioni dipiazza, per raccogliere informazioni o dissuadere di‑sordini (gli piaceva cercare di saperne di più sugliumori popolari; non se altre pubbliche autorità inItalia non abbiano poi effettivamente invece usato“ufficialmente”, su questa semplice e spontanea via,nelle manifestazioni propri uomini, magari, al con‑trario, come agenti provocatori). Quando noi ci tra‑sferimmo a Bari, Chimenti ogni Natale continuò avenirci a trovare con salami e fichi secchi. Una voltaportò un caprettino vivo, con cui noi ragazzini an‑dammo festosi a giocare in villa, ma che lui stesso
64
poi, fra la nostra inefficace esecrazione, sgozzò nellanostra cucina. Si piazzava a casa nostra, dormendoda noi, perché i calabresi sono fatti così (ma luiavrebbe dormito anche a terra). Una volta si pre‑sentò con moglie e l’ultima figlioletta, alla qualeaveva dato il nome di mia madre, Gilda, e dormi‑rono anche da noi. Ricordo che la sua forza, la suadedizione, la sua disponibilità per noi rimasero unconforto per mia madre in un città come Bari, dovenon avremmo mai più creato rapporti di tale tipo,sicché mia madre, quando si sentiva in difficoltà, di‑ceva: “Adesso chiamo Chimenti”. Di fatto lo fece ve‑nire quando mio padre dovette subireun’operazione. Tutti noi non capimmo perché. Cosaavrebbe dovuto fare Chimenti, pur con tutta la suavoglia di fare qualcosa per noi? Ma quell’uomo ge‑neroso le dava evidentemente un senso di prote‑zione, come, mi pareva, se con lui la Calabria stessa,Cosenza, con tutte le amicizie antiche e vere che miamadre aveva lì tante, la giovinezza stessa di miamadre, tornasse con lui e la proteggessero, ci pro‑teggessero tutti. Un Natale Chimenti non venne.Pensammo che forse cominciava anche lui a mol‑lare, ad allontanarsi, dopo tanto tempo del resto eranormale; ma gli facevamo torto: Chimenti eramorto, improvvisamente, con tutta la sua forza, lasua voglia di fare. Per i miei genitori si staccava l’ul‑timo anello residuo, umile ma autentico, con la Ca‑labria e Cosenza, i fichi secchi: si completava la finedi un ciclo.
65
2.A Bari
La città
Nel ‘53 Peppino P. fu promosso viceprefetto vica‑rio e trasferito a Bari.
Bari era una sede gradita naturalmente, ancheperché, vista da Cosenza, la città della Fiera era con‑siderata un punto di riferimento per il Sud, poi c’eral’Università per noi. Nei secondi anni ‘50 tutta l’Ita‑lia si avvicinava agli anni del boom e Bari era un cen‑tro dinamico, di natura specialmente commerciale;presenti, ma di peso minore, varie altre intraprese dicarattere industriale o comunque imprenditoriale(per lo più poggiante, in realtà, su un comodo e si‑curo sfruttamento edilizio); in qualche misura co‑minciava anche un’attività finanziaria (Bancapopolare); buono era il settore professionale, pog‑giante sull’Università, che dava naturalmente red‑dito anche dall’afflusso di studenti e professori, perlo più ancora pendolari. Diversi i rapporti esterniper via appunto della Fiera del Levante, allora inpieno vigore, e, anche per il porto, pur se non atti‑vissimo rispetto a quelli di Brindisi e Taranto; pre‑
67
sto si aggiunse l’aeroporto. Grandi ricchezze si eranoaccumulate e si accumulavano specialmente conl’urbanizzazione delle periferie rurali e della costa eanche, specie qualche anno più in là, della campa‑gna vicina, in particolare nella zona sud dei trulli:uno sviluppo prorompente quanto peraltro scrite‑riato, sia in città che fuori. Le zone di emarginazionepersistenti o che si creavano, d’altra parte, fornivanoterreno di cultura per lo sviluppo di nuclei di delin‑quenza che era però molto lontana ancora da comesi sarebbe incrementata e incrudita dagli anni ‘70. Ipaesi limitrofi erano infine per lo più di grandi e po‑polosi, con ottime comunicazioni, e anch’essi conuna ricchezza che si diffondeva nei ceti medioealti,trasformandosi naturalmente anche in consumi neiricercati negozi baresi. Era un entroterra che certonon conosceva, in generale, sacche di povertà para‑gonabili a quelle degli sperduti paesini presilani delcosentino nel dopoguerra (e non solo per la guerra).
L’ufficio
La prefettura era ampia e molto articolata nellasua struttura. Per Peppino P., abituato ad essere ilcuore dell’ufficio in tanti anni come capo di gabi‑netto a Cosenza, fu un inizio difficile. Ma comunquepresto si adattò ad una situazione, in fondo, più nor‑male, dove non tutto dipendeva da lui. Tutto l’am‑biente del resto era diverso ed erano appunto inpiena evoluzione anche i tempi. Certi rapporti co‑sentini non si sarebbero più creati. Negli anni ‘60 co‑munque una serie di commissioni e rappresentanze
68
nel grande attivismo barese gli diedero anche l’op‑portunità di guadagnare compensi (un costume de‑stinato notoriamente ad uno straordinario quantopatologico successo verso fine secolo) del tutto in‑consueti per lui, che non aveva mai ricevuto una lirain più dello stipendio per le sue spericolate escur‑sioni nel casentino durante e dopo la guerra.
Così partecipammo un po’, modestamente da im‑piegati statali, anche noi agli anni del boom.
Le prefetture continuavano ad agire da sole nelterritorio, scoperte sul lato politico: Peppino P. assi‑sterà infine, solo da pensionato, all’attuazione deglistatuti regionali che furono votati nel ’70. La lottapolitica non presentava però più, se non episodica‑mente, le scissioni e la drammaticità sociale, i tu‑multi, degli anni cosentini: quindi v’era in generaleuna maggiore serenità e spirito collaborativi. Le si‑tuazioni si complicavano piuttosto per una più ac‑cesa competitività politica fra gli stessi partiti digoverno e al loro interno, con personaggi di alto li‑vello nazionale impegnati negli scontri, con variecorrenti politiche che suscitavano problemi, a voltepressioni che suscitavano imbarazzi in prefettura. Ineffetti qualche prefetto poteva trovarsi in qualchemodo inserito nelle correnti di partito. Mio padre aCosenza era stato probabilmente di fatto vicino aduna idea di governo/Stato in situazioni tumultuose,al limite dell’eversivo, del dopoguerra e comunquenella democrazia bloccata, con una situazione inter‑nazionale ancora intesa pericolante, con una oppo‑sizione al governo che era opposizione anche agliuffici statali, ma ora e in una situazione normaliz‑
69
zata e politicamente mobile, diventava un problemadi partito/Stato, corrente di partito/Stato, leader po‑litico/Stato e Peppino P. non ci stava più. Così ci fuqualche momento di tensione, in cui ebbe da un pre‑fetto anche una volta una non tanto velata “minac‑cia” di trasferimento in Sardegna, se non si fosseottenuto qualcosa (a livello, comunque, non piùlosco di una raccomandazione).
Peppino P. ebbe comunque anche qui, in generale,ottimi prefetti e ottimi colleghi o compagni di lavoroanche di altre amministrazioni, ma, in generale, vi‑geva anche all’interno della prefettura una certacompetitività alla quale non era abituato. Come aCosenza, mio padre restava come sempre tutto ilgiorno in ufficio, ma la sera scappava volentieri permettersi a sentire a casa alla radio sul terzo pro‑gramma, alle 19 e 15, “Il concerto della sera”.
La società
Anche le amicizie rispetto a quelle cosentineerano rarefatte, come del resto quelle di mia madreche pure era più facilmente socievole. La società ba‑rese, che pure sa essere calda e simpatica, è piuttostocircospetta nei suoi ambienti, nei suoi circoli, va as‑secondata nelle sue abitudini per chi voglia parteci‑parvi; a certi livelli, mostrò uno stile di vitamondano troppo dispendioso ed ostentatorio ri‑spetto allo stile di vita sobrio e semplice maturatonella pur “buona” borghesia cosentina (quei gioiellifasulli di mia madre, così gentili e ben tenuti, ri‑spetto ai massicci ori e brillanti doc delle signore
70
71
bene baresane! Peraltro a Cosenza si sapeva, comenormale, che erano fasulli, qui, magari si sarebberopresi anche per veri!) e di fronte comunque a opzionicomportamentali diverse. Mio padre rifuggiva dal‑l’andare la sera “a mangiare i fagioli ad Altamura” o“i calamari a Trani”, piuttosto sfruttava la possibi‑lità di godere delle maggiori occasioni culturali cheoffriva la più grande città, specie in fatto di teatro e,specie, in fatto di musica. Non mancava, in partico‑lare, mai ai concerti e alle Opere, non tanto al Pe‑truzzelli, dedito ormai al cinema, quanto al Piccini,applaudendo musicisti, contanti lirici, magari ancheattori con giovanile frenesia da vecchio loggionistasancarlesco. Notevole il suo impegno per le diverseistituzioni culturali che allora cominciavano a sor‑gere a Bari. Un suo lavoro emblematico fu, a ri‑
Nel Petruzzelli. 1963. Come conciliare nel breve tempo libero musicae lettura del Corriere.
guardo, l’attività per l’Istituzione del locale Conser‑vatorio musicale, il cui atto fondativo porta la suafirma.
A riguardo, un meritorio raccoglitore di storia ecronaca baresi, Vito Maurogiovanni, ricordava unepisodio sulla locale “Gazzetta del Mezzogiorno”.Negli “eventi”, come si direbbe oggi, del “maggio”barese del 1958, il Presidente dell’Ente Turismoaveva fatto il grande sforzo di far venire a Bari ilMaestro von Karajan con la sua Filarmonica diVienna, ma pochissimi erano stati i biglietti prenotatiper la prima serata (allora non vi era ancora lagrande forza mediatica di ora sugli artisti e gli“eventi”). Preparandosi un, peraltro poco dignitoso,flop, il Presidente chiese aiuto a mio padre, che,scandalizzato, praticamente precettò le Ammini‑strazioni di Provincia e Comuni per sostenere l’ini‑ziativa. La sera della prima il Petruzzelli erastracolmo.
L’Acquedotto pugliese
In prefettura ci si trovava spesso di fronte pro‑blemi delicati che coinvolgevano grandi interessi,sfioravano grandi manovre, sconosciute al piccoloe povero mondo cosentino. Una volta Peppino P.dovette affrontare una situazione che coinvolgevaun piccolo comune: era sorto un forte contenziosofra il sindaco del paese e l’Acquedotto pugliese perun problema ecologico fra pubbliche fognature erischi di salmonellosi; Peppino prese decisamente
72
posizione per il sindaco. Gli fu detto che l’Acque‑dotto pugliese era un Ente potente che poteva spo‑stare prefetti e che a lui, viceprefetto vicario,poteva giocare la carriera. Ma in questi casi il fun‑zionario diventava ancora più irremovibile: ri‑spose che non gli importava nulla delle possibiliconseguenze per lui: fin quando era lui a quelposto, l’Acquedotto si sarebbe dovuto attenere allesue indicazioni sicché le rimostranze del sindacofurono soddisfatte.
Il primo ministro alla Fiera
Un episodio simpatico riguarda un potente poli‑tico non pugliese, presidente del Consiglio, che noncito perché forse non è giusto ricordarlo solo perquesto, anche se qualcuno potrà riconoscerlo. Ve‑nuto dunque a Bari ad inaugurare la Fiera del Le‑vante, l’uomo, per dare prova della sua energia, delsuo attivismo e della sua efficienza, volle fare a pieditutto il percorso che porta dall’Albergo delle Na‑zioni alla Fiera, direi circa un tre chilometri; nonsolo, ma lo fece camminando a passo di corsa e co‑stringendo tutto il seguito a corrergli dietro scom‑postamente. Il buon prefetto di quegli anni nellacorsa perse una scarpa.
“Che scostumato!” commentava Peppino P., inse‑rendo nel comportamento politico una categoria perquello in effetti alquanto anomala (ma se mio padresentisse i politici di ora!...).
73
Aldo Moro
Dell’onorevole Moro mio padre aveva grandestima per la sua statura culturale e la lunga visionepolitica; gli dispiaceva però certo suo immischiarsitroppo, lui e magari ancor più i suoi amici, nellebeghe correntizie di partito. Soprattutto ne seguì latragica fine con la più assoluta partecipazione, im‑medesimandosi nella situazione con grande ango‑scia e per il rapito e anche per i rapitori, capaci ditanto. Allora mio padre era in pensione e si arrovel‑lava continuamente al quel pensiero.
Mio padre aveva però qualcosa da ridire sulla de‑finizione di “statista” che per antonomasia venivaormai attribuita a Moro. Per lui uno statista sarebbedovuto essere persona più decisa, coraggiosa nellescelte, specie se ha una sua visione delle cose; menoteorica e didascalica. Evidentemente c’era a monteuna diversa concezione dello Stato, più amministra‑tivista e forse dirigista, pur nel suo liberalismo cul‑turale, da parte di mio padre, più dottrinaria edastrattamente politicistica da parte di Moro (ancorauna volta, se mio padre vedesse gli “statisti” dioggi!…).
Prefetto
Un po’ tardi infine – perché appunto Peppino P.sapeva poco tramare e per certe cose ce n’è assolutobisogno come gli si diceva, del resto, da più parti –mio padre fu promosso prefetto, con funzioni ispet‑tive a Roma. Negli ultimi anni infine, il prefetto Mar‑
74
fisa, già suo capo a Cosenza, che già quando erastato trasferito a Napoli aveva chiesto a mio padredi raggiungerlo (ma mio padre con mia madre nonsi sentirono di cambiare ancora), divenuto ora capodel personale al Ministero degli Interni, si ricordòancora del suo valoroso capo di gabinetto degli annieroici e belli cosentini e quanto gli doveva e quantogli doveva lo Stato; così credo che fu forse lui a far‑gli raggiungere il grado di prefetto di prima classe.
75
Testimonianze
Avendo pochi aneddoti baresi raccontati, vorreiora qui utilizzare, in loro vece, alcune lettere scrittea mio padre, specie in occasione della sua promo‑zione a prefetto, non per una agiografia, che a luinon piacerebbe affatto (“chi è statu grand’omme?”:il dialetto i napoletani se lo portano sempre ap‑presso), ma perché mi pare una documentazione si‑gnificatica e dei contatti professionali, checostituivano parte del suo lavoro a Bari, e di quelliumani, pur possibili in rapporti amministrativi. Essaci dà anche un quadro anche di mio padre vistodagli altri (rispetto a noi) nella sua azione quoti‑diana, aprendo così intanto anche il capitolo dellasua personalità più intima. D’altra parte, mi pareedificante far vedere come certe qualità umane sipossano esprimere anche in un ufficio burocratico, ecome poi esse trovino largo riscontro sociale. Nellostesso tempo alcune testimonianze schiudono uncerto mondo marginale, poco considerato.
“Le bambine di Stignano” dunque, un orfanotro‑fio femminile, gli scrivono per il San Giuseppe del’66, più o meno dettate: “Noi vediamo in Lei il padreputativo di tutti i poveri, di tutti i derelitti, di tutti i
79
bisognosi (…) speriamo sempre di vederLa arrivarequi da noi, perché il suo arrivo ci riempie di un en‑tusiasmo particolare e già sappiamo con quale dol‑cezza e comprensione ci guardano i suoi occhi”. E ame, leggendo la lettera, tornavano a mente le foto‑grafie di Peppino P. che, con occhi sagaci e sorridentie anche un po’ sorpreso, bambino anche lui fra ibambini, distribuiva i regali ai bambini poveri nellefeste di Natale del dopoguerra, nella prefettura diCosenza, con quel vecchio cappottone troppogrande… Per alcuni i dopoguerra non finiscono mai!Per fortuna c’è sempre anche qualcuno che sa man‑tenere quella stessa tensione morale e solidale.
Dalla “Casa della Bontà Sociale” di Terlizzi gliscrive la Direttrice per la sua promozione a prefettoche comportava presumibilmente un trasferimento:“Siamo tutte afflitte per aver appreso la Sua par‑tenza. Non Le nascondo che abbiamo pianto. La vitadella nostra istituzione è legata al Dr. Pani per le in‑numerevoli opere di bene ricevute. Le bimbe tutte, iragazzi mi chiedono perché hanno tolto da noi chici comprendeva e ci aiutava (…) La finezza del Suoprofondo sentire più che rara, unica, non la potremomai dimenticare!”
Sempre per la sua promozione a prefetto, il se‑gretario generale della CISL gli scrive nel ’64: “Ser‑berò il miglior ricordo della Sua persona per lasensibilità altamente sociale da Lei dimostrata intutte le occasioni che la hanno vista interessata aiproblemi dei lavoratori”.
Il Presidente della Giunta consultiva senatorialeper il Mezzogiorno osservava: “Il riconoscimento e
80
la riconoscenza che lo Stato italiano Le deve nonsono mai troppi e non devono considerarsi cosìesauriti”.
Simpatico l’inizio della lettera di un collega pre‑fetto di Firenze: “Debbo proprio sforzare le meningialla ricerca di tutte quelle fiorite espressioni care allagentilezza e alla signorilità del Tuo animo per dirtidella mia gioia?”.
Fra le altre, particolarmente incisiva la lettera diEnrico Pappacena: “Ella appartiene al novero diquelle persone di cui basta la presenza in città peressere lieti come di una Forza benefica che ci pro‑tegga e corrobori (…) Da quando (…) ebbi la gioia diun indimenticabile colloquio, in cui le nostre anime,egualmente fervide di fede, s’incontrarono, cercandoqualche attimo di fulgida comunione, mi sono sem‑pre rallegrato pensandola accessibile”.
L’Arcivescovo Mincuzzi coglieva l’altro aspetto dimio padre: “Godo per la Sua promozione, mi addo‑lora il Suo trasferimento (…). Non siamo stati troppotempo insieme, ma i nostri incontri erano ricchi diintesa su un piano di ricerca della perfezione, delbello, cioè di Dio. Bari perde una persona pulita edè una gran perdita”.
Perché v’è anche un richiamo a qualcosa di extrarispetto alle consuete valutazioni di un’attività am‑ministrativa, attingo qui alle “Note caratteristiche”sui dipendenti che i Prefetti inviano al Ministero, ungiudizio del prefetto di Bari, Cappellini, per il 1958(“Rapporto informativo sul vice prefetto dott. G.P.”).
81
Dopo le valutazioni più professionali di chi gli vo‑leva evidentemente particolarmente bene, spicca perme una frase: “Uomo di fervida mente, di superiorenobiltà d’animo, esercita un grande ascendente suidipendenti”.
Ma l’affinità elettiva più continua e profonda permio padre nacque certamente col Rettore dell’Uni‑versità, prof. Pasquale Del Prete, che aveva cono‑sciuto partecipando come rappresentante delprefetto al Consiglio di amministrazione dell’Uni‑versità. Era maturata presto fra loro una fervida, ete‑rea amicizia nata dalla capacità comune diconservare fra i rapporti di lavoro amministrativouno spazio appunto extra professionale che toccasseil sentire sui grandi temi, la condizione umana,l’amore per l’arte, la musica, le letture, l’ispirazionecristiana.
Al momento della promozione e, si pensava, tra‑sferimento, il Rettore gli scriveva dunque: “Gliaspetti buoni, positivi dell’evento mi paiono tutti ve‑lati e nascosti dal sipario che si abbassa per divi‑derci: “Sento cadé n’goppa st’autunnu n’atamalincunia” [i versi di Di Giacomo]. In questa cittàdura e tesa avevi portato la ricchezza del Tuo senti‑mento e della Tua presenza, avevi diffuso a pienemani il premio (…) di una umanità consapevole,profonda, articolata in ogni giudizio, in ogni scelta,in ogni atto della vita. È una grave perdita per Bari:la privazione di un bene insostituibile. Penso alletante cose che avremmo potuto dirci e che sono stateimpedite dalla lontananza, attutite dal frastuono fa‑stidioso di voci scomposte, ma mi conforto perché
82
83
la vera amicizia nasce dai lunghi silenzi: nei loro in‑tervalli, bastava un delicato pensiero, un correre delsentimento sul filo della memoria suscitata da un ar‑ticolo, una musica per richiamare lo spirito ad un le‑game, ad una elezione definitivamente compiuta.Questo è stato bello!”.
Infine, come epigrafe della sua attività, valga labellissima lettera di Del Prete a mio fratello, Egidio,nel febbraio de1 1981, dopo la morte di nostro padre:“Lo ricordo negli anni della appassionata Sua operadi controllo sulle amministrazioni locali, nelle suefunzioni di giudice amministrativo, integerrimo edumano, sensibilissimo e sprezzante di ogni intrigo,di ogni falsa virtù, generoso con i deboli, ma di in‑sospettata fermezza con i prepotenti, con i trafficantisubdoli, con i disonesti. Un’anima veramente nobile:spiritualmente una creatura eletta. Pochissimi Uo‑mini ho conosciuto nella mia ormai lunga vita, che,come Lui, riunissero in sé doti di un perfetto equili‑brio (raggiunto, forse, con doloroso sacrificio degliimpulsi di una natura sensibile alle suggestioni dellagrande Arte e della Bellezza) con gli interessi di unacultura giuridica aderente al senso del concreto e alleesigenze del pubblico bene. Lo ricordo nel Consigliodi Amministrazione dell’Università, prezioso consi‑gliere per me e sicura guida per il Collegio. Lo ri‑cordo nella sua bontà operosa e entusiasta, nellapurezza del suo galantomismo che si rilevava inogni occasione, aderente al principio della coerenzamorale che ispirava tutta la sua vita”.
Il senso della vita
Per le caratteristiche della sua indole e in modalitàche investivano le ragioni del nostro stesso esisteremio padre si distingueva in maniera del tutto singo‑lare e mi pare giusto segnalare qui un suo primato.Purtroppo egli nulla ci ha lasciato di queste sue po‑sizioni intellettuali, o anche sentimentali, se nonbrevi racconti o battute, che per me hanno però unvalore gnoseologico e che non resta ora qui che cer‑care di raccogliere, anche perché li vedo appuntocome segni di interrogativi comuni e di sempre.
Mio padre avvertiva in maniera particolare ilsenso del mistero della nostra vita e insieme il biso‑gno di darle una ragione. Questi sentimenti, checerto sono appunto comuni a molti, in lui – qui lasingolarità – erano costantemente presenti ed eranocolti con certa ipersensibilità nel quotidiano, allaprima occasione. Sapeva, in tale temperie, misurarela miseria e nello stesso tempo la grandezza del‑l’uomo, che è capace nella ricerca, nell’arte di rag‑giungere qualcosa che va oltre la sua esistenza,qualcosa che lui dunque avvicinava all’idea del di‑vino. Il senso dell’immortalità sarebbe allora legatoa queste espressioni della grandezza dell’uomo. Di‑ceva, ad esempio, che una biblioteca è una delle
87
prove dell’esistenza dell’anima: “Se no, perché tuttoil lavoro creativo che vi si conserva?”. Era come unrichiamo all’aspetto immateriale di una biblioteca: ilpensiero che v’è racchiuso e non è chimicamente in‑dividuabile e selezionabile, la sua anima, che non sivede, come non si vede e non si individua la nostranel corpo materiale.
In particolare poi la musica, che lui ascoltava conun trasporto molto passionale, era per lui l’espres‑sione precipua del divino che è in noi e nel mondo:il nervo che ci collega alle ragioni misteriose del‑l’esistenza; qualcosa che rinvia all’altro da noi, di su‑periore, all’al di là. Questi segni della grandezzadell’uomo si presentano dunque anche come stru‑menti di conoscenza: ci avvicinano cioè alla nostraessenza, ci fanno penetrare per qualche verso nel mi‑stero che ci circonda e che pure resta indefinibile; cifanno capire comunque che c’è qualcosa che dob‑biamo raggiungere, ma che sentiamo già nostra; unasorta di Paradiso perduto, di cui c’è rimasta la co‑scienza e soprattutto la nostalgia. Da questi presup‑posti nasceva la sua concezione particolare della vitae del mondo che poggiava su un pilastro fonda‑mentale: l’unificazione del bello, del buono, del giu‑sto e del divino. Una concezione, come si sa, pernulla ritenuta valida della dottrina cattolica allaquale pure mio padre si ispirava.
Maria Melato a Cosenza
Un aneddoto cosentino allude bene, pur nella sualevità, a questa concezione. Una sera, a fine anni ’40
88
venne dunque a Cosenza, al teatro “Rendano”, l’at‑trice Maria Melato, famosa per la sua voce dolcis‑sima e musicale; mio padre se ne entusiasmava,come si entusiasmava per la voce di Ruggero Rug‑geri. La Melato veniva e recitava nella dannunziana“La figlia di Iorio”, un’opera che evidentemente neavrebbe esaltato le qualità, come ne sarebbe stataesaltata. Mio padre era alquanto emozionato dal‑l’evento, raro peraltro nella città, e avrebbe volutoportare a teatro mia madre. Ma era un primo ve‑nerdì del mese e mia madre aveva fatto un voto allaMadonna che vietava in questa ricorrenza ogni di‑vertimento o “mondanità”. Mio padre non se ne fa‑ceva capace e reagì a modo suo: “Il giorno delgiudizio universale il Padreterno dirà: “Questadonna non è andata a sentire Maria Melato ne “La fi‑glia di Iorio” perché era il primo venerdì del mese?All’inferno!”.
La musica
In questa visione cristiana sui generis, mio padrenon aveva nessun dubbio che gli artisti, in partico‑lare i musicisti, qualunque tipo di vita avessero con‑dotto, dopo la morte andassero direttamente inParadiso, alla destra del Padre. Da questo punto divista, alla destra del Padre ci doveva essere una certaressa. Perché vi poneva, di volta in volta, Bellini,Schubert, ultimamente Mahler. Beethoven poi,“l’uomo più grande che sia mai esistito” a volte siidentificava col Padre stesso. Ascoltando un suo con‑certo per piano,non ricordo quale (quello in “do”?),
89
ad un certo punto cominciò a zittire tutti (anche senessuno stava parlando): “Ssssss! Qui è il Padreternoin persona che parla.” Fra gli angeli, serafini o che‑rubini quindi, fra gli altri, Lalo, Saint‑Saëns, Bizet.Per il resto solo compatimento e sarcasmo per la mo‑glie di Puccini che, miserella “Faceva la gelosa: comese Puccini fosse soltanto suo!”.
Naturalmente mio padre aveva scelto per tempola sua musica da ascoltare in punto di morte: e, na‑turalmente, la wagneriana morte di Isotta che glisembrava rendesse, nel suo drammatico, insistitopatema, lo sforzo dell’animo per liberarsi dal corpo(e il ridere quando ricordava che una sua parenteaveva capito che in punto di morte mio padreavrebbe voluto ascoltare il Bolero di Ravel! “È unabella musica, ma Gesù!).
La cosiddetta musica
Non tutta la musica per mio padre era “vera mu‑sica” (e qui era probabilmente anche un suo limiteantropologico). Quando venne una mia zia dagliUsa raccontò, con il suo italonapoletano america‑nizzato (che faceva impazzire mio padre), come il fi‑glio suonasse la chitarra ed avesse messo su uncomplessino con cui girava per Albany: “Sì – spie‑gava la buona donna – a John ci piace a’ mmusica!”.Non l’avesse mai detto! Mio padre, immaginando diche tipo di musica si trattasse, cominciò ad imper‑versare, come suo solito in questi casi, perfidamentecanzonatorio: “Ah, bene bene! Bravo! Ci piace a’
90
mmusica!”. E da allora in poi, ogni volta che incap‑passe involontariamente a sentire la musica zumzum zum, che aborriva, alla radio o nei suoi rari ca‑polini televisivi, se ne fuggiva con le mani nei capellidalla stanza, continuando a ripetere fra sé e sé: “Cipiace a’ mmusica, ci piace a’ mmusica”. Questoquando non usciva proprio dai gangheri. Una voltasi mise a vedere con noi un nuovo programma tele‑visivo, molto pubblicizzato e che lo aveva attrattocome titolo, ma, sentendo la sola sigla di apertura,uno zum zum zum particolarmente sguaiato, si alzòdi furia e fuggì sbraitando: “No! Non si può; non èpossibile; una persona per bene non può restare im‑passibile”, lasciando anche impietosamente distucco noi malcapitati che con più pazienza stavamoaspettando di vedere come fosse quel programma.
Un’annotazione ancora su mia zia d’America, dicui mio padre (allora in età…) non riusciva a sop‑portare l’accento. Quando ci salutò per ripartire, miopadre l’accompagnò con un sorriso insieme affet‑tuoso e doloroso, per poi sbottare verso di me: “Checonforto che non la vedrò più!” “Papa!” feci io intono attonito. “E va bene!” fece lui e poi rifacendoleil verso: “Che bbella ggiornate!”. Certe volte non locapivo.
L’applauso
Come tutti gli amanti del teatro e della musicamio padre aveva uno speciale culto dell’applauso.L’applauso è il ringraziamento, il premio a chi hadato, ma, soprattutto, il segnale dell’avvenuto con‑
91
tatto e corrispondenza fra il messaggio che l’artistaha voluto tramettere e la ricezione che l’ascolta‑tore/spettatore ha inteso: un rito perfezionato: piùintenso e prolungato è l’applauso, più si amplia ilcontenuto, lo spessore del messaggio e la capacità diintenderlo e riviverlo, di farlo continuare anzi so‑prattutto da parte di chi lo ha ricevuto e lo ha fattoproprio, di portarlo con sé. Fra i tanti cantanti cheaveva ascoltato, da quando da giovane, nei primianni ‘20, si precipitava ogni sera da Caserta a Na‑poli, al San Carlo, mio padre aveva una particolarepredilezione per Magda Olivero. Una volta, a fineanni ’50, la sentì a Bari nella Traviata. Ci sono stateforse cantanti ancora migliori, fra le grandissime, mapare che la Traviata della Olivero fosse effettiva‑mente qualcosa di molto speciale. Mio padre ap‑plaudì quella sera in piedi, a lungo con entusiasmo;poi andò ad omaggiarla nel camerino per dirle: “Iocontinuerò a batterle le mani per tutta la vita”. DallaOlivero ebbe una grande foto con dedica che cam‑peggiò in cornice nel nostro salotto.
Una sera, in vecchiaia, dopo più di vent’anni,quando mio padre, stanco e sofferente, non fre‑quentava più i teatri, se non quelli dorati e felici dellasua fantasia, e la Magda non cantava più, sentii chenella stanza da letto – dove posava di solito distesosulla poltroncina fra radio e “Divina commedia” –ascoltava alla sua radiola al buio, col solo lumicinodella Madonna, cara a mia madre, un brano dellaTraviata. Alla fine dell’aria, dalla stanza si levò unapplauso intenso e forte e il grido un po’ roco di“Brava! Brava!”. Mi affacciai nella sua stanza dal cor‑ridoio: “È la Magda…” mi fece mio padre dal buio,
92
felice di potermelo comunicare e di includermi inquell’emozione, rinvigorito per breve dall’entusia‑smo; e io intravedevo gli occhi rossi, come gli capi‑tava in queste circostanze (il Paradiso perduto erapiù vicino), illuminati dal fervore e dalla lucetta, emi ricordai allora di quella frase che mio padreaveva detto alla Magda nel camerino dell’artista: “Iocontinuerò a batterle le mani per tutta la vita”.
Il Duomo di Orvieto
La visione etica dell’arte valeva naturalmenteanche per la poesia. Da qui l’episodio che ho rac‑contato della commissione epuratrice: mio padre di‑fendeva il farmacista di Fuscaldo che scriveva poesieper lui toccanti, perché non riusciva a capacitarsi dicome potesse essere poi nella vita implicato mala‑mente col fascismo.
Ad altre forme d’arte come pittura, scultura ar‑chitettura mio padre era meno educato, ma il belloaveva in lui sempre lo stesso effetto. Ebbe molto daprotestare, per esempio, quando vide come attornoalla Chiesa di Santa Croce a Firenze potesse scorrerenormalmente il traffico automobilistico. E alla sco‑perta del bello si accompagnava sempre lo stupore.
Aveva intorno ai 70 anni mio padre e non avevaancora mai visto il Duomo di Orvieto (una volta, pervari motivi, si viaggiava anche molto meno diadesso), sicché, andando insieme in macchinaun’estate a Chianciano, pensai di fermarmi lì e fargliquesta sorpresa. Ricordo il passaggio lungo le po‑derose mura medievali di Orvieto, l’addentrarsi su e
93
giù della macchina seguendo le indicazioni stradali:“Duomo” (una continua promessa), fra le casupoledella città vecchia, basse, decrepite, appiccicate l’unaall’altra, scure e sconnesse. Ad un certo punto, si de‑lineò infine un’imponente, lunga, elegante fiancatarigata, bianca e grigia: era il Duomo; appresso, si in‑travide la piazza che si allarga a mano a mano allavista per chi viene da dietro e, giunti qui, improvvi‑samente, di fronte, alta, luminosa, colorata apparvela facciata che si eleva sotto il cielo azzurro, il suoslancio solenne e poderoso ed insieme armonioso eleggero: quello stare lì come un segreto nascosto tro‑vato e svelato, qualcosa di grande, che fa parte dellastoria del mondo, quindi lontano, però infine oraanche tuo. Dopo un po’ che la osservavo con rinno‑vata meraviglia in tutta la sua ricchezza, mi voltaiverso mio padre per chiedergli cosa ne pensasse.Non c’era bisogno di chiedergli nulla. Aveva gliocchi rossi e gonfi di lacrime. Fece venire le lacrimeagli occhi anche a me. Fu bella quella sensazione inquella giornata di sole con mio padre davanti alDuomo di Orvieto.
Ma a Venezia, mi dice mio fratello, visitata sem‑pre da anziano, fu per lui pianto vero e proprio.
La pratica religiosa
La connessione fra miseria e grandezza era unacaratteristica della sua concezione dell’uomo e anchealla base della sua scelta per la fede cattolica, quellache certo più di ogni altra religione, filosofia o dot‑trina, quale che sia la sua verità, sa coniugare quei
94
due fondamentali, contraddittori aspetti della con‑dizione umana. Ho detto già delle sue idee a ri‑guardo della connessione divino, giusto, bello,trascendenza dell’uomo.
Nella pratica dei comportamenti religiosi, per ilresto, in tanti particolari mio padre aveva di fatto an‑ticipato il concilio Vaticano II. Verso la fine deglianni ‘50, visitando la cattedrale di San Francesco adAssisi, ad un certo punto non lo trovavamo più; poilo vedemmo che, approfittando di una cappelladove il celebrante stava comunicando, si era messodirettamente in fila per prendere la comunione,dopo aver appena fatto colazione e senza passare dalconfessore. E tuttavia in qualcosa era più severo. Iro‑nizzava, sia pur con clemenza, come ho già ricor‑dato, su certi parlamentari democristiani che sidiceva si comunicassero ogni giorno. “Un politico –diceva – non può farsi la comunione ogni giorno”.
Dei non credenti mio padre aveva comprensione,ma non ne sopportava la molto comune arroganza esaccenteria: così come quando ricordava di quel par‑lamentare comunista a Cosenza nel dopoguerra chenon entrò in chiesa al matrimonio della figlia per sot‑tolineare la sua “sapienza” di non credente o l’altrotizio che proclamò. “Io sono ateo!”, sbattendo ilpugno sul tavolo. Non lo sopportava.
Esasperazioni
Delle volte l’ipersensibilità di mio padre, in vec‑chiaia, gli faceva dare un po’ i numeri. Ho ricordatogià della buona zia d’America. Ricordo un episodio
95
eclatante che ha tanto del simpatico, quanto forseanche dell’antipatico, pur se era evidente il tono dabattuta dell’uscita di mio padre; comunque egli erafatto così; altrimenti cosa ci sarebbe da raccontare.Noi avevamo una brava donna di cameriera che par‑lava per lo più un dialetto barese molto stretto e ad‑densato. Quando la poveretta prendeva a parlare unpo’ di più, raccontando qualcosa di casa sua a miamadre, che a volte capiva, a volte no, ma comunqueascoltava quei fatti di vita che facevano anche com‑pagnia, e, anzi, le dava consigli, mio padre allora siproteggeva chiudendo le porte della sua stanza e delcorridoio. Un giorno capitò che mio padre si trovavain cucina quando la donna fu chiamata a telefono nelcorridoio. Dall’altro capo era una comare con laquale la nostra accese una discussione acerrima. Miopadre sulla soglia della cucina si sentì perduto; vo‑leva riguadagnare la sua stanza e barricarsi, ma do‑veva passare dal corridoio accanto al telefono.Aspettava così col viso contratto nella giacca del pi‑giama il momento giusto; alla fine prese coraggio epassò di corsa; ma scelse il momento sbagliato; pro‑prio mentre lui le era accanto, la donna, tutta presadalla sua polemica, perso ogni controllo, cominciò ascatenarsi al telefono con una risposta furibonda avoce alta in un dialetto veemente e strascicato, in‑terminabile. Mio padre sorpreso si mise le mani sulleorecchie, scappando vieppiù e urlando a sua volta;infine, oltrepassato il corridoio, chiuse la porta die‑tro di sé, vi si appoggiò con le spalle per prenderefiato e se ne uscì con questa sconvolgente osserva‑zione: “No, no. E questa l’anima non c’è l’ ha proprio.Ma che vogliamo scherzare?”.
96
Aihmé! quel suo voler cercare continuamente ildivino nell’uomo!
Così, quando vedeva alla televisione qualche do‑cumentario su uomini di civiltà primitive, li seguivacon grande interesse con tutta la buona disponibilitàa conoscere, capire; rispettava anche i loro costumi, leloro forme di religiosità, ma di fronte a quei saltelliattorno a un fuoco restava con espressione indefini‑bile; potrei dire forse, dispiaciuta. Non lo diceva pernon essere troppo disfattista, ma io so quello che pen‑sava. “Che tristezza !”. E io sapevo cosa significava.
Gli animali
Quel certo comportamento di mio padre non si‑gnificava prosopopea o boria. Egli, ad esempio, eraun amante degli animali e naturalmente, come sipotrà immaginare, dei cani. Negli ultimi anni, nonpotendo prendere un cane, si mise un gigantesco po‑ster di un cane da pastore tedesco di fronte alla suapoltrona. Gli piaceva molto stare seduto e vedere difronte a sé, lo diceva, le due cose che amava: l’ampianostra libreria principale ed il cane. Guardava dun‑que spesso i documentari televisivi sugli animali.Una volta vedeva un servizio su certi uccelli che sal‑tellavano fra le piante e si aggiravano a beccare perterra il rado cibo e li seguiva, notai un po’ impres‑sionato, con una partecipazione assoluta che quasirifaceva qualche loro verso. Poi, di fatti, se ne uscìcon questa frase. “Ecco! Perciò a me piacciono, per‑ché mi pare di essere uguale a loro”.
97
Libri e musica nell’età della pensione
L’età della pensione mio padre l’accolse come iltempo in cui avrebbe potuto finalmente dedicarsi li‑beramente ai suoi libri e alla sua musica; fra i primisempre la Divina Commedia (e lo vidi ancora com‑muoversi a leggere di Paolo e Francesca), che ac‑compagnava con la nuova Lectura Dantis; fra glialtri classici, le Novelle di Pirandello, che preferiva alteatro; poi romanzi italiani recenti e contemporanei,di cui aveva essenzialmente notizia nelle pagine cul‑turali dei giornali: Berto, Calvino, Cassola, Landolfi,Gianna Manzina, Prisco, Lalla Romano; un misto diattrazione, per le sue qualità narrative, e di repul‑sione, per quello che gli pareva a volte ostentato“scandalismo”, esercitava Moravia, di cui comun‑que leggeva molto; grande affetto invece per ilMosca dei Ricordi di scuola e per il napoletano Ma‑rotta; e poi, nel gruppetto degli ultimi libri che te‑neva accanto a sé, quando con la caduta per stradacominciò la sua crisi fisica, insieme col “premio” pa‑terno Scurpiddu, due “scoperte” recenti la storiadella letteratura italiana di Flora, che prese ad amareper il suo stile suggestivo, un volume del teologoHans Küng, Essere cristiani.
Della Letteratura di Flora si dette anzi a scriveresu un quaderno in bella grafia un compendio ben or‑dinato per capitoli, con numerazione delle pagine edindice; l’età tracciata era il ‘700. Francamente conmio fratello non lo abbiamo apprezzato, pensandoa come su quel quaderno avrebbe potuto scriverequalcosa di suo. Lo apprezzò invece giustamente lanipote Gilda, ormai professoressa di Lettere a
99
scuola, quando ritrovai il quaderno che dormiva da30 anni, e glielo feci vedere. Fu un bel momento: lanipotina ritrovava il nonno; ammirata e incantata difronte a quel quaderno, lo sfogliava su e giù: “Chemeraviglia!... Ma questa è una cosa preziosa” e ve‑devo che sorridendo oscillava con la testa come adire “Solo lui…”. Chi sa che il nonno non l’avessescritto proprio per lei!
Soprattutto però il tempo di Peppino P. in pen‑sione era dedicato alla musica (anche se aveva la‑sciato [fortunatamente per noi] lo studio del violinoche lo aveva accompagnato per tanti anni a Co‑senza). Nuove rare scoperte di ascolto alla radio su‑bito appuntate e disperatamente ricercate nei negozidi dischi: fra i suoi ascolti preferiti, la musica operi‑stica in genere (un amore particolare per La son‑nambula di Bellini o per aree come “Una macchia equi tuttora” del Macbeth con la Callas, ma natural‑mente tante), quindi Beethoven (in particolare, lanona sinfonia, della quale trovava fuori posto però,dopo l’altissimo precedente, “l’inno alla gioia” fi‑nale; poi i quartetti, il concerto per pianoforte in do),Schubert; Mahler (scoperta recente e trascinante; inparticolare, la quarta sinfonia), Ciaikowski natural‑mente, la sinfonia in do maggiore di Bizet, i quartettidi Borodin e Shstakovich, il Valse triste di Sibelius,Dvoràk (in particolare, il concerto per violoncello op.104), o i meno famosi al gran pubblico due gioiellinidi Martucci che mi fece scoprire, Novelletta e Not‑turno, op. 70; quindi Lalo (la Sinfonia spagnola e ipezzi per violino), ancora i concerti per violino diSaint‑Saëns e di Bruch e quindi il violino di Paganinie tanti altri pezzi.
100
Sicché, da questo suo mondo, mio padre se laprendeva con tutti quelli che lamentavano di nonaver nulla da fare stando in pensione (anche se nontutte le sue nuove letture poi alla fine ricordava e nerestava sconfortato: “mio Dio! La vita che hai vissutoè come se non l’avessi mai vissuta, i libri che hai lettoè come se non li avessi mai letto” si lasciò detto unavolta che gli si accumularono insieme due dimenti‑canze di vita e di lettura).
Un suo compagno fedele in questi anni fu il Ra‑diocorriere, dove appuntava tutte le trasmissioni,specie musicali naturalmente, che avrebbe dovutoascoltare. Ma l’ascolto della radio era un misto di go‑dimenti e sofferenze. Una volta mandò al periodicouno sfogo, a modo suo, (che è uno dei suoi pochis‑simi scritti conservati) su qualcosa che non gli an‑dava. Apparve dunque sul settimanale questa letteracon la sua firma: “(…) Non vorrei che in un ibrido,insostenibile connubio fossero maldestramente al‑ternate musica e varia scienza. Della cultura la tra‑smissione è un vago scimmiottamento (…). Nonvorrei che suoni mostruosi e barbari costituissero lasigla del Giornale radio della terza rete (…). Nonvorrei che venissero adoperati titoli che agghiac‑ciano: per esempio: “Il terzo orecchio” (…). Non vor‑rei sentire più la parola “diciamo”, una pandemiainarrestabile e rivoltante. Così indecente è diventatoquesto triviale “diciamo” che io proporrei venisseaddirittura eliminato nella coniugazione del verbo“dire”, propriamente alla prima persona plurale del‑l’indicativo presente. Fuori i “diciamo” per carità, al‑trimenti io, già ricolmo di sdegno, impazzisco didisperazione”.
101
Il nome Anna Maria
Purtroppo, dicevo, mio padre non ha lasciatonulla di scritto, così bisogna andare a cercare qual‑cosa di suo sparso, come nella lettera a Radiocor‑riere, o in un’altra rivolta a me, che cito più giù, o inuna lettera a mia sorella Anna Maria per il suo ono‑mastico, che mia sorella aveva giustamente conser‑vato.
Qui, dopo aver ricordato che quell’anno cadevaanche il decimo anniversario del matrimonio diAnna Maria, “dieci anni o, con parola più trionfante,un decennio”, giocò sul doppio anniversario; delmatrimonio, scriveva, ella conservava i più intimisentimenti, ma sul nome aggiungeva: “ ‘AnnaMaria!’: del tuo nome tu che puoi dire? È un belnome dal punto di vista estetico, significativo dalpunto di vista religioso.
Ma i presupposti, le lunghe vigilie di nove mesi,i dubbi sul sesso del nascituro, mentre vivo era ilmio desiderio della femminuccia e, in questo casofortunato, il nome (…). Amante dei suoni cercavo unnome, fra l’altro, che ben armonizzasse col cognome.I dolci pensieri della dolce attesa! Fu così – sfuggonoormai i particolari – che, d’accordo con la mamma, equale somma delle proposte di ambedue, nacque,prima di te, il nome Anna Maria, che comprendevail nome della Vergine, cara alla mamma, con San‑t’Anna, tanto venerata a Caserta.
L’armonia era raggiunta: bene il nome si appog‑giava nella quadruplice sfilata della vocale “a”. Laquale, peraltro, è vocale distesa, serena, pacifica‑trice”.
102
La nipotina
Uno scritto sereno è una lettera che mi scrisse du‑rante un mio soggiorno a Firenze, sulla nipotina.“La bambina ha ricominciato i suoi studi di ‘ricerca’.Questa volta riguardavano gli animali migratori. Ioin verità, nella mia ignoranza, ricordavo soltanto lerondini, anche per la nota poetica che caratterizza iloro voli, né l’Enciclopedia, consultata, ha risposto.Allora ho pensato a quel tuo libro di geografiaOrbis, che, come già ti ho detto, contiene conden‑sato tutto lo scibile terrestre, e là ho trovato tutto.Quante prove dovrò superare perché Gilda Pia su‑peri la terza elementare!”. Fra le frasi famose dellanipotina, una lo aveva particolarmente emozionato
103
Frammento di lettera.
e reso felice. Mentre la accompagnava un pomerig‑gio per mano a casa nostra, la bambina esclamò con‑tenta: “Come è bello andare a casa della nonna!”.Un’espressione che mio padre volle trascrivereanche al suo caro amico, il professor Del Prete, colquale continuava a tenere una tenera consuetudineepistolare: gli sembrava l’espressione col quale tuttinoi desideriamo andare alla biblica “casa delPadre”.
L’aldilà
Il pensiero dell’aldilà, che mio padre aveva in re‑altà sempre tenuto accanto a sé, allora diventava piùvicino. Presto ci sarebbe passato in quell’al di là tantevolte evocato nella sua vita e lo avrebbe reso piùumano e più ricco per quanto più poveri ci avrebbelasciato.
Nei suoi ultimi giorni, mio padre avvertì lucida‑mente e drammaticamente l’esaurirsi della sua vita‑lità in una sua certa abulia, in particolare quindinella difficoltà di entusiasmarsi ora più per la mu‑sica. Ne parlò lucidamente col suo dottore, ricordo,l’ultima volta che lo vide prima di entrare in clinicadove sarebbe subentrata la crisi finale. “Che mi suc‑cede? – chiedeva – io ascolto la musica che amavosenza emozione, sono già morto?”. Il dottore loguardava interdetto: probabilmente non aveva maisentito da un paziente, né letto sui manuali fra i sin‑tomi di una malattia qualcosa del genere. Si dette atranquillizzarlo tuttavia: non gli sembrava quellauna cosa grave. Lo era invece.
104
L’ultimo sogno
Nei suoi ultimi giorni in clinica mio padre avevaperso la sua lucidità per sopraggiunti problemi re‑nali ed era toccante vederlo così, tutto sommato peròsognante, lui sempre tanto presente a sé stesso e in‑trospettivo. Un giorno, quando andai a trovarloverso le 14 (in un raro momento in cui non c’era nes‑suno di noi), vidi che era circondato da medici e in‑fermieri che cercavano di tenerlo buono mentre luivoleva mettersi le scarpe. Tutt’intorno nell’ampiastanza guardavano gli altri ricoverati: quello che siergeva solo con il busto dal letto, alto e diritto comeFarinata, che parlava delle stranezze di mio padredurante la notte con naturalezza e grande dignità,come se fossero cose normali e sensate che fosse giu‑sto fare; il giovane che era sempre piangente perché,entrato in dialisi, temeva di perdere il lavoro e dinon potersi più sposare e che mia madre spesso cer‑cava di consolare allontanandosi per un po’ da miopadre; l’altro, sempre in piedi, che all’inizio, appenaentrato diceva, sicuro di sé, che non aveva nulla, eora, dopo qualche giorno di cura, vagava nellastanza come un ubriaco; l’altro ancora che stava sem‑pre sotto le coperte, senza farsi vedere, e soffriva dipiaghe da decubito in tutto il corpo; ora lo vedevoseguire ogni cosa, tirandosi sempre su le coperte, malasciando gli occhi spaventati di fuori. Quando mivide, mio padre tirò un sospiro di sollievo con l’ariadi chi pensa “Oh! Finalmente c’è chi mi capisce”. “Sivuole alzare” – disse un medico – “vuole andare acasa”. In effetti avevamo pensato di riportarlo a casail giorno dopo. Dissi: “Papà, domani; domani vieni
105
106
a casa; stiamo preparando tutto”. “Domani!?” fecemio padre guardandomi rassicurato, ma perplessoe poi guardando avanti, dopo aver taciuto, improv‑visamente come avvertendomi: “Però poi il trenoparte”. Pensai che, stando lì, gli sembrasse ora chela sua casa fosse tanto lontano che ci fosse bisognodel treno. E ancora io per rassicurarlo, cercando dirazionalizzare, ma percependo che qualcosa ci sfug‑giva: “Non c’è bisogno del treno; andiamo con lamacchina”. E mio padre mi assentì ancora come sefosse rassicurato; ma i suoi occhi guardavano in alto,lontano, nel vuoto per me, ma in realtà, ripensaidopo, come al confine fra la vita e la morte: a queltreno in partenza. Forse quello che lui non avrebbepiù preso, o quello che lo avrebbe portato via, ol’uno e l’altro? (quante saranno su quel confine le di‑mensioni?). Mio padre non tornò più a casa. All’albadel giorno dopo ci lasciò: era il 29 febbraio del 1980.
Dopo che fu rimosso dalla sua stanza della clinicae ricomposto nel locale apposito, quando, fatta sera,eravamo per andarcene, mentre stavo per uscire, tor‑nai improvvisamente indietro, nella stanza dove erastato mio padre e salutai i suoi compagni di stanzaad uno ad uno quasi con un inchino: “Buonasera,buonasera, auguri”. Loro forse si meravigliaronoche, mentre mio padre era morto, io mi preoccupassidi usare questa gentilezza. Ma io volli salutare quelliche lui si era trovato ad avere come ultimi compa‑gni di viaggio della sua vita.
INDICE
Prefazione 00
I.L’EDUCAZIONE
La casa dell’Italietta 00La rivoluzione industriale 00Il papà Egidio e la vita come sacro dovere 00Lo zio Eugenio e la belle époque 00La domestica e la Prima Guerra Mondiale 00La scuola 00La giovinezza 00Toh! il Fascio 00
II. IL FUNZIONARIO DI PREFETTURA
1. A CosenzaLa prefettura e Cosenza 00La divisa, le marce, l’OVRA e la voce del Duce 00Il feroce Saladino 00La guerra, i funzionari e il vetturino 00La città vuota 00Il commissario di polizia 00Il prefetto fascista 00Il commissario di polizia 00Gli indiani a Cosenza 00Il grano 00La caduta del fascismo 00“L’uomo qualunque” 00Il prefetto socialista 00
La prefettura centro politico 00La commissione epuratrice 00Il referendum 00Le elezioni del ‘48 00Il difficile dopoguerra 00Il prefetto, barone napoletano 00Il questore 00La politica 00La società 00L’usciere e il gioco dell’otto 00Le illegalità 00Chimenti 00
2. A BariLa città 00L’ufficio 00La società 00L’Acquedotto pugliese 00Il primo ministro alla Fiera 00Aldo Moro 00Prefetto 00
APPENDICETestimonianze 00
III. LA PERSONALITÀ
Il senso della vita 00Maria Melato a Cosenza 00La musica 00La cosiddetta musica 00L’applauso 00Il Duomo di Orvieto 00La pratica religiosa 00Esasperazioni 00Gli animali 00Libri e musica nell’età della pensione 00Il nome Anna Maria 00La nipotina 00L’aldilà 00L’ultimo sogno