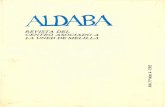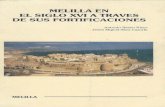L'immigrazione clandestina nelle città autonome di Ceuta e Melilla
Transcript of L'immigrazione clandestina nelle città autonome di Ceuta e Melilla
Corso di Laurea Magistrale in Lingue e Culture per la
Comunicazione e la Cooperazione Internazionale
L’immigrazione clandestina nelle città
autonome di Ceuta e Melilla
Tesi di Laurea di:
Debora Procopio
Matr. n. 8 2 7 1 9 8
Relatore: Beatriz Hernán-Gómez Prieto
Correlatore: Maria Matilde Luisa Benzoni
Anno accademico 2013/2014
Indice
Introduzione .................................................................................................................................. 3
I Capitolo ....................................................................................................................................... 5
1. La storia di Ceuta dalla conquista portoghese ai giorni nostri .............................................. 5
1.1. Dal XV secolo alla fine del XIX secolo .......................................................................... 5
1.2. Dal XX secolo a oggi .................................................................................................... 13
2. La storia di Melilla dalla conquista dei Re Cattolici ai giorni nostri ................................... 20
2.1. Dal XV secolo alla fine del XIX secolo ........................................................................ 20
II Capitolo ................................................................................................................................... 33
1. Il fenomeno migratorio in Spagna ....................................................................................... 33
1.1. Le prime iniziative politiche per regolare il fenomeno dell’immigrazione .................. 35
1.2. Il processo di regolarizzazione degli immigrati ........................................................... 37
1.3. L’immigrazione clandestina nella penisola spagnola .................................................. 38
1.4. L’immigrazione clandestina a Ceuta e Melilla ............................................................ 39
2. La storia dell’immigrazione clandestina a Ceuta e Melilla ................................................. 40
2.1. I primi disordini a Ceuta e Melilla ............................................................................... 42
2.2. Le iniziative promosse dal governo spagnolo .............................................................. 45
2.3. Las vallas: la costruzione delle barriere di separazione ............................................. 46
2.4. La nascita dei CETI a Ceuta e Melilla ......................................................................... 47
2.5. Gli incidenti e i disordini avvenuti durante l’anno 2005 ............................................. 48
2.6. Il rafforzamento delle barriere di separazione ............................................................ 50
2.7. L’immigrazione clandestina tra il 2006 e il 2012 ........................................................ 51
2.8. Il tragico salto alla “valla” di Melilla: l’episodio del 25 aprile 2013 e le sue
conseguenze ......................................................................................................................... 52
2.9. La tragedia del 6 febbraio 2014 nella città di Ceuta ................................................... 54
3. Ceuta e Melilla oggi ............................................................................................................ 57
3.1. Chi sono gli immigrati che arrivano a Ceuta e Melilla? ............................................. 57
3.2. Non solo uomini: le donne migranti ............................................................................. 59
3.3. Non solo adulti: i minori migranti ............................................................................... 61
3.4. Come vengono raggiunte Ceuta e Melilla dai migranti? ............................................. 63
3.5. I CETI e i servizi da loro offerti a Ceuta e Melilla ...................................................... 66
3.6. E una volta superata la valla? ..................................................................................... 67
3.7. Expulsiones en caliente ................................................................................................ 71
3.8. Possibili soluzioni al fenomeno della migrazione clandestina a Ceuta e Melilla ........ 73
III Capitolo .................................................................................................................................. 76
1. Il fenomeno dell’immigrazione nei mass media ................................................................. 76
2. I giornali digitali .................................................................................................................. 78
2.1. L’uso della fotografia nei giornali digitali ................................................................... 80
2.2. L’uso di contenuti audiovisivi nei giornali digitali ...................................................... 81
3. Analisi degli articoli di giornale inerenti all’episodio del 25 aprile 2013 a Melilla ............ 82
3.1. El País .......................................................................................................................... 82
3.2. El Mundo ...................................................................................................................... 86
3.3. El Diario Digital de Melilla ......................................................................................... 89
3.4. El Faro Digital ............................................................................................................. 93
3.5. Considerazioni generali ............................................................................................... 95
4. Analisi degli articoli di giornale inerenti all’episodio del 6 aprile 2014 a Ceuta ............ 96
4.1. El País .......................................................................................................................... 96
4.2. El Mundo .................................................................................................................... 100
4.3. El Faro Digital ........................................................................................................... 103
4.4. Ceutaldía .................................................................................................................... 105
4.5. Considerazioni generali ............................................................................................. 107
Conclusioni ............................................................................................................................... 109
Bibliografia ............................................................................................................................... 112
1. Libri ................................................................................................................................... 112
2. Articoli .............................................................................................................................. 113
3. Articoli di giornali ............................................................................................................. 116
Sitografia ................................................................................................................................... 120
Ringraziamenti .......................................................................................................................... 122
3
Introduzione
La tesi che andrò a presentare sarà dedicata interamente alle uniche due città
autonome spagnole, Ceuta e Melilla.
Ceuta e Melilla sono due città singolari poiché pur appartenendo di diritto allo
stato spagnolo, non soltanto sono circondate da un’altra entità statale, il Marocco, ma si
trovano addirittura di un altro continente, l’Africa.
Questa loro particolarità ha fatto sì che esse siano diventate il punto di arrivo di
moltissime persone provenienti dai paesi più poveri al mondo, ossia dall’Africa
subsahariana.
Queste rotte migratorie hanno causato, quindi, l’arrivo in massa di moltissimi
migranti subsahariani nelle due città autonome costringendo così il governo spagnolo ad
adottare misure di difesa. La più importante fra queste è stata la costruzione di alte
barriere di filo spinato allo scopo di separare fisicamente Ceuta e Melilla dal continente
africano e, pertanto, controllare e ostacolare l’immigrazione irregolare.
Il presente lavoro è stato realizzato con la finalità di studiare come il governo
spagnolo e le due città autonome siano riuscite, o meno, a contrastare il fenomeno
dell’immigrazione clandestina nel tempo.
Per fare ciò si è deciso di organizzare e strutturare la presente tesi in tre capitoli.
Nel primo capitolo, a fini introduttivi, si fornisce una panoramica storica,
andando a ripercorrere la storia di Ceuta e Melilla al fine di indagare il motivo per cui
due città apparentemente appartenenti al continente africano facciano invece parte dello
stato spagnolo. Per fare ciò è stato necessario andare molto indietro nel tempo,
precisamente al XV secolo, quando Ceuta era entrata a far parte dei domini della
Corona portoghese mentre Melilla, quale città semi abbandonata, venne conquistata dai
sovrani di Spagna nel 1497. Per la cessione della città di Ceuta sarà necessario aspettare
4
due secoli quando nel 1668 il Portogallo cederà la città al Regno spagnolo attraverso il
Tratado de Lisboa.
Nel secondo capitolo, invece, ci addentriamo nel tema al centro della tesi, ossia
l’immigrazione clandestina, iniziando a fornire una panoramica generale sul fenomeno
migratorio in Spagna per poi concentrare l’attenzione sugli effetti che la pressione
migratoria ha avuto, e ha tuttora, nelle due città autonome. In particolar modo ho voluto
innanzitutto ripercorrere la storia dell’immigrazione irregolare a Ceuta e Melilla
partendo dagli anni del protettorato spagnolo del Marocco arrivando ai giorni nostri.
Con riferimento a questa dimensione verranno studiate le diverse iniziative promosse
dal governo spagnolo per gestire il fenomeno migratorio, fra le quali troviamo: la
realizzazione delle barriere di separazione e la nascita dei CETI quali strutture di prima
accoglienza per gli immigrati; verranno inoltre affrontati i problemi che sono sorti in
corrispondenza dell’aumento del fenomeno migratorio e del numero di immigrati nelle
città, come ad esempio l’episodio avvenuto a Melilla il 25 aprile 2013 e la tragedia di
Ceuta il 6 febbraio 2014. Per ultimo, verrà studiata la situazione odierna, indagando in
particolare su chi sono i migranti, come arrivano e cosa succede loro dopo essere entrati
nel suolo spagnolo.
Infine, il terzo capitolo sarà dedicato interamente al modo in cui i mezzi di
comunicazione di massa, e in particolare i giornali digitali, affrontano il tema
dell’immigrazione. Successivamente ho voluto analizzare come alcuni quotidiani
digitali hanno trattato i due gravissimi incidenti molti gravi avvenuti a Melilla e Ceuta
già precedentemente descritti nel secondo capitolo. Per fare ciò ho esaminato due
quotidiani nazionali, El País ed El Mundo e due locali, El Diario Digital de Melilla ed
El Faro Digital per quanto riguarda Melilla ed El Faro Digital e Ceutaldía per quanto
riguarda Ceuta, per poi metterli a confronto.
Per ultimo, trarrò le mie conclusioni sulla base dei documenti studiati.
5
I Capitolo
1. La storia di Ceuta dalla conquista portoghese ai giorni nostri
1.1. Dal XV secolo alla fine del XIX secolo
Agli albori del XV secolo, il re portoghese Giovanni I1 volle intraprendere
un’iniziativa bellica contro l’Islam. Per fare ciò, il Papa allora regnante, Gregorio XII2,
gli concesse una bolla delle Santissime Crociate che permise a Giovanni I di provare ad
espandere i domini portoghesi verso il Nordafrica muovendo guerra alle popolazioni
musulmane lì stanziate.
Il primo obiettivo della conquista portoghese fu Ceuta, una ricca e fiorente città
sulle coste mediterranee marocchine, importante perché non molto lontana dalle coste
iberiche oltre al fatto che vi era il principale porto dello Stretto di Gibilterra.
Per la conquista di Ceuta il comando portoghese noleggiò navi provenienti da
Castiglia, Biscaglia, Galizia, Fiandre, Germania, Gran Bretagna e Inghilterra. Inoltre, da
quest’ultima, acquisì delle armi (Villada Paredes 2009: 319).
Il 21 agosto 1415 avvenne lo sbarco a Ceuta dove il re Giovanni I, insieme ai
suoi tre figli Enrico3, Edoardo4e Pietro5, conquistò la città in un’unica giornata
incorporandola così alla corona portoghese e mettendo in fuga i suoi abitanti. La città
venne completamente saccheggiata da parte della compagnia portoghese e,
successivamente, il re ordinò che venisse purificata la moschea principale della città con
1 Giovanni d'Aviz detto il Buono o il Grande (Lisbona 11/04/1358 – Ibídem 14/08/1433). 2 Gregorio XII, il cui vero nome era Angelo Correr (Venezia, 1335 circa – Recanati, 18/10/1417). 3 Enrico di Aviz, detto Enrico il Navigatore o principe di Sagres (Porto, 04/03/1394 – Sagres,
13/11/1460). 4 Pietro di Aviz o principe Pietro delle Sette Parti (del Mondo) (Lisbona, 09/12/1392 – Vila Franca de
Xira, 20/05/1449). 5 Edoardo di Aviz detto Edoardo il Filosofo o l'Eloquente (Viseu, 31/10/1391 – Tomar, 09 settembre
1438).
6
lo scopo di consacrarla come chiesa e celebrare un Te Deum come ringraziamento per la
vittoria cristiana avvenuta.
Ceuta rimase per molti anni l’unica piazzaforte portoghese forte del Nordafrica
fino alla conquista di Alcazarsegher nel 1458. Nonostante ciò, la vita a Ceuta era
tutt’altro che facile; essa spesso era oggetto di scaramucce e assedi da parte delle
popolazioni stanziate nelle aree circostanti. Inoltre la produzione locale di prodotti di
prima necessità era insufficiente a sfamare l’intera popolazione, la quale era costretta a
dipendere dall’approvvigionamento peninsulare. Non è un caso che l’infante Pietro nel
1425 espose i suoi dubbi mostrando perplessità sulla necessità di mantenere il controllo
di Ceuta, aggiungendo che anche in Inghilterra si vociferava che sarebbe stato un errore
tenere la città (Saraiva 2004: 102).
Il 12 settembre del 1578 morì nella battaglia di Alcázarquivir il re portoghese
don Sebastiano6 il quale non aveva né discendenti né fratelli. Il trono passò quindi
all’anziano cardinale Enrico, nonché zio di suo padre Giovanni7. Il cardinale don
Enrico8, però, ricevette la corona all’età di 64 anni. Egli era malato e anch’esso senza
discendenti. Alla sua morte, il trono portoghese passò così al re Filippo II di Spagna9, in
quanto figlio di Isabella del Portogallo10. Il sovrano assunse il nome di Filippo I del
Portogallo (Saraiva 2004: 143).
Inizia così un periodo storico compreso fra il 1580 e il 1640 che vede l’unione
della Corona del Portogallo alla Corona di Spagna con a capo la Casa d’Asburgo.
La Spagna era prima di tutto interessata a mantenere il possesso dei territori
portoghesi situati nel Nordafrica, oltre Ceuta, Arcila, Tangeri, Mazagan e Ceuta, sia per
motivi di prestigio sia per motivi economici e di sicurezza di fronte ai continui attacchi
dei marocchini.
Il nuovo sovrano Filippo I insistette molto sulla difesa della città di Ceuta e sulla
protezione dei suoi abitanti, per questo motivo venne, in un primo momento, accolto
calorosamente dal popolo e dichiarato legittimo il titolo di re del Portogallo.
Tuttavia, la partecipazione della Spagna alla Guerra dei Trent’Anni avrebbe fatto
insorgere lamentele da parte dei portoghesi per l’impiego dei propri soldati per conflitti
6 Sebastiano I di Aviz detto il Desiderato ( Lisbona, 20/01/1554 – Alcazarquivir, 04/08/1578). 7 Giovanni Manuele d'Aviz (Évora, 03/06/1537 – Lisbona, 02/01/1554). 8 Enrico I del Portogallo (Lisbona, 31/01/1512 – Almeirim, 31/01/1580). 9 Filippo II d'Asburgo (Valladolid, 21/05/1527 – San Lorenzo de El Escorial, 13/09/1598) 10 Isabella d'Aviz (Lisbona, 24/10/1503 – Toledo, 01/05/1539).
7
di puro interesse della monarchia di Spagna. In particolare, il conte di Olivares11, primo
ministro del regno di Spagna, insisteva nel progetto di far partecipare tutti i regni della
monarchia asburgica alle guerre che essa aveva in Europa. Questo piano, conosciuto
come l’Unione delle Armi, scatenò nel 1640 diverse rivolte del sistema imperiale
iberico, fra le quali le sommosse in Portogallo che sfociarono nella sua indipendenza.
Proprio per questo motivo, si verificò una ribellione contro la Casa d’Asburgo e
a favore di Giovanni IV della famiglia Braganza12, disposto, a sua volta, a diventare il
nuovo re del Portogallo.
Il re Filippo IV provò in varie occasioni a dissuadere il duca di Braganza
offrendogli incarichi importanti in diverse corti europee, ma questi sempre rifiutò. Così,
approfittando delle rivoluzioni presenti nello stesso anno in Catalogna, i portoghesi
presero le armi a favore del duca di Braganza e lo proclamarono re del Portogallo con il
nome di Giovanni IV (Villada Paredes 2009: 15 – 23).
L’istituzione politica portoghese allora vigente riconobbe subito Giovanni IV
quale legittimo sovrano del Paese e lo stesso fecero i governatori dei territori
d’oltremare, ad eccezione di Ceuta (AA.VV. 1989: 237).
Le notizie della sommossa del Portogallo arrivarono a Ceuta nel febbraio del
1641. Il re Giovanni IV cercò di convincere Ceuta a riconoscerlo come suo nuovo
sovrano inviando dal Portogallo un carico di alimenti, munizioni e denaro proveniente
dal Portogallo, rifiutato a sua volta dagli abitanti di Ceuta.
Secondo lo storico Carmona, i portoghesi di Ceuta non si unirono alla sommossa
perché erano riconoscenti degli aiuti e del costante invio di contingenti militari, del
materiale bellico e del rifornimento di alimenti e denaro proveniente dall’Andalusia
(Carmona cit. in Villada Paredes 2009: 24).
La formale integrazione di Ceuta nel regno di Spagna avvenne tuttavia solo nel
1668 attraverso il Tratado de Lisboa, anche se già negli anni quaranta dello stesso
secolo la città stava subendo un processo di “spagnolizzazione” spinto dai governatori a
favore del potere spagnolo. Il 30 aprile 1656 il re Filippo IV ottenne definitivamente il
11 Gaspar de Guzmán y Pimentel Ribera y Velasco de Tovar, conte di Olivares e duca di Sanlúcar (Roma,
06/01/1587 – Toro, 22/06/1645). 12 Giovanni IV di Braganza, detto il Fortunato (Vila Viçosa, 18/03/1604 – Lisbona, 06/10/1656).
8
controllo della città di Ceuta e, come detto, attraverso il Tratado de Lisboa13 del 1668
tra Spagna e Portogallo, tale annessione fu riconosciuta a livello internazionale.
Da questo momento, Ceuta diventò a tutti gli effetti una città spagnola anche se
essa conservava molte abitudini portoghesi quali, ad esempio, l’utilizzo di documenti in
lingua portoghese fino alla fine del XVII secolo. L’incorporazione di Ceuta alla Corona
di Castiglia sarà accolta con piacere, per questo venne conferito alla città il titolo di
“Siempre Noble, Leal y Fidelísima”. Fra il 1640 e il 1700, Ceuta subì molti attacchi da
parte delle tribù berbere stanziate nell’entroterra. A causa di ciò, le autorità iniziarono a
sviluppare parapetti, trincee, cave e artifici che in un primo momento si dimostrarono
efficaci a contenere gli attacchi.
Nella primavera del 1656 si accesero le ostilità fra l’Inghilterra e la Spagna.
Infatti, gli inglesi aspiravano al controllo dello Stretto e da lì minacciare l’egemonia
spagnola sul mar Mediterraneo. Inoltre, tra i progetti inglesi, vi fu una collaborazione
con i magrebini con lo scopo di espellere definitivamente gli spagnoli da Ceuta. La
situazione peggiorò ulteriormente quando il Portogallo cedette Tangeri a Carlo II
d’Inghilterra14 rendendo gli inglesi pericolosamente vicini ai territori spagnoli.
Il tutto finì però con un tacito accordo fra i due paesi al fronte della necessità di
una reciproca alleanza contro la minaccia dell’espansionismo francese e la volontà del
sultano Isma’il15 di voler espellere tutti gli europei dal Nordafrica (Villada Paredes
2009: 29 – 33).
Perciò, il XVIII secolo iniziò con un lungo assedio alla città di Ceuta da parte
delle truppe marocchine; gli attacchi marocchini e i contrattacchi spagnoli durarono più
di trent’anni (dal 1694 al 1727). In quegli anni l’importanza di Ceuta continuò a
crescere diventando il principale centro di difesa di piazzeforti marittime spagnole sulla
costa nord africana dato che la Spagna non poteva più contare sui porti di Napoli,
Messina, Cagliari e Orano, città perse durante la Guerra di Successione, oltre al
territorio di Gibilterra ceduto all’Inghilterra per mezzo del Tratado de Utrecht, firmato
l’11 aprile del 1713 (Lynch 2009: 37).
13 Con il Tratado de Lisboa del 1668 avviene il riconoscimento da parte spagnola della sovranità della
nuova dinastia del Portogallo, la casa Reale di Braganza. 14 Carlo II Stuart (Londra, 29/05/1630 – Londra, 6/02/1685). 15 Mulay Ismāʿīl ibn ʿAlī al-Sharīf (Sigilmassa, 1645 – Meknes, 22/03/1727).
9
Nella prima metà del XVIII secolo, a causa dei continui assedi, blocchi navali,
epidemie di peste e difficoltà di ogni tipo, a Ceuta si misero in marcia importanti
cambiamenti in tutti gli ambiti: si riorganizzarono le unità militari, fu migliorata la
milizia armata e fu creato il Reggimento Fijo di Ceuta (Villada Paredes 2009: 68).
A metà del XVIII secolo, salì al trono marocchino Muhammad Ben Abdallah
Muhammad III16, il quale intraprese una politica di apertura verso i paesi europei.
Questo monarca si dimostrò disponibile nei confronti degli stati europei circostanti,
orientando la sua politica verso la modernizzazione del Marocco. Alla base della
modernizzazione del paese vi era l’apertura dello stesso verso il commercio estero.
Infatti, nel 1767, venne firmato il Tratado Hispano-Marroquí de Amistad y Comercio
fra la Spagna e il Marocco che consentiva ad entrambi i paesi libertà di navigazione,
pesca e commercio lungo le rispettive coste. La pace tuttavia non durò a lungo, infatti,
nel 1773, in seguito alla morte del monarca marocchino, le tensioni e gli episodi bellici
fra Spagna e Marocco si riaccesero, anche se un nuovo Tratado de Paz del 1799 riportò
l’equilibrio fra i due paesi (Comellas 2003: 215).
Nella seconda metà del XVIII secolo, l’economia di Ceuta aveva nondimeno
cominciato a crescere come mai aveva fatto fino ad allora.
La dinastia borbonica si dimostrò infatti molto interessata alla difesa di Ceuta.
Per questo motivo decise di dotarla permanentemente di una nutrita guarnigione sia per
difenderla dagli attacchi provenienti dal Nordafrica, sia per contrastare la presenza
inglese a Gibilterra.
Ceuta così diventò un insediamento militare nel quale il numero dei civili era
nettamente inferiore rispetto al numero dei militari, infatti, nel 1789 si contavano circa
1.200 uomini del commando armato (Villada Paredes 2009: 72 – 73).
Se l’esercito e le fortificazioni garantivano la difesa degli abitanti di Ceuta, la
Chiesa si occupava della loro fede. Di fatti, in quell’epoca la popolazione spagnola era
molto religiosa e tutte le attività quotidiane erano scandite dalla religione. La Chiesa,
perciò, aveva il compito di gestire l’educazione e la sanità.
La terza importante istituzione di Ceuta fu la Junta de Abastos, creata nel 1731
con il cui compito era di gestire e garantire le necessità alimentari e materiali della
popolazione civile e militare di Ceuta (Villada Paredes 2009: 74 – 76).
16 Muhammad III, o Muhammad ibn Abd Allah (1710 – 9/04/1790).
10
Durante il XIX secolo, la potenza francese era molto forte e dominante in
Europa e ogni iniziativa presa dai loro governanti incideva in qualche modo sulla
politica spagnola.
Nel 1807 Napoleone17, primo console del nuovo governo francese, obbliga Carlo
IV a dichiarare guerra al Portogallo. Il primo ministro spagnolo Godoy18 non appoggia
il progetto francese per cui spinge verso l’avvicinamento all’Inghilterra. In seguito però,
vedendo i successi ottenuti dall’esercito francese, Godoy ritratta e torna ad appoggiare
la Francia.
Ceuta in questi anni non solo dovrà prestare attenzione verso ciò che accade
nella penisola spagnola, ma dovrà anche occuparsi dei problemi economici che
riguardano l’approvvigionamento oltre alle epidemie che devastano Cadice e i territori
africani circostanti. Il Marocco, d’altro canto, è sempre in attesa di un momento di crisi
che possa andare a suo favore per impossessarsi di Ceuta senza dover ricorrere a un
attacco alla guarnigione (Villada Paredes 2009: 122 – 126).
Il 4 maggio 1808 il re Carlo IV e suo figlio Fernando VII19 abdicano a favore
della casa Bonaparte. Al trono sale Giuseppe Bonaparte20, fratello di Napoleone
Bonaparte, proposto dal Consiglio di Castiglia.
La popolazione spagnola era contraria all’occupazione francese e questo
malcontento sfociò in rivolte e in una guerra per l’indipendenza che durò sei anni.
Ceuta, come tutta la provincia di Cadice, manterrà lealtà a Fernando VII e vedrà
arrivare alcune delle sue unità a protezione della città.
La situazione inizia a precipitare all’inizio del 1810 con l’invasione da parte
francese dell’Andalusia. Ceuta, però, può ritenersi fortunata perché può contare su una
buona fortificazione nel caso di un attacco francese oltre all’aiuto da parte inglese di un
rafforzamento della guarnigione con un reggimento britannico a Gibilterra (Villada
Paredes 2009: 126).
Finalmente, nel 1813, l’esercito lealista spagnolo respinse l’ultima offensiva
francese a Vitoria e a San Marcial obbligando i francesi ad abbandonare la penisola
17 Napoleone Bonaparte (Ajaccio, 15/08/1769 – Isola di Sant'Elena, 05/05/1821). 18 Manuel Francisco Domingo Godoy Álvarez de Faria Ríos Sánchez Zarzosa (Badajoz, 12/05/1767 –
Parigi, 07/10/1851). 19 Ferdinando VII di Borbone (San Lorenzo de El Escorial, 14/10/1784 – Madrid, 29/09/1833). 20 José I Bonaparte o José Napoleón I (Corte, 07/01/1768-Florencia, 28/07/1844).
11
iberica. Così nel 1814 venne restaurata la monarchia con il ritorno di Fernando VII al
trono di Spagna.
Nel 1827, Ceuta, da semplice città, passa ufficialmente a rivestire il ruolo di
municipio governato da un presidente, tre consiglieri, un sindaco e due deputati. Questa
nuova posizione permetterà a Ceuta di vedere nascere importanti cambiamenti e
sviluppi nella città quali ad esempio la costruzione di un nuovo mercato, di un cimitero
e la denominazione stradale.
La città di Ceuta fu anche coinvolta nelle guerre carliste che afflissero la Spagna
per diversi anni nel corso del XIX secolo. Durante la prima guerra carlista non era raro
vedere a Ceuta cartelli affissi in luoghi pubblici in cui si osannavano gli ideali liberali;
inoltre ci furono molti militari guidati da generali liberali che parteciparono alle guerre
civili. Tale contributo venne riconosciuto dal regno di Spagna attraverso medaglie
d’onore (Villada Paredes 2009: 139 – 140).
Durante il periodo in cui regna Isabella II (1833 – 1868), si verifica un lento
aumento della popolazione di Ceuta proveniente da Cadice e Malaga.
Nel 1840 venne instaurato il Registro Civile Municipale e nel 1841 Ceuta viene
dichiara ufficialmente territorio spagnolo d’oltremare.
Il 7 ottobre 1844 venne firmato l’Atto di esecuzione nel quale venivano stabiliti i
limiti territoriali di Ceuta. La demarcazione territoriale costruiva un aspetto di
fondamentale importanza per gli abitanti di Ceuta poiché stabiliva i confini tra il
territorio spagnolo e quello marocchino.
Nel frattempo, il malcontento e i periodi di crisi alimentare sembrano non
cessare; nel 1847 torna nuovamente a non essere sufficiente la farina tanto da
costringere il municipio a chiedere farina a Gibilterra per assicurare una regolare
somministrazione di pane alla popolazione.
In questi anni, il rapporto di pace con il Marocco è altalenante; l’ennesimo
episodio di contrasto avverrà nel 1859. La causa di tale contrasto fu la distruzione della
fortificazione che la Spagna aveva fatto costruire per proteggere i confini di Ceuta. Di
fatti, la tribù Anyera, situata nei terreni contigui a Ceuta, considerava la fortificazione
un’intromissione abusiva nel territorio marocchino e per questo motivo la distrusse.
Come risposta a questo comportamento, il governo spagnolo impose una serie di
richieste quali: la consegna dei responsabili, l’ampliamento territoriale e la
12
fortificazione dei monti vicini. Il rifiuto del Marocco a tali richieste aprì una guerra tra i
due paesi che durerà un anno (Crespo Redondo 1994: 162). La guerra finirà con un
trattato di pace richiesto dal Marocco, dove all’articolo tre dello stesso, si dichiara che il
re del Marocco cede alla regina della Spagna il pieno dominio di tutto il territorio di
Ceuta (Villada Paredes 2009: 158).
Nel 1860, la Spagna esercitava indisturbata il proprio potere sui territori
settentrionali dell’odierno Marocco e avrebbe potuto anche espandere i propri domini se
solo la Gran Bretagna non avesse minacciato un intervento militare qualora gli spagnoli
avessero esteso ulteriormente i propri domini nel Nordafrica, poiché non voleva nemici
vicino allo Stretto dominato dagli inglesi (Comellas 2002: 206).
Negli anni settanta, la Spagna sperimenterà per la prima volta nella sua storia
l’abbandono della monarchia per abbracciare una nuova forma di governo, ossia la
repubblica. Infatti, nel 1871 il re Amedeo I21 della casa Savoia sale al trono dopo
l’uscita di scena della regina Isabella II. Il regno però ebbe vita breve, poiché il re si
trovò privo del consenso popolare e nel 1873 fu costretto a rinunciare al trono di
Spagna.
Così, l’11 febbraio alla notizia dell’abdicazione del re, l’Assemblea Nazionale si
riunì per votare il futuro del Paese; perció qualche ora dopo la caduta della monarchia
venne proclamata la Prima Repubblica di Spagna. Il consenso fu piuttosto alto
considerando che 256 furono i voti a favore e solo 32 votanti si dimostrarono contrari
(Tuñón de Lara 2000a: 12).
La prima repubblica spagnola ebbe però una breve durata e in essa si
succedettero quattro presidenti durante gli undici mesi di governo prima del colpo di
stato che portò definitivamente alla fine della repubblica nel 1874.
Poco si sa di quello che avvenne a Ceuta in questi anni, poiché sono arrivati a
noi pochi documenti. Tuttavia possiamo dire che durante questo periodo di transizione
politica, fu data poca attenzione ai possedimenti spagnoli nel Nordafrica.
Nel 1874 venne restaurata la monarchia e Alfonso XII22 salì al trono di Spagna.
Nei primi mesi della restaurazione ci furono cambiamenti importanti nel fronte africano:
il 27 luglio fu creato il Reggimento d’Africa e fu aumentata la guarnigione (Villada
Paredes 2009: 161 – 173).
21 Amedeo Ferdinando Maria di Savoia (Torino, 30/05/1845 – Torino, 18/01/1890). 22 Alfonso XII di Borbone (Madrid, 28/11/1857 – Madrid, 25/11/1885).
13
La Restaurazione diede un forte impulso allo sviluppo industriale, oltre alla
costruzione di nuove strade ferrate e servizi pubblici in tutta la Penisola (Vives 1966:
147).
Dagli anni ottata iniziano importanti cambiamenti anche nella città di Ceuta: nel
1884 il re Alfonso XII autorizzò la costruzione del porto di Ceuta e un importante
lavoro di fortificazione; nel 1891 venne inaugurata a Ceuta la prima stazione telegrafica
di Ceuta che permetteva di mettere in comunicazione i suoi cittadini con la Penisola
(Villada Paredes 2009: 174).
1.2. Dal XX secolo a oggi
All’inizio del XX secolo a Ceuta vi erano 13.269 abitanti. La popolazione era
molto giovane e caratterizzata da una grande sproporzione tra uomini e donne dovuto
alla presenza di numerosi militari.
Proprio in questi anni inizia a svilupparsi un intenso movimento migratorio che
permetterà una crescita demografica e un bilanciamento numerico dei sessi, dovuto
principalmente al ricongiungimento familiare oltre che all’incremento delle nascite.
Le principali attività lavorative del momento sono il commercio, la pesca, la
costruzione edile, le attività artigianali e le piccole industrie che soddisfano le necessità
primarie. I prodotti agricoli di Ceuta sono principalmente il grano, le barbabietole, gli
ortaggi e la frutta. Tuttavia, la maggior parte dei prodotti alimentari proviene dal
Marocco, dalla metropoli spagnola o da altri paesi. Molto più importante è l’attività
ittica, che occupa più del 14% delle attività totali.
La crescente immigrazione portò a Ceuta moltissima manodopera non
qualificata che venne introdotta nel mondo del lavoro con salari molto bassi e in
condizioni di vita precarie. Tutti questi problemi, sommati alla crisi della Prima Guerra
Mondiale, portarono a una presa di coscienza della classe operaia in merito alle loro
condizioni socioeconomiche: tra il 1917 e il 1921 apparsero anche a Ceuta le prime
organizzazioni proletarie e nel 1919 avvenne il primo sciopero (Villada Paredes 2009:
214 – 224).
Gli anni che vanno dal 1923 al 1930, segnati dalla dittatura di Primo de Rivera23
portarono a dei miglioramenti nella città di Ceuta, come ad esempio l’estensione del
23 Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (Jerez de la Frontera, 08/09/1870 – Parigi, 16/03/1930).
14
telefono, l’aumento delle automobili in circolazione, la nascita dell’Associazione
Hispano-Ebrea e l’arrivo di nuove istituzioni bancarie. Anche l’istruzione pubblica
cominciò a migliorare grazie all’aumento del numero di scuole, passando nel 1930 a
essere 34 di cui 22 pubbliche. Durante gli anni della dittatura la situazione sanitaria
denota un lieve miglioramento grazie anche all’apertura dell’ospedale militare
O’Donnell nel 1926. Tuttavia, la città era ancora afflitta dalla tubercolosi e dalla
denutrizione che rappresentavano una costante minaccia per la popolazione (Villada
Paredes 2009: 240 – 241).
Tra il 1931 e il 1940 si verificarono, com’è ben noto, in Spagna due importanti
periodi dal punto di vista politico: nel 1931 ha inizio la seconda repubblica spagnola
mentre nel 1936 ha inizio la Guerra Civile. In questi anni il numero della popolazione di
Ceuta andò aumentando, raggiungendo i 52.528 abitanti nel 1936 e i 59.115 abitanti nel
1940.
Nonostante il settore dell’edilizia stesse vivendo un periodo di crisi, l’attività
portuale conobbe un importante sviluppo negli anni repubblicani, così come l’attività
peschereccia la cui esportazione era diretta principalmente verso il mercato italiano.
Tuttavia, nonostante i grandi passi avanti intrapresi dalla città di Ceuta, la
maggioranza della popolazione viveva ancora nella povertà più assoluta. I suoi cittadini
andavano mal vestiti, erano malnutriti e vivevano in abitazioni sporche prive di servizi
igienici. Nel 1933 la beneficienza municipale si occupava di oltre 2.238 persone.
Proprio in questi anni arrivano a Ceuta le più importanti organizzazioni dei lavoratori
quali la Unión General de Trabajadores (UGT) e la Confederación Nacional del
Trabajo (CNT) (Villada Paredes 2009: 252 – 257).
Si possono distinguere quattro tappe nell’evoluzione della vita politica di Ceuta
durante la seconda Repubblica: la prima tappa si estese nei mesi fra l’aprile e l’ottobre
del 1931 e fu caratterizzata dall’unione Repubblicano - Socialista. Le principali
realizzazioni di questo periodo furono: la creazione di venti nuove scuole, la costruzione
di una scuola media superiore, la creazione della giunta di Assistenza Sociale e la messa
in marcia di riforme per la limitazione della disoccupazione.
Una seconda tappa si sviluppò tra il 1931 al 1933 e fu caratterizzata da un
governo formato da radicali – socialisti e dal partito PSOE oltre che dall’appoggio della
15
città al governo Azaña24. In questi anni fra le più importanti realizzazioni a Ceuta ci
saranno la costruzione del Campo Municipale dello Sport (1932) e la creazione e lo
sviluppo della Commissione Interministeriale per la Riforma Tributaria e
Amministrativa della Piazza di Soberanía (1932).
La terza tappa durò tre anni, dal 1933 al 1936, e fu caratterizzata dai tagli alla
spesa sociale, dalla privatizzazione dei servizi municipali quali l’esattoria e la pulizia e
dalla celebrazione della Fiera Campionaria Hispano - Marocchina (1934 - 1935).
La quarta e ultima tappa durò pochi mesi, dal febbraio al luglio dell’anno 1936,
con al governo il Fronte Popolare. In quegli anni, Sánchez-Prado25 fu il sindaco di
Ceuta e le sue principali iniziative furono: la costruzione di trecento case, il
rafforzamento della beneficienza municipale, l’ispezione sanitaria nelle baraccopoli e la
realizzazione delle opere di bonifica (Villada Paredes 2009: 262 – 263).
Sempre durante gli anni repubblicani, attraverso un decreto del 1931, Ceuta si
vede per la prima volta rappresentata nelle Cortes españolas, con circoscrizione
elettorale propria per l’elezione di un deputato. Sánchez-Prado sarà il primo deputato
proveniente da Ceuta. I suoi interventi parlamentari furono diretti alla difesa degli
interessi della propria città, ad esempio: la concessione del monopolio del tabacco, la
denuncia per la grave situazione sociale e per la crisi economica che stava attraversando
la città, la difesa della conservazione della circoscrizione elettorale di Ceuta,
l’indipendenza da Cadice e la configurazione definitiva dell’articolo 8 della
Costituzione secondo cui i territori spagnoli nel Nordafrica possano organizzarsi
autonomamente in relazione diretta al potere centrale.
Nel luglio del 1936 ha inizio la guerra civile spagnola.
Tra il 17 e il 18 luglio del 1936 Ceuta venne occupata dai militari che si
sollevarono contro il governo di Madrid, e in generale, contro la Repubblica. Ceuta non
oppose resistenza permettendo così alle truppe del Generale Franco26 di entrare nella
città. Alcuni militari leali al governo e alcune personalità del Fonte Popolare, come
Sánchez-Prado, vennero successivamente fucilati dai nazionalisti. Tra il luglio del 1936
e il gennaio del 1937, furono uccise impunemente 107 persone a Ceuta. A queste
vittime vanno sommate le oltre 160 persone condannate a morte in seguito a processi
24 Manuel Azaña Diaz (Madrid, 10/01/1880 – Montauban, 03/11/1940). 25 Antonio López Sánchez-Prado (Herrera, Siviglia, 04/05/1888 - Ceuta, 5/09/1936). 26 Francisco Franco y Bahamonde (Ferrol, 04/12/1892 – Madrid, 20/11/1975).
16
fittizi, celebrati illegalmente e senza garanzie processuali. La repressione coinvolse non
solo i militari che si rifiutavano di aderire all’insurrezione, ma anche i dirigenti delle
organizzazioni operaie e i partiti della sinistra repubblicana. In totale, più di 700
cittadini di Ceuta furono detenuti e patirono le dure pene della prigione. Alcuni di essi
riuscirono a fuggire imboccando la via dell’esilio; molti altri rimasero a Ceuta e
dovettero subire la sistematica repressione civile esercitata dai tribunali filonazisti.
Il 1° aprile del 1939 crolla definitivamente la repubblica spagnola e inizia la
dittatura del generale Francisco Franco, dittatura che durò fino al 1975 (Villada Paredes
2009: 273 – 275).
A differenza di altre città spagnole, date le premesse sopra descritte,
l’opposizione di Ceuta contro il regime dittatoriale fu debole e quasi inesistente.
Durante questi anni, Ceuta sarà caratterizzata da flussi immigratori ed emigratori
che modificheranno costantemente la numerosità della sua popolazione. Tra il 1941 e il
1950 ci fu per esempio un saldo migratorio che portò alla perdita di 5.443 abitanti; nel
decennio successivo, invece, ci fu un importante processo immigratorio che fece
aumentare la popolazione a 73.000 abitanti. Infine, tra il 1961 e il 1970 si verificò una
fortissima emigrazione che portò alla perdita di 15.478 persone dirette alla penisola
spagnola o all’estero.
Per quanto riguarda l’istruzione, il tasso di analfabetismo è in continua discesa
arrivando al 15,5% della popolazione nel 1970. Al contrario, la sanità non ottenne
altrettanti successi quanto l’istruzione; il servizio sanitario fu completamente trascurato
dalle amministrazioni ed è solo grazie alla Croce Rossa se in questi anni si vedrà
l’apertura di un nuovo ospedale nel 1969 che andrà a sostituire il vecchio ospedale Jesus
y María aperto nel 1918.
L’economia conobbe una lenta crescita negli anni successivi alla fine della
guerra civile; le esportazioni erano dirette principalmente verso l’estero (79,5%), ma
anche in direzione delle isole Canarie, Melilla e altri territori spagnoli in Africa. Inoltre,
proprio in questi anni nasce la cosiddetta “economia del bazar” che consisteva nella
vendita di una vasta gamma di prodotti alle migliaia di acquirenti peninsulari che
quotidianamente attraversavano lo Stretto. Lo scopo di questa economia era quello di
vendere prodotti alimentari, tessili e manifatturieri a prezzi più bassi rispetto alla
Penisola.
17
Dalla fine della guerra civile, Ceuta stava intraprendendo, seppur lentamente, dei
grandi cambiamenti che andranno a modificare l’intera struttura della città. Ciò fu
possibile grazie anche all’aumento della classe media e a quello di manodopera
qualificata e alla conseguente diminuzione di operai non qualificati.
Tuttavia, il periodo post-bellico fu molto duro per i cittadini di Ceuta; nei primi
vent’anni successivi alla guerra civile gli abitanti dovettero affrontare nuovamente il
problema delle carestie.
Il 1941 fu l’anno contraddistinto per il triste record di mortalità tra i cittadini di
Ceuta, con 1.108 morti, addirittura superiori ai deceduti in tempo di guerra. Le cause di
morte furono principalmente suicidio o malattie legate alla fame, alla mancanza d’igiene
e alla miseria.
Il costo della vita moderò la sua crescita soltanto nel 1959 attraverso il Piano di
Stabilità (Villada Paredes 2009: 288 – 300).
Intanto, nel 1956 il Marocco era diventato uno stato indipendente senza mai
abbandonare l’idea d’inglobare nel suo territorio Ceuta e Melilla, arrivando anche a
ufficializzare la rivendicazione sulle due città all’ONU.
L’11 novembre del 1960, il delegato marocchino Ali Skalli esigette che
entrambe le città figurassero nella dichiarazione spagnola come “Territori non
autonomi”, soggetti a futura decolonizzazione, senza però mai riuscire a raggiungere il
suo obiettivo. La questione rimase sospesa per diversi anni finché nel 1975 il
rappresentante permanente dell’ONU, Slaoui, diresse una lettera al presidente della
Commissione sollecitando che le città di Ceuta e Melilla venissero dichiarate “Territori
non autonomi” con lo scopo di procedere con la decolonizzazione. Tale richiesta venne
rifiutata classificandola come un mezzo volto a ledere l’integrità dello stato spagnolo. Il
7 marzo dello stesso anno, il Marocco contrattacca inviando all’ONU una lettera con le
sue motivazioni; lo stesso fece la Spagna il 22 aprile. Tuttavia l’ONU rimandò la
questione anche se poi il tema non venne più affrontato. Il 26 giugno del medesimo
anno furono piazzate a Ceuta due bombe che causarono la morte di un cittadino e
parecchi feriti. Questo fu un chiaro avvertimento affinché la Spagna modificasse la sua
posizione riguardo Ceuta e Melilla. Nonostante ciò, il Marocco negò sempre una sua
responsabilità sui fatti accaduti (Villada Paredes 2009: 308 – 309).
18
Gli anni successivi, dal 1975 al 2000, sono definiti gli anni della transizione e
del nuovo regime democratico. Infatti, nel 1973 il generale Franco, vecchio e malato,
inizia ad ammalarsi così decise di cedere il potere all’ammiraglio Luis Carrero Blanco27
che però pochi mesi dopo morì in seguito ad un attentato da parte dell’ETA.
Il suo posto venne preso da Carlos Arias Navarro28, il quale cercò di sostenere il
regime ormai in decadenza: di fatti, la Spagna non era più la stessa del periodo del dopo
guerra.
Grazie alle trasformazioni socio-economiche e culturali indotte dal boom degli
anni 60, il paese aveva ormai una nuova ambizione, ossia quella di indirizzarsi verso i
modelli statali già presenti in Europa, abbandonando la politica dell’isolazionismo per
abbracciare la democrazia.
Nel frattempo la salute del generale Franco, affetto dal morbo di Parkinson, si fa
sempre più cagionevole finché, il 20 novembre del 1975, muore a Madrid.
Dopo la morte di Francisco Franco, il 22 novembre dello stesso anno Juan
Carlos I29 fu incoronato re di Spagna, gettando le premesse per la transizione della
Spagna verso la democrazia.
La vita quotidiana dei cittadini di Ceuta andrà incontro a profonde
trasformazioni nel periodo democratico, come risultato dell’accelerato processo di
cambiamento culturale che la società spagnola avrà modo di sperimentare in questi anni.
Durante questo periodo continuano a registrarsi a Ceuta i flussi di emigrazione
iniziati negli anni sessanta, anche se si denota un lieve calo. Al contempo, il tasso di
natalità mantiene una media piuttosto alta trovandosi al di sopra della media nazionale.
Per quanto riguarda il livello d’istruzione, la città mantiene un alto indice di
analfabetismo rispetto alla media nazionale, con il 7,33% di tutta la popolazione
maggiore di dieci anni d’età (nella Penisola la media è del 2,53%). Ci sarà, tuttavia, un
aumento per quanto riguarda il numero delle scuole nella città arrivando a un totale di
251 pubbliche e 80 private. Inoltre, verranno istituite due facoltà universitarie in
collaborazione con l’Università di Granada quali Grado de Maestro en Educación
Infantil, Grado de Maestro en Educación Primaria e Grado en Ingeniería Informática.
27 Luis Carrero Blanco (Santoña, 04/03/1904 – Madrid, 20/12/1973). 28 Carlos Arias Navarro (Madrid, 11/12/1908 – Madrid, 27/10/1989). 29 Juan Carlos di Borbone (Roma, 05/01/1938).
19
Anche il settore sanitario ha fatto progressi, infatti, negli anni ottanta furono
istituiti tre centri di salute e ci fu un aumento del personale nelle strutture sanitarie.
Dal punto di vista economico, Ceuta avrà degli alti e bassi. La cosiddetta
“economia del bazar”, che aveva arricchito la città negli anni sessanta, entrò in crisi a
causa di una serie di fattori quali: la crisi energetica degli anni settanta, che portò un
aumento dei costi dei trasporti marittimi, l’apertura dei commerci attraverso lo stretto di
Gibilterra nel 1982, che portò a modificare la tratta percorsa dai commercianti e la
progressiva liberalizzazione e apertura dell’economia spagnola che permetteva a
quest’ultima di commerciare con altri paesi. Tuttavia, il flusso commerciale non cessò,
indirizzando principalmente le sue attività verso il Marocco.
È importante sottolineare il fatto che il traffico commerciale era rimasto
principalmente d’importazione piuttosto che d’esportazione.
Il porto continuava a rappresentare un’importante fonte di attività economica,
anche se il ritmo di crescita era sostanzialmente diminuito. Anche la pesca iniziò a
perdere peso nell’economia di Ceuta e questo a causa della concorrenza con la vendita
di pesce proveniente dal Marocco a prezzi nettamente inferiori.
Ceuta smetterà di essere una città isolata e lontana dall’Europa grazie al
trasporto marittimo e aereo che ebbe modo di svilupparsi in questi anni.
Il settore terziario è quello che presenta una maggiore crescita rispetto al
primario e al secondario. Le sue attività principali sono: il commercio (27%), i trasporti
e la comunicazione (15%), il settore alberghiero e di ristorazione (10,2%). Questo portò
a un profondo squilibrio fra i settori con la conseguente crescita di disoccupazione dei
suoi cittadini (Villada Paredes 2009: 315 – 326).
Il 13 marzo del 1995 venne approvato lo Statuto di Autonomia di Ceuta
mediante la Legge Organica 1/1995.
Ceuta, così come Melilla, prima dell’approvazione dello Statuto di Autonomia,
erano, infatti, città appartenenti alla Comunità Autonoma dell’Andalusia, in seguito,
però, fu presa la decisione di rendere queste due città autonome.
Il primo articolo dello Statuto di Autonomia dichiara quanto segue:
“Ceuta, como parte integrante de la Nación española y dentro de su
indisoluble unidad, accede a su régimen de autogobierno y goza de
20
autonomía para la gestión de sus intereses y de plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines, de conformidad con la Constitución, en los
términos del presente Estatuto y en el marco de la solidaridad entre todos los
territorios de España”30.
Pertanto, Ceuta viene dichiarata città autonoma, potendo quindi godere del
diritto di autogoverno mediante un Consiglio di Stato proprio e di autonomia per la
gestione degli interessi strettamente legati alla città di Ceuta.
Gli organi istituzionali di Ceuta vengono citati nell’articolo 6 del medesimo
statuto. Essi sono: l’Assemblea, il Presidente e il Governo.
La sostanziale differenza fra le comunità autonome spagnole e le città autonome
spagnole risiede nel fatto che quest’ultime non possono svolgere iniziativa legislativa,
ma gli viene comunque loro permesso di richiedere alle Corti le iniziative legislative
che ritengono opportune solo per Ceuta o per Melilla.
Oggi Ceuta è una città abitata da 84000 abitanti: vi convivono diversi credi
religiosi.
2. La storia di Melilla dalla conquista dei Re Cattolici ai giorni nostri
2.1. Dal XV secolo alla fine del XIX secolo
Ceuta non fu l’unico territorio nordafricano in cui si stanziarono gli iberici a
partire dal XV secolo.
Infatti, gli allora re di Spagna31, nutrivano un profondo interesse verso quei
luoghi e la prova ne è il fatto che, nel 1494 venne firmato il Tratado de Tordesillas, che
consentiva la divisione dei territori nell’oceano Atlantico all’interno dei quali la Spagna
e il Portogallo potevano adottare una politica espansionistica. L’interesse esercitato da
Melilla sui sovrani spagnoli, in particolare Ferdinando d’Aragona, era dovuto al fatto
30 Estatuto de Autonomía de Ceuta. Tratto da: www.congreso.es.
http://www.congreso.es/consti/estatutos/estatutos.jsp?com=80&tipo=2&ini=1&fin=5&ini_sub=1&fin_su
b=1 (Consultato in data 18/01/2015) 31 Isabella di Trastámara o Isabella I di Castiglia o Isabella la Cattolica (Madrigal de las Altas Torres,
22/04/1451 – Medina del Campo, 26/11/1504) e Ferdinando di Trastàmara (Sos, 10/03/1452 –
Madrigalejo, 23/01/1516), anche comunemente chiamati “Re Cattolici”.
21
che essa aveva una grande importanza strategica, sia nel Mediterraneo che nella regione
nordafricana. (AA.VV. 1989: 189).
Sebbene si fosse stabilito che il regno di Fez entrasse a far parte dell’influenza
portoghese, tuttavia si autorizzò ai Re Cattolici a conquistare la città di Melilla da cui
era possibile avviare un’espansione verso il Nordafrica. Al contempo, il Papa
Alessandro VI32 concesse una bolla delle Santissime Crociate che permetteva ai Re
Cattolici di conquistare il Nordafrica oltre alla cessione di mezzi economici per
intraprendere tale impresa.
Prima di dare inizio alle spedizioni, tra il 1492 e il 1493 i Re Cattolici
ordinarono al segretario Fernando di Zafra33 di raccogliere informazioni sulla costa
nordafricana. Si realizzarono perciò diversi viaggi di perlustrazione a Melilla, con lo
scopo di analizzare lo stato delle sue fortificazioni e degli edifici oltre che della sua
situazione politica.
I viaggi iniziarono a intensificarsi anno dopo anno, finché nel 1494 venne
negoziata la cessione del territorio con le autorità locali. Nel 1495 il Re Ferdinando
ordina a Martín Fernández Galindo la missione di studiare le possibilità di occupare
Melilla. La città risultò semi abbandonata. Il vero motivo per cui gli abitanti dell’epoca
avevano lasciato Melilla non è chiaro: alcuni sostengono che, siccome la popolazione di
Melilla si era opposta al potere e all’autorità del sultano di Fez34 , lui stesso avesse
distrutto la città. Altri sostengono che Melilla fu distrutta non appena si seppe
dell’arrivo della flotta spagnola. In ogni modo, gli spagnoli si trovarono di fronte un
insediamento in profonda decadenza e con pochi abitanti rimasti. Tali persone
accettarono immediatamente la sovranità spagnola poiché ciò avrebbe loro permesso di
riconquistare lo status anteriore (Bravo Nieto 2004: 7 – 12).
Nel frattempo, venne preparata la spedizione. L’iniziativa di inviare una
spedizione per l’occupazione di Melilla fu dei Re Cattolici, mentre l’esecuzione vera e
propria spettò al Duca di Medina Sidonia35, anche se le fonti bibliografiche non sono
chiare e gli storici si dividono in merito a chi abbia realmente favorito quest’iniziativa.
32 Alessandro VI, nato col nome di Roderic Llançol de Borja, italianizzato Rodrigo Borgia (Xàtiva,
01/01/1431 – Roma, 18/08/1503). 33 Fernando di Zafra (1444 - 1508). 34 Muhammad al-Shaykh al-Wattasi. 35 Con il duca nominato si fa riferimento a Enrique Pérez de Guzmán y Meneses (†1492) che fu il
secondo duca di Medina Sidonia.
22
Il ducato di Medina Sidonia è un casato nobiliare di Spagna il cui primo titolo fu
assegnato nel 1445. Quando Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona diventarono i
Reali di Spagna, il potere del ducato di Medina Sidonia era già affermato. Nonostante
ciò, la monarchia non attaccò mai lo status della casata, ma cercò comunque di
contenere il suo potere. Il ducato di Medina Sidonia mantenne sempre una buona
relazione con il Nordafrica, proprio grazie alla sua influenza che si concentrava
principalmente in Andalusia. Per questi motivi Enrique Pérez, l’allora duca di Medina
Sidonia, si mostrò interessato a Melilla e volle partecipare alla sua conquista.
Stabilire quale figura fu decisiva nell’occupazione di Melilla risulta tuttavia
difficile, e questo a causa di un problema storiografico poiché: i cronisti del Casato di
Medina Sidonia affermano l’autorità del duca e l’approvazione dei re, mentre i cronisti
reali affermano che i Re Cattolici decisero di organizzare il viaggio, intrapreso poi dal
duca di Medina Sidonia. Gli storici, però, ipotizzano che l’atto sia stato eseguito dal
duca e, in concreto, dal militare Pedro de Estopiñán y Virués e che in seguito la presa di
possesso sia stata appoggiata dai Re Cattolici.
Isabella di Castiglia e Ferdinando d’Aragona, avevano molteplici ragioni per
sostenere questa spedizione. In primo luogo, perché essi non avrebbero corso nessun
rischio; infatti, se la spedizione fosse andata a buon fine la monarchia si sarebbe
incaricata del pagamento di una parte dei costi necessari per far fronte all’impresa, in
caso contrario le spese sarebbero state tutte a carico del duca. Secondariamente, perchè i
Re Cattolici avevano già meditato di conquistare Melilla (Bravo Nieto 1990: 19 – 26).
Finalmente nel 1497 partì una spedizione di 5.000 persone e con a capo il
militare Pedro de Estopiñán y Virués. Ufficialmente il 17 settembre venne occupato il
territorio di Melilla (Bravo Nieto 1990: 26 – 27). All’arrivo, il comandante ordinò la
realizzazione di importanti lavori di manutenzione ai quali parteciparono moltissimi
operai. Inoltre, venne ordinato il ripopolamento della città, previo stabilimento con
esattezza del numero di persone che dovevano risiedere a Melilla e i corrispondenti aiuti
economici provenienti da Siviglia e Jerez. In questi primi anni il numero di persone
stabilito oscillava tra i 600 e i 700. La città era retta da un governatore, il quale veniva
seguito da due persone fidate inviate dai Re Cattolici per controllare la situazione e il
suo operato (Bravo Nieto 2004: 11 – 13).
23
Melilla diventerà quindi una fortezza spagnola in territorio africano, sprovvista
di cavalleria e condannata a difendersi dagli attacchi provenienti da Fez potendo
proteggersi esclusivamente grazie alla muraglia che circondava l’insediamento (Bravo
Nieto 1990: 28).
Nei primi anni del XVI secolo, la Spagna inizia a perdere interesse verso i
territori del Nordafrica. L’arrivo degli Asburgo nella Penisola aveva determinato,
infatti, un cambiamento generale della politica spagnola, mettendo in secondo piano le
conquiste oltremare. Come conseguenza, la costa africana smise di essere l’obiettivo
principale dei reali spagnoli per trasformarsi in un vero e proprio problema per la
Spagna, a causa dei continui attacchi da parte dei pirati, dei turchi e dei corsari che
Melilla riceveva.
Proprio per questi motivi, il re Carlo I decise di non continuare il progetto di
conquista delle coste africane. Egli optò piuttosto per la salvaguardia di Melilla dai
frequenti attacchi. La risposta spagnola a tali attacchi fu principalmente difensiva.
Proprio per questo, dal 1516 iniziano una serie di lavori con lo scopo di proteggere e
difendere Melilla. Tra i progetti vi fu l’idea di costruire una muraglia con torri circolari
secondo la tipologia medievale (Bravo Nieto e Uriel 2005: 344 – 345).
Nel 1532 la Spagna perde la fortezza Cazaza, a pochi chilometri da Melilla,
anch’essa amministrata dal duca di Medina Sidonia, anche se meno importante di
Melilla.
Dall’inizio del XVI secolo, l’instabilità interna del regno di Fez aveva creato uno
status di semi-tolleranza nei confronti della presenza spagnola a Melilla. Tuttavia, le
cose cambiarono quando salì al potere una nuova dinastia, la Sadiana, la quale diede
inizio a una serie di guerre contro gli spagnoli e i portoghesi per eliminare
definitivamente la loro presenza dalle coste nordafricane. Infatti, in poco tempo la
dinastia Sadiana riuscì a espellere gli iberici dall’odierna Sidi Ifni nel 1524, da Agadir
nel 1541, da Safi nel 1542 e da Assilah e Alcazarseguer nel 1549.
Il pericolo per Melilla era evidente, per questo motivo la Corona spagnola si
convinse che era necessario intervenire inviando immediatamente materiali bellici,
denaro e un famoso ingegnere dell’epoca, Miguel de Perea. Questo importante
ingegnere arrivò a Melilla il 15 marzo del 1549 e rapidamente ebbero inizio i lavori per
la ristrutturazione delle muraglie (Bravo Nieto e Uriel 2005: 346 – 348).
24
La vita quotidiana a Melilla non era sicuramente facile. La popolazione era
povera e mal nutrita e la mancanza di denaro nel paese era evidente. Melilla nel 1554
aveva solo un ospedale e un’infermiera a disposizione, oltre alla possibilità di ospitare
solo dieci malati. Inoltre l’ospedale era sprovvisto di medicine e alimenti da fornire ai
malati, solo i soldati avevano diritto ai principali mezzi di sussistenza durante il
soggiorno ospedaliero.
Inoltre, erano molte le preoccupazioni di cui il governo di Melilla doveva
occuparsi; il primo problema da gestire era la mancanza di legna. La legna era
fondamentale per cuocere il pane e a Melilla gli alberi erano davvero pochi. Per questo i
suoi abitanti dovevano uscire dalla città per cercare legname altrove, correndo però il
rischio di dover affrontare la popolazione della costa africana. Un altro elemento
fondamentale per la sopravvivenza urbana era l’acqua dolce, e anche questa
scarseggiava (Polo 1986: 18 – 20).
Dal 1556 inizia una nuova tappa per la storia di Melilla, tappa che finirà nel
1667. Si tratta di un periodo piuttosto lungo e complesso in merito al quale si hanno
poche informazioni perché sono pochi i documenti a noi pervenuti. Gli storici hanno in
particolar modo eletto il 1556 come anno d’inizio di questa tappa, poiché in quest’anno
Carlo I abdica in favore del figlio Filippo II e, in secondo luogo, perché il duca di
Medina Sidonia rinuncia definitivamente al controllo di Melilla, essendosi reso conto
che non avrebbe potuto più aspirare all’espansione nelle aree circostanti.
In questo periodo, Melilla alterna periodi di pace e tranquillità a periodi di
profonda crisi. Nella seconda metà del XVI secolo, Madrid e il Sultano Muhammad al-
Shaykh36 stabilirono una pace di fatto; inizia quindi un periodo di tregua durante il
quale Melilla, sia pure solo momentaneamente, non attaccata dalle popolazioni a lei
vicine.
Tuttavia, dopo non molto tempo, Melilla si ritrovò catapultata nel peggior
momento della sua storia da quando è entrata sotto la protezione spagnola. Difatti, dal
1580, la Spagna entrò in una profonda crisi economica che fece precipitare il paese in
paurose carestie obbligandolo a richiedere il grano ai paesi baltici; per di più il
rendimento agricolo del paese era piuttosto scarso, non riuscendo a competere né in
qualità né in prezzo con i prodotti dell’Italia, della Francia e delle Fiandre. La crisi, così,
36 Abū ʿAbd Allāh Muḥammad al-Shaykh al-Mahdī (1490 – 23/10/1557).
25
coinvolse immancabilmente anche Melilla. Fin allora Melilla era stata una solida città,
tranquilla e in crescita, ma presto la situazione cambiò completamente.
Nonostante il periodo di crisi economica, nel 1613 Melilla ottenne il titolo di
città e, nonostante il periodo di crisi economica, la sua popolazione iniziò ad aumentare
arrivando a quarantuno nascite annue nel periodo compreso fra il 1605 e il 1614.
Nel 1618 scoppiò in Europa la guerra dei trent’anni e i possedimenti spagnoli nel
mar Mediterraneo furono nuovamente dimenticati. Nel 1621 Melilla fu costretta a
presentare un informe alla Corona sollecitando più attenzione verso i propri problemi,
dichiarando comunque di comprendere la grave situazione politica ed economica che
stava vivendo la monarchia di Spagna. D’altro canto, Melilla esigeva il permesso di
commerciare liberamente con i paesi del Nordafrica. Il rapporto venne però archiviato
poiché la Spagna aveva impegni più immediati da affrontare, dato che la guerra non si
stava dimostrando vittoriosa. Nel 1627 ha inizio il caos finanziario in seguito alla
bancarotta in Castiglia, e in questi anni si produsse il primo caso di fame a Melilla. Il
fenomeno della fame non accenna a diminuire anzi, a partire dal 1640, Melilla iniziò a
sperimentare una pericolosa penuria che investirà la città fino al decennio successivo.
Nel frattempo, i rapporti con le popolazioni africane circostanti erano altalenanti;
infatti, gli abitanti del Rif alternavano periodi di attività commerciali ad attacchi e
pressioni.
Alla morte dell’ultimo sovrano sa’adiano37 nel 1659, si consolidò a Fez la
dinastia alawide, dinastia tuttora regnante in Marocco. Al loro arrivo, gli Alawidi
s’impegnarono nell’unificazione di tutta la zona occidentale del Magreb e quindi nella
volontà di cacciare gli ultimi spagnoli rimasti in terra africana. Iniziò così una serie di
attacchi rivolti agli ultimi possedimenti africani rimasti in mano alla Spagna, tra cui
Melilla. La Corona spagnola mostrò con fermezza di voler mantenere Melilla sotto il
proprio controllo e per questo motivo nel 1688 vennero inviati rinforzi da parte del re
Carlo II.
Gli ultimi anni del XVII secolo furono caratterizzati da continui attacchi e
assedi. Per questo motivo questo periodo fu dedicato principalmente alle opere di
fortificazione della città. I continui attacchi causarono un interrotto aumento della
37 Ahmad al-'Abbas.
26
mortalità a Melilla, aggravata ulteriormente dalla peste che colpì la città nel 1680
(Bravo Nieto e Uriel 2005: 352 – 367).
Il XVIII secolo sarà un periodo molto importante per Melilla, perché porterà al
miglioramento di molti suoi aspetti amministrativi.
Nel frattempo, la pressione offensiva sembra non diminuire, così, alla fine della
Guerra di Seccessione, nel 1714 la nuova dinastia alla guida della Spagna decide di
fortificare ulteriormente la città.
In tutti questi anni, il governo spagnolo vedeva Melilla esclusivamente come una
città militare, fortificata per resistere alle pressioni straniere e preparata a difendersi
attraverso la sua guarnigione. Lo sviluppo di altri settori, come ad esempio il settore
commerciale, risultava secondario in una città fondamentalmente militare. Tuttavia, non
tutti erano della stessa opinione; vi erano, infatti, alcuni politici che spingevano verso la
pianificazione di una città vera e propria e con un futuro prospero.
Nonostante il fatto che la legislazione avesse imposto un numero ristretto di
abitanti, dal momento che la città aveva una funzione militare, in questi anni la
popolazione di Melilla non aveva fatto altro che aumentare, arrivando a 1.400 persone
nella metà del XVIII secolo. Infatti, gli abitanti di Melilla avevano iniziato a sposarsi e a
mettere su famiglia, non curanti delle disposizioni governative.
Sempre verso la metà del XVIII secolo, la monarchia spagnola iniziò a
domandarsi se era necessario continuare a difendere i possedimenti oltremare oppure se
era meglio abbandonarli. I sovrani, infatti, erano preoccupati dai continui assedi alle
piazzeforti spagnole ubicate in costa africana, così iniziarono a consultare degli esperti
per prendere una decisione.
Nel 1763 il parroco della chiesa di Melilla, Joseph García Gomez, scrisse un
breve documento sulla storia di Melilla affinché il governo conoscesse l’importanza
storica della città. Tra il 1764 e il 1765 vennero elaborate diverse analisi, tutte con lo
scopo di comprendere se mantenere o meno il controllo sulla città di Melilla. Infine, la
maggior parte delle analisi erano favorevoli al suo mantenimento e la Corona spagnola
decise di continuare ad esercitare la sovranità su di esse.
Nel 1767, la Spagna e il Marocco firmano un trattato di pace. Tuttavia, questo
trattato ebbe vita breve poiché alla morte del sultano che firmò il trattato con la Corona
spagnola, ossia Muhammad Ben Abdallah Muhammad III, salì al trono il sesto sultano
27
della dinastia alawide, Mulay al-Yazīd ibn Muḥammad38 il quale nel 1774 inviò una
lettera al re Carlo III per annunciargli che il trattato firmato in precedenza prevedeva
soltanto una forma di pace via mare e non anche via terra come invece credeva la
monarchia spagnola.
Così il 23 ottobre dello stesso anno il Marocco dichiarò guerra a Melilla.
L’assedio durò più di un anno, motivato dalla volontà di espellere gli spagnoli dalla
costa nordafricana da parte del sultano Mulay Muhammad e dalla ferma volontà di
Carlo III di conservare il controllo della città. Infine, il re Carlo III vinse la battaglia e
Melilla continuò a essere controllata dal governo spagnolo.
Dal 1776 le relazioni con il Marocco iniziarono a essere più pacifiche, infatti, nel
1780 fu firmato un nuovo trattato tra i due paesi.
Infine, l’ultimo avvenimento importante del XVIII secolo fu la ricostruzione
totale della muraglia che avvenne fra il 1794 e il 1796 (Bravo Nieto e Uriel 2005: 399 –
422).
Il XIX secolo fu per eccellenza il secondo periodo storico di crisi nella storia di
Melilla, crisi che porterà a una grave decadenza della città. Nei primi anni del XIX
secolo, infatti come abbiamo già sottolineato, la Spagna si vedrà subordinata ai francesi
e nel frattempo il Marocco continuerà ad attaccare le popolazioni spagnole nel
Nordafrica, con la rinnovata speranza di eliminare definitivamente la loro presenza da
Ceuta e Melilla. Come risultato a questa situazione, Melilla si ritrovò completamente
impoverita, caratterizzata dall’aumento della mortalità dovuta alla mancanza di beni di
prima necessità. Nel 1800 Melilla aveva una popolazione piuttosto numerosa: 2.195
abitanti, comprendente la guarnigione.
La restaurazione borbonica nel 1814 non comportò sostanziali miglioramenti.
Fra gli anni venti e trenta, Melilla si trovava completamente immersa nel caos, assediata
dalla fame e dai nemici.
Nel frattempo, il governatore di Melilla Demetrio María de Benito y Hernández,
stava maturando l’idea di ampliare i confini della città, così nel 1858 il sultano
marocchino, Muhammad IV39, accetta la proposta spagnola di allargare la città di
Melilla per un totale di dodici kilometri quadrati. Il 24 di agosto dello stesso anno,
38 Mulay al-Yazīd ibn Muḥammad (Fes, 1750 – Marrakech, 1792). 39 Muhammad ibn 'Abd al-Rahmad (Fes, 1803 – Marrakech, 16/09/1873).
28
venne firmato un trattato secondo cui il Marocco cedeva alla Spagna il territorio di
Melilla.
Da questo momento la vecchia città fortificata inizia a perdere la sua principale e
antica funzione, ossia quella difensiva, per assumere quella di una vera e propria città in
grado di accogliere non soltanto militari ma anche la popolazione civile che cominciò a
crescere sempre più. Fu, infatti, nel 1864 che le autorità spagnole permisero il libero
insediamento di civili nella città.
Come precedentemente narrato, nel 1873 la Spagna diventa una repubblica in
seguito all’abdicazione del re Amedeo I e il 27 febbraio del medesimo anno, ci fu la
proclamazione ufficiale della prima repubblica spagnola a Melilla.
Durante gli undici mesi di repubblica, Melilla visse un sentimento misto di
speranza e delusione: speranza poiché si attendeva un miglioramento politico ed
economico della Spagna e, di conseguenza, un maggior riguardo verso i possedimenti
oltremare e delusione quando ci si rese conto del fallimento della repubblica (Esquembri
2013: 14 – 15).
Alla fine del XIX secolo, iniziarono nondimeno importanti opere d’infrastruttura
urbana portate avanti dall’ingegner Eligio Souza y Fernández de la Maza, il quale
diresse la costruzione di nuove fortezze per la difesa dei nuovi confini territoriali di
Melilla (Bravo Nieto e Uriel 2005: 422 – 429). Queste opere alimentarono un conflitto
che prese il nome di Guerra di Margallo.
Infatti, negli anni novanta del XIX secolo, precisamente tra il 1893 e 1894,
Melilla si vedrà coinvolta in un conflitto armato poiché l’allora governatore di Melilla,
Juan García y Margallo40, aveva disposto di costruire una nuova cinta di mura attorno
alla città, struttura che venne costruita sopra la tomba di un santo marocchino. Quasi
immediatamente, 6000 berberi, provenienti dalle tribù stanziate ai lati della città, si
mobilitarono per attaccare Melilla e i suoi abitanti.
Melilla aveva a disposizione soltanto 400 soldati ma, nonostante fosse stata
organizzata una milizia civile per far fronte all’attacco straniero, la grande sproporzione
numerica esistente fra i due popoli obbligò Melilla a ritirarsi dalla battaglia. I berberi
così iniziarono ad assaltare la città scalando la muraglia. Dalla Penisola arrivarono
rinforzi dopo la morte del generale Margallo, il 28 ottobre del 1893, per paura che si
40 Juan García y Margallo (Montánchez, 12/07/1839 - Melilla, 28/10/1893).
29
scatenasse una guerra con il Marocco. Infine, il conflitto terminò grazie a un accordo tra
i due paesi che prevedeva che il Marocco pagasse un indennizzo di quattro milioni di
duros41 per i danni causati a Melilla, stabilendo definitivamente una zona neutrale tra il
Marocco e il territorio di Melilla. I colpevoli di tale attacco vennero puniti duramente
dall’allora Sultano marocchino42 ed il 5 marzo del 1894 fu firmata la Tratado de
Marrakech tra i due paesi (Crespo Redondo 1994: 164 – 165).
Nel 1912 il Regno di Spagna assunse il controllo di un’area del Marocco fino al
1956, dando inizio così al protettorato spagnolo del Marocco. Il motivo principale era
quello di bilanciare la presenza francese nel Nordafrica (Gozalbes Cravioto 2011: 1). Il
protettorato spagnolo ebbe fine nel 1956 quando, insieme all’ex protettorato francese, il
Marocco diventò uno stato indipendente. Solo Ceuta, Melilla e Ifni rimasero sotto la
protezione spagnola anche se nel 1969 Ifni venne ceduta al Marocco.
Durante gli anni del protettorato, Melilla ebbe modo di sviluppare l’economia,
sperimentando così un’esponenziale aumento della popolazione (Aragón Reyes 2013:
89). Infatti, se nel 1910 la città era abitata da 9000 persone, nel decennio successivo il
numero degli abitanti superò i 50000.
In questi anni Melilla ricevette molti aiuti economici dalla Corona spagnola, e
questo le permise di migliorare il servizio scolastico e sanitario della città.
Nel 1924 i bambini di Melilla erano 10000 e le scuole funzionanti erano 35, di
cui 25 pubbliche e 10 private, anche se non sufficienti a contenere tutti gli alunni. In
quegli anni non tutti i bambini frequentavano la scuola; secondo il censimento
scolastico effettuato nel 1924 (García Alonso 1985: 121), circa 6000 bambini non
ricevevano istruzione, più della metà dei bambini di Melilla, figli, per lo più, della
classe operaia. I più fortunati invece erano i figli della borghesia (García Alonso 1985:
122 – 124).
Per quanto riguarda i servizi pubblici, nel corso del novecento sono state
promosse avanti importanti opere come la distribuzione dell’acqua potabile e la
costruzione di un sistema di drenaggio urbano in diversi quartieri della città con lo
scopo di risolvere il grave problema delle frequenti inondazioni che avvenivano in
seguito alle forti precipitazioni (Díez Sánchez. In stampa).
41 Il duro era una moneta spagnola composta da cinque pesetas. La peseta, a sua volta, era la valuta di
Spagna in circolazione fino al 1999, precedente all’euro. 42 Mulay Ḥasan I Fes, (1836 – Tadla, 07/06/1894).
30
Nel 1930 cade la dittatura di Primo de Rivera, lasciando la Spagna in una
situazione di precarietà. Presto la monarchia perse il consenso popolare, lasciando
spazio a quella che sarà la Seconda Repubblica spagnola (Bravo Nieto 1985: 93).
Il 14 aprile del 1931 iniziarono a circolare voci a Melilla riguardo la possibile
caduta della monarchia e l’instaurazione della Repubblica, così nel primo pomeriggio si
riunì il Comitato Rivoluzionario per studiare la situazione. Il comitato era composto da
uomini che rivestiranno un importante ruolo politico nella città, quali: Antonio Díez,
leader del socialismo melillense e futuro sindaco di Melilla, Antonio Aculla, futuro
primo deputato di Melilla, Gaspar García Dómine, futuro primo delegato del governo
civile della città e Carlos Echeguren, anch’egli futuro deputato.
Verso le quattro del pomeriggio, i membri del comitato s’incamminarono verso
l’ufficio postale della città in attesa di notizie provenienti dalla Penisola. All’arrivo della
notizia ufficiale dell’avvento della Repubblica, venne issata la nuova bandiera spagnola
sull’edificio postale mentre i cittadini di Melilla accorsero in via Castelar per celebrare
la proclamazione della Repubblica a Melilla (Esquembri 2013: 60 – 61).
A Melilla la Repubblica fu accolta calorosamente, dando vita ad una vera e
propria rivoluzione democratica che mise le basi per trasformarla da base militare a città
democratica dotata di diritti civili e politici come qualsiasi altra città spagnola. Questo
fu quindi il primo governo che diede a Ceuta e Melilla maggior equità rispetto al resto
della Penisola (Moreno García 1984: 47).
Nonostante ciò, la nuova realtà politica non sempre si dimostrò stabile
mostrando talvolta un corso altalenante e instabile dovuto alla successione e dimissione
di sindaci in poco tempo. Difatti, lo stato spagnolo investiva meno nelle città oltremare
rispetto alla Penisola e Melilla presentava moltissimi problemi; questo era il motivo
principale delle molteplici dimissioni politiche. Altri problemi che caratterizzarono
questo governo furono: l’aumento della disoccupazione, la mancanza di alimenti e
d’infrastrutture (Bravo Nieto 1985: 96 – 97).
D’altro canto, da un punto di vista sociale, durante il periodo repubblicano
Melilla visse un momento di grande libertà e apertura verso il rinnovamento, come ad
esempio l’integrazione delle donne nella vita politica e lavorativa. I successi raggiunti
ebbero vita breve in seguito all’arrivo della dittatura di Franco.
31
Con questo clima di tensione Melilla si stava avvicinando al 1936, data d’inizio
della Guerra Civile (López Senosiain 2010: 11).
Da tempo i nazionalisti stavano preparando una cospirazione con lo scopo di far
cadere la Repubblica e restaurare la monarchia. A capo della cospirazione vi era Emilio
Mola43, un militare spagnolo che diresse la sommossa in Spagna. Secondo Mola era di
fondamentale importanza che la sommossa si producesse in maniera simultanea in tutte
le province spagnole. Tuttavia, i preparativi venivano continuamente intralciati dal
governo repubblicano che neutralizzava i generali sospetti.
Nei primi giorni di luglio i golpisti iniziarono a incontrarsi a Melilla per
organizzare la sommossa che avrebbe avuto luogo nella stessa città (López Senosiain
2010: 14 - 22).
La mattina del 17 luglio 1936 il colonnello Solans e i tenenti Seguí, Gazapo e
Bertomeu diedero le ultime istruzioni comunicando ai loro compagni l’ora esatta
dell’insurrezione che si sarebbe svolta il giorno seguente (Tuñón de Lara 2000b: 391).
Tuttavia, uno dei dirigenti, probabilmente un infiltrato, tradì la Falange e
informò immediatamente il segretario dell’Unione Repubblicana del colpo di stato che
si stava progettando. Così, alle ore dodici dello stesso giorno, venne scoperto il piano
dei ribelli.
Nelle prime ore del pomeriggio, il tenente della polizia Juan Zaro si presentò
dinanzi ai golpisti per arrestarli e questi chiamarono in loro soccorso la Legione
Straniera Spagnola. Gli ufficiali insorti dichiararono lo stato di guerra, occupando tutti
gli edifici pubblici di Melilla e tutti i militari che rimasero fedeli alla Repubblica
vennero fucilati. Iniziò così a Melilla l’insurrezione militare che diede inizio a quasi tre
anni di guerra civile.
Alle prime luci del giorno del 18 luglio, i ribelli riuscirono a sopraffare le forze
politiche e militari della Repubblica che si arresero ai golpisti; Melilla quindi cadde
nelle mani dei ribelli (Barberi 2006: 125 – 128). Il 20 luglio venne aperto il primo
campo di concentramento franchista a Melilla. Questo campo di concentramento fu il
primo fondato dai franchisti e prende il nome di Alcazaba de Zeluan. Il campo non si
trovava esattamente a Melilla ma a qualche kilometro dalla città. La Alcazaba era già
esistente prima della guerra civile, infatti si tratta di un recinto fortificato all'interno di
43 Emilio Mola Vidal (Placetas, Villa Clara, Cuba, 09/07/1887 – Alcocero, Burgos, 03/06/1937).
32
una città cinta di mura, la cui funzione era quella di difesa militare. Venne costruita a
fine del XVII secolo dall’allora popolazione marocchina e in seguito, quando Melilla
venne occupata dai golpisti nel 1936, il campo venne trasformato in campo di
concentramento dove venivano torturati coloro che difendevano la Repubblica (Moga
Romero 2006: 115)
Melilla, quindi, fu la prima città spagnola in cui esplose la violenza politica e in
cui iniziò la repressione esercitata sulla popolazione, dove il principale obiettivo era
l’eliminazione fisica di tutti gli oppositori del franchismo.
Durante gli anni della guerra civile, Melilla visse il terrore esercitato dal
franchismo come qualsiasi altra città spagnola: censura mediatica, sequestro di beni,
omicidi e carestia (Fernández Díaz 2012: 232). Alla fine della guerra civile, essa
conobbe un periodo di grande sviluppo urbanistico; infatti, è di questi anni la
costruzione di Plaza de Toros, dello Stadio Municipale, del Palazzo del Comune e dei
grandi edifici destinati ad accogliere la maggior parte della popolazione melillense.
Negli anni quaranta a Melilla iniziarono a proliferare le industrie; infatti, nel
1948 erano presenti sul territorio 1177 aziende che davano lavoro a circa 9000 persone
(Díez Sánchez. In stampa).
Nel 1964 a Melilla c’erano circa 80000 abitanti raggiungendo il maggior numero
di abitanti della storia di Melilla.
In seguito all’indipendenza del Marocco avvenuta nel 1956, Melilla smette di
essere la capitale economica dell’area orientale lasciando spazio allo stato novello.
Nel 1978 la Costituzione Spagnola riconosce le città di Ceuta e Melilla come
comunità autonome appartenenti allo stato spagnolo, e nel 1979 si celebrano in
entrambe le città le prime elezioni municipali.
Il 13 marzo del 1995 venne promulgato lo statuto di autonomia di Melilla
assieme a quello di Ceuta. Gli statuti sono pressoché identici, benché facciano
riferimento a due città differenti.
Per tanto, anche Melilla fu dichiarata città autonoma potendo quindi godere del
diritto di autogoverno e della libertà di gestione delle questioni appartenenti
esclusivamente alla sua città.
Attualmente la popolazione di Melilla è piuttosto numerosa: supera infatti gli
80000 abitanti.
33
II Capitolo
1. Il fenomeno migratorio in Spagna
In un lasso di tempo record, la Spagna è passata da essere un paese di forte
emigrazione a paese recettore di un intenso flusso migratorio, in entrambi i casi, alla
base, vi sono motivi molto complessi.
Il risultato di questa svolta è dovuto, in particolar modo, ai cambiamenti che la
società spagnola ha subito a partire dal 1975, ossia cambiamenti sociali, politici ed
economici che l’hanno investita mentre s’inseriva nell’Europa occidentale.
Uno dei cambiamenti che ha rivoluzionato per sempre la società spagnola
riguarda la struttura dei posti di lavoro; il radicale aumento del livello formativo delle
nuove generazioni spagnole ha provocato la diminuzione d’interesse verso i posti di
lavoro a livelli più bassi. Tali posti di lavoro, come l’edilizia e il lavoro nei campi, non
sono scomparsi nella società spagnola, ma sono rifiutati dai giovani spagnoli che, con
un più alto livello formativo, aspirano a trovare un posto di lavoro nel settore terziario.
Cosicché, la domanda nel settore primario e secondario ha fatto sì che il governo
spagnolo abbia permesso l’apertura delle porte dell’immigrazione per andare a coprire i
posti di lavoro scoperti, mentre, nel frattempo, la disoccupazione ha iniziato a dilagare
all’interno del settore terziario che non riesce a soddisfare l’intera popolazione
spagnola.
Il risultato di questa realtà è stato l’aumento sempre più massiccio di immigrati
che nei primi anni del 2000 arrivavano sul suolo spagnolo per trovare un impiego. Se
nel 1996, delle 245.100 persone che lavoravano nel servizio domestico 20.000 erano
straniere, nel 2004 su 500.000 lavoratori 300.000 erano stranieri (Alonso e Blasco 2007:
6).
34
Nel 2013 risulta che vi era una percentuale del 13.87%44 di stranieri sull’intero
suolo spagnolo. Le percentuali francesi e tedesche non si discostano di molto rispetto a
quelle spagnole, con la differenza però che il processo avvenuto in Spagna è stato molto
più rapido e intenso.
Tuttavia, dagli ultimi tre anni, si sta verificando una diminuzione del numero di
immigrati che rimangono in terra spagnola e questo a causa del fatto che la Spagna non
è più considerata come un paese appetibile a causa della crisi sociale ed economica in
cui versa, riconoscendo quindi la difficoltà nel trovare un impiego.
Gli stranieri spinti alla “fuga” sono principalmente latinoamericani, con una
prevalenza di persone provenienti dall’Ecuador e dalla Colombia.
Il motivo che spinge molti stranieri a lasciare la Spagna è che la mancanza o la
perdita del posto di lavoro comporta la perdita del permesso di soggiorno, che conduce
a uno stato d’irregolarità che si ripercuote anche sulla prole45.
Nonostante ciò, il numero degli immigrati residenti in Spagna è ancora piuttosto
alto: essi, su un totale di 46 milioni di abitanti, hanno raggiunto il numero di 6 milioni di
unità.
Gli immigrati che arrivano in Spagna sono di diverse nazionalità, anche se vi è
un’alta percentuale di immigrati marocchini che supera il 15% del totale degli stranieri.
Seguono i latinoamericani, i subsahariani, le popolazioni asiatiche, in particolar modo i
cinesi, e gli immigrati provenienti dall’Europa dell’est. Le comunità autonome
predilette dagli immigrati sono la Catalogna, Madrid, la Comunità Valenciana,
l’Andalusia, Murcia e le isole Canarie (Alonso e Blasco 2007: 6 – 10).
Se fino a qualche anno fa, prima dell’inizio della grande crisi economica, la
popolazione spagnola si dimostrava ben tollerante nei confronti degli stranieri e
l’immigrazione non sembrava preoccuparla, ora, invece, più della metà degli spagnoli
inizia a pensare che il numero di immigrati che entrano nello stato spagnolo sia più di
44 Nazioni Unite, Dipartimento per gli Affari Economici e Sociali (2013), Trends in International Migrant
Stock: The 2013 Revision. Tratto da: www.un.org/en/
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatestotal.shtml. Dati
consultabili nelle tabelle 1 e 3. (Consultato in data 03/01/2015). 45 Joaquín Arango, Sei milioni di troppo? – L’immigrazione della Spagna nella crisi, 2012. Tratto da:
www.fieri.it
http://fieri.it/2012/10/31/sei-milioni-di-troppo-limmigrazione-nella-spagna-della-crisi/ (Consultato in data
12/01/2015).
35
quanto il paese possa davvero accogliere46. La situazione attuale in cui si trova la
Spagna, così come molti altri paesi europei, è quella di una reale difficoltà economica
aggravata da una preoccupante disoccupazione, soprattutto nel segmento giovanile. Se è
vero che la popolazione spagnola punta a posti di lavoro sempre più qualificati, è anche
vero che molti spagnoli iniziano ad accontentarsi andando a svolgere mestieri poco
inerenti al proprio ambito di studi.
I datori di lavoro, d’altro canto, molto spesso preferiscono assumere dipendenti
stranieri perché accettano, generalmente, salari più bassi rispetto alla media nazionale e
tendono ad avere un atteggiamento di maggiore sottomissione sul luogo di lavoro. In
poche parole, il lavoratore straniero si accontenta di più, poiché considera già un
privilegio il fatto di risiedere in un paese avanzato e sviluppato come la Spagna
(Grados, Francisco: "Los empresarios prefieren coger a los inmigrantes porque les
pagan menos”, 20 minutos, 10/12/2008).
1.1. Le prime iniziative politiche per regolare il fenomeno dell’immigrazione
Le prime iniziative europee per costruire una politica di asilo e immigrazione
comune coincidono con l’inizio del fenomeno migratorio spagnolo (Alonso y Basco
2007: 11). Nel 1985 entra in vigore la prima Ley de Extranjeria in Spagna che costituì il
primo tentativo di stabilire un controllo sui meccanismi dell’immigrazione47.
Sempre nello stesso anno più stati europei, precisamente Francia, Germania,
Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi, si riunirono nella città di Schengen, in
Lussemburgo, per firmare un accordo48 che prende il nome della città stessa, poi esteso
a numerosi stati europei. Lo scopo di tale accordo era quello di creare un territorio privo
di frontiere, aprendo la strada a un nuovo livello di integrazione europea: tale territorio
venne denominato “Spazio Schengen”. All’interno dello Spazio Schengen è garantita la
46 Statistica di opinione pubblica inerente al tema dell’immigrazione in Spagna, realizzata nel maggio del
2014 e portata avanti dall’azienda spagnola Siempre Lógica. Tratto da: www.siemprelogica.com
http://www.simplelogica.com/iop/iop14006-inmigracion-en-espa%C3%B1a.asp (Consultato in data
03/01/2015). 47 Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. (Vigente
hasta el 1 de febrero de 2000). Tratto da: www.noticiasjuridicas.es
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-lo7-1985.html (Consultato in data: 19/02/2015). 48 Acquis di Schengen - Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della
Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, Gazzetta Ufficiale, 22/09/2000. Tratto da: www.eur-lex.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(01)&from=EN
(Consultato in data19-02-2015)
36
libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone. L’accordo aveva finalità
prettamente economiche, poi in seguito nacque l’idea di creare una politica comunitaria
d’immigrazione49. Nel 1991 la Spagna firma l’accordo rendendo così accessibile il suo
territorio a tutti i cittadini presenti nello Spazio Schengen. Col passare degli anni
sempre più stati europei firmarono l’accordo, arrivando oggi ad includere ventisei
paesi50.
Fra il 1990 e il 1994 nasce una politica migratoria più attiva e socialmente più
completa, che pretendeva di trovare una soluzione per tutti gli immigrati clandestini
localizzati principalmente nella Catalogna, a Madrid e nelle province lungo la costa del
Mediterraneo. E’ di questo periodo, quindi, il documento Resolución de 7 de junio de
1991, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 7 de junio de 1991 sobre regularización de trabajadores
extranjeros51, secondo cui alcuni dei principi fondamentali sono: la regolarizzazione
straordinaria di immigrati irregolari che svolgono un lavoro sul suolo spagnolo;
l’accoglienza dei richiedenti asilo o rifugiati; la creazione di nuove strutture pubbliche
legate all’immigrazione e l’intensificazione delle misure contro l’immigrazione
irregolare (Gozálvez Pérez 2000: 50).
Nel 1994 nasce il Plan para la Integración Social de los inmigrantes, rivolto
agli immigrati che già risiedono in Spagna in condizione di regolarità. Oltre al tema
dell’integrazione sociale degli stranieri, il documento stabilisce anche un’altra
importante linea di attuazione, quale la cooperazione per lo sviluppo dei paesi emettitori
di immigrati (Gozálvez Pérez 2000: 50).
Nel 1995 sono stati introdotti dal governo spagnolo due organi statali in
appoggio al Plan para la Integración Social, ossia il Foro para la Integración Social de
los Inmigrantes (FORO) e il Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI). Il
primo ha come obiettivo quello del dialogo e della cooperazione fra le amministrazioni
49 Schengen, cos’è e come funziona, europarlamento 24, -/04/2010. Tratto da: www.europarlamento24.eu
http://www.europarlamento24.eu/schengen-cos-e-e-come-funziona/0,1254,106_ART_142,00.html
(Consultato in data 02/01/2015). 50 Schengen (Acuerdo y Convenio). Tratto da: www.europa.eu
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/schengen_agreement_es.htm (Consultato in data
19/02/2014). 51 Resolución de 7 de junio de 1991, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de junio de 1991 sobre regularización de trabajadores
extranjeros., «BOE» núm. 137, 08/06/1991.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-14599
37
pubbliche, le organizzazioni sociali e le associazioni d’immigrati, il secondo invece ha il
compito di raccogliere informazioni per conoscere e valutare le questioni relative
all’immigrazione.
Tra le attività svolte in seguito all’introduzione del Plan para la Integración
Social, ha rilevanza la redazione e l’approvazione nel 1996 di un nuovo regolamento di
esecuzione della Ley de Extranjería del 1985; tra gli aspetti più interessanti vi sono le
disposizioni destinate a facilitare il ricongiungimento familiare degli immigrati
all’interno dello stato spagnolo (Gozálvez Pérez 2000: 50 - 51).
All’inizio del XXI secolo, il quadro inizia a cambiare profondamente, il flusso
migratorio si fa sempre più incessante e il governo spagnolo si trasforma in guardiano di
frontiera intento a controllare le persone che si accingono a entrare all’interno del paese.
Nell’anno 2000, venne approvata la nuova Ley de Extranjeria52, che garantiva
una maggiore estensione dei diritti agli immigrati, quali la protezione giuridica e la
politica del welfare state, con l’obiettivo di facilitare l’integrazione sociale. Nello stesso
anno venne ulteriormente modificata la legge, introducendo un rafforzamento dei
controlli lungo le frontiere e inasprendo le sanzioni nei confronti degli stranieri
sprovvisti di documenti o verso gli imprenditori che assumono immigrati irregolari nel
loro posto di lavoro. Inoltre, vennero introdotte delle sanzioni anche nei confronti di chi
trasporta immigrati clandestinamente fino in Spagna.
In sostanza, la revisione della nuova legge ha complicato la situazione degli
stranieri che entrano irregolarmente nel territorio spagnolo, limitando alcuni dei loro
diritti, come ad esempio l’accesso all’istruzione a un più alto livello (per gli immigrati
che hanno superato la maggiore età) (Alonso e Basco 2007: 12).
1.2. Il processo di regolarizzazione degli immigrati
La Ley de Extranjería dell’anno 2000, negli articoli 31 e 32, fa riferimento a due
situazioni per la regolamentazione degli immigrati: il permesso di soggiorno di breve
durata e il permesso di soggiorno di lunga durata.
Nella prima situazione si autorizza l’immigrato a rimanere in Spagna per un
periodo superiore ai 90 giorni e inferiore a cinque anni. I permessi di soggiorno di breve
52 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social. Tratto da: Tratto da: www.boes.es
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544 (Consultato in data 19/02/2015).
38
durata vengono concessi per ragioni umanitarie, per motivi di lavoro, per gli stranieri
che, in assenza di un posto di lavoro, dispongono di mezzi sufficienti per il proprio
sostentamento, ed eventualmente, della propria famiglia e in altre circostanze
eccezionali. Per concedere la residenza temporanea è fondamentale che la persona in
questione non possieda precedenti penali in Spagna, o nei paesi in cui ha risieduto in
precedenza, per reati esistenti nell’ordinamento spagnolo. Le autorizzazioni di durata
inferiore a cinque anni possono essere anche rinnovate, ma solo in assenza delle
seguenti circostanze: il mancato compimento degli obblighi in materia tributaria o di
previdenza sociale e l’esistenza di precedenti penali.
La seconda situazione fa invece riferimento al permesso di soggiorno di lunga
durata; in questo caso si autorizza lo straniero a risiedere e lavorare in Spagna per un
periodo di tempo indeterminato, nelle stesse condizioni della popolazione spagnola.
Hanno diritto al permesso di soggiorno di lunga durata coloro che hanno vissuto
legalmente in Spagna per cinque anni in maniera continuativa. Con l’espressione
“maniera continuativa” vengono prese in considerazione anche quegli individui che,
dopo aver aver presentato delle motivazioni considerate valide, devono lasciare
temporaneamente la nazione.
La Ley de Extranjería, inoltre, dichiara che si può verificare il caso di estinzione
del permesso di soggiorno di lunga durata ma solo nei seguenti casi: quando
l’autorizzazione sia stata ottenuta in maniera fraudolenta; quando viene dettato un
ordine di espulsione secondo i casi previsti dalla Legge; quando si verifica l’assenza dal
territorio dell’Unione Europea per un periodo di dodici mesi consecutivi; quando si
ottiene il permesso di soggiorno di lunga durata in un altro stato membro. Tuttavia, le
persone che si vedono estinti i permessi di soggiorno di lunga durata possono, in alcuni
casi, riottenere gli stessi mediante un procedimento semplificato che avverrà secondo
quanto stabilito dalla Legge53.
1.3. L’immigrazione clandestina nella penisola spagnola
53 Articoli 31 e 32 della Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. Tratto da: www.boes.es
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544 (Consultato in data 01/02/2015).
39
Se i dati generali sull’immigrazione in Spagna denotano, negli ultimi anni, una
lieve diminuzione del numero dei regolari, lo stesso non si può dire dell’immigrazione
irregolare, in particolar modo proveniente dal continente africano.
Partendo dal presupposto che, a oggi, non esiste una definizione univoca del
concetto di “immigrazione irregolare”, con questo termine s’intende un movimento di
individui che, violando le norme e le leggi che disciplinano il transito delle persone tra
le diverse nazioni, partono da un paese senza avere un regolare documento di viaggio e
arrivano in un altro senza le autorizzazioni necessarie per lavorarci e viverci
(Perruchoud 2004: 34 – 35). In spagnolo l’immigrato in condizione d’irregolarità viene
comunemente denominato “inmigrante sin papeles”.
Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo EuropaPress nell’articolo “La
inmigración irregular subió en España un 130% en el primer trimestre, sólo por detrás
de Italia”, durante i primi tre mesi del 2014, l’immigrazione clandestina è aumentata
del 130% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, percentuale che colloca la
Spagna come secondo paese con un più alto tasso d’immigrazione irregolare, preceduta
soltanto dall’Italia che ha sperimentato un aumento del 600% (AA.VV. 2014: 12).
Sempre lo scorso anno, la Spagna, la Grecia e l’Italia hanno registrato più della metà
delle entrate irregolari in tutta l’Unione Europea. Ceuta e Melilla sono invece risultate le
città spagnole in cui si sono verificati i maggiori tentativi di entrate irregolari
(Anonimo, “La inmigración irregular subió en España un 130% en el primer trimestre,
sólo por detrás de Italia”, EuropaPress, 26/08/2014).
Esistono svariati metodi per eludere i controlli alle frontiere, come ad esempio
nascondersi nelle macchine o nei camion che quotidianamente attraversano le frontiere,
utilizzare documenti falsi, affidarsi ai contrabbandieri e molto altro.
Benché sia illegale risiedere in Spagna senza documenti, gli immigrati “sin
papeles” godono comunque di alcuni diritti quali, ad esempio, assistenza sanitaria
gratuita, assistenza giuridica gratuita, il diritto all’istruzione ai minori di 18 anni e il
diritto di associazione, di sciopero e libertà sindacale (AA.VV. 2011: 5).
1.4. L’immigrazione clandestina a Ceuta e Melilla
40
Da diversi anni, le due città autonome spagnole, Ceuta e Melilla, si sono
trasformate nelle due mete predilette dei migranti africani per raggiungere il suolo
europeo.
A causa della loro particolare posizione geografica, Ceuta e Melilla sono gli
unici territori europei che possono essere raggiunti via terra dai migranti africani senza
che i migranti debbano mettere a repentaglio la loro vita con una pericolosa e rischiosa
traversata nel Mediterraneo come avviene invece nel caso dell’immigrazione verso le
isole italiane e greche.
Ciò che rende interessanti e uniche queste due città dal un punto di vista
politico, sociale e antropologico è il fatto che esse non solo sono il crocevia dei migranti
che dall’Africa vogliono raggiungere la Spagna, ma rappresentano anche un ponte
culturale fra due continenti, l’Europa e l’Africa appunto, fra le vecchie potenze
occidentali e i paesi che hanno vissuto l’esperienza del colonialismo europeo, fra il
“noi” e il “loro” (Castan Pinos 2013:13 – 14).
La particolarità delle due città sta nel fatto che, nell’esatto momento in cui un
migrante mette piede in una di loro, egli può godere di diritti e garanzie che, al
contrario, nessuno stato africano potrebbe garantire loro, come ad esempio l’assistenza
gratuita all’interno dei Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)54, di cui
parleremo più avanti (AA.VV. 2011: 5).
Sebbene, da ormai alcuni decenni, le autorità marocchine rivendichino il fatto
che Ceuta e Melilla debbano entrare a far parte dello Stato nordafricano, queste due
città, da un punto di vista politico e culturale, si sentono molto più vicine e più affini
alla realtà europea alla quale, per essere precisi, appartengono di diritto (Castan Pinos
2013:14).
2. La storia dell’immigrazione clandestina a Ceuta e Melilla
54 I CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) di Ceuta e Melilla sono
stabilimenti della pubblica amministrazione, concepiti come dispositivi di prima accoglienza destinati
a conferire servizi e prestazioni sociali basiche al gruppo di immigrati e richiedenti asilo che arrivano
nelle Città Autonome. I CETI non sono strutture private ma strutture pubbliche a carico del Instituto
de Mayores y Servicios Sociales (INSERSO).
41
L’immigrazione a Ceuta e Melilla ha una notevole tradizione: durante gli anni
del protettorato spagnolo del Marocco (1912 – 1956), cominciò, infatti, ad arrivare una
popolazione migrante proveniente soprattutto dalla provincia di Cadice, di Malaga e,
per la prima volta, dal Maghreb.
Durante questo periodo, tuttavia, gran parte delle persone di origine magrebina
che si trovavano nelle città di Ceuta e Melilla vivevano in condizione d’irregolarità.
Alcuni migranti erano provvisti di un documento, la cosiddetta Tarjeta de Estadística,
che però non dava loro alcun accesso ai diritti sociali, civili o politici, ma serviva
esclusivamente a registrare gli immigrati; altri, invece, non possedevano alcun
documento violando così le normative vigenti (Lara 2014: 10 – 11).
In un articolo de El País dell’11 maggio 1985 intitolato “Legalizar Melilla”, lo
scrittore Aomar Mohammeddi Duddu commentò duramente la gestione degli immigrati
a Melilla, facendo riferimento alla Tarjeta de Estadística sostenendo che “sirve para
llevar un registro de personas, de modo semejante a como se registran libros en una
biblioteca o animales en las oficina de Sanidad”, alludendo al poco interesse del
Governo spagnolo e delle autorità politiche di Melilla nel voler integrare realmente gli
immigrati nella società.
Inoltre, egli sottolineò che la mancanza di documenti era la causa di molti
problemi per la popolazione magrebina a Melilla; infatti senza di essi, gli immigrati non
potevano comprare o prendere in affitto abitazioni se non attraverso una speciale
autorizzazione, inoltre in caso di un’emergenza medica coloro che erano sprovvisti di
documenti non potevano farsi curare in un qualsiasi centro medico dello stato spagnolo.
Sempre secondo lo scrittore, infine, commentò che “en estas condiciones, hablar de
integración musulmana es un puro sarcasmo” (Duddu, “Legalizar Melilla”, El País,
11/05/1985) .
Nel 1985 il Governo promulga la Legge Organica 7/1985 meglio conosciuta
come la Ley de Extranjería de 1985. Secondo questa legge, i magrebini residenti a
Ceuta e Melilla che non possedevano la nazionalità spagnola erano considerati
extracomunitari (Lara 2014: 11).
42
Questo principio veniva formulato chiaramente nel primo articolo di legge che
così dichiarava: “Se consideran extranjeros, a los efectos de aplicación de la presente
Ley, a quienes carezcan de la nacionalidad española”55.
Perciò nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1985 si produssero una
serie di proteste con lo scopo di rivendicare l’accesso alla nazionalità spagnola, con tutti
i diritti e doveri derivanti (Lara 2014: 11).
Finalmente, nel 1986 il Governo González approvò un processo di
nazionalizzazione di tutti i magrebini residenti a Ceuta e Melilla (Lara 2014: 12).
Nel 1989 si verificò il primo naufragio sulla spiaggia Los Lances a Tarifa che
portò alla morte di undici persone. In quegli anni le imbarcazioni trasportavano
principalmente immigranti di origine marocchina, mentre i migranti subsahariani erano
solo il 20% del totale. Infatti, in quel periodo il Marocco stava vivendo anni difficili per
diverse ragioni: in primis ciò era dovuto alla diffusione del pensiero islamico estremista,
tradizionalmente estraneo alla cultura marocchina, e in secondo luogo alla decisione del
governo di Rabat di partecipare alla guerra in Iraq, scelta non gradita da un grande
numero di cittadini (Lara 2014: 12).
Melilla e Ceuta iniziarono così a permettere l’entrata dei primi immigrati
subsahariani nelle rispettive città: a Ceuta s’istallarono lungo le mura della città, mentre
a Melilla furono accolti nel vecchio ospedale della Croce Rossa (Lara 2014: 12).
2.1. I primi disordini a Ceuta e Melilla
Secondo quanto viene riportato dal dossier “Informe Frontera Sur. 1995 – 2006:
10 años de violación de los derechos humanos” redatto dall’associazione SOS Racismo,
l’11 ottobre del 1995 nella città di Ceuta più di duecento immigrati, esasperati
dall’attesa e dalla mancanza di risposta da parte del governo spagnolo in merito alla
richiesta di un visto per viaggiare liberamente nella Penisola, decisero di manifestare
dando vita a un duro scontro fra le forze armate e gli immigrati. Durante la protesta gli
immigrati si scontrarono con la Guardia Civil che dovette far uso di tutti i mezzi a
propria disposizione per placare la sommossa. Lo scontro si concluse con alcuni feriti e
nessun decesso (Maleno Garzón, De Lucas et al. 2006: 8).
55 Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. (Vigente
hasta el 1 de febrero de 2000). Tratto da: www.noticiasjuridicas.es
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-lo7-1985.html (Consultato in data: 19-02/2015).
43
In quest’occasione Basilio Fernández, sindaco della città autonoma di Ceuta,
dichiarò: “Que se vayan … vivimos en una ciudad de 19 kilómetros cuadrados, es una
cuestión de espacio que no podemos compartir con los inmigrantes”. Due giorni dopo
l’accaduto, gli immigrati di Ceuta vennero messi in libertà e trasferiti a Calamocarro,
ossia un antico accampamento situato a 4 km da Ceuta dove vennero istallate undici
tende militari e fu messo a disposizione un servizio di acqua corrente per tre ore al
giorno oltre alla distribuzione di alimenti da parte della Croce Bianca e Croce Rossa.
Nel mese di dicembre dello stesso anno erano 85 gli immigrati subsahariani accolti a
Calamocarro (Maleno, De Lucas et al. 2006: 8).
All’inizio del 1996 nell’accampamento di Calamocarro erano presenti 150
persone di cui 110 subsahariani e i restati 40 algerini. Le condizioni igienico-sanitarie
erano precarie e il cibo non era abbastanza per tutti. Il numero dei nuovi immigrati
arrivati a Ceuta era in continuo aumento, fino ad arrivare a 270 nell’aprile del 1996.
Alla fine di ottobre del 1995, in un’altra area sempre della città di Ceuta, una
quindicina d’immigrati creò un accampamento lungo la striscia di terra che separa la
città autonoma dal Marocco, conosciuta con il termine “Tierra de Nadie”. I migranti
costruirono delle baracche di legna e plastica e bevevano acqua piovana. I pasti
arrivavano solo una volta al giorno: questi ultimi altro non erano che gli avanzi che la
Croce Rossa riusciva a raccogliere dalle cucine militari. A causa delle condizioni
precarie in cui erano costretti a vivere gli immigrati, ci furono casi di tubercolosi e
scabbia. Inoltre, dal momento che l’accampamento era stato costruito vicino al mare e
vi era il pericolo concreto di allagamenti e straripamenti, la polizia spagnola fu costretta
a trasferire il campo degli immigrati in una zona meno esposta, sempre nella “terra di
nessuno”.
In questi mesi venne rafforzata la vigilanza con più di 100 agenti della Guardia
Civil nei pressi del confine. Inoltre, con l’appoggio dell’Unione Europea, iniziarono i
lavori per la realizzazione di una strada di vigilanza lungo il confine della città. La
strada, tuttora esistente, è lunga 8 km e larga 6 m, dotata di un Sistema Integrato di
Supervisione e Vigilanza lungo tutto il confine e di un sistema di megafonia per
diffondere messaggi di avviso. Il costo di tale opera fu di 600 milioni di pesetas, il
doppio rispetto a ciò che era stato inizialmente previsto (Maleno Garzón, De Lucas et al.
2006: 9).
44
Secondo quanto riportato dalla Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
(APDHA) nel suo dossier “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2014”, a Melilla
alcuni immigrati furono trasferiti al Centro Lucas Lorenzo o nella struttura agricola
della Granja, mentre altri vennero sedati ed espulsi dalla città (Lara 2014: 15).
Infatti, come descritto più dettagliatamente da Martín Rojo e da Van Dijk
“Había un problema y se ha resuelto. Legitimación de la Expulsión de Inmigrantes
“Ilegales” en el Discurso Parlamentario Español”, nel luglio del 1996, in seguito a
degli incidenti verificatosi durante una protesta messa in atto dagli immigrati per
denunciare pubblicamente le condizioni disumane nelle quali essi vivevano, alcuni di
loro vennero trasferiti a Malaga con degli aerei dell’esercito. Essi vennero quindi
rinchiusi nel carcere della città secondo il piano che venne poi ribattezzato con il nome
“Operazione Melilla”. In seguito, i 103 immigrati vennero prelevati e riportati al loro
paese d’origine con la forza. Sugli aerei di ritorno vennero sedati illegalmente e
segretamente attraverso narcotici introdotti in bottigliette d’acqua a loro destinate allo
scopo di evitare possibili proteste. Gli immigrati rimasero spossati per tutto il viaggio e
alcuni si trovarono in stato d’incoscienza anche 24 ore dopo l’accaduto. Questa
espulsione provocò fortissime proteste nazionali e internazionali. Fu in questo caso che
il presidente José María Aznar pronunciò la famosa frase “Había un problema y se ha
resuelto” (Martín Rojo e Van Dijk 1998: 1 - 2).
L’APDHA di Melilla denunciò le condizioni in cui si trovavano gli immigrati
dichiarando che erano “por debajo de la dignidad humana”, il che significa: solo sei
docce e quattro gabinetti per quasi 400 persone accolte. Alcuni di loro erano costretti a
dormire per terra per mancanza di posti letto e di spazio. Gli immigrati erano perlopiù
marocchini, ma c’erano anche immigrati subsahariani che provenivano principalmente
da Mali, Nigeria e Costa d’Avorio. Nell’agosto del 1997, la APDH dichiarò: “Duermen
a la intemperie, cuentan con una sola comida al día y disponen de unos servicios
médicos totalmente insuficientes” (Idoia Noain, Más de 800 inmigrantes africanos
esperan hacinados en Melilla cruzar el Estrecho, El País, Madrid, 13 agosto 1997).
Secondo l’APDHA, nonostante le condizioni di vita nella Granja fossero
insostenibili, l’ordine di chiusura della struttura fu dato solo nel 1999, quando in essa si
trovavano 1500 persone (Lara 2014: 15 – 16).
45
Nel frattempo, l’accampamento di Calamocarro di Ceuta vide aumentare
vertiginosamente il numero d’immigrati accolti, provenienti dai vari stati, tra i
Camerun, Guinea, Senegal, Nigeria, Sierra Leone, Angola, Zaire, Etiopia, Sudan ed
Eritrea. Nell’ottobre del 1999 erano 2500 gli immigrati ospitati (il campo era stato
progettato per accogliere 900 persone), i quali vivevano in condizioni disastrose (Lara
2014: 17). Il giornalista Pedro de Tena descriveva così l’accampamento:
“La densidad demográfica equivale a 150000 personas por km2, como si se
agolparan sus 2000 habitantes en el rectángulo de un campo de fútbol… sin
agua corriente, sin higiene suficiente, sin calefacción, sin alimentos, sin
intimidad, sin idiomas comunes y sin proyectos posibles. La primera
impresión de Calamocarro es la de un parque zoológico, donde los animales
son los inmigrantes. Huele a mugre sin zotal, a excrementos en libertad, a
fuego salvajes y se desmayan de asco hacia la carretera arroyos podridos de
aguas fecales” (Lara 2014: 17).
2.2. Le iniziative promosse dal governo spagnolo
Nel dicembre del 1997 l’“Instituto de Mayores y Servicios Sociales”
(IMSERSO) e il Ministero degli Interni approvarono un “Programma di Accoglienza e
accesso al lavoro per gli immigrati subsahariani di Ceuta e Melilla” che si era posto
l’obiettivo di decongestionare le due città del giro di due mesi. Gli immigrati che
presero parte al progetto ricevettero una formazione di tre mesi da parte delle ONG che
s’incaricarono di accoglierli e gli venne loro concesso un permesso iniziale di soggiorno
e lavoro. Gli immigrati che riuscirono ad accedere a questo piano d’emergenza furono
1418. L’anno successivo, a causa dell’arrivo di un’altra ondata di immigrati a Ceuta e
Melilla, il progetto venne riconfermato e altri 2828 migranti subsahariani ebbero modo
di prenderne parte. Lo scopo di questo progetto fu quello di integrare gli immigrati nella
comunità, trasferendoli poi in zone dove esisteva una domanda di lavoro
prevalentemente nel settore agricolo o dell’edilizia (Maleno, De Lucas et al. 2006: 14).
Durante il 1999 il governo spagnolo dispose l’operazione “Choque”, con lo
scopo di trasferire alla penisola spagnola tutti gli immigrati della Granja e di
Calamocarro una volta inaugurati i rispettivi CETI. Così, sempre durante l’anno 1999,
46
con una media mensile di circa 500 persone, 7500 immigrati vennero trasferiti dalle
città di Ceuta e Melilla diretti ad Almeria, Alicante, Murcia e Catalogna, le destinazioni
più frequenti in quanto in grado di offrire maggior possibilità di lavoro. Agli immigrati
venivano dati un biglietto ferroviario, 1000 pesetas e un permesso di soggiorno di un
anno. Inoltre, gli veniva dato loro l’indirizzo delle ONG nelle città dove erano stati
indirizzati, anche se spesso queste non venivano avvisate (Lara 2014: 19).
Nell’anno 2000 il governo spagnolo fece chiudere definitivamente il campo di
Calamocarro.
Infine, nel 2001 iniziarono delle campagne informative che avevano lo scopo di
dissuadere l’immigrazione irregolare. Queste campagne vennero portate avanti non
soltanto dalla Spagna ma anche dal Marocco (Maleno Garzón, De Lucas et al. 2006:
19).
2.3. Las vallas: la costruzione delle barriere di separazione
Durante tutti questi anni, continuò senza sosta la costruzione di barriere di
separazione in entrambe le città. Si tratta di barriere fisiche che separano il Marocco
dalle due città spagnole, Ceuta e Melilla, realizzate per impedire e ostacolare
l’immigrazione irregolare e il contrabbando.
È proprio nel periodo tra l’approvazione della Ley de Extranjería del 1985 e
l’adesione al Trattato di Schengen nel 1991, che la Spagna inizia una politica di
crescente chiusura delle frontiere; nasce in questo contesto l’idea di creare delle barriere
di separazione per dividere fisicamente due paesi tanto vicini quanto diversi. Le ragioni
che spinsero il governo spagnolo a investire molti soldi per la costruzione delle barriere,
furono sostanzialmente dettate dal fatto che dagli anni novanta si verificò un’ondata
migratoria senza precedenti verso lo stato spagnolo. Perciò, l’idea fu quella di ricorrere
ad uno strumento per controllare, e allo stesso tempo ostacolare, l’immigrazione
irregolare.
La costruzione delle barriere di separazione ebbe inizio prima a Ceuta nel 1995,
in seguito a un tentativo da parte di gruppo di immigranti di attraversare illegalmente la
frontiera. Vennero costruite così le prime due barriere di separazione (una interna e una
esterna) alte 2,5 m, una strada di circonvallazione pattugliata dalla Guardia Civil e
dall’Esercito, una rete di riflettori alogeni e sensori elettronici acustici e visivi.
47
Nell’ottobre del 1996 venne rinnovato il reticolato, poiché quello
precedentemente utilizzato era facilmente scavalcabile e non svolgeva perciò la sua
funzione principale. Inoltre, fu necessaria la presenza continua di militari lungo la
frontiera per monitorare costantemente l’area.
Nel 1999, venne elevata la valla esteriore (dove con valla s’intende, in italiano,
una palizzata) portandola da 2,5 m a 3,10 m, mentre la valla interna venne rinforzata
attraverso la concertina, ossia il più efficace strumento di protezione perimetrale di aree
che necessitano di sistemi anti intrusione. Nel febbraio del 2000 si conclusero, per un
primo momento, i lavori lungo la frontiera di Ceuta, con barriere di separazione lunghe
8,3 km e di 3,10 m di altezza.
Per quanto riguarda Melilla, invece, la costruzione della barriera di separazione
iniziò nel 1998. Inizialmente venne progettata una sola valla dalla lunghezza di 12 km.
Successivamente, si è però voluto seguire il modello delle barriere di separazione di
Ceuta, così venne costruita una seconda valla, entrambe di 3 m di altezza. Tuttavia, le
barriere di separazione hanno risolto solo parzialmente il problema, poiché molti
immigrati hanno tentato e tentano tuttora di scavalcarle per entrare in terra spagnola
(Lara 2014: 19).
2.4. La nascita dei CETI a Ceuta e Melilla
Durante il completamento delle barriere di separazione, iniziarono i lavori per la
progettazione e costruzione dei CETI che si inaugurarono nel 1999 a Melilla e nel 2000
a Ceuta.
I CETI vennero costruiti durante il primo governo Aznar ed inaugurati
dall’allora ministro delle Politiche Sociali, Manuel Pimentel.
Il CETI di Melilla è stato progettato per accogliere un massimo di 480 persone,
mentre quello di Ceuta, leggermente più grande, è in grado di accogliere 512 persone, in
seguito all’ampliamento effettuato durante l’estate del 2004.
Tuttavia, in entrambe le strutture si raggiunge frequentemente il numero
massimo di posti accessibili andando quindi ad ospitare più migranti del dovuto.
Nonostante ciò, quando un gruppo numeroso d’immigranti riesce a superare le barriere,
questi vengono accolti non soltanto nei CETI ma anche nelle tende dell’Esercito o della
Croce Rossa, mentre molti altri sono costretti a dormire per strada. Nonostante ciò, i
48
CETI tendono a non rispettare il numero esatto di posti a loro designati, accogliendo
molti più immigrati del dovuto56.
È’ possibile quindi descrivere i CETI come due strutture che vengono
esclusivamente utilizzate per accogliere gli immigrati che entrano nel territorio di Ceuta
e Melilla; sono tuttavia strutture aperte, dove gli immigrati possono entrare e uscire
tranquillamente durante il giorno (Lara 2014: 21).
2.5. Gli incidenti e i disordini avvenuti durante l’anno 2005
I responsabili dell’organizzazione APDHA riportano che durante il 2005, in
prossimità delle barriere di separazione, si verificò una serie di incidenti che portò alla
morte di numerosi immigrati mentre tentavano di raggiungere Melilla e Ceuta; in
particolar modo, dall’agosto del 2005 all’ottobre dello stesso anno, avvennero
molteplici assalti alle barriere di separazione di entrambe le città (Lara 2014: 26).
Il primo incidente si verificò il 28 agosto quando un giovane di 17 anni
originario del Camerun morì a Melilla per essersi rotto il fegato cercando di saltare le
barriere di separazione. L’associazione SOS Racismo riporta, nel suo documento
“Informe Frontera Sur 1995 – 2006: 10 años de violación de los derechos humanos”,
che tutti i testimoni presenti quel giorno dichiararono che tale episodio si era verificato
invece a causa di un’aggressione provocata dalla Guardia Civil, la quale fece un uso
sproporzionato delle armi anti sommossa. I testimoni dichiararono inoltre che le
aggressioni furono di una violenza abnome giacché gli immigrati venivano colpiti
“como a animales” (Maleno, De Lucas et al. 2006: 37).
Il 27 settembre, la stessa associazione riporta che, circa 500 subsahariani
provarono ad assalire le barriere ma furono fermati dalle Forze Armate marocchine,
dalla Guardia Civil, dalla polizia nazionale e locale: i diversi corpi di sicurezza
utilizzarono abbondantemente armi anti sommossa. Sedici ore dopo, un secondo gruppo
di 500 persone cercò di raggiungere Melilla ma solo 200 di loro ci riuscirono. In quel
momento nel CETI di Melilla alloggiavano 750 persone, quando la capacità massima
della struttura è di 480 e nella città si trovava un totale di 1150 persone in situazione
irregolare. Gli ultimi immigrati arrivati furono costretti a dormire in tende improvvisate
56 Il documento “APDHA – Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2014” riporta che, a marzo
2014, il numero di immigrati ospitati nel CETI di Melila era di 1900.
49
o alle intemperie in ogni angolo della città. Molti di questi immigrati erano richiedenti
asilo e provenienti da paesi in guerra, quali la Repubblica Democratica del Congo, la
Costa d’Avorio o la Nigeria (Maleno, De Lucas et al. 2006: 43 – 44).
La mattina seguente, 600 immigrati scavalcarono le barriere di Melilla con il
risultato di 44 feriti fra immigrati e uomini della Guardia Civil; tra i feriti vi erano
anche delle donne con i loro bambini (Maleno Garzón, De Lucas et al. 2006: 44).
Il 29 settembre cinque persone morirono a causa di colpi di pistola in seguito
all’ennesimo assalto alla frontiera di Ceuta. La Spagna e il Marocco si accusarono
reciprocamente senza ammettere alcuna responsabilità sull’accaduto. Infine, però, le
autorità marocchine dichiararono la propria colpevolezza (Lara 2014: 27).
Il 6 ottobre quasi cento persone riuscirono a oltrepassare le barriere di
separazione lasciando il Marocco. L’APDHA nel suo documento “Derechos Humanos
en la Frontera Sur 2014” riferisce che nella stessa mattinata queste persone vennero
prelevate da Melilla e trasferite in aereo a Malaga. La stessa notte, un altro aereo in
partenza da Malaga e diretto in Marocco, lasciò la Spagna con a bordo 73 immigrati.
Non è chiaro se si è trattato dello stesso gruppo di persone.
Secondo l’APDHA l’espulsione di queste persone presentò numerose
irregolarità:
- in primo luogo, il giudice che si occupò del caso aveva ordinato il
trasferimento delle persone in questione a Fuerteventura, tuttavia non
vennero mai trasferiti in quest’isola. Difatti gli immigrati, senza alcuna
autorizzazione, viaggiarono prima a Malaga in aereo, successivamente in
autobus fino a Algeciras, dove vennero imbarcati per Tangeri e consegnati
alle autorità marocchine;
- non gli venne permesso di richiedere asilo politico, nonostante rientrasse
nei loro diritti. Non gli venne data, inoltre, la traduzione dei documenti che
dovevano obbligatoriamente firmare;
- secondo quanto denunciato dall’associazione Pro Derechos de la Infancia
(PRODEIN) e SOS Racismo, un importante numero di immigrati risultava
ferito e non ricevette l’adeguata attenzione medica;
50
- con questa deportazione, lo stato spagnolo violò gravemente il Diritto
Internazionale, in particolar modo l’Art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene e trattamenti crudeli o degradanti secondo cui “No
State Party shall expel, return ("refouler") or extradite a person to another
State where there are substantial grounds for believing that he would be in
danger of being subjected to torture”57.
SOS Racismo y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
presentarono un ricorso di contenzioso amministrativo per la difesa dei Diritti
Fondamentali dell’uomo poiché i 73 immigrati furono messi in situazione di pericolo in
quanto vennero espulsi e inviati in un paese dove si stavano commettendo delle
violazioni dei Diritti Umani. Le stesse associazioni invocarono la violazione di tre
articoli della Costituzione Spagnola (Lara 2014: 28 – 30).
2.6. Il rafforzamento delle barriere di separazione
Il governo spagnolo, in risposta ai vari episodi avvenuti durante il 2005, decise
di rafforzare ulteriormente le barriere di separazione di Ceuta e Melilla (Lara 2014: 31).
Si decise quindi di incrementare quelli che vennero eufemisticamente definiti
“medios disuasorios”, attraverso nuovi marchingegni, la collocazione di concertine
della morte e l’impiego di 720 soldati lungo le frontiere delle due città spagnole. Il
Marocco a sua volta impiegò circa 16000 uomini per il pattugliamento delle due aree
(Miguel González, El Gobierno refuerza con más medios la valla fronteriza, El País,
04/10/2005).
Lo scopo di questo rafforzamento fu quello di dissuadere gli immigrati ad
dall’assalire le barriere. Infatti, le concertine, poste fra le due barriere già esistenti di
Ceuta e Melilla, possono causare gravi ferite se l’immigrato dovesse cadere
accidentalmente tra di esse, poiché la concertina è caratterizzata dalla presenza di
taglienti lame (Lara 2014: 31).
57 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,
OHCHR, New York, 1987.
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
51
Inoltre, il Governo prese la decisione di elevare ulteriormente le barriere di
separazione portandole da tre a sei metri di altezza, oltre a costruire una terza valla di
due metri che ha lo scopo di impedire il passaggio alla prima e seconda valla.
A causa delle continue lamentele e controversie inerenti alle ferite provocate
dalle lame presenti sulle barriere di separazione, il premier socialista José Luis
Rodríguez Zapatero le fece togliere nel 2007. Tuttavia, la concertina di Ceuta è stata
mantenuta nella sua integrità mentre in quella di Melilla le lame vennero sostituite con
della corda tridimensionale sebbene la parte esterna della valla, ossia quella del lato
marocchino, rimanesse inalterata (Lara 2014: 32).
2.7. L’immigrazione clandestina tra il 2006 e il 2012
Tra il 2006 e il 2012 si ridussero i tentativi di assalto alle barriere di separazione
rispetto agli anni passati, tuttavia, secondo Zamorano Galán, durante questi anni si
verificarono comunque episodi di estrema violenza da parte delle forze dell’ordine di
entrambi i paesi, anche se il Marocco ha sempre esercitato una maggiore violenza
rispetto alla Spagna (Zamorano Galán 2013: 14).
La pressione militare e politica che il Marocco svolgeva attraverso i costanti
blitz nel monte Gurugù e l’appoggio della Guardia Civil spagnola che quasi
giornalmente sorvolava la zona con un elicottero per intercettare i clandestini e
informare i suoi collaboratori marocchini in materia d’immigrazione, portava gli
immigrati a raggiungere e assalire le barriere di separazione per cercare di salvare la
propria vita.
Lo stesso Zamorano Galán afferma che sono molti i testimoni che dichiararono
che se gli immigrati venivano catturati dalle forze dell’ordine marocchine queste spesso
gli fratturavano le mani o le braccia, le caviglia o le gambe, prima di abbandonarli nella
zona di frontiera tra l’Algeria e il Marocco (Zamorano Galán 2013: 15).
Anche Médecins Sans Frontières denunciarono che: “Los heridos presentan
traumatismos diversos en cráneo, tórax, brazos y piernas, fracturas de manos y dientes,
así como contunsiones y cortes en cabeza, cara y pies” (Zamorano Galán 2013: 15).
Secondo José Palazón, responsabile della ONG PRODEIN di Melilla, il numero
massiccio di clandestini che cercano di entrare nelle città autonome è provocato
52
principalmente dal Marocco, il quale, con un eccesso di violenza e retate, fa sì che molti
immigrati raggiungano disperatamente le barriere di separazione per salvarsi la vita.
Lo stesso autore, in un’intervista fatta nel 2012 per il giornale Diagonal Global
dichiarò quanto segue:
“Al igual que en el 2005 los saltos son consecuencia directa de la
presión del ejercito marroquí sobre los asentamientos que los inmigrantes
tienen en las proximidades de Melilla. Dicha presión obedece con toda
claridad a intereses bilaterales políticos y económicos de Marruecos y
España, siendo además, una forma de tener una presencia ante la UE que de
otra forma no podrían tener ambos países” (Anonimo, "En la frontera la
violencia estatal española y marroquí alcanza niveles intolerables",
Diagonal Global, 10/09/2012).
2.8. Il tragico salto alla “valla” di Melilla: l’episodio del 25 aprile 2013 e le sue
conseguenze
Il 25 aprile del 2013 un numeroso gruppo di persone provenienti dall’Africa
subsahariana, approfittando della scarsa presenza di militari marocchini e dell’assenza
della Guardia Civil all’orizzonte, decisero di saltare la tripla valla di Melilla (Zamorano
Galán 2013: 45).
Secondo quanto riportato dai testimoni, gli immigrati provarono a saltare la
barriera di separazione la notte precedente, tuttavia decisero di rimandare al giorno
successivo a causa della numerosa presenza di soldati nella zona di frontiera. Infatti, era
necessario che ci fossero poche guardie in modo da poterle facilmente schivare.
Scalare le barriere di separazione è un’impresa tutt’altro che facile: Zamorano
Galán spiega che le barriere vanno scalate a piedi nudi in modo da inserire i piedi tra i
fili di ferro poiché con le scarpe si rischia di scivolare. Tuttavia, la scalata a piedi nudi è
molto lesiva perché la barriera del lato marocchino è caratterizzata da un reticolo a
spirale che presenta lame comunemente chiamate a “lingua di serpente”. Dopo aver
superato la prima barriera di 6 m di altezza, si va incontro a corde tridimensionali che
rendono difficile il movimento e danno un’errata percezione di ciò che vi sta sotto;
dopodiché si dovrà scalare un’altra barriera alta quanto la prima. Ciò che rende
53
ulteriormente difficoltosa la scalata sono le pietre lanciate dai soldati marocchini agli
immigrati, ma anche i lunghi pali ricoperti di chiodi con i quali vengono aggrediti. Una
volta arrivati in terra spagnola, gli immigrati devono fuggire a piedi nudi per non farsi
catturare dagli agenti spagnoli.
La Guardia Civil, infatti, fa largo uso di armi che sparano palline di acciaio
ricoperte di gomma. Teoricamente queste palline andrebbero lanciate per terra per poi
rimbalzare al fine di non creare danni permanenti alle persone, tuttavia, spesso le forze
dell’ordine tirano i colpi direttamente alle persone che, a vari metri di altezza, stanno
scalando le barriere (Zamorano Galán 2013: 45 – 46).
L’episodio del 25 aprile risulta quindi un caso isolato, poiché non si è soliti
assistere a un gruppo numeroso di immigrati che riescono a oltrepassare completamente
le barriere di separazione ed entrare in Spagna. Tuttavia, una volta arrivati in terra
spagnola, vi erano due furgoncini delle forze dell’ordine che aspettavano i migranti, in
seguito a segnalazioni ricevute; gli agenti poi riuscirono a chiudere loro la strada
bloccandoli di fronte a un garage di un domicilio. Ventuno, dei cinquanta immigrati che
si trovavano in quella situazione, furono costretti a salire a bordo dei due furgoncini
della Guardia Civil, i restanti immigrati, invece, opposero una resistenza pacifica
alzando le braccia e gridando “por favor señor” (Zamorano Galán 2013: 48).
In quel preciso momento, secondo quanto riferito da testimoni, alcuni membri
del corpo di polizia intervennero facendo uso di gas lacrimogeni, che penetrarono
all’interno dell’abitazione appartenente a Mustafa Aberchán, ex sindaco ed ex
presidente della città di Melilla negli anni 1999 – 2000 (Zamorano Galán 2013: 48 –
49).
Per quanto riguarda l’uso di gas lacrimogeni, le forze dell’ordine hanno sempre
negato di averne fatto uso.
Davanti alla drammatica situazione in cui si trovavano i clandestini, il
proprietario dell’abitazione aprì loro la porta per evitare che si esercitasse ulteriore
violenza nei loro confronti, offrendogli assistenza medica poiché laureato in medicina.
Finalmente si arrivò a un accordo fra gli agenti di polizia, gli immigrati e la
persona che li accolse in casa: gli immigrati sarebbero usciti dall’abitazione e scortati a
piedi fino al CETI di Melilla, per assicurarsi che nessuno li espellesse fuori dal confine
spagnolo.
54
L’arrivo al CETI fu un’esplosione di allegria, tutti ballavano, cantavano si
abbracciavano e pregavano. (Zamorano Galán 2013: 49 – 51).
Nell’ottobre del 2013, in seguito ai vari tentativi di assalto alle barriere, il
governo di Mariano Rajoy decise di ricollocare le lame nell’intera valla di Melilla oltre
ad aggiungere una maglia di ferro che impedisce l’introduzione delle dita nella stessa.
Tale decisione provocò un’ondata di proteste, in particolar modo dopo che il
presidente del Consiglio dichiarò che non si sapevano esattamente quali potessero
essere gli effetti delle lame sulle persone mentre, in un secondo momento, dichiarò che
avrebbero potuto provocare soltanto ferite superficiali.
Dopo che venne presa la decisione di rinforzare le barriere di separazione con
nuovi dispositivi atti a rendere il passaggio più difficoltoso, diverse personalità
spagnole, e non, si batterono per verificare la legalità di tali strumenti. Fra questi c’è il
procuratore generale Torres-Dulce, il quale annunciò l’apertura di un’indagine sul
ricollocamento delle lame nella valla di Melilla.
Tuttavia, il 18 dicembre del 2013, il Parlamento spagnolo, votò il rigetto della
proposta di ritirare le lame dalle barriere di Ceuta e di Melilla, con l’unica spiegazione
che “no existe una alternativa tan eficaz”, secondo quanto affermato dal Ministro degli
Interni, Jorge Fernández Díaz.
Il 13 gennaio del 2014 Cecilia Malmström, Commissario europeo per gli affari
interni, confermò che le lame nella valla di Melilla non vanno contro la legislazione
dell’Unione Europea, sebbene abbia raccomandato di impiegare mezzi alternativi per
vigilare le frontiere di entrambe le città.
Ciò nonostante, sia il Parlamento e sia l’Unione Europea riconoscono la
pericolosità e la possibile violazione dei Diritti Umani che l’istallazione e l’esistenza
delle concertine presuppone (Lara 2014: 37 - 38).
2.9. La tragedia del 6 febbraio 2014 nella città di Ceuta
Il 6 febbraio del 2014, nelle prime ore del mattino, circa 300 persone uscirono da
distinti punti dei boschi in prossimità di Ceuta, nei quali erano soliti vivere, e si
diressero a nuoto verso la spiaggia di Ceuta, El Tarajal.
Le forze marocchine, vedendoli in mare, smisero di intervenire, ma fu proprio in
questo momento che intervenne la Guardia Civil spagnola situata lungo i frangiflutti.
55
Inizialmente, le forze dell’ordine si misero a sparare in aria per convincere le persone a
non proseguire, poi iniziarono a sparare verso di loro con pallini di gomma, colpendo i
loro corpi e il salvagente che gli immigrati avevano addosso. I testimoni presenti
riferirono inoltre che la Guardia Civil impiegò anche armi anti sommossa, in particolare
gas lacrimogeni, in maniera del tutto spropositata poiché non si considerava una
situazione di grave minaccia (Maleno Garzón, Sánchez Sánchez et al. 2014: 13).
Nel rapporto condotto dai membri del collettivo Ca-minando fronteras intitolato
“Informe de análisis de hechos y recompilación de testimonios de la tragedia que tuvo
lugar el 6 de febrero de 2014 en la zona fronteriza de Ceuta”, sono registrate le
testimonianze dei sopravvissuti di quella mattinata, che così raccontano:
“La policía marroquí ha intentado retenernos pero no podía porque
éramos muchos. Hemos atravesado todos los controles y hemos llegado al
agua. Cuando estábamos en el agua la Guardia Civil ha constatado que algo
pasaba, han salido y han empezado a dispararnos al cuerpo. Disparaban y
los flotadores se pinchaban. De golpe veo un humo que se eleva desde el
agua, era el gas lacrimógeno que lanzaban, eso ahogaba a las personas.
Personalmente me he desmayado, la única imagen que me ha quedado en la
cabeza porque mi amigo, con quien iba siempre y con el que he llegado a
Marruecos ha perdido su vida” (Maleno Garzón, Sánchez Sánchez et al.
2014: 13).
“La primeras veces han disparado al aire, cuando se han dado cuenta
de que estábamos llegando a la parte española, pasábamos la ‘desviación58,
entonces han disparado a los cuerpos. A mí la primera bala me ha llegado a
la espalda y la segunda a la mandíbula” (Maleno Garzón, Sánchez Sánchez
et al. 2014: 15).
Almeno quindici persone morirono affogate cercando di raggiungere la costa
spagnola. Secondo quanto raccontato dai sopravvissuti, al momento degli spari gli
immigrati si lasciarono prendere dal panico poiché non riuscivano a restare a galla a
58 Con “desviación” si fa riferimento alle scogliere artificiali che separano il territorio marocchino e
quello spagnolo.
56
causa dei salvagente bucati e, inalando i gas lacrimogeni che gli erano stati lanciati
contro di loro, avevano grosse difficoltà respiratorie. Molti ritornarono a nuoto in
Marocco di propria volontà, altri invece venivano spinti dalla Guardia Civil (che in
parte si trovava su un’imbarcazione) verso il Marocco, nonostante il fatto che
chiedessero aiuto (Maleno Garzón, Sánchez Sánchez et al. 2014: 14 - 15).
La rabbia di fronte ai cadaveri dei compagni morti sulla spiaggia, l’impunità
degli agenti che esercitavano la forza senza che nessuno li fermasse e vedere il secondo
gruppo di persone rimandate in Marocco, fece sì che gli immigrati tirassero pietre
contro la torre di controllo in cui si trovavano alcuni degli agenti.
“Cuando vimos los cuerpos en el suelo hemos rezado y cantado el
himno nacional y después hemos cogido piedras y hemos lanzado piedras al
‘mirador’. Estábamos nerviosos. Los guardias continuaban tirando incluso
después de tener los cuerpos allí y al lado marroquí” (Maleno Garzón,
Sánchez Sánchez et al. 2014: 15).
“Pensabamos que los españoles nos salvarían y cuando vimos los
cuerpos en el suelo del otro lado, nos hemos enfadado, dijimos que no era
normal” (Maleno Garzón, Sánchez Sánchez et al. 2014: 15).
Secondo quanto dichiarato dalla APDHA, la Guardia Civil spagnola non offrì in
nessun momento alcun tipo di aiuto alle persone, né in mare né una volta arrivati sulla
terra ferma, anzi impiegarono incessantemente armi e gas contro di essi. Le sole ventitré
persone che riuscirono ad arrivare sulla costa furono immediatamente espulse dal
territorio spagnolo e rispedite in Marocco, violando la legislazione spagnola e
internazionale (Lara 2014: 42). Non vennero chiamate neanche la Guardia Costiera e la
Croce Rossa e inoltre non venne preso in considerazione il protocollo di salvataggio
marittimo, nonostante il fatto che ci fossero delle persone in mare in acque spagnole
(Lara 2014: 42).
Tutti questi elementi hanno portato molte organizzazioni a iniziare azioni legali,
come ad esempio la red Migreurop e la APDHA (Lara 2014: 40 – 41).
57
Il quotidiano digitale eldiario.es espose, nel suo articolo “Mentiras oficiales: las
1001 versiones sobre la tragedia de Ceuta” pubblicato il 7 febbraio 2014, le molteplici
versioni officiali che gli agenti della Guardia Civil e i responsabili politici fornirono per
giustificare le proprie azioni. Le bugie iniziarono da parte della Delegazione del
Governo di Ceuta e dal Direttore Generale della Guardia Civil, i quali mentirono
sull’utilizzo di armi anti sommossa. In un secondo momento questi ultimi ritrattarono
affermando però che erano stati utilizzati soltanto contro le barriere e mai in acqua.
Successivamente le autorità incolparono gli immigrati della violenza esercitata contro
gli agenti, per poi offrire video manipolati sui fatti accaduti. Finalmente il Ministro
degli Interni ammise l’utilizzo di armi anti sommossa in acqua ma negò di aver espulso
gli immigrati fuori dal territorio spagnolo. Anche in questo caso, in un secondo
momento, fu ritrattato ciò che era stato inizialmente detto sostenendo che le persone
furono invece rimpatriate legalmente (Sánchez, Mentiras oficiales: las 1001 versiones
sobre la tragedia de Ceuta, eldiario.es, 07/02/2014).
Tuttavia, né las Cortes Generales né il Governo sono riusciti a definire
chiaramente i fatti, né a individuare chi diede l’ordine di sparare sugli immigrati che
cercavano di raggiungere la riva e neanche chi decise di omettere l’obbligo di prestare
soccorso. Il risultato quindi fu la mancata determinazione delle responsabilità (Lara
2014: 43).
3. Ceuta e Melilla oggi
Ceuta e Melilla sono tutt’oggi mete di arrivo di moltissimi immigrati che
attraversano il continente africano per cercare una vita migliore in Europa. Nonostante
ciò, essi vedono ancora queste due città autonome come luoghi in cui sosteranno
momentaneamente in attesa di poter entrare nella penisola spagnola o in qualsiasi altro
paese europeo. Questo fenomeno prende il nome di migrazione di transito, secondo cui
Ceuta e Melilla rappresentano pertanto esclusivamente un territorio di passaggio verso
la destinazione tanto sognata (Bondanini 2014: 195).
3.1. Chi sono gli immigrati che arrivano a Ceuta e Melilla?
Come si è già accennato, gli immigrati che si trovano e cercano quotidianamente
di raggiungere Ceuta e Melilla sono principalmente persone provenienti dall’Africa
58
subsahariana, in particolar modo nigeriani, ghanesi e maliani. Oltre ad essi, attualmente
Melilla ospita anche gruppi di siriani scappati dalla guerra civile che devastando dal
2011 il loro paese.
A Ceuta e Melilla si trovano anche immigrati magrebini anche se questi
preferiscono recarsi direttamente alla Penisola piuttosto che fare una sosta nelle due
città autonome.
Secondo Gómez Fayrén e Bel Adell, i subsahariani che arrivano a Ceuta e
Melilla si dividono principalmente in due gruppi: i francofoni e gli anglofoni. I
francofoni sono generalmente persone umili e semplici, buoni lavoratori, abituati al
lavoro nei campi e al piccolo commercio. Sono persone socievoli, rispettose e con un
carattere aperto; passano la maggior parte del tempo lavorando, tuttavia sviluppano uno
spiccato interesse nell’imparare la lingua e i costumi del paese che li ospita per potersi
integrare al meglio.
Gli anglofoni, invece, sono cittadini che provengono principalmente da paesi in
cui vi è la guerra e per questo si mostrano tristi, spenti e sofferenti. Sono persone che
hanno dovuto sopportare le dittature militari che devastano le città distruggendo scuole,
ospedali e privano la popolazione dei servizi di base. In genere provengono da famiglie
benestanti e per questo si muovono preferibilmente in aereo e arrivano con denaro,
telefoni cellulari e vestiti di marca. Il loro carattere è diverso da quello della
popolazione francofona. Essi presentano un atteggiamento di superiorità e un carattere
ribelle (Gómez Fayrén e Bel Adell 2008: 4 – 5).
Ovviamente queste sono generalizzazioni che non si adattano perfettamente alla
singola persona.
Per quanto riguarda il genere dei migranti possiamo dire che la sex ratio risulta
assolutamente sproporzionata, poiché il 90,12% dei migranti sono uomini e il restante
9,88% sono donne. Tuttavia, si può osservare negli ultimi sette anni un progressivo
aumento di donne migranti come risultato di una maggior presa di coscienza delle
donne verso sé stesse (Gómez Fayrén e Bel Adell 2008: 9).
Solo poche persone raggiungono la Spagna come rifugiati politici, poiché
generalmente la protezione dei rifugiati può avvenire anche all’interno del continente
africano. Infatti, alcuni subsahariani preferiscono rifiutare la protezione come rifugiati
59
politici per richiedere lo statuto d’immigrato economico in modo da raggiungere la
Penisola.
A differenza degli africani del nord, che generalmente lasciano il continente per
cercare di migliorare le condizioni di vita della famiglia d’origine, realizzando spesso
un trasferimento familiare, i subsahariani sono quasi sempre espressione di un progetto
migratorio individuale appoggiato, a volte, dalla propria famiglia o da amici senza che
questi chiedano nlla in campo.
Come già evidenziato, i motivi che spingono i subsahariani a partire sono
perlopiù dovuti alla situazione politica difficile dei paesi di provenienza, a causa delle
guerre, della mancanza di promozione personale o di mobilità sociale, a causa di
persecuzioni religiose e mancanza di prospettive future.
Il 50% di questa compagine di migranti considera la situazione economica della
propria famiglia disastrosa, mentre l’altra metà sostiene il contrario.
Le aspettative dei migranti sono spesso molto elevate e si scontrano molto
facilmente con una realtà che si presenta più ostile di quello che essi avevano
immaginato; tuttavia, il loro desiderio è quello di arrivare in Europa per ottenere un
buon lavoro e metter su famiglia.
Secondo Gómez Fayrén e Bel Adell, è difficile stabilire quanti subsahariani
siano arrivati in Spagna fino ad ora, ciò che invece possono affermare con certezza è
che il flusso migratorio non si fermerà ma continuerà ad aumentare anno dopo anno,
oltre a farsi più complesso a causa dell’incremento migratorio di donne e bambini
(Gómez Fayrén e Bel Adell 2008: 4 – 12).
3.2. Non solo uomini: le donne migranti
Da meno di dieci anni il fenomeno migratorio ha iniziato a interessare non solo
gli uomini ma anche le donne, e questo è dovuto in parte al superamento, in alcuni paesi
africani, dell’immagine di donna-oggetto atta solo alla procreazione e alla cura della
casa.
Secondo il rapporto “Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2014”
dell’associazione APDHA, le donne che transitano nelle città di Ceuta e Melilla
soffrono tuttavia di una tripla discriminazione: la prima, per il semplice fatto di essere
donne; la seconda, per essere straniere; e la terza, per la situazione d’insicurezza
60
personale in cui esse si vengono a trovare, ossia in un ambiente in cui è facile avere a
che fare con l’illegalità (Lara 2014: 35).
Lo stesso rapporto descrive così le migranti subsahariane: “Se trata de un
colectivo specialmente vulnerable expuesto a abusos y situaciones de discriminación
(incluso malos tratos y explotación) ocultas en la mayoría de las ocasiones” (Lara 2014:
35).
Le donne molto spesso hanno scarse conoscenze dei metodi contraccettivi e
delle malattie sessualmente trasmissibili, e ciò porta ad un’alta percentuale di donne che
rimangono incinte durante il viaggio o sul suolo europeo a causa della pratica della
prostituzione (Gómez Fayrén e Bel Adell 2008: 9).
Gómez Fayrén e Bel Adell concordano nell’affermare che anche in questo caso
esistono importanti differenze fra le donne provenienti dai paesi francofoni e anglofoni.
Le prime, che sono la minoranza, sono generalmente più colte e hanno alle spalle studi e
carriere lavorative. Viaggiano sole o vengono aiutate da un uomo che viene ritrovato
lungo il tragitto. Le donne anglofone invece sono solitamente analfabete e senza una
posizione lavorativa affermata. Generalmente queste donne arrivano in Spagna
attraverso l’inganno, ossia pagando intermediari che le finanziano il viaggio con la
promessa di un lavoro stabile o corsi di studio nella Penisola, alla fine però si ritrovano
implicate nel giro della prostituzione senza la possibilità di uscirne (Gómez Fayrén e
Bel Adell 2008: 7).
Come dichiara il giornalista Toni Martínez nel suo articolo “Las mujeres que
transitan por Ceuta y Melilla sufren una triple discriminación” nel giornale digitale
LaMarea, lo stato civile delle donne migranti è principalmente “sposata” con una
minoranza di nubili. Tuttavia, negli ultimi anni stiamo assistendo a un aumento del
numero di donne migranti non coniugate rispetto a quelle che hanno già costruito un
loro nucleo familiare. Le donne migranti, in questo caso, spesso fuggono da mancanza
di opportunità lavorative, dalle poche aspettative di sviluppo personale, dai bassi salari
o dall’assenza di servizi socio sanitari di base.
Il lavoro svolto dalle donne subsahariane a Ceuta e Melilla è principalmente
quello domestico, caratterizzato da orari di lavoro massacranti. Lo stipendio solitamente
è piuttosto basso, oscillante tra i 150 e i 300 euro al mese. È un tipo di lavoro che non
obbliga il datore ad assicurare il proprio dipendente quindi spesso le donne si trovano
61
senza assicurazione sanitaria (Martínez, “Las mujeres que transitan por Ceuta y Melilla
sufren una triple discriminación”, LaMarea, 22/04/2014).
3.3. Non solo adulti: i minori migranti
Il migrante che arriva a Ceuta e Melilla non è soltanto un adulto ma anche un
minore. Risulta infatti preoccupante la crescita del flusso di minori che abbandonano il
continente africano per entrare in Europa. È molto frequente, infatti, che i giovani
africani scappino dalle loro famiglie per intraprendere da soli il viaggio.
I bambini che si trovano nelle due città autonome non provengono unicamente
dall’Africa subsahariana, ci sono anche molti bambini marocchini o bambini che
provengono da paesi in guerra, come la già menzionata Siria.
L’APDHA sostiene che per anni a Ceuta e Melilla sono stati violati numerosi
diritti, praticando espulsioni irregolari non soltanto di adulti ma anche di bambini, come
lo scandalo, riportato dall’associazione stessa, avvenuto nel novembre del 1998 quando
tre poliziotti marocchini denunciano coraggiosamente l’espulsione irregolare e il
maltrattamento di minori marocchini da parte delle forze armate nella città di Ceuta.
L’espulsione seguiva uno schema ben preciso: si facevano salire i minori sui furgoncini
della polizia con il pretesto di praticare loro il vaccino contro la filaria per poi, invece,
trasportarli oltre la frontiera spagnola.
I bambini passavano ore intere dentro i furgoncini, i quali versavano in
condizioni di pessima salubrità perché venivano utilizzati per il trasporto di pesce o
verdura destinati al CETI. In risposta ai fatti accaduti, la Delegazione del Governo e la
Città Autonoma, invece di compiere le indagini sul caso, diedero vita a campagne di
protezione nei confronti dei poliziotti, descritti come uomini onesti, e campagne di
diffamazione contro le ONG accusandole di divulgare informazioni false e denigranti
(Lara 2014: 20).
Nel corso degli ultimi anni sono stati denunciati le condizioni disumane in cui
vivono i bambini, non soltanto per strada ma anche nei centri sociali, e il trattamento
discriminatorio che alcuni di essi ricevono. I giornalisti Ana Carbajosa e Diego Estrada
descrivono, nel loro articolo “Cientos de niños malviven en centros de inmigrantes en
España”, il CETI di Melilla:
62
“En Melilla, basta poner un pie a las puertas del CETI para darse
cuenta de que este no es un lugar adecuado para los menores. La
abrumadora presencia de niños resulta tan evidente, que a ratos, las puertas
del centro parecen la salida de un colegio. A través de las verjas se percibe
la falta de espacio. A casi cualquier ora, decenas de niños corretean con la
cara tiznada entre los subsaharianos renqueantes y heridos tras alguno de los
saltos de la valla y sorteando en ocasión a los antidisturbios que acuden a
poner orden cuando el ambiente se calienta” (Ana Carbajosa e Diego
Estrada, “Cientos de niños malviven en centros de inmigrantes en España,
El País, 05/06/2014).
Attualmente i CETI di entrambe le città si ritrovano affollati e accolgono molte
più persone rispetto al numero originariamente pensato. Il risultato è che si hanno
strutture sporche e insalubri, dove i bambini si ammalano spesso e l’assistenza sanitaria
è insufficiente rispetto al numero di bisognosi. I criteri di trasferimento degli immigrati
alla Penisola danno, teoricamente, priorità alle famiglie con bambini; tuttavia, la
numerosa quantità di rifugiati siriani, che a partire da ottobre 2013 sono arrivati a Ceuta
e Melilla, hanno congestionato le pratiche di trasferimento (Ana Carbajosa e Diego
Estrada, Cientos de niños malviven en centros de inmigrantes en España, El País,
05/06/2014).
L’antropologa Jiménez Álvarez afferma che maggior parte dei bambini migranti
proviene da famiglie disastrate e molto povere oppure si tratta di bambini orfani che
vivono per un certo periodo della loro vita in orfanotrofi per poi essere lasciati in tenera
età per andare a cercare fortuna altrove. Molto spesso i bambini sono analfabeti o hanno
una bassa scolarizzazione. Una volta arrivati a Ceuta o Melilla mendicano per strada o
svolgono qualche piccolo lavoro per cercare di ottenere i soldi per arrivare nella
Penisola. La loro età media oscilla fra i tredici e i sedici anni, però ci sono anche
bambini che hanno solo otto anni (Jiménez Álvarez 2004: 423).
63
3.4. Come vengono raggiunte Ceuta e Melilla dai migranti?
I migranti che dal continente africano giungono a Ceuta e Melilla percorrono, a
seconda del luogo di partenza o dei mezzi di trasporto a loro disposizione, dei tragitti
differenti.
I magrebini percorrono un tragitto più breve, avvantaggiati dalla prossimità di
paesi quali Algeria, Libia e Marocco, mentre i subsahariani sono obbligati a percorrere
un tragitto più lungo e sicuramente più pericoloso.
I magrebini, tendenzialmente più ricchi dei subsahariani, raggiungono il
Marocco per vie aeree o comunque spostandosi in automobile. Due degli snodi
principali sono la città di Tripoli o la città di Gadames in Libia.
Le agenzie International Centre for Migration Policy Development (ICMPD),
European Police Office (Europol) e Frontières extérieures (Frontex) hanno identificato
nel 2007 le tre rotte principali dell’immigrazione clandestina africana nel loro dossier
“Document de Travail des Partenaires Arabes at Européens pour la Gestion Conjointe
des Flux Migratoires Mixtes”: la prima via aveva come punto di partenza la regione del
Corno d’Africa, la seconda e la terza portavano i migranti in Marocco partendo dai
paesi dell’Africa Occidentale, come il Camerun e la Nigeria, ma percorrendo due
itinerari leggermente differenti.
Gli snodi principali di queste rotte erano la città di Agadez in Niger e la città di
Tamanrasset in Algeria, anche se è ben noto il fatto che i migranti utilizzavano come
appoggio anche le città di Gao in Mali e di Kufra in Libia. Una volta raggiunto il
confine marocchino o libico, la strada per le città di Ceuta e Melilla rimaneva lunga e
difficoltosa (Simon, Jensen e Leese 2007: 19 – 21).
Dal 2007 ad oggi sono passati diversi anni, il quadro internazionale è cambiato a
causa delle numerose crisi scoppiate in Medio Oriente e nell’Africa sub sahariana e
sicuramente si sono prodotti alcuni cambiamenti poiché le associazioni criminali, ma
anche i migranti stessi, tendono a modificare continuamente e repentinamente i vari
tragitti in modo da non venire ostacolati dalle forze dell’ordine. Per questo motivo è
difficile stabilire quali sono attualmente le rotte principalmente utilizzate.
Il mezzo di trasporto principalmente utilizzato per arrivare a Ceuta e Melilla è
l’automobile, con una percentuale del 48,6%, seguono poi il treno, le imbarcazioni e
64
altri mezzi non specificati. I più poveri, invece, sono costretti a fare l’intero viaggio a
piedi, impiegando anche più di un anno (Gómez Fayrén e Bel Adell 2008: 7).
Come spiegano Gómez Fayrén e Bel Adell, il viaggio che porta i migranti verso
il confine del Marocco prevede numerose tappe che possono essere grandi città,
aeroporti, villaggi nel deserto, oasi o campi di rifugiati: la suddivisione in tappe di
questo viaggio è la naturale conseguenza del fatto che i contrabbandieri si servono di
queste frequenti soste per convincere altre persone a tentare l’impresa (Gómez Fayrén e
Bel Adell 2008: 3).
Il viaggio che ogni migrante si appresta ad affrontare è lungo, pericoloso e
pieno d’imprevisti: i migranti che partono dai paesi dell’Africa Occidentale (Costa
d’Avorio, Mali, Mauritania, Nigeria, Niger, Senegal, ecc.), dopo che nella maggior
parte dei casi hanno versato nelle tasche dei contrabbandieri ingenti quantità di denaro,
impiegano minimo tre mesi per percorrere tutti i chilometri che li separano dai confini
marocchini e libici e lo fanno utilizzando dei mezzi di trasporto improvvisati e adattati,
quali piccoli camion o piccoli autobus. Spesso gli immigrati vengono nascosti in doppi
fondi realizzati appositamente nelle automobili per passare le frontiere senza che gli
agenti di polizia si rendano conto della presenza di immigrati clandestini (Gómez
Fayrén e Bel Adell 2008: 3 - 7).
Lungo il tragitto, i migranti si vedranno più volte sfruttati dalla gente del posto
che approfitta del loro stato di bisogno, impiegandoli in lavori il più delle volte
sottopagati o al costo di un biglietto dell’autobus.
Il motivo per cui molti migranti si affidano ai contrabbandieri è che con il
passare degli anni i sistemi di vigilanza e i mezzi di sicurezza istallati lungo le frontiere
di Ceuta e Melilla sono diventati sempre più complessi, così i migranti per poter
attraversare i confini si affidano ai contrabbandieri. Questi ultimi agiscono tuttavia nella
piena illegalità e sono tra i principali obiettivi della polizia spagnola (Gómez Fayrén e
Bel Adell 2008: 3 - 7).
Se ci si affida ai contrabbandieri il costo del viaggio è piuttosto alto, oscillando
fra i 1800 e i 2000 euro e portando gli immigrati ad indebitarsi con le organizzazioni
mafiose.
Tuttavia, non tutti gli immigrati si affidano ai contrabbandieri, infatti coloro che
cercano di scavalcare le barriere di separazione sono solitamente persone che tentano di
65
arrivare in Europa in maniera del tutto autonoma. In questo caso spesso si parla di scelte
obbligate perché i clandestini non hanno abbastanza denaro per pagare le
organizzazione mafiose (Fernández, “Los migrantes cada vez cruzan más a España por
sus propios medios en vez de pagar a mafias”, 20 Minutos, 05/05/2014).
Una volta arrivati in Marocco, tappa obbligatoria per entrare in una delle due
città spagnole, molti subsahariani si ritrovano bloccati senza poter proseguire il viaggio
o ritornare in patria. Il risultato è che per circa sei mesi gli immigrati devono sostare
obbligatoriamente nello stato marocchino aspettando il momento propizio per tentare il
superamento delle barriere di separazione o trovare un metodo alternativo, sempre
illegale, per entrare a Ceuta o Melilla.
Fra le due città autonome, Melilla è soggetta a un maggior pericolo di assalto
rispetto a Ceuta, e questo a causa del fatto che la barriera di separazione di Melilla è più
facilmente scavalcabile, mentre quella di Ceuta è più difficilmente attraversabile a causa
della sua particolare posizione geografica e conformazione del terreno che crea ostacoli
ai migranti.
A causa del fatto che dal 2006 è diventato molto più difficile entrare a Melilla e
Ceuta, Zamorano Galán nel suo lavoro “El salto de la valla: 25/04/2013 Melilla.
Anotaciones y reflexiones” spiega che i migranti hanno incominciato ad utilizzare nuovi
itinerari: alcuni, ad esempio, si dirigono verso le isole Canarie servendosi di barconi da
pesca comunemente utilizzati dai pescatori locali, altri cercano di raggiungere l’isola di
Lampedusa che si trova a pochi chilometri dalle coste tunisine, altri ancora traggono
vantaggio dal disordine politico che si è venuto a creare a seguito della caduta del
regime di Gheddafi e salpano dalle spiagge libiche. Inoltre, si sono sviluppate anche
nuove mete migratorie negli isolotti di sovranità spagnola che si trovano nel mar
Mediterraneo, come l’isola di Alborán, l’isolotto di Perejil, le isole Chafarinas, Peñón
Vélez de la Gomera e Peñón de Alhucemas (Zamorano Galán 2013: 31 – 36). I tragitti
studiati da Zamorano Galán risalgono al 2013, tuttavia non abbiamo fonti attuali che
dimostrino se negli ultimi due anni si sono verificati dei cambiamenti.
66
3.5. I CETI e i servizi da loro offerti a Ceuta e Melilla
Il CETI di Ceuta è ubicato in una zona periferica, non lontano dall’ex campo di
Calamocarro. Si eleva sul terreno di una collina e si estende su una superficie irregolare
di 12815 m2. La sua capacità di accoglienza è di 512 persone. (Deu del Olmo 2014: 8).
Il CETI di Melilla si trova anch’esso nella periferia della città, in una zona
marginale studiata appositamente in modo tale che tutto sia visibile, senza aree nascoste
tra la frontiera, il CETI e la valla, rappresentando quindi uno spazio facile da controllare
a livello visivo. La sua superficie è di circa 17000 m2 e la sua capacità di accoglienza è
di 480 persone.
Al loro interno i CETI hanno una via centrale che li attraversa per intero e una
serie di padiglioni. Ogni padiglione presenta diverse stanze e bagni e ogni stanza è
composta da otto letti. Le stanze degli uomini sono separate da quelle delle donne e si
trovano in padiglioni diversi, mentre i bambini generalmente dormono con le madri.
All’interno dei CETI ci sono anche spazi ludici, come ad esempio un campo da
calcio, un campo da pallacanestro e uno da cricket. E per finire un’area riservata allo
studio (Bondanini 2014:194).
Come enunciato nel sito web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
www.empleo.bob.es, i CETI continuano tutt’oggi ad offrire una serie di servizi agli
immigrati accolti, quali:
- servizi di alloggio e ristorazione;
- servizi di tipo sociale, come ad esempio supervisione ed esecuzione delle
attività e programmi diari del Centro, partecipazione degli utenti alle attività formative e
culturali e controllo di entrata e uscita secondo il protocollo;
- interventi di sostegno psicologico, che hanno lo scopo di ridurre l’impatto
emotivo del fenomeno migratorio e di vigilare la salute mentale dei residenti;
- servizi di tipo sanitario;
- servizio di consulenza legale;
- servizi di formazione e gestione delle attività di ozio e tempo libero, come ad
esempio, lezioni di spagnolo, formazione inerente alla prevenzione delle malattie
67
sessualmente trasmissibili, lezioni d’informatica, attività ludiche e sportive e l’accesso
alla biblioteca del Centro59.
Secondo Bondanini, i CETI possono benissimo essere identificati come dei non-
luoghi, ossia spazi che non si possono definire né identitari, né relazionari e neanche
storici. Bondanini aggiunge che questi spazi non creano identità individuale e
relazionale, alimentando invece solitudine e omogeneità. Il rischio è quello di
omologare le persone sotto lo stigma del soggetto irregolare e quindi potenzialmente
pericoloso, non riconoscendo la sua singola storia e personalità (Bondanini 2014: 195).
3.6. E una volta superata la valla?
E’ stato calcolato che durante il 2014 circa 35000 subsahariani sono riusciti a
superare la valla di Melilla, e che, la maggior parte di essi, si trovano ora nel territorio
peninsulare. Solo per il fatto di essere riusciti a oltrepassare la tanto temuta barriera di
separazione, ciò anima molti altri subsahariani a tentare il lungo viaggio.
Il Ministro degli Interni, Jorge Fernández Díaz, ha dichiarato che sono 80000 le
persone in attesa di lasciare lo stato marocchino per entrare nella città autonoma di
Melilla (Paradinas, ‘El ministro de Interior ya no sabe cómo meter miedo: “Hay 80.000
inmigrantes esperando saltar la frontera”’, El Plural, 04/03/2014).
Benché le barriere di separazione rappresentino dei mezzi realizzati per
contenere l’immigrazione clandestina, il numero di immigrati che riesce effettivamente
ad entrare nelle Città Autonome è molto alto.
Ma dove vanno tutti coloro che riescono a scavalcare la barriera e a superare la
frontiera? Il giornalista Villaécija spiega nel suo articolo “La vida después de la valla”
pubblicato su elmundo.es il 19 gennaio 2015 che, salvo i rari casi in cui si verificano le
espulsioni illegali realizzate dalle forze dell’ordine marocchine o spagnole, la maggior
parte di essi vengono trasferiti nella Penisola. In primo luogo però, gli immigrati
passano qualche mese nei CETI presenti nelle città di Ceuta e Melilla. I più fortunati
rimangono nelle due città autonome solo per tre mesi, altri invece rimangono fino a due
anni. All’interno dei CETI, gli immigrati cercano di risolvere la questione della
59 Guía Laboral - Actuaciones dirigidas a inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección
internacional, apatridia y protección temporal. Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI),
tratto da: www.empleo.gob.es
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_15/contenidos/guia_15_37_3.htm (Consultato in data
20/01/2015).
68
clandestinità chiedendo, nella maggior parte dei casi, il diritto di asilo per ottenere i
documenti e poter restare legalmente in Europa (Raquel Villaécija, “La vida después de
la valla”, El Mundo, 19/01/2015).
Per quanto riguarda il diritto di asilo, la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani, firmata il 10 aprile del 1948, dichiara, nell’art. 14, che:
“Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from
persecution.”60
Inoltre, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Asilo Territoriale adottata, con
Risoluzione 2312, il 14 dicembre del 1967 nell’art. 1, paragrafo 1 dichiara che:
“Asylum granted by a State, in the exercise of its sovereignty, to persons entitled to
invoke article 14 of the Universal Declaration of Human Rights, including persons
struggling against colonialism, shall be respected by all other States” (Dichiarazione
delle Nazioni Unite sull’asilo territoriale – Risoluzione 2312, 14/12/1967: s.p.).
Tuttavia, non tutte le richieste d’asilo vengono però accettate. La stessa
Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’Asilo Territoriale, nell’art. 1, paragrafo 2,
afferma che:
“The right to seek and to enjoy asylum may not be invoked by any
person with respect to whom there are serious reasons for considering that
he has committed a crime against peace, a war crime or a crime against
humanity, as defined in the international instruments drawn up to make
provision in respect of such crimes” (Dichiarazione delle Nazioni Unite
sull’asilo territoriale – Risoluzione 2312, 14/12/1967: s.p.).
Inoltre il questore ha la facoltà di trattenere il richiedente asilo quando questo
viene fermato alla frontiera in assenza di un documento di identità valido o di
documenti di viaggio. È un caso che si verifica quasi sempre, dal momento che colui
che scappa da un paese perché perseguitato, difficilmente avrà con sé la
documentazione che dimostri la propria identità oppure perché i contrabbandieri
60 The Universal Declaration of Human Rights, United Nations, 10/04/1948.
http://www.un.org/en/documents/udhr/ (Consultato in data 17/03/2015).
69
incitano gli immigrati a stracciare i loro documenti in modo da non essere riconosciuti e
quindi rispediti nel paese di origine (Bermejo e Ngalikpima 2010: 3).
Difatti, secondo quanto affermato dal giornalista Burgo Muñoz nel suo articolo
“España niega el asilo al 90% de las personas que lo solicitan” il 9 dicembre del 2013,
soltanto il 10% delle persone che fanno richiesta di asilo politico in Spagna riescono ad
ottenere lo Statuto di Rifugiato. Secondo Patricia Barcena, direttrice di CEAR Euskadi,
questa bassa percentuale non è dovuta al fatto che ci siano meno richiedenti asilo, ma
perché “España y Europa incumplen sistemáticamente la normativa europea” (Burgo
Muñz, “España niega el asilo al 90% de las personas que lo solicitan”, eldiario.es,
09/12/2013).
Ciò comporta che non tutti gli immigrati riescono ad ottenere i documenti per
poter rimanere legalmente sul suolo europeo. Infatti, una volta che un immigrato
s’introduce illegalmente all’interno delle città di Ceuta e Melilla, sia che lo faccia
saltando le barriere di separazione sia attraverso qualche altro stratagemma, questi si
trasforma in un immigrato irregolare. La polizia poi andrà a identificare l’immigrato e lo
condurrà all’interno dei CETI, dove potrà alloggiare. Nel frattempo il Governo inizia
contro di lui un processo che definiremo di espulsione, regolato dalla Legge Organica
4/2000 sui Diritti e sulle Libertà degli Stranieri in Spagna e sull’Integrazione sociale.
Mentre il Governo porta avanti tutti i passaggi burocratici del caso, gli immigrati
possono liberamente circolare all’interno delle città di Ceuta e Melilla, ma soltanto in
esse perché la loro condizione d’irregolarità non gli permette loro di ottenere un
biglietto aereo o navale valido per l’Europa continentale. Tuttavia, in entrambe le città,
gli immigrati sono uomini liberi e anche la loro permanenza nei CETI è totalmente
volontaria (Portillo Rodrigo 2014: s.p.).
Se il Governo, alla fine del processo di espulsione, chiede al potere giudiziario
che autorizzi l’internamento dell’immigrato in un Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE) e il giudice lo autorizza, allora il migrante verrà trasferito alla
Penisola. In caso contrario gli verrà inflitta una multa. Un CIE è uno stabilimento dove
gli immigrati sono privati della loro libertà; a differenza dei CETI di Ceuta e Melilla,
nei CIE gli immigrati non possono entrare e uscire liberamente. Ogni settimana, quindi,
circa una cinquantina di immigrati vengono trasferiti nella Penisola per essere introdotti
all’interno dei CIE. Infatti, nelle due città autonome non esistono queste strutture,
70
benché siano due realtà in cui ogni giorno entrano, o tentano di entrare, illegalmente
moltissimi immigrati clandestini.
Tutti i CIE si trovano nella Penisola, in particolar modo a Madrid, Barcellona,
Murcia, Malaga, Algeciras e Valencia. Il motivo per cui gli immigrati vengono internati
all’interno di queste strutture è dato dal fatto che il Governo non può controllare gli
spostamenti dei singoli immigrati, poiché questi, sapendo di essere implicati in un
processo di espulsione, potrebbero allontanarsi da Ceuta e Melilla. Per tale motivo viene
autorizzato che queste persone vengano localizzate in una struttura chiusa fino a quando
il tribunale emette la sentenza (Portillo Rodrigo 2014: s.p.).
Il governo Zapatero stabilì la durata massima di sessanta giorni d’internamento
degli immigrati nei CIE. Nel caso in cui la sentenza non venga emessa dal giudice entro
i sessanta giorni previsti, il migrante che era stato condotto in giudizio non potrebbe
essere più internato nel CIE perché il suo caso sarebbe già stato preso in considerazione
precedentemente. In questo caso, gli immigrati si ritroverebbero liberi dovendo, però,
contattare un avvocato per presentare ricorso contro l’ordine di espulsione (AA.VV.
2011: 16).
Uno dei problemi principali che si riscontrano in queste situazioni è che spesso
l’immigrato mente sulle proprie origini o semplicemente nasconde la propria
nazionalità, obbligando così il Governo a chiedere informazioni ai governi africani
affinché essi lo riconoscano e acconsentano al suo rimpatrio.
Quando arriva il decreto di espulsione, si intima l’immigrato ad abbandonare il
territorio nazionale in un arco di tempo che va dai sette ai trenta giorni. Nel caso in cui
l’immigrato non parta entro i termini, le autorità competenti procederanno con la sua
detenzione per poi procedere, nell’arco di settantadue ore, alla sua espulsione. Inoltre,
nell’eventualità che l’espulsione non fosse possibile nell’intervallo prestabilito, si
chiederà alle autorità giudiziarie l’ingresso dell’immigrato all’interno dei CIE. Laddove,
però, l’immigrato sia stato internato precedentemente all’interno di tale strutture, questo
non potrà essere nuovamente detenuto61.
Nel caso in cui l’immigrato decida di rimanere in Spagna nonostante la sentenza
di espulsione, deve sapere che la sua posizione verrà considerata irregolare e che
61 Ejecución de la resolución de expulsión. Tratto da: www.interior.gob.es
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/expulsion (Consultato
in data 24/02/2015).
71
comunque gli verrà proibito di entrare in qualsiasi altro paese europeo per un periodo di
tempo che va da tre a cinque anni (aumentabile fino a dieci anni in casi eccezionali), il
che renderà difficile regolarizzare la sua situazione in un futuro prossimo (AA.VV.
2011: 11).
3.7. Expulsiones en caliente
Il termine “expulsiones en caliente” si applica principalmente quando le forze
dell’ordine dello stato spagnolo consegnano alle autorità marocchine gli immigrati
irregolari intercettati nei territori di sovranità spagnola senza procedere per le vie legali
normalmente previste (Martínez Escamilla 2014: 19).
Uno dei principi alla base del diritto internazionale è quello che concerne la
protezione della figura del rifugiato. Il rifugiato è definito quale individuo che, per
fondata paura di persecuzione per ragioni essenzialmente politiche, ma anche
economiche, sociali, di razza e religiose, è costretto ad abbandonare lo Stato di cui è
cittadino e dove risiede, per cercare rifugio in uno Stato straniero (Perruchoud 2004:
52).
Il principio di non-refoulement è il caposaldo della protezione internazionale dei
rifugiati, il cui art. 33 della Convenzione del 1951 dispone che:
"No Contracting State shall expel or return ('refouler') a refugee in
any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or
freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality,
membership of a particular social group or political opinion."62.
Una persona non diventa un rifugiato perché è stata riconosciuta come tale, ma è
riconosciuta come tale proprio perché è un rifugiato. Ne consegue che il principio di
non-refoulement si applica non solo ai rifugiati riconosciuti, ma anche a coloro il cui
status non è stato formalmente dichiarato. Quindi, gli immigrati africani che lasciano il
proprio paese per cercare di entrare in Europa vengono riconosciuti come rifugiati e per
questo aventi il diritto di abbandonare il proprio paese per recarsi in una nazione in
grado di soddisfare la propria persona in quanto essere umano (AA.VV. 2007: 2 – 3).
62 UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement, novembre 1997.
http://www.refworld.org/docid/438c6d972.html (Consultato in data 24/02/2015).
72
Ciò che non è legale è entrare illegalmente all’interno di uno stato, tuttavia,
questo non implica che le forze dell’ordine dello stato in questione debbano espellere gli
immigrati clandestini senza prima avviare un processo (Martínez Escamilla 2014: 20).
Il Marocco e la Spagna, per aver più volte espulso i migranti che si trovavano
illegalmente nel loro stato e per averli trasferiti in paesi con reale rischio per la loro
incolumità o in condizioni di mettere seriamente in repentaglio la loro vita, come ad
esempio l’episodio avvenuto il 6 ottobre del 2005 quando il Marocco abbandonò 700
immigrati nel deserto del suo stesso stato, hanno più volte violato il principio di non-
refoulement commettendo gravi crimini internazionali.
In tutta questa vicenda le responsabilità ricadono, in realtà, su entrambi i
governi: nonostante ciò, in questi anni si la Spagna che il Marocco hanno cercato di
nascondere i propri errori e si sono limitati ad incolpare la propria controparte.
Alcune delle giustificazioni che il Ministro degli Interni Jorge Fernández Díaz
ha fornito per motivare le espulsioni “en caliente” avvenute nel suo Paese sono state le
seguenti: in primo luogo, le espulsioni venivano considerate dallo stato spagnolo come
una sorta di divieto d’ingresso nei confronti di cittadini stranieri che cercavano di
entrare all’interno del territorio europeo; una seconda argomentazione è stata che è
possibile espellere, senza procedere con processo alcuno, tutte le persone che entrano
clandestinamente nel territorio nazionale; infine, il ministro ha fatto riferimento
all’Accordo ispano-marocchino inerente alla circolazione di persone, al transito e alla
riammissione di stranieri entrati illegalmente, firmato a Madrid il 13 febbraio del 1992
(Martínez Escamilla 2014: 6 – 12). Tale accordo fu redatto con lo scopo di fermare, o
comunque diminuire, il flusso migratorio clandestino all’interno dei due paesi. Il primo
articolo dichiara che:
“Las autoridades fronterizas del Estado requerido readmitirán en su
territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado
requirente, a los nacionales de paises terceros que hubieren entrado
ilegalmente en el territorio de este último procedente del Estado
requerido”63.
63 Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la
circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en
Madrid el 13 de febrero de 1992, BOE num. 10, 25/04/1992.
73
Tuttavia, secondo Martínez Escamilla, l’Accordo firmato dai due paesi non
rappresenta un titolo giuridico sufficiente per giustificare le espulsioni illegali prodotte
dalle forze dell’ordine dei rispettivi paesi (Martínez Escamilla 2014: 12).
Zamorano Galán, nel già citato lavoro “El salto de la valla: Melilla Anotaciones
y reflexiones”, afferma che nelle città di Ceuta e Melilla, le espulsioni venivano
realizzate attraverso delle piccole porte che si trovano in alcuni punti delle barriere di
separazione e che sono state progettate esclusivamente per portare a termine lavori di
riparazione e manutenzione delle stesse e non possono essere utilizzate per nessun’altra
ragione. Inoltre, egli aggiunge che le espulsioni a Ceuta e Melilla non sono stati episodi
isolati e singolari, ma che questi avvengono, tutt’ora, alla luce del giorno senza il timore
di ripercussioni penali.
Nonostante questo stato di cose, molte organizzazioni internazionali sono
intervenute denunciando i comportamenti portati avanti dai due stati confinanti, come
ad esempio PRODEIN e APDHA anche se non sono ancora riuscite ad ottenere dei
risultati concreti sul piano penale (Zamorano Galán 2013: 52).
Amnesty International criticò aspramente le dichiarazioni fatte dal Ministro degli
Interni Jorge Fernández Díaz, il quale affermò di voler modificare la Ley de Extranjería
per permettere liberamente le espulsioni senza procedimenti legali per gli immigrati che
arrivano illegalmente nel territorio spagnolo.
“Estas practicas ilegales deben parar inmediatamente. Ninguna persona debe ser
expulsada de una manera directa o indirecta a un lugar donde su vida, su integridad o su
libertad puedan correr peligro” commentò Esteban Beltrán, direttore della Amnesty
International spagnola (Anonimo, “Cambiar la Ley de Extranjería para facilitar
expulsiones “en caliente” viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos”, Amnesty
International, 24/02/2014).
3.8. Possibili soluzioni al fenomeno della migrazione clandestina a Ceuta e
Melilla
Come più volte ricordato, ilIl motivo per cui Ceuta e Melilla esercitano una
notevole attrazione agli occhi degli immigrati africani è dettato dal fatto che queste due
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-8976 (Consultato in data 25/02/2015)
74
città costituisconi le uniche frontiere terrestri dell’Unione Europea all’interno dell’intero
continente africano e, per questo motivo, più facilmente raggiungibili.
Secondo la APDHA, durante tutti questi anni, le risposte del Governo spagnolo
alle ondate migratorie provenienti dall’Africa subsahariana sono state principalmente
sempre le stesse: barriere di separazione sempre più alte e più complesse, l’impiego
costante del corpo militare e di polizia per il controllo delle frontiere, milioni di euro
investiti, l’implementazione di nuovi e sofisticati sistemi tecnologici oltre all’impiego
continuo di elicotteri e pattuglie. Tuttavia, pare che tutti gli sforzi impiegati sembrino
vani, poiché l’assalto alle frontiere non si è mai fermato, anzi esso è in continuo
aumento, e i metodi per aggirare i controlli alle frontiere sembrano sempre più ricercati
ed efficienti (Lara 2014: 56).
Inoltre, la stessa associazione ha criticato aspramente l’attuale modo di gestire
l’immigrazione da parte dallo Stato, sostenendo che questa porta con sé gravissime
violazioni dello stesso, oltre a causare enormi sofferenze ai migranti in cerca di una vita
migliore in Europa. I tentativi di attraversare le frontiere delle due città autonome non
cesseranno: nonostante vengano costruite barriere di separazione sempre più alte e
mettano nuove concertine, nonostante venga aumentato il numero delle forze
dell’ordine, i migranti continuano a tentare di entrare nel suolo europeo e altri innocenti
muoiono. Il più delle volte si tratta di persone che non hanno niente da perdere, senza
famiglia e con una situazione economica precaria, ed è proprio questa condizione che
spinge gli immigrati a cercare fortuna in un altro paese, anche se questo significa
mettere in repentaglio la propria vita (Lara 2014: 56 – 57).
Proprio per questi motivi è necessario che, non soltanto la Spagna, ma anche
l’Unione Europa intervenga per mettere in marcia importanti cambiamenti per quanto
riguarda la situazione dei migranti.
L’associazione APDHA ha proposto quattro possibili soluzioni per gestire al
meglio l’immigrazione clandestina: in primo luogo, facilitare e velocizzare la
regolarizzazione di queste persone; in secondo luogo, facilitare e garantire l’arrivo
nell’Unione Europea a coloro che sono in condizione di sollecitare la protezione
internazionale in qualità di richiedenti asilo; in terzo luogo, adottare criteri di
riunificazione familiare per permettere l’entrata nell’Unione Europea a coloro che
hanno familiari risiedenti in essa, concedendo visti di ingresso temporaneo; infine,
75
concedere un numero significativo di visti ai paesi africani da cui vengono la maggior
parte dei migranti (Lara 2014: 57 – 58).
76
III Capitolo
1. Il fenomeno dell’immigrazione nei mass media
Oggigiorno il fenomeno dell'immigrazione risulta essere un tema frequente nei
mezzi di comunicazione di massa di spagnoli. La presenza ricorrente e costante di
servizi riguardanti l’immigrazione fa capire che ci troviamo di fronte a un fenomeno che
preoccupa notevolmente le istituzioni e, di conseguenza, la società. Infatti, negli ultimi
quindici anni, parallelamente a un aumento considerevole nel numero di lavoratori
stranieri che ogni anno raggiunge il territorio spagnolo, i mass media hanno
incominciato a mostrare una realtà prima di allora sconosciuta nella società come, ad
esempio, la diversità di opinioni che suscita il fenomeno migratorio, le norme e le leggi
che si ipotizzano durante i dibattiti politici legati al tema, i casi di cronaca che vedono
implicate persone di origine straniera e le differenze culturali spesso percepite come
problematiche da risolvere (Xambò 2010: 161 - 162).
Prima di analizzare come i giornali digitali spagnoli affrontano il tema
dell'immigrazione, è necessario dare spazio alla teoria dell'Agenda Setting, ossia la
teoria che sta alla base delle notizie riportate dai mass media.
Il giornalista Maxwell McCombs e il professore universitario di giornalismo
Donald Shaw sono i principali studiosi che si sono dedicati alla teoria dell’Agenda
Setting. Nell’articolo “The Agenda-Setting function of mass media” pubblicato
su“Public Opinion Quarterly”, gli stessi dichiararono:
“In choosing and displaying news, editors, newsroom staff, and
broadcasters play an important part in shaping political reality. Readers
learn not only about a given issue, but also how much importance to attach
77
to that issue from the amount of information in a news story and its position.
In reflecting what candidates are saying during a campaign, the mass media
may well determine the important issues—that is, the media may set the
“agenda” of the campaign” (McCombs, M. E. / Shaw D. L., The Agenda-
Setting function of mass media, Vol. 36 No. 2., Estate 1972).
Perciò, secondo la teoria dell’Agenda Setting, i mezzi di comunicazione di
massa influenzano notevolmente il modo di pensare dei lettori o degli ascoltatori,
agendo in maniera del tutto celata, utilizzando diverse tecniche a seconda del tipo di
media in questione: i quotidiani lo fanno attraverso la scelta delle notizie da collocare in
prima pagina, attraverso la lunghezza data ad ogni articolo, la grandezza del titolo, la
scelta delle immagini e le parole utilizzate nel testo; la televisione, invece, lo fa
attraverso la scelta delle persone da intervistare, l’ordine e la durata data ad ogni
servizio e la scelta di determinati video da accompagnare alla voce narrante (McCombs
2003: 1).
Ne deriva, quindi, una percezione deformata e condizionata delle questioni
politiche, economiche e sociali pilotata, in gran parte, dai mezzi di comunicazione di
massa. Dagli studi sviluppati sulla base di questa prospettiva teorica, gli specialisti
hanno avuto modo di osservare che ogniqualvolta viene data maggiore enfasi mediatica
a un determinato tema o questione sociale, maggiore si rileva la preoccupazione
dell’opinione pubblica su quel determinato tema (Igartua Perosanz, Muñiz Muriel et alt.
2007: 93).
Nel 2012, il Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) condusse una ricerca
inerente all’immigrazione intitolata “Actitudes hacia la inmigración (VI)” che aveva
l’obbiettivo di indagare a proposito del modo in cui veniva percepito il fenomeno
migratorio dalla popolazione spagnola (AA.VV. 2012: 1).
All’interno dell’indagine figurano alcune domande legate al rapporto dei media
con il fenomeno migratorio. In particolar modo, nella domanda numero 32a è stato
chiesto agli intervistati dove hanno avuto modo di sentire commenti negativi nei
confronti degli immigrati; la seconda risposta, per numero di votanti, è stata “en la
televisión” ottenendo un 33% preceduta soltanto da “en la calle” che ha ottenuto una
percentuale del 64,3% mentre la radio, la stampa e internet hanno ottenuto
78
rispettivamente 6,2%, 6,1% e 4,6%. La domanda 34 chiedeva, invece, che tipo di
immagine emergesse dai mezzi di comunicazione di massa in riferimento agli immigrati
e la risposta con la percentuale più alta è stata “más bien negativa” che ha ottenuto un
36,3%. (AA.VV. 2012: 13).
Il linguista olandese Teun Van Dijk sostiene che le persone vengono influenzate
inconsciamente dai mezzi di comunicazione di massa per quanto riguarda il tema
dell’immigrazione. Infatti, lo studioso afferma che è interessante osservare come le
tematiche legate all’immigrazione non sono quasi mai uguali a quelle che si applicano
al resto della popolazione; inoltre l’autore aggiunge che i media spagnoli trattano il
fenomeno migratorio conferendogli l’immagine di una vera e propria invasione di
massa, associandolo spesso a un problema e non a un vantaggio economico e culturale
per il paese. Basti pensare alle immagini dei barconi pieni d’immigrati provenienti
dall’Africa che sbarcano sulle coste spagnole o alle precisazioni inerenti alle nazionalità
quando i media trattano casi di cronaca nera (Van Dijk cit. in Martínez Lirola 2008: 15).
La scelta di chi intervistare e di chi fare intervenire nei servizi non è per nulla
causale ma, al contrario, fa parte di una logica precisa e segue perciò determinate
dinamiche. Per questo motivo e al fine di far credere che il fenomeno migratorio è un
tema serio e degno di grande rilevanza mediatica, i media utilizzano alcune strategie che
sono tipiche dei mezzi di comunicazione di massa come, ad esempio, il fatto che essi
citino delle fonti autorevoli (le autorità, professori universitari, le forze dell’ordine,
direttori di ONG, ecc.) o che essi menzionino dettagli, cifre e statistiche in grande
quantità. (Martínez Lirola 2008: 16).
2. I giornali digitali
La nascita dei giornali digitali ha rappresentato una vera e propria rivoluzione
nel mondo giornalistico e non solo. Infatti, la possibilità di poter leggere le notizie su
uno strumento portatile (come può essere un telefono cellulare, un computer o un tablet)
ha permesso di potersi informare con maggiore comodità e rapidità. Inoltre, questi
dispositivi comportano anche un considerevole risparmio energetico e cartaceo.
Tuttavia, i giornali in formato cartaceo non sono scomparsi nella società ma
rappresentano una scelta alternativa al formato digitale.
79
Nel 1994 iniziarono a comparire in rete i primi giornali digitali spagnoli.
Tuttavia, il numero di questi quotidiani era ancora limitato perché, come spiega Ramón
Salaverría, a quel tempo la rete internet era poco diffusa nella società e veniva utilizzato
solo da specialisti (Ramón Salaverría cit. in Rost 2006: 100 - 101). Nel 1996 vengono
introdotte le versioni digitali dei più importanti quotidiani digitali spagnoli, ossia El
País, El Mundo e ABC, fino ad arrivare all’anno 2000 quando è possibile consultare ben
78 giornali digitali, ossia più della metà dei giornali cartacei che vengono pubblicati in
Spagna (Rost 2006: 102).
I quotidiani cartacei e quelli digitali non sono uno l’esatta copia dell’altro ma, al
contrario, presentano alcune differenze degne di nota.
L’informatico danese Jakob Nielsen ha studiato le diverse modalità di lettura del
lettore di quotidiani cartacei e digitali affermando che le persone che leggono le notizie
dalle pagine web difficilmente leggono i testi parola per parola. Questo è dato dal fatto
che la lettura su dispositivi elettronici è molto più difficoltosa e richiede uno sforzo
maggiore da parte del lettore, egli si concentrerà piuttosto su alcuni punti del testo come
le parti in neretto o le citazioni. Inoltre i lettori di giornali digitali difficilmente
leggeranno tutte le notizie del giorno presenti sul quotidiano, andando a cogliere invece
le notizie di maggior interesse personale (Jakob Nielsen cit. in Rost 2006: 137 – 138).
Un’altra caratteristica che differenzia il giornale cartaceo da quello digitale è che
quest’ultimo il più delle volte è consultabile gratuitamente, salvo alcune eccezioni per le
quali è necessario sottoscrive un abbonamento per poter leggere le notizie. Inoltre, con i
quotidiani digitali è possibile leggere notizie in tempo reale perché in ogni momento
della giornata vengono pubblicati degli articoli, cosa invece impossibile per i quotidiani
cartacei. Grazie ai quotidiani digitali è possibile anche risalire a notizie di vecchia data
perché sono spesso conservate negli archivi del giornale (Rost 2006: 155 - 158).
L’interattività è un’altra grande qualità dei giornali digitali perché dà la
possibilità al lettore di commentare le notizie e confrontarsi con gli altri lettori
attraverso commenti a fine articolo o forum ma anche di mettersi in contatto con il
giornale attraverso indirizzi e-mail.
Il lettore di quotidiani digitali può, quindi, assumere un ruolo attivo
discostandosi dal lettore di giornali cartacei che non ha mai la possibilità di confrontarsi
con il giornalista (Rost 2006: 151).
80
Infine un’ultima caratteristica, ma forse la più importante, è la multimedialità,
ossia la possibilità di avere una molteplicità di contenuti all’interno di un unico
giornale, come ad esempio testi scritti, fotografie e contenuti audiovisivi (Rost 2006:
152).
2.1. L’uso della fotografia nei giornali digitali
I giornali digitali fanno largo uso di fotografie e di video con lo scopo di
facilitare e velocizzare la comprensione delle notizie.
Le fotografie esistono anche nei giornali cartacei ma, in questi ultimi, è dato
maggior spazio al testo proprio perché il giornale cartaceo deve avere un determinato
numero di pagine e deve lasciare spazio anche ad agli altri contenuti. Mentre, per quanto
riguarda i giornali digitali, alcuni possiedono delle vere e proprie sezioni dedicate alla
fotografia e ai reportage fotografici poiché i quotidiani digitali non hanno gli stessi
limiti che ha un giornale cartaceo; un esempio è la sezione “Fotografía” del quotidiano
digitale El País (Rost 2006: 152).
La fotografia oltre ad essere un mezzo di comunicazione in grado di fornire
informazioni dirette e immediate ai lettori, viene spesso usata per attirare l’attenzione
del lettore e, per questo motivo, negli ultimi anni si è fatto ampio uso di immagini
sempre più grandi e colorate. Tuttavia, la fotografia non è uno strumento di
comunicazione indipendente e infatti, il più delle volte, essa è accompagnata da un testo
o da una semplice frase per completare la comprensione (Yuste Robles, Sandoval
Martín e Franco Álvarez 2006: 1 – 2).
Man mano che la tecnologia ha avuto modo di svilupparsi e avanzare, sono nati
dei software specializzati nell’elaborazione e nel ritocco di immagini digitali come ad
esempio Photoshop, il più famoso programma del momento nell’ambito del fotoritocco.
Nonostante i quotidiani debbano raccontare e mostrare una realtà più veritiera possibile,
è anche vero che i giornalisti fanno spesso uso di programmi come Photoshop per
manipolare le fotografie. Bisogna aggiungere che la manipolazione di fotografie non è
nata con la nascita dell’era digitale. Infatti, in passato, i giornalisti erano soliti ritagliare
le foto per farle rientrare negli spazi limitati dei giornali cartacei. Nella storia dei
reportage giornalistici quello che forse fu uno dei primi casi di seria manipolazione
fotografica fu il caso del giornalista Brian Walski che venne licenziato per aver
81
modificato una fotografia da lui stesso scattata con l’obbiettivo di aumentare la
drammaticità. La fotografia in questione ritraeva una scena del conflitto in Irak
avvenuto nel 2003 (Yuste Robles, Sandoval Martín e Franco Álvarez 2006: 7).
Sebbene oggigiorno il fotoritocco sia tutelato dalle grandi agenzie di stampa,
Yuste Robles, Sandoval Martín e Franco Álvarez ritengono che sia bene ricordare che la
manipolazione fotografica non deve diventare una pratica abituale nei mezzi di
comunicazione (Yuste Robles, Sandoval Martín e Franco Álvarez 2006: 7).
Per quanto riguarda il tema dell’immigrazione, Gaona Pisonero ritiene che le
foto che documentano il fenomeno dell’immigrazione siano ripetitive e mai originali. La
loro carica semantica è incentrata sull’orrore, stereotipando il fenomeno migratorio
come realtà dolorosa e tormentata. Un esempio di “orrore stereotipato” si ha quando i
giornali mostrano le foto di gommoni in mare cricche di migranti provenienti
dall’Africa nera. I migranti non arrivano in Spagna solo per mezzo di gommoni o
imbarcazioni improvvisate così come in realtà non tutta la popolazione migrante vive il
fenomeno dell’immigrazione in maniera negativa. È proprio per questo motivo che
sarebbe opportuno trattare il tema dell’immigrazione in maniera più complessa,
declinando l’argomento secondo le sue diverse sfaccettature (Gaona Pisonero 2004: 2).
2.2. L’uso di contenuti audiovisivi nei giornali digitali
L’introduzione e l’impiego di contenuti audiovisivi hanno rappresentato una
vera e propria rivoluzione nel mondo giornalistico.
L’uso dei video nei giornali digitali ha permesso al lettore di ottimizzare i tempi
e semplificare la comprensione delle notizie. Inoltre, attraverso i video, il pubblico
crede che quello che sta osservando rappresenti la realtà dei fatti perché ha modo di
osservare riprese video e audio. Nonostante ciò, bisogna ricordare che il giornalista, già
nel momento in cui sceglie cosa far vedere, cosa tagliare e in quale momento mostrare i
fatti, rende il tutto artificioso e poco oggettivo.
Il direttore del Observatorio y Grupo de Investigación en Migración y
Comunicación (MIGRACOM), Lorite García, si pose la domanda “¿Puede ser
científica y objetiva la mirada audiovisual de la realidad migratoria?”, che altro non è
che il titolo del suo lavoro pubblicato nel 2006. Studiando contenuti audiovisivi inerenti
al fenomeno migratorio, Lorite García sostiene che per quanto l’osservatore s’impegni
82
nel cercare di scorgere una realtà oggettiva dei fatti, i suo sforzi risulteranno vani poiché
l’osservatore sarà influenzato, benché inconsciamente, dalle proprie conoscenze e dal
proprio background culturale (Lorite García cit. in Lario Bastida 2006: 87).
Infatti, sebbene un video sia caratterizzato da audio e immagini in scorrimento,
l’osservazione non potrà essere mai oggettiva perché ogni individuo, in base al proprio
background culturale, alle proprie conoscenze pregresse sul tema e alla propria
predisposizione personale potrebbe interpretare in maniera diversa la notizia.
3. Analisi degli articoli di giornale inerenti all’episodio del 25 aprile 2013 a
Melilla
In questo sottocapitolo andrò ad analizzare come diversi quotidiani digitali
hanno narrato i fatti accaduti a Melilla il 25 aprile del 2013, quando un numeroso
gruppo d’immigrati assalì le barriere di separazione ed entrò nella città.
I quotidiani in questione sono quattro, rispettivamente due nazionali, El País e
El Mundo, e due appartenenti alla città di Melilla, El Diario Digital de Melilla e El
Faro Digital.
In tutti i quattro giornali ho scelto di analizzare gli articoli che, per la prima
volta, hanno raccontato lo svolgimento dei fatti così da poter studiare l’approccio del
giornalista alla notizia.
3.1. El País
L’articolo in questione s’intitola “El líder opositor de Melilla refugia en su casa
a 30 inmigrantes que saltaron la valla”, scritto da Ignacio Cembrero e pubblicato il 26
aprile del 2013 alle ore 00.31, quindi poche ore dopo l’accaduto.
Il titolo fa subito riferimento a Mustafa Aberchán, proprietario dell’abitazione
che ha ospitato gli immigrati, ex sindaco della città e leader della Coalición por Melilla
(CPM), attirando l’attenzione del lettore e traendolo in inganno, poiché presenta il
leader politico come un convinto protettore della figura dell’immigrato clandestino e
conferisce una sfumatura politica ai fatti. Il giornalista si riferisce ad Aberchán con le
parole “el líder opositor” piuttosto che con il suo cognome, poiché El País è un
quotidiano nazionale e perciò non tutta la popolazione spagnola potrebbe sapere di chi
si tratta.
83
Subito dopo il titolo, Cembrero inserisce un sottotitolo che altro non è che una
citazione di Aberchán, “Les he abierto porque no quería heridos ni intoxicados en la
puerta de mi casa”, il quale chiarisce immediatamente le vere motivazioni dell’ex
sindaco.
La notizia presenta numerosi collegamenti ipertestuali che consentono al lettore
di essere rinviato ad approfondimenti sullo stesso tema o su temi similari. Alcuni di
questi collegamenti si trovano al di sotto del sottotitolo, come ad esempio: Melilla,
inmigrantes africanos, inmigración irregular, conflictos fronterizos e molto altro;
mentre nel corpo della notizia troviamo: coalición de Melilla, Mustafa Aberchán64 e el
presidente de Melilla, Juan José Imbroda65.
Il corpo della notizia presenta numerose citazioni. Le citazioni sono, in particolar
modo, di Aberchán, il quale spiega i fatti avendoli vissuti in prima persona, come ad
esempio “había cargas policiales, botes de humo y les tenía aquí apiñados, en la rampa
del garaje, así que, para su seguridad, les dejé entrar” e “en mi casa los treinta
inmigrantes han tenido un comportamiento ejemplar”.
Il giornalista ripete due volte il ruolo politico di Aberchán all’interno dei primi
due paragrafi della notizia: nel primo paragrafo scrive che Aberchán appartiene alla
“Coalición por Melilla”, mentre nel paragrafo successivo ripete il concetto aggiungendo
dei particolari, “Líder de Coalición por Melilla, el principal partido de oposición al PP
que gobierna”, volendo quindi sottolineare che il gesto compiuto da Aberchán è il
risultato del suo orientamento politico.
Nel quarto paragrafo viene citato il giornalista Toñy Ramos che, con le parole
del giornalista Cembrero, spiega i motivi per cui circa 200 immigrati sono riusciti a
saltare le barriere di separazione ed entrare a Melilla. Infatti, secondo quanto spiegato
da Ramos, l’episodio si verificò nel momento del cambio di turno della Guardia Civil
quando, lungo la frontiera, non erano presenti forze dell’ordine. Non è chiaro il punto
esatto in cui gli immigrati sono riusciti a scavalcare le barriere di separazione, entrando
a Melilla poiché le indicazioni sono piuttosto generiche, ossia “a lo largo del perímetro
fronterizo”. Il motivo potrebbe essere dato dal fatto che un cittadino che non vive nella
64 Mustafa Hamed Moh Mohamed Aberchán (Melilla, 17/10/1959) è un politico spagnolo leader del
partito Coalición por Melilla. 65 Juán José Imbroda Ortiz (Melilla 24/06/1944), attuale sindaco e presidente della città autonoma di
Melilla e senatore del Partido Popular.
84
Città Autonoma non sarebbe in grado di identificare i luoghi e vie e quindi le
indicazioni stradali esatte sarebbero risultate superflue o comunque non avrebbero
aiutato il lettore nella comprensione dei fatti.
Successivamente, Cembrero mette in risalto l’atteggiamento aggressivo e
insolente degli immigrati che arrivano a Melilla, scrivendo “no solo recurren a la fuerza
para saltar la valla o acercarse en patera a la ciudad, sino que no se dejan fácilmente
capturar y se enfrentan con palos y cuchillos a las fuerzas de seguridad”. Aggiunge poi
che la domenica precedente sei uomini della Guardia Civil erano rimasti feriti nel
tentativo di fermare i migranti.
Nel terzultimo paragrafo vengono citati l’attuale presidente della Città
Autonoma di Melilla, Juan José Imbroda, e il delegado del Gobierno, Abdelmalik el
Barkani, i quali affermano “El que viene con palos y cuchillos no viene a buscar trabajo,
vienen a otra cosa”, alludendo al comportamento violento degli immigrati.
La Guardia Civil non dà una propria versione dei fatti nell’articolo, tuttavia la
Asociación Unificada de Guardias Civiles afferma che i migranti non sono persone
pacifiche e che si atteggiano a persone indifese solo per evitare di essere espulsi dalla
Spagna immediatamente.
Infine viene fatto riferimento alla pratica delle espulsioni “en caliente” e agli
episodi di espulsione avvenuti nelle acque spagnole agli inizi di marzo 2013.
All’interno di tutto l’articolo non viene mai data la parola agli immigrati, non
risulta alcuna loro citazione e non si è tenuto conto delle motivazioni che hanno spinto i
migranti a superare le barriere e raggiungere la città di Melilla. Inoltre gli immigrati
vengono descritti come persone violente e poco interessate a cercare un impiego e
migliorare le loro condizioni di vita con il risultato di conferire loro un’immagine
85
assolutamente negativa.
La notizia è accompagnata da un contenuto audiovisivo, la cui foto sovrastante è
il fermo immagine che compare nel video.
Il video dura 1 minuto e 41 secondi e si apre con le immagini di una trentina di
immigrati stanchi e affaticati e dai loro pianti e lamenti. Subito dopo compare
l’immagine di Alberchán che cerca di dialogare con loro.
L’unica persona intervistata sarà proprio Alberchán il quale afferma:
“En ningún momento los inmigrantes han tenido un comportamiento
violento sino ejemplar, ejemplar y esquisito. Y cuando digo ‘ejemplar’ y
esquisito’ es porque no puedo decir lo mismo de mi Cuerpo de Seguridad. Y
he dicho en variadas ocasiones que estaban en mi propiedad y que no iba a
permitir en mi propiedad ni derramamiento de sangre ni agresiones. Lo he
dicho una vez, dos veces, tres veces y he procedido abrir la puerta al garaje
porque era inhumano lo que estaba viendo”.
L’attacco di Aberchán fa alle forze dell’ordine spagnole è esplicito e diretto,
inoltre quella di Aberchán è l’unica testimonianza, nell’intero articolo, da cui ne deriva
un’immagine positiva degli immigrati.
Subito dopo l’intervista compaiono le immagini degli immigrati che, uniti in un
unico grande abbraccio, si avviano zoppicanti per le strade di Melilla. Successivamente
si vedono gli abitanti di Melilla che li accolgono con un applauso e seguono il loro
cammino insieme alle volanti della polizia. L’arrivo al CETI è un’esplosione di urla e
felicità. Gli immigrati corrono, urlano e gioiscono consapevoli della loro fortuna.
Nonostante il fatto che nel video compare soltanto l’intervento dell’ex presidente
della Città Autonoma, Mustafa Aberchán, possiamo affermare che lo stesso arricchisce
o meglio equilibria i contenuti del corpo della notizia. Infatti, se nel testo scritto traspare
un’immagine negativa degli immigrati e di compassione nei confronti della Guardia
Civil, nel video, invece, gli immigrati vengono visti come le vere vittime della vicenda
mentre gli agenti delle forze dell’ordine vengono mostrati come soggetti violenti. E’
stato lo stesso Aberchán che, intervistato sull’argomento, ha sottolineato come le forze
dell’ordine abbiano tenuto una condotta aggressiva.
86
3.2. El Mundo
L’articolo in questione s’intitola “El líder de la oposición de Melilla
refugia en su casa a 50 indocumentados” scritto da Paqui Sánchez il 26 aprile 2013 alle
ore 11.52. In questo caso l’articolo è stato scritto il giorno successivo ai fatti e non
poche ore dopo come nel caso dell’articolo su El País; il giornalista, quindi, ha avuto
più tempo per includere nella notizia, oltre il riassunto dei fatti, le dichiarazioni fornite
dagli esponenti politici della città.
Anche in questo caso il titolo trae in inganno il lettore, il quale potrebbe
interpretare i fatti in maniera diversa e, come nel caso dell’articolo su El País, il
giornalista ha preferito utilizzare le parole “líder de la oposición” piuttosto che il
cognome della persona in questione proprio perché si tratta, anche in questa occasione,
di un quotidiano nazionale. Infine è possibile costatare un errore numerico nel titolo
poiché, come chiarito nel sottocapitolo 2.8. della presente tesi, cinquanta è in realtà il
numero totale degli immigrati che riuscirono a superare le barriere di separazione,
mentre furono soltanto ventinove quelli ospitati nell’abitazione di Aberchán.
Sotto il titolo possiamo leggere quattro sottotitoli divisi da elenchi puntati che
forniscono al lettore ad avere un breve riassunto dei fatti. In effetti, le quattro frasi
offerono un esemplare riassunto, spiegando in maniera chiara e concisa cosa è successo
la notte del 25 aprile. Le frasi in questione sono le seguenti: “Entre 150 y 200
inmigrantes han intentado entrar en avalancha / Unos 50 han conseguido entrar
terminando en la casa de Mustafa Aberchán / Les ha abierto la puerta porque ‘no quería
agresiones en su casa’ / Denuncia que les tenían agrupados de forma ‘escandalosa e
inhumana’”.
La notizia è molto lunga e ricca di dettagli, divisa in più sottoparagrafi a
ciascuno dei quali il giornalista ha dato un titolo.
Nella prima parte del corpo della notizia il giornalista fa un riassunto dei fatti
citando soltanto alcune parole di Aberchán senza però inserire frasi complete come, ad
esempio, “violenta”, “peligraba su vida”, “tomada por la Policia” e “escandalosa e
inhumana”. Nel testo viene specificata l’ora e la data del salto con l’espressione “a las
22,00 horas del jueves”, il luogo esatto dove gli immigrati sono riusciti a scavalcare la
valla con la forma “el salto se ha producido entre el Cementerio Musulmán Sidi
Guariach y Villa Pilar” e il motivo per cui l’area in quel momento non era sorvegliata,
87
ossia “la Guardia Civil que en ese momento estaba efectuando el relevo de personal en
el perímetro fronterizo”; il tutto fornisce un arco temporale al lettore che può così
inquadrare bene i fatti. Anche se si tratta di un quotidiano nazionale, il giornalista ha
voluto comunque specificare il luogo esatto in cui è avvenuto il salto, indicando il
cimitero islamico e la Villa Pilar come punti di riferimento.
Come nel caso della notizia riportata su El País, Sánchez sottolinea più volte le
cariche politiche investite da Aberchán negli ultimi anni: “presidente de Coalición de
Melilla (CPM)”, “presidente de la Ciudad Autónoma entre 1999 y 2000” e “líder de la
oposición” e rende esplicite le critiche che Aberchán fa agli agenti della Guardia Civil.
Il primo sottoparagrafo s’intitola “En la casa de Aberchán” e in questa parte
della notizia appaiono le prime dichiarazioni di Aberchán, il quale afferma: “Vi unas
condiciones inhumanas que no se podían soportar y he advertido a la Policía de que si
veía agresiones en mi propiedad, iba a proceder a abrir la puerta del garaje” e,
riferendosi alle scene viste in prima persona, “comportamientos que cualquier
ciudadano no tiene que aguantar”; anche in questo caso il giornalista vuole mostrare al
lettore l’attacco diretto che Aberchán ha fatto alle forze dell’ordine. In seguito si fa
riferimento alla decisione presa dell’ex presidente e dall’agente di polizia Ángel Riesco
di portare i migranti subsahariani al CETI della città.
In riferimento ai fatti, El Mundo pubblica i messaggi che Aberchán divulgò sulla
sua pagina personale di Twitter come testimonianza concreta dei fatti da lui vissuti.
Il secondo sottoparagrafo s’intitola “Reacciones en Twitter”, nel quale il
giornalista fa sapere che Aberchán non è stata l’unica persona a esporsi su Twitter, ma
88
che anche altri cittadini di Melilla hanno pubblicato foto e racconti di quella notte, senza
però soffermarsi su questi. Tuttavia, viene fatto riferimento alla posizione dell’attuale
presidente e senatore della città, Juan José Imbroda, scrivendo ciò che il presidente ha
affermato sul social network: “acabar con las mafias que explotan a inmigrantes, cada
vez más jóvenes y más violentos”, e per fare ciò “hay que modificar la Ley de
Extranjería y habilitar una zona de rechazo inmediata a la frontera” e “poner en valor el
acuerdo España-Marruecos del 92”.
Infine, nell’ultima parte della notizia, che ha come titolo “Debate a flor de piel”,
si fa riferimento al dibattito politico che il fenomeno migratorio solleva nel Paese, come
ad esempio l’intervento della Asociación Unificada de Guardias Civiles la quale si
mostra preoccupata del fatto che questo episodio possa convincere altri immigrati a
tentare l’assalto alle barriere di separazione di Melilla.
L’impressione che deriva da quest’articolo è che ci sia un maggior senso di pietà
e comprensione per gli immigrati che vengono considerati più come vittime che come
persone violente, al contrario di quanto si era potuto leggere dall’articolo pubblicato su
El País. La scelta degli interventi fatti da Imbroda ne è un esempio; infatti, nell’articolo
su El País il presidente accusa gli immigrati di essere persone violente e disinteressate
al lavoro, mentre in quest’articolo Imbroda sembra incolpare in primo luogo le
associazioni mafiose che sfruttano gli immigrati. E’ normale che Imbroda, che riveste
sia la carica di presidente che di sindaco della città, abbia rilasciato agli organi di
stampa numerose dichiarazioni riguardo la vicenda ma vi è la sensazione che i
giornalisti abbiano voluto far riferimento solamente ad alcune frasi specifiche in modo
da fornire una determinata posizione ideologica agli articoli. L’ipotesi è che ciascuna
testata giornalistica abbia deciso di sottolineare quegli aspetti della vicenda che
concordano con la loro posizione politica sul tema dell’immigrazione. Inoltre in
quest’articolo non viene mai fatto riferimento alla condotta violenta degli immigrati.
Per finire, un’altra caratteristica che risulta subito evidente è l’impiego di frasi o
parole in neretto per attirare l’attenzione del lettore su alcuni punti cruciali della notizia
e l’assenza di dichiarazioni da parte dei migranti subsahariani o dagli agenti delle forze
dell’ordine coinvolti nella vicenda.
Il corpo della notizia era accompagnato da un contenuto audio visivo non più
disponibile. Inoltre, a differenza dell’articolo precedentemente analizzato, quest’ultimo
89
risulta essere povero di collegamenti ipertestuali poiché ne ha solo uno, ossia
“inmigración”.
3.3. El Diario Digital de Melilla
Riferendoci a El Diario Digital de Melilla, ho deciso di prendere in analisi due
testi: nel primo caso si tratta semplicemente di una notizia flash preparata e pubblicata
in tarda mattinata da parte della redazione per raccontare velocemente l’accaduto; nel
secondo caso si tratta di un articolo completo pubblicato sul sito web nel primo
pomeriggio e nel quale si fornisce un’analisi più completa e dettagliata dei fatti.
La notizia flash s’intitola “Aberchán refugia en su casa a medio centenar de
inmigrantes” pubblicata il 26 aprile del 2013 alle ore 12.00; quindi molte ore dopo
l’accaduto. Non conosciamo il nome del giornalista, ma solo il fatto che la notizia è
stata scritta dalla redazione.
Anche in questo caso, il titolo attira l’attenzione del lettore, in particolare per
l’impiego delle parole “medio centenar de inmigrantes” invece di “cincuenta
inmigrantes” per dare un’ingannevole percezione numerica a proposito del numero
effettivo di immigrati coinvolti nella vicenda. Inoltre, a differenza dei quotidiani
precedentemente analizzati, in questo caso il giornalista ha deciso di inserire il cognome
del protagonista in questione, ossia Aberchán, poiché il presente è un quotidiano locale
della città di Melilla, di conseguenza l’ex presidente della Città Autonoma è facilmente
identificabile dai cittadini della stessa.
Il corpo della notizia non fornisce molte informazioni, inoltre non risulta chiaro
il motivo per cui Aberchán abbia voluto ospitare gli immigrati in casa propria. Il
giornalista, infatti, non spiega che l’ex sindaco ha compiuto quel gesto poiché voleva, in
primo luogo, proteggere gli immigrati da quello che lui definiva un comportamento
“violento” adottato dagli agenti della polizia.
Tuttavia, si fa riferimento al punto in cui gli immigrati hanno superato la
barriera, indicando con precisione il luogo esatto, ossia “en zona anexa al aeropuerto, y
en las inmediaciones de la carretera de Farhana, donde vive Aberchán”. Anche il
quotidiano El Mundo ha indicato il luogo dove è avvenuto il salto prendendo come
punti di riferimento il Cementerio Musulmán Sidi Guariach e Villa Pilar; in questo il
giornalista utilizza in realtà un’indicazione stradale diversa e forse più precisa poiché
90
indica la via esatta, “carretera Farhana”,dove è avvenuto il salto, facendo inoltre
riferimento alla zona in cui vive Aberchán. Il motivo potrebbe essere dato dal fatto che,
essendo El Diario Digital de Melilla un notiziario diretto principalmente ai cittadini di
Melilla, è possibile fare riferimenti puntuali poiché facilmente individuabili.
Infine, l’ultima frase del corpo specifica che la rete televisiva “Cablemel
Televisión” avrebbe trattato il tema in maniera più dettagliata al telegiornale delle 12.
Nell’intera notizia non è presente alcuna citazione delle persone direttamente
coinvolte nei fatti o delle figure politiche che si sono espresse sulla vicenda e non
presenta neanche alcun collegamento ipertestuale che rimanda a temi similari rispetto a
quello trattato.
Un video di 1 minuto e 44 secondi accompagna il corpo della notizia. Le
immagini in scorrimento sono circa le stesse del video nell’articolo su El País. Tuttavia,
non c’è una voce narrante che spiega i fatti o interviste alle persone presenti, si sentono
invece soltanto le voci di sottofondo degli immigrati che parlano nella loro lingua
madre. In questo caso il video arricchisce il testo poiché già povero di contenuti ma non
favorisce la comprensione poiché la mancanza di una voce narrante costringe il
telespettatore ad interpretare i fatti.
Leggendo questa notizia, il lettore potrebbe rimanere confuso sui fatti i quali
sono narrati in maniera poco chiara e imprecisa. Posso quindi affermare che la notizia
flash così come scritta è incompleta; il testo risulta tuttavia neutrale.
L’articolo di giornale invece s’intitola “Aberchán dice que no le quedó más
remedio que dar refugio a los inmigrantes” pubblicato sempre il 26 aprile alle ore 15.52
dal giornalista José Manuel Guirval. La notizia è stata scritta molte ore dopo l’accaduto,
e questo ha permesso al giornalista di fornire più informazioni rispetto alla notizia flash,
dello stesso giornale, precedentemente analizzata.
Per il titolo dell’articolo il giornalista si è servito di una frase che è stata ripresa
da una dichiarazione che l’ex presidente della Città Autonoma ha rilasciato in seguito ai
fatti da lui vissuti in prima persona. Anche in questo caso è stato inserito il cognome e
non la sua carica pubblica ricoperta.
L’intero corpo della notizia si concentra solamente sul gesto di Aberchán senza
soffermarsi nella descrizione del salto da parte dei migranti. Il giornalista riporta quindi
le parole di Aberchán, il quale spiega la ragione per la quale ha deciso di aprire le porte
91
della sua abitazione ai migranti: il suo obiettivo era quello di proteggerli ed evitare
ulteriori scontri con la Guardia Civil.
Nel secondo e terzo paragrafo della notizia il giornalista riporta la versione dei
fatti, ricca di dettagli, fornita da Aberchán senza però prendere in esame le versioni
degli immigrati o degli agenti della Guardia Civil presenti sul posto; inoltre non è
presente alcun intervento delle figure politiche più importanti di Melilla come invece
sono stati riportati dagli altri articoli analizzati.
Anche in questo caso, la notizia non presenta alcun tipo di collegamento
ipertestuale non permettendo così al lettore di approfondire ulteriormente il tema.
Il tono utilizzato dal giornalista è distaccato e neutrale non facendo trasparire
una presa di posizione del quotidiano.
Il corpo della notizia è accompagnato da un contenuto audiovisivo dalla durata
di 2 minuti e 42 secondi. Nel video una voce narrante ripete esattamente il contenuto
presente nel secondo e terzo paragrafo, intervallato dalla conferenza stampa di
Aberchán.
Nella prima parte del filmato appaiono le riprese video della notte precedente:
l’inquadratura si sofferma sulla via, piena di volanti delle forze dell’ordine, dove vive
Aberachán che nel frattempo tenta di dialogare sia con il capo della Guardia Civil sia
con un numeroso gruppo di immigrati.
La voce narrante, nel frattempo, spiega i motivi per cui Aberachán aprì le porte
di casa sua per accogliere i migranti. In questa prima parte del video viene mostrata
anche una conferenza stampa in cui appare il delegado del Gobierno di Melilla,
92
Abdelmalik el Barkani, che conferma l’uso del gas lacrimogeno da parte delle forze
dell’ordine.
Subito dopo appare una parte della conferenza stampa di Aberchán il quale
ribadisce i motivi che lo hanno spinto a prendere la decisione di accogliere gli immigrati
nel suo domicilio; inoltre fa un riferimento specifico a due uomini della Guardia Civil
che, secondo lo stesso, non avrebbero tenuto la corretta condotta che, come
comunemente ci si aspetta, un agente delle forze dell’ordine dovrebbe avere. Aberchán
continua a esporre la sua dichiarazione e aggiunge che lui aveva già fatto presente in
precedenza la questione al capo della Guardia Civil e che quest’ultimo gli aveva
assicurato che non ci sarebbero state ulteriori violenze. Tuttavia, le condotte delle forze
dell’ordine nei riguardi degli immigrati non cambiarono ed è proprio per questo motivo
che si vide costretto ad aprire le porte di casa sua.
Nel frattempo, oltre alle registrazioni che avevano come soggetto l’ex presidente
durante la conferenza stampa, vengono mostrati anche dei filmati non presenti nei video
precedentemente analizzati, ossia immagini dello scompiglio rimasto nel cortile di casa
dell’ex presidente Aberchán e davanti al suo garage come testimonianza dei fatti
accaduti.
Successivamente la voce narrante continua con la sua descrizione dei fatti, nella
quale si rende noto che i migranti vennero condotti al CETI della città. Le immagini che
accompagnano la voce narrante ritraggono i migranti incamminarsi verso il CETI;
fondamentalmente le immagini che vengono mostrate in questa fase del video sono le
stesse che è possibile vedere nei video che accompagnano le notizie fornite da El País e
dalla notizia flash de El Diario Digital de Melilla.
Infine Aberchán, con tono deciso, si rivolge ai cittadini di Melilla chiedendo di
non criminalizzare gli immigrati, invitandoli a disporsi dalla loro parte, poiché sono le
vere vittime di questo episodio.
In conclusione, non vi è dubbio che questo filmato, tra tutti quelli
precedentemente presi in considerazione ed analizzati, sia il più lungo ed il più
esaustivo; la ragione è che in questa registrazione vengono utilizzate delle immagini e
delle dichiarazioni inedite e precedentemente ignorate che permettono all’ascoltatore di
comprendere l’accaduto in maniera più completa ed esaustiva.
93
Rispetto al video sul quotidiano El País, questo fornisce un intervento più lungo
dell’ex presidente Aberchán. Il motivo potrebbe essere dato dal fatto che, El Diario
Digital de Melilla, essendo un quotidiano locale, ha interesse a trattare più
dettagliatamente un episodio che riguarda direttamente la città stessa. Per questo motivo
nel video su El País non è stato mostrato l’intervento del delegado del Gobierno,
Abdelmalik el Barkani, presente invece in quello locale.
3.4. El Faro Digital
L’articolo in questione s’intitola “Decenas de inmigrantes asaltan la valla de
Melilla y al menos 50 lo consiguen” scritto il 26 aprile 2013. In quest’articolo oltre al
nome del giornalista non compare neanche l’ora di pubblicazione.
Il titolo scelto è molto chiaro e con poche parole il giornalista è riuscito a
riassumere i fatti. A differenza degli articoli precedentemente analizzati, in questo caso
il giornalista non fa alcun riferimento ad Aberchán ma si concentra principalmente sul
salto avvenuto.
Come nel caso degli articoli su El Diario Digital de Melilla, anche in questa
notizia non è presente alcun collegamento ipertestuale.
Il corpo è diviso in tre parti, ognuna delle quali presenta un proprio titolo.
Nella prima parte dell’articolo, intitolato “Aprovecharon el cambio de turno de
la Guardia Civil que vigila el perímetro fronterizo”, il giornalista fa un lungo e
minuzioso riassunto dei fatti avvenuti la notte precedente. Nel corpo dell’articolo il
luogo esatto dove è avvenuto il salto è indicato con l’espressione “zona conocida como
Villa Pillar, muy próxima al aeropuerto local”, l’ora dei fatti con la frase “a las 22.00
horas” e il motivo per cui la frontiera non era sorvegliata in quel momento è contenuto
nella parte “el salto coincidió con el cambio de turno de los agentes”, anche se era già
stato anticipato nel titolo del paragrafo.
Se nella prima parte della notizia non è presente alcuna citazione ma solo un
riassunto dei fatti, la seconda e la terza parte sono invece ricche di dichiarazioni da parte
delle figure politiche più importanti di Melilla che hanno avuto modo di esprimersi sui
fatti: ci sono le dichiarazioni dell’ex presidente Aberchán, dell’attuale presidente della
città Imbroda e di Liarte, il leader politico del partito Populares en Libertad. Inoltre, nel
testo, è possibile ritrovare alcuni riferimenti a Conesa e Rivas del Partido Popular.
94
Nella seconda parte della notizia sottotitolata “Mustafa Aberchán acompaña al
CETI a los inmigrantes que se refugiaron en su vivienda”, il giornalista spiega il motivo
per cui l’ex presidente Aberchán accolse gli immigrati nella sua abitazione e lo fa
attraverso una citazione dello stesso nel quale spiega che li ospitò per proteggerli dalla
“salvajes agresiones de la policía para expulsarlos”.
Inoltre, tra le altre citazioni di Aberchán, compare una dichiarazione che non è
stato possibile ritrovare in nessuno degli articoli precedentemente analizzati e che dice
“Debemos ser los primeros en demostrar civismo y respeto por los derechos humanos,
no hay que olvidar que vienen desesperados”.
Nella terza e ultima parte della notizia, intitolata “Imbroda propone una ‘zona de
rechazo inmediata en la frontera’”, viene data voce ad altri esponenti politici. Di
particolare rilevanza è l’intervento di Imbroda che afferma “Hay que modificar la Ley
de Extranjeria y habilitar una zona de rechazo inmediata a la frontera”, dal momento
che, fra gli articoli finora analizzati, solamente El Mundo aveva fatto riferimento a
questa dichiarazione, anche se quest’ultimo l’aveva presentata in relazione al fatto che
che lui stesso aveva fatto richiesta di porre fine allo sfruttamento dei migranti da parte
delle associazioni mafiose, cosa che non è possibile leggere sull’articolo de El Faro
Digital poiché non viene fatto alcun riferimento a ciò. Inoltre si fa rifermento anche a un
altro intervento che compare sempre ne El Mundo, nel quale Imbroda denuncia la
criminalità organizzata per poi aggiungere “La UE debe implicarse más en un fenómeno
que afecta a todos”, dichiarazione che non compare in nessun altro articolo analizzato e
nella quale il Presidente chiede indirettamente un intervento da parte dell’Unione
Europea.
Infine vengono citati tre esponenti politici della città di Melilla, Conesa, Rivas e
Liarte che invece non vennero menzionati nei giornali precedenti. Il motivo potrebbe
essere dato dal fatto che si tratta di due esponenti probabilmente sconosciuti nell’intera
Penisola e per questo né El País né El Mundo ne ha fatto riferimento. Tra le
dichiarazioni di questi esponenti risalta la critica indirizzata da Liarte alle figure
politiche, denunciando la loro indifferenza sulla questione dell’immigrazione.
In generale possiamo affermare che l’articolo presenta i fatti in maniera neutrale
e utilizza un tono distaccato riguardo alla vicenda, inoltre questo risulta essere l’articolo
più dettagliato fra quelli analizzati.
95
Il corpo della notizia è
accompagnato da un’immagine
presumibilmente scattata la notte
del 25 aprile. Dico
“presumibilmente” poiché il testo
non fa alcun riferimento alla
fotografia e non possiamo sapere
se è una foto di repertorio oppure
se è una foto risalente a quella
notte. La fotografia è stata scattata
dall’alto e mostra una strada
illuminata, una camionetta e degli
uomini che sembrerebbero far
parte del corpo di polizia. Non è presente alcun riferimento scritto inerente alla
fotografia ma, considerando il fatto che il quotidiano è pubblicato nella città di Melilla,
il giornalista non ha ritenuto necessario spiegare in che via è stata scattata l’immagine
poiché i cittadini di Melilla probabilmente sono in grado di riconoscere il luogo in
questione. In ogni modo, l’immagine dovrebbe raffigurare la via e l’abitazione di
Aberchán.
3.5. Considerazioni generali
I fatti raccontati dai quotidiani, nazionali e locali, non si discostano di molto
rispetto alle versioni ufficiali presentate nel sottocapitolo 2.8. della presente tesi. Infatti
tutti gli articoli analizzati rendono noto, nel corpo della notizia o nei contenuti
audiovisivi, ciò che è realmente accaduto la notte del 25 aprile del 2013.
Le notizie fornite dai quotidiani nazionali, El País ed El Mundo, sono piuttosto
lunghe, dettagliate e ricche di interventi; il lettore quindi, leggendo gli articoli, può
facilmente capire ciò che si è verificato nella notte del 25 aprile. Anche per quanto
riguarda i quotidiani locali, El Diario Digital de Melilla ed El Faro Digital, gli articoli
studiati sono semplici e dettagliati poiché narrano i fatti in modo chiaro e permettono al
lettore di avere informazioni precise sui fatti accaduti. Perciò possiamo affermare che
sia i quotidiani nazionali sia quelli locali hanno prestato un’adeguata attenzione al caso.
96
Esistono tuttavia delle differenze; infatti, sebbene in quasi tutti gli articoli i
giornalisti abbiano esposto le notizie utilizzando un tono distaccato rispetto alle
vicende, l’articolo su El País risulta invece prendere una posizione ed essere di parte nei
confronti della Guardia Civil. Infatti, il giornalista Cembrero non soltanto afferma che i
migranti che arrivano nella città di Melilla danno prova di comportamenti violenti ma fa
anche riferimento a molti interventi che confermano la sua tesi.
Un altro caso in cui è possibile notare alcune differenze nel taglio della notizia
nei diversi articoli riguarda la notizia su El Diario Digital de Melilla. Infatti, l’articolo
di giornale analizzato presenta poche dichiarazioni, le quali in particolar modo
appartengono ad Aberchán. Sebbene è possibile affermare che il corpo della notizia e il
video allegato forniscano al lettore una chiara descrizione dei fatti, sarebbe stato
opportuno che il giornalista introducesse ulteriori dichiarazioni da parte delle figure
politiche più importanti di Melilla allo scopo di rendere più completa la notizia.
4. Analisi degli articoli di giornale inerenti all’episodio del 6 aprile 2014 a
Ceuta
In questo sottocapitolo andrò ad analizzare come diversi quotidiani digitali
hanno raccontato i fatti accaduti a Ceuta il 6 febbraio 2014, quando circa 300
subsahariani si diressero a nuoto verso la spiaggia El Tarajal di Ceuta e, secondo le
prime fonti, dove nove di loro persero la vita nelle acque.
I quotidiani in questione sono due nazionali, El País e El Mundo, e due
appartenenti alla città di Ceuta, El Faro Digital e Ceutaldía.
In tutti i quattro giornali ho scelto di analizzare gli articoli che hanno raccontato
per la prima volta i fatti in modo da studiare l’approccio del giornalista alla notizia.
4.1. El País
L’articolo su El País s’intitola “Nueve inmigrantes mueren durante un intento de
entrar por mar a nado a Ceuta”, scritto da Rocío Abad e pubblicato sul sito del giornale
il 6 febbraio 2014 alle ore 22.07, quindi molte ore dopo l’accaduto, il che ha permesso
alla giornalista di scrivere un articolo ricco di informazioni e interventi.
Il titolo si concentra sulla morte dei nove migranti, la cui drammaticità del caso
attira l’attenzione del lettore e suscita sgomento.
97
I due sottotitoli, “Nueve cuerpos han sido ya localizados por las Fuerzas de
Seguridad” e “Unos 400 subsaharianos han tratado de cruzar la frontera del Tarajal a las
ocho de la mañana”, forniscono un breve riassunto e aiutano il lettore a comprendere
meglio i fatti. La precisazione numerica fornita e l’utilizzo del numero e non delle
lettere, per indicare la cifra degli immigrati che ha tentano di entrare nella città, ha lo
scopo di creare inquetudine e sgomento nel lettore.
Sotto i sottotitoli sono stati inclusi alcuni collegamenti ipertestuali che rinviano
ad articoli e servizi, anche in lingua inglese, e che consentono al lettore di studiare e
approfondire ulteriormente il tema dell’immigrazione.
Il corpo della notizia è piuttosto lungo, ricco di dettagli e citazioni. Nella parte
introduttiva dell’articolo la giornalista redige un breve riassunto dell’accaduto e fornisce
al lettore informazioni di carattere temporale e spaziale che sono di fondamentale
importanza per una piena comprensione dei fatti. Perciò egli scrive che, alle ore 5.45
del 6 febbraio, un numeroso gruppo di subsahariani, “entre 250 e 450 ”, cercò di
raggiungere a nuoto la spiaggia di Ceuta El Tarajal, il che portò alla morte di nove di
essi, tra i quali una donna e otto uomini. I dettagli forniti sull’intero tragitto percorso dai
migranti sono molto precisi.
98
Al fine di permettere al lettore una migliore comprensione del testo, lungo il
corpo della notizia compare una’immagine che ritrae una cartina geografica nel punto
esatto di confine fra il Marocco e la Spagna. Cliccando su di essa è possibile
ingrandirla: all’interno della cartina si può vedere il tragitto percorso dai migranti
tracciato da alcune frecce gialle sopra le quali indicati dei numeri. Ai numeri è collegata
una breve spiegazione che consente al lettore di capire meglio come si sono svolti i fatti.
Procedendo con la lettura è possibile costatare come la giornalista fa riferimento
alle prime indiscrezioni secondo le quali gli immigrati subsahariani avrebbero accusato
la Guardia Civil di aver sparato loro mentre erano ancora in acqua facendo uso di
palline di gomma o di piombo; in questo modo la Guardia Civil li avrebbe
profondamente spaventati e avrebbe causato la tragedia. In seguito però vengono citate
le parole di Francisco Antonio González, delegado del Gobierno di Ceuta, il quale
accusa gli immigrati di una violenza inaudita “lanzando piedras contra los agentes y
demostrando una actitud muy violenta” il che causò tra agenti ferite di lieve entità. Gli
stessi ammisero di aver fatto uso di armi antisommossa “de manera disuasoria” ma
smentirono ufficialmente di aver causato il panico fra gli immigrati dal momento che
erano stati gli stessi ad entrare in acqua “pisándose unos a otros”.
Successivamente la giornalista cita le dichiarazioni fornite dai migranti e dalle
ONG locali. Queste dichiararono che gli agenti della Guardia Civil spararono pallini di
gomma contro i migranti e che, inoltre, lanciarono contro di essi gas lacrimogeni mentre
si trovavano ancora in acqua; altri immigrati, inoltre, fornirono la loro personale
testimonianza accusando alcuni membri delle forze dell’ordine di aver mirato e sparato
ai salvagenti allo scopo di farli affondare.
Il susseguirsi di dichiarazioni che smentiscono le affermazioni precedentemente
lette causano nel lettore confusione e non lo aiutano nella vera comprensione dei fatti.
Leggendo questa notizia si fa fatica a capire cos’è accaduto la mattina del 6 febbraio
poiché le dichiarazioni presenti nell’articolo provengono tutte da istituzioni serie e
attendibili come ONG, agenti della Guardia Civil, istituzioni politiche e persone
direttamente coinvolte nella vicenda. Il risultato finale è che il lettore finisce per trovarsi
in una situazione di confusione totale e quindi non sarà in grado di prendere una
posizione dovendo attendere nuovi sviluppi sulla vicenda.
99
Continuando la lettura è possibile imbattersi nella dichiarazione del delegado del
Gobierno Francisco Antonio González il quale afferma di aver più volte fatto presente
al Ministro degli Interni, Jorge Fernández Díaz, la necessità di prolungare la costruzione
delle barriere di separazione di Ceuta verso il mare dal momento che, in caso di bassa
marea, la maggior parte degli uomini sarebbe stato in grado di superare facilmente la
frontiera ed eludere la sorveglianza.
Nella parte finale della notizia si fa riferimento a episodi simili del passato:
viene riportato l’esempio del 17 e il 18 settembre del 2013 quando un gruppo di
immigrati cercò di raggiungere a nuoto la città di Ceuta o quando il 19 settembre 2009
vennero trovati in mare otto cadaveri in seguito al naufragio di una imbarcazione.
La giornalista fa presente che anche il segretario del PSOE, Óscar López, e il
Ministro degli Interni, Fernández Díaz, hanno espresso il proprio dispiacere per i fatti
accaduti. Compare infine una citazione di Fernández Díaz il quale spiega che la vicenda
è da impuntare al fatto che “se cierra una vía de acceso y se abre otra, lo que genera que
la presión de la inmigración ilegal sobre Ceuta y Melilla se haya intensificado”.
In conclusione si può indubbiamente affermare che la notizia è ricca di dettagli e
di interventi delle persone direttamente coinvolte e non, fornendo tutte le dichiarazioni
sul caso. L’articolo quindi non si discosta di molto rispetto ai fatti effettivamente
avvenuti e raccontati nel secondo capitolo della presente tesi (sottocapitolo 2.9.).
Tuttavia, ciò comporta che la notizia risulta essere confusionaria e di difficile
comprensione. Infine possiamo asserire che dal testo non traspare alcuna presa di
posizione del giornale poiché il tono utilizzato dalla giornalista è neutrale e distaccato.
100
L’immagine sovrastante rappresenta un contenuto audiovisivo dalla durata di 59
secondi presente nella notizia. La voce narrante che accompagna le immagini fornisce
un breve riassunto dei fatti accaduti la mattina del 6 febbraio. Le riprese si concentrano
principalmente lungo la costa che separa il lato marocchino da quello spagnolo; al
momento delle riprese la situazione è tornata alla normalità e infatti sulla spiaggia non
c’è traccia degli immigrati ma, al contrario, si vedono solo le imbarcazioni del comando
armato impegnati nella ricerca delle salme degli immigrati deceduti nelle prime ore del
mattino. In seguito viene fatto riferimento a un simile episodio avvenuto due mesi prima
mostrando le immagini di quel giorno in cui si vede una lunga e numerosa fila di
immigrati e forze dell’ordine lungo la costa. Successivamente le riprese tornano a
riprendere l’episodio avvenuto il 6 febbraio nelle quali vengono mostrati gli agenti del
comando armato che sorvegliano la costa. L’unico intervento che viene mostrato è
quello di un volontario della Croce Rossa che si dimostra dispiaciuto per i fatti accaduti.
La telecamera continua poi a inquadrare la costa e le barriere di separazione che
dividono il Marocco dalla Spagna. Infine compaiono le immagini di un numeroso
gruppo di immigrati subsahariani ai lati delle barriere dove è possibile vedere anche
alcuni agenti della Guardia Civil dialogare con loro. L’ultima scena invece ritrae un
gruppo numeroso di forze dell’ordine che sorvegliano la frontiera.
Il giornalista ha voluto introdurre nella notizia il presente video con l’obiettivo
di permettere al lettore di avere un breve riassunto dei fatti. Tuttavia, il video contine
pochi interventi che avrebbero potuto rendere più completa la notizia. Si può concludere
quindi che questo contenuto audiovisivo non fornisce ulteriori informazioni rispetto a
quelle che si ottengono leggendo il corpo della notizia.
4.2. El Mundo
L’articolo in questione s’intitola “Mueren 9 inmigrantes al intentar entrar a nado
en Ceuta” pubblicato sul sito del giornale il 6 febbraio 2014 alle ore 19.34 e tratto da
Europa Press. Anche in questo caso l’articolo è stato scritto molte ore dopo l’accaduto.
Il titolo è molto simile a quello su El País, ottenendo quindi lo stesso obiettivo.
Sotto il titolo si possono leggere quattro sottotitoli divisi da elenchi puntati che
forniscono al lettore un esaustivo riassunto dei fatti: “Unos 300 subsaharianos
intentaron entrar de manera masiva por la frontera del Tarajal / Unos lo hicieron a pie
101
mientras otros lo intentaron a nado y perecieron en el intento / De momento, se han
recuperado nueve cadáveres pero no se descarta encontrar más”.
Una grande immagine, che riproduce una fotografia aerea scattata da satellite,
precede l’intero corpo della notizia ed anche in questo caso, come è già stato possibile
osservare nell’articolo de El País, la cartina è d’aiuto al lettore. Essa infatti, grazie ai
numeri collegati a sintetica spiegazione, è di supporto al lettore per aiutarlo a
comprendere più facilmente la notizia e il tragitto percorso dagli immigrati.
Il corpo della notizia è molto corto e meno ricco di dettagli rispetto all’articolo
proposto da El País, inoltre non è presente alcun collegamento ipertestuale nell’intera
notizia. Nella prima parte il giornalista redige un sintetico riassunto dell’accaduto e
aggiunge che il Marocco sta portando avanti operazioni di ricerca e soccorso nelle
acque di Ceuta, particolare non presente nell’articolo precedentemente analizzato.
Nella seconda parte del corpo il giornalista fornisce alcune informazioni non
presenti sull’articolo de El País: prima di tutto spiega che tredici uomini sono stati
recuperati dalle acque e prontamente ricoverati presso l’ospedale Hasán II de Fnideq e,
in secondo luogo, ci informa che alle ore 9.30 il Pleno de la Asamblea di Ceuta ha
osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’Olocausto al quale fu
sommato un omaggio ai migranti subsahariani deceduti nelle acque marocchine.
102
L’articolo si conclude quindi con la conferma che nessun migrante subsahariano è
riuscito ad entrare nella città di Ceuta.
Dalla notizia non traspare alcuna presa di posizione da parte del giornalista, il
quale utilizza un tono neutrale. Per focalizzare l’attenzione del lettore su alcuni punti
salienti, il giornalista ha voluto far uso del grassetto applicato ad alcune parole presenti
nella notizia.
L’articolo, in generale, è povero di contenuti e non risulta completo. Una delle
due citazioni presenti nell’intera notizia è quella del delegado del Gobierno di Ceuta,
Francisco Antonio González, il quale dichiara che gli immigrati morirono nel “Reino
alauí”. La notizia risulta quindi essere povera di interventi e citazioni non soltanto delle
persone direttamente coinvolte nella vicenda ma anche delle figure politiche spagnole.
La prima impressione che si ha leggendo questo articolo è che si tratta di una
notizia molto diversa rispetto agli episodi realmente accaduti la mattina del 6 febbraio e
descritti nel secondo capitolo della presente tesi; infatti, in tutto l’articolo non viene
menzionata la controversia secondo cui gli immigrati accusarono la Guardia Civil di
aver fatto un uso sproporzionato di armi antisommossa, che gli agenti non prestarono
aiuto alle persone in mare e che non venne chiesto l’intervento della Croce Rossa; al
contrario viene comunicato che la Delegación ha precisato che il decesso degli
immigrati è avvenuto per annegamento e che non è stato causato da condotte violente.
L’impressione che ne deriva è quindi che il giornalista abbia intenzionalmente evitato di
trattare e approfondire il tema.
103
La foto sovrastante rappresenta il fermo immagine di un filmato dalla durata di
23 secondi che accompagna il corpo della notizia.
A differenza del contenuto audiovisivo presente su El País, il presente filmato
non possiede una voce narrante ma è possibile vedere soltanto le riprese fatte lungo la
spiaggia e la frontiera che divide il Marocco dalla Spagna. In questo caso il video
fornisce poche informazioni al lettore, il quale dovrà fare uno sforzo immaginativo per
interpretare i fatti.
4.3. El Faro Digital
L’articolo su El Faro Digital s’intitola “Fallecen ocho inmigrantes en aguas
próximas a la frontera de Ceuta”, scritto e pubblicato sul sito del giornale il 6 febbraio
2014. L’articolo in questione non presenta i nome del giornalista e l’ora di
pubblicazione.
Anche in questo caso l’intestazione è molto simile ai titoli degli articoli
precedentemente analizzati, con l’unica differenza che si fa riferimento a otto decessi
anziché nove, il che probabilmente è dovuto al fatto che la notizia sia stata redatta poche
ore dopo l’accaduto; inoltre, l’utilizzo delle parole “en agua próxima a la frontera de
Ceuta” ha lo scopo di attribuire i fatti non soltanto alla città di Ceuta ma anche allo stato
marocchino.
Il corpo della notizia è molto corto e povero di dettagli.
Il giornalista riassume brevemente l’accaduto facendo riferimento alla fonte
principale ossia la Delegación del Gobierno di Ceuta. Leggendo l’articolo non risulta
chiaro il numero esatto di decessi dal momento che nel primo paragrafo si fa riferimento
a otto migranti deceduti nelle acque prossime alla frontiera del Tarajal, mentre nel
secondo paragrafo si rende noto che le forze dell’ordine marocchine hanno localizzato
in mare cinque corpi senza vita di migranti subsahariani. L’articolo si conclude quindi
con una precisazione da parte della Delegación, la quale afferma che il decesso degli
immigrati è avvenuto per annegamento escludendo quindi condotte violenti da parte del
corpo di sicurezza spagnolo.
104
Infine, sotto il corpo della notizia, il giornalista ha voluto precisare che maggiori
informazioni saranno fornite il giorno successivo nell’edizione cartacea de El Faro
Digital di Ceuta. Nessun collegamento ipertestuale accompagna il corpo della notizia.
In conclusione possiamo affermare che la presente notizia risulta essere
incompleta poiché povera di dettagli informativi e carente di interventi, in particolar
modo, da parte dei testimoni che hanno vissuto in prima persona i fatti. Anche in questo
caso, come nell’articolo su El Mundo, la notizia così com’è presentata risulta essere
completamente diversa rispetto agli avvenimenti realmente accaduti, infatti non viene
presa in considerazione la controversia secondo cui alcuni immigrati avrebbero
denunciato una condotta scorretta e un comportamento violento da parte della Guardia
Civil, riferendo invece soltanto la posizione della Delegación. La ragione di questa
mancanza potrebbe essere data dal fatto che l’articolo è stato redatto poco dopo
l’accaduto e che quindi i testimoni non avevano ancora rilasciato le loro dichiarazioni.
L’immagine a lato è la fotografia che accompagna il corpo della notizia; questa
ritrae alcuni agenti della Guardia Civil, facilmente identificabili per via delle divise
indossate, a fianco di alcuni migranti subsahariani nei pressi della frontiera.
Un ulteriore indizio che ci
fa credere che la notizia sia stata
stilata poche ore dopo l’accaduto
è dato dal fatto che la foto in
questione provenga dall’archivio
privato del giornale. Infatti, una
didascalia posta alla base della
fotografia rende noto che questa è
una foto di repertorio. In questo
caso il lettore non può utilizzare la
fotografia come supporto
informativo per ricavare ulteriori
informazioni ed approfondire la propria conoscenza sull’accaduto. L’immagine in
questione viene semplicemente utilizzata come contorno della notizia.
105
4.4. Ceutaldía
L’articolo in questione s’intitola “Nueve subsaharianos muertos en aguas
marroquíes, balance provisional de la tragedia en la frontera”, scritto e pubblicato il 6
febbraio 2014. L’ora della pubblicazione e il nome del giornalista non sono indicati.
Il titolo della notizia non si discosta di molto rispetto ai titoli degli articoli
precedentemente analizzati. L’unica osservazione degna di nota è il fatto che il
giornalista abbia voluto precisare che i decessi sono avvenuti nelle acque marocchine,
come se la sua intenzione fosse stata quella di assolvere dalle responsabilità la città di
Ceuta e di conseguenza lo stato spagnolo.
La notizia presenta anche due sottotitoli in neretto divisi da due elenchi puntati:
“ La información procedente del país vecino con la que trabajan las autoridades
españolas no descarta que aparezcan más cadáveres en el agua de los ya localizados” e
“La Marina Real contuvo a los indocumentados que intentaban acceder a la ciudad
autónoma a través de la costa del Tarajal”; in questo caso i sottotitoli forniscono un
riassunto della vicenda e chiariscono al lettore cosa si è verificato esattamente. Come
nel titolo, il giornalista ha voluto specificare nei sottotitoli che la Reale aeronautica
militare marocchina ha gestito la situazione bloccando gli immigrati clandestini ed
evitando il loro ingresso nel territorio spagnolo, ribadendo quindi il concetto che la
vicenda riguarda più lo stato marocchino che quello spagnolo.
Il corpo della notizia inizia trattando la morte degli immigrati subsahariani nei
pressi delle acque di Ceuta. Come nel caso dell’articolo fornito da El Faro Digital, non
è chiaro il numero esatto dei decessi poiché, se nel titolo e nel primo paragrafo del
corpo il giornalista indica che sono nove gli immigrati deceduti, nel secondo paragrafo
si fa riferimento a sette vittime. L’indecisione numerica porta quindi il lettore a essere
confuso e incerto sui fatti accaduti. Tuttavia, il giornalista specifica che si tratta di un
bilancio provvisorio e non esclude che possa aumentare il numero delle vittime.
Soltanto nel terzo paragrafo il giornalista fa riferimento ai 400 immigrati che tentarono
di entrare clandestinamente nella città di Ceuta. Continuando la lettura, il giornalista
precisa che nessun immigrato è riuscito a oltrepassare la frontiera. Infine, l’ultimo
paragrafo fa riferimento alle dichiarazioni riportate dalle forze dell’ordine spagnole le
quali accusarono gli immigrati di aver adottato una condotta violenta lanciando pietre
contro gli agenti marocchini. Per quanto riguarda quest’ultimo dettaglio, è possibile che
106
il giornalista abbia commesso un errore, dal momento che gli agenti colpiti dagli
immigrati facevano parte delle forze dell’ordine spagnole e non marocchine.
Anche in quest’articolo non viene fatto alcun riferimento alle dichiarazioni
fornite da parte delle ONG locali o dagli immigrati che hanno vissuto tale esperienza in
prima persona e mancano le controversie secondo cui gli agenti delle forze dell’ordine
spagnole avrebbero adottato condotte poco consone alla loro posizione nella società; il
giornalista ha quindi riportato esclusivamente la versione della Guardia Civil il che
rende l’articolo incompleto e impreciso. Anche in questo caso la notizia si discosta
molto dalla realtà dei fatti raccontati nel secondo capitolo del presente lavoro.
In conclusione, la presente notizia risulta essere incompleta e poco chiara e ciò
fondamentalmente a causa della mancanza di citazioni e dalle inesattezze ed errori
commessi dal giornalista, i quali sono probabilmente dovuti al fatto che la notizia è stata
redatta poche ore dopo l’accaduto.
All’interno della notizia non è presente alcun collegamento ipertestuale che
possa dare al lettore maggiori informazioni sul caso.
Due fotografie scattate la mattina del 6 febbraio accompagnano il corpo della
notizia.
La fotografia a lato è stata scattata la
mattina del 6 febbraio e ritrae la
spiaggia El Tarajal come indicato nella
didascalia che si trova alla base della
foto sul quotidiano. L’immagine non è
molto nitida poiché è stata scattata
attraverso le barriere di separazione.
Tuttavia è possibile notare che la spiaggia è deserta e non è traccia degli immigrati.
La seconda fotografia è stata scattata dal lato marocchino è ritrae una grande
folla di cittadini. Una didascalia alla base della fotografia riporta soltato che la
fotografia è stata scattala la mattina del 6 febbraio, non andando però a spiegare il
motivo per cui un numero considerevole di persone è bloccato lungo una strada della
città. Il lettore dovrà quindi fare uno sforzo immaginativo per interpretare i fatti dal
momento che il giornalista non ha fornito alcuna spiegazione nel corpo della notizia. La
107
motivazione forse più ovvia è che si tratta di un gruppo di cittadini marocchini il cui
passo è stato bloccato a causa degli avvenimenti avvenuti la stessa mattina.
4.5. Considerazioni generali
In questo caso, la notizia riportata dal quotidiano nazionale El País si è
dimostrata la più completa ed esauriente rispetto agli articoli riportati dai quotidiani
locali e da El Mundo; infatti, sebbene l’articolo de El País sia il più complesso fra gli
articoli analizzati, questo risulta essere però anche il più completo poiché fornisce tutte
le versioni del caso.
Invece, per quanto riguarda i quotidiani locali, le notizie da loro riportante
presentano imprecisioni e poche informazioni, obbligando così il lettore a dover
attendere ulteriori sviluppi. Nessuna di esse ha trattato il tema nella sua interezza, dando
come risultato dei contenuti che si discostano completamente dai fatti realmente
accaduti: nessuna delle tre ha affrontato il tema della violenza esercitata dagli agenti
della Guardia Civil nei confronti degli immigrati o le accuse secondo le quali gli agenti
avrebbero sparato ai salvagenti degli uomini in mare causando il panico e quindi la
morte di alcuni di essi.
In questo caso risulta difficile fare un confronto fra i quotidiani nazionali e locali
poiché, sebbene ci siano delle somiglianze fra i due quotidiani locali, lo stesso non si
può dire di quelli nazionali.
Infine, benché siamo a conoscenza del fatto che gli immigrati entrarono in acque
spagnole e che per questo vennero colpiti dalle armi anti sommossa utilizzate dalla
108
Guardia Civil, nessuno degli articoli studiati fa un riferimento espicito a ciò, limitandosi
a riferire i che corpi degli immigrati deceduti sono stati trovati “en aguas próximas a la
frontera de Ceuta” o “en aguas próximas a la frotera del Tarajal”.
109
Conclusioni
Uno degli obiettivi che mi sono posta realizzando questo lavoro è stato quello di
cercare di capire come mai due città spagnole quali Ceuta e Melilla siano oggetto
d’invasione da parte di molti immigrati africani in cerca di una vita migliore in Europa e
se gli strumenti adottati dal governo spagnolo siano in grado di affrontare il fenomeno
migrario.
Infatti, se in passato la fama e l’importanza di queste due città era dovuta
principalmente alla loro posizione geografica che permetteva ai popoli spagnoli di
esercitare il loro controllo su gran parte del mar Mediterraneo e quindi su un’area molto
strategica per i traffici commerciali, oggigiorno Ceuta e Melilla sono associate
essenzialmente al fenomeno dell’immigrazione clandestina, diventando quindi due delle
principali frontiere migratorie europee.
Attraverso gli studi e le ricerche personalmente effettuate ho avuto modo di
appurare che il motivo primario per cui Ceuta e Melilla sono due delle destinazioni
predilette dai migranti subsahariani è la presenza di queste due città autonome proprio
all’interno del continente africano. Infatti, molti immigrati che arrivano in Europa
provengono dagli stati africani più poveri il che comporta che molti di essi non
possiedano grandi risorse economiche sufficienti per permettersi un viaggio in nave per
arrivare nel continente europeo, così alcuni di essi decidono di compiere il viaggio a
piedi o in automobile impiegando anche anni prima ad arrivare a destinazione. Inoltre,
l’ingresso all’interno di queste due città consente agli immigrati alcuni diritti anche in
assenza di permesso di soggiorno, come ad esempio la possibilità di risiedere
temporaneamente nei CETI e l’assistenza sanitaria gratuita. Tuttavia, Ceuta e Melilla
non vengono considerate dai migranti come destinazioni finali del loro lungo viaggio,
ma come un passaggio obbligato per arrivare nella penisola spagnola o comunque in
un’altra entità statale europea.
110
Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati dallo stato spagnolo per fermare, o
comunque limitare, l’immigrazione clandestina a Ceuta e Melilla possiamo affermare
che il più delle volte essi sono risultati vani e inefficienti. Infatti, la principale risposta
del governo spagnolo al massiccio aumento di immigrati che tentavano di eludere i
controlli alle frontiere fu quello di rafforzare ulteriormente le barriere di separazione
incrementanto quei marchingegni che hanno lo scopo di scoraggiare l’immigrato a
scalare le barriere. La triste realtà è però che il più delle volte gli immigrati che tentano
il lungo viaggio, e quindi il “salto”, sono persone terribilmente disperate che non hanno
nulla da perdere se non la vita. Questo significa che anche un incremento del numero di
agenti e un rafforzamento delle barriere non impediranno al fenomeno
dell’immigrazione di continuare ad alimentarsi perché la forza di volontà dei migranti
sarà sempre più forte di queste minacce.
Oserei quindi affermare che l’Unione Europea dovrebbe intervenire e aiutare gli
stati africani in modo da impedire la massiccia fuga dal continente oltre a dover mettere
in marcia importanti cambiamenti legislativi per quanto riguarda la situazione
migratoria.
Il secondo obiettivo postomi è stato quello di cercare di capire se le notizie sui
quotidiani digitali presentano con esattezza la realtà o se è possibile riscontrare una
verità manipolata e politicizzata sulla base degli interessi e delle posizioni politiche dei
giornali.
Alla conclusione dello studio e dell’analisi dei quotidiani locali e nazionali sono
giunta alla conclusione che non vi siano caratteristiche peculiari che possono essere
attribuite solo ai primi piuttosto che ai secondi.
In generale posso affermare che, la vicenda avvenuta a Melilla è stata raccontata
sia dai giornali nazionali che da quelli locali includendo tutti i particolari e tutte le
controversie del caso; lo stesso non si può dire per quanto riguarda i fatti avvenuti a
Ceuta. Infatti, a differenza dell’articolo proposto da El País, quando leggiamo le notizie
redatte dagli altri quotidiani la sensazione che si ha è quella di leggere storie
completamente diverse rispetto alla realtà dei fatti. Infatti, in questi casi, i giornalisti
hanno preferito tacere sulle gravi accuse rivolte agli agenti della Guardia Civil
sospettati di aver adottato una condotta violenta e scorretta nei confronti dei migranti.
111
Sembra quindi che i giornalisti abbiano voluto proteggere e schierarsi dalla parte delle
forze dell’ordine.
In generale, in tutte le notizie proposte, i giornalisti hanno adottato un tono
neutrale e distaccato nei confronti delle vicende narrate, a differenza però dell’articolo
redatto da El País inerente alla vicenda avvenuta a Melilla. Difatti, in questo caso il
giornalista ha espresso un chiaro giudizio personale attaccando senza mezzi termini il
comportamento e le condotte dei migranti riferendosi non soltanto ai fatti avvenuti il 25
aprile ma anche alle settimane precedenti.
Concludendo, è possibile affermare che, dall’analisi effettuata sui quotidiani
studiati è emerso che non tutti i giornali raccontano i fatti avvenuti in modo esauriente e
completo mostrando, a volte, un’esplicita o un’implicita posizione ideologica sulla base
degli interessi e delle ideologie dei quotidiani. Da ciò deriva che il lettore, per poter
comprendere la realtà oggettiva dei fatti, deve compiere uno sforzo personale per
interpretare quello che viene scritto da parte delle testate giornalistiche.
112
Bibliografia
1. Libri
Autori Vari (1989), “La frustación de un imperio (1476 – 1714)” in Historia de España.
Dirigida por Manuel Tuñón de Lara, Barcelona, Labor.
Aragón Reyes, M. (a cura di) (2013), El Protectorado español en Marruecos: la
historia trascendida, Bilbao, Iberdrola.
Barberi, P. (2006), Le cause della guerra civile spagnola, Roma, Robin.
Bravo Nieto, A. (a cura di) (2004), El gran capitán y la España de los Reyes Católicos,
Córdoba, Centro de Exposiciones de la Fundación GASELEC.
Bravo Nieto, A. / Uriel, P. F. (dir.) (2005), Historia de Melilla, Ciudad Autónoma de
Melilla, Consejería de Cultura y Festejos.
Comellas, J. L. (2002), Historia de España contemporánea, Madrid, Ediciones Rialp.
Comellas, J. L. (2003), Historia de España moderna y contemporánea, Madrid,
Ediciones Rialp.
Crespo Redondo, J. (a cura di) (1994), Historia de Marruecos, Rabat, Consejería de
Educación de la Embajada de España en Rabat.
Díez Sánchez, J. Melilla en la primera guerra mundial (in stampa).
Esquembri Hinojo, C. (2013), Carlos Echeguren ocio y el republicanismo en Melilla.
(1873 – 1936), Ciudad Autónoma de Melilla, Consejería de Cultura y Festejos.
Fernández Díaz, M. E. (2012), Hebreos y musulmanes durante la guerra civil en
Melilla. Violencia política y represión, Madrid, Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
Lara, R. (2014), Derechos Humanos en la frontera sur 2014, Sevilla, Asociación Pro
Derechos Humanos de Andalucía.
113
Lario Bastida, M. (2006), Medios de comunicación e inmigración, Murcia, Convivir sin
racismo.
Lynch, J. (2009), La España del siglo XVIII, Barcelona, Editorial Crítica.
Maleno Garzón, H. (a cura di) (2006), Informe frontera sur. 1995 – 2006: 10 años de
violación de los derechos humanos, SOS fronteras.
Martínez Lirola, M. (2008), Inmigración, discurso y medios de comunicación, Alicante,
Istituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
Moga Romero, V. (2006), Las heridas de la historia: testimonios de la guerra
civilespañola en Melilla, Barcelona, Edicions Bellaterra.
Perruchound, R. (2004), Glossary on Migration, Geneva, International Organization for
Migration.
Saraiva, J. H. (2004), Storia del Portogallo, Milano, Bruno Mondadori.
Tuñón de Lara, M. (2000a), La España del siglo XIX, Madrid, Ediciones Akal.
Tuñón de Lara, M. (2000b), La España del siglo XX, Madrid, Ediciones Akal.
Villada Paredes, F. (a cura di) (2009), Historia de Ceuta. De los orígenes al año 2000,
Ciudad Autónoma de Ceuta, Istituto de Estudios Ceutíes.
2. Articoli
Autori Vari (2007), Parere consultivo sull’applicazione extraterritoriale degli obblighi
di non-refoulement derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati
del 1951 e dal suo Protocollo del 1967, UNHCR.
Autori Vari (2011), Guía para personas sin papeles, Sevilla, Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía.
Autori Vari (2012), Actitudes hacia la inmigración (VI), Estudio n°2967, Cientro de
Investigación Sociológica.
Autori Vari (2014), Fran Quaterly, Quarter 1 January – March 2014, Warsaw, Frontex.
Alonso, M. / Blasco, E. F. (2007), España: de la emigración a la inmigración,
València, Universitat de València.
Bermejo, P. / Ngalikpima, M. (2010), National asylum procedure, Madrid, Comisión
Española de Ayuda al Refugiado.
Bondanini, F. B. (2014), Migración de tránsito: Entre temporalidad y largas esperas.
El caso del CETI de Melilla, Universidad de Granada.
114
Bravo Nieto, A. (1985), “Algunos aspectos de la proclamación de la República en
Melilla: Abril Elecciones Municipales, 1931”, ALDABA Revista del centro
asociado a la UNED de Melilla, pp. 93 – 108.
Bravo Nieto, A. (1990), “La ocupación de Melilla en 1497 y las relaciones entre los
Reyes Católicos y el Duque de Medina Sidonia”, in Revista Aldaba n° 15 año
1990, Ciudad Autónoma Melilla, pp. 15 - 37.
Castan Pinos, J. (2013), ‘Building Fortress Europe? Schengen and the Cases of Ceuta
and Melilla, Queen’s University Belfast.
Carmona Portillo, A. (1993), “La inmigración andaluza al norte de África en el siglo
XVIII: caso del presidio de Ceuta”, in Hespérides: Anuario de investigaciones,
Nº. 1, 1993, pp. 389 – 406.
Deu del Olmo, M. I. (2014), Ceuta: inmigración, interculturalidad y convivencia,
Madrid, Fundación pluralismo y convivencia.
Fayrén, G. / Bel Adell, J. Y. (2008), Nueva inmigración africana en España: inmirantes
subsaharianos, Universidad de Murcia.
Gaona Pisonero, C. (2004), Correspondencia visual de la inmigración: un análisis de los
movimientos migratorios desde la imagen, Barcelona, Departamento de Antropología
de la Universidad de Barcelona.
García Alonso, J. (1985), La enseñanza en Melilla durante la Dictatura de Primo de
Rivera, Melilla, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED Melilla).
Gozalbes Cravioto, E. (2011), El protectorado español de Marruecos (1912-1956) en
las imágenes de los sellos de correos, Universidad de Castilla-La Mancha.
Gozálvarez Pérez, V. (2000), “La inmigración irregular de africanos en España, bilance
y perspectivas”, in Investigaciones Geográfica, n° 23, pp. 47 – 57.
Igartua Perosanz, J. J. / Muñiz Muriel, C. / Otero Parra, J. A. (2007), El tratamiento
informativo de la inmigración en los medios de comunicación españoles. Un
análisis de contenido desde la Teoría del Framing, Universidad de Salamanca.
Jiménez Álvarez, M. (2004), “Los menores no acompañados: el caso de Ceuta y
Melilla” in Atlas de la inmigración marroquí España, Universidad Autónoma de
Madrid, pp. 423 – 424.
Lopez Senosiain, M. E. (2011), El 17 de julio de 1936 en Melilla. Memoria en clave de
presente, Universitat Oberta de Catalunya.
115
Lorite García, N. (2006), ¿Puede ser científica y objetiva la mirada audiovisual de la
realidad migratoria?, Universidad Autónoma de Barcelona.
Maleno Garzón, H. (a cura di) (2014), Informe de análisis de hechos y recopilación de
testimonies de la tragedia que tuvo lugar el 6 de febrero de 2014 en la zona
fronteriza de Ceuta, Tangeri, Ca-minando Fronteras.
Martín Rojo, L. / Van Dijk, T. A. (1998), “Había un problema y se ha resuelto”.
Legitimación de la Expulsión de Inmigrantes ‘Ilegales’ en el Discurso
Parlamentario Españl, Universidad Autónoma de Madrid e Universidad de
Amsterdam.
Martínez Escamilla, M. (a cura di) (2014), “Expulsiones en caliente”: cuando el estado
actua al margen de la ley, Universidad Complutense de Madrid.
McCombs, M. E. / Shaw, D. L., (2003), The Agenda-Setting Role of the Mass Media in
the Shaping of Public Opinion, University of Texas at Austin.
Moreno García, A. J. (1984), “Melilla, enero-julio 1936” in Revista Jabega n. 47, pp. 45
– 54.
Nielsen/NetRatings (2003), Online newspapers enjoy double-digit year-over-year
growth, reaching one out of four Internet users according to Nielsen/NetRatings,
New York.
Polo, M. (1986), La vida cotidiana en Melilla en el siglo XVI, Tolosa, Centro Virtual
Cervantes.
Ramón Salaverría, A. (2007), la investigación sobre ciberperiodismo en españa:
tendencias, resultados y perspectivas, Valencia, Universitat de València.
Rost, A. (2006), La interactividad en el periódico digital, Belaterra, Universitat
Autónoma de Barcelona.
Sandoval Martín, M. T. / Franco Álvarez, G. / Yuste Robles, B. (2006), “Uso de la
fotografía y la infografía en los periódicos digitales”, in III congreso on-line
observatorio para la cibersociedad.
Simon, J. / Jensen, M. / Leese, G. (2007), Document de Travail des Partenaires Arabes
et Europeens pour la Gestion Conjointe des Flux Migratoires Mixtes, UNHCR.
Soddu, P. (2006), “Ceuta y Melilla: gestión fronteriza, derechos humanos y seguridad”
in Med. 2006 : el año 2005 en el espacio Euromediterráneo, Barcelona, Istituto
Europeo del Mediterraneo, pp. 216 – 218.
116
Van Dijk, T. A. (1989), Mediating racism. The role of the media in the reproduction of
racism, University of Amsterdam.
Xambó, R. (2010), La inmigración en los medios de comunicación, Universitat de
València.
Zamorano Galán, M. (2013), El salto de la valla: 25/04/2013 Melilla. Anotaciones y
reflexiones, Melilla, PRODEIN.
3. Articoli di giornali
Abad, R., Nueve inmigrantes mueren durante un intento de entrar por mar a nado a
Ceuta, El País, 06/02/2014.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/06/actualidad/1391678431_535759.html
Anonimo, Amnistía Internacional dice que las deportaciones de inmigrantes que realiza
España 'son ilegales', El Mundo, 08/10/2005.
http://www.elmundo.es/elmundo/2005/10/08/espana/1128742243.html
Anonimo, Cambiar la Ley de Extranjería para facilitar expulsiones “en caliente” viola
el Convenio Europeo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, 24/02/2014.
https://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/cambiar-la-ley-de-extranjeria-para-facilitar-
expulsiones-en-caliente-viola-el-convenio-europe/
Anonimo, Decenas de inmigrantes asaltan la valla de Melilla y al menos 50 lo
consiguen, El Faro Digital, 26/04/2014.
https://www.elfarodigital.es/melilla/sucesos/121991-decenas-de-inmigrantes-asaltan-la-valla-de-melilla-
y-al-menos-50-lo-consiguen.html
Anonimo, El Ejército patrulla las fronteras de Ceuta y Melilla tras otro asalto con
cinco muertos, El País, 30/09/2005.
http://elpais.com/diario/2005/09/30/portada/1128031201_850215.html
Anonimo, En la frontera la violencia estatal española y marroquí alcanza niveles
intolerables, Diagonal Global, 10/09/2012.
117
https://www.diagonalperiodico.net/global/la-frontera-la-violencia-estatal-espanola-y-marroqui-alcanza-
niveles-intolerables.html
Anonimo, Fallecen ocho inmigrantes en aguas próximas a la frontera de Ceuta, El
Faro Digital, 06/02/2014.
http://elfarodigital.es/ceuta/sucesos/140105-fallecen-ocho-inmigrantes-en-aguas-proximas-a-la-frontera-
de-ceuta.html
Anonimo, La inmigración irregular subió en España un 130% en el primer trimestre,
sólo por detrás de Italia, EuropaPress, 26/08/2014.
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-inmigracion-irregular-espana-sube-casi-130-
primer-trimestre-2014-segundo-mayor-aumento-ue-20140826152506.html
Anonimo, Médicos sin Fronteras denuncia el abandono de cientos de subsaharianos en
el desierto, ABC, 07/10/2005.
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-07-10-2005/abc/Ultima/medicos-sin-fronteras-denuncia-el-
abandono-de-cientos-de-subsaharianos-en-el-desierto_611386383317.html
Anonimo, Mueren 9 inmigrantes al intentar entrar a nado en Ceuta, El Mundo,
06/02/2014.
http://www.elmundo.es/espana/2014/02/06/52f35328ca474110768b456b.html
Anonimo, Schengen, cos’è e come funziona, Europarlamento 24, -/04/2010.
http://www.europarlamento24.eu/schengen-cos-e-e-come-funziona/0,1254,106_ART_142,00.html
Anonimo, Nueve subsaharianos muertos en aguas marroquíes, balance provisional de
la tragedia en la frontera, Ceutaldía, 06/02/2014.
http://www.ceutaldia.com/content/view/101015/163/
Arango, A. Sei milioni di troppo? – L’immigrazione della Spagna nella crisi, fieri.it,
31/10/2012.
http://fieri.it/2012/10/31/sei-milioni-di-troppo-limmigrazione-nella-spagna-della-crisi/
Burgo Muñoz, P., España niega el asilo al 90% de las personas que lo solicitan,
eldiario.es, 09/12/2013.
118
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/Espana-niega-asilo-personas-solicitan_0_205429988.html
Carbajosa, A. / Estrada, D., Cientos de niños malviven en centros de inmigrantes en
España, El País, 05/06/2014.
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/05/actualidad/1401982200_939254.html
Cembrero, I., El líder opositor de Melilla refugia en su casa a 30 inmigrantes que
saltaron la valla, El País, 26/04/2013.
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/26/actualidad/1366927561_068366.html
Duddu, M. A., Legalizar Melilla, El País, 11 maggio 1985.
http://elpais.com/diario/1985/05/11/espana/484610406_850215.html
Fernández, D., Los inmigrantes cada vez cruzan más a España por sus propios medios
en vez de pagar a mafias, 20 Minutos, 05/05/2014.
http://www.20minutos.es/noticia/2090304/0/inmigracion/ceuta-melilla/rutas-mafias/
González, M., El Gobierno renfuerza con más medios la valla fronteriza, El País,
04/10/2005.
http://elpais.com/diario/2005/10/04/espana/1128376804_850215.html
Grados, A., Francisco: “Los empresarios prefieren coger a los inmigrantes porque les
pagan menos”, 20 Minutos, 10/12/2008.
http://www.20minutos.es/noticia/435507/0/francisco-orta/crisis/paro/
Guirval, J. M., Aberchán dice que no le quedó más remedio que dar refugio a los
inmigrantes, El Diario Digital de Melilla, 26/04/2014.
http://www.digitalmelilla.es/index.php/inmigracion/2522-aberchan-dice-que-no-le-quedo-mas-remedio-
que-dar-refugio-a-los-inmigrantes
I. N., Más de 800 inmigrantes africanos esperan hacinados en Melilla cruzar el
Estrecho, El País, 13/08/1997.
http://www.udel.edu/leipzig/texts3/ela13087.htm
119
Martínez, T. Las mujeres que transitan por Ceuta y Melilla sufren una tripla
discriminación, La Marea, 22/04/2014.
http://www.lamarea.com/2014/04/22/un-informe-de-apdha-denuncia-la-triple-discriminacion-de-las-
mujeres-en-ceuta-y-melilla/
Milá, E., Y después de saltar la valla ¿qué?, Minuto Digital, 22/10/2014.
http://www.minutodigital.com/2014/10/27/y-despues-de-saltar-la-valla-que/
Paradinas, M., El ministro de Interior ya no sabe cómo meter miedo: “Hay 80.000
inmigrantes esperando saltar la frontera”, El Plural, 04/03/2014.
http://www.elplural.com/2014/03/04/el-ministro-de-interior-ya-no-sabe-como-meter-miedo-hay-80-000-
inmigrantes-esperando-saltar-la-frontera/
Portillo Rodrigo, F., ¿A dónde van los inmigrantes que entran en Melilla?, Hay
derecho, 24/03/2014.
http://hayderecho.com/2014/03/24/a-donde-van-los-inmigrantes-que-entran-en-melilla/
Rodríguez, J. A., La plaza de toros de Tánger es utilizada para encerrar a inmigrantes
ilegales, El País, 02/91/1993.
http://elpais.com/diario/1993/01/02/espana/725929202_850215.html
Sánchez, J. L., Mentiras oficiales: las 1001 versiones sobre la tragedia de Ceuta,
eldiario.es, 07/02/2014.
http://www.eldiario.es/desalambre/uniforme-versiones-oficiales-tragedia-Ceuta_0_226428120.html
Sánchez, P., El líder de la oposición de Melilla refugia en su casa a 50
indocumentados, El Mundo, 26/04/2013.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/25/espana/1366925730.html
Villaécija, R., La vida después de la valla, El Mundo, 19/01/2015.
http://www.elmundo.es/espana/2015/01/19/54bbde0f22601d2e488b4579.html
120
Sitografia
The Universal Declaration of Human Rights, United Nations, 10/04/1948.
http://www.un.org/en/documents/udhr/
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España. (Vigente hasta el 1 de febrero de 2000).
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-lo7-1985.html
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, OHCHR, New York, 1987.
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
Resolución de 7 de junio de 1991, de la Subsecretaría, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de junio de 1991 sobre
regularización de trabajadores extranjeros, «BOE» núm. 137, 08/06/1991.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1991-14599
Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos
relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros
entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992, BOE num. 10,
25/04/1992.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1992-8976
UNHCR Note on the Principle of Non-Refoulement, novembre 1997.
http://www.refworld.org/docid/438c6d972.html
121
Guía Laboral - Actuaciones dirigidas a inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de
protección internacional, apatridia y protección temporal. Centros de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI).
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/texto/guia_15/contenidos/guia_15_37_3.htm
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2000-544
Acquis di Schengen - Accordo fra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux,
della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo
all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, Gazzetta Ufficiale,
22/09/2000.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:42000A0922(01)&from=EN
Estatuto de Autonomía de Ceuta.
http://www.congreso.es/consti/estatutos/estatutos.jsp?com=80&tipo=2&ini=1&fin=5&ini_sub=1&fin_su
b=1
Trends in International Migrant Stock: The 2013 Revision Nazioni Unite, Dipartimento
per gli Affari Economici e Sociali (2013).
http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/estimatestotal.shtml.
Statistica di opinione pubblica inerente al tema dell’immigrazione in Spagna, realizzata
nel maggio del 2014 e portata avanti dall’azienda spagnola Siempre Lógica.
http://www.simplelogica.com/iop/iop14006-inmigracion-enespa%C3%B1a.asp
Ejecución de la resolución de expulsión. Ministerio del Interior.
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/extranjeria/regimen-general/expulsion
Schengen (Acuerdo y Convenio).
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/schengen_agreement_es.htm
122
Ringraziamenti
Il mio ringraziamento va in particolar modo alle professoresse Beatriz Hernán
Gómez-Prieto e Maria Matilde Luisa Benzoni per aver accolto con piacere il tema della
mia tesi e per avermi accompagnata e sostenuta durante l’elaborazione di questo
lavoro.
Desidero inoltre ringraziare vivamente tutte le persone che mi hanno aiutata
nella ricerca del materiale poiché, anche grazie a loro, è stata possibile la realizzazione
della presente tesi. Ringrazio quindi: Carlos Esquembri, Juan Díez Sánchez, Antonio
Bravo Nieto, Gúzman García Bueno e i funzionari della biblioteca dell’Instituto
Cervantes di Milano.
Ma soprattutto voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in
questi ultimi due anni e che mi hanno sempre esortata a non arrendermi mai, ossia i
miei genitori, le mie amiche e il mio fidanzato Riccardo.