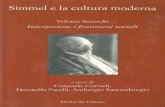Lezioni di morfologia I. Definizione, ambiti, scopi (Morphology Lessons I)
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Lezioni di morfologia I. Definizione, ambiti, scopi (Morphology Lessons I)
Grazia Crono Galèas
LEZIONI DI
MORFOLOGIA [J] Definizone, ambiti, s1opi
l@ LiNIVERSITY STUDIO PRESS ExMonç Emm:l]fiOV~xtiiV B~~À-iwv ;tm fif'{IIOiìLltlÙV
EJEHAI\ONIKH 2007
l@ UNIVERSITY STUDIO PRESS
Ilpc.ltq éxBooq: 0<aoa1ovitu] 2007 ISBN 978-960-12-1662-1
H pE(!tx~ Jj oÀtx'lj avar(mwar; eire rJ xa8' owv(njnore re6.nov avaJta(!aywytj rov {3t{3Àiov, xa8Wç xm 1J <pan:orVm]O'IJ TJ1tjJ1aroç ij oÀ6xlr;Qov rov {Jtj3Àfov, XWQ{ç TlJV ÉYJI(!Q((!YJ d0Eta rov sxò6rrJ, !lflW(!dTat an6 ro v611o.
© GRAZIA CROCCO GALÈAS
© UNIVERSITY STUDIO PRESS A.E. AQ~EVOn01JÀOU 32, 546 35 eEirAAONIKH T~À. 2310 208731, 2310 209637, 2310 209837, Fax 2310 216647 e-mail: [email protected] HÀextgovtx6 ~t~ÌI,to:rtwAeCo: www.universitystudiopress.gr
ITOA TOY BIBAIOY- IIEO."al;òyÀou 5, 105 64 A0HNA T~À. & Fax 210 3211097
And ali in war with time for love of you As he takes from you, I engraft you new
(W. Shakespear, Sonnets, When I consider everything that grows)
INDICE
Premessa . . . 13
La struttura interna delle parole 15 1.0. Morfologia: prima definizione . 15 1.1. Derivazione, composizione, conversione: cenni introduttivi 15
1.1.1. Derivazione 15 1.1.1.1. Parole semplici o primitivi
1.1.2. Composizione 1.1.3. Conversione
1.2. Flessione: cenni introduttivi
17 19 21 22
1.3. Prima sintesi 23 1.3.1. Formazione delle parole e flessione 24 1.3.2. Duplicità semantica del termine 'morfologia' 24
1.3.3. Le tecniche morfologiche e la flessione 25
2. La covariazione sistematica di forma e significato 27 2.0. Morfologia: seconda definizione 27 2.1. La struttura dei primitivi in italiano: struttura minima 27 2.2. Variazioni di forma e significato: l'oggetto dell'analisi
morfologica 30 2.3. La struttura interna si inquadra in un sistema di alternanze
e opposizioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2.4. La covariazione di forma e significato deve essere regolare,
sistematica e predicibile 31 2.4.1. La doppia articolazione: elementi con funzione
distintiva vs. elementi dotati di significato 32 2.4.2. Regolarità, sistematicità e predicibilità 33
10 Lezione di morfologia I
2.5. Le opposizioni morfologiche sono alternanze regolari di
forma e contenuto 2.6. Deroghe al principio della covariazione sistematica dì forma
34
e significato 35 2.6.1. Omonimie grammaticali 35 2.6.2. Sottoclassi di classi di parole 36 2.6.3. Un esempio di classe semantico-derivazionale . 38
2.7. Definizione L e definizione 2.: struttura interna e covaria-
zione sistematica di forma e significato 41
3. La struttura in costituenti 43 3.0. Morfologia: terza definizione 43 3.1. Le unità di prima articolazione: i monemi 43 3.2. L'analisi in costituenti: dalla frase al morfema 44 3.3. La segmentazione morfematica sta alla base della terza
definizione di morfologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.4. II morfema classico ................ ., . ...... ....... ..... 47 3.5. Esempi di segmentazione morfematica 47
3.5.1. Un esempio tipico di segmentazione in morfemi 47 3.5.2. Un tipico caso problematico di scgmentazionc
morfematica 49 3.6. I limiti della terza definizione 53
4. Una definizione globale di morfologia 57 4.0. Le tre definizioni a confronto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 4.1. Definizione l : la struttura interna della parola 57 4.2. Definizione 2.: la eovariazione sistematica di forma
e significato 58 4.3. Definizione 3 : la struttura in costituenti e il morfema 59 4.4. Sintesi 59 4.5. La specificità della morfologia 60
4.5.1. L'approccio semiotico 60 4.5.1.1. Un esempio di articolazione del 'terzo livello'. 61 4.5.1.2. Nuovi interrogativi 62
4.5.2. L'approccio funzionalista: la dinamica dei componenti tra naturalezza c innaturalezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 4.5.2.1. Naturalezza fonologica vs. naturalezza mor·
fologica 63
btdice 11
4.5.2.2. Morfemi vs. parole . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . .. . . . 67 4.5.2.3. Naturalezza morfologica vs. naturalezza
lessi cale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 67 4.5.2.3.1. La lessicalizzazione . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . . 68
4.5.2.4. Tra fonologia e morfologia: un esito innaturale 70 4.5.2.5. Morfologia vs. sintassi .. ... .. . .. . .. .. ... .. . .. .. .. .. 71
4.5.2.5.1. Un fenomeno di prevalenza della sintassi sulla morfologia (Fl) . ... . . . . . . 72
4.5.2.5.2. Un fenomeno di prevalenza della morfologia (FP) sulla sintassi . . . . . . . . . 73
4.5.2.5.3. FP ed Fl rispetto alla sintassi . . . . . . . . . 78 4.5.2.5.4. F1 e sintassi ............................... 79 4.5.2.5.5. Fenomeni di prevalenza della F1 sulla
sintassi . . . . . . . . . ... . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . .. .. 81 4.5.2.5.5.1. Forme analitiche e forme
sintetiche .. .... .. .. .. .. . .. .. 81 4.5.2.5.5.2. La categoria della
definitezza .. .. .. .. .. .. . .. .. . 81 4.5.2.5.6. I tipi linguistici e la Fl .. .. . . . .. . . . .. . . .. 82
4.5.2.6. L'equilibrio della grammatica e la diacronia delle lingue . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. 83
4.5.2.7. Sintesi . . . .. ... . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . .. . . .. 83 -1..6. Che cosa è la morfologia? .. .. .. .. ............... .... .. . ..... . .. .. .. 84
4.6.1. Che cos'è la morfologia? -Quesito 1.- Il componente 85 4.6.2. Il dominio della morfologia - Quesito 2. . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.6.2.1. a) La specificità . . . . . . . ... . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . ... . .. 85 4.6.2.2. b) La legittimità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 4.6.2.3. c) Le funzioni ....................................... 86
4.6.3. La variabilità interlinguistica- Quesiti 4. e 5. . . . . . . . . . . . 87 4.6.4. La morfologia è un lusso delle lingue?- Quesito 6. . . . 89
5. Conclusioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
PREMESSA
Questo libro è il primo di una serie di saggi monografici destinati ad illustrare le nozioni c i concetti di base della morfologia linguistica. Ad esso seguiranno i volumi dedicati alla parola, al morfema, a ciascuna delle tecniche morfologiche- derivazione, composizione e conversione- a fenomeni quali il suppletivismo e la retroformazione, e via di seguito altri temi specifici. Sei presente saggio si affronta la spinosa questione della definizione della morfologia in relazione al suo dominio e agli scopi che la caratterizzano in quanto componente della grammatica delle lingue verbali. In particolare, ,-engono prese in esame tre definizioni classiche di morfologia, a ciascuna delle quali è dedicato un capitolo. Muovendo dalla considerazione dei limiti e le aporie che esse presentano, viene proposta nel quarto capitolo una defmizione complessivamente intesa a superare le precedenti, facendo perno su due approcci teorici, la semiotica e il funzionalismo dinamico, qui visti in relazione complementare tra loro. Le argomentazioni ivi addotte in riS{X)Sta alla serie di interrogativi chiave connessi alla nuova proposta definitoria sono infine riprese e sintetizzate nel capitolo conclusivo.
Il libro, che presuppone una conoscenza basilare delle principali nozioni della linguistica generale, non contiene riferimenti bibliografici dato che si presenta nella forma di un breve saggio. E' stato in gran parte redatto a \~ienna durante il mio anno sabbatico 20005-2006 ed è stato portato a compimento a Salonicco, non senza averne adottato una prima versione sotto forma di appunti per studenti dei miei corsi di morfologia dell'Università -Aristotele" di Salonicco.
Grazia Croceo Galèas
Salonicco, 27 settembre 2007
CAPITOLO l
LASTRUTTURAINTERNADELLEPAROLE
1.0. Morfologia: prima definizione
La linguistica è la scienza che studia, descrive e interpreta la struttura e il funzionamento delle lingue e mira altresì a proporre un modello della facoltà del linguaggio, quest'ultima intesa come fondamento semiotico di tutte le lingue verbali e non verbali.
La morfologia è una delle molteplici discipline o branche della linguistica alla stessa stregua della fonologia, la sintassi, la semantica. In particolare, la morfologia è lo studio della struttura interna delle parole.
Questa definizione di morfologia comporta che l'analisi linguistica riconosca delle entità denominate parole e che almeno una parte del lessico delle lingue sia costituita da parole complesse, vale a dire parole aventi una struttura interna.
Inoltre, la definizione di parola complessa presuppone ovviamente l'e~ sistenza di parole non complesse, vale a dire parole semplici (o primitivi) in qualche modo connesse, come vedremo, con le parole complesse.
Infine, parlare di struttura interna delle parole significa ammettere che le parole abbiano anche una struttura, per così dire esterna, la quale non costituisce propriamente oggetto d'indagine del linguista che si occupa di morfologia.
1.1. Derivazione, composizione, conversione: cenni introduttivi
1.1.1. Derivazione
Le parole1, in quanto dotate di significante e significato, sono le unità di ba-
l. Adottiamo qui una definizione generica di parola, rinviando ad un'altra monografia la questione dell'esistenza di unità della lingua dette parole.
CAPITOL02
LA COV ARIAZIONE SISTEMATICA DI FORMA
E SIGNIFICATO
2.0. Morfologia: seconda definizione
In questo capitolo illustreremo una seconda definizione di morfologia che non necessariamente esclude la prima, ma, anzi, si affianca ad essa e ci per~ mette di prendere in considerazione alcuni aspetti della struttura delle parole che non appaiono evidenti alla luce della prima definizione. In base alIa seconda definizione, dunque, la morfologia si occupa della covariazione sistematica di forma e significato delle parole di una lingua.
2.1. La struttura dei primitivi in italiano: struttura minima
In 1.0. abbiamo definito la morfologia come lo studio della struttura interna delle parole. Con ciò abbiamo introdotto una differenza tra parole complesse (dotate di struttura interna) e parole semplici o 'primitivi', che stanno alla base delle parole complesse: in altri termini, le parole complesse pre
suppongono l'esistenza di parole semplici. Ricordiamo inoltre che per lingue come l'italiano le parole semplici
hanno pur sempre una qualche struttura, una struttura, per così dire, 'minima' rispetto alla struttura delle parole complesse; essa consta di una basecon una determinata sequenza fonologica e un determinato significato che fa parte del lessico della lingua- cui segue direttamente un elemento nella
- parte finale della parola che nella tradizione grammaticale è detto desinenza o terminazione o, secondo la terminologia linguistica, suffisso flessionale. Questo elemento, che per il momento non tenteremo di definire formal
mente né di specificare ulteriormente, in una lingua come l'italiano non può
CAPITOLO 3
LA STRUTTURA IN COSTITUENTI
3.0. Morfologia: terza definizione
Prendiamo ora in esame la seguente definizione di morfologia che pone in luce un altro aspetto della struttura delle parole complesse: la morfologia
è lo studio delle diverse combinazioni di morfemi che generano parole. Questa definizione è conciliabile con la prima definizione (la struttura interna delle parole complesse) piuttosto che con la seconda (il covariare sistematico di forma e significato). Per buona parte della linguistica moderna la struttura interna di una parola complessa consiste in una determinata combinazione di morfcmi. I morfemi, come vedremo nei paragrafi seguenti, sono i segni linguistici minimi, dotati, in quanto segni, di forma e significato, c non ulteriormente scomponibili in segni di rango inferiore. Le parole si articolano in morfcmi e la struttura interna delle parole altro non è che una sequenza di morfemi. L'analisi morfologica è dunque un'analisi della struttura morfematiea delle parole. Nei paragrafi seguenti ci soffermeremo sulle particolari implicazioni della terza definizione di mor
fologia.
3.1. Le unità di prima articolazione: i monemi
~ella sezione 2.4.1. abbiamo introdotto la nozione di moncma in quanto unità di prima articolazione. Abbiamo aggiunto che esistono almeno quattro ordini di monemi:
l) i morfemi, che combinandosi tra loro formano parole 2) le parole, che si combinano per formare sintagmi
CAPITOL04
UNA DEFINIZIONE GLOBALE DI MORFOLOGIA
4.0. Le tre definizioni a confronto
Abbiamo fm qui discusso tre possibili modi di intendere lo studio della morfologia, ciascuno dei quali sottende una diversa interpretazione della struttura del componente modologico, del tipo di unità che lo costituiscono, dei meccanismi e delle operazioni che in esso si verificano. Riassumiamo brevemente nei paragrafi seguenti.
4.1. Definizione 1: la stmttura interna della parola
La morfologia è lo studio della struttura interna delle parole. Ciò comporta il riconoscimento di parole semplici (o primitivi), prive di struttura (ma ciò è variabile da lingua a lingua, come è stato illustrato in 1.1.1.1.) e parole complesse, ossia aventi struttura interna. Le parole complesse sono formate a partire da delle basi che possono essere semplici o complesse. In 1.1.1. abbiamo presentato un esempio di parola complessa, zuccheriera, formata su una base semplice: infatt~ il significante e il significato di zuccheriera presuppongono il significante e il significato del primitivo zucchero. Esistono anche parole complesse che derivano da parole a loro volta complesse: ad esempio, il nome storicismo viene derivato dall'aggettivo storico, il quale, a sua volta, deriva dal nome storia. Non ci siamo soffermati su questo secondo tipo di parole complesse, che sono altrettanto numerose quanto quelle furmate a partire da basi semplici, ma è chiaro che i meccanismi di produzione sono gli stessi: derivazione, composizione e conversione. La definizione di morfologia come studio della struttura interna delle parole va tuttavia sviluppata e precisata: è necessaria, ma non sufficiente. Essa propone im-
58 Lezione di moifologia I
plicitamente che la competenza morfologica del parlante di una determinata lingua comporti la capacità di riconoscere e formare secondo varie modalità parole aventi struttura. Da questo punto di vista la morfologia costituisce quel componente della grammatica mentale che genera parole a partire da altre parole esistenti nel lessico, anch'esso mentale, della lingua. Oc
corre però chiarire con quali unità o con quali tipi di segni opera intuitiva
mcnte il parlante nella produzione e nella ricezione di parole aventi struttura interna; detto in altri termini, che cosa deve essere presupposto in sede teorica per poter interpretare la competenza morfologica: la parola o un suo
costituente di rango inferiore?
4.2. Definizione 2: la covariazione sistematica di forma e significato
La definizione di morfologia come studio della covariazione sistematica di forma e significato tenta di evidenziare un criterio ritenuto fondamentale
per la struttura del componente morfologico, nonché sostanziale per l'indagine del morfologo: in base a tale criterio la sola variazione formale non co
stituisce un fenomeno morfologico, ossia un fenomeno al livello della paro
la, che come tale implichi il presupposto della struttura interna delle paro
le. Si è visto infatti che i cambiamenti del significante, quando non siano accompagnati da sistematiche differenze di significato, appartengono allivel
lo fonologico, ovvero alla seconda articolazione delle lingue. Nonostante il
tentativo di evidenziare un aspetto che dovrebbe essere essenziale per la
morfologia- in quanto disciplina linguistica- e per il componente morfologico- in quanto livello autonomo della grammatica del parlante- numero
si e 'sistematici' sono i 'paradossi' che contraddicono o indeboliscono la portata di questa definizione: si vedano i casi di omonimie grammaticali, che
consistono nella corrispondenza tra uno stesso significante e significati dif
ferenti, come illustrato in 2.6.1., o i casi di sinonimie di elementi formativi,
come, ad esempio, la sinonimia dei suffissi che in italiano derivano nomi deverbali d'azione, vista in 2.6.2. Va detto inoltre che la definizione che attri
buisce al dominio della morfologia, come tratto caratterizzante, le covaria
zioni di forma e significato non permette di distinguere tra covariazioni allivello della parola e covariazioni al livello sin tattico, ossia per monemi supe
riori alla parola nella gerarchia degli elementi di prima articolazione. Infine, questa definizione non dice nulla riguardo ai focus, per così dire, o al
l'entità che viene interessata dal cambiamento formale e semantico: in altri
Una definizione globale di mmfologia 59
termini non ci dice se ciò che si modifica è la parola o un qualche suo componente, e ciò~ si badi~ espressamente per evitare le incongruenze della terza definizione, quella legata, come già sappiamo, alla nozione di morfe-
4.3. Definizione 3: la struttura in costituenti e il morfema
La definizione della morfologia come studio dell'analisi in costituenti implica la nozione di morfema che più volte abbiamo richiamato. Da un lato, questa definizione, a differenza della precedente, individua nel morfema la sede del fenomeno morfologico, definendo i morfema come la più piccola unità di prima articolazione, vale a dire non ulteriormente scomponibilc in elementi che abbiano il valore di segni; d'altro lato, questa stessa definizione non coglie la specificità dei fenomeni morfologici, giacché il morfema, visto come costituente immediato della parola, non si differenzia dagli altri costituenti superiori: in tal modo l'analisi morfologica, intesa come segmentazione, non si distingue da quella sin tattica e, di conseguenza, restano ignorati o difficilmente descrivibili proprio quei fenomeni che nemmeno la precedente definizione 2. riesce a interpretare. L'analisi della struttura della parola intesa come analisi in costituenti rivela sostanziali contraddizioni, incoerenze e deroghe rispetto alla definizione classica di morfema.
4.4. Sintesi
A questo punto si pongono tre interrogativi:
a) Che cosa è la morfologia? b) Esiste un dominio della morfologia autonomo, tale che gli studi di mor
fologia abbiano una loro specificità e legittimità? c) La nozione di morfema è necessaria perché si delimiti il campo di inda
gine della morfologia c, ancor prima, si identifichi la natura del componente morfologico? E se sì, la definizione di morfema va adeguatamente modificata?
Per rispondere a queste domande bisognerebbe fare riferimento a molti studi teorici e a numerose evidenze empiriche che in questa sede non possiamo prendere in esame. Avanzeremo delle risposte nei paragrafi della sezione 4.5., per poi dare una definizione complessiva di morfologia nella sezione 4.6.
60 Lezwne di morfologia l
4.5. La specificità della morfologia
4.5.1. L'approccio semiotico
La lingua è un codice, cioè un sistema di segni destinato alla produzione e
ricezione di messaggi. Come tutti i codici la lingua è dotata di un lessico,
cioè un insieme di segni, e una sintassi, cioè un insieme finito di regole per
la combinazione dei segni. Dal punto di vista della semiotica {la scienza che si occupa dei sistemi
di segni o codici) la sintassi di una lingua -come di qualsiasi codice - non
richiede necessariamente l'articolazione dei propri ~egni né in unità di se
condo livello (i fonemi) né in unità segniche che potremmo definire 'segni minimi' (i morfcmi). Molti codici infatti dispongono solo di monemi semplici su cui operano le regole sintattiche e sono privi di una qualche artico
lazione paragonabile tanto all'articolazione in fonemi quanto a quella in morfemi propria delle lingue storico-naturali. Dunque. in termini semiotici,
si potrebbe affermare che la struttura interna delle parole in morfemi non
sia una condizione altrettanto necessaria al funzionamento della lingua
quanto la struttura ~intattica. E tuttavia, come il livello fonologico, cosi anche il livello morfologico risponde ad un'esigenza fondamentale, quella di rendere più potente e duttile il codice lingua. In particolare, la morfologia
si pone come livello intermedio tra seconda articolazione, con clementi con sola funzione distintiva, e prima articolazione, con elementi dotati di signi
ficato. In tal modo la lingua si caratterizza rispetto a innumerevoli altri codici non soltanto per la doppia articolazione, ossia per l'opposizione dei due
livelli fonematico e monematico, ma anche per l'esistenza di un terzo livel
lo, che si colloca tra i due precedenti, modulando i segni del lessico, cioè le parole, in segni minimi, cioè i morfcmi, e radicalizzando così la articolari età dell'intero codice.
In particolare, la scomponibilità delle parole in segni minimi non ulteriormente analizzabili, permette alla lingua di esprimere un maggior nume
ro di significati di quanti ne potrebbero esprimere il lessico, attraverso una serie di segni semplici, e la sintassi, con le sole regole combinatorie. In tal senso la morfologia è sia un meccanismo di organizzazione interna del les
sico, che altrimenti sarebbe solo una lista di monemi formalmente e scmanticamente immotivati e pertanto inanalizzabili, sia un mezzo di potenzia
mento delle capacità espressive delle regole sin tattiche.
La morfologia è dunque il componente che si situa tra fonologia e sin-
Una definizione globale di mOJfologia 61
tassi ed è tuttavia dotato di una sua autonomia proprio in virtù della sua funzione di raccordo: la funzione precipua della morfologia consiste nell'articolare i segni del codice lingua in maniera più profonda e complessa di quanto non faccia il livello di seconda articolazione, vale a dire il livello fonologico.
4.5.1.1. Un esempio di anicolazione del 'terzo livello'
Per comprendere quale sia la portata dell'articolazione morfematica consideriamo un esempio. Ogni lingua dispone di mezzi per l'espressione del plurale dei nomi. La varietà dei mezzi è numericamente e tipologicamente 17 finita. Tra questi, molto frequente è la flessione, una modalità di espressione tipicamente morfologica: moltissime lingue infatti fanno uso di suffissi flessivi per l'espressione dell'opzione di plurale all'interno della categoria del numero. L'italiano, ad esempio, modifica la parte finale delle parole appartenenti alla classe dei nomi creando un'alternanza di suffissi che, come sappiamo (v. 2.1.), rappresenta un'opposizione morfologica, ovvero una covariazione sistematica di forma e significato: pertanto, al singolare tavol-o corrisponde il plurale tavol-i, così come a cas-a corrisponde cas-e. Se la lingua non ricorresse alla flessione, se dunque non sfruttasse le potenzialità dovute alla struttura interna delle parole, per la forma del plurale dovremmo attenderci un segno non scomponibile ulteriormente in segni più piccoli: al segno X, con valore di singolare, corrisponderebbe un segno di plurale Y formalmente irrelato con X. Viceversa, tramite la flessione si ha una situazione rappresentabile nel seguente modo: X1 vs. X2, laddove X rappresenta la base formalmente e semanticamente comune tanto al singolare quanto al plurale e gli esponenti l e 2 indicano la diversità del significante e del signi-
17. La tipologia è quella disciplina linguistica che studia le lingue in dimensione comparativa con lo scopo di evidenziare le somiglianze e le differenze che caratterizzano sistemi linguistici diatopicamcnte e diacronicamcntc distanti l'uno dall'altro. At· traverso il confronto interlinguistico la tipologia identifica 'tipi' linguistici, ovvero insiemi strutturati di tratti fonologici, morfologici c sintattici che ricorrono in determinate lingue e non in altre. L'indagine tipo logica mira a individuare non soltanto le differenze che costituiscono i divcr&i tipi, ma anche quei tratti 'universali' che accomunano tutte le lingue storico-naturali. La tipologia mostra come la varietà delle lingue non sia indefinita, ma sia riconducibile in ultima analisi a un numero finito di sistemi possibili.
62 Lezione di moifologia I
ficato dei due suffissi flessivi. In tal modo vengono realizzate due forme parzialmente diverse di una stessa parola: un unico significato di base, espre~;. so dall'identità del significante in entrambe le forme, e due diversi suffissi portatori di due opzioni distinte di uno stesso contenuto grammaticale; nel nostro caso, il contenuto grammaticale di numero si attualizza in italiano attraverso due opzioni, singolare e plurale18. Risulta facilmente comprensibile il guadagno in termini di economia dei mezzi formali. Lo stesso valga per i suffissi della formazione della parola: la parola complessa zuccheriera si correla formalmente al nome di base zucchero, con il quale è semanticamente legata.
4.5.1.2. Nuovi interrogativi Se si assume la prospettiva semiotica secondo cui la morfologia rappresenta un ulteriore livello di articolazione oltre ai livelli fonematico e monematico, si apre un'altra serie di interrogativi che si aggiungono a quelli formulati in 4.4.: ad essi, come ai precedenti, risponderemo chiamando in causa un secondo approccio teorico che va di pari passo con quello semiotico, vale a dire il funzionalismo. I quesiti che avanziamo sono i seguenti:
1) Perché, nonostante il vantaggio derivante dall'articolazione delle parole in morfemi, esistono lingue quasi o del tutto prive di morfologia?
2) Perché i sistemi morfologici differiscono profondamente da lingua a lingua in quanto a grado di complessità?
3) È ragionevole sostenere, come fanno autorevoli linguisti, che una morfologia particolarmente ricca sia solo un 'malattia delle lingue', un di più o un lusso?
4.5.2. L 'approccio funzionalista: la dinamica dei componenti tra naturalezza e innaturalezza
Se la morfologia rappresenta un terzo livello di articolazione che rende il codice più sofisticato perché capace di esprimere in modo sistematico e
18. Esistono molte lingue in cui le opzioni all'interno della categoria di numero sono più di due. Oltre al singolare e al plurale, una lingua può infatti presentare un triale, talora anche un quadrai e e un paucale. Come è noto, il greco classico era dotato di una forma di duale tanto per la flessione dei nomi quanto per quella dei verbi.
,,. Una definizione globale di morfologia 63
obbligatorio una fitta rete di significati, è lecito attendersi che tutte le lingue verbali dispongano di un apparato morfologico e che tale apparato, nella sua struttura, sia sostanzialmente simile se non identico da lingua a lingua. Non è esattamente cosi. Per rispondere agli interrogativi l) e 2) in 4.5.1.2. bisogna anzitutto guardare all'intero meccanismo della grammatica astratta e mentale che il linguista tenta di descrivere, esplicitare e rappresentare formalmente. Secondo un particolare modello teorico di tipo funzionalista19 il codice lingua ha due funzioni primarie: l) la comunica· zione e 2) l'espressione delle capacità cognitive degli esseri umani. Il funzionamento del codice nella produzione e ricezione dei messaggi è regolato dal sistema della grammatica, la quale è costituita da almeno tre componenti semiautonomi20: fonologia, morfologia e sintassi. Il rapporto che vige tra i vari componenti è di tipo conflittuale e dinamico. Ciascuno di essi, infatti, congiuntamente al lessico, risponde a esigenze specifiche il cui soddisfacimento genera contrasti che si risolvono solo attraverso il raggiungimento di un equilibrio dinamico, vale a dire soggetto a continui rimodellamenti. A tale equilibrio contribuisce anche la tendenza generale che fa sì che nei conflitti sia rispettata una certa gerarchia dei componenti: in altri termini, i componenti prevalgono l'uno sull'altro a seconda della loro salienza semiotica.
4.5.2.1. Naturalezza fonologica vs. naturalezza moifologica
Si consideri il rapporto tra fonologia e morfologia. Da un lato, la fonologia, attraverso le sue regole e operazioni, garantisce la possibilità di produzione e ricezione dei foni, dunque la possibilità di riconoscimento dei fone-
19. I modelli teorici che si rifanno all'approccio funzionalista in linguistica sono più d'uno e in parte si differenziano tra loro. Tutti però hanno in comune il presupposto che la lingua sia un codice fmalizzato a soddisfare determinate funzioni, tra cui la comunicazione tra gli esseri umani, e in quanto tale sia strutturato proprio per rispondere con mezzi adeguati ai suoi scopi primari.
20. L'approccio funzionalista si differenzia in ciò dall'approccio generativista, secondo .... cui i componenti sono moduli della mente che funzionano l'uno indipendentemen
te dall'altro. Viceversa, il modello teorico del funzionalismo dinamico sostiene che i componenti sono autonomi solo in parte poiché interagiscono tra loro e altresi con le altre capacità cognitive.
64 Lezione di morfologia I
mi21; dall'altro, la morfologia fa sì che le unità minime che costituiscono le
parole, in breve i morfemi, siano ben identificabili &otto l'aspetto del significante e, dal canto loro, i significati delle parole siano il più possibile composizionali, vale a dire dati dalla somma dei significati dei singoli morfcmi-."
Le due diverse tendenze, fonologica e morfologica, entrano inevitabilmente in conflitto. La fonologia, ai fini della pronunciabilità o della percezione dci foni, può determinare attraverso una varietà di operazioni -come l'assimilazione22 o la dissimilazionc23 - fenomeni che finiscono per oscurare i
21. Va detto che possono sussistere contrasti anche tra le diverse funzioni di uno stesso
componente. La fonologia, in particolare, deve soddisfare le opposte esigenze della produzione e della percezione dci ~uoni: ciò comporta la duplice tendenza a favori
re, da un lato, la pronunciabilità da parte del parlante, dall'altro, la comprensibilità da parte dell'ascoltatore. La fonologia opera pertanto attraver~o fenomeni di due tipi: lenizione e fortizione. Si ha lenizione quando due suoni vengono resi più simili in
base al luogo o al modo di articolazione per facilitarne la pronunciabilìtà: è questo
il principio che determina la nasalizzazione di vocali seguite da consonanti nasali o la ~onorizzazionc di consonanti sorde in posizione intcrvocalica; viceversa, si ha for
tizione quando due suoni simili si diver~ificano per luogo o modo di articolazione af
finché il contrasto articolatorio sia più marcato e, quindi, più facilmente percettibile: è questo il caso delia desanalizzaL.ionc di vocali nasali, le quali, essendo poco sa
lienti dal punto di vista della ricezione. sono meno frequenti delle corrispondenti vocali orali nei sistemi vocalici delle lingue del mondo.
22. L'assimilazione è un tipico processo fonologico di lenizione: si tratta infatti dell'm,
vicinamcnto tra due suoni contigui nella sequenza fonologica. In italiano, come in
molte altre lingue, si ha assimilazione della consonante nasale al luogo di articolazione della consonante ~ucccssiva. Questo fenomeno di adeguamento articolatorio
si verifica ad esempio in presenza della nasale finale del prefisso con valore negati-vo in-, il quale ricorre come tale solo quando precede una base con vocale ini.dale,
tutti gli altri contesti la na~a-
nasale bilabiale in forme come im-popolare, una nasale lahiodcntale in forme come in-felice, una nasale velare in forme come in-capace. e via di seguito. Fenomeni di as
similazione si verificano spesso nello sviluppo diacronico delle lingue. I\cl passaggio dal latino all'italiano, ad esempio, il nesso -a- di oeclmiva velare c occlusiva dentale, in parole come acta o lactem, si è trasformato in una consonante occlusiva den
tale lunga, che ha dato luogo rispettivamente alle forme otto c latte.
23. La dis&imilazione è il fenomeno opposto all'assimilazione: due suoni simili ~i diversificano per luogo o modo di articolazione. Il latino arbor, w·boris si è moditicato nel
l'italiano albero, in cui una delle due liquide polivibranti è divenuta liquida laterale.
Crw definizione globale di mmfologia 65
confini morfematici e dunque per opacizzare la trasparenza del significante e la composizionalità del significato delle parole complesse. Dal canto suo, la morfologia, favorendo la trasparenza del significante, cioè la sua in,·ariabilità, può ostacolare in larga misura la generalità delle regole fonologiche, !imitandone gli effetti. Esistono pertanto fenomeni naturali, tali che assecondano la struttura e il funzionamento di un componente, e fenomeni che viceversa risultano rispetto ad esso innaturali. Le ragioni della naturalezza differiscono dall'uno all'altro componente.
Valga come esempio la regola della palatalizzazione delle occ\usive velari davanti a vocali pala tali in italiano; in base ad essa, J'occlusiva velare di parole come quelle esemplificate in (44):
(44) amic-o psicolog-o
si palatalizza (più esattamente diventa atlricata postalveolare) dinanzi alla \'Ocale palatale del suffisso di plurale (o di qualche altro suffisso, come il suffisso aggettivale -ic-o in artistico - artistici), dando come esito rispettivamente le forme in ( 45):
(45) amic-i psicolog-i
Lo stesso fenomeno si realizza, ad esempio, dinanzi alla vocale liJ dei suffissi derivazionali -izi-a e-ia
( 46) amic-izia psicolog-ia
La palatalizzazione in italiano non è tuttavia un fenomeno che si manifesta in tutti i casi in cui si realizza il contesto previsto dalla formulazione della regola: detto in altri termini, la sua applicazione non è del tutto obbligatoria; se lo fosse si tratterebbe propriamente di una regola fonologica che, in quanto tale, sarebbe con molta probabilità produttiva, dovrebbe cioè applicarsi tutte le volte in cui un'occlusiva velare è seguita da vocale pala tale. Ciò non awicnc, come dimostrano, ad esempio, le forme di plurale dci nomi in (47) e degli aggettivi in ( 48):
Fenomeni di dissimilazione sono meno frequenti nelle lingue ri~pctlo a fenomeni di assimilazione.
66 Lezione di rrwifologia I
(47) carico mago
(48) sporco vago
le cui rispettive forme di plurale sono date in (49) e (50):
(49) carichi maghi
(50) sporchi vaghi
In tutte queste occorrenze l'occlusiva velare presente nella forma del singolare si mantiene anche nel plurale nonostante sia seguita dalla vocale palatale del suffisso -i. In questo come in molti altri casi di mancata palatalizzazione prevale la tendenza a lasciare inalterato il significante della forma di base, affinché l'identità del morfema sia preservata: in altri termini, le finalità morfologiche prevalgono su quelle fonologiche.
Dall'esempio dato risulta chiaro che ciò che è naturale ai fini della fonologia non lo è ai fini della morfologia e viceversa. Più in generale, secondo il modello teorico dell'equilibrio dinamico, nei conflitti fra componenti si ha la tendenza a rispettare la priorità di un componente sull'altro: in particolare, le ragioni della morfologia prevalgono su quelle della fonologia, poiché è più utile ai fini del funzionamento del codice preservare la riconoscibilità della struttura interna delle parole piuttosto che favorire la generalizzazione dei fenomeni fonologici; questi ultimi, infatti, dovendo garantire la pronunciabilità e l'identificabilità dei suoni di una lingua, agiscono indipendentemente dai confini morfematici. Nel caso della palatalizzazione, come in molti altri casi, risulta evidente che la necessità di un'agevole identificabilità dei morfemi ostacola la diffusione di un fenomeno fonologico naturale. È fonologicamente naturale che le consonanti occlusive velari si palatalizzino quando sono seguite da vocali palatali, ma è altresl morfologicamente naturale che i morfemi mantengano invariato il loro significante all'interno di parole morfologicamente e semanticamente correlate; nel conflitto hanno la meglio le esigenze della naturalezza morfologica contro quelle della naturalezza fonologica, dato che la logica del codice attribuisce più peso ai morfemi, che sono segni, piuttosto che ai fonemi, che sono unità distintive.
Una definizionè 'globale di moifologia 67
4.5.2.2. Morfemi vs. parole
Avendo adottato congiuntamente il punto di vista della semiotica e il modello teorico del funzionalismo dinamico, risulta necessariamente che i morfemi, essendo i segni linguistici minimi, prevalgano sui fonemi, che non sono segni, bensì unità con funzione distintiva. In base a tali premesse consegue altresì che le parole, essendo segni primari, abbiano la meglio sui morfemi, che sono solo segni secondari. l segni primari - le parole - costituiscono le unità di cui è composto il lessico, mentre i segni secondari- i morfemi- essendo segni all'interno di segni, non entrano direttamente a far parte del lessico, ma solo mediatamentc, attraverso la struttura interna delle parole.
4.5.2.3. Naturalezza m01fologica vs. naturalezza lessicale
Data la maggiore salienza semiotica delle parole sui morfcmi, ci aspettiamo che, nel quadro dell'equilibrio dinamico dei componenti della grammatica, il lessico abbia la priorità sulla morfologia, specificamente sul sottocomponente morfologico della FP piuttosto che su quello della Fl. E infatti, le ragioni della FP differiscono da quelle del lessico e con esse i rispettivi criteri di naturalezza/innaturalezza: ciò che è naturale ai fini dell'organizzazione e il funzionamento del componente morfologico non lo è per la strutturazione e le finalità del lessico. La funzione primaria della morfologia (sia essa FP o Fl) consiste nel motivare i significanti e i significati delle parole, arricchendo in tal modo il serbatoio lessicale (ad opera dei meccanismi di FP) e creando forme diverse di una stessa parola, ai fini del funzionamento della sintassi (ad opera della Fl). La funzione primaria del lessico, viceversa, consiste nell'immagazzinare nuove unità, le quali, dotate di una forma fonologica, un contenuto semantico e numerose informazioni grammaticali (come la categoria e la struttura esterna24), vengono trasmesse al componente sin tattico che le utilizza secondo determinate regole combinatorie.
È intrinsecamente naturale per la morfologia e, in particolare, per la FP, motivare la forma c il significato delle parole, dato che tutte le tecniche e le operazioni morfologicbc che incrementano le unità del lessico consistono proprio nel formare parole nuove a partire dalla forma e il significato di
24. Per struttura esterna (o valenza) si intende la capacità di una parola di legarsi ad altre parole per formare i monemi di rango superiore, ossia i sintagmi.
68 Lezione di morfologia l
parole preesistenti. D'altra parte il lessico tende a modificare nel percorso diacronico il significato e il significante delle nuove parole complesse generate dal componente morfologico, affinché l'unità (o entrata) lessicale sia una semplice etichetta, cioè una determinata sequenza fonologica denotante univocamente un determinato contenuto scmantico.
Al fine di possedere etichette con mera funzione dcnotativa è irrilevan
te che il significante e il significato delle parole siano una funzione delle parti che li costituiscono. Il lessico è in primo luogo un insieme di monemi de
stinati alle regole di combinazione della sintassi, esso mira pertanto a disporre di unità non analizzabili. Ai fini dell'immagazzinamento delle unità
lessicali è supertluo che significante e significato delle parole siano trasparenti; al contrario, il significante e il significato di un segno primario devo
no essere preferibilmente unici e inanalizzabili, senza rinviare ad altri significanti e significati: la motivazione morfologica finisce quindi in secondo piano rispetto alla necessità del codice di disporre di semplici monemi da combinare tra loro per ottenere i significati complessi delle frasi.
Le parole complesse, generate dal componente morfologico attraverso
le tecniche di derivazione, composizione e conversione, permangono nel lessico e tendono ad assumere significati non più composizionali bensì inana
lizzabili nelle parti costituenti, poiché ogni parola tende a cristallizzarsi in un significato unico e indipendente dai suoi morfemi. Se dunque il lessico, in sincronia, è prevalentemente motivato dalle regole della FP, tende, invece,
in diacronia, a trasformarsi in mero elenco di etichette. Più specificatamente, l'uso delle parole attraverso il funzionamento del codice porta all'opacità morfologica e, d'altra parte, favorisce lo stoccaggio lessicale. Le nuove uni
tà generate continuamente dal sottocomponente della FP si adattano alle esigenze del lessico perdendo la loro naturalezza morfologica: la permanen
za delle parole complesse nel lessico, ovvero il loro uso, fa sì che la traspa
renza dei confini morfematici e la composizionalità dei contenuti si opacizzi. Ciò è innaturale per la morfologia, ma naturale e funzionale per il lessico.
4.5.2.3.1. La lessicalizzazione
Un tipico esempio di prevalenza del lessico sulla morfologia è dato dai processi di lessicalizzazione delle parole complesse, siano esse derivate, composte o convertite.
Si considerino alcune parole composte dell'italiano, come quelle esem
plificate in (51):
(51) camposanto capostazione
lavapiatti agrodolce altopiano
69
Il significato di ciascun composto in (51) è trasparente, ossia è dato dalla somma dei significati dei suoi costituenti, vale a dire delle parole che formano il composto. Ad esempio, un capostazione è 'qualcuno che sta a capo di una stazione', analogamente, agrodolce si dice di qualcosa che ha un sapore al tempo stesso agro e dolce.
Si osservino ora i dati in (52):
(52) falegname
gentiluomo
madreperla
panforte
quintessenza
Diversamente dal significato dei composti in (51), il significato di ciascuno dei composti elencati in (52) non è trasparente, cioè non corrisponde alla somma dei significati delle parole di base. Ad esempio, un gentiluomo non è 'un uomo gentile', così come panfone non è 'un pane forte'. Nel caso di falegname non risulta nemmeno evidente che la parola sia una parola composta, cioè formata da due costituenti, i quali sarebbero un verbo ifa dal verbo fare) c un nome (legname)Z5.
I composti in (52), a differenza di quelli in (51), hanno perso la loro motivazione semantica. Sebbene sia rawisabile in ognuno di essi la struttura tipica di un composto dell'italiano, formato da due parole di base, sul piano del significato non è possibile, senza il ricorso all'analisi etimologica, assegnare all'intera parola un contenuto che sia il risultato della somma delle due basi. Si dice pertanto che le parole in (52) sono Jessica\izzate, vale a dire rappresentano delle unità o entrate lessicali semanticamente inanalizzabili. La loro permanenza nel lessico, dal momento in cui sono state forma-
25. In origine, la parola composta falegname è stata prodotta dalla stessa regola di FP che produce ancora in sincronia composti verbo + nome del tipo di apribottiglie, guardaboschi, spazzacamino.
70 Lezione di mmfologia l
te, nonché il loro uso hanno compattato e oscurato la composizionalità semantica.
La lessicalizzazione delle parole complesse è un fenomeno che mostra chiaramente come l'esigenza di immagazzinamento cd ctichcttamcnto lessicale prevalga sulla motivazione formale e semantica, ovvero sulla naturalez
za morfologica.
4.5.2.4. Tra fonologia e morfologia: un esito innaturale
Poiché la gerarchia semiotica dei componenti della grammatica è solo una tendenza e non un'universale assoluto, molti sono i fenomeni che nelle lingue violano la scala di priorità: avviene pertanto che la naturalezza di un componente meno 'forte' dal punto di vista semiotico abbia la meglio sulla naturalezza di un componente generalmente dominante. Valga come esempio il caso tutt'altro che infrequente in cui delle regole fonologiche oscurino la trasparenza morfematica, ottimizzando così la salicnza dei fonemi a scapito di quella dei morfemi.
In proposito basti citare una tipica regola fonologica che opera sistematicamente in tedesco, ossia la desonorizzazione delle consonanti occlusi
ve sorde in posizione finale di parola26. In tale contesto (pur con dei precisi condizionamenti che qui non esamineremo), si realizza la neutralizzazione dell'opposizione di sordità/sonorità a favore di fonemi occlusivi sordi: ciò significa che in fine di parola le consonanti occlusive si presentano regolar
mente come sorde e mai come sonore. I nomi e gli aggettivi rispettivamente in (53) e (54) hanno consonanti sorde finali, nonostante la grafia registri grafemi indicanti le omotopiche sonore27:
(53) Kalb [p] 'vitello' Rad lt] 'ruota' Tag [k] 'giorno'
26. Va detto propriamente che la regola agisce al confine di morlema e, conseguentemente, in posizione finale di parola; tuttavia, per semplicità di esposizione, ci limiteremo a prendere in considerazione solo quest'ultimo caso.
27. Non a caso la grafia mostra chiaramente che la consonante di base, ossia quella che
ricorre in tutte le forme del paradigma tlessionale, ad eccezione del nominativo (privo di suffisso), è una sonora. Non ci soffermercmo oltre sul perché vada postulata
una forma di base con un fonema sonoro c non sordo, tuttavia la generalità e la frequenza di occorrenza costitui~cono un buon argomento a favore di una direzionalità che va dal fonema sonoro a quello sordo e non viceversa.
,\_-
Una definizione globale di morfologia 71
(54) gelb [p] 'giallo' lustig [k] 'divertente'
Poiché in tutti gli altri contesti l'opposizione di sonorità vige, si verifica re~ golarmente nei paradigmi flessionali un'alternanza fonologica tra conso~ nanti occlusive sonore in posizione intervocalica e relative consonanti oc~ elusive sorde in fine di parola. In breve, quando la consonante è seguita da un suffisso iniziante per vocale, trovandosi in posizione intervocalica man~ tiene il tratto di sonorità che, viceversa perde nella posizione finale di paro~ la A tal proposito valgano come esempio le forme di genitivo, sia nominale che aggettivale, con suffisso ~es, riportate in (55) e (56), che corrispondono alle forme di nominativo date rispettivamente in (53) e (54):
(55) Knlb-es Rad~es
Tag-es
(56) gelb-es lustig-es
La desonorizzazione delle occlusive in posizione fmale di parola è un fenomeno spiegabile in termini di plausibilità fonetica e, pertanto, fonologicamente naturale e, non a caso, ricorre anche in altre lingue, come ad esempio il russo. La sua applicazione produce tuttavia un'opposizione fonologica che danneggia l'integrità dei morfemi di uno stesso paradigma flessionale. Si verifica infatti una variazione del significante che opacizza la riconoscibilità del morfema di base. È questo un tipico caso in cui le ragioni della naturalezza fonologica prevalgono su quelle della naturalezza morfologica: la struttura fonematica si modifica per rispondere a esigenze di pronunciabilità, giacché dal punto di vista articolatorio è relativamente 'facile' o 'na~ turate' realizzare in posizione finale di parola consonati prive, piuttosto che provviste, del tratto di sonorità; d'altra parte risulta compromessa l'invariabilità della struttura del morfema e, conseguentemente, i paradigmi fl.essionali presentano un'alternanza morfologica che, con termini tecnici, è detta alternanza allomorfica fonologicamente condizionata.
4.5.2.5. Morfologia vs. sintassi Risiede nella struttura stessa della grammatica e nella dinamica dei suoi componenti la ragione della maggiore o minore complessità dei sistemi
72 Lezione di m01j'alogìa l
morfologici delle diverse lingue del mondo. Numerose lingue sono infatti provviste di una ricca e articolata morfologia, tanto flessiva quanto di formazione della parola, mentre molte altre, come l'inglese, fanno uso in prevalenza di mezzi sintattici, ad esempio indici28, che funzionalmente hanno lo stesso valore delle desinenze di lingue come l'italiano.
Nei paragrafi che seguono mostreremo due esempi dì conflitto tra morfologia e sintassi, laddove nel primo caso è la sintassi a prevalere, nel secondo la morfologia. Ci soffcrmcremo poi sul diverso rapporto tra FP e sintassi, da un lato, e Fl c sintassi, dall'altro. Infine accenneremo brevementeal ruolo dci tipi linguistici nella risoluzione dei conflitti tra i diversi componenti.
4.5.2.5.1. Un fenomeno di prevalenza della sintassi sulla morfologia (Fl)
Le preposizioni rappresentano un tipico caso di parole funzionali o grammaticali29 che svolgono in lingue a prevalenza sintattica la stessa funzione dei morfemi di caso in lingue più o meno tlessive. È certamente un esempio di evoluzione in senso sintattico il cambiamento diacronico dal latino, lingua di tipo30 fortemente flessivo, all'italiano, lingua debolmente flessiva, o al francese, lingua pressoché isolante in cui la tlessione è sostituita dall'ordine dei costituenti frasali e dall'uso di parole funzionali. A causa dci mutamen-
28. Dal punto di vista semiotieo un indice è un segno che focalizza l'attenzione dell'u
tente sull'oggetto denotato dall'indice medesimo. Ad esempio, il fumo è considera
to solitamente indice del fuoco, così come sintomi specifici o febbre sono considerati indici di una determinata malattia. In linguistica è detto indice ogni segno che rinvii ad altro segno avente un significato primario o centrale nel codice e nel mes
saggio. In particolare, i morfemi flessionali sono indici che segnalano o individuano il contenuto lessicale, o scmantieo, del morfema di base al quale sono aggiunti. Ol
tre ai suffissi, sono indici i quantificatori e i determinanti, le preposizioni e le posiposizioni e altri tipi di parole con significato prcttamcnte grammaticale. (Per questo
si veda la nota seguente).
29. In morfologia si distingue tra parole con contenuto Iessicale e parole con contenuto grammaticale, dette anche funzionali. Le parole lcssicali hanno un significato che fa
parte del lessico di una lingua. Le parole funzionali segnalano &oprattutto contenuti di tipo grammaticale, ossia interni al funzionamento del codice, o relazioni logiche all'interno della fra~c. Tipiche parole funzionali sono, ad esempio, gli articoli, i di
mostrativi, le congiunzioni.
30. Per la definizione di tipo flessivo si veda oltre 4.6.3.
UfUJ definizione globale di morfologia 73
ti fonologici che hanno modificato la parte finale delle parole del latino, provocando il dileguo di tutti i suffissi flessivi, le relazioni sintattiche all'interno dei sintagmi sono rese nelle lingue romanze moderne attraverso una serie di preposizioni che svolgono in vario modo la stessa funzione delle desinenze di caso e numero della lingua madre. Pertanto, ad un sintagma del latino, come quello esemplificato in (56), costituito da una testa nominale (liber) e un complemento di specificazione (puell-ae), rappresentato dal suffisso flessivo di caso genitivo e numero singolare (-ae), corrisponde in italiano un sintagma del tipo dato in (57), ossia con testa nominale (il libro) seguita da un sintagma preposizionale (della ragazza):
(56) liber puel/-1!!'_ (57) il libro della ragazza
Alla desinenza -ae in (56) corrisponde in (57) la preposizione articolata della, data dall'unione della preposizione di e l'articolo del femminile la.
Questo esempio mostra le diverse realizzazioni, rispettivamente morfologica e sintattica, di una stessa relazione sintagmatica, vale a dire la relazione tra un complemento e il sintagma nominale che lo regge. Nel percorso diacronico dal latino all'italiano, nella codifica delle relazioni di caso tra i nominali, il componente sintattico prevale su quello morfologico.
4.5.2.5.2. Un fenomeno di prevalenza della morfologia (FP) sulla sintassi
Benché non frequenti (per le ragioni che vedremo in 4.5.2.5.3.), si verificano pur tuttavia casi in cui nel conflitto tra il sottocomponente della FP e il componente della sintassi è il primo ad avere la meglio. Un esempio in proposito è dato dalla struttura argomentale dei composti verbali.
Si considerino i nomi composti dell'inglese e dell'italiano rispettiva
mente in (58) e (59):
(58) truck-driver 'guidatore di camion' lett. 'camion guidatore' music-lover 'amante della musica' lett. 'musica amante'
(59) accettazione reclami trasporto merci raccolta rifiuti
La struttura dei composti è la stessa in entrambe le lingue: si tratta di nomi composti aventi per basi due costituenti di cui l'uno è la testa, ossia la pa-
74 Lezione di m01fologia I
rola che determina il significato lessi cale e la categoria lcssicale (nome, verbo, ecc.) dell'intero composto, l'altro è il determinante o modificatore, ossia il costituente che specifica il contenuto semantico della testa; pertanto, in trnck-driver la testa è driver e il determinante è truck, laddove dalla testa deriva che un trnck-driver è un driver, mentre dal determinante consegue che si tratta di un particolare tipo di driver. Analogamente, in raccolta rifiuti la testa è raccolta c il determinante è rifiuti, e l'intero composto raccolta rifiuti indica un tipo particolare di raccolta. La sola differenza tra i composti dell'inglese c dell'italiano è la posizione della testa, che, in generale, per ciò che riguarda la composizione, è sempre 'a destra' in inglese e prevalentemente 'a sinistra' in italiano.
Si noti che la testa dei composti verbali esemplificati in (58) e (59) è sempre una parola complessa, più esattamente un nome derivato da un verbo mediante un suffisso derivazionale. In truck-driver, driver 'guidatore' dcriva morfologicamente dal verbo drive 'guidare' tramite l'aggiunta del suffisso -er, così come lover in music-lover deriva dal verbo love 'amare' con l'aggiunta dello stesso suffisso.
In italiano si ha un'analoga costruzione. In accettazione reclami, la testa accettazione è un nome derivato dall'unione della base verbale accett-a-re31
con il suffisso -zion-e. Anche trasporto merci c raccolta rifiuti sono composti verbali, va detto però che la testa in entrambi è un nome convertito e non derivato come accettazione. La base del nome trasporto è il verbo trmportare, la cui radice traspari- viene convertita semanticamente e categorialmente (si intende qui la categoria lessicale) in nome, secondo la tecnica morfologica della conversione illustrata in 1.1.3. Allo stesso modo, la base del nome raccolta è il verbo raccogliere, più propriamente la forma femminile del participio passato raccolto. Tanto tra:.porto e raccolta quanto accettazione sono dunque parole complesse, nomi deverbali costruiti rispettivamente tramite conversione e derivazione.
Nei composti verbali, sia dell'inglese sia dell'italiano, il costituente che
31. Analogamente a quanto già visto in 1.1.1. a proposito dctla parola complessa zuccheriera, la parola di base è presente nella struttura morfotattica della parola derivata in una particolare forma: nella fattispecie, il verbo di base accett-a-re è prcsen· te nel derivato accettazione come tema, o&sia radice accett- più vocale tematica -a. La scgmentazione morfematica di accettazione è pertanto la seguente: radice (accett·) +vocale tematica (-a-)+ suffisso derivazionale (-zion-) +suffisso flessionale (·e).
Una definizione globale di mmfologia 75
fa da determinante può essere considerato un argomento del costituente testa. Ciò significa che il nome che determina semanticamente la testa del composto ha la stessa funzione di un elemento che si troverebbe nella strut
tura 'esterna' o argomentale del nome testa. Esaminiamo ora alcuni esempi di struttura 'esterna' delle parole per ca
pire cosa si intende per argomento del nome testa. Ogni parola si caratterizza per una detenninata capacità di combinazione con altre parole: detto in altri termini, ogm parola si lega in un certo modo con altre parole per formare una struttura sintagmatica. Gli clementi - parole o sintagmi - che la
parola necessariamente richiede per formare strutture sintagmatiche corrette, sono dette argomenti. L'aggettivo sicuro, per esempio, può reggere un complemento introdotto dalla preposizione di, come esemplificato in (60):
(60) sicuro di se stesso
ma non può avere come complemento un sintagma preposizionalc introdotto dalla preposizione a, come dimostra la agrammaticalità della struttura in (61)
(61) *sicuro agli altri
Si dice pertanto che di se stesso può occupare grammaticalmente il ruolo di
argomento dell'aggettivo sicuro, mentre agli altri non può. Viceversa un aggettivo come utile può legarsi ad un complemento
espresso da un sintagma preposizionalc avente per testa la preposizione a,
come risulta da (62):
(62) utile agli altri
ma non può essere seguito da un sintagma introdotto dalla preposizione di, come è dimostrato dall'agrammaticalità della struttura in (63):
( 63) *utile di se stesso
Allo stesso modo, il verbo amare può avere come complemento un nome, come in (64):
( 64) amo mio figlio
ma non un sintagma preposizionale, come appare chiaro dall'agrammaticalità di (65):
76 Lezione di morfologia I
(65) 'amo a mio figlio
contrariamente, il verbo telefonare può reggere un sintagma preposizionale
(66), ma non un sintagma nominale (67):
(66) ho telefonato al mio amico
(67) *ho telefonato il mio amico
I nomi deverbali dei composti verbali dell'italiano in (59) si conformano es
senzialmente allo stesso tipo di restrizioni dei verbi da cui derivano: si clic;
pertanto che i nomi come accettazione, trasporto e raccolta ereditano la struttura argomentale dei rispettivi verbi di base, accettare, trasportare, raccogliere, sebbene i nomi, a differenza dei verbi, debbano sempre far precedere i propri sintagmi nominali in funzione di complemento dalla preposizione di. Ai sintagmi nominali retti dai verbi accettare, trasportare, raccogliere in (68)
(70) corrispondono sistematicamente i sintagmi preposizionali introdotti da di in (71)-(73):
(68) accetto i reclami
(69) ha trasportato le merci
(70) hanno raccolto i rifiuti
(71) l'accettazione dei reclami
(72) il trasporto delle merci
(73) la raccolta dei rifiuti
Da ciò risulta evidente che nei composti verbali elencati in (59), come del re
sto in ogni altro composto dello stesso tipo, il rapporto che lega la testa e il determinante è lo stesso che, nella corrispondente struttura sintagmatica, lega il nome testa al suo argomento, nella fattispecie il suo complemento, realizzato come sintagma preposizionale. Si dice pertanto che nel composto ver
bale accettazione reclami il costituente reclami in funzione di determinante
della testa accettazione soddisfa lo stesso ruolo argomentale che ha rispetto
allo stesso nome testa nella struttura sintagmatica l'accettazione dei reclami. Naturalmente come ogni altro nome anche il composto ha la sua strut
tura argomentale. Il punto cruciale è che la struttura argomentale dell'iute-
Una definizione globale di moifologia 77
ro composto accettazione reclami è la stessa della sua testa accettazione: in altri termini, il composto verbale eredita la struttura argomentale del suo costituente testa. Si ha dunque uno schema di questo tipo:
a) il verbo accettare ha una struttura esterna con due argomenti espres
si da due sintagmi nominali: 'X accetta Y':
(73) la ditta accetta i reclami
Jaddove la ditta rappresenta l'argomento X in funzione di soggetto e i recla
mi l'argomento Y in funzione di complemento b) il nome deverbale accettazione deriva la sua struttura argomentale
dal verbo, come risulta da (74) in cui il sintagma dei reclami corrisponde al
l'argomento Y con funzione di complemento e il sintagma da parte della dit
ta all'argomento X con funzione di soggetto:
(74) l'accettazione dei reclami da parte della ditta
c) infine, il nome composto accettazione reclami eredita la struttura ar
gomentale del nome testa accettazione, potendo pertanto esprimere gli stes
si argomenti, come è dato in (75)
(75) [l'accettazione reclami] da pane della ditta
laddove da pane della ditta è l'argomento dell'intero composto derivante direttamente dalla struttura argomentale della testa.
Si aggiunga che in questo tipo di composti è sempre la testa c mai il determinante ad assegnare la struttura argomentale all'intera parola comples
sa: gli argomenti del determinante non fanno parte della struttura argomentale del composto. Ad esempio, nel composto inglese destrnction story la ty;;;ta è story c il determinante è destrnction. Il determinante può avere degli
argomenti, come è dato dall'esempio in (76):
(76) destrnction of the city
Il suo argomento non può tuttavia diventare argomento del composto, co
me dimostra l'agrammaticalità di (77):
(77) *[destrnction story} of the city
La struttura sintagmatica in (77) è agrammatica\e perché il sintagma of the
city non può essere riferito a tutto il composto.
78 Lezione di morfologia I
I composti verbali mostrano come la struttura interna della parola complessa può determinare la struttura 'esterna'. Poiché la struttura esterna o argomentale delle parole appartiene allivello della sintassi, si verifica, !ad
dove essa sia condizionata dalla struttura interna, un fenomeno di prevalenza del componente morfologico - sottocomponente della FP - sul componente sintattico. Detto altrimenti, nei composti verbali, la capacità della pa
rola intera di costruire strutture sintattiche è condizionata dai due costituenti del composto, in particolare dalla testa, la cui struttura argomentale passa all'intero composto. Nei composti verbali le regole di combinazioiie
sintattiche del composto obbediscono alle restrizioni imposte dalla struttura morfologica dei costituenti. Il composto eredita la struttura argomentale della testa che a sua volta la eredita dal verbo da cui deriva. Il fatto che il no·
me testa di un composto verbale sia un derivato deverbale e non un nome semplice come, ad esempio, il nome capo nel composto capostazione, è la condizione che determina la struttura argomentale dell'intero composto. Si
potrebbe affermare che il campo d'azione della morfologia supera in questo
caso i confini della parola operando direttamente sulle strutture sintagmatiche, ovvero sui costituenti di rango superiore. La finalità di questa strategia
consiste nel rendere maggiormente 'leggibile', dunque più trasparente, la struttura interna della parola complessa. I monemi che la sintassi utilizza risultano in tal modo perfettamente motivati dal punto di vista morfologico e
la loro motivazione morfotattica e semantica si ripercuote sulla struttura sintattica. Non è questo un caso frequente nei conflitti che caratterizzano il rapporto tra morfologia e sintassi: infatti, il fenomeno interessa quella parte
della FP che è in più stretto contatto con la sintassi, ossia la composizione.
4.5.2.5.3. FP ed Fl rispetto alla sintassi
Dagli esempi in 4.5.2.5.1. e 4.5.2.5.2. appare chiaro che anche per quel che riguarda il rapporto tra componente sintattico e componente morfologico le
funzioni divergono, e con esse le strategie messe in opera. Va sottolineato tuttavia il diverso ruolo della FP e della Fl nei confronti della sintassi.
Dal punto di vista semiotico la sintassi soddisfa l'esigenza di creare mes
saggi comprensibili ed efficienti rispetto allo scopo primario del codice lingua, vale a dire la comunicazione. Poiché la comunicazione si realizza attra
verso enunciati la cui unità di base è tipicamente - anche se non unicamente - la frase, ai fini della comunicazione la frase è un segno dotato di maggiore salienza semiotica rispetto alla parola32• Di conseguenza, la struttura
Una definizione globale di moifologia 79
interna delle parole derivate o composte è essenzialmente irrilevante per il buon funzionamento delle regole sintattiche. Fenomeni come quello descritto in 4.5.2.5.2. non sono prototipici, ovvero non si verificano frequentemente nel contrasto tra FP e sintassi perché non sono naturali in base alla dinamica dei componcnti33 . In generale possiamo affcm1arc che la sintassi prevale sul sottocomponente della FP, dato che ricava le sue unità minime, le parole, direttamente dal lessico, non dalla morfologia, c le organizza secondo schemi di combinazione indipendentemente dal fatto che esse siano derivate, composte o convertite. Ciò che conta per la sintassi è la struttura 'esterna' (o argomentale) delle parole, non la loro struttura interna. Per la sintassi tutte le parole sono segni non scomponibili.
Diverso è il caso delle parole ±lesse. Se infatti ci riferiamo al sottocomponente della Fl, è evidente che la struttura interna delle parole è funzionale alla sintassi. In tal senso si può affermare che i mezzi morfologici potenziano le regole sin tattiche, soprattutto se si considerano quelle categorie grammaticali normalmente espresse dalla flessione, come, ad esempio, il caso, il numero, il modo o l'aspetto: tali categorie codificano tutta la rete dei contenuti obbligatoriamente espressi dalla grammatica di una lingua e in quanto tali articolano il componente sintattico. La flessione ha dunque il compito di organizzare significati interni al sistema, che diversamente sarebbero resi soltanto dalle regole combinatorie della sintassi.
4.5.2.5.4. Fl e sintassi
È dunque la Fl che condiziona la sintassi o viceversa? A tal riguardo sono d'obbligo due precisazioni.
32. L'analisi sintattica in costituenti non può dunque valere anche per la FP poiché la struttura delle parole complesse non è sempre e soltanto binaria come la struttura delle frasi. Nella FP ricorrono operazioni morfologichc (come ad esempio l'apofo-
è
re alla parola.
33. Sottolineiamo che qui, 'non naturali' sta per 'non prototipici', ma non per 'impossibili': dunque, pur essendo infrequenti, non sono da escludere. Per la teoria del funzionalismo dinamico è significativo che vi sia una tendenza verso la naturalezza dei fenomeni relativi a ciascun componente, la quale, proprio in quanto tendenza, non esclude fenomeni meno prototipici o meno naturali. La naturalezza è un fatto di gradualità non un requisito aut/aut.
80 Lezione di morfologia l
l) In primo luogo, la Fl convoglia attraverso mutamenti formali delle parole non solo significati grammaticali ma anche contenuti non privi di rilevanza semantica (ad esempio l'aspetto nel sistema verbale), dunque non del tutto diversi dai significati espressi dalle regole di FP, rispetto alle quali la differenza fondamentale sarebbe l'obbligatorietà: con ciò si ribadisce la funzione comune dei due sottocornponenti morfologici, ossia, come sappiamo, la motivazione semantica e formale delle parole, la quale rende peculiare la morfologia rispetto alla sintassi.
2) In secondo luogo, la Fl, pur contribuendo a esprimere relazioni sintatt+che, è autonoma rispetto alla sintassi, in quanto articola i suoi significati, ovvero le categorie grammaticali, e all'interno di queste, le opzioni, indipendentemente dalle regole di buona formazione della sintassi: l'organizzazione del sistema flessivo in classi flessionali non è determinata dal contesto sintattico. Valga al tal proposito l'esempio delle classi nominali del latino. a) Che le classi di flessione nominale del latino siano cinque piuttosto
che due o dieci è una conseguenza dell'autonomia di espressione del sottocomponentc della Fl.
b) Il sistema flessionalc del nome in latino esprime le categorie di caso, numero e genere, ma solo il caso riflette, attraverso modificazioni formali, le relazioni tra parole all'interno dci sintagmi c della frase; numero e genere, invece, sono contenuti grammaticali indipendenti dal
la dinamica della sintassi. c) Il numero delle classi flcssionali34c il numero delle opzioni all'interno
di ciascuna catcgoria35 non è prcdeterminato dalle relazioni dci costituenti all'interno dci sintagmi.
Non si ha dunque né una predominanza della sintassi sulla flessione né della flessione sulla sintassi. Si ha piuttosto una funzione di potenziamento delle regole della sintassi da parte della Fl, oltre che un'autonomia di organizzazione di quest'ultima: ciò depone a favore oltre che della peculiarità anche dell'autonomia dell'intero componente morfologico. Se la frase è un se-
34. Ad esempio, in italiano, la da~se dei nomi di genere maschile o neutro con vocale tematica -o- e la classe dci nomi femminili in -a-.
35. Per la categoria del genere, ad esempio, le tre opzioni ricorrenti in molte lingue sono maschile, femminile e neutro.
Una definizione globale di morfologia 81
gno semioticamente più forte della parola, la parola flessa contribuisce al funzionamento della sintassi.
4.5.2.5.5. Fenomeni di prevalenza della Fl sulla sintassi
Nonostante l'autonomia reciproca di Fl e sintassi e, al tempo stesso, la sinergia che entrambe mostrano nello strutturare sintagmi e frasi, numerosi sono i fenomeni di prevalenza della sintassi sulla FI, (come esemplificato 4.5.2.5.1. a proposito delle preposizioni) e altrettanto numerosi quelli in cui la Fl si sostituisce a costruzioni sintattiche.
4.5.2.5.5.1. Forme analitiche e fonne sintetiche
Si ha un chiaro esempio di alternanza tra costruzioni sintattiche e suffissi flessionali nei paradigmi verbali di lingue che fanno uso rispettivamente di forme analitiche e di forme sintetiche per esprimere spesso le stesse categorie grammaticali. Si considerino i seguenti esempi dell'inglese, in cui a. rappresenta la codifica perifrastica e b. la codifica morfologica:
(78) a. I have waited (aspetto perfettivo) 'ho aspettato' b. I waited (tempo passato) 'aspettai'
(79) a. the sounds of the engines (possessive) 'il rumore dei motori' b. the receptionist's smile (possessive) 'il sorriso del receptionist'
(80) a. more interesting 'più interessante' b. longer 'più lungo'
Le categorie di tempo e aspetto sono espresse perifrasticamente in (78a. ), tramite il suffisso flessivo -ed in (78b.). In (79a) il possessivo è espresso dalla preposizione of, in (79b) dal suffisso -s. Il comparativo è reso analitica.w.ente, cioè attraverso una struttura sintagmatica, in (80a. ), sinteticamente, cioè attraverso il suffisso -er, in (80b.).
4.5.2.5.5.2. La categoria della definitezza
Nello sviluppo diacronico molto spesso gli elementi di costruzioni perifrastiche tendono a fondersi e a dar vita a morfemi flessivi. In molte lingue europee, ad esempio, i nomi definiti sono marcati da un articolo, ovvero da una parola funzionale separata dal nome, come appare in (81):
(81) a. ing. !M_ newspaper 'il giornale' b. it. la casa
82 Lezione di morfologia l
c. fr. la rue 'la strada' d. ted. die Stadt 'la città'
In queste lingue la categoria della definitezza è dunque espressa sintattica~ mente come si può vedere in (82), dove è dato solo un esempio per l'inglese:
(82) the five yellows newspapers 'i cinque giornali gialli'
Vi sono d'altra parte lingue in cui la categoria della definitezza è espressa tramite un morfema legato al nome, il quale, in molti casi deriva diacronicamente da un precedente articolo o dimostrativo. Così in istro-rumeno il dimostrativo ille 'quello' del latino si presenta come un suffisso nominale indicante definitezza e caso, di cui un esempio è dato in (83):
(83) gospodar-i-lor 'dei capi'
In (83), al nome gospodar seguono il suffisso di numero plurale -i- e il suffisso di definitezza e caso genitivo -lor. Quest'ultimo deriva dal genitivo maschile illorum del dimostrativo latino ille.
I dati in (81)-(83) mostrano come la stessa categoria grammaticale possa essere espressa sintagmaticamente o morfologicamente sia all'interno di una stessa lingua in sincronia, sia nel corso dell'evoluzione diacronica. Va detto inoltre che la tendenza generale delle lingue a sviluppare morfemi flessivi a partire da costruzioni perifrastiche è molto frequente e si inquadra nella più vasta e generale tendenza a formare nuovi elementi flessivi nei processi di grammaticalizzazione36 che interessano la dinamica sincronica e diacronica di tutte le lingue.
4.5.2.5.6. I tipi linguistici e la Fl
In defmitiva, in un'ottica funzionalista, i componenti sono separati gli uni dagli altri per quanto riguarda la selezione delle forme e dei significati, le esigenze specifiche da soddisfare e le strategie messe in atto a tale scopo; so-
36. La grammaticalizzazione è quel processo in cui una forma lessicale o una costruzione perifrastica finisce per esprimere in determinati contesti specifiche funzioni grammaticali e via via, tramite un graduale sviluppo in senso grammaticale tanto nel significante quanto nel significato, acquista la forma e il contenuto di un morfema flessionale. Tale processo può verificarsi sia in sincronia sia in diacronia.
Una definizione globale di moifnlogia 83
no tuttavia semiautonomi se si considera la tendenza generale della grammatica a risolvere i contrasti tra i componenti attraverso una gerarchia di priorità.
Esiste tuttavia un altro filtro oltre alla rilevanza semiotica, che agisce nel mediare tra fini e strategie. A tal proposito va segnalato un aspetto della teoria del funzionalismo cui abbiamo fatto poc'anzi riferimento e che riprenderemo nel paragrafo 4.6.3.: vale a dire, il ruolo dei diversi tipi linguistici nell'assegnare di volta in volta ai vari componenti della grammatica la prevalenza nella tensione verso l'equilibrio conflittuale e dinamico. In quest'ottica, lingue di tipo isolante si differenziano da lingue di tipo flessivo, poiché mostrano la tendenza a segnalare i significati attraverso disposizioni delle parole piuttosto che attraverso variazioni dei loro significanti, in breve attraverso la sintassi. Viceversa, lingue di tipo flessivo affidano ai sistemi morfologici il compito di selezionare quelle categorie di contenuti che vanno espressi obbligatoriamente dal codice attraverso covariazioni sistematiche nella forma e nel significato delle parole.
4.5.2.6. L'equilibrio della grammatica e la diacronia delle lingue
Vi è una conseguenza importante derivante dall'impostazione semiotica e funzionalista fin qui illustrata attraverso più di un esempio. Se si assume il modello teorico della dinamica dei componenti è anche possibile spiegare le cause ultime del mutamento diacronico delle lingue, che generalmente sono considerate imponderabili. Il perché le lingue si differenzino nel tempo, e non solo in sincronia, è considerato il punto terminale e inattingibile delle possibilità esplicative di qualsiasi approccio teorico. Si sostiene infatti che i cambiamenti delle lingue attraverso l'evoluzione diacronica possano essere solo descritti, ma non spiegati in ultima analisi. Dalla prospettiva qui adottata appare chiaro invece che il cambiamento diacronico è condizionato dal costante riassestamento dell'equilibrio dei componenti della grammatica, il quale a sua volta è insieme l'effetto e la causa dell'adesione della lingua ad un tipo piuttosto che a un altro.
4.5.2. 7. Sintesi
Nei paragrafi della sezione 4.5.2. abbiamo fatto riferimento ad un modello teorico di tipo funzionalista secondo il quale la struttura e il funzionamento del componente morfologico si inquadrano in una dinamica complessiva che investe tutti i livelli del codice lingua. Il nucleo concettuale di tale mo-
84 Lezione di moifologia I
dello è l'equilibrio conflittuale e dinamico che regola i rapporti tra i vari componenti. In particolare, ci siamo soffcrmati su alcuni esempi che illustrano bene la tendenza generale della grammatica a risolvere i conflitti attraverso una gerarchia o priorità semiotica. Poiché si tratta di una tendenza
e non di un universale assoluto, abbiamo illustrato anche dci casi che con
traddicono tale tendenza. Complessivamente riteniamo che il modello del funzionalismo dinami
co ci permetta di spiegare perché le lingue, all'interno della dinamica dei lo
ro componenti, diano maggior peso all'una o all'altra finalità. Le modalitll
di organizzazione del livello morfologico si rivelano utili in moltissimi casi;
i meccanismi morfologici possono tuttavia essere sostituiti, quand'anche non in larga misura, dalle modalità di organizzazione del livello sintattico, laddove questo prevalga nel contrasto delle funzioni. Perché le lingue differiscano nel dare maggiore rilevanza agli scopi dell'uno o dell'altro compo
nente è spiegabile tramite l'adesione ad un approccio teorico che vede agire nella grammatica spinte continue e conflittuali in costante modifica e tendenti all'equilibrio dinamico del codice.
4.6. Che cosa è la morfologia?
Nei paragrafi 4.4. e 4.5.1 .2. abbiamo posto degli interrogativi che ripetiamo
qui di seguito per comodità.
l) Che cos'è la morfologia? 2) Esiste un dominio autonomo della morfologia tale che gli studi di mor
fologia abbiano una loro specificità e legittimità? 3) La nozione di morfema è necessaria perché si delimiti il campo di inda
gine della morfologia e, ancor prima, si identifichi la natura del componente morfologico? E se sì, la definizione di morfema va adeguatamente modificata?
4) Perché, nonostante il vantaggio derivante dall'articolazione delle parole in morfemi, esistono lingue quasi o del tutto prive di morfologia?
5) Perché i sistemi morfologici differiscono profondamente da lingua a lin-gua in quanto a grado di complessità?
6) È ragionevole sostenere, come fanno autorevoli linguisti, che una mor
fologia particolarmente ricca sia solo un 'malattia delle lingue', un di più o un lusso?
Motto e invio
So ali their praises are but prophecies
Of this our time, ali you prefiguring; An<!, for they look' d but with divining eyes, They had no skill enough your worth to sing; Por, we which now behold these present days, Have eyes to wonder, but Jack tongues to praise.
(W. Shakespear, Sonnets, When in the chronicle of wasted time)