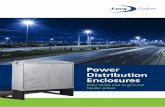Letteratura, folklore e immaginario musicale in «The New Mother» di Lucy Clifford
Transcript of Letteratura, folklore e immaginario musicale in «The New Mother» di Lucy Clifford
Il LiutoRivista della Società del Liuto
Numero 9, novembre 2014ISSN 2280-9392
1
Indice
Note di segreteriap. 2
Il concerto della European Lute Orchestra a Bologna
p. 3
Una partita di Filippo Sauli, tiorbista e mandolinista alla corte degli Asburgo
di Davide Rebuffap. 11
I brani di Thomas Mace (IV) in Flat Tuning, tradotti nell’accordatura in Re minore, secondo
la procedura descritta nel suo stesso librodi Peter Steur
p. 25
La Battaglia per liuto (IX)di Gian Luca Lastraioli
p. 51
«It really is a most beautiful thing, is a peardrum»: letteratura, folklore e immaginario
musicale in «The New Mother» di Lucy Clifford
di Alessandro Grillip. 57
Il Liuto nell’Arte (a cura di Rita Comanducci)Masaccio e l’invenzione del liuto prospettico
di Stefano G. Casu p. 67
Società del LiutoSede legale:
Via Aleardi 64, 30172 Venezia Mestre (VE)
Presidente - Alessandro GrilliVicepresidente - Gian Luca Lastraioli
Segretario e Tesoriere - Matteo SimoneConsiglieri - Franco Fois, Leonardo Pallotta
Comitato di Redazione della Rivista Rita Comanducci, Giorgio Ferraris,
Franco Fois, Alessandro GrilliGian Luca Lastraioli, Bob Van de Kerckhove
progetto grafico -Tim Watson
bbbwww.societadelliuto.it
bbbSegreteria e iscrizioni presso:
Matteo Simone, via Aleardi 64,30172 Venezia Mestre
telefono 041 2003706
(dalle 19,30 alle 20,30 dei giorni feriali)
Societa del liuto Revista 9 stampa/2014 .indd 1 11/12/14 09:18
fifl032 0
543
fifl5435
2 03
Ó‡533
5
4
5
4
fifl5435
150
Ä
Ó‡0225 3 2 0
Ó‡032
Ó·
03
Ó‡320
0
Ó‡543
3
fifl5553
Ó‡033
Ó·2 0 3 2
Ó‚3 2 0 2
Ç
fifl0033
Ó‡3032 4
Ó‡
53 2 0
fifl25
Ó‡03 2 0
fifl32
fifl53
0320 2
fifl03320
43
Ó‡21 0
2
fifl00
160fifl20420
Ó‡0020 2
fifl32
Ó‡322 3 0 2 3
Ó‡20 2 4
fifl35
Ó‡05 4 2
fifl204
fifl4
5
53 3
fifl102200
Ó‡543 0 1 3
fifl000
Ó‡0230 2 3
fifl0232
fifl20302020
170fifl023200232
fifl2003
Ó‡0 2
0 2
Ó‡0233 2 0
fifl0232
fifl0033
Ó‡3032 4
fifl0
05
Ó‡0 2
0 2
fifl0
32
05433
Ó‡0303 2 0
fifl0320
fifl2003
Ó‡0 2
0 2
Ó·0233 2 0
Ó‡3
Ó·2 0
fifl0232 ∏
0033
fifl032 0
543
fifl5435
2 03
Ó‡533
5
4
5
4
fifl5435
150
Ä
Ó‡0225 3 2 0
Ó‡032
Ó·
03
Ó‡320
0
Ó‡543
3
fifl5553
Ó‡033
Ó·2 0 3 2
Ó‚3 2 0 2
Ç
fifl0033
Ó‡3032 4
Ó‡
53 2 0
fifl25
Ó‡03 2 0
fifl32
fifl53
0320 2
fifl03320
43
Ó‡21 0
2
fifl00
160fifl20420
Ó‡0020 2
fifl32
Ó‡322 3 0 2 3
Ó‡20 2 4
fifl35
Ó‡05 4 2
fifl204
fifl4
5
53 3
fifl102200
Ó‡543 0 1 3
fifl000
Ó‡0230 2 3
fifl0232
fifl20302020
170fifl023200232
fifl2003
Ó‡0 2
0 2
Ó‡0233 2 0
fifl0232
fifl0033
Ó‡3032 4
fifl0
05
Ó‡0 2
0 2
fifl0
32
05433
Ó‡0303 2 0
fifl0320
fifl2003
Ó‡0 2
0 2
Ó·0233 2 0
Ó‡3
Ó·2 0
fifl0232 ∏
0033
57
L’analisi iconografica del liuto nell’arte è tradizionalmente uno dei canali privilegiati per la conoscenza tecnica dello strumento, soprattutto per le fasi precoci della sua storia, quando le raffigurazioni possono in parte contibuire a compensare la mancanza di documenti organologici diretti. Naturalmente l’assunto alla base di questo approccio è che le riproduzioni siano non solo realistiche, ma anche tecnicamente molto precise. Cosa di cui, ovviamente, si possono avere solo conferme indirette e per periodi relativamente tardivi.
In questo lavoro vorrei però mostrare come anche le illustrazioni imprecise, o addirittura i fraintendimenti grossolani relativamente all’immagine del liuto e degli strumenti congeneri, possano rivelarsi canali d’accesso privilegiati per la conoscenza musicale – una conoscenza certo non rivolta alla forma e alla struttura del liuto, ma a quella dell’immaginario musicale di cui comunque la sua presenza nell’arte è testimonianza.
Il mio discorso prende spunto da una illustrazione di un libro per l’infanzia dell’Inghilterra vittoriana (Fig. 1), una raccolta di racconti del 1882 dal titolo
«It really is a most beautiful thing, is a peardrum»: letteratura, folklore e immaginario musicale in The New Mother di Lucy Clifforddi Alessandro Grilli
Fig. 1. D. Tennant, «It really is a most beautiful thing, is a peardrum», illustrazione per L. Clifford, The New Mother in Ead., Anyhow Stories, Moral and Otherwise, London, MacMillan 1882, p. 16
Societa del liuto Revista 9 stampa/2014 .indd 57 11/12/14 09:20
58
Anyhow Stories. Moral and Otherwise.1 Si tratta di una raccolta «ostensibly, but not exclusively for children»,2 come una nota liminare alla seconda edizione si premura di esplicitare.3 L’autrice, Lucy Clifford (Sophia Lucy Jane Clifford, detta anche Lucy Lane Clifford, 1846-1929), benché quasi completamente dimenticata fino a pochi anni fa, ebbe di fatto un certo rilievo nel panorama letterario vittoriano.4 Scrittori e intellettuali di spicco, tra cui Henry James, furono suoi amici e intrattennero con lei una corrispondenza piuttosto regolare.5 La fama di Lucy Clifford, autrice di numerosi romanzi e raccolte di racconti, è oggi peraltro associata in primo luogo proprio al racconto cui la nostra illustrazione si riferisce, una storia perturbante dal titolo The New Mother, che finì ben presto per essere inclusa in un canone di letteratura per l’infanzia rappresentato da numerose scelte antologiche di racconti inglesi o internazionali.6
Il rimando al testo è esplicito nella didascalia dell’illustrazione, che riproduce una battuta del dialogo in corso e fornisce l’indicazione della pagina. L’incisione è opera di un’artista londinese, Dorothy Tennant, che all’epoca della pubblicazione del libro aveva 27 anni. Di estrazione borghese, nata e vissuta nel quartiere londinese di Bloomsbury, Tennant aveva ricevuto la sua educazione artistica a Londra e a Parigi, ma, più che dalla sua attività di pittrice, illustratrice e scrittrice, la sua fama era destinata a dipendere (fato non atipico per una donna della borghesia vittoriana) dalle imprese del suo primo marito, il celebre esploratore dell’Africa Henry Stanley, da lei sposato nel 1890.7
L’immagine rappresenta un incontro su una strada di campagna: una casetta nell’angolo superiore sinistro corona una metà dello spazio, che lo sfondo lascia intravvedere come un campo aperto; in opposizione ad esso, il lato destro allude
invece a una foresta, delimitata da un muretto in parte fatiscente. L’incontro ha per protagoniste due bambine in lindi abitini domestici e una ragazza di qualche anno più grande, raffigurata in una posa che le convenzioni iconografiche associano all’afflizione o alla pensosità, anche se con i chiari segni di un sorriso sulle labbra (si noti il tratteggio chiaroscurale agli angoli della bocca). Il contrasto fra posa ed espressione è un dato saliente, in quanto emerge con chiarezza, come vedremo, dal testo illustrato. A differenza delle bambine, la ragazza non indossa una cuffia, ma ha solo un foulard intorno al collo (che forse in precedenza le aveva coperto il capo), e le spalle coperte da uno scialle. La qualità dei vestiti sembra piuttosto neutra, ma in corrispondenza del ginocchio destro della ragazza è rappresentata una toppa nella stoffa: a significare il livello complessivamente povero e trascurato del suo abbigliamento. Accanto alla ragazza, poggiato su un lato del mucchio di pietre su cui è seduta, uno strumento musicale. Uno strano strumento musicale, che merita senz’altro un tentativo di commento non solo iconografico.
A giudicare dalla forma, si tratta di un piccolo cordofono assimilabile al liuto. La particolare forma del manico, e l’aggancio continuo alla cassa, portano peraltro a escludere che si tratti di un liuto o di un mandolino; piuttosto, questo particolare strutturale sembra suggerire una citola, ma con un ampio margine di dubbio. La prospettiva della rappresentazione, infatti, non permette di stabilire se la cassa armonica è piatta, come dovrebbe essere in una citola, o se invece è panciuta, come nelle varietà del liuto e del mandolino. Il numero di corde, tre, è a sua volta problematico, perché esso è sì compatibile con le varietà più antiche e più elementari della citola, ma non con quella più comune: questo strumento è infatti munito solitamente di quattro
1 Mrs. W. K. ClifforD, Anyhow Stories. Moral and Otherwise, London, MacMillan, 1882.2 P. Demers, Toys and Terrors: Lucy Clifford’s Anyhow Stories, in D. Denisoff (ed.), The Nineteenth-Century Child and Consumer Culture, Aldershot, Ashgate, 2008, pp. 189-200; la citazione è a p. 191.3 London, MacMillan, 1885, s.n.p.: «These stories were not written for very little children, but for those of middling size; and for the big folk who are not above reading about the little folk».4 La sola biografia sistematica della scrittrice segue in realtà le vicende anche del coniuge, il matematico e filosofo William Kingdon Clifford (1845-1879): M. Chisholm, Such Silver Currents - The Story of William and Lucy Clifford, 1845-1929, Cambridge, Lutterworth Press, 2002.5 M. Demoor e M. Chisholm, Bravest of Women and Finest of Friends: Henry James’s Letters to Lucy Clifford, Victoria, Canada, University of Victoria Press, 1999.6 Ad esempio, per citare solo le principali, in P. Demers (ed.), A Garland from the Golden Age: An Anthology of Children’s
Literature from 1850 to 1900, Toronto, Oxford University Press, 1983; A. Moss e J. C. Stott, The Family of Stories: An Anthology of Children’s Literature, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1986; A. Lurie (ed), The Oxford Book of Modern Fairy Tales, Oxford, Oxford University Press, 1993; J. Mark (ed.), The Oxford Book of Children’s Stories, Oxford, Oxford University Press, 2001; D. Sandner, J. Weisman e P. S. Beagle (eds), The Treasury of the Fantastic: Romanticism to Early Twentieth Century Literature, Berkeley, Frog, 2001; J. Zipes et alii (eds.), The Norton Anthology of Children’s Literature, New York, Norton, 2005; A. Garner (ed.), Collected Folk-Tales, London, HarperCollins Children’s, 2011. La sola traduzione italiana, che non sono purtroppo riuscito a consultare, è appunto in una antologia della letteratura fantastica: D. G. Hartwell (a cura di), Il colore del male. I capolavori dei maestri dell’horror, Milano, Armenia, 1989 (più volte ristampato), pp. 49-57.7 Del marito Tennant avrebbe tra l’altro curato anche l’autobiografia: D. Stanley (ed.), The Autobiography of Sir Henry
Societa del liuto Revista 9 stampa/2014 .indd 58 11/12/14 09:20
59
corde doppie, che implicherebbero quindi la presenza di otto piroli nella paletta. Qui, invece, i piroli sono solo due, entrambi su uno stesso lato. Non si può decidere, senza indicazioni esterne, se il pirolo mancante si trova sul lato non visibile del manico o se si tratta semplicemente di un’omissione non realistica. Altri due elementi, infine, forniscono motivo di perplessità: il primo è un piccolo oggetto, a forma di maniglia, che sporge dal lato inferiore del manico, a circa un terzo della sua lunghezza. Il secondo è un piccolo solido a forma di parallelepipedo che sembra semplicemente giustapposto allo strumento, in una posizione più o meno vicina al punto di attaccatura del manico con la cassa. In che modo questo parallelepipedo sia congiunto alla cassa, e in che misura il lato di contatto sia sagomato sul profilo della cassa, non è inferibile con chiarezza dall’immagine.
Mi sembra evidente, a questo punto, che la semplice lettura della figura non ci permette di farci un’idea precisa dello strumento rappresentato. Se vogliamo capire meglio che cosa abbiamo davanti non possiamo fare a meno di cercare indizi nel testo cui l’illustrazione si riferisce.
Come abbiamo detto, The New Mother è oggi senz’altro il racconto più noto di Lucy Clifford, quello cui sembra affidata più che a ogni altro suo testo la recente riscoperta dell’autrice. Il punto di svolta per questa rinascita è costituito sicuramente da alcune ammissioni del popolare scrittore fantasy Neil Gaiman, che a proposito di Coraline,8 un suo fortunato romanzo per ragazzi poi oggetto di una bella trasposizione cinematografica firmata da Henry Selick (2009),9 sostiene di aver ricavato proprio da The New Mother l’ispirazione per il tema del doppio materno demoniaco.10 L’atmosfera del racconto è infatti dominata dalla sinistra figura della «new mother», un mostro con occhi di vetro
e coda di legno che finisce per sostituire la madre delle due bambine come spaventosa punizione per il loro comportamento, diventato gradualmente del tutto incontrollabile. Nella situazione iniziale, invece, le bambine sono le due figlie giudiziose e ubbidienti di un padre marinaio sempre in viaggio lontano e di una mamma amorevole che vive con loro e con il terzo figlio neonato in una piccola casa fuori dal villaggio, ai margini della foresta. Mandate a prendere la posta all’villaggio, le bambine incontrano una strana ragazza dall’aspetto povero e triste, seduta su un mucchio di sassi, che mostra loro uno strumento musicale, sostenendo che nella piccola scatola attaccata da una parte ci sono un omino e una donnina che, quando lo strumento suona, si mettono a danzare con movenze aggraziate. Prese dalla frenesia di vedere i due piccoli danzatori, le bambine scoprono che la cosa è possibile solo all’insolita condizione di essere molto, molto cattive: come specifica la ragazza, «I only show them to naughty children» (p. 17). Il desiderio di vedere i due omini cresce, e la sua ripetuta frustrazione, a motivo dell’insufficiente ‘cattiveria’, determina un’escalation di intemperanza delle due bambine; quando poi il loro comportamento in casa sarà così scalmanato da mettere a repentaglio la vita familiare, si realizza la minaccia prospettata inizialmente dalla madre: le bambine vengono lasciate sole, e al posto della madre si presenta una «new mother» mostruosa, che entra in casa spaccando la porta con la coda di legno e di cui le bambine, fuggite nel bosco, continuano a vedere gli sfavillanti occhi di vetro oltre le finestre (p. 47).
L’interpretazione letteraria del racconto apre squarci di notevole interesse, ma non possiamo darle spazio in questa sede.11 Ciò che qui ci interessa maggiormente è la presentazione dell’insolito strumento musicale. La ragazzina lo tiene
Morton Stanley, London, Sampson Low, Marston & Co. 1909. 8 N. Gaiman, Coraline, New York, HarperCollins, 2002.9 La scheda del film con tutti i riferimenti in http://www.imdb.com/title/tt0327597/?ref_=fn_al_tt_1 (ultimo accesso 07-10-14).10 In interviste con la stampa canadese (cfr. Ch. Buckley, Neil Gaiman’s ‘New Mother’ 1882–2002: How Coraline ‘Translates’ Victorian Fantasy, «Peer English», V, 2010, 36-46, qui p. 36). Sul rapporto di Coraline con i suoi archetipi gotici vd. K. Coats, Neil Gaiman and the Psychic Work of the Gothic, in A. Jackson, R. McGillis, K. Coats, The Gothic in Children’s Literature: Haunting the Borders, London, Routledge, 2013, pp. 77-92.11 Tra i non molti studi sul testo di L. Clifford si vedano almeno A. Moss, Mothers, Monsters, and Morals in Victorian Fairytales, «The Lion and the Unicorn», XII, 1988, pp. 47–60; A. Krugovoy-Silver, The Didactic Carnivalesque in Lucy Lane Clifford‘s The New Mother, «Studies in English Literature, 1500–1900», XL, 2000, pp. 727-743; S. Walsh, Gothic Children, in C. Spooner e E. McEvoy (eds.), The Routledge Companion to Gothic,
London, Routledge, 2007, pp. 183-191; E. Thiel, The Fantasy of Family: Nineteenth-Century Children’s Literature and the Myth of the Domestic Ideal, London, Routledge, 2008, pp. 78 sgg.; sulle valenze simboliche del «peardrum» vd. N. J. Wood “The New Mother”: Domestic Inversions, Terror, and Children’s Literature, «The Journal of Narrative Technique», XXVI, 1996, pp. 292-309, in particolare pp. 298-299.
Societa del liuto Revista 9 stampa/2014 .indd 59 11/12/14 09:20
60
inizialmente nascosto sotto lo scialle («hidden away under her shawl», p. 13), e le due bambine lo scambiano inizialmente per un neonato, tranne poi escludere questa ipotesi quando la ragazza poggia l’oggetto in terra e ci si siede sopra. L’illustrazione in questo caso non è fedele al testo, e rappresenta invece lo strumento a fianco del mucchio di pietre, per l’ovvia ragione che altrimenti esso non sarebbe pienamente visibile. Il testo, per nostra fortuna, ne fornisce una descrizione molto precisa (pp. 14-15):
“What are you sitting on?” she asked. “On a peardrum,” the girl answered, still speaking in a most cheerful voice, at which the children wondered, for she looked very cold and uncomfortable. “What is a peardrum?” they asked. “I am surprised at your not knowing,” the girl answered. “Most people in good society have one.” And then she pulled it out and showed it to them. It was a curious instrument, a good deal like a guitar in shape; it had three strings, but only two pegs by which to tune them. The third string was never tuned at all, and thus added to the singular effect produced by the village girl’s music. And yet, oddly, the peardrum was not played by touching its strings, but by turning a little handle cunningly hidden on one side. But the strange thing about the peardrum was not the music it made, or the strings, or the handle, but a little square box attached to one side. The box had a little flat lid that appeared to open by a spring. That was all the children could make out at first.
Confrontata con l’immagine, questa descrizione mette in evidenza una serie di problemi: in primo luogo, la figura dello strumento rappresentato nell’illustrazione non è affatto «like a guitar in shape». Tennant opta per una resa diversa, con la sagoma a forma di pera – cosa che in effetti è attestata per buona parte delle citole più antiche. Ma il testo è inequivocabile nel suggerire la forma di una chitarra, e pertanto il nome «peardrum» non può essere spiegato in questo modo. Il resto della descrizione, infatti, sembra alludere a uno strumento con la cassa a otto come il dulcimer,12 ma rimanda secondo me con la massima probabilità a una ghironda (fr. vielle à roue; ingl. hurdy-gurdy), uno strumento di origine medievale attestato fin dal X secolo. La ghironda è particolarmente
diffusa in Francia, ma risulta acclimatata in tutta Europa – compresa l’Inghilterra vittoriana – come strumento popolare. È di questo strumento che il testo descrive (non senza lacune e imprecisioni) il funzionamento di base: si tratta di un cordofono in cui il suono viene prodotto dallo sfregamento delle corde per mezzo di una ruota circolare ad esse perpendicolare, che viene appunto azionata da una manovella.13 Nella ghironda la ruota è coperta normalmente da una fascia, e questo spiega perché a un osservatore esterno il suono dello strumento appaia semplicemente come prodotto dal girare della manovella – e soprattutto come qui il testo possa parlare soltanto di una «little handle cunningly hidden on one side» senza alcuna menzione della ruota. La differenza di funzione tra le corde, invece, rivela sicuramente una mancanza di competenze organologiche da parte della scrittrice: l’incordatura della ghironda, in effetti, distingue nettamente la corda o le corde di bordone, che producono un suono fisso, dalla corda della melodia, la quale è manipolabile tramite un sistema di tasti che, premendola e accorciandola in punti diversi, le consentono di emettere suoni di altezze diverse. In pratica, il suonatore di ghironda gira la manovella con la mano destra, mentre la sinistra preme l’uno o l’altro dei tasti della piccola tastiera, realizzando così la melodia sulla corda di cantino. Il fatto che il suono di questa terza corda sia alterabile mediante tasti, tuttavia, non significa che essa non abbia un pirolo come le corde di bordone.
I dettagli organologici che ho ritenuto necessario esplicitare consentono di formulare alcune ipotesi sull’orizzonte di riferimento rispettivamente dell’artista e della scrittrice. Mi sembra infatti evidente che l’illustratrice parte dal testo senza capirlo: il nome «peardrum» evidentemente non le evoca alcun oggetto già visto, e anche la descrizione di un hurdy-gurdy, inequivocabile nonostante la denominazione diversa e l’aggiunta della scatolina fatata, non è sufficiente a farle individuare un oggetto preciso tra quelli di cui ha esperienza. Di conseguenza la giovane artista non visualizza alcun oggetto, e affida la sua immaginazione esclusivamente alle due parole chiave, «peardrum» e «guitar». Chiaramente, la chitarra è un oggetto fin troppo familiare, mentre l’altra parola è, come vedremo, molto oscura. Ma non oscura abbastanza da non suggerire l’idea, corroborata da univoche attestazioni di un simile uso figurato di «pear» (Oxford English Dictionary, s.v. 7a: «Something shaped like a pear»; gli esempi addotti riguardano
12 Ringrazio Franco Fois per questo suggerimento.13 DemerS, Toys and Terrors, cit., p. 195 dà una descrizione imprecisa ma tendenzialmente giusta dello strumento come «a lute- or balalaika-shaped stringed instrument, played like a hurdy-gurdy “by turning a little handle cunningly hidden
on one side”(15)». Naturalmente né liuto né balalaika hanno niente a che vedere con la forma a chitarra.
Societa del liuto Revista 9 stampa/2014 .indd 60 11/12/14 09:20
61
elementi vegetali, gioielli e motivi decorativi.), di una chitarra a forma di pera. Questi due elementi mi sembrano aver determinato le scelte dell’illustratrice, che ha optato per una resa del «peardrum» come una chitarra dalla cassa a pera – quindi casualmente simile a un liuto o a una citola medievale, ma senza alcun richiamo intenzionale, di fatto, a strumenti di questa famiglia. La fondatezza della mia ipotesi mi sembra provata dalla collocazione della manovella, che l’artista inserisce a un terzo del manico, in una posizione totalmente incongrua rispetto a qualsiasi dinamica di produzione del suono. Non solo: la mancata menzione nel testo di una ruota azionata dalla manovella fa sì che nell’illustrazione manchino totalmente non solo le tracce di una ruota, ma anche lo spazio per una sua possibile presenza nascosta (lo strumento ha infatti una cassa armonica piatta e mantiene le corde interamente scoperte). Lo strumento raffigurato nell’immagine qui sopra, insomma, non solo non esiste, ma non è nemmeno lo stesso strumento immaginario di cui parla il testo oggetto dell’illustrazione.
Resta da chiarire il particolare della scatolina: la collocazione nell’immagine è anch’essa del tutto implausibile, al punto che vedendo solo la figura ci si può chiedere se quel parallelepipedo scuro sia di pertinenza dello strumento oppure no, mentre il testo parla chiaramente di una «little square box attached to one side» che «had a little flat lid that appeared to open by a spring» (p. 15, corsivo mio). Se si torna col pensiero alla ghironda, si osserva che nella stragrande maggioranza dei casi i tasti della ghironda sono chiusi in una piccola scatola di legno, posizionata sopra la cassa armonica in posizione leggermente eccentrica verso il manico. Il coperchio di questa cassa è normalmente apribile e permette l’ispezione del vano interno.
Se dunque si può con certezza affermare che l’illustratrice Tennant non aveva mai visto una ghironda e non aveva idea che The New Mother parlasse di uno strumento simile, resta più difficile stabilire di che tipo di competenze organologiche disponesse Lucy Clifford, e su cosa facesse leva la sua immaginazione per l’elaborazione fantastica dello strumento. La mia ipotesi è che Clifford, lungi dall’avere in mente un liuto o uno strumento della famiglia dei liuti, si ispirasse effettivamente alla ghironda, strumento ampiamente attestato nelle strade della Londra vittoriana, ma che preferisse usare una variante rara del nome (su cui torneremo tra poco) per meglio motivare la natura magica e particolare dell’oggetto. La ghironda fornisce così i
tratti di base, ma la nuova etichetta li riconfigura in uno strumento raro e proprio per questo più idoneo a suscitare nel lettore (che rimane perplesso più o meno come le due bambine della storia) un effetto perturbante.
Che lo strumento fosse diffuso e ben noto ai Londinesi è testimoniato, tra gli altri, da Henry Mayhew, lo straordinario etnografo della classe lavoratrice metropolitana inglese alla metà del XIX secolo.14 Nella sezione del terzo volume di London Labour and the London Poor dedicata ai musicisti di strada, Mayhew descrive prima di ogni altra «Old Sarah», una suonatrice cieca di ghironda cui è dedicata anche una delle rare illustrazioni del volume.15 Come quasi tutte le storie raccolte da Mayhew, anche quella di Sarah è straziante, ma a noi interessa qui solo in quanto testimonia la fluttuazione lessicale relativa al nome dello
Fig. 2. Jules Richomme, Suonatrice di ghironda, olio su tela, 1879, collezione privata
14H. mayheW, London Labour and the London Poor, 4 voll. London, Griffin, Bohn & Co., 1861.15A p. 151, un’incisione di E. Whimper ricavata da un dagherrotipo di Beard che rappresenta la vecchia Sarah mentre suona e, alla sua sinistra, la sua accompagnatrice
con un piattino in mano. Andrà qui notato che tra le varianti onomastiche italiane la ghironda è nota anche come «vaiola a orbi», cioè viella suonata specialmente da musicisti ciechi.
Societa del liuto Revista 9 stampa/2014 .indd 61 11/12/14 09:20
62
strumento: «It took me just five months to learn the—cymbal, if you please—, the hurdy-gurdy ain’t it’s [sic] right name» (p. 160). Come si vede, ancora a metà del XIX sec. il nome dello strumento non è ancora fissato nel termine oggi corrente di hurdy-gurdy.
Più oltre, Mayhew racconta di un altro suonatore di ghironda, un Francese che con la musica dello strumento accompagnava la danza dei suoi bambini (pp. 171 sgg.). Di fatto, nel XIX secolo la ghironda è uno strumento a diffusione esclusivamente popolare, e attestato in particolare in relazione ai musicisti ambulanti. Una prova di grande interesse è fornita da un quadro di Jules Richomme datato 1879, che raffigura una ragazza povera mentre suona la ghironda (Fig. 2). Di particolare interesse l’abbigliamento della ragazza, con scialle sulle spalle e fazzoletto in capo, esattamente come la figura descritta in The New Mother, segno di una sostanziale equivalenza sociale – l’abbigliamento della ragazza povera cui non sono estranee, a Parigi come a Londra, le attività economiche occasionali e marginali come quella di musicista ambulante.
Lo strumento cui si ispira Lucy Clifford è perciò sicuramente una ghironda, di cui sono tra l’altro attestate in tutte le epoche sia varianti con la cassa a otto, cioè come una chitarra, sia varianti con la cassa a liuto, ovvero con una forma più simile a una pera (ammesso che questa sia l’interpretazione corretta di «peardrum»; ci torneremo sopra tra poco). La stessa presenza della scatolina magica con la coppia di omini danzanti mi sembra possa essere messa in relazione con la scatola dei tasti, che sicuramente a un osservatore inesperto può suggerire un corpo estraneo in forma di parallelepipedo semplicemente applicato sulla cassa armonica dello strumento. Non solo: su uno dei lati di questa ‘scatola’, i tasti azionati dalla mano sinistra dell’esecutore si muovono in su e in giù come i salterelli di un cembalo, e possono facilmente evocare l’idea di piccole figurine animate. Per quanto riguarda l’associazione di idee ‘ghironda’/‘musica di ghironda’/’omini in miniatura’/’omini danzanti’, mi sembra che le strade percorribili, oltre alla suggestione dei tasti appena menzionata, siano in sostanza tre: in primo luogo la ghironda è uno strumento popolare utilizzato per accompagnare la danza, anche in contesto di musica ambulante (come provato dal racconto del ghirondista francese raccolto da Mayhew e citato sopra); in secondo luogo la stragrande maggioranza
delle ghironde ha il manico decorato con protomi umane o grottesche, che possono far pensare a strani abitatori in miniatura dello strumento; in terzo luogo, una ghironda (accanto a un liuto) abitata da omini in miniatura è attestata in uno dei quadri più celebri del Rinascimento europeo, il Trittico delle delizie di Hieronymus Bosch, ora al Prado (Fig. 3). L’anta destra dell’opera, nota con il titolo L’inferno musicale, raffigura infatti, tra l’altro, proprio una ghironda in posizione verticale curiosamente poggiata sul manico; un omino nudo alla sua sommità è in atto di girare la manovella, mentre un altro individuo lì accanto è rappresentato in posizione curvata con un uovo gigante in equilibrio sulla schiena. Dalla tastiera della ghironda, ovvero proprio dalla scatolina che contiene i tasti, sporgono la testa e le braccia di un altro omino che suona un
Fig. 3. Hieronymus Bosch, Il giardino delle delizie (pannello di destra: L’inferno musicale, particolare), 1480-1490 ca., olio su tavola, Madrid, Prado
Societa del liuto Revista 9 stampa/2014 .indd 62 11/12/14 09:20
16Ringrazio Rita Comanducci per questo suggerimento.
63
triangolo metallico.A prescindere dalla presenza o meno di una
ghironda, l’immagine degli omini danzanti nell’immaginario ottocentesco rimanda senz’altro alle figurine presenti in molti carillon,16 come è attestato memorabilmente, ad esempio, dalle commoventi avventure della ballerina di carillon con il soldatino di stagno nella celebre fiaba di Andersen.
Una volta schizzato il commento della descrizione organologica presente nel racconto, resta da precisare origine e semantica della parola «peardrum». Poiché la parola è corredata nel testo dalla dettagliata descrizione dell’oggetto cui si riferisce, la sua interpretazione sembrerebbe non porre particolari problemi. Ma così non è, purtroppo. Come abbiamo visto, il termine corrente per indicare la ghironda in lingua inglese è hurdy-gurdy (attestato però solo a partire dal 1749, mentre lo strumento ha anche in Inghilterra una diffusione di sicuro molto anteriore). La ghironda non ha una denominazione uniforme in Europa, e anzi in ogni diversa lingua sembrerebbe presente una diversa filiera etimologica.17 In inglese, addirittura, sono attestate numerose denominazioni concorrenti: l’Oxford English Dictionary ne registra alcune («wind-broach», «humpenscrump», «humstrum», «vielle» ecc. – cui andrebbe aggiunto tra l’altro «cymbal», come testimoniato dall’uso linguistico di Old Sarah riportato da Mayhew e citato sopra), così come registra quelle di strumenti affini, con tasti e ruota («claviole», «tetrachordon»). Questo sembra deporre in favore dell’ipotesi che Lucy Clifford si sia servita di un sinonimo poco diffuso in quanto regionale o obsoleto del termine hurdy-gurdy, destinato a sua volta ad affermarsi sugli altri solo successivamente. Purtroppo non è possibile contestualizzare il termine «peardrum» su base lessicografica, perché di esso manca ogni traccia – sia tra i lemmi che nel testo pieno – nell’Oxford English Dictionary. Scriverò alla redazione dell’OED per segnalare la lacuna, ma resta il fatto che per il momento non posso fare affidamento su uno spoglio organizzato. Le ricerche che ho potuto eseguire su lessici dell’inglese medievale, come pure su repertori ed enciclopedie musicali ed organologiche, non hanno prodotto alcun esito. Si sarebbe spinti a credere che Lucy Clifford abbia inventato il termine, se non se ne trovasse traccia anche in altri contesti. In un romanzo di Ford Madox Ford, ad esempio,18 un uomo con un «peardrum» a tracolla è menzionato tra i musicisti presenti in un locale della Francia
meridionale – la presenza di una manovella rende inequivocabile l’interpretazione dello strumento come ‘ghironda’. Ma il termine «pear-drum» è anche usato in contesto musicologico in riferimento a strumenti orientali: in un suo studio sulla cultura teatrale del Sud-Est asiatico, il teatrologo americano James R. Brandon usa il termine «pear-drum» per designare uno strumento tailandese usato anche nell’accompagnamento di musica malese in contesti di frontiera,19 mentre in Thailandia un «double pear-drum», insieme ad altri strumenti come «bell-cymbals» e il doppio gong, accompagna gli spettacoli di Nang talung, il teatro delle ombre proiettate da marionette contro uno schermo.20
Altre attestazioni non sono particolarmente significative, se non per la loro valenza letteraria, poiché evidentemente derivano dall’opera di Lucy Clifford. È il caso di un romanzo apocrifo di Lewis Carroll opera di Kevin Sweeney, che lo presenta al pubblico come il presunto terzo volet ‘scomparso’ della ‘trilogia’ di Alice.21 Nel capitolo VI Alice ha a che vedere con dei suonatori di «peardrum», che eseguono una canzone di cui non si odono né la musica né le parole. Non sorprende, trattandosi di uno strumento che «Mr Interlocutor» tira fuori da sotto il tavolo, e che viene definito già dal narratore come «the strangest of all objects» (p. 46):
«My peardrum», he told her, «An instrument peculiar to myself».«It certainly is peculiar», Alice said, «Why, it’s something like a guitar, but with two strings, and something like a box on one side». (p. 47)
Come si vede, il rapporto di derivazione rispetto al testo di The New Mother, per quanto dissimulato dall’autore, è comunque affatto palese. Il contesto della pagina di Sweeney conferma anzi come la stessa attestazione dello strumento in Lucy Clifford sia di fatto associata a una connotazione strana e perturbante – senza la quale non avrebbe molto senso la sua curiosa e straniata riproposizione nell’apocrifo episodio di Alice. Mi sembra perciò che l’evidenza per l’uso del termine «peardrum» (o delle sue varianti grafiche «pear-drum» e «pear drum») si limiti in sostanza all’opera di Lucy Clifford, ai molti casi ad essa riconducibili e ai pochissimi altri indipendenti da essa (il romanzo di Ford Madox Ford e il saggio di James R. Brandon, in particolare).
In mancanza di dati concreti, non ho una
17 In italiano ‘ghironda’; in francese ‘vielle à roue’; in tedesco ‘Drehleir’; in spagnolo ‘zanfona’; in ungherese ‘tekerölant’; in russo ‘donskoj rylej’; sulle caratteristiche tecniche e la storia dello strumento si vedano almeno S. palmer, The Hurdy-Gurdy, Newton Abbot, David and Charles, 1980; R. A. Green, The Hurdy-Gurdy in Eighteenth-Century France, Bloomington, Indiana University Press,
1995.18Vive le roy, Philadelphia, Lippincott, 1936, pp. 312-315.19 J. R. branDon, Theatre in Southeast Asia, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1967, p. 57.20 Ivi, p. 330.21 L. Carroll e K. SWeeney, Exeunt Alice: The Lost Book of the ‘Alice’ Trilogy, Black Rainbow Press, 2008.
Societa del liuto Revista 9 stampa/2014 .indd 63 11/12/14 09:20
64
soluzione per il problema posto da etimologia e diffusione del termine, ma ritengo che qualche spunto di analisi sia ancora possibile. In particolare, mi sembra che, accanto all’ipotesi ovvia che il nome significhi genericamente ‘strumento sonoro a forma di pera’, ci sia spazio per un’altra possibile spiegazione: il termine «peardrum» potrebbe infatti riferirsi comunque alla ghironda, denotata però stavolta per metonimia con il nome di una delle sue parti, ovvero della ruota. Il termine «drum», infatti, oltre a riferirsi al tamburo, indica in inglese qualsiasi cilindro meccanico ruotante.22 Il «peardrum» è dunque una ruota, dove il determinante «pear» non indica tanto la forma (incompatibile con la necessaria circolarità del «drum»), ma la materia: non una ruota a forma di pera, bensì una ruota di pero. Se si considerano infatti alcuni esemplari storici di ghironda conservati nei musei di strumenti musicali, si osserva che il legno utilizzato per la costruzione della ruota è in genere un legno duro, in quanto la parte è la più soggetta ad usura. Il legno di pero è dunque uno dei candidati più probabili per un ruolo del genere, in quanto stabile e resistente. Un esempio di ghironda con ruota di pero è conservato nel Museo dell’Università di Edinburgo (Fig. 4) – uno strumento di fattura francese della fine del
Settecento firmato Ouvrard, con la cassa a forma di chitarra e la tastiera protetta da una copertura finemente intarsiata. È verosimile insomma che il termine «peardrum» sia uno dei tanti sinonimi per l’instabile termine hurdy-gurdy.
Un’ultima considerazione va infine riservata al problema dell’origine di questa storia, e pertanto dell’immaginario legato allo strano «peardrum». Anche in questo caso The New Mother offre lo spunto per una riflessione di notevole interesse sui rapporti tra letteratura d’autore e letteratura anonima popolare. La trama di The New Mother è infatti sicuramente invenzione di Lucy Clifford, come mostra la consonanza dei temi con quelli presenti nel resto dell’opera della scrittrice, oltre ad alcuni dettagli biografici (ad esempio i nomi delle protagoniste del racconto sono i soprannomi con cui Clifford chiamava le sue due bambine).23 Tuttavia, la penetrazione di questo testo nella cultura anglofona ha luogo in modo tale che già nel 1955 la rivista Folklore riceve una segnalazione da un certo J. Y. Bell, che chiede notizie sulle origini di un «fairy-tale» attestato oralmente nella sua famiglia con il titolo The Pear-Drum (e poi riportato in appendice alla richiesta):
My daughter, now in America, has been relating it to her children with impressive effect and she is anxious to know where it comes from. She has written it out as she remembers hearing it from her mother, and she in her turn had it from her mother but this has always been by word of mouth. The curious “pear-drum” has a Germanic flavour but I cannot find the tale in any of the editions of Grimm I have consulted.24
L’editore della rivista pubblica l’appello, ma nessuno risponde alla ‘query’. Qualche anno dopo, in compenso, la folklorista Katherine Briggs include la versione pubblicata dalla rivista nella sua raccolta di fiabe popolari inglesi, nella sezione «Nursery Tales».25 Per la parte che ci interessa, questo è il testo di Bell riportato da Folk-Lore.
Fig. 4. Ouvrard, Ghironda, Francia, fine del XVIII sec., Edimburgo, Museo dell’Università, cat. Uedin 1052
22 Oxford English Dictionary, s.v. drum, II, 5: «A cylinder or ‘barrel’ round which a belt passes or a rope is wound» (corsivo mio: si noti quanto la definizione si attagli alla ruota della ghironda).23 Cfr. ChiSholm, Such Silver Currents, cit.24 J.Y. bell, To the Editor of Folk-Lore, «Fol-Lore», XLVI, 1955, pp. 302-304, qui pp. 302-303.
25 K. M. briGGS, A Dictionary of British Folk-Tales in the English Language, Part A, Vols. 1-2, London, Routledge and Kegan Paul, 1970, citato dalla versione e-book, Taylor and Francis, 2005.
Societa del liuto Revista 9 stampa/2014 .indd 64 11/12/14 09:20
65
One day Blue-Eyes and Turkey went for a walk upon the moor, and they met a Gipsy Girl playing on a pear-drum. When she played, a little man and woman came out of the drum and danced.Blue-Eyes and Turkey were enchanted, and begged her to give them the pear-drum. “I will give it you,” she said, “but only if you are very naughty! Come back tomorrow.”26
Come si vede, la sezione relativa allo strumento musicale è profondamente diversa dalla versione ‘letteraria’ del 1882. Le bambine non sono più mandate dalla mamma al villaggio, e la perturbante ragazza seduta sullo strumento è una zingarella che suona uno strumento. Ma quest’ultimo ha completamente cambiato natura: non più un complesso cordofono con manovella e strane appendici, rappresentabile (sappiamo bene quanto impropriamente) nella figura di un liuto, bensì un semplice ‘tamburo’ («drum»), che quando viene suonato lascia fuoriuscire i due magici danzatori in miniatura. La richiesta di vedere l’omino e la donnina, di cui le bambine nella versione di Lucy Clifford sentono solo parlare, è quindi trasformata in una visione entusiasmante («Blue-Eyes and Turkey were enchanted»), che motiva la loro richiesta di ricevere in dono lo strumento fatato.
Un’analisi sistematica degli adattamenti nella versione ‘popolare’ testimoniata da J.Y. Bell, per quanto di estremo interesse anche nelle sezioni non direttamente riconducibili agli strumenti musicali, non è possibile in questa sede; basti dire che a tutti gli effetti il racconto ha la fisionomia di una vera storia popolare: Katherine Briggs la scheda infatti senza problemi sulla base della tipologia Aarne-Thompson, riconducendola al tipo 779B della classificazione, con l’aggiunta di alcuni motivi ben riconoscibili: K2261.1 (lo zingaro traditore); D1211 (tamburo magico); Q233 (punizione per aver ceduto a una tentazione). La conclusione di Briggs è tanto perentoria da essere imbarazzante, per noi che sappiamo quanto lei non sapeva:
This is a family story, and was probably a cautionary tale invented by the first teller in the family. The mother with glass eyes and a wooden tail is an unusual invention, but there is an authentic thrill about her. (Briggs 1970, p. 492)
Non c’è dubbio che il tocco dell’invenzione ‘d’autore’ riesca a lasciare una traccia anche dopo che gli altri dettagli narrativi sono stati levigati e ricondotti a stereotipi. Per quanto si possa semplificare il racconto, la madre con occhi di vetro e coda di legno resta pur sempre una «unusual invention».
Ma lo spunto di massimo interesse è pur sempre l’eccezionale circostanza che ci permette in questo caso di osservare in diretta qualcosa che potrebbe essere accaduto innumerevoli volte nella storia dell’immaginario, e cioè come l’invenzione di un individuo, per quanto originale e specifica, tenda comunque a scadere in breve tempo, se privata delle tutele di una trasmissione consapevole e rispettosa, su un piano molto più semplice e convenzionale. La sua trasformazione da testo d’autore a testo del repertorio folklorico mostra infatti come i dettagli ambiguamente perturbanti vengano semplificati in stereotipi retrivi e moralistici (la misteriosa ragazzina che diventa una zingara), mentre gli oggetti più rari o meno univocamente decifrabili, come il nostro «peardrum», vengono riconfigurati come referenti tendenzialmente più vicini all’esperienza quotidiana più comune (il tamburo invece del raro strumento a manovella).
È interessante osservare infine che con l’avallo di K. Briggs la storia, filtrata dalla memoria dei bambini e poi raccontata dagli stessi bambini divenuti adulti, ha finito in tre sole generazioni per essere trasformata in un racconto perfettamente conforme alle strutture della narrazione popolare, entrando di fatto nel repertorio folklorico: Robert D. San Souci,27 ad esempio, conosce sì il testo di Lucy Clifford,28 ma non si accorge che si tratta della versione originale della storia ‘popolare’ che egli si accinge a riformulare per la pubblicazione come
26 bell, To the Editor of Folk-lore, cit., p. 303.27 Even More Short & Shivery. Thirty Spine-Tingling Tales, New York, Dell Yearling/Random House, 1997 (più volte ristampato), con illustrazioni di J. Rogers.28 Che legge in Lurie, The Oxford Book of Modern Fairy Tales, cit., pp. 120-139.
Societa del liuto Revista 9 stampa/2014 .indd 65 11/12/14 09:20
un racconto del folklore delle isole britanniche: intrappolato dal presupposto che tutto ciò che è popolare deve essere gioco forza anteriore alle opere di autori storicamente individuati, San Souci considera curiosamente il racconto di Lucy Clifford solo una versione estesa, utile per la riscrittura, della versione ‘originale’, ovvero della variante popolare testimoniata da J. Y. Bell nel 1955, come si premura di esplicitare nella nota sulle fonti:
The New Mother: This story is based on «The Pear-Drum», published by J.Y. Bell […]. In the original [corsivo mio], the temptress is a gypsy girl. […] For this telling, I also consulted a much longer version in Anyhow Stories, Moral and Otherwise by Lucy Lane Clifford.
Interessante anche il fatto che nella versione di San Souci il «pear-drum» sia sostituito da una «music box»: segno che anche il nome dello strumento ‘originale’ risulta comunque troppo esotico e indefinito per permettere una chiara visualizzazione della scena. L’effetto di spiazzante ambiguità di cui nella versione originale di Lucy Clifford sono vittime dapprima le bambine e poi i lettori viene insomma a più riprese azzerato in un arrangiamento dove si vede tutto, e dove la sola parte misteriosa resta la bizzarra e diabolica condizione imposta dalla zingara. Il raro strumento musicale, come si è visto, finisce per diventare un semplice tamburo, e tutti i particolari ambigui e inquietanti dell’immaginario cliffordiano vengono appiattiti in una favola sicuramente efficace, ma certo lontanissima dalle qualità letterarie del suo modello dimenticato.
k
66
Societa del liuto Revista 9 stampa/2014 .indd 66 11/12/14 09:20













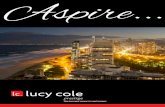

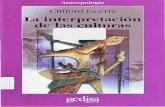

![Lucy v OCC Holdings P/L & Ors [2008] QDC 004](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6336e3d9d63e7c7901058f14/lucy-v-occ-holdings-pl-ors-2008-qdc-004.jpg)