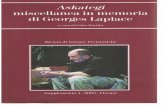Georges De Canino. Paesaggi romani. Le case dell'arte/la città dell'arte
"La Somiglianza per Contatto" di Georges Didi-Huberman
Transcript of "La Somiglianza per Contatto" di Georges Didi-Huberman
Martina Valente
“La somiglianza per contatto – Archeologia, anacronismo emodernità dell’impronta”
di
Georges Didi-Huberman
“Ci sono impronte che ci precedono o ci inseguono ovunque. Molte ci sfuggono, molte scompaiono, talvolta sotto i nostri occhi. […]
Molte continueranno a vivere dopo di noi. Ma per quanto siano numerose, possiamo domandarci se, considerata la loro diversità, essediano davvero vita ad un genere.”
La somiglianza per contatto – Archeologia, anacronismo e modernità dell’impronta di
Georges Didi-Huberman, pubblicato nel 2009 in Italia da Bollati
Boringhieri, è un saggio affascinante che nasce dall’esigenza
dell’autore di riabilitare l’Impronta, di inserirla nel percorso
della storia e della critica d’arte. Un progetto che può sembrare
forse debole, data l’aleatorietà apparente e la soggiacenza che
evocano l’oggetto di studio in questione, ma Didi-Huberman,
attraverso la metodologia rigorosa di discorso strutturato in due
Ouverture che racchiudono tre parti che sfaccettano l’impronta in
dodici aspetti diversi, riesce a convincerci dell’importanza di
questa “procedura”, riposizionandola in quegli interstizi
1
dell’arte finora invisibili e aprendola a varie possibilità
critiche.
La prima ouverture “Su un punto di vista anacronistico” (pag. 9)
presenta il progetto critico dell’autore e la sua crisi: come
parlare dell’Impronta come concetto? Da ciò la divisione in
problematiche, in sintomi, termine caro all’autore, su cui
interrogarsi. Perché l’impronta non appartiene né al passato
(pensiamo alla Preistoria che ha parlato di sé attraverso le
tracce) né al presente post-modernista: l’impronta necessita del
punto di vista anacronistico, anzi, ne è un esempio perfetto.
Per Didi-Huberman questo approccio critico è l’unico possibile
perché l’impronta non ha una storia. Vari precedenti illustri
mutuano l’autore nel suo procedimento, a partire da Carl Einstein
che nel 1915 procedette così per associare il Cubismo all’arte
africana ma è soprattutto a Walter Benjamin e Aby Warburg che
l’autore si rivolge. L’immagine dialettica e la Sopravvivenza
(Nachleben) sono le figure critiche di riferimento per un
approccio anacronistico in cui passato e futuro si compenetrano
per capire il presente, sono le basi di una critica d’arte che
prende in considerazione le impurità, gli scarti incomprensibili
che spingono <<lo storico a trasformarsi in antropologo>> per
analizzare un oggetto inattuale.
Se per ragionare in modo anacronistico bisogna partire dal
Presente allora è necessario anche mettere in luce la crisi di cui
è preda il nostro tempo, crisi che viaggia sui binari del
Postmodernismo e dell’Antimodernismo. Come esempio di questa
odiosa simmetria, l’autore cita L’Opera d’arte nell’epoca della sua
2
riproducibilità tecnica, celebre saggio di Benjamin che, nella sua
banalizzazione, ha diviso la critica in due atteggiamenti: quelli
che rivendicano la perdita dell’origine/originalità dell’opera
d’arte come cesura con il passato (Postmodernisti) e quelli che la
piangono in un afflato di nostalgia (Antimodernisti). Sono questi
gli atteggiamenti da evitare per tracciare la storia
dell’impronta: possiamo ridurla ad un dubbio amletico se sia
contatto dell’origine o perdita dell’origine? Paragonando
l’impronta all’opera d’arte di cui parla Benjamin, forse Didi-
Huberman complica il discorso, soprattutto nell’abbandonarsi in un
appassionato sillogismo in difesa del suo punto di vista, ma in
realtà è funzionale per farci comprendere la problematicità della
questione e introdurci all’autore che più ha saputo mettere in
difficoltà l’apparato critico contemporaneo: Marcel Duchamp. La
sua opera Foglia di vite femmina che apre e chiude il saggio, un calco
abbastanza informe del sesso femminile, è citato per illuminarci
subito sul parallelismo con il geniale artista. Didi-Huberman può
introdurre a questo punto ciò che mancava per esemplificare il
discorso sulla perdita di origine benjaminiana: il Ready- made,
con tutto il suo carico di complicanze critiche. Infatti,
dall’apparizione della prima fontana duchampiana, viene messo a
morte il mestiere tradizionale dell’artista, diventando il simbolo
della non-arte, come l’impronta è la non-opera per eccellenza.
Per l’autore, rispecchiando il suo non accontentarsi del “qui ed
ora”, questi atteggiamenti critici poco dialettici non sono che un
retaggio accademico, che parte da Vasari, antesignano autore del
Modernismo che tutt’ora conosciamo. Infatti il terrore della
3
perduta dell’unicità dell’opera d’arte, della sua riproducibilità
in serie fu ciò che spinse Vasari a demarcare le arti tra liberali
e meccaniche, insabbiando e cancellando dalla storia tutte quelle
tecniche ready-made che non brillassero di unicità, tra cui
l’Impronta.
Nella Parte Prima “L’impronta come paradigma: un’archeologia della
somiglianza” si entra nel vivo dell’analisi dell’impronta: dopo
aver chiarito il suo punto di vista, Didi-Huberman è libero di
procedere nella sua storia a ritroso in cui viene recuperata
l’importanza che l’impronta abbia avuto fin dai tempi dell’ ”alba
delle immagini” per arrivare all’Umanesimo.
L’impronta è prima di tutto un Gesto (pag. 25) , un dispositivo
tecnico completo, una sopravvivenza tecnica estremante primitiva.
Coinvolge, con la sua complessità, il tempo, la simbologia e
l’antropologia: l’uomo ha sempre utilizzato le estremità del
proprio corpo per imprimere un segno ma non si tratta di un gesto
rudimentale, rozzo e incolto ma di un’operazione euristica, perché
“fare un’impronta significa formulare un’ipotesi tecnica, per
vedere quale sarà il risultato”.
È un’apertura all’accidentale, un tentativo che può portare a
risultati brillanti, un qualcosa di indeterminato. Didi-Huberman
parla di Inconscio Tecnico per definire il gesto dei primitivi
quando si approcciarono alle prime tavole di argilla e vi
impressero la propria orma. Sono pagine dense di riferimenti
strettamente antropologici a cui l’autore si richiama per
tracciare questa origine del procedimento dell’impronta, quasi
come se fosse una tecnica d’elezione per quei primi uomini che
4
ancora dovevano scoprire il mondo. Ma forse era un gesto più
importante e consapevole di quanto possiamo immaginare perché c’è
un parallelismo notevole tra le Wunderkammer e le grotte, ad
esempio quella di Lescaux, dove troviamo calchi ornamentali di
conchiglie e fossili. Che fossero consapevoli del valore
dell’arte, dell’imitazione?
“Ciò che noi consideriamo come <<origine>> guardava già verso
un’<<origine>> ben pù antica: anche il nostro antenato amava le
antichità, come quelle forme fossili che, quando ci si imbatteva,
aveva cura di mettere da parte. Ma accostandole al resto della
collezione, e soprattutto scolpendo forme equivalenti, non creava
altro che una collisione tra il Già-stato e l’Adesso”
Tecniche più semplici dell’impronta non ce ne sono eppure, già
nella Preistoria, c’era stata una complicazione: il mistero delle
impronte negative. È un mistero la tecnica, il significato e,
soprattutto il perché. A questo punto l’impronta assume un valore
dialettico, portatore di un paradosso: sono mani fantasma che
rappresentano l’assenza.
Ma ci sono anche le impronte fatte e le impronte falsificate, come
ad esempio quelle australiane, ulteriore conferma che non si
trattava solo di un procedimento ma una vera e propria
iconografia, un processo a tutti gli effetti che sta per essere
investito di un carico simbolico sempre più importante.
E se l’impronta trasmette la somiglianza delle cose, creando una
copia che possiamo considerare figlia carnale, lo fa tramite la
Matrice (pag. 48) , il luogo in cui si coagula la somiglianza. Sono
5
matrici i crani scoperti a Gerico, i crani sovramodellati dipinti
ad imitazione delle fattezze del defunto: lo stesso cranio umano
diventa matrice per lo stampo da cui avranno origine poi le
maschere funebri e i ritratti romani. Viene messo in evidenza
quanta importanza avesse il gesto dell’impronta, questo procedere
direttamente sul volto per dare vita ad una somiglianza per
contatto, garanzia di vita per il morto nell’oltretomba, la
sopravvivenza della propria faccia.
Ma, come ribadito già nella prima ouverture, l’impronta non
esiste nella storia dell’arte, è la sua contropartita, un contro-
modello: Plinio il Vecchio, padre della storia dell’arte, cita il
calco come origine e fine della storia dell’arte, definita come
imaginum pictura. È un primo atto di censura dell’impronta, uno
scagliarsi contro la sua stessa natura perché, se da un lato il
calco del defunto è di per sé originale, la matrice permette la
riproduzione e quindi predispone alla presunta inautenticità del
ritratto: da qui la confusione, la decadenza dei patrizi romani
che ornavano i propri atri con innesti di maschere di defunti su
statue greche.
“La legittima trasmissione si svia in una trasformazione retorica
ed estetica che la <<legge dell’impronta>> rifugge, a che la
tecnica dell’impronta con tutta evidenza permette”.
La matrice è anche Potere (pag. 66), una suggestione che deriva dal
processo di impronta che diventa garanzia di singolarità: Didi-
Huberman si riferisce alle monete, alle medaglie, alle immagini
dei potenti sovrani la cui effigie avrebbe viaggiato in ogni parte
del mondo, recando in sé tutto il potere suggestivo dell’illusione
6
ottica che un ritratto sa mettere in opera. È il paradosso
dell’impronta che il conio sia garanzia di autenticità ma allo
stesso tempo anche la capacità legittima di riproduzione
illimitata: è qui che Didi-Huberman supera la tesi di Benjamin,
che non aveva colto che finchè c’è una matrice originale c’è anche
l’autenticità, che non c’è riproduzione che intacchi l’aura
dell’opera, come una moneta che non si svaluta nel suo riprodursi.
È il contatto dell’aderenza il plusvalore dell’impronta, che l’ha
investita di poteri magici e che addirittura ha permesso l’unica
rappresentazione di Dio possibile: la Sindone.
È un esempio eccellente della somiglianza per contatto,
un’immagine che non può essere accusata di idolatria perché è una
non-immagine, è solo un’impronta suggestiva
“ è meno di un’immagine perché è un campo di tracce
indescrivibili, appena visibili, che procedono per semplice
impressione materiale, è matrice dell’immagine perché le
conferisce la sua legittimità, il suo prototipo di generazione,
come dicono i bizantini, ma anche la sua controforma negativa,
il suo carattere in senso tecnico, infine è più di un’immagine,
perché va oltre qualsiasi imitazione <<artistica>>,
qualsivoglia mano d’uomo – perché si attiene meno al visibile di
quanto non faccia una visione in senso forte, meno al volto per
naturam di quanto non faccia un volto divino per gratiam”.
È importante vedere come il processo dell’impronta abbia delle
implicazioni molto più profonde di quanto potessimo pensare,
soprattutto perché l’autore, trasversalmente al concetto di
potere, vi associa quello dell’Aura, altro termine benjaminiano.
7
Il potere della Sindone è la sua Aura, ovvero quel desiderio
inappagato, quella fascinazione indescrivibile di un’opera che
arriva a toccare lo spettatore. La Sindone è un’immagine che esige
il contatto ma che lo esclude perché la mano umana è invisibile.
La storia dell’impronta delineata da Didi-Huberman è anche una
storia del non-detto, delle omissioni della cultura umanistica
sulle pratiche di calco dal vero. La formulazione dei principi
umanistici dell’Idea, del Disegno ha impedito che venissero
trasmesse tutte quelle pratiche più “scultoree”, legate al tatto e
alla manualità che avrebbero svilito il ruolo dell’artista
intellettuale al mero artigianato.
La storia dell’arte del Quattrocento, nonostante la censura
vasariana, è densa delle Sopravvivenze dell’impronta (pag. 87) :
Cennino Cennini dedica nove capitoli alle tecniche dell’impronta,
che oltretutto era una specialità dell’artigianato fiorentino
(come ad esempio gli ex-voto), la stessa cultura della città
conviveva con le immagini dei defunti e gli artisti stessi usavano
il calco dal vero come parte integrante del processo di creazione
artistica.
Donatello, uno dei maggiori sperimentatori delle possibilità
offerte dalla tecnica, usò il calco dal vero per il suo busto di
Niccolò da Uzzano ma Vasari rigetta questa attribuzione, ritenendo
impossibile che un artista del suo livello si abbassasse ad una
pratica tanto sgradevole e grossolana; anche la scultura “Giuditta
e Oloferne” fu creata a partire dall’innesto di vari calchi, le
cui tracce sono ancora visibili osservando bene il tessuto del
cappuccio della testa della donna.
8
L’impronta, per la mentalità ed il gusto umanistico, è perturbante
secondo Didi-Huberman perché la sua visione impone lo sguardo del
contatto ovvero sulla tattilità a scapito dell’otticità, e poi
perché apre uno squarcio nel tempo al di là delle storicizzazioni
schematiche imposte dall’estetica Vasariana, per cui il contatto
con il mondo antico è superficiale e frutto dell’oblio di tutto il
resto.
Il calco è la contropartita della storia, un procedimento che
attraversa i tempi: nel Rinascimento, secondo Didi-Huberman,
l’impronta è stata tanto usata quanto bistrattata, come un
qualcosa da tenere nascosto onde evitare di offuscare le proprie
doti di artista. A causa della propria vocazione artigianale,
antropologica, archeologica sarebbe stata dimenticata dalla storia
dell’arte di Vasari, per poi riemergere e sopravvivere con
prepotenza fino ai giorni nostri.
La seconda parte del libro, “L’impronta come processo: verso la
modernità in scultura”, riprende la critica delle rigide
schematizzazioni dell’eredità umanistica, che non lascia spazio
alla distinzione di esperienze diverse da quelle categorizzate da
Vasari.
Per l’autore, a questo punto, l’impronta emerge come Lutto (pag.
109), come una “forma che trascina la somiglianza verso la morte”.
Il procedimento del calco, dopo il Rinascimento, in una
prospettiva piuttosto scaramantica, rimanda alla Morte: pensiamo
alle maschere funerarie (ricordiamo che già Plinio ne evidenziava
il paradosso di origine e fine dell’arte), ma anche alla pratica
dei frammenti anatomici che rimandava ad un contatto troppo
9
diretto con la morte, la malattia, la bassa corporeità umana. Il
calco dal vero assume una connotazione mortificante perché
<<l’anatomia stabilisce per noi un “destino”: quello della nostra
frammentazione in pezzi, osservabili da altri, quello della nostra
messa a morte visualizzata”. Per quanto siano parte integrante
della vita pratica di un artista, i calchi sono antitetici alla
scultura per la loro aderenza eccessiva alla materia, a scapito
dell’Idea. E nulla può andare più detrimento dell’impronta che il
suo essere svincolata da un progetto ideale dell’artista, in un
secolo dominato dalle teorie dell’arte e dalle etichette dei
generi. La scultura (tradizionale) dà alla luce la vita
intrappolata nella materia, in pieno retaggio michelangiolesco,
mentre l’impronta ci permette di toccare la morte.
Didi-Huberman, con questo rovesciamento di senso, mette in luce
una nuova evidenza dell’impronta dopo l’enunciato iniziale perché
non solo è una forma che trascina la somiglianza verso la morte,
ma addirittura porta alla morte dell’arte stessa.
È un precipitato di luoghi comuni, di paure: quella della morte
fisica, quella della figura dell’artista intellettuale, quella
della riproduzione illimitata che svaluta il valore dell’opera.
Ancora una volta ci si trova dinanzi al paradosso impronta come
eccessiva aderenza all’origine e mancanza della stessa origine.
Didi-Huberman cita Horst W. Janson che nel 1957 mette in evidenza,
nel suo saggio sul dibattito del realismo nell’arte, quanto la
pratica del calco sia impossibile da annettere alle arti
tradizionali per la sua eccessiva dipendenza/eccesso di aderenza
alla materia, per l’indipendenza dalla mediazione intellettuale
10
dell’artista e per la sua atemporalità, che si traduce in una
messa in crisi del valore della Storia.
Per l’autore, quindi, l’Anacronismo è da sempre uno dei terrori
suscitati dall’impronta: mette orrore questa sua palese vicinanza
temporale alla morte e questo suo aspetto così ancestrale.
Nel XIX secolo la critica d’arte ignorò il calco, concentrata
com’era sul Realismo nell’arte; ma in realtà, se non fu una
questione di generale interesse, la sua legittimità continuò ad
interessare individualmente gli artisti e David d’Angers non può
che essere la cristallizzazione esemplare del punto di vista di
uno scultore del tempo. Artista molto noto ai suoi tempi
nonostante la mediocrità, scrisse taccuini interessanti in cui la
pratica del calco emerge come la distruzione del valore morale
dell’arte: troppo simile alla morte e troppo dettagliato nel
riprodurre ogni ruga della pelle, ogni segno dell’opera mortifera
del tempo.
Didi-Huberman, attraverso le suggestioni di uno scultore che
rispecchia magistralmente la mentalità del suo tempo, è
interessato a mettere in luce quanto l’artista fosse realmente
terrorizzato dalla materia e paralizzato dall’inquietante
parallelismo tra la scultura come impronta di vita e la morte come
scultura di impronte.
Ma l’impronta può essere anche sensualità o addirittura Scandalo
(pag. 128). Charles Baudelaire, contemporaneo di d’Angers, ribalta
la sua posizione sul calco, enunciando una teoria estetica a
favore di un procedimento che mettesse in evidenza la grana della
11
pelle, la testura del corpo della donna. Per lui, la scultura
doveva tornare ad essere primitiva e tribale perché, in balia
della perfezione anatomica, stava diventando “noiosa”.
Leggendo tra le righe delle sue poesie, Didi-Huberman rintraccia
una <<scrittura del contatto>>, che rimanda alla donna come un
idolo “moderno ed originario” fatto di pieghe della pelle e di
rughe, in una fascinazione perturbante per la morte e la
decadenza.
In quegli stessi anni, una scultura destò scandalo: “Donna morsa
da un serpente” di Auguste Clésinger, modellata sul calco dal vivo
di una modella. Era rappresentata una donna moribonda in tutta la
sua realtà e proprio l’indecenza dell’ utilizzo del procedimento
del calco dal vero fu ciò contro cui si scagliarono i critici,
contro quelle “piccole pieghe esattamente antitetiche alle grandi
superfici rivendicate, in quegli anni, da David d’Angers”.
Théophile Gautier, per cui la scultura doveva conservare l’aspetto
del corpo umano, scrisse un testo su questa scandalosa opera, in
cui apprezzava il coraggio dell’artista di aver scolpito una donna
vera, piuttosto che una ninfetta, una dea mitologica oppure una
santa:
<< Se non fosse di marmo, si direbbe che una bella e superba
creatura sia stata afferrata e bloccata a sua insaputa in uno
stampo magico nell’istante in cui qualche sogno incantevole e
terribile la faceva contorcere sotto [sic] le sue coltri di
piacere e dolore>>.
12
È proprio la procedura del calco, secondo Didi-Huberman, a
garantire l’eroticità di questa scultura e la chiave per
comprenderla: Baudelaire e Gautier assimilano termini propri
dell’arte dell’impronta per scrivere delle donne, per alludere al
contatto e all’appropriazione del corpo dell’amata.
Nonostante il rifiuto, l’impronta è Propedeutica alla scultura (pag.
136): anche per un artista della fine del XIX secolo che non
scolpisce attraverso il taglio diretto del marmo, è necessario
realizzare il calco per poi lavorare sulla propria opera. Sono
secoli che questo processo è tanto utilizzato quanto negato dagli
artisti, nonostante abbia una grandissima valenza procedurale: la
scultura teme il calco perché ha paura di esserne svilita ma non
può farne a meno allo stesso tempo, è utile perché permette di
fare una copia e di venderne trenta.
Un grande scultore come Antonio Canova, ovviamente, odiava il
calco e il gesso ma tuttavia è indispensabile alla sua arte:
possiede addirittura una vasta gipsoteca in cui sono conservati i
calchi delle sue opere, un vero e proprio repertorio di forme
vitale per la sua arte. Ciò che colpisce Didi-Huberman è come
Quatremère de Quincy, strenuo difensore dell’Idea a scapito della
Materia, arrivi a giustificare il palese uso del calco in gesso
che facesse Canova: dapprima giustifica con i bisogni economici
questa proliferazione di opere del maestro, poi sviluppa un
interessante concetto sulla questione della riproducibilità,
spiegando che per Canova, in realtà, si tratta di <<doppi
originali>>, su cui lavorare per trovare forme sempre diverse,
13
mettendo in luce ancora una volta il valore euristico
dell’impronta.
Solo con Rodin avviene la svolta, la presa di coscienza
sull’impronta come Lavoro (pag. 146). Il padre della scultura
moderna, alla fine del XIX secolo, si assunse la responsabilità
pratica dell’uso del calco: non lo nascondeva ma, anzi, arrivò a
farne il punto di arrivo delle sue sperimentazioni artistiche,
evidenziando un’euristica delle possibilità tecniche fino ad
allora tenute occultate dalla scultura tradizionale.
La differenza, rispetto alla gipsoteca di Canova, è radicale:
l’opera in progress di Rodin “diventa calco per poi essere subito
disseminata in una quantità considerevole di frammenti nomadi che
sono altrettante parti intercambiabili, altrettanti elementi
sintattici disponibili per nuove composizioni formali. Rodin non
lavorava solo nel suo museo personale ma nel suo museo scomposto,
nel suo museo smembrato, in cui ogni membro era virtualmente
capace di dar vita ad un nuovo organismo”.
Per Didi-Huberman, la nozione di calco di Rodin è un paradigma
formato dalla moltiplicazione (aspetto ancestrale dell’impronta
che dà vita a montaggi di frammenti che originano un movimento
organico), dalla frammentazione anatomica e dall’assemblaggio,
mettendo in luce l’artista come uno sperimentatore temerario delle
infinite possibilità di una procedura finora considerata
mortifera; la messa a morte attuata da Rodin quindi è la quella
non più dell’arte ma della scultura tradizionale perché il
procedimento del calco diventa un paradigma estetico che non
smette mai di autogenerarsi, dando vita ad infinite associazioni.
14
Rodin forse non era consapevole di quanto fosse anacronistico
questo suo lavoro di riabilitazione dell’impronta ma di certo ha
contribuito a far riacquistare al calco tutti quei diritti e lo
statuto artistico che gli era stato negato per secoli.
Per Didi-Huberman, il testamento estetico di Rodin è stato il suo
“Calco della mano che regge un torso femminile”: un inquietante
calco della mano dello scultore, ancora in vita, che regge un
torso di donna nel palmo della mano. Al di là dei paradossi e
delle suggestioni intrinsechi a questa scultura, vediamo che Rodin
abbia accettato di sottoporsi ad una pratica che aveva sempre
rifiutato di praticare nella sua arte, come ultimo atto di un
utilizzo legittimo del calco come sugello della morte
dell’artista. Quello che ha inaugurato Rodin è un nuovo
atteggiamento della scultura: la fine della lotta tra l’Idea e la
Materia.
Nella terza parte del libro “L’impronta come procedura:
sull’anacronismo duchampiano” Didi-Huberman torna sulla scultura
“Foglia di vite femmina” (pag. 163) per capire su quali discorsi
critici è stata polarizzata la rivoluzione scandalosa del ready-
made: parlarne significa annunciare la <<sparizione suicida
dell’arte>>, che squarcia in due il percorso dell’arte del XX
secolo e molti, come Thierry de Duve, generalizzeranno il gesto di
Duchamp con la celebre formula “fai una cosa qualsiasi”.
Ma è proprio così arbitraria, nulla e sovversiva la sua arte?
Questo antagonismo parte dalla contestazione del criterio di
15
singolarità dell’opera d’arte duchampiana: perso l’originale,
molte sono le copie della “Fontana” che, nella loro riproduzione
infinta, sembra che abbiano perso la loro materialità a scapito
dell’Idea generale, unica cosa su cui la critica pare si sia
soffermata. È un’idea che, per Thierry, sopprime l’oggetto e
trasforma l’opera d’arte soltanto in un lavoro concettuale, in
un’operazione sul discorso.
Parlare di Duchamp significa associarvi solo oggetti fittizi, la
volontà di condannare a morte l’arte e il mestiere dell’artista ma
Didi-Huberman vuole <<spazzolare la storia contropelo>>, accedere
alla contropartita della sua storia.
Per contestare l’istituzione del ready-made, analizza la
personalità dell’artista: chi è davvero Duchamp? Era il ciarlatano
manipolatore che destruttura l’arte per farsi autopromozione, come
siamo abituati a leggere? In realtà no perché le vicende della sua
vita mettono in luce che il suo atteggiamento era totalmente
diverso: Duchamp ha sempre voluto tenersi in disparte rispetto al
corporativismo artistico e al sistema delle gallerie già dal 1912,
quando il “Nudo che scende le scale” era stato ritirato dal Salon
des Indépendants, così come nel 1917 quando, esponendo la
“Fontana”, la sua vita continuò ad essere squattrinata ed isolata
dal sistema.
Realizzava opere che regalava ad amici, per mettere in discussione
il valore non commerciale dell’arte, tentava di rivoluzionare il
sistema senza trarne benefici, quindi senza la dietrologia della
truffa all’arte, della vendita di aria fritta di cui fu sempre
accusato. Tenendo conto dell’atteggiamento sociale di Duchamp,
16
giungiamo alla conclusione il valore attribuito al ready-made
dalla posterità è assolutamente anti-duchampiano, perché è
abbastanza un controsenso già l’aver creato opere di questo
genere, senza tener conto dell’impatto che avrebbero avuto.
I critici dimenticano che l’artista si era imposto di non
smembrare il suo corpus di opere, di tenerle tutte insieme come
un’unità organica: ecco un altro contromotivo della storia
delineato dall’autore. L’opera di Duchamp è euristica, è sempre
aperta al caso, stretta tra il rigore metodico e l’abbandono agli
imprevisti. Si tratta di oggetti indivisibili perché hanno più
valore nel loro insieme, come un montaggio di pezzi. Levi-Strauss
aveva intuito questo aspetto del ready-made quando, alla domanda
<<Chi mi impedisce di considerare qualsiasi oggetto un ready-made?
>>, rispondeva
<<Non è possibile realizzare l’operazione con qualsiasi oggetto
sistemato in modo qualsiasi. Non tutti gli oggetti possiedono
quelle qualità latenti; per determinare un ready-made
occorreranno sempre determinati oggetti in determinati
contesti>>.
Un altro dei punti critici di Duchamp è la perdita del mestiere
dell’artista: scompare l’artista come abile detentore della
tecnica per far posto all’enunciato del “questa è arte” ma
sostenere questa convinzione significa anche non tener conto che
la sovversione evidente messa in atto è frutto dei suoi tempi,
quelli dell’industrializzazione dell’arte, della fotografia e
della riproducibilità tecnica.
17
È un’operazione critica che ha avuto una risonanza più forte di
quanto si aspettasse l’artista.
L’opera di Duchamp però è sicuramente collocabile nella sfera del
Segno: sono opere in apparenza prive della manualità dell’artista
ma dense di teoria e due orientamenti critici si sono soffermati
su questo paradigma fotografico su cui si regge il corpus di
opere.
Jean Clair nel 1977 parla di primato tecnico di Duchamp partendo
dalla riflessione benjaminiana sul potere della fotografia
mettendo in evidenza le ossessioni dell’artista per le ombre e per
le silhouettes, rintracciando una storia che guardava al passato
con precedenti illustri fino al quadraturismo del XVII secolo ;
Rosalind Krauss, nello stesso anno, sempre partendo dalla
fotografia, formula un paradigma semiotico coniugando all’opera
duchampiana la categoria di Indice pierciana, dipanando così tutta
una serie di riferimenti postmodernisti che le permetteranno di
interpretare l’arte americana degli anni settanta.
Per Didi-Huberman la Krauss ha il merito di collegare il “senso”
al ready-made, stabilendo una relazione fisica con il referente
che ci permette di ritornare alla questione del Contatto, tornando
così all’Impronta.
Ci sono molte analogie tra l’atteggiamento di Rifiuto per un’analisi
dell’arte di Duchamp e l’impronta: i dibattiti critici suscitati
da entrambi sono simili, si scagliano entrambi sulle stesse
questioni della fobia del tatto della critica donatelliana
18
(pensiamo all’accusa di pigrizia tecnica per aver usato la tecnica
del calco per la “Giuditta e Oloferne”), sull’apertura alla cosa
qualsiasi, sulla non-arte e, addirittura, morte dell’arte.
Chiarita questa analogia e individuata la tecnica del contatto e
dell’indice, Didi-Huberman cercherà di
<<interrogare l’impronta prima come paradigma e poi come
processo. Ricongiungendo i due livelli di efficacia,
probabilmente riusciremo a farci un’idea del modo in cui
l’impronta, questo gesto tecnico e ancestrale, può accedere allo
statuto di procedura artistica>>.
Il “Grande Vetro” (pag. 181) è un’opera molto complessa, con varie
stratificazioni di significato: è un’opera dotata di una grande
reversibilità, è considerata antropomorfa e macchinica ma, se
tanti critici, citando per esempio Jean Clair, ne hanno tracciato
una storia a ritroso per far guardare Duchamp al passato piuttosto
che al futuro, è necessario invece rintracciare gli aspetti più
anacronistici dell’arte del maestro francese.
Uno dei leitmotiv duchampiani è la sua “critica del retinico” ed
per Didi-Huberman è necessario approfondirne il significato per
capire la consistenza metodica della dimensione tattile
dell’artista. Per critica del retinico non si intende soltanto la
difesa dell’aspetto più intellettuale dell’arte, la difesa della
“materia grigia” enunciata nelle Note al Grande Vetro; si intende
anche in rifiuto dell’impressione retinica (pittorica) a favore di
un metodo più poetico, come si legge dalle stesse parole
dell’artista
19
<<Ritenevo che in quanto pittore, era meglio che fossi
influenzato da uno scrittore piuttosto che da un altro pittore.
E Roussel mi mostrò la strada. La mia biblioteca ideale avrebbe
compreso tutti gli scritti di Roussel e di Brisset, forse
Lautréamont e Mallarmé. Mallarmé era un grande personaggio.
Indicò la direzione che l’arte deve prendere: l’espressione
intellettuale, più che l’espressione animale. Ne ho abbastanza
dell’espressione “stupido come un pittore”>>.
È evidente nelle Note al Grande Vetro quanto Duchamp sia
suggestionato dalla letteratura ma anche dalla tecnica, e anche
un’altra enigmatica opera, la “Scatola Verde” del 1934, ha le
tracce di questo dualismo intellettuale/tecnico di Duchamp, in cui
emergono le terminologie dell’Impronta. Lo stesso autore prende
coscienza dell’oscurità del linguaggio duchampiano ma non può
sfuggirgli il valore fondante che ha la tecnica del calco nella
sua opera.
La sfida di Duchamp al sistema dell’arte consiste anche in quella
che chiama “materia rosa” che si contrappone a quella grigia: una
materia che per Didi-Huberman ha la possibilità di esistere come
immagine tattile e come processo di presa, la capacità di Duchamp
di osare e di pensare all’impronta come scarto di cosa che va
verso il dissimile piuttosto che, come la pensiamo noi cioè ad uno
stampo che permette di replicare.
Il “Grande Vetro” è intriso di rimandi alla tecnica del calco: lo
stampo, la matrice, il setaccio, le controforme sono tutti segni
di questo paradigma dello stampo che
20
<<prevede la produzione di una forma per contatto, per poi
sottoporlo a un ribaltamento in grado di trasportare quella
stessa forma verso l’invisibilità: verso qualcosa di simile ad
una forma intangibile che, nondimeno, sigla il suo rapporto con
un contatto originario ( ricordiamo che la stessa, paradossale
articolazione costituiva già nel caso della Veronica la
principale determinante del carattere auratico dell’immagine)>>.
Per Didi-Huberman i Nove stampi malici e il Pistone d’aria quindi
posseggono la stessa auraticità della Sindone per il loro essere
la traccia di un contatto invisibile, la traccia lasciata
dall’aria così come quella lasciata dal volto di Cristo.
Un altro richiamo al calco è dato dal rapporto dell’autore con le
tecniche della fotografia e tipografia, con un’associazione di
queste due categorie professionali che rispondono ad una precisa
presa di posizione sulla questione della tecnica artistica: sia
perché egli aveva iniziato la sua carriera nel mondo dell’arte
come stampatore ed amava dedicarsi al bricolage, ma poi perché
Artigiano è un termine che egli preferisce sempre ad Artista, un
anacronismo che per Didi-Huberman ha una precisa funzione critica
ed ironica, ma che possiamo interpretare anche come un modo
dell’artista per sovvertire il mondo dell’arte nobilitando una
delle categorie più al servizio di essa.
Certamente Duchamp fa suo l’aspetto più euristico dell’impronta,
in una metodologia che vediamo essere sempre più sperimentale e
piena di possibilità: sia la sua vita che la sua opera sembrano
essere affidate alla týche , al caso e all’occasione di creare
21
qualcosa di diverso, in un atteggiamento volto ad aprire il campo
tecnico del mestiere dell’artista.
Quando si affronta Duchamp, se ne tralascia l’analisi della
questione tecnica ma invece era una parte essenziale del suo
lavoro: la meticolosità era uno dei principali Leitmotiv. Didi-
Humerman, per rintracciare l’impronta come Esperienza (pag. 200)
mette in luce quanto fosse meditato, quasi ossessivo, il
procedimento delle opere duchampiane, realizzate in tempistiche
non convenzionali senza l’ansia della successiva vendita.
Guardandole se ne percepisce l’usura, lo stretto contatto con
l’artista, come se fossero ricoperte da una patina fisica che non
è altro che “un’emanazione del tempo e del contatto, una
brillantezza un po’ sporca legata al contatto e alla cura
eccessiva che Duchamp riservava alle sue opere”.
Il metodo di lavoro è definito dall’autore come Sperimentale,
preciso ma allo stesso tempo ispirato al caso, in cui la
componente euristica e manuale convivono in maniera molto più
forte di quanto non traspaia da una lettura superficiale: è lo
stesso artista che dichiara più volte di preferire la manualità
alla tecnologia (anche nel caso del cortometraggio muto “Anemic
Cinema” del 1925-26), un una sorta di <<ritorno al lavoro
manuale>> in cui Didi-Huberman collega il paradigma
dell’impronta.
Duchamp arriva addirittura a simulare la stampa, come nell’
”Assegno Tzank” del 1919 in cui falsifica a mano l’intero assegno
22
oppure a lavorare ossessivamente per riprodurre nella posizione
originale i foglietti delle Note al Grande Vetro, per poi crearne
settanta copie, passando così dalla forma accidentale alla forma
dell’accidente, in una concatenazione operazionale di serialità e
somiglianza.
A questo punto, appare chiaro che l’atteggiamento euristico
caratterizza il lavoro di Duchamp, lungi dall’essere “la cosa
qualsiasi” : la sua arte implica la questione del contatto, della
materia, dell’esperimento, della tecnica e, per rintracciare il
Paradigma dell’impronta, ancora una volta il critico deve scoprire
il contromotivo, ancora una volta bisogna spazzolare la storia
contropelo, cercando gli aspetti del calco più significativi
ovvero lo sdoppiamento, il raddoppiamento e il capovolgimento come
modi in cui può venire in contatto con la materia.
È contorta questa operazione critica ma non possiamo non essere
consapevoli delle molte analogie tra l’impronta (sia come
paradigma che come procedura) e l’arte di Duchamp, che si svela ai
nostri occhi sempre più anacronistica e quasi ieratica, frutto di
un lavoro senza tempo e restrizioni votato alla sperimentazione
infinita delle tecniche e dei linguaggi; il contatto attraverso
l’impronta è presente in molte opere, dandoci l’idea di una
manualità ossessiva fatta per gesti controllati e procedure
rigide, ma aperta a qualsiasi risultato, purché non sia nei canoni
dell’arte tradizionale.
Molte sono le opere in cui è presente l’aspetto dello sdoppiamento,
con l’implicazione della similarità, della simmetria dell’immagine
che Duchamp chiama “principio della cerniera”: pensiamo al “Grande
23
Vetro” e alle crepe nel vetro, uguali e simmetriche, che
diventeranno parte integrante dell’opera; pensiamo all’effetto
ottico del quadro “Chiaro di luna sulla baia di Basswood” o la
“Nonna dell’artista” o il finto palindromo “Anemic Cinema”. Si
tratta di opere in cui letteralmente c’è una cerniera che le
divide in due e le sdoppia, proprio come uno stampo.
L’impronta crea anche il raddoppiamento, visibile nelle opere in cui
c’è un altro leitmotiv cioè l’Alone, il nimbo che raddoppia la
figura e crea un’ombra, una silhouette a cui Duchamp stesso
collega sia termini ottici che termini tattili, in idea di
impronta che funge da cerniera, un cardine dialettico tra positivo
e negativo, forma concava e convessa. È proprio nello scarto tra
matrice e impronta che si colloca l’infrasottile, una quarta
dimensione dell’artista che permetteva di definire quella
percezione infinitesimale della materia che possiamo semplificare
come lo scarto tra la pelle e il corpo, l’involucro e la materia.
L’impronta, allo stesso tempo, capovolge sia le condizioni
morfologiche del suo referente (corpo convesso e concavo) ma anche
tutti gli altri sensi: Duchamp giocava con i capovolgimenti di
senso, attraverso giochi di parole, soprattutto a sfondo sessuale,
dalla grande valenza euristica; lo stesso vocabolario francese
sulla sessualità <<trabocca di espressioni legate non solo al
contatto (com’è ovvio) ma anche all’idea, o addirittura alla
tecnica, dell’impronta>>.
E così si ritorna a “Foglia di vite femmina”, con la
consapevolezza della sfida lanciata dall’artista alla scultura
tradizionale attraverso il paradigma dell’impronta: se la foglia
24
di vite aveva il compito di proteggere le parti intime femminili
rivestendole quindi in qualità di “oggetto di pudore”, ecco che
una volta staccata dal proprio referente inizia a turbare lo
spettatore perché è l’impronta capovolta di ciò che stava
coprendo. Didi-Huberman la definisce una “controforma” perché è
evidente che nasconde un enigma e svela un’intimità.
Soffermandoci sul processo di produzione di questa scultura,
sappiamo che l’originale fu regalata da Duchamp a Man Ray che,
girando un film, recitò una scena, che poi andò distrutta sulla
pellicola, in cui radeva i peli pubici di una modella: è come se
Duchamp avesse dato alla luce quella scena; ma al di là di questa
suggestiva ipotesi, è necessario capire se si tratti di un vero
calco.
Se fosse finto, allora dovremmo riconoscere all’artista una
straordinaria abilità tecnica di simulazione per aver conferito
un’aura reale all’oggetto; se si tratta di un vero calco, allora
dovremmo riconoscergli di aver conferito all’oggetto un’aura di
artificio che la classifica come opera d’arte. Non potendo sapere
quale sia la verità, è certo che Duchamp ha realizzato la
possibilità di capovolgere la somiglianza perché, pur non potendo
riconoscere per certo cosa essa sia, sembra un’impronta diretta.
L’artista poi realizzerà il negativo della scultura attraverso la
fotografia, invertendo il rilievo, e esporrà lo stampo utilizzato
per realizzare le molte copie della “Foglia di vite femmina”,
facendo emergere l’Impronta non solo come procedimento, ma come
sistema completo di generazione.
25
Il calco accende in Duchamp quello che Didi-Huberman definisce
come “Erotismo tecnico” ( pag. 252) cioè un interesse per
l’interstizio, per l’intersezione tra forma e controforma che
danno vita, attraverso il contatto, ad un simile allo stesso tempo
“nativo” e “negativo”. Pensiamo alla moltitudine di fac-simile
prodotti a partire da un modello costruito dall’artista (la stessa
“Fontana” ha origine da un modello di cartapesta poi rivestito di
metallo e verniciato).
Tornando quindi al Ready-Made, prendiamo in considerazione i
termini che l’artista utilizza per descriverlo: “idea”, “frase” e
“indifferenza tecnica”, ovvero le fasi ed i presupposti della sua
creazione, il tutto permeato da una stranezza della riproduzione
tecnica.
Il lavoro di Duchamp è pieno di contraddizioni apparenti, che
possiamo sempre ricondurre al continuo gioco dialettico che di
presenta come <<una maniera nuova ed elaborata – non binaria- di
produrre e pensare lo “stesso” (même)>>.
Ed è proprio su Même che si concentra Didi-Huberman per condensare
le sue operazioni artistiche: esprime il simile che dipende dal
differente e il differente che dipende dal simile, come i ready-
made sono tutti simili ma non uguali perché hanno una matrice
comune ma non possono essere cloni ma solo oggetti simili.
È in questo scarto della somiglianza che si innesta il concetto di
Infrasottile, parola onnipresente nel vocabolario duchampiano: dandone
una definizione letterale, potremmo definirlo come
26
“infinitesimale” ma in realtà non è altro che lo scarto che esiste
tra due oggetti apparentemente uguali, è la differenza
infinitesimale tra due oggetti prodotti in serie.
Per Didi-Huberman è attraverso la nozione di “infrasottile” che
possiamo cominciare a guardare l’opera di Duchamp, che ha cercato
di farlo emergere in modo subliminale in tutte le sue sculture ma
anche attraverso giochi di parole quasi nonsense, come “quando il
fumo di tabacco sa anche della bocca che lo esala, i due odori si
accoppiano per infrasottile”, rispecchiando il gusto di Duchamp
per il paradosso dell’impossibile. Sono molte le opere in cui
emerge la fenomenologia dell’infrassottile: “La septième face du
dè” del 1936 che rappresenta degli spellati di sigarette in cui la
materia friabile del tabacco è presentata come se fosse appena
uscita dalla matrice; “Aria di Parigi” del 1919 che esprime lo
scarto infrasottile tra la soluzione fisiologica presente
nell’ampolla poi svuotata per contenere l’aria, producendo poi un
dichiarato calco d’aria; la fotografia “Coltivazione di polvere”
del 1920 che, letta sotto l’angolazione dell’impronta e
dell’infrasottile, è l’opera di un lentissimo pellicolaggio
millimetrici attuato dalla polvere che si stratifica sui fili
incollati al “Grande Vetro”.
Per Didi-Huberman l’Infrasottile duchampiano ha la stessa valenza
dell’Aura benjaminiana ovvero
<<uno scarto visivo che indica il contatto, un’approsiazione che
tiene a distanza e fa filtrare ciò che Pierre Fédida ha definito
“il soffio indistinto dell’immagine”>>.
27
Tornando all’Impronta presente nelle sue opere, “With my tongue in
my cheek” del 1959 viene definito come un <<sistema portatile
dell’impronta>> ma differente dalla lettura indicale fatta dalla
Krauss perché adesso è interpretato come un rilievo d’ombra, in
base ad una dialettica dell’immagine per cui “se l’ombra è più
vicina al versante ottico o rappresentativo, il risultato sarà
quello di un disegno dell’occhio, del naso e della bocca quanto
mai convenzionale”, per rendere così visibile lo spazio del volto,
creando così in realtà un ritratto più tradizionale di quanto
sembri. Ovviamente il punto di vista di Duchamp sulla sua stessa
arte è disturbante e criptico, in un sistema di significati oscuri
anche per chi tenti un’analisi più approfondita.
<<Ora tutti i motivi determinano esattamente il campo tecnico –
paradossale – dell’impronta: essa replica uno stesso per
contatto, ma il risultato di tale replica dà vita ad uno scarto,
magari infrasottile, in cui le somiglianze prodotte sono così
precise e brutali, così strane ed inquietanti da diventare,
almeno per un pensiero dell’imitazione, inassimilabili. Se l’impronta
ci parla della ripetizione e del caso, se essa, nel contatto,
provvede allo scarto di una distanza infrasottile, e nella
somiglianza, allo scarto nell’inassimilabile, allora dovremmo
pensare all’impronta come uno scarto del tempo, come una
differenza anacronistica, come un contropelo della storia.
Marcel Duchamp utilizza per tutto ciò un termine molto preciso:
Ritardo>>.
Il ritardo possiamo definirlo come il paradigma temporale, un contatto
dei tempi che ci riporta all’anacronismo dell’opera duchampiana, che reca
28
in sé tutti i paradossi dell’impronta in un lavoro che di forme e
controforme attestate <<nel lavoro misterioso di uno scarto che si
imprime>>.
La seconda Ouverture “Su un punto di vista icnologico” chiude il
saggio di Didi-Huberman, dopo questo affascinante viaggio in cui
abbiamo scoperto l’impronta a livello paradigmatico, processuale e
procedurale; nasce come primigenia forma d’arte e diventa sempre
più importante e scandalosa, spesso messa a tacere e nascosta per
il suo non-essere nobile quanto un’Idea (o meglio, per terrore che
la sua facilità tecnica intaccasse l’aura dell’artista), criticata
per il suo alone mortifero, infine rivalutata da Rodin e
trasformata in una sorta di forma mentis da Duchamp, che ne ha
assimilato tutte le sfumature critiche innestando i suoi lavori
proprio sul paradigma del calco.
La forza critica dell’impronta, anzi, la sua problematicità
risiede proprio nelle sue contraddizioni: perché il calco si
riveli, bisogna che la matrice lo abbandoni, generando un’impronta
che produce sempre uno scarto, minimo ma disturbante allo stesso
tempo, frutto del caso e del tempo. Donatello, Rodin e Duchamp
sono gli artisti che hanno segnato le tappe del percorso critico
nel saggio e dimostrano che l’impronta non è mai stata
indifferente agli occhi di chi l’ha guardata, che fosse nascosta
tra le pieghe del panneggio di una scultura oppure spunto di un
procedimento apparentemente ossessivo e nonsense.
29
Ma qual è stato il suo apporto all’arte del Novecento? Per Didi-
Huberman il prodigio della procedura dell’impronta nell’arte del
XX secolo è stato quello di essere stata una tecnica anacronistica
che ha saputo rompere con la tradizione artistica tanto quanto
l’arte delle avanguardie, ma senza disintegrare o astrarre il
referente, semplicemente ritornando con un’aderenza al reale
sovvertendolo, ribaltando la mimesi attraverso il contatto.
Per Didi-Huberman è stato necessario far convivere l’anacronismo
con l’archeologia, in un testo critico che vuole uscire dai binari
convenzionali della critica d’arte fatta di polarità e
categorizzazioni rigide, ma soprattutto chiusa rispetto ad altre
discipline. L’approccio archeologico è stato necessario per non
fermarsi alle apparenze rintracciando subito il referente senza
soffermarsi sul processo: parliamo di una disciplina abituata ai
tempi dilatati, che permette di soffermarsi sulle rimozioni
dell’arte e sulle sue inattualità. Le rigidità degli orientamenti
critici ortodossi impongono punti di vista o troppo positivisti o
troppo “informi” per un’oggetto di studio tanto mellifluo e
singolare per l’unicità di ogni sua manifestazione, per cui
l’autore chiudendo il suo saggio con l’apertura al punto di vista
icnologico, ci lascia una lezione importante: la Forma è in
continuo divenire, è un processo che tiene conto del tempo e della
materia, ed è il risultato di un processo infinito, libero di
fluttuare tra Passato-Presente-Futuro e, soprattutto, libero da
qualsiasi pregiudizio facile o etichetta.
30



































![Georges Florovsky, "The Great Disruption: Byzantium and Rome" [translation into Serbian]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632305d161d7e169b00ce3fc/georges-florovsky-the-great-disruption-byzantium-and-rome-translation-into.jpg)