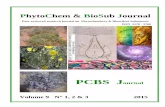Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]
Stefano Giazzon
Ira (e Ultio) nei Punica di Silio Italico
a Paolo Mantovanelli, con affetto
1.
A Tiberio Cazio Asconio Silio Italico è toccata la sventura di
essere ricordato per secoli solo per aver composto il più lungo epos
della letteratura antica (i Punica sono in diciassette libri per
complessivi 12.202 esametri).
Negli ultimi decenni, almeno a partire dal fondamentale e
innovativo testo di ALBRECHT 1964 e dalla più recente edizione critica di
DELZ 1987,1 si è avviata una fin troppo apologetica, in qualche caso, come
sempre, in questi frangenti, azione di recupero critico, volta a mettere
in evidenza, di volta in volta, i pregi della dictio poetica siliana,
1 Sono i due eventi decisivi per una nuova, equilibrata e innovativa valutazionedella poesia siliana: critico-interpretativo il primo; ecdotico il secondo.Forniamo qui una panoramica bibliografica sui Punica. Sull’epica latina ingenerale vd. Burck 1979. Per l’epica flavia e per l’estetica che la ispirò vd.rispettivamente Tandoi 1985: 154-169, Hardie 1993, Perutelli 2007: 167-224 eBardon 1962. Sulla vita di Silio cfr. Laudizi 1989: 9-26 e Vinchesi 2001: 78-79.Ricostruisce un quadro complessivo ancora valido delle fonti storiche egeografiche siliane Nicol 1936, da integrare con McGuire 1995 e Mezzanotte 1995.Per varie questioni di cronologia si rinvia a Wistrand 1956, Albrecht 1964,Venini 1972a, Ahl-Davis-Pomeroy 1986, Laudizi 1989: 27-54. Commenta i Punica, perla verità non sempre fornendo informazioni sufficientemente ampie e articolate,Spaltenstein 1986-1990. Su aspetti specifici del poema, oltre ai contributi giàcitati, cfr. almeno Ramaglia 1952, Vessey 1974, 1975, Santini 1983, Brizzi 1986,Neri 1986: 2026-2046, Küppers 1986, Ripoll 1998, Fucecchi 1990a, 1990b, 1992,1993, Laudizi 1991, Bocciolini Palagi 1991, Marks 2005. Puntuale la rassegnabibliografica curata da Ariemma 2000 che illumina sugli studi siliani compiutitra il 1984 e il 1999.
1
l’impo-stazione manieristica e allusiva della sua aemulatio,2 le spesso
originali dinamiche costruttive della sua scrittura epico-storica.3
Sgombrato il campo da molti luoghi comuni critici, è stato
finalmente possibile leggere il cospicuo disegno poematico dei Punica in
tutta la sua complessità e articolazione; sono state avanzate ipotesi
assai ragionevoli sulle verosimili origini padovane del poeta;4 sono
stati concretamente verificati i limiti della dialettica cura~in-genium e
si è provveduto a meglio precisare la contestuale, presunta, valutazione
negativa che inerirebbe la notissima riflessione pliniana su Silio;5 si è
sostanzialmente dimostrata l’esistenza di una non desultoria relazione
intellettuale del poeta con ambienti filosofici di orientamento stoico6,
che condizionarono potentemente alcune coordinate di riferimento, alcuni
assi di sviluppo tematico dei Punica e, in special modo, cosa che molto ci
interessa in questa sede, l’articolazione poematica della dialettica
ratio~passioni.
Sottolineo, in cauda, onde evitare di deludere orizzonti d’attesa
troppo raffinati, che il presente contributo intende solo costituire un
2 Cfr. Venini 1972b, Flammini 1983, Perutelli 1997.3 Cfr. Albrecht 1964, Santini 1983, Burck 1984, Ahl-Davis-Pomeroy 1986, Laudizi1989.4 Su cui soprattutto si veda Laudizi 1989: 9-26.5 Cfr. Plinio il Giovane, Epistulae, III. 7, dove, riferendosi al nostro, vienedetto: «scribebat carmina maiore cura quam ingenio». Per una revisione, se nondefinitiva, quantomeno estremamente plausibile, di alcuni lo-ci communes dellacritica siliana, tra cui questo, cfr. Santini 1983: 13-80 e Laudizi 1989: 9-26,i quali dietro il giudizio pliniano vedono essenzialmente il rispetto per unatradizione retorica e culturale che aveva valorizzato l’ένθουσιασμος (e con essola φύσις) rispetto alla τέχνη: da cui discende il privilegio accordatoall’ingenium sull’ars, pur non escludendo del tutto il rilievo di quest’ultima.Non si dimentichi che Quintiliano, Institutio oratoria, X. I.85-86 aveva parlato, nelcontesto di una synkrisis fra Omero e Virgilio, di cura e diligentia come categorieconsentanee al poeta latino più che al modello Omero, elogiato per altriaspetti. D’altra parte una semplice analisi grammaticale della frase pliniana dàconto del fatto che, laddove non si sia in malafede e non si interpreti lalettera secondo la logica del post hoc ergo propter hoc, non viene esclusoirrevocabilmente l’ingenium dal novero delle qualità poetiche di Silio: esso èsemplicemente subordinato (secondo coordinate che potrebbero comodamente essereapplicate a tutta l’epica di età flavia) all’ars. 6 Cfr. Albrecht 1964: 55-86, Danesi Marioni 1985, Billerbeck 1985 e 1986,Laudizi 1989, Matier 1990, Rocca Serra 1990, Brugnoli 1994.
2
punto di partenza per una più articolata riflessione sulla presenza delle
passioni aggressive e segnatamente dell’ira non solo nel poema siliano,
ma in tutta l’epica latina di età flavia.
2.
Ira, si sa, è parola topica nell’ambito della poesia epica fin dalle
origini del genere.7 Notava a questo proposito FILLION-LAHILLE 1984: 7: «La
colère: tel est le premier mot du premier monument de la littérature
antique», citando appunto il primo verso dell’Iliade.
Nell’ambito dell’epica latina, Virgilio (ri-)tematizza l’ira nello
spazio proemiale (luogo tradizionalmente molto esposto) del suo poema
(Aeneis, I, vv. 1-11),8 conferendole risalto mediante un raffinato
spartito di procedimenti figurali con cui dissemina il corpo fonetico
della parola nell’intera sezione,9 contestualmente segnalandone la
prominenza tematica e ideologica e la funzione strutturante per certe
dinamiche diegetiche.10
In seguito, Publio Papinio Stazio riprenderà la parola nel proemio
della Thebais, riferendola, come già accadeva in Virgilio, alla divinità
più frequentemente, topicamente, accostata all’esercizio di questa
passione, ovvero Giunone. 11
7 Cfr. Iliade, А, vv. 1-7.8 «Arma uirumque cano Troiae qui primus ab oris / Italiam fato profugus Lauinaqueuenit / litora, multum ille et terris iactatus et alto / ui superum, saeuaememorem Iunonis ob iram, / multa quoque et bello passus, dum conderet urbem /inferretque deos Latio, genus unde Latinum / Albanique patres atque altae moeniaRomae. / Musa mihi causas memora, quo numine laeso / quidue dolens regina deumtot uoluere casus / insignem pietate uirum, tot adire latore / impulerit. Tantaeneanimis caelestibus irae?».9 Ludus paronomastico ab oris-ob iram ai vv. 1 e 4 con ripresa a distanza al v. 10labores e polittoto al v. 11 con irae; radice [ir-] replicata in uirumque, uirum,adire, ma anche, con inversioni varie, in Troiae, primus, litora, terris, inferret, regina,impulerit, etc.. 10 Il peso specifico di Iuno come attante propulsivo per l’intero disegnopoematico virgiliano non può essere revocato in dubbio.11 Vd. Thebais, I, v. 11-12a: «unde graues irae cognata in moenia Baccho,/quod saeuaeIunonis opus».
3
Questi due illustri precedenti sono sufficienti a farci reputare
del tutto paradigmatica, nel perimetro epico (ma la stessa cosa si
potrebbe dire per l’ambito tragico), la mobilitazione lessicale della
passione aggressiva primaria par excellence,12 contrassegno di una
antropologia in cui spesso viene a coincidere con la dimensione
istintuale/passionale tout-court, sorta di adfectus metonimico che può essere
impiegato anche per parlare d’altro.
Occorre anche rilevare che l’ira è, fra le passioni negative,
quella più studiata, analizzata, interpretata, almeno a partire dal IV
secolo a. C.: nel momento in cui l’ira, che appartiene alla panoplia dei
valori fondanti l’etica eroica di matrice aristocratica, subisce un
aggiornamento nella concreta esperienza pratica, cresce il suo peso nel
contesto della trattatistica filosofica.13
Se già in Platone si trovano sparsi lacerti dedicati alla
cosiddetta parte irascibile della ψυχή,14 occorre risalire perlomeno alla
Retorica di Aristotele15 per vedere affrontata con un minimo di organicità
la quaestio dell’οργή.16
Dall’opera aristotelica emerge una interpretazione dell’ira come
passione moderatamente positiva, stimolante, di fatto governabile
razionalmente e addirittura in grado di produrre un qualche piacere:
12 Sulle passioni aggressive in generale vd. almeno Fromm 1975 e Mantovanelli1984 e 2001: in quest’ultimo vi è una puntuale ricostruzione delle differenzefra ira, saeuitia, furor, crudelitas, feritas. Per una interpretazione del ruolosemiotico delle passioni cfr. Greimas-Fontanille 1991 che si occupa peraltroessenzialmente di avarizia e gelosia. Per la collera vd. Greimas 1984.13 Cfr. Bodei 2003: 189-196. Occorre anche subito aggiungere che già nell’ambitodell’epica omerica si verifica l’aggiorna-mento del quadro di riferimento dellepassioni aggressive: Odisseo rappresenta perfettamente la capacità diautocontrollo ra-zionale rispetto ad Achille.14 Cfr. Platone, Repubblica, IV. 439 E, 440 A-E, 441 A-E, 442 A-C; IX. 581 A-D. Laposizione di Platone non è sostanzialmente troppo negativa nei riguardidell’ira, reputata educabile e controllabile dalla ragione.15 Cfr. Aristotele, Retorica, II. 1370b. 10 e soprattutto II. 1378a. 30-1380a. 4. 16 Il libro II dell’opera influenzerà largamente il pensiero sulle passioni diTeofrasto e della scuola peripatetica tutta. Naturalmente anche in altre operearistoteliche la questione delle passioni viene affrontata: vd. almeno, senzapretesa di esaurire l’argomento, Etica Nicomachea, 1105b. 22, 1105b. 24, 1149b.20, 1149b. 24 e De animo, 403a. 30 e 414a. 32.
4
l’ira, άλογος όρεξις, è collocabile tecnicamente nella fenomenologia
dell’όρεξις αντιλυπήσεος (= ‘desiderio di contraccambiare il dolore
provato’).17
In questa definizione sembra emergere, inscritta nel perimetro
dell’ira, la dinamica (eminentemente giuridica) della reciprocità
speculare di iniuria, vera o presunta, che scatena l’οργή e relativa
vendetta, valutata come necessario coronamento dell’impulso irato, sua
naturale conclusione, suo apice.18
L’erosione di queste posizioni eticamente ed assiologicamente
indulgenti nei confronti dell’οργή inizia già con Zenone, il fondatore
della scuola stoica,19 il quale, energicamente riposizionando la
questione dei πάθη al centro della riflessione filosofica nel perduto
Περί παθών e pur non occupandosi in maniera specifica dell’ira, contesta
la metriopatìa di ascendenza platonico-aristotelica:20 nessun valore
positivo può essere allegato alle passioni che andranno semmai
energicamente combattute.
Soprattutto con Crisippo la questione farà un significativo passo
avanti nei due trattati (anche questi perduti) Περί ψυχής e Περί παθών,
sui quali ci ragguaglia Galeno, a dimostrazione che la tassonomia delle
passioni ineriva anticamente anche, se non soprattutto (e in maniera
assolutamente peculiare), al pensiero medico e scientifico.21
17 Cfr. Aristotele, Retorica, II. 1382a. 12.18 Al di là di qualche oscillazione, non sembra revocabile in dubbio la pienalegittimità etica della vendetta per Aristotele: vd. Retorica, 1367a. 20 e 1370b.30. Dietro la dinamica ira-ultio si può forse ravvisare anche una nuovadeclinazione del rapporto potentia-actum. 19 Per le coordinate della riflessione stoica sulle passioni vd. Fillion-Lahille1984, Viansino 1988, Mantovanelli 2001, Bodei 2003: 202-231.20 Zenone definisce la passione come un άλογος καί παρά φύσιν ψυχής κίνησις,ovvero un «mouvement de l’âme déraisonnable et contre nature», secondo latraduzione di Fillion-Lahille 1984: 71.21 Per la posizione crisippea vd. Fillion-Lahille 1984: 51-118. Si tenga presenteche Galeno riporta passi dei trattati di Crisippo per contestarne le posizioni,non per valorizzarle. A Crisippo si deve, di fatto, la tassonomia stoica dellepassioni fondamentali: piacere, paura, dolore, desiderio.
5
Secondo Crisippo ragione e passioni dimorano entrambe nel cuore:
ammettendo che solo laddove ci sia la ragione possano esservi passioni, è
chiaro che la lotta per estirparle (nessun contemperamento essendo
pensabile) fosse concepita come l’obiettivo prioritario del sapiens: alla
buona, e molto accantonando, si può sostenere che per Crisippo la
passione sia una διαστροφή che deriva da un erroneo giudizio della
ragione, la quale cede per debolezza, sposando una falsa opinione.
Insomma: perché le passioni – che sono consustanziali alla ragione, non
esistendo per il filosofo stoico un’anima irrazionale – prendano il
sopravvento sulla ragione occorre che questa abdichi deliberatamente alla
propria funzione egemonica a causa di una errata valutazione.
Il rigore razionalistico del sistema crisippeo fu ammorbidito dalla
posizione della Stoa di mezzo (II-I sec. a. C.), che recuperò alcuni
tratti della speculazione platonico-aristotelica e che è perfettamente
rappresentata da Panezio, filosofo che molto influenzerà Cicerone,22 e
specialmente dal suo allievo Posidonio:23 questi non nega – come aveva
fatto Crisippo – che vi sia una parte irrazionale nell’animo umano
(επιθυμητικόν o παθητικόν): quando questa prenda il sopravvento sul
λογιστικόν, allora si sviluppa la passione vera e propria. Causa prima
delle passioni è che in noi vi sia il παθητικόν (ciò che rende possibile
lo scatenamento delle stesse); causa efficiente, che vi sia un giudizio
falso (e in questo Posidonio si adegua alla più ortodossa tradizione
stoica).
Quali che siano le talvolta eristiche dispute terminologiche e
filosofiche che oppongono zelatori di una scuola a corifei dell’altra,24
tutta questa varia trattatistica περί οργής confluisce nel De ira di
22 Non trascurabile il suo ruolo di mediatore di posizioni della filosofia greca:cfr. soprattutto, per la questione delle passioni, De finibus, III. 35, Tusculanaedisputationes, IV, De oratore, I. 51. 220.23 Su Posidonio rinvio ancora a Fillion-Lahille 1984: 119-199. Anche il Περίπαθών posidoniano ci è noto attraverso la mediazione di Galeno.24 Come si capisce, non possiamo qui nemmeno pensare di sfiorare l’argomento:trattati sull’ira scrissero anche, nel tempo, l’epicureo Filodemo di Gadara, ilpitagorico Sozione Alessandrino, Plutarco (Περί αοργησίας).
6
Seneca:25 questo dialogo è, data l’autorevolezza del filosofo e poeta
cordubensis, il non eludibile snodo e punto di partenza di qualsiasi
discorso sull’ira nel-l’ambito della riflessione filosofica e morale
antica, pagana e cristiana, latina e greca, dal I secolo d. C. in poi.26
3.
Senza pretendere di affrontare una superflua rilettura del
notissimo trattato senecano,27 mi pare opportuno gettare uno sguardo su
quei nuclei tematici, su quei nodi concettuali (e loro contestuale
articolazione terminologica), che utilmente possono essere usati per
chiarire alcune strategie di impiego del lessico dell’ira nei Punica
siliani, ritenendo ineludibile per un poeta doctus e φιλόκαλος28 quale
Silio Italico certamente fu, il quadro di riferimento antropologico,
psicologico, filosofico allestito sulla passione aggressiva regina dal De
ira senecano, tanto più per la contiguità – dato che diamo per acquisito
– fra il letterato patavino e lo stoicismo.
Seneca definisce l’ira, subito, «adfectus […] maxime ex omnibus
taetrum et rabidum» (I. 1.1) e – recuperando parzialmente il dettato
aristotelico (e ciceroniano)29 – «cupiditas doloris reponendi» (I. 3.3);
quindi, sottolinea il fatto che fanciulli e animali non possono essere
preda dell’ira, perché solo dove alberga la ratio vi è lo spazio per lo
scatenamento dell’impulso d’ira: le ferae hanno impetus, rabiem, feritatem,
incursum, ma non ira e luxuria (I. 3.4). Vedremo in seguito come questa25 Dove nel I libro Seneca recupera la lezione di Crisippo, nel II quella diPosidonio. 26 Cfr. Fillion-Lahille 1984, Viansino 1988, Guastella 2001: 9-30, Mantovanelli2001.27 Per cui si rinvia ancora a Fillion-Lahille 1984 e alla bibliografia iviallegata. Inoltre cfr. Viansino 1988 e Mantovanelli 2001.28 È sempre Plinio il Giovane, nell’epistola a Caninio (III. 7), a definire Siliocon questo culto grecismo.29 Vd. De oratore, I. 51. 220.
7
interpretazione delle passioni aggressive, di matrice crisippea, sembri
motivare alcune scelte di mobilitazione dei lessemi della famiglia
semantica dell’ira da parte di Silio epico.
Quando poi Seneca mobilita celebri figure storiche, anche se ormai
quasi dotate di un’aura mitica (Quinto Fabio Massimo, Annibale, Scipione
Africano) per esemplificare concretamente la dialettica ratio~passioni, ne
declina i tratti pertinenti secondo una gram-matica cui Silio guarderà
con attenzione per modulare gli attori del suo poema: prima, è chiamato
in causa Quinto Fabio Massimo Cunctator (tradizionale exemplum di
απάθεια), dicendo che seppe «cunctari et trahere et morari»30 (I. 9.5), e
che «iram ante uicit quam Hannibalem» (I. 11.5), che autorizza
l’interpretazione di Annibale come ipostasi diegetica dell’ira; poi,
viene invocato un altro dei protagonisti dei Punica: Scipione Africano (I.
11.6). Non vi è dubbio che Silio Italico abbia riattivato e variamente
declinato queste imprescindibili tessere senecane, trasformandole in
nuclei diegetici e naturalmente rifunzionalizzandole ed espandendole alla
luce del suo proprio disegno poematico.
Precisiamo subito che questa ipotesi ermeneutica non è in contrasto
né con la sicurissima dipendenza di Silio da Livio (e/o da altre fonti
storiche o annalistiche),31 né intende negare la dimensione di Aeneis
continuata32 che i Punica a più riprese esibiscono: dopo di che, però, urge
rendersi conto della non eludibilità di alcune riprese strutturali di
matrice senecana da parte del poeta flavio, magari anche solo per
30 Mora, moratus, morari, etc. è altra famiglia lessicale interessante inrelazione alle passioni, perché indica perfettamente l’indugio razionale, lacapacità di interdizione rispetto all’impulso, come dice Seneca stesso in De ira,II. 29.1: «maximum remedium irae mora est». Nei Punica la funzione tematica dellaparola è confermata da alcune occorrenze: Annibale sarà impatiensque morae (VIII,v. 4), iunctura che è precisa ripresa funzionale di una tessera tragica senecanamobilitata per descrivere il comportamento irrazionale di alcuni personaggi:cfr. Phaedra, v. 583 (riferito a Fedra) e Thyestes, v. 158 (nec patiens morae,riferito a Tantalo). Inoltre si veda XV, vv. 483-484, dove l’esercito romanoentrato nel campo spagnolo di Asdrubale «tenuitque moratas/a caede […] iras»,conseguenza dell’instaurazione dei nuovi valori del comando scipionico. 31 Su cui vd. specialmente Nicol 1936, Vinchesi 2001.32 Vd. Albrecht 1964: 144-184.
8
dimostrare che mediatore a lui più vicino di alcuni nuclei concettuali e
di alcune parole-chiave era stato appunto il filosofo e poeta cordubensis.
Procedendo lungo quest’asse si legga ancora De ira, I. 13.4-5 dove,
parzialmente riprendendo questioni già affrontate ad I. 9.1, Seneca
sostiene: «Sed ira, ebrietas, metus aliaque eiusmodi foeda et caduca
inritamenta sunt, nec uirtutem instruunt, quae nihil uitiis eget, sed
segnem alioqui animum et ignauum paulum adleuant. Nemo irascendo fit
fortior, nisi qui fortis sine ira non fuisset: ita non in adiutorium
uirtutis uenit, sed in uicem»: nessun ausilio può venire alla uirtus dalla
manipolazione delle passioni: queste, al limite (e ira è collocata non
per caso in posizione incipitaria), servono come surrogati di uirtus in
animi cui manchi appunto questo valore paradigmatico, per debolezza della
ratio. Questa considerazione costituisce uno dei cardini architettonici
dei Punica: fino ad un certo punto del poema l’ira (e, in parte, anche le
sue degenerazioni intensive: furor, saeuitia, rabies, crudelitas, feritas, etc.)
guida anche i comportamenti dei ductores romani,33 platealmente incapaci di
uirtus; dopo il compimento della formazione di Scipione come perfetto
sapiens, diegeticamente preannunziato – ancorché senza la dimensione
soteriologica che sembra consustanziale all’Africanus – da un altro,
diverso sapiens (Quinto Fabio Massimo Cunctator), il lessico dell’ira
diventa fortemente asimmetrico, finendo per caratterizzare solo la pars
punica e divenendo sempre più evanescente nei libri finali (quelli della
riscossa definitiva dei romani).
Proprio Scipione poi è protagonista di uno degli snodi diegetici e
simbolici più significativi dell’intero epos nel XV libro (vv. 18-128),
in cui viene letteralmente sottoposto (in un lavoro di manieristica
riscrittura dei modelli) a un erculeo bivio senofonteo in cui è costretto
a scegliere fra Virtus e Voluptas, prova che è anche una mise-en-abyme, se
non vediamo male, dello scontro antropologico e ideologico che oppone la
costellazione Roma-uirtus-ratio alla costellazione Carthago-uoluptas-ira dove,33 Publio Cornelio Scipione, Tiberio Sempronio Longo, Scipione Africano, GaioFlaminio, Gaio Terenzio Varrone, Gaio Claudio Nerone.
9
quali che siano i rapporti fra uoluptas e ira, qui mobilitate ad indicare
il perimetro delle pulsioni organiche e non organiche senza
distinzioni,34 i due referenti e i uerba tematicamente impiegati (uirtus vs
uoluptas) servono a connotare paradigmaticamente due inconciliabili
orizzonti antropologici, politici, etici, assiologici.
La dialettica Virtus-Voluptas, già tematica in Cicerone De officiis I. 118,
è l’epitome della conflittualità che sostanzia il poema siliano e
costituisce in piccolo la riarticolazione, sub specie allegorica, del cruciale
nodo che oppone la tradizionale diade del mos maiorum romano (ratio-uirtus)
alle passioni, spesso metonimicamente rappresentate dalla sola ira nei
Punica.35
Alla luce di questi vari dati, sembra evidente quanto Silio Italico
abbia tenuto conto di suggestioni del pensiero filosofico senecano, non
tanto o solo sul piano della materia del contenuto, quanto su quello –
pratico – della costruzione architettonica dei Punica e su alcune scelte
tematiche decisive.
Questo valore concettualmente paradigmatico di ira comporta un
cospicuo allargamento delle sfumature semantiche della parola e una sua
specifica duttilità anche tipologica. Si veda, pars pro toto e rinviando
per una più significativa disamina alle pagine seguenti, Punica, I, v. 101
«non ille [Annibale scil.] euhantis Massylae palluit iras», ove, al di là
dell’uso transitivo (raro) di pallesco, iras sta ad indicare qui
34 Per la distinzione fra pulsioni organiche (= istinti), filogeneticamenteprogrammate e al servizio della sopravvivenza di ogni specie vivente, e nonorganiche (= passioni), senza programmazione filogenetica e sostanzialmentesenza scopi biologici, cfr. Fromm 1975: 17-29.35 Ad autorizzare questa impostazione sembra essere proprio Seneca. Per esempio,in De ira, II. 12.2, dice: «nec magis quisquam eodem tempore et iratus potestesse et uir bonus, quam aeger et sanus», dove l’opposizione esclusivamalattia~sanità è invocata per caratterizzare l’irriducibilità dell’uomo inpreda all’ira all’uomo bonus. Ma cfr. anche De ira, II. 12.6, ove l’ira èdefinita maximum malum e ancora II. 36.6: «[…] maximum […] malum […] et omniaexsuperans uitia: alia paulatim intrant, repentina et uniuersa uis huius est.Omnis denique alios adfectus sibi subicit […]. Nullus adfectus est, in quem nonira dominetur», dove essa si configura come la pulsione aggressiva più terribilee sovradeterminata.
10
propriamente ‘furori cultuali’, ‘urla furenti’ e similia, riferibili alla
sacerdotessa del tempio di Didone in una fase di invasamento mistico.
Silio Italico attribuisce poi a Scipione, fino a un certo punto se
non francamente governato dalle passioni, perlomeno in una condizione di
προπαάθεια, un doppio tentativo di suicidio in Punica, IV, vv. 457-459:
«bis conatus erat praecurrere fata parentis/conuersa in semet dextra, bis
transtulit iras/in Poenos Mauors», dove il plurale iras, serve a
precisare, in eccentrica sintesi e certo in maniera espressivamente molto
efficace, il tentato doppio suicidio del giovane eroe.36
Due tessere, fra le tante che avremmo potuto scegliere, ad indicare
l’inusuale ampiezza dello spettro semantico assegnato ai lessemi dell’ira
nei Punica e punto di partenza per una più articolata, analitica
riflessione su consistenza quantitativa e tipologia qualitativa dei
medesimi nel perimetro del lungo poema siliano.
4.
Anzitutto, gettiamo uno sguardo all’architettura complessiva del
poema. Mi pare estremamente proficuo rileggere i Punica alla luce della
tipica evoluzione dell’accesso di ira (comprese la sua appendice
vendicativa e la relativa risoluzione finale di marca stoica, in questo
frangente), dalla condizione iniziale 1) di λύπη/dolor, provocato da una
species iniuriae, vera o presunta, alla fase 2) caratterizzata da un ictus
prerazionale aggressivo, alla fase 3) in cui la ratio concede il suo
assensus, provocando la trasformazione del puro impulso istintivo
(pulsione organica) in passione, che culmina 4) con l’attivazione del
36 Non si dimentichi che uno dei tratti distintivi dell’ira è per Seneca la suadisponibilità autodistruttiva: «in se ipsa morsus suos uertit» è detto, tra lealtre cose, a De ira III. 1.5 (ma cfr. anche De ira, I. 1.1 e I. 5.2). Nellatentazione suicida di Scipione io vedrei, a questa altezza, più che un debitonei confronti della diffusa e nota pratica stoica del suicidio filosofico (oltreal sicuro recupero intertestuale di Aeneis, X, vv. 680 ss. dove Turno per ben trevolte tenta di darsi la morte), piuttosto una decisiva influenza dei passisenecani sull’ira come passione masochistica e autodistruttiva. Essendo preda, aquest’altezza, di un pathetikòn ipertrofico, Scipione non sa ancora controllare ipropri impulsi.
11
meccanismo di ultio, per concludersi poi 5) con il recupero egemonico della
ratio: questo schema ci permette di interpretare i Punica come una
trascrizione macrotestuale delle dinamiche di attivazione-sviluppo-
conclusione dell’ira~ultio, cosa che conferma la funzione strutturale e
diegeticamente decisiva di questa passione nel poema.37
Il punto 1) della storia raccontata da Silio Italico, sua
ineludibile premessa diegetica, è lo stato di bisogno e frustrazione (=
λύπη) che accompagna l’iniuria subita da una costellazione di attanti,38
semicamente sussumibili sotto la categoria ‘irrazionalità’ (Iuno-
Annibale-Cartagine),39 contrapposti a una costellazione di attanti
riconducibili al nucleo semico40 della ‘razionalità’/‘virtù’ (Giove-
Scipione Africano-Roma).41 La fase 2) è caratterizzata dalla smisurata37 Quantunque scientificamente superato da ricerche successive, possiamosicuramente ritenere approssimativamente valido – per quanto concerne i Punicasiliani – il quadro teorico allestito dal comportamentismo e in particolar mododalla cosiddetta Frustration-Aggression Theory, avanzata nel 1939 da John Dollard (erivisitata negli anni Sessanta da Leonard Berkowitz: cfr. Fromm 1975: 96-99). Sipuò compendiare la teoria con questa frase di Dollard (vd. Fromm 1975: 96):«L’emergere di un comportamento aggressivo presuppone sempre l’esistenza dellafrustrazione e, viceversa, l’esistenza della frustrazione porta sempre a qualcheforma di aggressione». Si tenga presente poi quanto dice Greimas 1984: 218: «Inuna prima approssimazione possiamo dunque affermare che la collera si presentacome una sequenza che comporta una successione di: frustrazione > scontento >aggressività». A ciò aggiungiamo anche un altro cavallo di battaglia delcomportamentismo: il territorialismo (= istinto di difesa del proprio territorio,programmato filogeneticamente e fonte tra le principali di impulsi aggressivi),che spiegherebbe peraltro perfettamente – pur essendo esso pure idolum ampiamentesuperato (vd. ancora Fromm 1975: 154-158) – la fenomenale energia aggressiva diAnnibale e di Cartagine contro Roma. 38 Per la categoria interpretativa di attante vd. Greimas 2000 e 2001: 261-282.39 Giunone vuole vendicarsi dei troiani: cfr. Punica, I, vv. 42 ss. da mettere inrelazione con Aeneis, I, vv. 37-49. Per quanto riguarda Annibale: luogofondamentale per comprenderne la personalità è il formidabile ritratto propostoin Punica, I, vv. 56-69, che nasce dalla sistematica negazione dei valorifondamentali dell’eti-ca romana. Specialmente Ramaglia 1952 ha sostenuto lacompleta subordinazione funzionale di Annibale ai progetti di Giunone, così peròriducendo l’autonomia diegetica del ductor cartaginese. Sul ruolo di Giunone vd.anche Santini 1983: 13-80, sebbene in contesto non specificamente dedicato, eLaudizi 1989: 71-92. Per Annibale vd. Brizzi 1986 e Fucecchi 1990a, 1990b, 1992.Cartagine si identifica sostanzialmente con la continuità genealogica deiBarcidi.40 Per il concetto di sèma e nucleo sèmico vd. Greimas 2000.41 In Giove sono compresenti la dimensione di divinità capitolina platealmentefilo-romana e quella di dio che conosce i fata e che in qualche misura,
12
(antiadattiva a autodistruttiva)42 aggressività vendicativa accumulata da
Giunone ed Annibale verso i relativi competitori (Giove e i vari ductores
romani), che necessita di trovare una valvola di sfogo nelle fasi 3) e 4)
diegeticamente non disgiungibili ed dominate dalle battaglie (Ticino,
Trebbia, Trasimeno, Canne), con Canne che è il centro architettonico del
poema siliano: le passioni sembrano prevalere sulla ratio e sulla uirtus e
mettere in discussione la loro egemonia: ma alla fine, nella fase 5), è
la costellazione della razionalità a prevalere.43
Questa rapidissima ricostruzione isotopica sembra poter dare
adeguatamente conto di alcune dinamiche narrative seguite da Silio
Italico e tocca forse un livello di profondità superiore rispetto ad
altre ermeneutiche mobilitate per comprendere l’articolazione del
discorso epico dei Punica.
5.
Con inversione rispetto al titolo del presente contributo,
affrontiamo prima la questione della consistenza e tipologia del lessico
dell’ultio, notando subito che modesta è la presenza della famiglia
lessicale di ultio, ultionis e relativi esiti: quattordici occorrenze
complessive distribuite piuttosto uniformemente nel corso di tutto il
poema.
conoscendoli, li governa. Scipione è il competitore asimmetrico (lo è ancheFabio, ma meno decisamente) di Annibale, perché guidato da valori non omogenei aquelli che animano il condottiero punico; sul ruolo di Scipione si vedanosoprattutto Laudizi 1991 e Marks 2005. Roma è concepita come causa dellacondizione di dolor, responsabile dell’iniuria e minaccia all’autonomia politica diCartagine (già sconfitta in occasione del primo Bellum Poenicum).42 Annibale nel corso del poema è la perfetta ipostasi di questa tendenza.43 Occorre anche aggiungere che Iuno non si riconcilia coi romani, ma ottiene disalvare Annibale, il quale sconfitto sul campo a Zama senza combattere, rilanciala propria ira ai vv. 606 ss.. Intatta sembra la sua titanica energia (perchéintatta è la potenza delle passioni quando vengono espulse). Il poema non sichiude con una ricomposizione finale (impossibile essendo qualsivogliariconciliazione fra ratio e passioni) ma con il simbolico triumphus di ScipioneAfricano (= epitome della ratio).
13
Il motivo di questa scarsa consistenza deriverà, a mio avviso, dal
fatto che ultio è già referente inscritto nel perimetro dell’aggressività
irosa, suo naturale apice e sbocco, sua piena attuazione44 e perché, nel
caso specifico di Silio, essa viene diegeticamente sussunta sotto il
progetto vendicativo affidato da Giunone ad Annibale che è
antonomasticamente ultor, secondo le consolidate coordinate della
tradizione epica latina:45 talmente paradigmatica è la connotazione
vendicativa della figura di Annibale che l’autore dei Punica non sente la
necessità di dotare il lessico inerente l’ultio di un qualche particolare
rilievo tematico, sapendo che l’orizzonte d’attesa nel quale si inseriva
il suo poema non richiedeva ulteriori, precise puntualizzazioni sulla
natura, topicamente caratterizzata in questo senso, del peggior nemico
che Roma avesse avuto.
Qui di seguito le quattordici occorrenze:46
1. I, v. 539 > ultrix lancea2. II, v. 423 > ultricia bella47 3. II, v. 495 > statque dies … ultor48
4. IV, vv. 259-260 > parabat/ulcisci consul manes49 5. V, v. 655 > ultrix hora 6. VII, v. 488 > ultor patrisque necem50 7. VIII, v. 143 > ulta maritum51 8. IX, v. 496 > placet hic irae exitiabilis ultor52 9. XI, v. 63 > ultorem53 44 Vd. ancora Seneca, De ira, I. 1.1: «Ira est adfectus […] ultionis secum ultoremtracturae auidus».45 Come si evince dal rilievo profetico di Aeneis, IV, v. 625: «Exoriare aliquisnostris ex ossibus ultor».46 Imprescindibili Young 1964 e Wacht 1989-1990.47 Sono le guerre che Didone invoca nell’ecfrasi dello scudo di Annibale (cfr.Punica, II, vv. 406-452).48 Fides risponde ad Ercole che ne aveva chiesto l’intervento per scongiurare lacaduta di Sagunto, città a lui devota.49 Riferito a Publio Cornelio Scipione, padre del futuro Africano, in un contestodi feroce battaglia.50 Riferito a Scipione Africano all’interno della digressiva e stravaganteprofezia di Proteo, su cui cfr. Perutelli 1997.51 Rievocazione in sermocinatio, da parte di Anna Perenna, delle parole che avevanopreceduto il suicidio della sorella Didone, ad indicare la dimensionegenealogica di ultio inscritta nel destino dei Barcidi. Maritum è naturalmenteSicheo. Dietro avvertiamo ancora Aeneis, IV, v. 656 ulta uirum.52 Riferito al vento Volturno.53 Così è definito Annibale dal Senato di Capua che medita di staccarsi da Roma.
14
10. XI, vv. 527-528 > ille … larga/ultus caede dies54
11. XII, v. 272 > ostentant dis ultoribus enses 12. XII, v. 414 > ultrix harundo 13. XV, v. 205 > uobis ultor ego55 14. XVI, v. 593 > ultor patriaeque domusque56
Tralasciando gli usi quasi esclusivamente epitetici o esornativi, da
rilevare mi pare l’impie-go del nomen agentis maschile ultor, la più
frequente fra le parole riconducibili a questo campo lessicale nei Punica
e che reputeremmo tipico epiteto annibalico: per ben tre volte invece
(VII, v. 488; XV, v. 205; XVI, v. 593) viene associato a Scipione
Africano: a segnalare la natura ultrix di Annibale non servono eccessi
lessicali; basta davvero la perfetta profezia didonea di Virgilio, in un
gioco intertestuale decisamente vertiginoso.
6.
Andiamo ora a verificare, passando dal piano dei sèmi a quello dei
lessemi, la tenuta delle considerazioni compiute sopra a proposito di
ira. Ben diversamente articolato, sia sul piano della duttilità
semantica, sia su quello della pura consistenza, è rispetto a quello di
ultio, lo spartito delle occorrenze di ira, irae e di tutti i possibili
esiti.57 Per comodità, forniamo qui di seguito uno schema:
LIBRI OCCORRENZE DI
IRA
I 9
II 14
III 3
IV 10
V 17
VI 12
54 Riferito al primo bellum poenicum.55 Scipione Africano, che vuole vendicare padre e zio caduti in battaglia, siautodefinisce così.56 Ancora Scipione Africano.57 Utili si sono rivelati ancora Young 1964 e Wacht 1989-1990.
15
VII 12
VIII 6
IX 15
X 10
XI 12
XII 11
XIII 9
XIV 8
XV 5
XVI 6
XVII 7
TOTALE 166
Escludendo il libro proemiale, rilevantissimo sul piano tematico e
strutturale e per ovvie ragioni implicato nella posizione delle questioni
che verranno sviluppate nel prosieguo del poema,58 e i libri di raccordo
III e VIII, a forte caratura lirico-digressiva e in cui non vi è vero e
proprio avanzamento diegetico del racconto, gli altri libri sono tutti
coerentemente egemonizzati dalla rappresentazione di dinamiche
strategiche e belliche o, al limite, politiche, con i libri IX e X,
baricentro dei Punica, dedicati alla terribile battaglia di Cannae e gli
ultimi cinque che, compattamente, descrivono la riscossa romana e la
sostanziale sconfitta dei progetti della costellazione Giunone-Annibale-
Cartagine.59
Nove sono le occorrenze di ira nel I libro, alcune tematicamente
rilevantissime: a) tantarum causas irarum (v. 17), collocato in posizione
demarcativa in cauda all’esordio, riferito alle irae che hanno opposto
storicamente romani e punici;60 b) vv. 38-39: «Iamque deae cunctas sibi
58 Cfr. Küppers 1986 sul valore fondamentale della prima diade poematica.59 E del relativo nucleo sèmico di riferimento.60 Punica, I, vv. 17-19: «tantarum causas irarum odiumque perenni / seruatumstudio et mandata nepotibus arma / fas aperire mihi superasque recluderementes». Sul sintagma tantarum causas irarum Küppers 1986 ha costruito il titolo delsuo libro. Naturalmente qui irae vale, lato sensu, ‘furori’, ‘guerre’, ‘odîreciproci’…
16
belliger induit iras / Hannibal (hunc audet solum componere fatis)», dove
felice è l’immagine delle ire di Giunone, intese connotativamente come
‘abito’, ‘vesti da indossare’, che subito definisce il perimetro della
passione entro cui si affermerà la personalità annibalica nel corso del
poema, ne segnalano funzione e modelli di comportamento.
Di particolare interesse è poi anche I, v. 451 dove Silio dice
Hannibal ad poenam lentae mandauerat irae: stiamo assistendo all’assedio di
Sagunto, città foederata a Roma (e dunque sorta di anticipatorio doppio
dell’Urbe) e Annibale ha appena catturato il feroce saguntino Dauno e si
prepara a infierire su di lui. Se non vediamo male, qui c’è hypallagé
dell’aggettivo lentae grammaticalmente legato a irae, ma più propriamente
da riferire alla poena.61
Per quanto l’aggettivo lentus (= ‘tenace’, ‘resistente’, ma con una
connotazione anche sadica legata al rinvio del piacere della punizione
inflitta) possa far pensare a una com-ponente di feritas inerente la figura
(storica e mitica) di Annibale,62 va però subito aggiunto che
condividiamo SPALTENSTEIN 1986: X-XI e 74, quando, a proposito
dell’episodio, mette in guardia da una troppo facile, perché topica e
retorica, interpretazione di Annibale come epitome di bestiale saeuitia,
assai poco significativa a quest’altezza dello sviluppo del poema e di
fatto estranea alle strategie ideologiche e poetiche siliane,
senecanamente convinto che ira vi possa essere solo laddove c’è ratio.63
61 Secondo una tradizione illustre: cfr. Ovidio, Heroides, 3, 21-22: «Tot noctibusabsum/Nec repetor; cessas, iraque lenta tua est». Spaltenstein 1986: 74 rinvia, conqualche giustificata perplessità, a Virgilio, Aeneis, VIII, v. 488 dove si troval’i-sometrico e parzialmente omofonico longa morte.62 Per altri luoghi in cui la feritas di Annibale sembra messa in luce vd. Punica,VII, v. 69; X, v. 451; XI, vv. 250 e 378; XII, v. 566.63 E a questo proposito si veda il ritratto di Annibale (I, vv. 56-69) dovel’improba uirtus (v. 58) attribuita al condottiero punico non è negazione totale delfatto che in lui vi sia qualche, perversa, eccentrica forma di uirtus. Per lagiuntura, si rinvia certamente a Stazio, Thebais, IV, v. 319: «unde improbapectore uirtus?», nel contesto del dialogo fra Atalanta e il figlio Partenopeo, aqualificare peraltro ciò che eccede la misura e mostra audacia eccessiva.Inoltre vd. Seneca, Hercules, v. 39 indomita uirtus. Ancora Silio riecheggerà poiAeneis, XII, vv. 667-668 in I, vv. 493-494: «tum pudor accendit mentem, nec consciafallit/uirtus pressa loco», riferendosi sempre ad Annibale.
17
Annibale non è una belua, ma un formidabile avversario politico e
militare (e per questo il successo finale di Roma rifulge ancor più):
anche nel prosieguo del poema, la caratterizzazione del ductor barcide
come uomo in preda alle passioni non implica ipso facto una sua esclusione
dal perimetro del consorzio umano.
Anche in seguito, Silio riutilizzerà la iunctura (vd. Punica, VI, v.
699: «arridens Poenus, lenta proclamat ab ira» e XI, v. 378: «lentas
seruatus ad iras») sempre riferendola ad Annibale, come se lavorasse per
così dire automaticamente mediante la riproposizione inerziale di
epiteti, sintagmi, sequenze.
Da rilevare, naturalmente subito ribadendone l’impiego
eminentemente topico e retorico, i vari lessemi (nominali e/o verbali)
riconducibili al campo sèmico dell’ira mobilitati nel I libro dei Punica,
tutti inequivocabilmente riferiti ad Annibale: saeuus (v. 299), furit (v.
429), furibundus (v. 454), amens (v. 458), turbidus (v. 477), fera (v. 569) e
il notevole frendens luctatur di v. 494, che si può ricondurre ancora al
quadro sintomatologico proposto da Seneca sull’ira.64
Nel II libro si delinea il ruolo di Annibale come epitome di una
prodigiosa energia, prodotta dall’egemonia delle passioni, e principale
referente di ira (cui è possibile ricondurre, direttamente o
indirettamente, sei delle quattordici occorrenze reperite). Emerge come
dato tematico essenziale la potenza del χάρισμα negativo del condottiero
punico, le cui parole sanno suscitare iras nei soldati.65 E ancora:
poeticamente efficace mi pare l’immagine di un’ira così tremendamente
esplosiva, da non permettere ad Annibale (eroe dell’azione e non del
pensiero o della parola) di completare il discorso di minaccia prima
64 Cfr. De ira, I. 1.3 dentes comprimuntur e riferendosi alla ratio, di cui vienecelebrando le qualità, dice a I. 19.2 che non ha bisogno di digrignare i denti equindi è non frendens. Silio Italico riproporrà il motivo a XII, v. 636 a propositodi Annibale: «infrendens dum talia fatur».65 Punica, II, v. 55: «[milites scil.] stimulant clamoribus iras», alla fine di unavibrante rhesis di Annibale (vv. 44-53). Anche qui con estensione semantica:‘furori’, ‘ardori bellici’, ‘audacia’….
18
avviato: «gliscit Elissaeo uiolentior ira ty-ranno/[…]/nec plura effari sinit
ira, rotatque coruscum/mucronem» (II, vv. 239-243).
Il terzo è, come già detto, un puro libro di raccordo fra il
prologo bellico saguntino e le grandi battaglie dei libri IV, V, VI, VII.
Una specifica occorrenza di ira (v. 77: «uagitumque grauem atque irarum
elementa mearum») mi pare degna di nota: Annibale scorge sul volto del
piccolo figlio, nella patetica scena del discidium dalla moglie Imilce,
l’indizio sicuro della natura di stigma genealogicamente trasmissibile
dai Barcidi dell’ira vendicativa, garanzia della continuità nel male
della stirpe.
Con il IV libro si apre la compatta sezione che descrive la prima
fase del secondo Bellum Poenicum (quella delle sanguinosissime battaglie
del Ticino, della Trebbia, del Trasimeno). Pertanto cresce, in questa
sezione del poema, la consistenza della famiglia lessicale di cui ci
stiamo occupando, con alcuni significativi rilievi da fare: quando sia
riferita a Publio Cornelio Scipione e a Tiberio Sempronio Longo, ductores
romani, serve ad indicare l’incapacità di combattere Annibale, a questa
altezza, con armi autenticamente diverse da quelle che lui usa: questo
spiega le clamorose disfatte dell’esercito romano.66 Non si può
affrontare l’ira più potente di un nemico con altra ira: occorre prima
ridefinire, rimodulare i propri valori etici e filosofici; allora sarà
possibile produrre un’adeguata risposta politica e militare.67
Si vedano, per Scipione senior, Punica, IV, v. 262 surgit uiolentior ira che,
non per caso, è ripresa testuale di II, v. 239 (dove era Annibale il
referente, ad indicare platealmente continuità e contiguità di
ispirazione) e che verrà riproposta con variatio al v. 642: «sensit et
accensa ductor uiolentius ira». E inoltre: «nec detrectantem par ira
66 Si verifica in sostanza, sul piano delle dinamiche macrotestuali, unosconfinamento di alcuni attori riconducibili semicamente alla ratio nel perimetridel nucleo sèmico opposto (quello della passionalità).67 La rimodulazione etica implica essenzialmente, sulla base delle coordinatestoiche della sensibilità siliana, la purificazione dai πάθη e il ripristinodella funzione egemonica della ratio.
19
accenderat hostem» (IV, v. 272), ove l’ira furiosa del potente guerriero
gallo (= barbaro) Crisso viene messa in relazione con quella di uguale
intensità del console romano Scipione.
Infine: rabies (IV, v. 648) è quella che Scipione attribuisce al
fiume Trebbia, riproponendo la stultitia di chi come Ciro, esemplarmente
evocato da Seneca per il suo furor rabbioso in De ira III. 21, si era
adirato con il fiume Gynde, affluente del Tigri, e lo aveva deviato al
punto da farlo scomparire.68
Per Tiberio Sempronio Longo si osservi invece la tessera namque ira
coquit (IV, v. 538).
A questo stesso registro è accordata anche l’unica occorrenza,
tematicamente notevole, riferibile a Scipione Africano e di cui abbiamo
già detto (vv. 458-459: «[…] bis transtulit iras/in Poenos Mauors»).
Anche Scipione iunior, come gli altri duces romani, non è capace a questa
altezza diegetica di governare le passioni (ma con sicure
giustificazioni, essendo un puer predestinato e dotato di una uirtus
eccezionale):69 da ciò un doppio tentativo di suicidio. Proprio il
lessico dell’ira viene qui mobilitato per indicare, per così dire
metonimicamente, una fase di indecisione, incertezza, immaturità nella
vicenda, peraltro fulgida, del futuro Africano:70 non si è ancora attuato
il passaggio definitivo del puer nel campo sèmico della ratio.
Libro della cruentissima battaglia dal Trasimeno, ciò che
contraddistingue il V è il fatto che, proseguendo il percorso intrapreso
nel libro precedente, il principale referente di ira sia (assieme al
consueto, topico Annibale) un altro consul romano Gaio Flaminio che,
allineandosi lui pure alla logica aggressiva del condottiero barcide,
scende sul suo stesso perimetro, facendo prevalere il παθητικόν sul68 Adirarsi con gli elementi naturali non ha, va da sé, alcun senso e dimostrapiuttosto l’irrazionalità di chi indulge in questi atteggiamenti: l’analogiadunque ha una precisa funzionalità. Per il motivo del fiume (e della connessapotamomachìa) vd. l’eccellente Santini 1983: 81-140.69 Come dimostra qualche verso sotto, quando, nuovo Enea, salva il padre feritocaricandoselo sulle spalle.70 I Punica sono anche, certamente, il Bildungsroman di Scipione Africano.
20
λογιστικόν, vale a dire la panoplia di (dis)-valori punici sui valori
romani e da ciò viene sopraffatto, perché è un romano che sceglie di
gareggiare per la pars delle passioni, esattamente come avevano fatto P.
Cornelio Scipione e T. Sempronio Longo (e parzialmente Scipione iunior)
nel libro precedente: illuminante, a questo proposito, è che sia
nientemeno che Iuno,71 a scegliere Gaio Flaminio in qualità di comandante
dei romani.72
Ecco le occorrenze riferite a Flaminio:
acrius hoc accensa ducis surrexerat ira (V, v. 105)
[…] sed est uestrum cui nulla dolorispriuati rabies, is uero ingentia sumate medio, fodiant quae magnas pectus in iras (V, vv. 157-159)
turbidus (V, vv. 165 e 380)73
[…] socio te caedis et iras (V, v. 183)74
Naturalmente, l’altro catalizzatore del lessico dell’ira è Annibale: ai
vv. 344-345 troviamo «Aduolat interea fraterni uulneris ira/turbatus
Libyae ductor» (dopo il ferimento di Magone suo fratello); al v. 558
«pulchro Mauorte accensus in iram»; al v. 604 «iraque anhelatum proturbat
pectore murmur» (dopo la morte del prode punico Sicheo).
Per concludere e suggellare: ciò che balza agli occhi è proprio la
sostanziale contiguità e sovrapponibilità del vocabolario dell’ira
impiegato per Annibale e per i vari duces romani che gli si oppongono, ad
indicare certo – sul piano delle dinamiche diegetiche – una non precisa
distinzione dei loro tratti, una perniciosissima confusione fra nucleo
sèmico delle passioni e nucleo sèmico della ratio.
71 Che nel poema siliano è interpretabile come ipostasi dell’ira.72 Vd. Punica, IV, vv. 708-710: «hunc [Gaio Flaminio scil.] laeuis urbi genitum adfatalia damna/ominibus parat imperio Saturnia fesso/ductorem dignumque uirumueniente ruina»73 Significativo epiteto annibalico di I, v. 477 ad indicare una sostanzialeidentità fra i due caratteri.74 Rivolto al soldato romano Equano.
21
La iunctura poetica implicata con il lessico d’ira forse più felice
del V libro (e una delle migliori nell’intero poema) è uiridissimus irae di
v. 569.75 Straordinaria mi sembra la concentrazione, modernissima,
dell’inusuale costrutto (hapax) realizzato con un genitivo di relazione
che Silio userà altre volte, sempre in riferimento all’ira: si vedano XI,
v. 363 pulcherrimus irae e XVII, v. 307 laetissimus irae. Si tratta di iuncturae di
difficile restituzione (‘verdissimo d’ira’?, ‘bellissimo d’ira’?,
‘lietissimo nell’ira’?) e costituiscono una sorta di σσφραγίς dello stile
siliano.
Dopo un libro (il VI) in cui sembra prevalere un uso esornativo-
digressivo dei lessemi dell’ira, entra finalmente in scena nel VII il
primo competitore credibile di Annibale,76 investito da Giove stesso
della funzione di dictator:77 Quinto Fabio Massimo Cunctator.
Che Annibale sia perfettamente consapevole della infida
pericolosità di un tale avversario, nuovo rispetto ai ductores romani che
lo avevano preceduto e con i quali il Barcide poteva confrontarsi sullo
stesso terreno minato dalle passioni aggressive (e nondimeno con un
surplus di energia vendicativa che gli derivava dal fatto di essere75 Spaltenstein 1986: 379 dice, banalmente, ad locum, dopo aver notato che lagiuntura est unique: «‘Viridissimus’ désigne la jeunesse et contraste avec son [diLabico scil.] âge». Sostanzialmente, il commentatore fa rientrare la tournure nelloschema del genitivo di relazione che ha buona produttività nei Punica a partireda fideique sinister e deuius aequi che troviamo nel ritratto di Annibale (I, vv. 56 e57), per cui si rinvia a Spaltenstein 1986: 12-13. Il sintagma è riferito aLabico, guerriero anziano, ma ancora dotato di intatta energia, che Annibaleucciderà poco oltre. Il contrasto fra senilità corporea ed energia interiore(talvolta velleitariamente, volontaristicamente mobilitata) è riproposto poi aPunica, VII, vv. 3-4 in cui, a proposito di Quinto Fabio Massimo, viene dettouiridique … senio, che mi pare ancora molto bello. 76 Peraltro preannunziato nelle sue coordinate di prudentia già a I, v. 679: «atFabius cauta speculator mente futuri».77 In netta antitesi con quanto era accaduto a Gaio Flaminio, scelto da Giunone.Cfr. Punica, VI, vv. 609-618: «[…] dat numine magno / Aeneadis mentem gremiodeponere tuto / Romuleam tandem Fabioque salutis habenas / credere ductori. cuipostquam tradita belli / iura uidet, ‘non hunc’ inquit ‘superauerit unquam /inuidia aut blando popularis gloria fuco, / non astus fallax, non praeda aliusuecupido. / bellandi uetus ac laudum cladumque quieta / mente capax. par ingeniumcastrisque togaeque’. / sic genitor diuum recipitque ad sidera gressum». Come sivede, sono le armoniche dell’assenza di passioni a sollecitare Giove adindividuare nel Temporeggiatore il perfetto avversario di Annibale.
22
aiutato da Giunone), lo rivelano questi illuminanti versi: «[…] feruore
carentes/angebant anni fraudique inaperta senectus» (VII, vv. 25-26) (=
‘lo angosciavano gli anni [di Q. Fabio] liberi dal fervore delle passioni
e una vecchiaia chiusa alla frode’).
Q. Fabio è la perfetta sintesi attanziale dell’απάθεια stoica nel
poema. La sua arma più potente è la mens impenetrabilis irae (come proprio
Fabio dice, in un significativo corto-circuito diegetico, a proposito di
un altro grande eroe romano, Furio Camillo, da lui rievocato con questa
iunctura a VII, v. 561). E ancora: segnalando uno scarto decisivo rispetto
ai predecessori (o incapaci o troppo audaci), è expers irarum (vv. 516-517).
Annibale fa molta fatica a confrontarsi sul piano strategico con
Fabio, perché non riesce a prevederne le mosse e a comprenderne le
intenzioni, essendo antropologicamente e psicologicamente così diverso da
lui.78
Per questo i furori del ductor punico diventano per la prima volta
nel poema, dal punto di vista romano di Q. Fabio, ‘vani’, ‘vuoti’:
«Cassarum sedet irarum spectator et alti / celsus colle iugi domat ex-
sultantia corda / infractasque minas dilato Marte fatigat / sollers
cunctandi Fabius […]» (VII, vv. 123-126). E le sicurezze strategiche che
lo hanno accompagnato fin qui vacillano: «iamque dolore furens ita secum
immurmurat irae» (v. 146), dove notevole, per caratterizzazione
psicologica, è questo Annibale che tra sé e sé si rivolge alla propria
ira dotata quasi di plastica consistenza, sorta di δαίμων cui rivolgersi
per una perversa, rovesciata recognitio animi.
Fabio è totalmente asimmetrico rispetto ad Annibale, perché ha
compiuto un percorso di purificazione dalle passioni, stoicamente
sconfitte (e su questo Silio insiste ripetutamente): per questo risulta
spiazzante per il punico.
78 Già Livio, sul piano della riflessione storiografica, lo aveva benissimoevidenziato: cfr. Ab urbe condita, XXII. 12. 5-7: «ceterum tacita cura animumincessit, quod cum duce haudquaquam Flamini Sempronique simili futura sibi resesset ac tum demum edocti malis Romani parem Hannibali ducem quaesissent».
23
E si veda come esemplarmente la dialettica Q. Fabio~Annibale sia
riarticolata da Silio alla luce dell’op-posizione sèmica fra ratio/uirtus e
passioni: «[…]. omnia namque/dura simul deuicta uiro, metus, Hannibal,
irae,/inuidia, atque una fama et fortuna subactae» (VII, vv. 577-579),
vero e proprio catalogo allegorico di uitia in cui Annibale si colloca
(lui concretissimo) fra metus e irae.
Da rilevare, per concludere, che inizia nel settimo libro quel
processo di progressiva trasformazione di Annibale in fera, alla luce
della riaffermazione del mos maiorum e della contestuale espulsione delle
passioni dal quadro assiologico ed etico di riferimento: al v. 401 il
punico viene paragonato ad un Libycus leo (v. 401) che cova iras cum fraude (v.
403).
L’VIII libro è di puro raccordo, proprio come il terzo.
Tematicamente significativo è il fatto che vi ricompaia un motivo che
sarà sviluppato soprattutto nel libro successivo: quello dell’ira deorum,
quasi ad anticipare la natura niente meno che cosmica dello scatenamento
d’ira che tanta parte avrà nelle vicende cannensi: «Placata tibi manet
ira deorum», dice Anna Perenna, rivolgendosi ad Annibale al v. 213;
questi le fa eco ai vv. 234-235 «[…] placauimus iras/caelicolum».
Anche nella pars romana c’è chi mobilita e invoca gli dèi: Lucio
Emilio Paolo consul, chiedendo conto a Q. Fabio Massimo della follia del
comportamento del collega Gaio Terenzio Varrone, incapace e troppo
impulsivo, esclama: «sed quaenam ira deum?» (v. 332). La sottile azione
di spostamento dal piano degli uomini a quello degli dèi79 è annunciata
da queste tessere microtestuali che confermano quanto l’uso del lessico
dell’ira sia importante per capire l’architettura complessiva del poema,
lo sviluppo delle sue dinamiche di senso, l’articolazione della vicenda.
Il libro IX rappresenta lo snodo decisivo della fabula, il suo
baricentro: vi si racconta la battaglia di Canne. Fin da subito notiamo
che il console Gaio Terenzio Varrone, collega di Lucio Emilio Paolo,79 Il peso specifico delle divinità tradizionali è già messo in rilievo nei primiversi dei Punica: cfr. I, vv. 1-20. Sulla questione cfr. Tandoi 1985 e Neri 1986.
24
viene descritto su un piano di simmetria morale e psicologica rispetto al
nemico ed è dominato dalle passioni (come il predecessore Gaio Flaminio
di cui è una sorta di duplicato): il v. IX, 23 nam turbidus ira è un
plateale prelievo intratestuale da Punica, I, v. 477 (= Annibale); II, vv.
619 (= un anonimo saguntino che sta per compiere il nefas del matricidio);
V, vv. 165 e 380 (= Gaio Flaminio). Illuminante in questo frangente, come
in altri, l’uso di uno spartito lessematico semicamente consolidato,
investito della funzione di articolazione e/o mise en relief di importanti
isotopie poematiche.
Tutta la seconda parte del libro è caratterizzata dalla pesante
intromissione degli dei nelle vicende della battaglia: l’ira diventa un
fatto divino (Giove, Pallade, Giunone, Marte divengono referenti di
atteggiamenti aggressivi).
Dopo la vittoria di Canne, Annibale vive la propria personale
apoteosi. Il libro XI rappresenta, nell’eco-nomia strutturale del poema,
un momento delicatissimo perché, contraddicendo i fata, sembra che le
passioni possano prevalere sulla uirtus, che l’ira e il furor abbiano il
sopravvento sulla ratio.
L’ira domina ancora questo orgogliosissimo Annibale a cominciare
dall’ingresso a Capua ove subito è costretto a fronteggiare, con la
consueta energia aggressiva, la contestazione del saggio Decio Magio:
multa feta gerens ira praecordia Poenusadstabat muris […] (XI, vv. 203-204)
[…] suffuderat orasanguis, et a toruo surgebant lumine flammae.tum rictus spumans et anhelis faucibus actauersabant penitus dirum suspiria murmur.sic urbem inuectus […]effundit cunctam rabiem irarumque procellas. (XI, vv. 218-224)
Nella seconda sequenza testuale si noterà come la fisiologia dell’ira sia
modulata secondo armoniche ancora una volta senecane (De ira, I. 1.3-5).80 80 Qualche verso sotto Annibale sarà nuovamente paragonato a un leone cheincrudelisce immane sub ira (v. 244). Prosegue, dunque, quella progressivaevoluzione del ductor punico in fera che è il naturale preludio alla sua
25
Gettando uno sguardo agli usi più poeticamente originali del
lessico impiegato, notevole mi sembra la quasi ossimorica tournure
pulcherrimus irae (v. 363),81 riferita al figlio del capuano Pacuvio che, per
un momento, progetta di assassinare Annibale, nuovo alleato della città
campana, salvo poi desistere:82 contraddicendo una consolidata tradizione
che aveva descritto la deformata e grottesca bruttezza dell’irato,83 qui
assistiamo ad una spettacolare forzatura fisionomica (di matrice
ideologica?): il puer che prepara l’omicidio politico è non già, come ci
attenderemmo, brutto e deforme, bensì pulcherrimus.84
E Capua rappresenta, sotto molti punti di vista, lo zenith della
stella annibalica: dopo la fatale mollitia nella quale l’esercito punico è
precipitato durante la sua permanenza nella città, Annibale farà molta
fatica a rilanciare le sue azioni di guerra: da qui inizia il declino
dell’eroe cartaginese.
Nel XII libro il condottiero è definito furens (vv. 267 e 281) e ferox
(vv. 455 e 541); non più irae bensì furores (v. 683) sono quelli che lo
espulsione dalla storia e omologamente dal poema, secondo precise coordinateideologiche ed etiche di matrice stoica.81 Su cui già abbiamo detto supra, pp. 15-16.82 L’episodio introduce, nel perimetro del poema siliano, non senza ambiguità,peritanze e cautele, forse prodotte dal contesto politico, il temarilevantissimo del tirannicidio.83 Cfr. De ira, I. 1.3-5: «Ut scias autem non esse sanos, quos ira possedit, ipsumillorum habitum intuere. Nam ut furentium certa indicia sunt audax et minaxuultus, tristis frons, torua facies, citatus gradus, inquietae manus, coloruersus, crebra et uehementius acta suspiria, ita irascentium eadem signa sunt:flagrant ac micant oculi, multus ore toto rubor exaestuante ab imis praecordiissanguine, labra quatiuntur, dentes comprimuntur, horrent ac surriguntur capilli,spiritus coactus ac stridens, articulorum se ipsos torquentium sonus, gemitusmugitusque et parum explanatis uocibus sermo praeruptus et complosae saepiusmanus et pulsata humus pedibus et totum concitum corpus magnasque irae minasagens, foeda uisu et horrenda facies deprauantium se atque intumescentium.Nescias utrum magis detestabile uitium sit an deforme. Cetera licet abscondereet in abdito alere: ira se profert et in faciem exit, quantoque maior hocefferuescit manifestius».84 Per una più equilibrata valutazione ideologica dell’episodio occorre tenerepresente che a) Annibale è un τύραννος straniero e b) l’assassinio è soloprogettato ma non attuato. Certo l’epiteto pulcherrimus fa pensare a una platealeadesione di Silio alle ragioni dell’eroico (ma a metà) puer di Pacuvio.
26
incalzano dopo il reiterato tentativo di conquistare i moenia Romae85 a
descrivere un innalzamento della temperatura del vocabolario siliano
inerente le passioni aggressive perfettamente omologo alla crescita della
frustrazione e della rabbia di Annibale. E ancora – dopo la similitudine
con il leone dei libri precedenti – si assiste alla mobilitazione di
un’altra tessera ferina (la tigre caucasica), riferibile ad un’ira
bestiale (ira … immani si dice al v. 456), non più arginabile e che sempre
più viene connotata nei termini della rabies (vv. 430 e 462).86
La conclusione del libro è un altro snodo decisivo
nell’architettura del poema: Iuno è costretta, su precisa e imperiosa
ingiunzione di Giove, a fermare Annibale ’υβριστής che pervicacemente
insiste nel voler conquistare Roma (vv. XII, 701 ss.): è un luogo
simbolicamente molto importante dei Punica, sorta di coupure che segna un
punto di non ritorno per la direzione della storia: Giove, principio
cosmico maschile (= ratio/uirtus) richiama Giunone, principio cosmico
femminile (= passioni e ira), e ribadisce il proprio ruolo egemonico: non
poteva essere più esibita, sub specie allegorica, la nuova valorizzazione
tematica della dialettica ragione~passioni: queste ultime, per quanto
stimolate da un’indo-mabile energia, non possono più opporsi ai fata. Ed è
singolarmente indicativo che, da questo punto in poi, sempre meno
importante sia il ruolo di Annibale e, contestualmente, sempre meno
significative siano le occorrenze di ira.
Il XIII avvia l’irresistibile e fatale riscossa romana (la
riconquista di Capua è un primo segnale). Scipione Africano – passando
attraverso il percorso rituale e conoscitivo della catabasi, che occupa
buona parte del libro (vv. 395-895) – acquisisce lo status di primus inter
pares rispetto agli altri duces romani, si palesa come Dardanus ductor (cui
Silio aveva alluso a Punica, I, vv. 14-15) e come uera Iouis proles (IV, v.
475): da questo momento in poi è lui il protagonista assoluto del poema
85 Motivo ritenuto centrale da Albrecht 1964: 24-46.86 Che è appunto attribuito delle fiere, ma non dell’uomo in De ira, I. 3.4.
27
segnando anche l’affermazione definitiva del nucleo sèmico ratio/uirtus
sulle passioni, sempre più messe in ombra, emarginate, espulse.87
Le occorrenze di ira sono decisamente poco significative sul piano
tematico,88 perché rispetto al quadro assiologico su cui hanno basato
erroneamente le loro battaglie precedenti, altri sono i valori con cui i
Romani ora conquistano le città e trattano i prigionieri nell’ottica
genuinamente apologetica di Silio: prevale la concreta pratica della
clementia stabilita dalla ratio come criterio-guida su cui impostare una
nuova politica, ormai disancorata dalla logica delle passioni.
Proseguendo il discorso avviato nel precedente, il XIV libro
esibisce il tentativo, riuscito, da parte del nuovo console Marco Claudio
Marcello, di estirpare da perfetto stoico,89 le ire dai petti dei soldati
romani che assediano Siracusa, secondo un’ideologia filantropica
impostata sulla clementia che fa prevalere le ragioni del logos e in cui
sentiamo operare, in piccolo, le linee del disegno architettonico
complessivo del poema: si veda XIV, vv. 182-183: «[…]sedare
monendo/pectora caeca uirum atque iras evellere auebat», dove il
comandante si comporta da sapiens, e la non meno illuminante, bellissima
sequenza di XIV, vv. 666-675:
His tectis opibusque potitusAusonius ductor [Marcello scil.] postquam sublimis ab altoaggere despexit trepidam clangoribus urbeminque suo positum nutu, stent moenia reguman nullos oriens uideat lux crastina muros,ingemuit nimio iuris tantumque licerehorruit et propere reuocata militis ira
87 Nessun dubbio può esservi sulla natura di psicomachia che questa vittoriasulle passioni possiede. 88 Qualche diegetico rilievo mi sembra avere a XIII, vv. 391-392: «[…] pietas iratasinistris/caelicolis furit […]», che costituisce la premessa della catabasi diScipione (il quale vuole rivedere il padre e lo zio uccisi in battaglia inSpagna): qui, poi, tra le umbrae incontrate vi è Amilcare, padre di Annibale,«cui frons nec morte remissa / irarum seruat rabiem» (XIII, vv. 733-734), adindicare iperbolicamente, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la naturagenealogica dell’ira dei Barcidi, sorta di μίασμα trasmissibile.89 Marcello, giova ricordarlo, si suiciderà nel corso del libro XV. Sulpersonaggio, davvero notevole, vd. Albrecht 1964: 78, Ahl-Davis-Pomeroy 1986:2536-2540, Vinchesi 2001: 55-56.
28
iussit stare domos indulgens templa uetustisincolere atque habitare deis. sic parcere uictis pro praeda fuit, et sese contenta nec ullosanguine polputi plausit Victoria pennis.
Qui il brivido del potere, che per un momento sfiora Marcello, fornisce
lo spunto per una memorabile meditatio sull’orrore della distruzione e
trasforma la sete di vendetta in clementia.
A strutturare gli ultimi libri del poema è proprio la sistematica
disfatta delle passioni, la loro interdizione da parte di una ratio/uirtus
finalmente soverchiante, capace di affermarsi definitivamente su di esse
e di sostituirle nel cuore e nei cervelli dei protagonisti, finalmente
depurati dalla perniciosa influenza dei πάθε. Negli ultimi tre libri vi
sono tante occorrenze di ira quante ne avevamo trovate nel solo libro V:
una evanescenza progressiva e irresistibile che dipende in toto
dall’affermazione della costellazione attanziale Giove-Scipione-Roma e
dal nucleo sèmico di riferimento: la ragione. Domina ideologicamente il
libro XV la vicenda paradigmatica di Scipione al bivio (= novello
Ercole),90 che sceglie le ragioni della Virtus contro i falsi allettamenti
della Voluptas: vera e propria unità sintagmatica dotata di larga
autonomia e inserita digressivamente come pars pro toto dello sviluppo
ideologico della fabula.
A verificare sul campo la tenuta di questa opzione etico-ideologica
di Scipione in favore della Virtus (di una uirtus che andrà intesa non tanto
90 Eroe che era stato risemantizzato secondo coordinate stoiche, come si evince(a tacere d’altre opere) almeno dallo Hercules furens senecano e dallo Oetaeuspseudosenecano e che quindi autorizza una interpretazione stoica di Scipionestesso. Non va dimenticato che Herakles/Hercules era diventato, in area romana e nelcontesto della cultura imperiale, il perfetto duplicato simbolico del princeps:legatus di Giove, duramente avversato da Hera/Iuno, nelle sue fatiche siriconoscevano le curae e gli impegni del potere. Da tempo peraltro il personaggiogodeva di straordinario favore per la sua natura antitirannica e ben presto losi interpretò anche come paradigma del trionfo sulle passioni: cfr. almenoEpitteto, ΔΙΑΤΡΙΒΑΙ, II. 16. 45-47. Tutti questi elementi fanno comprendere comedietro la scelta di mobilitare un episodio così strutturato quale il bivioerculeo vi fossero ben precise sollecitazioni diegetiche e ideologiche. Per unainterpretazione che tende a ridimensionare il valore allegorico dei monstraaffrontati da Ercole nel dodeclato vd. proprio Seneca, De constantia sapientis, 2.
29
come eroica quanto piuttosto come umanistica) è XV, vv. 483-484:
«tenuitque [Scipione scil.] moratas/a caede iras»: un esercito
(ri-)educato ai valori della clementia e della tolleranza è quello che
pretende il condottiero romano che trattiene da incomposti scoppi d’ira i
propri soldati impegnati in Spagna, proprio come aveva fatto Marcello a
Siracusa. Su questa falsariga, nemmeno Marco Livio Salinatore, altro
console, può sopportare l’ira e arriva a punirla in un nemico crudele
(Nabi), il quale usava spogliare i cadaveri dei caduti: «non tulit hanc
iram tantosque in corde tumores» (XV, v. 689).91
Ennesimo, estremo slancio annibalico troviamo a XVII, vv. 292-295:
«Dux uetus armorum scitusque accendere corda / laudibus ignifero mentes
furiabat in iram / hortatu decorisque urebat pectora flammis», allusione
alla formidabile capacità del condottiero punico di alimentare le irae e i
furori dei suoi soldati. Inoltre, nell’ultimo libro rinveniamo la già
citata, bellissima, iunctura laetissimus irae (v. 307), altro hapax riferito da
Annibale a un imprecisato suo guerriero di cui vuole sollecitare il
valore militare.
Ma la uirtus ha ormai trionfato. Zama segna la fine della
costellazione Giunone-Annibale-Cartagine e il trionfo della Romanitas,
rimodellata dalla ratio e dalla clementia di Scipione. L’ira è stata
sconfitta, ma (verrebbe da aggiungere) per quanto?
7.
Per concludere: rileggere i Punica, selezionando alcuni nuclei
lessematici (ira e ultio) e sèmici (passione~ragione), è operazione che ha
dimostrato la sua fecondità per comprendere architettura e articolazione
diegetica e ideologica del poema.
In questo senso, seguire consistenza e qualità del lessico di ira e
ultio nell’epos siliano significa tracciare il perfetto diagramma degli
sviluppi e degli snodi decisivi della vicenda narrata: dalla prima fase,
91 Con iram che qui starà per ‘crudeltà’, ‘ferocia’ e simili.30
arcaica, in cui i ductores romani dominati dalle passioni sono simmetrici
ad Annibale, in nulla distinguendosi da lui, a quella costruita sugli assi
di ratio/uirtus e dominata dalle figure di Quinto Fabio Massimo e Scipione
Africano,92 sorta di sapientes stoici che esercitano il proprio potere
ricorrendo alla clementia e all’humanitas, si snoda l’intero disegno epico
siliano.
Ad altre spalle, più robuste, spetterà il compito di approfondire
queste suggestioni.
BIBLIOGRAFIA
ALBRECHT 1964 = M. VON ALBRECHT, Silius Italicus. Freiheit und Gebundenheit römischer Epik, Amsterdam,Schippers, 1964
AHL-DAVIS-POMEROY 1986 = F. AHL, M. A. DAVIS, A. POMEROY, Silius Italicus, in «Aufstieg undNiedergang der Römischen Welt», II, 32.4, Berlin-New York, 1986, pp. 2492-2561.
92 Per i cui tratti regalistici rinviamo certamente a Marks 2005.31
ARIEMMA 2000 = E. M. ARIEMMA, Tendenze degli studi su Silio Italico: una panoramica sugli ultimi quindici anni, in«Bollettino di Studi Latini», XXX, 2000, pp. 577-640.
BARDON 1962 = H. BARDON, Le goût à l’époque des Flaviens, in «Latomus», 21, 1962, pp. 732-748.
BILLERBECK 1985 = M. BILLERBECK, Aspects of Stoicism in Flavian epic, in «Papers of the LiverpoolLatin Seminar», 5, 1985, pp. 341-356.
BILLERBECK 1986 = M. BILLERBECK, Stoizismus in der römischen Epik neronischer und flavischer Zeit, in«Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt», II, 32.5, Berlin-New York, 1986, pp. 3116-3151.
BOCCIOLINI PALAGI 1991 = L. BOCCIOLINI PALAGI, Enea, Scipione e i fratelli siculi, in «Maia», XLIII, 1991,pp. 199-207.
BODEI 2003 = R. BODEI, Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso politico, Milano,Feltrinelli, 2003.
BRIZZI 1986 = G. BRIZZI, Nuove considerazioni sulla ‘leggenda’ di Annibale, in «Rivista Storicadell’Antichità», XVI, 1986, pp. 111-131.
BRUGNOLI 1994 = G. BRUGNOLI, Seneca tragico e Silio Italico, in «Aevum Antiquum», 7, 1994, pp. 333-340.
BURCK 1979 = E. BURCK, Das römische Epos, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft,1979.
BURCK 1984 = E. BURCK, Historische und epische Tradition bei Silius Italicus, München, Beck, 1984.
DANESI MARIONI 1985 = G. DANESI MARIONI, Un martirio stoico. Silio Italico, Punica I, 169 sgg., in«Prometheus», 15, 1989, pp. 245-253.
DELZ 1987 = J. DELZ (a c. di), Silii Italici Punica, Stuttgart, Teubner, 1987.
FILLION-LAHILLE 1984 = J. FILLION-LAHILLE, Le De ira de Sénèque et la philosophie stoïcienne des passions,Paris, Klincksieck, 1984.
FLAMMINI 1983 = G. FLAMMINI, Tecnica e strutture del chiasmo in Silio Italico, in «Giornale Italiano diFilologia», XXXV, 1-2, 1983, pp. 85-101.
FROMM 1975 = E. FROMM, Anatomia della distruttività umana, Milano, Arnoldo Mondadori, 1975 (ed.orig.: The Anatomy of Human Destructiveness, New York, Holt, Rinehart and Winston, 1973).
FUCECCHI 1990a = M. FUCECCHI, Empietà e titanismo nella rappresentazione siliana di Annibale, in «Orpheus»,XI, 1990, 1, pp. 21-42.
FUCECCHI 1990b = M. FUCECCHI, Il declino di Annibale nei Punica, in «Maia», XLII, 1990, pp. 151-166.
FUCECCHI 1992 = M. FUCECCHI, Irarum proles: un figlio di Annibale nei Punica di Silio Italico, in «Maia»,XLIV, 1992, pp. 45-54.
FUCECCHI 1993 = M. FUCECCHI, Lo spettacolo delle virtù nel giovane eroe predestinato: analisi della figura diScipione in Silio Italico, in «Maia», XLV, 1993, pp. 17-48.
32
GREIMAS 1984 = A. J. GREIMAS, Della collera. Studio di semantica lessicale, in ID., Del senso II. Narrativa,modalità, passioni, Milano, Bompiani, 1984, pp. 217-238 (ed. orig.: Du sens II. Essais sémiotiques,Paris, É-ditions du Seuil, 1983)
GREIMAS-FONTANILLE 1991 = A. J. GREIMAS, J. FONTANILLE, Sémiotique des passions. Des états de choses auxétats d’âme, Paris, Éditions du Seuil, 1991.
GREIMAS 2000 = A. J. GREIMAS, Semantica strutturale. Ricerca di metodo, Roma, Meltemi, 2000 (ed.orig.: Sémantique structurale. Recherche de méthode, Paris, Larousse, 1966).
GREIMAS 2001 = A. J. GREIMAS, Del senso, Milano, Bompiani, 2001 (ed. orig.: Du sens, Paris,Éditions du Seuil, 1970).
GUASTELLA 2001 = G. GUASTELLA, L’ira e l’onore. Forme della vendetta nel teatro senecano e nella sua tradizione,Palermo, Palumbo, 2001.
HARDIE 1993 = P. HARDIE, The epic successors of Virgil: a study in the dynamics of a tradition, Cambridge,Cambridge University Press, 1993.
KÜPPERS 1986 = J. KÜPPERS, Tantarum causas irarum. Untersuchungen zur einleitenden Bücherdyade derPunica des Silius Italicus, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1986.
LAUDIZI 1989 = G. LAUDIZI, Silio Italico: il passato tra mito e restaurazione etica, Galatina, CongedoEditore, 1989.
LAUDIZI 1991 = G. LAUDIZI, Scipione e Appio Claudio in Silio Italico, in «Bollettino di Studi Latini»,XXI, 19-91, pp. 3-16.
MANTOVANELLI 1984 = P. MANTOVANELLI, La metafora del Tieste. Il nodo sadomasochistico nella tragediasenecana del potere tirannico, Verona, Libreria Universitaria Editrice, 1984.
MANTOVANELLI 2001 = P. MANTOVANELLI, ‘Perversioni’ morali e letterarie in Seneca, in «Scrinia», 18, 2001,pp. 53-86.
MARKS 2005 = R. MARKS, From Republic to Empire. Scipio Africanus in the Punica of Silius Italicus, Frank-furtam Main, Peter Lang, 2005.
MATIER 1990 = K. O. MATIER, Stoic Philosophy in Silius Italicus, in «Akroterion», 35, 1990, pp. 68-72. MCGUIRE 1995 = D. T. MCGUIRE JR., History compressed: the Roman names of Silius’ Cannae episode, in«Latomus», 54, 1, 1995, pp. 110-118.
MEZZANOTTE 1995 = A. MEZZANOTTE, Echi del mondo contemporaneo in Silio Italico, in «Rendicontidell’Istituto Lombardo», 129, 1995, pp. 357-388.
NERI 1986 = V. NERI, Dei, Fato e divinazione nella letteratura latina del I sec. d. C., in «Aufstieg undNiedergang der Römischen Welt», II, 16.3, Berlin-New York, 1986, pp. 2026-2046.
NICOL 1936 = J. NICOL, The historical and geographical sources used by Silius Italicus, Oxford, BasilBlackwell, 1936.
PERUTELLI 1997 = A. PERUTELLI, Sul manierismo di Silio Italico: le ninfe interrogano Proteo (VII, 409-493), in«Bollettino di Studi Latini», XXVII, 1997, pp. 470-478.
PERUTELLI 2007 = A. PERUTELLI, La poesia epica latina. Dalle origini all’età dei Flavi, Roma, Carocci, 2007.
33
RAMAGLIA 1952 = L. RAMAGLIA, La figura di Giunone nelle Puniche di Silio Italico, in «Rivista di StudiClas-sici», I, 1952, pp. 35-43.
RIPOLL 1998 = F. RIPOLL, La morale héroïque dans les épopées latines d’époque flavienne: tradition et innovation,Louvain-Paris, Peeters, 1998.
ROCCA SERRA 1990 = G. ROCCA SERRA, Imitatio Alexandri et stoïcisme: Manilius et Silius Italicus, in«Latomus», 209, 1990, pp. 379-387.
SANTINI 1983 = C. SANTINI, La cognizione del passato in Silio Italico, Roma, Cadmo Editore, 1983.
SILIO ITALICO 2001 = SILIO ITALICO, Le guerre puniche, a c. di M. A. VINCHESI, Milano, Bur, 2001.
SPALTENSTEIN 1986-1990 = F. SPALTENSTEIN, Commentaire des Punica de Silius Italicus, I, livres 1 à 8,Ginevra, Droz, 1986 e ID., Commentaire des Punica de Silius Italicus, II, livres 9 à 17, Ginevra,Droz, 1990.
TANDOI 1985 = V. TANDOI, Gli epici di fine I secolo dopo Cristo, o il crepuscolo degli dei, in «Atene e Roma»,30, 1985, pp. 154-169.
VENINI 1972a = P. VENINI, Cronologia e composizione nei Punica di Silio Italico, in «Rendicontidell’Istituto Lombardo», 106, 1972, pp. 518-531.
VENINI 1972b = P. VENINI, Tecnica allusiva in Silio Italico, in «Rendiconti dell’Istituto Lombardo»,106, 1972, pp. 532-542.
VESSEY 1974 = D. W. T. C. VESSEY, Silius on the fall of Saguntum, in «Classical Philology», 69,1974, pp. 28-36.
VESSEY 1975 = D. W. T. C. VESSEY, Silius Italicus: the shield of Hannibal, in «American Journal ofPhilology», 96, 1975, pp. 391-405.
VIANSINO 1988 = G. VIANSINO, Premessa, in SENECA, Dialoghi III-IV-V: De ira, vol. 1, Milano,Arnoldo Mondadori, 1988, pp. 119-141.
VINCHESI 2001 = M. A. VINCHESI, Introduzione, in SILIO ITALICO, Le guerre puniche, Milano, Bur,2001, pp. 5-88.
WACHT 1989-1990 = M. WACHT, Concordantia in Silii Italici Punica, Hildesheim-Zürich-New York, Olms-Weidmann, 1989-1990.
WISTRAND 1956 = E. WISTRAND, Die Chronologie der Punica des Silius Italicus. Beiträge zur Interpretation derflavischen Literatur, Göteborg, Göteborgs Universitets Årsskrift, 1956.
YOUNG 1964 = N. D. YOUNG, Index verborum silianus, Hildesheim, Georg Olms, 1964 (= StateUniversity of Iowa, 1939).
34
![Page 1: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/18.jpg)
![Page 19: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/19.jpg)
![Page 20: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/20.jpg)
![Page 21: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/22.jpg)
![Page 23: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/23.jpg)
![Page 24: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/24.jpg)
![Page 25: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/25.jpg)
![Page 26: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/26.jpg)
![Page 27: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/27.jpg)
![Page 28: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/28.jpg)
![Page 29: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/29.jpg)
![Page 30: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/30.jpg)
![Page 31: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/31.jpg)
![Page 32: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/32.jpg)
![Page 33: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/33.jpg)
![Page 34: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/34.jpg)
![Page 35: Ira (e Ultio) nei 'Punica' di Silio Italico (2011) [CHAPTER IN BOOK]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023013105/631c9a8a5a0be56b6e0e485b/html5/thumbnails/35.jpg)