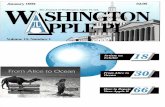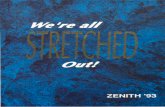I Carabinieri 1814-1993
Transcript of I Carabinieri 1814-1993
Virgilio Ilari
I CARABI�IERI
Scritto nel 1995 per la Collana L'Identità �azionale de Il Mulino – Bologna, diretta da
Ernesto Galli Della Loggia, ma non pubblicato.
Indice
I carabinieri e l'Italia
I - Nei secoli fedele
II - Usi obbedir tacendo
III - La Benemerita
Prima e dopo Porta Pia
Tabelle
1 - L'Albo d'oro dei carabinieri (1814-1996)
2 - Il Corpo dei carabinieri reali (1814-61)
3 - Gli organici dell'Arma (1861-1996)
4 - Forza dei comandi superiori carabinieri al 1° giugno 1940
5 - Effettivi dei corpi di polizia dal 1861 al 1996
6 - Gli ordinamenti dell'Arma (1862-1980)
7 - L'ordinamento attuale (1996)
8 - I 54 comandanti generali (1814-1997)
Bibliografia
I CARABI�IERI E L'ITALIA
In occasione del 150° anniversario dell'Arma (1964), Giovanni Artieri scrisse che il
carabiniere fa parte del paesaggio italiano, come l'Etna e il Vesuvio, le Alpi e gli Appennini. In
uniforme ordinaria non porta più la "lucerna", il famoso cappello a tricorno: ma anche i turisti
stranieri riconoscono la bandoliera bianca. Per loro il pennacchio rosso-blu dell'uniforme di gala è
una sineddoche dell'Italia, come le giubbe rosse e la guardia svizzera lo sono per il Canada e il
Vaticano.
Per noi italiani, invece, il carabiniere è una sineddoche dello stato. Non dello stato come
effettivamente è, ma dell'idea di stato come autorità e giustizia, garanzia e imparzialità. Ai nostri
occhi, l'Arma rappresenta la continuità dello stato e la certezza del diritto oltre i mutamenti
costituzionali e politici.
Nel 1988-89 Giorgio Forattini disegnò tutto il Gotha della prima Repubblica in uniforme
da carabiniere: Cossiga, Spadolini, Andreotti, Craxi, De Mita, Zanone e Nilde Iotti (con la gonna
e senza pennacchio, ma anche lei con sciabola e bandoliera). Il caso volle poi che nell'agosto
1992, sei mesi dopo l'arresto del "mariuolo" Mario Chiesa, Craxi pretendesse le "scuse" dell'Arma
per fughe di notizie su indagini riservate a carico di esponenti del Psi. In novembre toccò a Bossi
accusare l'Arma di tramare contro la Lega. Ma, fors'anche grazie a polemiche del genere, gli
italiani l'Arma non l'hanno mai identificata con nessun regime e con nessun partito.
Critiche e polemiche le riserviamo ai servizi segreti, e di tanto in tanto a polizia, guardia
di finanza e magistratura. Ai carabinieri, invece, sono toccate le barzellette (notoriamente gestite
da apposito ufficio del comando generale dell'Arma, che importa e adatta quelle che i francesi
raccontano sui belgi).
Oggi, con i suoi 117.000 uomini (inclusi 15.000 ausiliari di leva) l'Arma ha raggiunto in
tempo di pace gli stessi effettivi con cui nel 1941 presidiava territorio metropolitano, colonie,
territori occupati e retrovie del fronte.
La Benemerita (così definita dalla relazione parlamentare del 24 giugno 1864) è ancora la
più numerosa delle cinque polizie italiane, leggermente meno costosa (8.600 miliardi) della
polizia di stato e meno antica (1814) della guardia di finanza (1774).
Il suo bilancio equivale al reddito medio di 270.000 famiglie italiane e alla multa
comunitaria per lo scarto dai parametri di Maastricht, e supera quello dell'esercito, di cui dal 1822
costituisce la "prima Arma". Del resto, con 32 medaglie italiane e 1 sammarinese, la sua bandiera
è la più decorata della Penisola.
Il primo regolamento dei carabinieri (1841) lo scrisse un gesuita, e arrestarono tre volte
Garibaldi, due più di Pinocchio. Ma a leggere il ritratto che ne faceva la Civiltà cattolica nel 1860
sembrano bolscevichi ante litteram, e a Porta Pia c'erano anche loro.
L'11 novembre 1948, pochi mesi dopo la scomunica del comunismo, la sconfitta del
Fronte popolare e la semi-insurrezione seguita all'attentato contro Palmiro Togliatti, l'ordinario
militare monsignor Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone propose a Pio XII di porre anche i
carabinieri sotto il patronato mariano (Virgo Fidelis), quarti dopo aviatori (Vergine di Loreto),
commissariato militare (Madre della Divina Provvidenza) e militari cattolici americani (Maria
SS. Immacolata).
Agli americani il patronato mariano Pio XII l'aveva accordato l'8 maggio 1942, lo stesso
giorno il cui l'Us Navy vinse la battaglia del mar dei Coralli. I carabinieri li fece attendere fino
all'11 novembre 1949, sette mesi dopo l'adesione italiana al Patto atlantico.
Anche questo è un tratto di distinzione rispetto alle altre polizie, dotate di semplici santi.
Patrono della guardia di finanza è, ratione officii, l'apostolo Matteo, pubblicano pentito. Forse in
omaggio a "celere" e "113", alla polizia di stato è toccato invece l'arcangelo Michele, a mezzadria
con i paracadutisti. Quella penitenziaria ha san Basilide, la gendarmeria francese sainte
Geneviève, e i vigili urbani san Sebastiano (forse l'hanno proposto gli automobilisti).
Dal 1916 la banda dell'Arma (1862) si esibisce all'estero, anche a Manhattan per il
Columbus day, e dal 1933 il Carosello storico conclude in piazza di Siena gli anniversari della
fondazione. Benchè non sia affatto vero, gli italiani sono convinti che la nuova uniforme blu
scuro, e non più nera, adottata dall'Arma nel 1988 rechi la firma dello stilista Armani.
Per ogni posto da carabiniere ci sono (1995) 52 concorrenti e mezzo (42.000 per 800). Per
ogni carabiniere in servizio ce ne sono altri tre in congedo, di cui due iscritti all'associazione
dell'Arma (190.277), la più antica (1885) e la più numerosa e capillare di tutte dopo quella degli
alpini (400.000), alimentata però dalla coscrizione obbligatoria. Entrambe le associazioni hanno
sezioni in tutto il mondo.
La tiratura del Carabiniere (1872), il più antico periodico ufficioso dell'Arma, oggi diretto
da un giornalista professionista (Pietro Zullino), supera le 200.000 copie mensili, con punte di
250.000. Appena un ottavo del settimanale Famiglia cristiana, ma più di Stars and Stripes
(161.000), il famoso quotidiano delle forze armate americane. Il 92 per cento degli abbonati non
appartiene all'Arma.
Da un sondaggio Pragma (1988) emerge che oltre metà degli italiani è convinta di
conoscere molto o abbastanza i carabinieri (mentre polizia e finanza sono conosciute solo dal 39 e
dal 35 per cento). Gli indici di fiducia sono 64, 62 e 57 e il "voto" di merito è 7 e mezzo.
Secondo un sondaggio Consulting Unit (1990), l'88 per cento degli italiani ritiene che i
poliziotti siano troppo pochi e sottopagati, e il 45 che abbiano troppo poco potere. Il 79 li vuole
armati anche nei servizi ordinari.
Solo il 13 per cento consiglierebbe ad amici e parenti di arruolarsi in polizia: piuttosto nei
carabinieri (20) e soprattutto in finanza (39). Ma la propensione personale dei giovani (16-20
anni) è di segno opposto: il 42 per cento lo farebbe, con schiacciante preferenza per polizia (48) e
finanza (42) rispetto ai carabinieri (10), considerati meno moderni e troppo "militari".
La polizia batte i carabinieri in efficacia (71 a 60), servizi (57 a 52), qualità umana (49 a
44), simpatia (46 a 33), modernità (43 a 17), competenza (43 a 29) e aggiornamento (43 a 24).
L'Arma prevale invece in tradizione e fedeltà (73 a 37) e organizzazione (57 a 38). Ma è la
finanza a surclassarle entrambe, tranne che in efficacia (60) e tradizione (57).
Tre quarti degli italiani addebitano gli episodi negativi alle "mele marce", e solo un quarto
li considera indizio di "malessere" o "decadimento generale", reclamando una selezione più
accurata e un maggior controllo disciplinare. In ogni caso i carabinieri sono considerati meno
inclini della polizia ad eccessivo uso delle armi (17 a 20), deviazioni (28 a 63), negligenze (32 a
37), abuso di potere (40 a 44) e corruzione (42 a 52). Alla pari, invece, inadempienze (17) e
favoreggiamento (37 a 36). La finanza registra però indici migliori dei carabinieri, tranne che per
la corruzione (63).
Triplicato rispetto al 1935, il complesso delle cinque polizie statali impiega oggi 305.000
effettivi e 24.000 ausiliari di leva, più delle tre forze armate (140.000 effettivi, 160.000 di leva e
50.000 civili). Il costo supera i 30.000 miliardi, quasi una volta e mezza le spese militari (22.000)
e ventiquattro volte le spese per la sicurezza pubblica del 1928 (pari a 1.250 miliardi attuali).
Siamo il paese occidentale con il maggior numero di polizie statali e di poliziotti (uno
ogni 168 cittadini, come in Turchia), ma almeno la prima è una anomalia abbastanza relativa.
Infatti soltanto Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Olanda e paesi scandinavi hanno un
modello decentrato, basato su polizie regionali e locali coordinate e integrate da un'unica polizia
centrale, generalmente piccola e specializzata.
Nel resto d'Europa prevale infatti il modello napoleonico, con due o tre polizie statali
parallele e competenze sovrapposte. Malgrado forti differenze, Gendarmerie nationale, Guardia
civil e Bundesgendarmerie sono gli equivalenti francese, spagnolo e austriaco dei carabinieri
italiani.
Questo sistema è sicuramente diseconomico e meno razionale dell'altro, ma risponde a
criteri politici ancora attuali, rafforzati dal peso della tradizione e degli interessi corporativi. Lo
scopo della doppia o tripla polizia non è tanto il controllo reciproco quanto di impedire una
concentrazione di potere, mantenendo un contrappeso tra la forza pubblica a disposizione del
governo e quella a disposizione dello stato.
Naturalmente questa ripartizione della forza pubblica non sta scritta da nessuna parte.
Eppure l'esperienza storica ben presente agli italiani è che la polizia "al servizio del cittadino"
dipende in realtà dal governo e ne riflette l'orientamento politico, mentre i carabinieri "usi obbedir
tacendo" (secondo il loro primo motto, tratto da un poemetto di Costantino Nigra) dipendono
dallo stato, cioè da sé stessi.
Come può accadere che carabinieri e finanzieri, posti alle dipendenze gerarchiche dei
ministri degli Interni, delle Finanze e della Difesa, siano di fatto più autonomi non solo dei
poliziotti, ma perfino dei magistrati, la cui indipendenza è tutelata dalla Costituzione?
In realtà anche l'autonomia delle forze dell'ordine, come dei militari, dei diplomatici e
dell'intera burocrazia pubblica, si fonda su norme costituzionali. Dipendono dal governo e
dall'autorità giudiziaria (e i corpi a ordinamento militare anche dal comando presidenziale delle
forze armate), ma sono al servizio esclusivo della nazione, e vincolati ai principi di legalità,
imparzialità e apoliticità.
Richiamandosi a questi principi, il vertice gerarchico ha potuto tutelare l'autonomia
dell'Arma e della Guardia di finanza meglio dei vertici collegiali, e in parte politico-sindacali, di
polizia e magistratura. Nei primi due corpi, tradizione, gerarchia, etica e disciplina militare, per
quanto attenuate rispetto al passato, hanno infatti contrastato quell'individualismo che invece ha
reso polizia e magistratura vulnerabili ai gruppi di potere interni e ad intromissioni esterne ben
più gravi di quelle del governo.
Ma questo è solo un aspetto dell'arcano. L'altro è che la stessa partitocrazia, come aveva
fatto anche il fascismo, ha preferito controllare dall'esterno le due polizie a statuto militare,
sforzandosi di evitare interferenze dirette. Rari e circoscritti gli scontri e le polemiche, e ancor più
rari e velleitari i tentativi di riforma legislativa. Al contrario, polizia e magistratura non sono
rimaste immuni da tentativi di occupazione del potere e pratiche di consociativismo spartitorio.
Tuttavia entrambi gli atteggiamenti riflettono la particolare importanza che la sicurezza interna
riveste in un sistema politico fragile come quello italiano. Non a caso polizia e giustizia sono gli
unici settori della spesa pubblica finora risparmiati dalla scure del Tesoro.
Un osservatore straniero potrebbe trovare singolare che la grande autonomia di cui oggi
gode l'apparato di sicurezza interna, invece di suscitare inquietudini, ne accresca il prestigio.
Infatti non è stato sempre così. L'importanza e l'attuale struttura delle forze di sicurezza interna
sono il prodotto delle guerre civili reali e "virtuali" e delle contrapposizioni ideologiche radicali
che in questo secolo hanno segnato la politica e le istituzioni italiane, inclusi i carabinieri.
Il loro maggiore prestigio deriva soprattutto dalla sorprendente solidità e flessibilità
dimostrata durante le crisi che hanno invece più volte squassato polizia e servizi segreti, e da
ultimo anche finanzieri e magistratura. Ma un pizzico di sano machiavellismo italiano condisce
anche la storia dell'Arma.
Nel suo famoso saggio su Caporetto, Curzio Malaparte asserisce di aver visto il cartello
"aeroplano abbattuto" piantato per scherno accanto al cadavere di un carabiniere (i fanti li
sfottevano chiamandoli "aeroplani", per via della "lucerna" ricoperta di tela grigioverde).
Ma nessuno ha mai potuto rivolgere ai carabinieri italiani le tremende parole che nel 1931
Ramon Sender dedicò a quelli spagnoli trucidati dalla popolazione di Castilblanco: "quando ci si
arruola nella guardia civile, si dichiara la guerra civile".
Da vari anni i sondaggi Doxa sulla fiducia nelle varie istituzioni registrano l'assoluto
primato delle forze dell'ordine, e in particolare dei carabinieri. Nel raffronto 1992-93 (L'Espresso,
24 aprile 1993) l'indice dei carabinieri cresce dall'83 all'86 per cento, contro 83-82 della polizia,
77 della guardia di finanza e 68-76 delle forze armate. La fiducia nel parlamento scende da 24 a
15, nella pubblica amministrazione da 28 a 15. Mani Pulite quasi raddoppia la fiducia nella
magistratura (da 37 a 61). Ma resta indietro alle stesse forze armate.
Il prestigio dei carabinieri non è solo il frutto di vent'anni di mobilitazione civile contro
terrorismo, criminalità organizzata e corruzione politica. Nasce dall'antica capillare presenza sul
territorio, dal forte radicamento sociale e familiare, dalla capacità di conciliare tradizione e
modernità, dallo stile militare e da una sapiente gestione dell'immagine.
Il prestigio delle procure militanti e della polizia civile è più recente. In parte vi ha
contribuito il ciclo hollywoodiano e televisivo del "cane sciolto" e del "giudice ragazzino", basato
sul tipo di eroismo coltivato dal fascismo, dalle sinistre, dal giustizialismo. Recitato e inimitabile,
individualista e sornione, superomista e androgino.
Quello del carabiniere è un eroismo diverso: delle piccole cose, dal volto umano, a misura
di italiano. Collettivo, silenzioso, paziente, quotidiano, anonimo, pasticcione, arrangiato, testardo.
Ma soprattutto con le "stellette".
I - �EI SECOLI FEDELE
Quando c'era il Buon governo
Tenace traccia dell'antica tradizione sabauda dei carabinieri non più reali, è una certa
reticenza delle storie ufficiali sulle origini del corpo. Non amano sottolineare che il suo
ordinamento era modellato sulla gendarmerie nationale creata in Francia nel 1790 dall'assemblea
nazionale costituente al posto della maréchaussée monarchica, e sugli analoghi corpi di
gendarmeria esportati anche in Italia da Napoleone.
Del resto una recente pubblicazione (Besson e Rosière, 1982) non include i carabinieri
italiani nella quarantina di gendarmerie estere direttamente derivate da quella francese.
In effetti l'imitazione non fu pedissequa né vi fu alcuna filiazione diretta. Ovviamente alla
Restaurazione i gendarmi e poliziotti dei regimi napoleonici furono sottoposti ad epurazione
politica: solo una piccola aliquota fu ammessa nei nuovi corpi creati dai governi legittimisti, e
non sempre conservando grado o incarico. Semmai furono richiamati e preferiti gli elementi
espulsi in passato perchè sospettati di nostalgie monarchiche o di avversione alla Francia. Solo un
quinto dei primi 27 ufficiali dei carabinieri proveniva dal servizio francese e uno soltanto dalla
gendarmeria imperiale. Tutti gli altri erano ufficiali della vecchia armata sarda rimasti fedeli al re.
Ciò non toglie però che in ultima analisi Vittorio Emanuele I, come tutti gli altri sovrani
reinsediati, creò (il 13 luglio 1814) il corpo dei carabinieri reali a piedi e a cavallo proprio per
mantenere, con diverso nome, l'indispensabile gendarmeria ex-repubblicana e imperiale degli
ex-dipartimenti piemontesi e savoiardi, e poi anche di quelli liguri annessi al regno nel 1815.
Il corpo (al comando del colonnello di fanteria Luigi Provana di Bussolino) fu costituito
assieme e alle dipendenze della direzione generale e ispezione di buon governo (generale
Giuseppe Thaon di Revel di Sant'Andrea). Nonostante il nome, il Buon governo era un mero
organo di polizia, del tutto autonomo dalla segreteria di stato per gli affari interni (antenata
dell'attuale ministero).
Il 18 gennaio 1815 i carabinieri assorbirono il Buon governo. Il secondo comandante
(colonnello Carlo Lodi di Capriglio) assunse infatti la carica di primo presidente e capo di buon
governo, e gli altri ufficiali quelle di ispettori, commissari e vicecommissari.
Ma le altre autorità amministrative e giudiziarie reagirono contro una tale concentrazione
di potere, e nell'ottobre 1816 il Buon governo fu nuovamente scisso in "ministero di pulizia"
(Lodi di Capriglio) e corpo dei carabinieri reali (colonnello Giovanni Battista d'Oncieux de la
Batie). Al primo spettavano le funzioni direttive di pubblica sicurezza (Ps), e al secondo quelle
esecutive, in concorso però con gli agenti locali di polizia.
Infatti nel 1817 il regno di Sardegna contava addirittura 10 diversi corpi di polizia con ben
9.500 effettivi (1 ogni 200 abitanti).
Due erano speciali per la Sardegna, dove ai 435 cavalleggeri (1726) si erano aggiunti 313
moschettieri (formati nel 1814 con un'aliquota della reale gendarmeria genovese). Solo nel 1819
vennero unificati formando il corpo dei cacciatori reali di Sardegna (683).
Nelle province di terraferma (Piemonte, Savoia, Nizza e Liguria) di corpi ce n'erano 8:
due a carattere generale (polizia e 2.068 carabinieri), due urbani (41 reali gendarmi di Genova e
38 guardie civiche di Torino), due di polizia militare (prevostura e arcieri di reggimento) e due, i
più numerosi, di finanza.
Questi ultimi erano i 2.646 reali preposti alle dogane (anch'essi creati dai francesi e
mantenuti dalla Restaurazione) e la legione reale leggera (3.768), un'aliquota dell'esercito
specificamente destinata alla vigilanza e repressione del contrabbando già esistita nel 1774-96.
Ricostituita nel 1817 con i reduci della Grande Armée, la legione era però politicamente
inaffidabile, e fu sciolta nel 1821 per aver appoggiato il moto costituzionale.
Nella sollevazione della cittadella di Torino (12 marzo 1821) i 300 carabinieri (di stanza
nel palazzo Vittone, poi caserma Bergia) rimasero neutrali, continuando ad assicurare i normali
servizi di istituto. Ma più tardi, quando il governo costituzionale destituì il tenente colonnello Des
Geneys, raggiunsero di propria iniziativa l'armata lealista riunita a Novara da Vittorio Emanuele I.
Dopo la vittoria, le poche defezioni verificatesi nel corpo furono sanzionate da pene esemplari.
L'antenato di Berlinguer e il nipote di Chateaubriand
Fu proprio l'esperienza del 1821 ad assicurare la fortuna dei carabinieri. La legione reale
leggera fu soppressa e la reale gendarmeria di Genova addetta al servizio carcerario. Il ministero
degli Interni incorporò la polizia, declassata a corpo militare, e creò un proprio servizio segreto
civile (ufficio settimo, affari di polizia).
I carabinieri, promossi "primo corpo dell'armata attiva", incorporarono prevostura militare
e cacciatori reali di Sardegna, salendo a 3.000. D'Oncieux de la Batie, promosso maggior
generale, assunse l'ispezione generale dell'Arma. Dipendevano da lui un generale viceispettore e
due colonnelli, uno comandante in prima per i reparti di terraferma e l'altro in seconda per quelli
insulari.
Ma anche questo riassetto della sicurezza interna ebbe vita travagliata. Nel 1825 la polizia
fu sdoppiata in "alta" (politica) e "bassa" (comune), e riprese ad erodere il primato dei carabinieri,
finchè nel 1831 l'ispezione generale fu soppressa e il corpo nuovamente sdoppiato. Quello di
terraferma conservò al vertice un maggior generale col titolo di comandante generale, mentre il
corpo insulare tornò autonomo col vecchio nome di reggimento cavalleggeri di Sardegna.
Vi apparteneva la seconda medaglia d'oro dell'Arma, il capitano Girolamo Berlinguer,
antenato del segretario del Pci e dell'attuale ministro della Pubblica istruzione, ucciso da un
malvivente al momento dell'arresto (1835).
Ossessionata dal timore di ripetere il clamoroso fiasco del 1821, la polizia politica
sabauda usava metodi spregiudicati. Nel 1834 arrivò addirittura a far pubblicare sulla Gazzetta
piemontese un falso atto di condanna a morte nei confronti dei marinai disertori Garibaldi e
Mutru, che l'ammiraglio comandante, per coprire lo scandalo, non aveva denunciato e che
pertanto non avevano subito alcun processo.
Ma a furia di agenti provocatori e complotti inventati la polizia politica andò a pestare i
piedi allo stesso datore di lavoro, tanto che nel 1836 il re dovette intervenire con clamorose
destituzioni ed epurazioni.
Tuttavia solo nel 1841 Carlo Alberto prese la drastica misura di trasferire la polizia al
ministero della Guerra e marina, sotto un ispettore generale (poi comandante generale)
proveniente dai carabinieri (il primo fu Fabrizio Lazzari), da cui dipendeva anche la polizia
politica, ribattezzata gabinetto particolare. La segreteria degli Interni fu riunita con quella delle
Finanze, da cui dipendevano i reali preposti alle dogane. Inoltre i servizi di sicurezza in Sardegna
furono affidati a uno speciale corpo di 41 carabinieri veterani, collocati fuori organico.
Al 1841 risale anche il primo regolamento dei carabinieri. L'autore fu un gesuita:
probabilmente padre Chateaubriand (nipote dello scrittore), ministro della Casa dei Santi Martiri,
ma alcuni studiosi propendono piuttosto per padre Taparelli d'Azeglio (fratello di Massimo)
oppure per padre Francesco Pellico (fratello di Silvio).
Naturalmente anche il riassetto del 1841 subì i contraccolpi della successiva rivoluzione
costituzionale. Già alla vigilia, nel 1847, la polizia fu nuovamente smilitarizzata, tornando alle
dipendenze degli Interni e riprendendo l'abito civile. Nel 1848 mutò nome in amministrazione di
Ps, e alle sue dipendenze fu organizzata una forza di 700 carabinieri veterani, da impiegarsi in
uniforme in Sardegna (127) e nei servizi urbani di Genova e Torino (dove rimase però anche il
corpo delle guardie municipali).
Nel 1852 i carabinieri veterani furono trasformati in corpo guardie di Ps con 412 uomini e
2 compagnie (Genova e Torino), ma in compenso ai carabinieri fu attribuita preminenza
gerarchica sulla polizia e i cavalleggeri furono ribattezzati corpo dei carabinieri reali di Sardegna.
Tuttavia rimasero autonomi fino al 1861, quando furono formalmente incorporati nell'Arma come
legione carabinieri di Cagliari. Nel novembre 1859 la materia relativa alla Ps fu disciplinata dalla
legge Rattazzi, legge fondamentale della polizia italiana.
L'antenato di Ludovico Garruccio
Come tutte le corti europee, anche quella sabauda disponeva di un servizio segreto
particolare, svolto dai paggi e dalle guardie del corpo (1580). Per bilanciare lo strapotere della
polizia politica, nel 1836 Carlo Alberto creò una commissione superiore di statistica cui
appartennero anche Cavour e Alessandro La Marmora, e potenziò l'archivio segreto della Real
casa, avvalendosi in misura crescente e poi esclusiva di ufficiali dei carabinieri.
Nel 1842 i carabinieri svolsero per la prima volta il servizio d'onore di casa Savoia, in
concorso con le guardie del corpo e di palazzo. Nella campagna del 1848 mobilitarono 280
effettivi a cavallo per la scorta del re e del quartier generale. Il 30 aprile furono loro a proteggerli
dagli austriaci con la famosa carica di Pastrengo.
Comandava uno dei 3 squadroni il capitano Luigi Incisa di Camerana, antenato del
penultimo capo di stato maggiore dell'esercito (1993-96) e dei suoi due cugini, entrambi
ambasciatori, uno dei quali apprezzato autore di vari saggi di politica estera (anche con lo
pseudonimo di Ludovico Garruccio).
Tuttavia nelle successive campagne del Risorgimento la scorta del re fu attribuita alla
cavalleria, e solo nel 1870, con la soppressione delle ultime guardie di palazzo, il servizio d'onore
e custodia del re fu attribuito ad un apposito e più economico squadrone carabinieri creato a
Firenze nel 1868, i famosi corazzieri.
Nel 1946 lo squadrone rimase in vita come carabinieri guardie del presidente. Fu Cossiga,
nel 1990, ad elevarlo al rango di reggimento e a ribattezzarlo guardie della repubblica (in analogia
con la garde républicaine francese, anch'essa inquadrata nella gendarmerie nationale). Nel 1993
ha assunto il nome di reggimento corazzieri.
La carriera di Biambilla
Riorganizzati da Cavour, la polizia politica e il servizio segreto personale del capo del
governo (diretto dal colonnello Alessandro di Saint-Front) svolsero un ruolo determinante negli
eventi del 1856-60, spesso per il tramite di varie reti esterne a doppia struttura (palese ed occulta),
tra cui soprattutto la Società nazionale fondata (1856) da Daniele Manin e diretta da Giuseppe La
Farina, forte di 4.000 affiliati.
I reparti dei carabinieri formarono la rete periferica del primo servizio segreto militare,
istituito nel 1855 sotto la direzione dell'avventuroso e geniale maggiore Giuseppe Govone.
Nell'ambito delle loro competenze di polizia militare (Pm), i carabinieri assicurarono il
servizio di controspionaggio (Cs), ma furono largamente impiegati anche nella branca offensiva
(ricerca e raccolta informazioni e operazioni clandestine militari e politiche).
Nel 1854-56 il corpo svolse la sua prima missione all'estero, con 52 carabinieri in Crimea
(nella base di Balaklava) e presso il comando d'armi di Costantinopoli (con distaccamento a
Yenikoi), con compiti non solo di Pm ma anche di Pg e sanitaria (connessi con l'epidemia di
colera).
Nel 1857 i carabinieri concorsero con la polizia a sventare la sommossa mazziniana di
Torino. Durante la campagna del 1859 costituirono 2 centri informativi militari appoggiati alle
stazioni di Trecate e S. Martino, e svolsero attività di ricognizione, infiltrazione e spionaggio oltre
le linee.
Nel 1860 i carabinieri cooperarono al finto colpo di mano con cui i garibaldini si
impadronirono dei due vapori della società Rubattino utilizzati per il trasporto dei Mille in Sicilia.
Secondo la sospetta testimonianza di un anonimo agente "pentito" (tradotta dal francese
dalla Civiltà cattolica), i carabinieri avrebbero adottato contro i governi preunitari le stesse
tecniche di infiltrazione messe in atto nel 1914-17 dai bolscevichi contro il regime zarista.
Ottanta, travestiti, avrebbero costituito la rete occulta impiantata da Carlo Boncompagni per
pilotare l'annessione della Toscana. Altri avrebbero inscenato finte ovazioni popolari all'ingresso
delle truppe piemontesi.
A Roma e Ancona vari carabinieri travestiti avrebbero fomentato tumulti di piazza e si
sarebbero arruolati nell'armata pontificia per indurre diserzioni, gettare il panico e colpire gli
ufficiali alle spalle. Effettivamente, a Castelfidardo (18 settembre 1860), dal 2° cacciatori
indigeni partirono fucilate contro i carabinieri svizzeri. E il carabiniere infiltrato Biambilla
sarebbe stato promosso maresciallo per aver inferto la terza ferita mortale al ventre del prode
generale Georges de Pimodan.
Epurati e riciclati
La trasformazione dei due corpi dei carabinieri piemontesi e sardi nell'Arma dei
carabinieri reali dell'esercito italiano (24 gennaio 1861) riflette lo stesso criterio politico con cui
furono costituiti e organizzati esercito, marina e amministrazione pubblica del nuovo Regno
d'Italia.
Al contrario dell'unificazione tedesca del 1870, quella italiana fu infatti plebiscitaria e non
federativa. Gli organi ed enti militari, amministrativi e giudiziari degli stati preunitari furono
semplicemente soppressi e sostituiti dalle corrispondenti strutture piemontesi, estese alle province
annesse.
Alle dotazioni organiche si provvide dove possibile con trasferimenti dal Piemonte e
nuovi reclutamenti di personale politicamente affidabile, e solo per necessità si attinse anche al
personale che aveva servito i vecchi sovrani. E' interessante osservare che nel 1990 l'unificazione
delle due Germanie è avvenuta seguendo più o meno il criterio piemontese del 1859-61.
I criteri adottati nei confronti delle vecchie gendarmerie degli stati preunitari furono
diversi. Nel 1848 i dragoni piacentini e parmensi e i gendarmi modenesi e lombardi erano stati
aggregati in blocco ai carabinieri. Ma nel 1859 solo i 375 dragoni parmensi vennero assorbiti in
blocco, conservando grado e attribuzioni. In Lombardia si preferì bandire un reclutamento
straordinario fra i cittadini di sicura fede italiana, ammettendovi però anche i 1.449 ex-poliziotti e
gendarmi del cessato governo austriaco.
Ad epurare dragoni e gendarmi estensi, pontifici e granducali provvidero i governi
provvisori dell'Italia centrale, con la consulenza di ufficiali piemontesi. Così fu abbastanza
semplice, al momento delle annessioni, trasformare guardia municipale modenese, veliti di
Romagna e legione dei carabinieri toscani in altrettante strutture periferiche dei carabinieri del
regno.
Era invece fuori questione reimpiegare su larga scala i poliziotti e i gendarmi borbonici:
almeno ai livelli inferiori erano fedeli, ma a Francesco II. In Sicilia, dove il popolo li aveva fatti a
pezzi, furono sostituiti da due distinti corpi di carabinieri, 500 reclutati dal governo dittatoriale e
100 spediti dal Piemonte dopo il plebiscito, unificati non senza problemi e contrasti. Del resto il
governo dittatoriale espulse per spionaggio La Farina, poi nominato consigliere di luogotenenza
per gli Interni e la polizia. Un autonomo corpo di militi a cavallo creato dal governo dittatoriale
rimase in servizio sino al 1877, quando, travolto dalle accuse di connivenza con la criminalità
organizzata, fu sostituito da uno speciale corpo di Ps a cavallo per le province siciliane.
Anche nelle province di qua dal Faro furono trasferiti nuclei di carabinieri
centro-settentrionali e indetti arruolamenti straordinari. Dalla vecchia gendarmeria borbonica
transitarono nell'Arma il 40 per cento degli ufficiali (61 su 150), ma appena il 3.5 per cento della
truppa (240 su 6.792). Altri furono però reimpiegati quali guardie di Ps.
Nel 1861 le forze di polizia contavano 36.000 uomini (18.461 carabinieri, 14.153 guardie
doganali e 3.463 di Ps), saliti a 40.000 nel 1862 (nel 1901 erano 53.000).
Nelle successive annessioni del 1866 (Veneto e Friuli), 1870 (Lazio) e 1919 (Trentino,
Alto Adige, Venezia Giulia, Istria e Dalmazia) l'Arma costituì i nuovi reparti territoriali con
personale già in servizio, alimentandoli attraverso il reclutamento ordinario, senza attingere ai
cessati corpi di gendarmeria austriaca e pontificia.
Prima le stazioni, poi la ferrovia
Già nel 1862 un'Italia ancora incompleta, analfabeta, rurale e priva di rete postale,
ferroviaria ed elettrica, era coperta da quella delle 2.199 stazioni dell'Arma, e pattugliata a piedi o
a cavallo dalle famose coppie di carabinieri (uno per leggere e l'altro per scrivere, oppure per
sorvegliarsi a vicenda, secondo le due note teorie affacciate al riguardo dalla voce popolare).
Questa presenza capillare dello stato non aveva precedenti: le stazioni dei carabinieri e le
brigate dei finanzieri erano infatti ben più numerose dei vecchi "posti" di gendarmeria e dogana
già parsimoniosamente stabiliti dai governi preunitari.
Il loro mantenimento era però basato sull'antico criterio fiscale (ancor oggi parzialmente
in vigore) di imporre ai comuni l'obbligo di fornire alloggio (in edifici comunali o a pigione),
casermaggio e "utensili" (paglia per i letti, legna da ardere e olio per i lumi).
Le stazioni avevano forza variabile a seconda del tipo (a piedi, a cavallo o miste) e
dell'estensione del circondario, ma da 2 a 9 uomini appena. Il comandante (generalmente un
maresciallo) era allora il terzo in rango dopo parroco e sindaco, e altrettanto autorevole del
farmacista e del maestro.
Malgrado il brigantaggio sardo e meridionale, il facile insediamento sociale di una forza
di gendarmeria reclutata fuori del circondario, e la particolare autorevolezza del comandante di
stazione, sono testimoniati da innumerevoli documenti anche letterari. Sono a tal punto penetrati
nel costume, da sembrarci naturali e scontati. In realtà, benchè i rapporti con la popolazione non
siano stati sempre e dovunque idilliaci, il consenso e il prestigio sociale dei carabinieri italiani
sembrano piuttosto anomali rispetto alle analoghe esperienze straniere.
Non era infatti scontato che i carabinieri, incaricati di vigilare sui militari di leva e di
catturare i disertori (93.532 arresti e 719 conflitti a fuoco, con 22 carabinieri uccisi e 189 feriti nel
1915-19), beneficiassero del clima patriottico determinato dalla grande guerra.
Tutti i comuni d'Europa vollero onorare i caduti con cippi e monumenti, ma solo quelli
italiani lanciarono una grande iniziativa, dal 1916 al 1933, per donare la bandiera nazionale alle
stazioni dei carabinieri (che solo nel 1917 furono autorizzate ad esporla nelle ricorrenze delle
feste nazionali).
Fino al 1915 l'Arma disponeva di un solo tipo di organizzazione: territoriale, e di reparto
operativo: la stazione. E fino al 1963 l'unico vero titolare dell'attività informativa e investigativa
era di fatto il sottufficiale comandante (brigadiere o maresciallo). Le stazioni dipendevano
gerarchicamente da tenenze e compagnie rette da ufficiali, ma questi ultimi avevano allora
funzioni essenzialmente ispettive e disciplinari. Diversamente da oggi, erano infatti meri organi
demoltiplicatori dei comandi intermedi retti da ufficiali superiori (divisioni e legioni).
Il controllo legionale delle dipendenti stazioni era analogo a quello episcopale nei
confronti delle parrocchie diocesane. Entrambi si basavano su tre elementi. Anzitutto
l'interiorizzazione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio (ottenuta attraverso selezione,
addestramento, carriera e valorizzazione istituzionale di persone di modesta estrazione sociale:
ancor oggi i comandanti di stazione hanno il loro timbro personale). In secondo luogo procedure
standardizzate (regolamenti, modelli, norme di comportamento, disciplina).
Il terzo elemento era il controllo gerarchico e ispettivo. Da notare che con la promozione a
maggiore gli ufficiali perdevano la qualifica di funzionari di polizia giudiziaria (Pg). In tal modo
il maresciallo, pur dipendendo dall'autorità giudiziaria per ogni singola indagine, continuava a
dover rispondere anche ai comandi di divisione (gruppo provinciale) e legione, sia pure
nell'ambito delle specifiche attribuzioni disciplinari e amministrative.
Ci voleva la mano forte
Lo Statuto albertino (1848) concesse la guardia civica (o nazionale) reclamata dalla
Sinistra, ma col nome meno impegnativo di "milizia comunale". Del resto aveva ben poco a
vedere con organizzazioni semisovversive come la guardia nazionale francese del 1789 e 1848, la
Landsturm prussiana del 1813 e le guardie civiche create dai governi rivoluzionari italiani del
1796-98, 1821, 1831 e 1848.
Infatti, come altre istituzioni analoghe create dai governi assolutisti, la milizia sabauda era
una semplice registrazione obbligatoria dei cittadini dai 21 ai 55 anni che potevano essere
chiamati a prestare "man forte" alle autorità preposte all'ordine e sicurezza pubblici (carabinieri
inclusi) o a sostituire nei servizi di guarnigione le truppe regolari mobilitate. Traccia di questo
istituto resta ancor oggi nell'obbligo di assistenza a legale richiesta dell'autorità di polizia (art. 16
codice di procedura penale).
Nel 1859 la milizia comunale fu ribattezzata guardia nazionale (Gn), organizzata su base
territoriale e con quadri inferiori elettivi, ed ebbe anche un modesto impiego bellico. Nel 1864 la
Gn fu dotata anche di uno speciale corpo di investigazione.
Contro il brigantaggio meridionale governo e borghesia locale accollarono il lavoro più
sporco proprio alle locali guardie nazionali (nel 1862 erano 63 compagnie e 2 squadroni, sostituiti
nel 1863 da 35 squadriglie con 753 militi specializzati nelle operazioni di controbanda),
capillarmente controllate e inquadrate dalle autorità militari e dai 4.733 carabinieri (1862)
dislocati nelle province meridionali.
In Sicilia erano 2.114, di cui 800 a Palermo (dove ebbero 53 morti nell'insurrezione del
16-23 settembre 1866). Nel primo decennio postunitario (1860-70) le legioni meridionali ebbero
361 caduti, 516 feriti e 850 decorazioni al valore.
Rimasero però meri sogni i due opposti progetti di Pisacane e Garibaldi, ispirati
rispettivamente alla milizia svizzera e alla Volunteer force britannica, di adottare la cosiddetta
"nazione armata" sostituendo coscrizione obbligatoria, regio esercito permanente e carabinieri
reali con la milizia obbligatoria o con una guardia nazionale volontaria e politicizzata.
Nonostante la querulomania dei reduci garibaldini, le cifre dimostrano che nei loro
confronti la manica dell'esercito regio fu, sia pure a malincuore, abbastanza larga. In fin dei conti
nel 1862 si presero ben 12 generali e il 35 per cento (1.387) degli ipertrofici quadri dell'esercito
meridionale (garibaldino): mica pochi, se si pensa che nel 1945 i ruoli dell'esercito accolsero
appena 85 ufficiali e 25 sottufficiali provenienti dai partigiani non militari.
Vero è, tuttavia, che almeno metà degli ufficiali ex-garibaldini rimase senza impiego
effettivo, pagati a casa solo per figurare in un ruolo speciale dei volontari, mobilitato nel 1866 al
comando di Garibaldi. Ma Custoza fornì il pretesto per archiviare questa anomala struttura (la
sottile raffinatezza dello stato maggiore regio giunse al punto di assegnare per motto alla brigata
di fanteria erede delle tradizioni dei cacciatori delle Alpi il famoso "obbedisco!" telegrafato da
Bezzecca).
Malgrado la tenace difesa fattane in parlamento da Garibaldi, anche la Gn fu soppressa nel
1876, e sostituita dalla milizia (mobile e territoriale), cioè dal complesso dei militari di leva in
congedo inquadrati dagli ufficiali della riserva e di complemento in unità di prevista
mobilitazione.
Rurales a chi?
Neppure l'ideologia economica della Destra (1861-76) riuscì a domare la lussureggiante
burocrazia sabauda. Per qualche anno la politica del bilancio in pareggio potò tutti i settori
dell'amministrazione, ma l'unico risultato fu di ridurne l'efficienza, senza riuscire ad accorparli. E
alla fine la necessità di alimentarli costrinse alla dilatazione della spesa pubblica, da cui il potere
politico trasse inestimabili benefici.
Nel 1878 il governo Cairoli attribuì la funzione di capo della polizia al ministro degli
Interni, ma non si arrestò la tendenza alla proliferazione dei corpi di polizia e alla sovrapposizione
delle competenze.
Fra i primi atti del terzo governo Depretis (1881-87) vi fu la militarizzazione delle guardie
doganali (dipendenti dalla Direzione generale delle gabelle) trasformandole in guardia di finanza
(Gdf), e attribuì ai suoi ufficiali funzioni di Pg (estese ai marescialli nel 1906 e a tutti i
sottufficiali nel 1923). Analogo sviluppo riguardò il corpo delle capitanerie di porto dipendenti
dalla marina.
In teoria si poteva bilanciare lo sviluppo delle polizie speciali con l'accorpamento di
quelle generali, ma l'Italia è storicamente refrattaria ad una simile concentrazione di potere, che
neppure Mussolini riuscì a realizzare. Il governo Crispi (1887-96) pensò allora di ridurre la
sovrapposizione tra polizia e carabinieri ripartendo non già le competenze bensì la giurisdizione
territoriale: le città alle questure, e la campagna alle stazioni dei carabinieri.
La relazione 23 maggio 1887 del comando generale dell'Arma prevedeva di esonerare i
carabinieri dai servizi di Ps all'interno delle 14 città sede di questura, lasciando loro soltanto
l'assistenza ai tribunali e consigli di leva, la traduzione dei detenuti e la sorveglianza delle aree
suburbane e dei nodi stradali.
In questo modo si contava di risparmiare 557 carabinieri e 62 stazioni. A Roma ne
sarebbero rimaste solo 2 (quelle "storiche" di piazza del Popolo e S. Lorenzo in Lucina) più 2
nuove suburbane (Porta Portese e Regio parco), dimezzando i 279 carabinieri in servizio nella
capitale (ora sono cinquanta volte tanti).
Probabilmente il progetto rifletteva le ambizioni della aristocratica aliquota a cavallo
(ignara che invece del potenziamento sperato, stava per essere soppiantata dal non ancora
proletario velocipede, adottato nel 1896).
Le leggi 23 dicembre 1888 e 21 dicembre 1890 lasciarono però la direzione del servizio di
Ps ai prefetti e sottoprefetti, mentre alla Ps rimasero gli stessi compiti esecutivi dei carabinieri.
Andò anzi a finire che la "ruralizzazione" dell'Arma si risolse nel puro e semplice declassamento
del corpo guardie di Ps, ribattezzato con legge 21 dicembre 1890 corpo guardie di città. Nel
marzo 1892 fu sciolto anche lo speciale corpo di Ps a cavallo della Sicilia, sostituito dai
carabinieri.
Solo nel dicembre 1897, a seguito delle polemiche suscitate dal primo attentato anarchico
contro Umberto I, si ebbe una redistribuzione delle competenze limitatamente alla sola capitale.
La questura fu soppressa e il prefetto assunse anche la direzione del servizio di Pg all'interno della
cinta daziaria, riservato in via esclusiva a 62 funzionari e 220 agenti di polizia in borghese,
affiancati da 32 ufficiali subalterni e 1.553 graduati e guardie di città del corpo speciale di Roma
(inclusa la scuola allievi di Trastevere).
Fu poi potenziata la polizia politica, creando il casellario politico centrale (1896), la
scuola superiore di polizia (1902) e i servizi di informazioni riservate (1901) e di intercettazione
(1903). Nel 1907 la Gdf fu inclusa tra i corpi militari e sottoposta ad uno specifico ispettorato del
ministero della Guerra, abolito nel 1920.
I cannoni di Bava Beccaris
Nel 1794 gli ordini del general comando delle armi pontificie vietavano alla truppa di
"framischiarsi" coi "birri", non essendo "mai del decoro di un soldato" l'aver a che fare "con simil
sorta di gente". La pensava così anche Giuseppe Guerzoni, già segretario di Garibaldi, quando
scrisse (1879) che "l'ideale militare del borghese si ferma al carabiniere".
Leggermente aumentati nel 1880, ancora nel 1899 i carabinieri erano soltanto 25.603, più
18.267 finanzieri, 9.238 poliziotti e 7.320 guardie campestri, daziarie, boschive e comunali.
Come all'epoca dell'antico regime, a molti servizi oggi espletati dalle forze di polizia (ordine
pubblico, sorveglianza esterna delle carceri) provvedeva abitualmente l'esercito, sia pure alle
temporanee dipendenze dell'autorità di Ps, con prevalenza gerarchica, a parità di grado, dei
carabinieri (proprio per questo il grado di carabiniere corrisponde a quello di caporale, e quello di
allievo carabiniere a soldato).
E non sempre bastavano le unità attive: nel 1898, 1902 e 1904 fu necessario richiamare in
servizio di ordine pubblico 130.000, 102.000 e 65.000 riservisti. A cavallo del secolo, la
repressione militare delle lotte sociali fece almeno 426 vittime civili: 101 nel 1893-94 (92 in
Sicilia e 9 a Carrara), 129 nel 1898 (di cui 80 a Milano, con 450 feriti), 126 nel periodo 1901-15,
almeno 70 negli scioperi torinesi del 1916-17.
Indipendentemente dalla controversa costituzionalità dello stato d'assedio, anche
nell'attuale ordinamento repubblicano le autorità militari conservano le stesse competenze in
materia di ordine e sicurezza pubblici e di eventuale assunzione dei poteri civili (norme Apam)
che avevano nell'ordinamento albertino.
L'art. 19 della legge comunale e provinciale (1934) pone le autorità militari alle
dipendenze dei prefetti, sullo stesso piano dei questori (anche se oggi un ventesimo dei prefetti
proviene dai questori). Fu Randolfo Pacciardi, il ministro della Difesa più popolare tra i vecchi
ufficiali, ad emanare il nuovo regolamento del servizio territoriale e di presidio del 28 ottobre
1948 (disponeva tra l'altro di evitare il fuoco indiscriminato e mirare ai caporioni) e la circolare n.
400 del 1° giugno 1950 sull'impiego delle forze armate nei servizi di ordine pubblico. Più
pudicamente l'art. 1 della legge n. 382 del 1978, approvata poco dopo l'uccisione di Aldo Moro,
attribuisce alle tre forze armate anche compiti di "concorso alla salvaguardia delle libere
istituzioni".
Quelle competenze sono state croce e delizia dell'esercito. Da un lato gli hanno consentito
di giustificare l'ipertrofia delle strutture territoriali e spesso organici doppi o tripli rispetto alle
striminzite risorse finanziarie. Ma dall'altro gli hanno cronicamente impedito di addestrare la
truppa, ne hanno svilito la connotazione guerriera, e a cavallo del secolo lo
corresponsabilizzarono nella repressione antisocialista e antipopolare.
La sua attuale immagine ha tratto un indubbio beneficio dal cosiddetto impiego contro la
criminalità organizzata (operazioni "Forza Paris", "Vespri Siciliani", "Riace"): tanto che da
almeno un decennio di fronte ad ogni nuova "emergenza" si invoca l'intervento dell'esercito.
Cionondimeno gli è accaduto di celebrare il centenario di Adua più o meno nelle stesse
condizioni riferite alla camera del 1896 dal ministro della Guerra generale senatore Luigi Pelloux:
"l'esercito esiste sì, ma pel mantenimento dell'ordine pubblico, ed è alla completa disposizione
della pubblica sicurezza". Con la sola differenza che oggi carabinieri e poliziotti sono sei volte
più numerosi che cent'anni fa.
La prima guerra civile del XX secolo
Tuttavia i fasci d'arme in piazza Duomo e le cannonate del generale Bava Beccaris (1898)
segnarono una svolta decisiva. La campagna antimilitarista, la dissidenza interna degli ufficiali
modernisti, le prime agitazioni sindacali dei sottufficiali, resero sempre più difficile il ricorso
all'esercito.
Già nel primo decennio del XX secolo gli effettivi dei carabinieri salirono a 30.000 e il Rd
24 dicembre 1911 fissò una duplice dipendenza dell'Arma: dal ministero della Guerra
relativamente ad ordinamento, disciplina, amministrazione, riparto territoriale, servizio militare e
servizio leva e mobilitazione, e dal ministero dell'Interno per il servizio d'ordine e sicurezza
pubblica.
Con i Rd 14 agosto e 2 ottobre 1919 il governo Nitti sostituì il corpo delle guardie di città
con due nuovi corpi, uno di agenti investigativi in borghese e uno di regie guardie per la Ps, con
ordinamento militare analogo a quello dei carabinieri, al comando di un tenente generale e con
377 ufficiali e 25.000 guardie, salite nel 1921 a 40.000.
E' da notare che nel primo dopoguerra corpi di ordine pubblico analoghi alla guardia regia
furono istituiti anche in altri paesi a rischio di guerra civile, come la garde républicaine mobile
francese (1921), la schutzpolizei tedesca (1920), i reparti mobili della gendarmeria belga (1919),
le truppe di sorveglianza volontaria svizzere (1919-20). In ritardo, si aggiunse in Spagna la
guardia de seguridad y asalto (1931).
L'Arma reagì a questa invasione di campo raddoppiando l'organico d'anteguerra (60.000) e
dotandosi per la prima volta di una autonoma forza di ordine pubblico, svincolata dai comandi di
presidio e soprattutto dalla rivale guardia regia. Già nel febbraio 1917 furono arruolati 18.000
carabinieri ausiliari da trattenere per sei mesi dopo la fine della guerra. Nel 1919 all'Arma fu
assegnato un contingente di militari di leva, scelti d'autorità e non, come adesso, a domanda, per
costituire 18 battaglioni (12.282). Erano dislocati nelle principali città (3 a Roma, 2 a Torino,
Milano e Napoli, 1 ad Alessandria, Genova, Verona, Bologna, Firenze, Ancona, Bari, Palermo e
Catania) a disposizione dei comandi legionali e superiori. Contavano ciascuno 743 o 764 effettivi
con 2 o 4 mitragliatrici, biciclette e qualche autocarro.
Nel 1919-23 si ebbero almeno 2.500 morti per disordini e conflitti politici, di cui 428
fascisti. In soli 18 mesi (1920-21) vi furono 461 morti e 2.091 feriti, di cui 75 e 506 tra le forze
dell'ordine. Nel triennio 1919-22 i soli carabinieri svolsero 233 operazioni, con 43 morti, 474
feriti e 119 decorati al valore, tra cui 2 medaglie d'oro alla memoria.
Tuttavia agli occhi delle classi dominanti, terrorizzate dalla rivoluzione sociale, il
richiamo al combattentismo e la difesa dell'ordine sociale attenuavano la pericolosità del
sovversivismo politico del fascismo. Ciò garantì agli squadristi ampia tolleranza, parzialità e
talora connivenza e sostegno da parte di singoli militari e settori deviati dell'apparato di sicurezza
dello stato: ma non dei loro vertici, e tantomeno della magistratura.
Nel 1931 una ex-squadra d'azione formata interamente da carabinieri imbarazzò
Mussolini chiedendo il riconoscimento della qualifica di "antemarcia". Ma dieci anni prima (23
luglio 1921), a Sarzana, erano stati i 13 carabinieri del capitano Jurgens, nipote dell'onorevole
Barzilai, ad arrestare la squadraccia senese di Renato Ricci e poi a mettere in fuga la colonna di
400 squadristi capeggiata da Amerigo Dumini, futuro sicario della "ceka" del Viminale e
assassino di Giacomo Matteotti (i carabinieri abbatterono a fucilate i primi 10, la reazione
popolare altri 36).
Del resto, come era avvenuto nei confronti dei legionari fiumani, contro la marcia su
Roma esercito e carabinieri avevano predisposto le adeguate contromisure decise dal governo
legittimo. Fu il re a negare la firma allo stato d'assedio accettando da Mussolini "l'Italia di
Vittorio Veneto".
Ma ancora il 30 ottobre 1922, a Cremona e Bologna i carabinieri spararono contro i
fascisti che pretendevano di occupare caserme e campo d'aviazione. Il 2 novembre 1926, a
Genova, gli squadristi spararono contro i carabinieri che difendevano la sede del Lavoro,
uccidendone uno e provocando una ferma protesta dell'Arma. Sandro Pertini ricordò la solidarietà
privatamente espressagli da un anonimo maresciallo, figlio di un socialista turatiano, dopo la
condanna inflittagli dal tribunale speciale per la difesa dello stato (1929).
Va ricordato, inoltre, che anche gli arditi del popolo (anarco-socialisti) trovarono qualche
isolato appoggio nell'esercito e nella guardia regia. Quest'ultima si attirò l'odio dei fascisti dopo la
sparatoria di Modena (26 settembre 1921), dove gli agenti, aggrediti da una colonna fascista per
essersi rifiutati di salutare i gagliardetti, uccisero 8 camicie nere.
E' interessante osservare che anche nella seconda repubblica spagnola (1931-39)
l'orientamento politico dei corpi di sicurezza interna fu in parte determinato dalle loro rivalità
istituzionali. Nell'esercito spagnolo la spaccatura fu essenzialmente generazionale e di classe: si
ribellarono i quadri intermedi, mentre la massa dei generali e degli ex-sottufficiali neopromossi e
sindacalizzati rimase fedele alla repubblica. Invece gli altri corpi si comportarono in modo
relativamente più omogeneo: nella guardia civil (gendarmeria) prevalsero le destre, nei
carabineros (finanzieri) i massoni di sinistra e negli asaltos (polizia armata) i comunisti.
Moschettieri del re e guardie del cardinale
Nel suo primo governo Mussolini assunse l'interim dell'Interno (sottosegretario Aldo
Finzi), nominò il quadrumviro Emilio De Bono intendente generale di Ps (dal 20 dicembre 1923
capo della polizia), pose la Gdf alle dirette ed esclusive dipendenze del ministro delle Finanze, le
attribuì il servizio di polizia tributaria e investigativa, qualificò i carabinieri unica forza armata in
servizio permanente di Ps, e sciolse l'odiata guardia regia.
In 14 città migliaia di agenti epurati si ammutinarono inneggiando a Lenin e Nitti. I
carabinieri si occuparono della repressione, e a Torino, dove ebbero il rinforzo di autoblindo,
squadristi e alpini, ci furono 5 morti.
Transitoriamente, guardie regie e agenti investigativi furono assorbiti a domanda dalla
Gdf e dai carabinieri. Questi ultimi costituirono il cosiddetto ruolo specializzato dell'Arma, con
108 ufficiali e 7.000 agenti (4.800 inquirenti, 1.200 tecnici e 1.000 vigilanti).
La forza "non permanente" di Ps fu costituita (1° febbraio 1923) dalla milizia volontaria
per la sicurezza nazionale (Mvsn), definita da Mussolini "guardia della rivoluzione" e "pupilla del
regime", formata dagli ex-squadristi e poi alimentata dalle nuove leve del Pnf.
Lo statuto del regno riservava al re il comando di tutte le forze di terra e di mare. Invece la
Mvsn fu posta alle dirette ed esclusive dipendenze del capo del governo. Il carattere diarchico del
nuovo sistema politico fu in seguito emblematizzato dalla speciale guardia del corpo voluta da
Mussolini, i famosi moschettieri del duce che montavano la guardia a Palazzo Venezia,
"contraltare" specifico dei corazzieri quirinalizi.
Per quanto possa oggi sembrare sorprendente, l'attribuzione di compiti dello stato a quello
che si autodefiniva esplicitamente come il "partito armato" del fascismo, non suscitò allora
particolare sdegno ed allarme nell'opposizione.
Solo dopo la crisi determinata dall'assassinio di Matteotti, Mussolini costrinse la Mvsn a
prestare giuramento al re (28 ottobre 1924) e a trangugiare l'"ingranamento" nell'esercito che le
risparmiò lo scioglimento meditato dai generali.
Le 483 coorti territoriali della Mvsn resero superflui i battaglioni carabinieri (ne rimasero
solo 4 mobili) e consentirono di ridurre gli effettivi dell'Arma fino al minimo di 47.000 (1935).
Ma, come denunciò in senato l'ex-socialista Ettore Ciccotti, nel primo quadriennio del regime le
spese per la sicurezza pubblica crebbero di sette volte, dai 132 milioni del 1922-23 ad oltre un
miliardo (cioè da 180 a 1.250 miliardi in lire attuali). Nel 1937-38 sfiorarono 1.5 miliardi (1.800
attuali. Oggi superano i 30.000).
Nel breve periodo in cui il ministero dell'Interno fu retto da Luigi Federzoni (1924-26) fu
inoltre ripristinata l'autonomia della polizia. Nel 1925 fu ricostituito il corpo degli agenti di Ps
(12.000), inclusa una divisione speciale metropolitana della capitale (5.000) con annessi scuola
tecnica e reparto a cavallo, che fino al 1944 svolse anche le funzioni dei vigili urbani.
A seguito delle polemiche per i falliti attentati del 1926, Mussolini nominò il giovane
Arturo Bocchini capo della polizia, riassunse l'interim dell'Interno (sottosegretario Leandro
Arpinati, poi dal 1933 Guido Buffarini Guidi), costituì una speciale polizia politica del ministero
(Ovra) e creò il servizio di investigazione politica della Mvsn con 132 uffici (Upi) dipendenti
dalle legioni ordinarie.
Alla Mvsn appartenevano anche una milizia confinaria (1925) e 5 milizie speciali
(1923-28) di polizia, assegnate ai ministeri delle Comunicazioni (ferroviaria, portuale,
postelegrafonica, della strada) e dell'Agricoltura e foreste (forestale: correlata anche alla
liquidazione degli "usi civici" attuata dal regime). Nel dicembre 1930 contavano 24.169 uomini,
di cui solo un quarto permanenti.
Ma la valorizzazione della polizia proseguì con l'istituzione della banda e della festa di
corpo (1928), la concessione della bandiera di guerra (1930), l'istituzione dei servizi cinofilo
(1930) e marittimo (1931) e delle divisioni speciali metropolitane per Napoli (1937) e Palermo
(1939). Dal 1927 al 1937 i funzionari aumentarono da 1.651 a 1.799 e gli agenti da 15.000 a
17.699. Nel decennio il complesso delle forze di polizia crebbe da 100.000 a 120.000 uomini,
metà dei quali carabinieri.
E' però significativo che nel 1929 il regime abbia preferito attribuire ai carabinieri,
anzichè alla Mvsn o alla Ps, il servizio di vigilanza alle dipendenze dell'Ispettorato del lavoro
istituito nel quadro della riforma corporativa.
Inoltre varie iniziative collaterali rinforzarono la coesione interna e l'immagine dell'Arma.
Tra queste l'erezione in ente morale del museo storico (1925) e della federazione (poi
associazione) nazionale dei carabinieri in congedo (1928), l'istituzione della cassa di previdenza
(1929) e del carosello storico di Villa Borghese (luglio 1933), la grande sottoscrizione per il
monumento al carabiniere che raccolse 3 milioni di lire (quasi 5 miliardi attuali), destinando
l'eccedenza ad una fondazione filantropica.
Il monumento, realizzato da Edoardo Rubino, fu inaugurato a Torino il 22 ottobre 1933
(evitando la coincidenza con l'11° anniversario della marcia su Roma). Altra manifestazione fu il
raduno romano di 15.000 carabinieri in congedo in concomitanza con l'inaugurazione (5 giugno
1937) della nuova e definitiva sede del museo storico in piazza Risorgimento (già sede, nel
1906-1925, della scuola marescialli allievi ufficiali).
Faccetta nera
Parte integrante dell'esercito, fin dal 1815 (carica di Grenoble in Delfinato) i carabinieri
hanno preso parte a tutte le campagne di guerra anche con reparti combattenti. Inoltre dal 1912 al
1918 ben 173 carabinieri passarono in aviazione come tecnici o piloti: e tra questi Ernesto
Cabruna, uno degli "assi" italiani della grande guerra.
I nomi assegnati nel 1936 alle divisioni territoriali di Milano e Roma (Pastrengo e
Podgora) ricordano appunto le maggiori imprese belliche: la carica del gruppo squadroni del
quartier generale a Pastrengo (30 aprile 1848) e l'assalto del reggimento mobilitato (53 morti, 143
feriti e 55 decorati) sul monte Podgora (19 luglio 1915).
Quello assegnato nel 1938 alla 3a divisione di Napoli (Ogaden) ricorda invece le
operazioni del gruppo bande autocarrate sul fronte somalo (2 febbraio e 24 aprile 1936), dove
furono impiegati 1.123 carabinieri, 3.143 zaptié e 2.500 dubat. Comandante superiore dei reparti
mobilitati per la guerra italo-etiopica era il generale Azzolino Hazon. Ebbero 208 caduti, 800
feriti e 596 decorazioni.
Nelle colonie africane le funzioni di Pm, Pg e Ps furono tendenzialmente accentrate a
speciali reparti coloniali dell'Arma integrati da personale indigeno (zaptié).
Il più antico reparto coloniale fu la compagnia carabinieri d'Africa istituita a Massaua nel
1885 e trasformata nel 1918 in autonomo corpo di polizia. Nel 1912 aliquote di zaptié eritrei
furono trasferite in Tripolitania e Cirenaica alle dipendenze dei rispettivi reparti carabinieri, che
solo in seguito arruolarono personale libico. Fu un carabiniere ausiliario a catturare il famoso
capo della resistenza libica Omar al-Mukhtar, giustiziato il 16 settembre 1931.
Il regio corpo di polizia della Somalia risale al 1905. Nel 1923 l'ambizioso governatore De
Vecchi di Val Cismon lo potenziò, dotandolo di un plotone d'onore a cavallo e ribattezzandolo
corpo zaptié della Somalia. Dopo la spietata occupazione militare della Migiurtina e
dell'Oltregiuba, nel 1933 fu però ridotto a compagnia carabinieri della Somalia.
Nel 1938 i reparti d'oltremare contavano 6 gruppi in Aoi (Addis Abeba, Gondar,
Mogadiscio, Gimma, Asmara e Harar), 2 in Libia (Tripoli e Bengasi) e 1 a Rodi.
Tuttavia anche nelle colonie carabinieri e zaptié furono affiancati dalle guardie carcerarie
e doganali (Gdf), dalla polizia commissariale indigena (gogle) e dalle guardie di polizia (ilalo) e
campestri (sagal) dipendenti dalle regie residenze, nonchè da bande irregolari di frontiera, come i
dubat somali.
In seguito si aggiunsero la milizia coloniale, le guardie forestali, e infine la polizia
coloniale (1936), poi ribattezzata polizia Africa italiana (1939). Dotata anch'essa di personale
indigeno, ma anche di automezzi e autoblindo di cui i reparti africani dell'Arma erano sprovvisti,
la Pai del colonnello Maraffa era un corpo piccolo ed elitario, con ufficiali decisi e ambiziosi,
naturali antangonisti dei carabinieri, alle dirette dipendenze del ministero delle Colonie (poi
dell'Africa italiana).
Culqualber
Alla guerra di Spagna (1936-39) presero parte 649 carabinieri (9 caduti, 33 feriti e 163
decorati). Al 30 settembre 1937 il corpo truppe volontarie (Ctv) contava 509 carabinieri e 1
ispettore dei servizi di polizia (colonnello Ugo Luca). Nel 1939 l'Arma assorbì parte dei 3.116
gendarmi albanesi in 2 nuove legioni (Tirana e Valona) con 3.849 carabinieri.
Nelle operazioni di grande Pm in Aoi (1937-40) e durante la guerra 1940-43 l'Arma ebbe
2.000 caduti e 578 dispersi e fu presente su tutti i fronti con 410 sezioni, 19 compagnie, 1 gruppo,
1 squadrone e 37 battaglioni (di cui 1 paracadutisti).
Sul fronte greco-albanese furono impiegati 6.186 carabinieri (generale Crispino
Agostinucci) con 90 morti e 295 feriti. Il III battaglione si distinse sulla Vojussa, a Ponte Perati
(20-21 novembre 1940) e Klisura (15 dicembre-2 gennaio). Altri (XIV, XX, IX) furono impegnati
in operazioni di Pm e controguerriglia in Jugoslavia e Albania.
In Russia (Armir) operarono 1 battaglione (XXVI) e 45 sezioni di Pm. Qui si verificò la
maggior concentrazione di perdite della storia dell'Arma: 1.300 carabinieri, poco meno di quelli
caduti durante la grande guerra (durante le campagne del Risorgimento furono appena 9). Il
capitano Dante Jovino e il tenente Salvatore Pennisi, condannati da un tribunale sovietico, furono
rimpatriati solo nel 1954.
Ma gli episodi più noti si svolsero in Africa orientale. Al comando del generale Leonetto
Taddei, i carabinieri si distinsero nella difesa di Cheren (15-18 marzo 1941) e dell'Amba Alagi
(maggio). In novembre, nella sacca di Gondar, il 1° gruppo mobilitato (226 nazionali e 180 zaptié
eritrei) si immolò nella disperata difesa del costone dei roccioni, perno del caposaldo di
Culqualber.
In dicembre, dopo la resa degli ultimi reparti, il maggiore dei carabinieri Domenico
Lucchetti organizzò un efficiente fronte clandestino di resistenza, in contatto radio con Roma e
dotato di una organizzazione fiancheggiatrice (associazione figli d'Italia). Lucchetti fu catturato
nell'ottobre 1942.
Radio Londra citò con ammirazione la "leonina" resistenza (33 morti e 37 feriti) opposta il
19 e 20 dicembre 1941, al bivio di Eluet el Asel (Libia), dal 1° battaglione carabinieri
paracadutisti (1940-42), incaricato di proteggere la retroguardia italiana in ritirata lungo la via
Balbia. Il suo comandante, Edoardo Alessi, cadde poi da partigiano in Valtellina (26 aprile 1945).
Nel settembre e dicembre 1942 il XVIII battaglione svolse un ruolo essenziale nella difesa di
Tobruk.
Nel giugno 1943, alla vigilia dello sbarco in Sicilia, l'Arma contava 145.000 uomini, di
cui 35.000 fuori del territorio nazionale. Il 3 agosto, appena decisa l'evacuazione dell'Isola, fu
costituito il comando carabinieri Sicilia (generale Ernesto Sannino) per assicurare il servizio di
istituto anche dopo l'occupazione nemica.
Tuttavia fino al 18 novembre il governo militare alleato (Amgot) considerò i carabinieri
prigionieri di guerra sulla parola, impiegandoli disarmati e con bracciale Amgot alle dipendenze
della Pm alleata. Con la conseguenza di diminuirne il prestigio a tutto vantaggio della mafia, che
del resto era il vero referente politico del colonnello americano Charles Poletti.
Fedeli al giuramento
Nei combattimenti dell'8 e 9 settembre nuclei di carabinieri, spesso rinforzati da personale
in congedo, si batterono a Bolzano, Tolmino, Tortona, Cremona, Reggio, Terni, Orte, Teramo,
Nola, Benevento, Casoria, e in Puglia, Sardegna e Corsica. Ancora il 10 settembre, alla stazione
centrale di Milano, si opposero ai tedeschi e ne catturarono 60.
Nel porto di Napoli i tedeschi fucilarono 14 carabinieri presi in ostaggio. Durante le
quattro giornate (28 settembre - 1° ottobre) le caserme dell'Arma furono i principali capisaldi
degli insorti.
A Roma, al momento dell'armistizio, le forze di polizia contavano 18.000 uomini: 9.000
carabinieri e 2.600 finanzieri (di cui 4.000 e 1.400 impiegabili), più 1.300 agenti Pai con carri L e
16 autoblindo, 1 battaglione mobile di Ps e 5.000 metropolitani (militarizzati da Badoglio il 10
agosto 1943).
Tuttavia negli scontri del 9 settembre si distinsero soltanto due unità di carabinieri, il 2°
battaglione allievi e il gruppo squadroni, che ripresero ai tedeschi il caposaldo n. 5 del settore
Magliana e lo tennero per l'intera giornata (17 morti e 48 feriti).
Il 10 settembre il comando della città aperta di Roma attribuì le funzioni di capo della
polizia al comandante della Pai Maraffa, ma i servizi di Pg e Ps restarono di competenza dei
carabinieri. Alcuni piccoli reparti tentarono di opporsi all'occupazione tedesca, attuata in palese
violazione dell'accordo appena sottoscritto, e focolai di resistenza rimasero attivi fino al 16
settembre: in questa fase furono disarmati 1.700 carabinieri. Il 6 ottobre i tedeschi trasferirono
alla Pai anche i servizi di ordine pubblico, e il 7 circondarono le caserme dei carabinieri
forzandone alcune dopo aspri combattimenti.
Tuttavia, grazie alle misure predisposte, circa 7.000 carabinieri poterono sottrarsi alla
cattura, nascondere la bandiera dell'Arma nei sotterranei del museo storico e formare 5 reti
clandestine (Manfredi, Hazon, Filippo, Montesacro, Mosconi).
Aggregate poi nei gruppi Aversa e Blundo, in novembre confluirono nel fronte
clandestino carabinieri (generale Filippo Caruso). Dal fronte dipendevano un centro radio in
collegamento con Bari, una rete informativa, un raggruppamento territoriale (2.850) e uno mobile
(2.900) costituito da 23 bande esterne operanti in Italia centrale.
Formalmente il fronte di Caruso era inquadrato in un più ampio fronte militare clandestino
assieme alle analoghe organizzazioni occulte delle altre armi e della Gdf, ma di fatto era il più
numeroso, efficiente ed autonomo.
A Roma il fronte svolse soprattutto attività informativa a favore degli alleati, ma anche
numerose azioni di sabotaggio e guerriglia (85 caduti, 42 feriti, 129 arrestati e 50 deceduti per
altre cause).
Vari carabinieri furono catturati e torturati a via Tasso, e 12 (6 ufficiali, 3 sottufficiali, 2
carabinieri e 1 corazziere) trucidati il 24 marzo 1944 alle Fosse Ardeatine. Lo stesso Caruso fu
arrestato il 29 maggio 1944, ma riuscì ad ingoiare l'organigramma del fronte, e poi ad evadere e
riassumerne il comando in tempo per cooperare alla liberazione di Roma.
Alla Resistenza presero parte 13.850 carabinieri (5.857 nel fronte clandestino, 7.166 in
Alta Italia e 827 all'estero). In territorio nazionale operarono 51 bande carabinieri patrioti. Le più
note agirono nel Teramano (Bosco Martese), a Radicofani (Tassi), in Valsesia (Ballerani) e
Valtellina (Alessi), a Padova (Marcello), Bergamo ("Barba") e Milano ("Gerolamo"). Al
momento dell'insurrezione quest'ultima (maggiore Ettore Giovannini) contava 700 uomini.
Ma i carabinieri confluirono anche in formazioni a carattere politico, come la brigata
Matteotti del Monte Grappa, e talora ne assunsero il comando, come nel caso della 1a divisione
giustizia e libertà di Piacenza (tenente Fausto Cossu), della 2a divisione ligure unificata
Centocroci (carabiniere garibaldino Federico Salvestri) e delle brigate 46a e 47a Garibaldi (Valli
di Lanzo-Canavese) e 5a giellina di Firenze.
In Albania (dove il 1° settembre 1943 era stata formalmente ricostituita l'autonoma
gendarmeria albanese), il comandante della legione di Tirana, colonnello Giulio Gamucci,
raccolse una colonna di 2.000 uomini, metà dei quali carabinieri. Decimata da tedeschi e
partigiani, la colonna finì per sbandarsi. Duecento carabinieri raggiunsero una formazione
partigiana italiana (comando truppe della montagna). Un centinaio, con Gamucci, vennero fucilati
dai partigiani a Burreli il 16 ottobre 1943.
A Cefalonia i tedeschi fucilarono 21 carabinieri. A Spalato 100 del IX battaglione
riuscirono ad imbarcarsi per l'Italia. Altri 200 formarono il nucleo della brigata partigiana Italia.
In Montenegro la divisione partigiana Garibaldi ne contava 550 (398 morti e dispersi, 58 feriti, 94
superstiti).
Il 12 settembre la legione di Bari (colonnello Romano Dalla Chiesa) formò un comando
cc Italia meridionale, dove si raccolsero altri 3.000 carabinieri. Il 15 novembre divenne comando
cc Italia liberata, estendendo la sua giurisdizione anche su Campania, Calabria, Sicilia e
Sardegna, e fu indetto un primo reclutamento straordinario (8.600).
Una unità speciale, il "contingente R" (2.300), fu assegnata alle armate alleate con
l'incarico di ricostituire comandi e stazioni nei territori liberati. Dopo aver contribuito allo sbarco
di Anzio (6 morti e 32 feriti) e alla liberazione di Roma, l'8 giugno 1944 venne fuso con il fronte
clandestino, ripristinando il comando generale dell'Arma. Numerosi carabinieri furono impiegati
anche nel counter intelligence corps (Cic) americano.
,elle mani del nemico
Per ordine del governo Badoglio, l'aliquota territoriale continuò ad assicurare i servizi di
istituto anche nel territorio occupato dai tedeschi. Tuttavia il carteggio fu opportunamento
selezionato, l'armamento pesante occultato e dove possibile comandi e stazioni divennero centri
di resistenza clandestina. Si deve tuttavia considerare la particolare costrizione in cui venne a
trovarsi il personale anziano e coniugato.
Il 27-28 gennaio 1944 la stazione di Campione d'Italia, enclave in territorio svizzero,
appoggiò il colpo di mano antifascista che consentì di farne una importante base informativa e
logistica della Resistenza in Alta Italia.
Ma i casi più famosi furono quelli delle stazioni di Palidoro e Fiesole, illustrate dal
sacrificio del brigadiere Salvo D'Acquisto (23 settembre 1943) e dei tre carabinieri Vittorio
Marandola, Fulvio Sbarretti e Alberto La Rocca (12 agosto 1944), consegnatisi al plotone
d'esecuzione per evitare rappresaglie contro civili inermi.
L'esecuzione di Ettore Muti (24 agosto 1943) aveva rinfocolato l'antico odio squadrista nei
confronti dell'Arma. I duri e puri di Salò cantavano: "hanno ammazzato Ettore Muti / la
pagheranno cara, / mille carabinieri / andranno nella bara".
A Renato Ricci, poi, già comandante generale della gioventù italiana del littorio (Gil) e
creatore della nuova guardia giovanile legionaria (Ggl), bruciava anche il ricordo dei 16 camerati
ammazzati a Sarzana. L'8 dicembre 1943 Mussolini gli dette l'occasione di vendicarsi
nominandolo comandante generale della guardia nazionale repubblicana (Gnr) derivata dai resti
della Mvsn. Il 24 dicembre vi confluirono formalmente le milizie speciali, i reparti romani della
Pai e l'aliquota territoriale dei carabinieri. Trasferito al Nord, il 10 gennaio 1944 il comando
generale fu ridotto a ufficio stralcio.
In realtà l'incorporazione dei carabinieri nella Gnr si ridusse alla sostituzione delle stellette
monarchiche col gladio e l'alloro repubblicani, e all'abolizione formale di comandi già di fatto
disattivati (generale, di brigata e di legione), passando i comandi di gruppo alle dipendenze delle
legioni Mvsn, trasformate in comandi provinciali della Gnr.
Non fu una buona idea quella di rinforzare (e controllare) le stazioni con aliquote della
Ggl, cioè i 18.000 ragazzi che avevano risposto all'arruolamento volontario indetto da Ricci nel
settembre 1943. Ricordiamo un episodio, l'attacco (23 febbraio 1944) della banda partigiana di
Silvio Corbari contro la stazione appenninica di Galeata di Forlì: i 7 militi furono massacrati, i 5
carabinieri si unirono ai partigiani, brigadiere e maresciallo si eclissarono. Poco dopo Corbari
uccise il comandante della stazione di Tredozio.
Nel gennaio 1944 la Gnr contava 140.000 uomini, di cui 121.000 in Italia e 19.000
all'estero. In marzo l'aliquota carabinieri costituiva il 36 per cento degli effettivi in territorio
nazionale (790 ufficiali, 8.523 sottufficiali e 35.155 appuntati e militi).
Nel giugno 1944 il maresciallo dell'aria Hermann Goering pretese da Mussolini 10.000
militari destinati alla contraerea tedesca in Germania. La scelta cadde sulla Gnr e Ricci la
indirizzò sull'aliquota carabinieri, di cui ben a ragione diffidava. La voce dell'imminente
rastrellamento provocò un'ondata di diserzioni (2.382 solo nel primo mese). Il 6 luglio 1944 i
3.000 carabinieri di Trieste, Pola e Fiume furono disarmati dai tedeschi nel momento in cui
assunsero il governo diretto del Litorale Adriatico (Ozak), e inclusi nel contingente. In una lettera
del 9 agosto a Goering, Mussolini valutava di avergli già fornito 7.600 carabinieri. Il 25 aprile
1945 gliene restavano forse 15.000.
L'ultima carica a cavallo
Nell'ottobre 1944 la Missione militare alleata (Mmia) valutò l'ipotesi di trasformare
l'esercito italiano in una semplice forza di sicurezza interna (constabulary force) dotata di
armamento leggero, e di abolire i carabinieri "perchè inefficienti e inutili".
Ma lo scoppio della guerra civile in Grecia e le iniziative del Cln Alta Italia per creare una
polizia partigiana indussero l'alto comando alleato a scegliere la soluzione opposta. In novembre
decise di favorire l'arruolamento nei carabinieri elevandone gli effettivi da 43.000 a 55.000, di cui
6.000 per ricostituire i comandi in Alta Italia, e approvò il ripristino della guardia regia col nuovo
nome di corpo delle guardie di Ps, in cui confluirono non solo gli agenti di Ps ma anche tre
ex-milizie speciali (stradale, ferroviaria e postelegrafica).
Nel febbraio 1945 vi confluì anche la Pai, che fornì soprattutto gli ufficiali (7 dei 9
generali della Ps provenivano dalla Pai. Ex-Pai era pure il generale Enzo Felsani, principale
aertefice della riforma del 1981 tesa a subordinare l'Arma alla polizia civile sindacalizzata). Vi
entrarono poi 5.000 ex-partigiani, 5.000 poliziotti della Rsi e infine, nel 1954, i "cerini" della
Civil police organizzata dagli alleati nel Territorio libero di Trieste (il primo corpo di polizia
italiano includente anche personale femminile).
Nel maggio 1945 furono arruolati altri 10.000 carabinieri, nel marzo 1946 15.000 ausiliari
di Ps. Nel giugno-dicembre 1947 ancora 45.000 uomini: 10.000 carabinieri, 30.000 poliziotti e
5.000 finanzieri. Nell'ottobre 1949 le forze dell'ordine contavano 200.000 effettivi: 75.000
carabinieri, 50.000 guardie e 20.000 ausiliari di Ps, 40.000 finanzieri, 10.000 agenti di custodia e
5.000 forestali.
I carabinieri ricostituirono 13 battaglioni mobili e 34 nuclei autocarrati con personale
effettivo. Nel 1945 avevano 5 mezzi corazzati, 79 autocarri e 466 autovetture: nel 1949
rispettivamente 264, 1.358 e 897. L'ultima carica a cavallo della storia militare italiana non fu
quella del Savoia cavalleria ad Jsbuschenskij (24 agosto 1942), ma quella di uno squadrone
carabinieri a Porta S. Paolo, guidata dall'olimpionico Raimondo d'Inzeo (6 luglio 1960).
Il 1° reparto celere di Ps (Roma) nacque nel novembre 1944. Ne seguirono altri 3 (2°
Padova, 3° Milano, 4° Cesena), più 19 reparti mobili (su 4 compagnie mobili, 12 autoblindo
Staghound o Humber e 4 mortai da 81 mm), presenti in 34 centri industriali o agricoli.
Dal 1946 al 1979 gli scontri di piazza costarono 10.000 feriti e 219 vittime, di cui 193
civili (129 nel 1946-50, 19 nel 1951-57, 14 nel 1960-62, 31 nel 1968-79), 14 agenti e 12
carabinieri (19 nel 1946-51, 1 nel 1960 e 6 nel 1968-77).
Nel 1955 nacquero però anche gli autonomi nuclei di Pg. Nel 1957 erano 7.646 (3.060 Ps,
2.849 carabinieri, 1.737 finanza). Nel novembre 1993 c'era un carabiniere, poliziotto o finanziere
ogni 217 abitanti (Usa 355, Svizzera 598, Giappone 558 e Israele 310). La presenza nei
capoluoghi di provincia variava vistosamente (in rapporto più alla provenienza regionale del
personale e agli insediamenti politico-amministrativi che alla criminalità) da un massimo di 1
ogni 88 abitanti (Roma) a un minimo di 1 a 2.079 (Bergamo).
Peacekeeping
L'Arma dei carabinieri ha effettuato 36 missioni all'estero. Nel periodo anteriore alla
grande guerra prese parte agli interventi internazionali in Crimea (1854-56), a Creta (1897-1906),
in Cina (1900-06) e Albania (1913-14).
A Creta l'Arma organizzò e inquadrò la gendarmeria locale, e fornì missioni di
cooperazione per riorganizzare quelle macedone (1904-11) e greca (1912-23) e i carabineros
cileni (1909-11).
Nel 1916 il colonnello Cosma Manera si recò in Russia per ricercare i 10.000 soldati
triestini e trentini catturati dall'esercito zarista e rimpatriarli attraverso la Manciuria e la
concessione di Tien Tsin. Nel 1918 ne raccolse 2.000 nella cosiddetta legione redenta, base del
corpo di spedizione italiano in Siberia (1918-20).
I carabinieri concorsero inoltre alle operazioni militari internazionali nell'Impero
ottomano. Nel 1917 una compagnia fu aggregata al corpo di spedizione italiano in Palestina, e 37
carabinieri rimasero a Gerusalemme nel 1919-1921, svolgendo anche servizio d'onore al Santo
sepolcro. Altri 154 prestarono servizio a Costantinopoli, inquadrati nella forza internazionale di
gendarmeria incaricata di vigilare sulla riorganizzazione della gendarmeria turca (1919-23). In
Bulgaria (1919) e Anatolia (1919-22) operarono le sezioni della 35a e 33a divisione. Inoltre
l'Arma organizzò la gendarmeria albanese (1919-20) e il corpo carabinieri di Rodi e Castelrosso
(1920-21).
Sezioni carabinieri concorsero anche a missioni internazionali per il rafforzamento della
pace di Versailles: forze di interposizione in Dalmazia (1918-20) e a Klagenfurt (1919-21) e
controllo dei plebisciti ad Allenstein e Marienwerde (1920). Un battaglione di 346 carabinieri fu
inserito nel contingente italiano (1.300) del corpo di polizia internazionale (3.300) per il
plebiscito nella Saar (1934-35).
Dal 1921 al 1936 un distaccamento di 20 carabinieri operò anche nella repubblica di S.
Marino per controllare il territorio e addestrare la gendarmeria.
Dal 1941 al 1952 i reparti coloniali dell'Eritrea continuarono ad assicurare il servizio di
istituto sotto l'amministrazione britannica. Nel 1950, nel quadro dell'amministrazione fiduciaria
italiana in Somalia (Afis), l'Arma rioccupò la Migiurtina con 1 battaglione motoblindato e 2
compagnie autoportate, subito dopo rimpatriati.
Rimasero invece 521 carabinieri quale nucleo del costituendo corpo di polizia della
Somalia (Cps). Nel 1956 il Cps fu trasformato in forze di polizia della Somalia (Fps). Nel
dicembre 1959, alla vigilia del trapasso dei poteri alla repubblica somala, restavano
nell'ex-colonia solo 51 carabinieri.
Aliquote del 1° battaglione cc paracadutisti Tuscania (ricostituito nel 1963) sono state
impiegate nelle missioni di pace Libano 1 e 2 a Beirut (1982-83), Airone nel Curdistan iraqeno
(1991), Ibis in Somalia (1992-93), Tiph ad Hebron in Cisgiordania (dal 1994) e Ifor/Sfor a
Serajevo (dal 1995). Sono state impiegate anche aliquote dei battaglioni cc 3° Lombardia (Libano
1) e 13° Friuli-Venezia Giulia (Ifor/Sfor).
Minori reparti di Pm hanno preso parte alle operazioni Untag in Namibia (1989-90) e
Pellicano in Albania (1991-93), alla guerra del Golfo (1990-91) e all'evacuazione della comunità
italiana in Somalia (1991).
I carabinieri hanno fornito inoltre 5 uomini alla spedizione italiana sull'Everest (1973), 75
alla missione Untac in Cambogia (1992-93), 10 all'Uncivpol in Salvador (1991-95), 10
all'Uncivpol in Guatemala e 20 alla forza di polizia unificata croato-bosniaco-europea di Mostar
(entrambe in corso dal 1995).
Durante le missioni di pace del secondo dopoguerra, l'Arma ha avuto 4 caduti: 2 a
Chisimaio (1° agosto 1952), 1 sottufficiale del Sismi a Balad (12 novembre 1993) e 1 ufficiale a
Mostar (27 dicembre 1995).
Ottomila miliardi e centododici gazzelle
Già tra le due guerre la crescente complessità e importanza politica della sicurezza interna
resero l'Arma di fatto sempre più autonoma dal resto dell'esercito. La guerra civile virtuale tra
comunisti e anticomunisti che ha segnato il periodo della guerra fredda, radicò definitivamente
nella cultura politica italiana il primato della sicurezza interna sulla sicurezza internazionale, delle
forze di polizia sulle forze armate e dei carabinieri sul resto dell'esercito.
Il passo decisivo avvenne all'epoca del generale de Lorenzo, quando, con la riforma
Andreotti del 1962-66, l'Arma ottenne l'autonomia di bilancio, trasformando il comando generale
in ente programmatore del ministero della difesa sullo stesso piano degli stati maggiori della
difesa e di forza armata e della segreteria generale.
Per di più, mentre l'Arma gode di forti risparmi potendo usufruire gratuitamente delle
infrastrutture logistiche e addestrative della Difesa, il suo bilancio non è vincolato ai limiti di tetto
finanziario e di quota stabiliti per quelli degli altri 5 enti programmatori del ministero. Ciò le ha
consentito un illimitato finanziamento "per esigenze" e una espansione ininterrotta, al riparo dalla
politica finanziaria generale e dalla famigerata "scure" del Tesoro che, al contrario, in mezzo
secolo hanno progressivamente ridotto le spese militari dal 3 all'1 per cento del Pil e sconquassato
la programmazione a lungo termine delle tre forze armate.
E ciò senza contare le ingenti somme aggiuntive stanziate sul bilancio degli Interni e della
dozzina di altri ministeri, enti e servizi pubblici che si avvalgono dei servizi speciali dell'Arma, e
che sono difficilmente quantificabili data la struttura intenzionalmente capziosa e occulta del
bilancio statale italiano.
Benchè l'Arma resti pur sempre a bassa intensità di capitale (le spese del personale hanno
incidenza doppia rispetto al resto delle forze armate, dotate di infrastrutture e armamenti "duri") il
bilancio autonomo e il finanziamento "per esigenze" hanno consentito di pianificare gli
investimenti necessari per modernizzare il servizio di istituto ed estendere le capacità e i compiti
speciali, oggi ben più numerosi e socialmente pervasivi di quelli della polizia.
Già all'epoca di de Lorenzo l'accentramento di competenze al comando generale e ai
comandi provinciali e urbani e il servizio di pronto intervento (sala operativa, "112" e "gazzelle"
radiomobili) archiviarono ogni ipotesi di "ruralizzazione" dell'Arma.
Inoltre alle tre "organizzazioni" preesistenti (territoriale, addestrativa e mobile) si
aggiunse quella speciale, composta dai servizi cinofili, navale (sommozzatori e motovedette),
aereo (elicotteri) e di investigazione scientifica, e da una unità alle dirette dipendenze del
comando generale, il nucleo antiterrorismo (1978), trasformato nel 1990 in raggruppamento
operativo speciale (articolato in 28 sezioni anticrimine).
Dal 1° reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania (Livorno) dipendono inoltre il
gruppo interventi speciali (1978) creato dopo il sequestro Moro, e i 2 squadroni eliportati
carabinieri cacciatori Calabria (Vibo Valentia) e Sardegna (Abbasanta), creati nel 1991 per il
controllo di aree impervie.
La legge di riforma della polizia (121/1981) ha formalmente invertito rango e precedenza
dei due corpi di polizia a carattere generale, elevando le vecchie guardie di Ps a "polizia di stato"
e declassando i carabinieri a "forza armata in sevizio permanente di Ps". Inoltre ha attribuito il
coordinamento delle forze di polizia al dipartimento (già direzione generale) di Ps e ai questori,
nell'intento di subordinare l'Arma alla polizia. Ma di fatto il coordinamento è rimasto lettera
morta, mentre la subordinazione si è verificata solo a livello periferico, dato che il comandante
generale dipende dal ministro della Difesa e può corrispondere direttamente col presidente del
Consiglio e il capo dello stato.
I carabinieri hanno ceduto alla polizia il servizio di scorta valori, ma hanno mantenuto i
propri servizi di pronto intervento e tutela della circolazione stradale, nonchè tutte le funzioni
specializzate che avevano prima della legge 121/1981 e a cui provvedono in via esclusiva con
personale fuori organico e bilancio a carico del ministero o ente competente: servizio estero e
sicurezza rappresentanze diplomatiche, tutela della legislazione sul lavoro (1929) e del
patrimonio artistico (1969), antisofisticazione e sanità (1963), antidroga (1970), vigilanza esterna
delle carceri di massima sicurezza (1977).
In seguito hanno ottenuto altre importanti competenze esclusive: sicurezza esterna della
banca d'Italia e antifalsificazione monetaria (1982), tutela ambientale e difesa ecologica (1987),
tutela delle norme comunitarie e agroalimentari. Lo stesso Antonio Di Pietro, nei pochi mesi in
cui è stato ministro dei lavori pubblici del governo Prodi, ha chiesto di distaccarvi uno specifico
comando carabinieri, e non della polizia.
La modernizzazione ha modificato soprattutto il profilo professionale degli ufficiali,
sempre meno militare e sempre più simile a quello dei funzionari di polizia. I 2.500 ufficiali dei
carabinieri sono appena un decimo dei colleghi delle altre armi e forze armate, e godono di vari
privilegi, miglior trattamento economico e maggior prestigio sociale.
Reclutati tramite l'accademia dell'esercito e tra i migliori sottufficiali, restano ancora un
corpo molto più omogeneo degli altri, benchè le molteplici dipendenze funzionali da uffici
giudiziari, amministrazioni pubbliche ed enti di sicurezza e polizia interforze stiano
progressivamente attenuando la disciplina interna e lo spirito di corpo.
Inoltre la smilitarizzazione e sindacalizzazione della polizia (1981), imposte dai sindacati
unitari e dal movimento dei sottufficiali, hanno prodotto inevitabili contraccolpi anche sulle due
forze di polizia a ordinamento militare, differenziandole sempre più dal resto delle forze armate.
Vi ha influito anche la fine della guerra fredda. Negli anni '60 i 13 battaglioni mobili
formati da ausiliari di leva erano addestrati alla controguerriglia e 2 (il 7° di Laives e il 13° di
Gorizia) erano unità meccanizzate organicamente inserite in comandi operativi. Ma oggi il
servizio di istituto ha netta priorità rispetto all'addestramento e impiego propriamente militare, ora
limitato a paracadutisti e reparti di Pm.
In concreto, l'appartenenza dell'Arma all'esercito si fonda oggi soltanto sulla tradizione,
sull'uso comune di infrastrutture logistiche e addestrative, sul comune iter formativo degli
ufficiali (biennio in accademia e corsi della scuola di guerra) e su un limitato impiego interforze
(servizio informazioni e missioni all'estero).
Negli ultimi anni vari esponenti del Cocer-carabinieri (organo di vertice della
rappresentanza militare elettiva istituita nel 1978 per le forze armate e i corpi di polizia a statuto
militare) hanno proposto di trasformare l'Arma in quarta (anzi: prima) forza armata autonoma,
lasciandola alle dipendenze del ministero della Difesa, ma sullo stesso piano dell'esercito, e non
più formalmente subordinata al relativo stato maggiore e al comandante esterno.
Nel 1988 (sondaggio Pragma) la maggioranza degli italiani (57.8), in particolare maschi
(64) e laureati (72), era contraria alla smilitarizzazione dell'Arma, pur considerando molto
positivamente (77) la riforma della polizia (sindacato e arruolamento femminile).
Vari esponenti dei sindacati di polizia (Siulp e Sap) e del Pds (in particolare Luciano
Violante e Pino Arlacchi) hanno più volte proposto di smilitarizzare i carabinieri, o almeno di
passarli alle dipendenze del ministero dell'Interno e della polizia.
Finora, però, tali progetti hanno avuto il solo effetto di ricompattare Sme, comando
generale e Cocer attestandoli sulla linea del Piave, nonchè di acuire le polemiche Cocer-Siulp,
isolare le iniziative parlamentari, provocare esternazioni di capi di Sme e comandanti generali e
far traballare perfino governi di ferro come quello dell'Ulivo.
II - USI OBBEDIR TACE�DO
I tutori dell'Ordine (nuovo)
Les Echelles, Savoia, 3 febbraio 1834. Il carabiniere Giovanni Battista Scapaccino merita
la prima medaglia d'oro dell'esercito italiano, ammazzato dai mazziniani di Girolamo Ramorino
per essersi rifiutato di gridare "viva la Repubblica".
La vendetta arriva nella piazza d'armi di Torino, il 22 maggio 1849. Il fiero trapasso di
Ramorino, unico generale condannato a morte da una corte marziale italiana, dovrebbe assolvere i
generali piemontesi dalla sconfitta di Novara, certificando che fu colpa dei volontari lombardi
comandati dal vecchio sovversivo genovese.
Torino, Camera dei deputati, tornata del 24 giugno 1864. Si discute l'aumento di lire
778.595 (5 miliardi attuali) del capitolo 19 del bilancio della Guerra per arruolare altri 1.340
carabinieri (il costo unitario è di 3.7 milioni attuali). Eccezionalmente, malgrado lo strabiliante
onere finanziario, stavolta i deputati sono tutti d'accordo, ma qualcuno chiede di sciogliere i
doppioni inutili, guardie di Ps e compagnie d'armi di Sicilia. Il relatore Soldi conclude: "... ci fu
grato convincerci che l'interesse che tutti prendono perchè l'arma dei reali carabinieri proceda di
bene in meglio è in ragione appunto del pregio in cui essa è tenuta, e degli indefessi e segnalati
servigi che la rendono dovunque veramente benemerita del paese ...".
Ogliastro, Sicilia, 17 settembre 1866. A Palermo si combatte casa per casa, nei dintorni
dilaga la rivolta separatista al grido di "viva la repubblica, viva Santa Rosalia", e si linciano i
carabinieri. Circondato dagli insorti, e supplicato da sindaco e notaio di evitare un bagno di
sangue, il brigadiere a cavallo Luigi Taroni accetta di consegnare le armi alla guardia nazionale.
Invece sfugge a stento al linciaggio chiudendosi in caserma coi suoi 7 uomini. Il più
giovane, previdente, si è nascosta addosso la rivoltella con 7 colpi, e adesso la consegna al
comandante. La folla inferocita sfonda la porta, massacra 2 carabinieri. Taroni guadagna tempo
freddando un assalitore, poi si chiude con i 5 superstiti al piano superiore dell'edificio comunale.
Si guardano e decidono. Ma i 6 colpi che restano non bastano per tutti. Tocca al più giovane
restare vivo.
Fiume, 3 ottobre 1919. Il carabiniere a piedi Burocchi Giovanni, di scorta ad un
mercantile, guadagna la medaglia d'oro alla memoria, ucciso da dirottatori dannunziani.
Vittoriale degli Italiani, maggio 1936. "Semper adamas", il Comandante verga su carta
intestata una prolissa congratulazione al pilota da caccia Riccardo Moizo, appena nominato
comandante generale dell'Arma. Manco a dirlo, l'ex-reggente del Carnaro, "il più grande
rivoluzionario italiano" (parola di Lenin), è carabiniere pure lui: nel '19, a Fiume, durante
un'ispezione al rancio, i colleghi di Burocchi lo acclamarono "appuntato".
Lasciamogli la parola: "i Carabinieri in Fiume d'Italia, nella città assediata affamata
denigrata tentata torturata, furono i promotori e i sostenitori non dell'Ordine instituito dai nemici
interni d'Italia ma di un Ordine più alto più puro e più difficile. Furono l'esempio della impavida
fedeltà alla Patria vera, alla Patria tradita. E meritarono come non mai il titolo perpetuo che fa
insigne l'Arma 'fedelissima'". Peccato che Carl Schmitt ignorasse questo testo: calzava a pennello
per la sua celebre Teoria del partigiano (1963).
Tripoli, Libia, 14 giugno 1935. Il tribunale respinge il ricorso di Cocola Sebastiano contro
la condanna a 8 mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali per oltraggio nei
confronti dell'allievo zaptié Canul ben Ramadan, motivando che nel personale indigeno dell'Arma
la qualità di pubblico ufficiale sussiste anche nei confronti dei cittadini italiani metropolitani.
Niksic, Montenegro, 17 ottobre 1944. I dirigenti del II korpus jugoslavo, spalleggiati dagli
agit-prop comunisti arrivati dall'Italia (tra cui l'attentatore di via Rasella e un futuro presidente
della Lega delle cooperative), vogliono epurare gli ufficiali dell'Italijanska partizanska divisija
Garibaldi, tutti borghesi marci di patriottismo monarchico. Tocca al compagno Mario Palermo,
mite gentiluomo napoletano e conciliante sottosegretario alla guerra nel governo di Salerno,
pelare quella gatta.
Fortunatamente Palermo dispone di un eccellente interprete, un compagno di sicura fede e
assoluta riservatezza. Glielo ha trovato il tenente colonnello Carlo Ravnich, che governa la
divisione con l'astuzia di Ulisse e la tigna di Senofonte. E' il valoroso carabiniere Ricci ("Ridji")
Mazzino, commissario politico di battaglione, accolto per meriti di guerra nel comitato regionale
montenegrino del Pc jugoslavo.
Grazie a lui, Ravnich conosce in anticipo ogni mossa. Da alpino ruzante, ha
accompagnato il fervorino patriottico con una concreta promessa di promozione ad aiutante di
battaglia. Ma il povero Mazzino non ci arriva. Il 10 dicembre si imbarca sul battello Cettigne col
primo gruppo di allievi del corso di qualificazione politica tenuto dal capitano Valdo Magnani.
Nelle Bocche di Cattaro, presso Tivat (Teodo), li attende una mina.
Branova, Slovacchia, 8 dicembre 1944. Il carabiniere Filippo Bonavitacola, già partigiano
in Albania, catturato, poi evaso, unitosi alla resistenza slovacca e nuovamente catturato dai
nazisti, affronta il plotone di esecuzione per essersi rifiutato di calpestare gli alamari di cui ha
continuato a fregiarsi. Prima di morire sferra un pugno all'ufficiale che cerca di bendarlo.
Roma, 10 giugno 1946. Tre carabinieri reali posano per l'obiettivo dell'ufficio propaganda
fingendo di leggere il giornale col titolo di scatola "Repubblica italiana". Uno accenna un sorriso,
uno è serio, in mezzo il brigadiere dai baffetti impenetrabili. Eloquente, invece, il cannoncino da
37 mm dell'autoblinda Humber Mk.IV cui voltano le spalle.
Washington, 16 maggio 1947. In un memorandum per il presidente Truman e il segretario
di stato Marshall sul rischio di una insurrezione comunista, l'ambasciatore Alberto Tarchiani
afferma che il governo italiano dispone "di un esercito disorganizzato e incapace di resistere, di
forze di polizia largamente infiltrate da comunisti, mentre quelle dei carabinieri, anche se molto
fidate, sarebbero facilmente sopraffatte".
Sassari, Sardegna, vigilia del 18 aprile 1948. Lo studente di giurisprudenza Francesco
Cossiga, con altri attivisti democristiani pronti a insorgere in caso di vittoria del Fronte popolare,
prende in consegna le armi leggere americane depositate in parrocchia dai carabinieri.
Lo racconta allegramente nel gennaio 1992, ringalluzzito dalla ginnastica col giudice
Casson, dando la stura a buon numero di testimonianze analoghe dall'Emilia e dal
Lombardo-Veneto.
Convento di Romitello, Sicilia, 30 giugno 1949. Dopo la perquisizione condotta da un
centinaio di carabinieri e agenti di Ps del corpo forze repressione banditismo, il frate guardiano
denuncia la scomparsa di 40 chili di pane, 60 di formaggio, 6 litri di olio e di quantità imprecisate
di vino e viveri in scatola. La legione carabinieri di Palermo rimborsa 50.000 lire (1.2 milioni
attuali).
Montassilone, Alto Adige, 13 settembre 1964. Il tenente colonnello Giancarlo Giudici
rastrella la Val di Tures col VII battaglione carabinieri di Laives, alla ricerca dei terroristi che
pochi giorni prima hanno ucciso il carabiniere Vittorio Tirallongo e fatto saltare una camionetta
sulla provinciale Roson-Anterselva ferendone altri sei, e ferma 15 sospetti.
Da Bolzano arriva in elicottero il comandante della legione, colonnello Francesco
Marasco, e, secondo le reminiscenze (1991) di Giudici, gli ordina di "metterli al muro e bruciare
le case", eseguendo una presunta direttiva di rappresaglia immancabilmente attribuita al sulfureo
generale de Lorenzo. Ma senza esagerare: solo "cinque tedeschi per ogni italiano". Ovviamente
non succede. Nel 1991 Marasco querela.
Arzello di Melazzo, Alessandria, 5 giugno 1975. La brigatista cattolica Mara Cagol muore
in conflitto a fuoco con una pattuglia di carabinieri, proteggendo coraggiosamente la fuga del suo
uomo, fondatore e primo capo delle Br, che lei stessa, armi in pugno, aveva in precedenza liberato
dal carcere. La sua ultima bomba a mano uccide l'appuntato Giovanni D'Alfonso, ferisce il
maresciallo Rosario Cataffi e mutila il tenente Umberto Rocca (medaglia d'oro e generale del
ruolo d'onore, poi a lungo presidente del museo storico dell’Arma).
Roma, 13 febbraio 1981. Per la prima e unica volta nella storia, i vertici dell'Arma
(generali Cappuzzo, De Sanctis e Dalla Chiesa) compaiono in televisione (a "Tam Tam", rubrica
settimanale del Tg 1) per rassicurare il paese sull'efficienza dei carabinieri e l'inevitabile sconfitta
delle Br.
Nell'intervista Cappuzzo cita un articolo di Paolo Guzzanti, il quale (su Repubblica del 9
febbraio) ha osservato che "ormai questi carabinieri piacciono anche al Pci". Il senatore Ugo
Pecchioli, capo dell'organizzazione segreta di sicurezza del Pci, ha già rettificato una intervista
all'Europeo confermando la propria fiducia a Dalla Chiesa. Su Panorama Chiappori propone "un
monocolore dei carabinieri con l'appoggio esterno del papa".
Sigonella, Sicilia, notte del 10 ottobre 1985. I carabinieri della base aerea circondano col
mitra spianato la Delta force americana che a sua volta circonda gli avieri della Vam di guardia al
Boeing 737 egiziano con a bordo il capo palestinese Abul Abbas e i 4 dirottatori dell'Achille
Lauro. Bettino Craxi e Ronald Reagan parlano al telefono. Sulla pista rambo e avieri
fraternizzano all'arrivo del caffé espresso. I carabinieri lo bevono dopo.
Roma, 1996. La mia generazione (Wilma Labate) riconcilia la coppia brigatista (Claudio
Amendola e Francesca Neri) e il capitanino dei Nuovi carabinieri buonisti (Silvio Orlando) che
assomiglia a Papageno. Tamino e Pamina riconoscono un errore di metodo: ingannati dalla
Regina della notte (infantilmente malati di estremismo), si costrinsero riluttanti a bucare qualche
bandoliera nella speranza di colpire il cuore dello stato. Nel finale li illumina Sarrastro (Mani
Pulite), svelando l'ansia di un cuor che indomito servì il nemico di classe pensando di sbatterlo in
galera.
Quis custodiet custodem?
Per quasi un ventennio (1849-67) al vertice dei carabinieri ci fu Federico Costanzo Lovera
di Maria, prima col grado di colonnello, poi di maggior generale e infine di luogotenente generale
(1862-67).
Tuttavia nel primo ventennio postunitario (1861-82) l'Arma ebbe un vertice non solo
collegiale, ma quasi confederale. Lovera infatti non divenne comandante, ma soltanto presidente
di un comitato di 4 membri, 2 parigrado (il vicecomandante del corpo piemontese e il comandante
di quello sardo, che poi gli subentrò nella presidenza) e 2 maggiori generali ispettori delle 6
legioni meridionali (Giovanni Serpi e Trofimo Arnulfi, i due ufficiali che nel 1860 avevano
creato i corpi provvisori dei carabinieri in Sicilia e a Napoli).
Dal comitato (trasferito nel 1866 a Firenze e nel 1873 a Roma) dipendevano 2 tenenti
colonnelli, capi dello stato maggiore e della minuscola segreteria esecutiva, leggermente
potenziata nel 1870, quando al presidente fu data preminenza gerarchica su tutti i membri, ridotti
a tre.
Tuttavia solo nel 1882 fu adottato un vero vertice gerarchico, sostituendo il comitato con
un comando generale di rango corrispondente a quello dei 12 corpi d'armata in cui si divideva
allora l'esercito.
Non furono ampliati, però, i compiti e gli organici dello stato maggiore e della segreteria.
Nulla a che vedere, quindi, con la complessa organizzazione interna dell'attuale comando
generale. Ma allora comandare l'Arma era relativamente facile. Siccome la quasi totalità delle
spese era costituita dal personale e dai quadrupedi, la pianificazione consisteva nell'ottimizzare il
"riparto" territoriale dell'Arma in base a criteri affinati con l'esperienza.
Il mutamento del vertice dei carabinieri era connesso con quello generale dell'esercito.
Tradizionalmente lo stato maggiore era costituito dall'insieme degli alti comandanti militari,
direttamente dipendenti dal re e non dal governo. Solo nel 1873 fu istituito un organo collegiale
consultivo del governo, il comitato di stato maggiore generale presieduto dal comandante del
corpo di stato maggiore.
Il 29 giugno 1882 le attribuzioni del comitato furono trasferite alla nuova carica di capo di
stato maggiore dell'esercito (Sme). Nella marina la carica fu istituita solo nel 1889. Ci vollero
però il disastro di Adua (1896) e la straordinaria energia e capacità del terzo e quarto capo di
Sme, Tancredi Saletta (1896-1908) e Alberto Pollio (1908-14), per limitare i poteri del ministro
della guerra (ancora scelto tra i generali) a vantaggio dello Sme, dotando anche il regio esercito
italiano di un vero e proprio organo tecnico direttamente responsabile verso il re della
pianificazione operativa e logistica delle forze terrestri, in grado di trasformarsi in comando
supremo all'atto della mobilitazione.
La tendenza alla centralizzazione ebbe ripercussioni anche sul comando dei carabinieri e
della Gdf. Nel 1919 il comando generale fu istituito anche nella Gdf (ma non nella guardia regia,
retta da un semplice ispettorato), e nel 1920 quello dell'Arma entrò a far parte dello Sme.
Dal 1905 si istituzionalizzò la prassi (trasformata in norma dalla legge 899/1934) di
scegliere il comandante generale al di fuori dell'Arma, destinandovi un tenente generale (e poi un
generale di corpo d'armata) proveniente dalle altre armi dell'esercito. Il Rd 855/1926 limitò la
carriera degli ufficiali dell'Arma al grado di generale di divisione e all'incarico di
vicecomandante.
A questo criterio, adottato anche per la Gdf e ancora in vigore, si derogò in seguito
soltanto cinque volte, sempre in tempo di guerra: nel 1918 (Luigi Cauvin), 1942 (Azzolino
Hazon), 1943 (Angelo Cerica e Giuseppe Pièche) e 1945 (Brunetto Brunetti). Al momento della
nomina Cauvin, Hazon e Pièche ricoprivano l'incarico di vicecomandante.
Hazon morì il 19 luglio 1943 nel bombardamento alleato di Roma, assieme al suo capo di
stato maggiore colonnello Ulderico Barengo, valente storico dell'Arma, mentre coordinavano la
protezione civile nel quartiere di San Lorenzo.
Fu il suo successore Cerica, già capo dell'apparato informativo dell'Arma e futuro senatore
e capogruppo della Dc, a organizzare l'arresto di Mussolini.
Pièche, già informatore personale del duce, capo del controspionaggio del Sim (1934-40)
e organizzatore della polizia politica di Ante Pavelic, era stato rimosso dalla carica di
vicecomandante il 22 luglio 1943. Ma il 19 novembre Badoglio lo chiamò ad assumere il
comando provvisorio di Bari. Colpito da epurazione, il 21 luglio 1944 il governo Bonomi lo
sostituì con l'ex-ministro della Guerra del governo Badoglio, generale Taddeo Orlando,
ripristinando la prassi del comandante esterno.
Ma anche questa scelta non fu fortunata, perchè pochi mesi dopo il governo comunista
jugoslavo reclamò l'estradizione di Orlando per asseriti crimini di guerra, creando non poco
imbarazzo anche agli alleati. Lo scandalo suscitato dalla fuga del generale Mario Roatta
(l'ex-capo del servizio segreto militare sotto processo per le deviazioni del Sim) fornì il pretesto
per trasferire Orlando ad un incarico più defilato.
Il 7 marzo 1945 il comando fu assunto interinalmente dal generale di divisione Brunetti, e
un decreto luogotenenziale del 26 aprile ripristinò la norma del comandante esterno. Tuttavia
Brunetti rimase in carica fino al 5 aprile 1947.
Naturalmente la provenienza esterna modificò il ruolo del comandante generale, non più
un tecnico, ma un filtro tra l'istituzione e il vertice politico-militare dello stato, con il compito di
controllare l'indirizzo di governo.
Ciò rafforzò la figura del capo di stato maggiore dell'Arma, principale punto di
riferimento della gestione tecnica del personale e del servizio, e coordinatore del comando
generale, ormai articolato in uffici e reparti sempre più analoghi a quelli degli stati maggiori di
forza armata.
Già alla vigilia della grande guerra all'incarico fu normalmente preposto un colonnello, e
il suo titolare del 1902-13 (Luigi Cauvin) lo conservò anche dopo l'avanzamento a maggior
generale, passando poi a ricoprire gli incarichi di vicecomandante (1916-18) e comandante
generale (1918-19).
Nel periodo 1945-50 l'Arma venne di fatto comandata dal vicecomandante, generale
Leonetto Taddei, già comandante superiore in Aoi (1940-41). Ma dopo di lui l'incarico perse di
importanza a vantaggio del capo di stato maggiore, riducendosi ad un ruolo quasi meramente
onorifico, con attribuzioni nettamente inferiori a quelle del comandante in seconda della finanza.
Dal 1952 l'incarico di capo di stato maggiore fu attribuito a colonnelli prossimi
all'avanzamento a generale di brigata. Arnaldo Ferrara lo tenne per un decennio (1967-77) anche
da generale di divisione, fin quando divenne consigliere per la sicurezza del presidente Pertini.
Dal 1977 è riservato a un generale di brigata o di divisione.
Dal 1962 al 1984 i due incarichi di vicecomandante dei carabinieri e comandante in
seconda della finanza furono utilizzati per compensare la limitazione di carriera dei generali dei
due corpi rispetto ai loro colleghi delle altre armi.
Infatti una leggina concesse il grado di generale di corpo d'armata agli ex-vicecomandanti
e comandanti in seconda, e si instaurò la prassi di attribuire tali incarichi a rotazione (anche di
pochi mesi) a tutti i generali di divisione dei carabinieri e della finanza. In seguito, però, un'altra
leggina (429/1984) estese la promozione in ausiliaria a tutti i generali di divisione "idonei",
rendendo inutile la rotazione del vicecomando.
Per assicurare la rotazione, i titolari dovevano eventualmente dimettersi anche prima di
essere collocati in ausiliaria per raggiunti limiti di età. Nel 1964 il rifiuto del vicecomandante
(1963-68) Giorgio Manes, un caparbio generale molisano-arbresh, di rispettare la prassi,
determinò una spiacevole polemica con il comandante generale Giovanni de Lorenzo (1962-66)
sul "Primo carabiniere d'Italia", poi strumentalizzata ed enfatizzata nel contesto dello scandalo
delle schedature del servizio segreto militare (Sifar) e del presunto tentativo di colpo di stato del
1964.
Già in quell'occasione alcune forze politiche sponsorizzarono la proposta di attribuire il
comando dell'Arma a un carabiniere, e in particolare il Psdi, partito di riferimento del
parasindacalismo militare, ne fece uno dei suoi cavalli di battaglia, peraltro più esibito che
inforcato. Quel cavallo è poi passato in eredità ai delegati del Cocer carabinieri.
In realtà il comandante esterno è un correttivo contro la naturale tendenza alla chiusura
corporativa. In Francia l'Ispettorato generale della gendarmeria nazionale è attribuito a rotazione a
un magistrato o a un prefetto. Semmai è discutibile che a tale principio si sia recentemente
derogato per la polizia italiana, scegliendo il capo non più tra i prefetti della carriera ordinaria,
bensì nell'aliquota proveniente dai questori.
In partibus infidelium
Il ruolo del colonnello Alessandro Panizzardi nel caso Dreyfus (1894) dimostra che anche
gli addetti militari italiani si davano da fare. Tuttavia, soppresso nel 1866, l'ufficio informazioni
del corpo di stato maggiore rinacque solo nel 1900, e ci vollero quasi due lustri perchè
cominciasse a funzionare.
Allora aveva sede occulta nella fatale via Rasella, e contava solo 3 ufficiali (direttore,
segretario, contabile), più 1 dei carabinieri e 2 agenti addetti al controspionaggio (Cs). La rete
periferica era appoggiata sulle questure e sui comandi dei carabinieri. Il centro principale era
presso la legione di Verona, coordinato dai capitani dell'Arma Giulio Blais e Aldo Rossi.
Tra le operazioni note, l'esfiltrazione (in una cesta di biancheria) di un ufficiale disertato
dall'esercito austriaco, il rilevamento delle nuove fortificazioni delle Giudicarie, e il trafugamento
di una carta topografica al 25.000 (fotografata dall'Istituto geografico militare di Firenze e poi
rimessa al suo posto).
Altri servizi segreti dipendevano dalla Casa reale, dagli Esteri, e dalla marina (Sis). Il
ministero dell'Interno ne ebbe sempre almeno due (affari riservati e polizia politica). Nel 1915 ne
costituì un terzo, l'ufficio centrale d'investigazione (Uci), per contrastare sabotaggio e propaganda
sovversiva. Fino al 1919 dall'Uci (con sede in piazza S. Apostoli) dipendevano un servizio
speciale (Sspi) e i comitati di difesa interna (Cdi) composti di volontari civili. Infine nel 1917 il
presidente del consiglio Boselli aggiunse l'ufficio centrale di sicurezza (Ucpmi) per vigilare su un
ventilato colpo di stato nazionalista.
Nel 1923-26 l'Uci fu sostituito dalla famosa Ovra. La volle Mussolini, allarmato dalle
indagini sull'attentato subito il 31 ottobre 1926, che il capitano dei carabinieri Giovanni Cannone
aveva attribuito a dissidenti fascisti. I gerarchi ottennero però che l'indagine fosse trasferita alla
polizia, la quale avallò la responsabilità del giovanissimo Anteo Zamboni, già linciato sul posto
dagli squadristi. Anche la Mvsn creò un proprio servizio politico investigativo (Spi), che ebbe tra
i suoi direttori il console Salvatore Fontana, proveniente dai carabinieri.
Sin dal 1866 le varie edizioni del regolamento del servizio in guerra attribuivano il
servizio di Cs, considerato parte integrante della Pm, ai carabinieri, che vi provvedevano con i
reparti territoriali e con quelli mobilitati presso le grandi unità operanti.
Tuttavia durante la grande guerra la diretta competenza dell'Arma fu di fatto limitata alla
zona d'operazioni e alla marina. Nel 1916, su informativa dei carabinieri, il comando supremo
strapazzò il capo ufficio "I" dell'armata del Trentino per aver violato le norme postali
organizzando un traffico di corrispondenza attraverso la Svizzera, che gli consentiva di conoscere
tutti gli spostamenti delle unità nemiche.
Le retrovie erano invece di competenza della sezione U (Udine) del servizio informazioni
del comando supremo (Sics), che impiegava i carabinieri per la Pm e la polizia per il Cs (3
commissari, rinforzati dopo Caporetto da 154 agenti). Nella zona territoriale il Cs dipendeva dalla
sezione R (Roma), collegata col centro interalleato di I e Cs. Ma di fatto anche l'Uci svolse
attività di Cs (nel 1917 smantellò una rete informativa nemica a Roma).
Nel 1925 ciascuno dei 3 servizi segreti militari (Sim, Sis e Sia) disponeva di un proprio
Cs. Quello del Sim fu potenziato sotto la direzione del colonnello dei carabinieri Pièche
(1934-40). Mussolini, che diffidava dell'Ovra, chiese a Pièche di organizzargli un servizio
speciale di informazione privata analogo a quello creato poi da de Lorenzo per il presidente
Gronchi (1955-62).
In aggiunta a Pm e Cs, il regolamento del 1936 attribuì ai carabinieri anche i servizi
speciali (Ss) in paese nemico: ricerca di guide ed emissari, sequestro e conservazione di casse
pubbliche e documenti, e "compiti speciali di fiducia".
Fu il generale Roatta a sviluppare i Ss del Sim, affidandoli al colonnello dei carabinieri
Santo Emanuele. Nel 1945 Roatta ed Emanuele furono condannati anche per l'omicidio dei
fratelli Rosselli e l'attentato di Marsiglia contro re Alessandro I Karagjorgjevic e il ministro degli
esteri francese Barthou (1937), ma nel 1949 furono assolti dalla corte d'assise di Perugia.
Ufficiali dell'Arma furono però addetti anche alla branca offensiva del Sim. Tra questi
Manfredi Talamo, capo della sezione penetrazione, che nel dicembre 1941 riuscì a fotografare il
codice segreto dell'addetto militare americano a Roma. Subentrò poi ad Emanuele quale capo del
Cs, e nei 45 giorni del regime badogliano fu capo dell'ufficio Sim per la repressione delle attività
fasciste in ambito militare.
Talamo entrò poi nel fronte clandestino carabinieri quale capo centro radio in
collegamento col comando provvisorio di Bari. Arrestato dai nazisti il 2 ottobre 1943, fu fucilato
alle Fosse Ardeatine assieme ai due colleghi (Giovanni Frignani e Raffaele Aversa) che il 25
luglio avevano eseguito l'arresto di Mussolini a Villa Savoia, e al capo di stato maggiore del
fronte (maggiore Ugo De Carolis).
Nel 1949 fu il ministro Pacciardi a unificare il servizio informazioni forze armate (Sifar).
Nel 1955 l'Arma fu declassata a organo esecutivo di Pm e Cs, alle dipendenze del Sifar (organo
direttivo).
L'Arma non era tuttavia coinvolta nell'organizzazione segreta di persistenza oltre le linee
(Gladio). Soltanto a seguito della strage di Peteano (31 maggio 1972) in cui 3 carabinieri furono
uccisi con esplosivo prelevato da uno dei depositi clandestini della Gladio (Nasco), le stazioni
dell'Arma ne presero in custodia armi, esplosivi e materiali.
Fu il ministro Paolo Emilio Taviani ad attribuire al Sifar anche compiti di polizia politica.
Lo schedario dell'ufficio D (difesa) includeva le rubriche M (agenti stranieri), Mae (personale
degli Esteri), Ppp (persone politicamente pericolose) ed E (enucleandi).
Nel 1947 il ministro degli Interni Mario Scelba nominò il generale Pièche prefetto di
Roma e lo incaricò di riorganizzare il casellario politico centrale. Nel 1950 Scelba lo nominò
capo dell'ufficio antincendi di Ps, nome di copertura per la famosa organizzazione di difesa civile
(Dciv) bloccata in parlamento dalla dura opposizione delle Sinistre.
Il progetto di legge Scelba sulla Dciv fu approvato dalla camera, ma insabbiato in senato.
Tra i suoi oppositori il senatore Cerica, esponente della destra Dc legata agli agrari, che accusò
Scelba di finanziare una rivista neofascista, ostentando di averlo appreso da una informativa dei
carabinieri. L'attacco sembrò un indiretto monito dell'Arma, ostile alla creazione di un organismo
come la Dciv, che avrebbe interferito con le proprie competenze di Pm e Cs.
Solo due volte il comando generale dei carabinieri è stato attribuito a ex-capi del servizio
segreto militare, i generali de Lorenzo (1962) e Sergio Siracusa (1996). Nel 1991 il VII governo
Andreotti scartò la candidatura inversa del comandante generale Antonio Viesti a direttore del
Sismi.
Ancor più anomala l'attribuzione del servizio ad un ufficiale dei carabinieri. L'unico caso
(1965) fu quello di Giovanni Allavena, già preposto alle schedature politiche e poi all'ufficio D
del Sifar, organizzatore della scorta a Paolo VI durante il suo pellegrinaggio in Terrasanta e uomo
di fiducia sia di de Lorenzo che del suo rivale generale Giuseppe Aloia. Fu Aloia a vincere le
perplessità del ministro Andreotti sul nome di Allavena. Il presidente Saragat lo destituì il 3
giugno 1966.
Per due volte, invece, generali dei carabinieri hanno assunto la direzione del servizio
segreto civile (Sisde): Giulio Grassini (1978-81) e Gaetano Marino (1994-96). Il generale dei
carabinieri Giuseppe Tavormina è stato invece direttore operativo della Dia (1992-93) in
condominio col questore Gianni De Gennaro (direttore esecutivo), e poi segretario del Cesis
(1993-94).
Nel 1981 Allavena e Grassini risultarono iscritti alla loggia massonica P2 del venerabile
Licio Gelli, processata per cospirazione politica e recentemente assolta. Nell'Arma i piduisti erano
52, di cui 9 generali (nel 1975 erano in servizio 39 generali e 712 ufficiali superiori). Tra costoro,
3 ex-vicecomandanti generali, 1 comandante di divisione, il generale Dino Mingarelli inquisito
per il depistaggio delle indagini su Peteano, e il generale Romolo Dalla Chiesa, fratello di Carlo
Alberto (la cui domanda di iscrizione era rimasta inevasa).
Benchè la legge del 1977 abbia formalmente ridotto i servizi di informazione e sicurezza a
2, militare (Sismi) e "democratica" (Sisde), in pratica ne abbiamo almeno 16. La presidenza del
Consiglio ne ha 2 (Ucsi, Cesis), gli Interni 5 (Sisde, Polizia di prevenzione, Sco, Dia, Servizio
protezione), le Finanze 3 (ufficio I, Scico, Secit), la Difesa 4 (Sismi e 3 Sios), i carabinieri 2
(ufficio I, Ros).
Solo di recente, a seguito dello scandalo dei fondi neri del Sisde, sono stati diffusi dati
parziali sui bilanci funzionali (esclusi cioè gli stipendi del personale) dei servizi segreti. Dal 1986
al 1992 quello del Sisde è aumentato da 63 a 131 miliardi. Il senatore Libero Gualtieri ha però
calcolato che nei sette anni le sole spese riservate (senza rendiconto) di Sismi e Sisde sono
ammontate a 1.942 miliardi (nel 1965 i fondi riservati del Sifar erano 1 miliardo, pari a 25
attuali). Nel 1993 per Sismi e Sisde furono stanziati 741 miliardi.
Dall'Arma dipendono direttamente nuclei, reparti e comandi di Pm e Cs (XII brigata) e 2
servizi segreti (ufficio informazioni e raggruppamento operativo speciale).
Dipendono dall'Arma solo ai fini amministrativi i reparti assegnati ad altri servizi segreti:
ufficio centrale sicurezza interna (Ucsi), comitato esecutivo (Cesis), Sisde, Sismi, direzione
investigativa antimafia (Dia) e servizio protezione pentiti di mafia (Spcg). Negli anni di de
Lorenzo (1959-66) i carabinieri costituivano l'80 per cento del CS (ufficio D), e oggi il 28 per
cento della Dia (270 su 945).
Benchè alcuni servizi interforze ricorrano anche al reclutamento diretto, la massa del
personale è distaccata dalle forze armate e di polizia. Ciò rappresenta un filtro necessario e
opportuno, ma crea molti problemi, perchè i periodi di permanenza nei servizi interforze si sono
via via allungati sino a coincidere con l'intero arco della carriera residua.
Il corpo di provenienza non li controlla più ai fini disciplinari e di avanzamento, perchè
sono collocati fuori organico e la scelta comparativa spetta al Cesis. Accade però che per varie
ragioni rientrino al corpo di provenienza, alterando le aspettative di carriera dei colleghi. I
correttivi via via individuati (equipollenza tra comandi operativi e incarichi nei servizi,
avanzamento in soprannumero) non hanno impedito il ricorrere di problemi e polemiche.
Da alcuni anni qualcosa di simile si sta verificando anche per il servizio investigativo alle
dipendenze dell'autorità giudiziaria inquirente. Nei casi ordinari è svolto dai normali uffici e
reparti di Pg, ma gli speciali pool di magistrati impegnati in indagini particolarmente lunghe,
complesse e delicate sotto il profilo politico tendono a creare squadre investigative ad hoc con
personale di polizia selezionato su base fiduciaria e informale.
In tal modo di fatto lo sottraggono al controllo disciplinare del corpo di appartenenza e
interferiscono sui criteri di assegnazione di incarico e sede, e perfino di avanzamento. Ciò si è
verificato specialmente nelle istruttorie relative a stragi, terrorismo, commercio internazionale
degli armamenti, cospirazione politica, attentato agli organi costituzionali, corruzione ed
estorsione in pubblici appalti e forniture militari, voto di scambio e concorso esterno in
associazione mafiosa.
I carabinieri hanno un fortissimo spirito di corpo: l'appartenenza all'Arma conferisce un
crisma indelebile, quasi come l'ordinazione sacerdotale cattolica. Eppure alla lunga non sarà
irrilevante che un numero crescente di ufficiali sia ormai distaccato in permanenza fuori dalla
"casa madre".
Solo un piano
Nell'estate 1964, durante la crisi del primo governo "organico" di centrosinistra, silurato
dalla confindustria e da un intervento del commissario Cee Marjolin, il presidente della
repubblica, Antonio Segni, tentò, senza riuscirvi, di pilotarla per dare l'incarico al ministro
dell'Interno Paolo Emilio Taviani e sciogliere le camere, allo scopo di rovesciare l'esito delle
elezioni del 1963, che avevano visto l'affermazione delle sinistre.
Le reazioni e le accuse immediate non furono estranee all'ictus che condusse Segni alle
dimissioni e poi alla morte. Tre anni dopo, il "cittadino Scalfari" qualificò quell'episodio come un
tentativo di colpo di stato, accusando implicitamente Nenni di averlo coperto per non dare spazio
al massimalismo socialista. E quattordici anni dopo gli inquisitori delle Br non mancarono di
chiederne conto allo stesso Moro.
La stessa commissione parlamentare di inchiesta presieduta dal giurista democristiano
Alessi (1969-71), scrisse che lo scioglimento delle camere, "in sé e per sé ineccepibile sul piano
costituzionale, si tramuterebbe in atto illecito e in attentato alle pubbliche libertà
costituzionalmente garantite, ove risultasse programmaticamente predisposto alla produzione di
avvenimenti intesi al sovvertimento della situazione politica".
Come è spesso avvenuto nelle fasi più critiche della storia costituzionale italiana, i fatti
rilevanti e i veri protagonisti furono defilati grazie a sensazionalismi e polveroni abilmente
montati sulla paranoica meschinità e sulle senili vendette del sottobosco politico e militare. E,
come nell'opera dei pupi, in cui il colto e l'inclita conoscono in anticipo la morale nonchè ogni
gesto e ogni battuta, la pseudostoria del colpo di stato di Segni e de Lorenzo è divenuta addirittura
l'incunabolo di quelle analoghe successivamente recitate sul teatrino della repubblica.
Il generale Giovanni de Lorenzo, artigliere, ingegnere, massone, capo ufficio I del fronte
militare clandestino (1944), capo del Sifar (1956-62), comandante generale dei carabinieri
(1962-66), unico capo di stato maggiore dell'esercito (1966-67) destituito dal governo per lo
scandalo delle schedature eccellenti commissionate al Sifar dal regime democristiano, e
successivamente deputato monarchico (1968-71) e del Msi-Dn (1971-73), aveva le fisique du role
per interpretare il personaggio del "fellone" (appropriato termine da operetta, riesumato nel 1967
da Ferruccio Parri ed Eugenio Scalfari).
Il monocolore Taviani vagheggiato da Segni, che avrebbe ottenuto la maggioranza col
voto determinante delle destre, rischiava di innescare un bis del governo Tambroni, abbattuto
quattro anni prima da sanguinosi tumulti di piazza. Segni si premunì ordinando a de Lorenzo di
predisporre un piano di sicurezza a carattere preventivo con l'impiego dei soli carabinieri.
In termini formali, ciò significa che le misure preventive furono inquadrate nell'ambito
della Pm (Sifar e carabinieri) anzichè nel normale ordine pubblico (prefetture e questure), allo
scopo di poterne trasferire la responsabilità esecutiva dal ministro dell'Interno (Taviani) a quello
della Difesa (Andreotti).
Che il trasferimento di responsabilità fosse effettivamente dovuto all'asserita inaffidabilità
della polizia "comunista" non persuade. Suona spiegazione di comodo, escogitata piuttosto per
mascherare la vera ragione. Più probabilmente non si ritenne opportuno e costituzionalmente
corretto concentrare nella stessa persona (Taviani) l'eventuale incarico di formare il nuovo
governo e la diretta responsabilità dell'ordine pubblico in una situazione di potenziale emergenza.
Fra l'altro (come era già avvenuto in precedenti occasioni) il presidente volle che le
consultazioni, all'insaputa dell'interlocutore, fossero registrate dal Sifar. Durante i colloqui Segni
osservò che i carabinieri erano più "affidabili" della polizia perchè, sulla base delle statistiche
elettorali fra di essi si registrava una minore percentuale di voti comunisti (del resto, come poi
ammise Cossutta, tutte le forze dell'ordine erano infiltrate dal Pci).
Ma anche le altre autorità politiche e militari preposte alla tutela dell'ordine pubblico
furono non solo informate, ma anche attivamente coinvolte nello stato di preallarme. Nel discorso
pronunciato alla speciale parata per il 150° dell'Arma fu Andreotti a dire che "nella sua infallibile
sensibilità il popolo sa bene cosa pensare di quanti sono contro i carabinieri".
Diffidando di Vicari e della polizia, il 15 luglio Segni convocò de Lorenzo per chiedergli
una garanzia militare. Il generale tergiversò e informò subito i suoi diretti superiori Aloia e
Andreotti. Il 16 de Lorenzo e Vicari furono informalmente convocati dal vertice Dc, presidente
incaricato (Moro), segretario (Rumor) e presidenti dei gruppi parlamentari (Zaccagnini e Gava).
Moro ne informò Nenni, riferendogli che i due alti funzionari avevano assicurato "che la
situazione era perfettamente controllata e l'ordine pubblico non correva alcun serio rischio", ma
che avevano raccomandato "una sollecita soluzione della crisi appunto perchè la tensione non
sboccasse in manifestazioni di piazza". Quest'ultimo colloquio fu decisivo. Le trattative ripresero
il 17. Il 22 il II governo Moro, anch'esso "organico di centro-sinistra", prestò giuramento.
Dalle direttive emanate da de Lorenzo nel 1963-64 emerge nettamente l'intendimento di
potenziare l'impiego in ordine pubblico dell'organizzazione territoriale dell'Arma, salvaguardando
il prioritario impiego militare dei reparti mobili (riuniti ai soli fini amministrativi nell'XI brigata
meccanizzata, ma rimasti a diretta disposizione dei prefetti e impiegabili fuori sede solo su
autorizzazione specifica e congiunta dei ministri degli Interni e della Difesa).
L'idea di fondo era quella di sviluppare l'operatività della componente urbana dei
carabinieri. Un'idea accolta con malcelato e non infondato scetticismo da parte dei suoi
collaboratori, che la consideravano una "fisima" nata dal desiderio "di dimostrare l'efficienza e la
prontezza dell'Arma rispetto alla Ps".
Nacque di qui l'iniziativa di studiare un piano di difesa minimo (piano E. s., poi detto
piano Solo), limitato agli obiettivi "vitali", da attuarsi in alternativa sia ai piani Apam predisposti
dalla Difesa, sia ai piani di emergenza predisposti nel 1962 dai prefetti delle 15 aree urbane
principali in esecuzione di specifica direttiva impartita da Vicari.
In sostanza, de Lorenzo volle verificare la concreta possibilità di assicurare gli obiettivi
essenziali di Pm con l'impiego dei soli 20 mila uomini di cui l'Arma disponeva nelle 10 città
principali (di cui 5.700 a Roma) e senza dover ordinare la misura estrema dell'"abbandono delle
stazioni".
E risultando evidente l'insufficienza della forza, pensò di risolvere il problema ricorrendo
alle forze di mobilitazione di 2° tempo, cioè alle compagnie carabinieri richiamati" già previste
dai piani di mobilitazione, facendo studiare meccanismi tecnici per mobilitarle rapidamente e in
modo autonomo. Glli ufficiali incaricati di elaborare gli studi lo fecero di malavoglia e senza
convinzione, e trassero tutti la conclusione che il piano sarebbe stato tecnicamente inattuabile. Lo
studio si trascinò per un anno, dal luglio 1963 al luglio 1964, e in seguito fu lasciato cadere, ad
eccezione della parte relativa alle nuove procedure di richiamo della forza in congedo.
Quando la crisi politica giunse all'acme, il piano non era ancora pronto (i relativi
documenti sono semplici appunti manoscritti). Le uniche misure effettivamente messe a punto
riguardavano gli autonomi piani di difesa del Quirinale (piano "K") e della Rai-tv (piano
"Ravenna Treviso") e l'enucleazione e trasferimento nella base Sifar di Capo Marrargiu
(Sardegna), dei 731 presunti potenziali sabotatori. I quali erano ovviamente tutti socialisti e
comunisti, dato che gli elenchi in possesso del Sifar fotografavano la mappa politica degli anni
'50, in cui l'intero Psi era ancora ufficialmente su posizioni frontiste. La lista dei 731 enucleandi,
effettivamente diramata dal Sifar ai comandi territoriali dell'Arma, fu specificamente segretata dal
governo Rumor nel 1970. Vent'anni dopo il VII Governo Andreotti rimosse il segreto di stato
sulla vicenda Sifar-Piano Solo e trasmise al Parlamento i relativi documenti: tutti, tranne quella
lista, che senza code polemiche risultò ufficialmente scomparsa.
Scossa sismica
Nella primavera del 1977 Cossiga, ministro per la riforma burocratica, varò una riforma
dei servizi segreti civili e militari che ne prevedeva l’unificazione. Sembra che l’unificazione
suscitasse reazioni negative negli ambienti interessati, se (come Andreotti ha dichiarato
nell’aprile 1997) il capo del Sid (ammiraglio Casardi) e del disciolto Ispettorato antiterrorismo
(Santillo) fecero pervenire alla commissione parlamentare una memoria di critica al testo del
governo.
Il clima piuttosto teso ebbe qualche ripercussione anche sull’Arma. La nomina (8 agosto)
del generale barese Mario De Sena a capo di stato maggiore, imposta dal ministro della Difesa
Vito Lattanzio, suo conterraneo, suscitò aspre critiche del capo uscente e attuale vicecomandante,
generale Arnaldo Ferrara, al punto da indurre il comandante generale, Enrico Mino, a presentare
le dimissioni, respinte dal governo. (De Sena divenne poi sindaco "gavianeo" di Salerno). Altre
polemiche seguirono per la cosiddetta fuga (15 agosto) del criminale di guerra Herbert Kappler,
in realtà già scarcerato a seguito di accordi italo-tedeschi ma ricoverato all'ospedale militare del
Celio e ancora sorvegliato dai carabinieri. Indignate, le Sinistre chiesero la sostituzione di
Lattanzio e di Mino. Ferrara criticò aspramente il superiore per la punizione disciplinare inflitta al
personale di sorveglianza. Il Psdi e Indro Montanelli chiesero di sostituirgli un comandante
proveniente dall'Arma, in chiaro riferimento a Ferrara. Fu il tesoriere del Psi Vincenzo Balzamo a
difendere Mino.
Mino, amico di Moro e apprezzato dal cardinale Siri per le discrete indagini condotte sulla
massoneria vaticana, teneva regolari contatti con il gran maestro della loggia P2 Licio Gelli e con
Mino Pecorelli, direttore dell'agenzia Op. Il 31 ottobre perì, con 5 ufficiali del suo seguito, in un
incidente elicotteristico in Calabria, dovuto "ad un complesso di cause meteorologiche e di fattori
di natura accidentale e professionale".
Il governo scelse a succedergli l'energico generale Pietro Corsini, proveniente dalla
fanteria. Nel gennaio 1978 Ferrara rifiutò la nomina a direttore del Sisde, in dissenso con la scelta
del parlamento (conforme alla memoria Casardi-Santillo) di mantenere due distinti servizi
anzichè unificarli. Il 19 settembre il presidente Sandro Pertini lo nominò nell'inedito incarico di
consigliere presidenziale per la sicurezza.
Declinate o scartate altre candidature (tra cui quelle di Santillo e del generale Dalla
Chiesa), finì che ai vertici dei due nuovi servizi e del comitato di coordinamento furono nominati
tre esponenti della loggia massonica P2 di Licio Gelli. Erano in carica all’epoca del sequestro e
dell’uccisione di Aldo Moro (marzo-maggio 1978) e furono sostituiti nel 1981, quando esplose il
caso della P2.
Il brigadiere Craighero
L'estensione a carabinieri e Gdf dei benefici e privilegi accordati alla polizia nel 1981 fu
oggetto di tenaci resistenze. I vertici militari temevano, come poi avvenne, che l'equiparazione
avrebbe trasformato la rappresentanza militare elettiva in un sindacato di fatto, ed esteso i criteri
civili di lavoro e avanzamento dai corpi di polizia a statuto militare al resto delle forze armate,
con gravi ripercussioni sulla loro efficienza. Ma ancor più ostili erano i sindacati della polizia
(Siulp e Sap), consapevoli che l'onere finanziario dell'estensione avrebbe ridotto l'entità dei
benefici goduti dalle categorie protette. Il nodo principale riguardò l'equiparazione dei 25.000
marescialli dell'Arma ai 6.000 ispettori di polizia, un ruolo intermedio tra i vecchi sottufficiali
(sovrintendenti) e i funzionari, istituito nel 1981 per la sola polizia civile. Sotto la presidenza del
tenente colonnello Antonio Pappalardo (1988-91), il Cocer carabinieri dette voce al "malessere"
dell'Arma ben oltre le funzioni puramente consultive attribuitegli dalla legge, promuovendo la
"vertenza sottufficiali". Dal canto suo un gruppo di marescialli si affidò ad un brillante avvocato
di Ancona che sollevò la questione di incostituzionalità e nel giugno 1991 ottenne ragione dalla
Consulta. (In seguito l'avvocato fu assassinato. Ai suoi funerali intervenne una folla di
sottufficiali, e, finchè gli autori dell'omicidio non furono arrestati, tra i carabinieri corse
addirittura la voce che fosse stato giustiziato per "vendetta" degli ispettori).
Ma la sentenza arrivò in piena bancarotta del regime consociativo, e il VII governo
Andreotti approfittò delle polemiche del Siulp-Sap per procrastinarne l'esecuzione. Al contrario il
presidente Cossiga, attaccato dalle Sinistre e oggetto addirittura di una iniziativa di impeachment,
versò benzina sul fuoco: il 30 novembre 1991, in occasione del giuramento di 550 sottufficiali
carabinieri del battaglione di Velletri, si lasciò incautamente scappare la frase "giudicatemi voi"
(il battaglione mostrò il suo perfetto addestramento non eseguendo l'ordine di "attenti" impartito
direttamente dal presidente, anzichè, come prescritto dal regolamento militare, per il tramite del
comandante, colonnello Palombo, prima rimbrottato e poi elogiato dallo stesso Cossiga).
Il Cocer approfittò invece di quella esternazione per emanare un irricevibile comunicato di
solidarietà con Cossiga, corredato di critiche a parlamento e governo, "messaggi" al popolo e
avvertimento finale a non abusare della pazienza dei carabinieri. Le doverose dissociazioni e i
provvedimenti disciplinari furono in parte addolciti da un messaggio presidenziale di "sofferta"
condanna che riduceva il pronunciamento ad un mero fatto "spiacevole per una parte del
parlamento".
Il 9 dicembre Pappalardo fondò un movimento politico (Progetto 2000, poi Arn) per
"restituire all'Arma il primato sulla polizia" (nelle successive elezioni politiche l'Arn fu accolta
con ben 37 candidati nelle esangui liste del Psdi. Fu eletto il solo Pappalardo, che per breve
tempo fu anche sottosegretario). Il Sap ipotizzò in risposta un "partito dei poliziotti". Il 12
dicembre 10.000 poliziotti parteciparono alla grande manifestazione sindacale. Il 22, durante un
appostamento notturno non comunicato ai carabinieri, 4 poliziotti uccisero, scambiandolo per un
malvivente, il brigadiere Germano Craighero. Ormai al calor bianco, Cocer e Sap si rinfacciarono
la responsabilità del mancato coordinamento interforze. Il ministro dell'Interno Scotti sgridò il
Cocer.
Il 28 dicembre finalmente il governo decretò l'equiparazione, riconoscendo inoltre ai
Cocer carabinieri e finanza un vero "ruolo negoziale" e non più solo consultivo, analogo a quello
dei sindacati di polizia. Poco dopo, per placare il Siulp, beneficò anche la polizia civile (scatti di
livello e una tantum), e, per non far torto a nessuno alla vigilia delle ultime elezioni del vecchio
regime partitocratico, pure la dirigenza civile e militare (adeguamenti automatici della
retribuzione). Infine non potè negare l'estensione dei benefici economici anche ai sottufficiali
delle forze armate, visto che votavano pure loro.
Il 12 febbraio 1992 la camera, rilevando eccezionalmente l'assoluta mancanza di copertura
finanziaria, rinviò l'esame del decreto. I sindacati risposero proclamando lo stato di agitazione.
Cossiga manifestò la sua solidarietà alle forze dell'ordine, impartì ai politici un'altra razione di
picconate, e convocò al Quirinale capo della polizia (Parisi) e comandanti generali (Viesti e
Berlenghi).
Proprio lo stesso giorno altri 2 giovani carabinieri furono uccisi a Pontecagnano durante
un normale servizio di controllo. Un rapporto dell'Arma ipotizzò che gli assassini godessero di
coperture nella polizia. In Tv il ministro della Giustizia Martelli dichiarò che erano morti per
scarsa professionalità. Ai funerali la folla fischiò i politici. Pappalardo si presentò al Quirinale per
consegnare a Cossiga un duro atto d'accusa contro Scotti e Martelli.
Il 16 febbraio Cossiga discusse con i ministri competenti l'ipotesi di rendere i carabinieri
autonomi dall'esercito. Il 17, ignorando il suo tardivo appello ad evitare proteste, i sindacati di
polizia sfilarono in corteo. Il 18 una durissima nota del Quirinale accusò il governo di aver
frenato il capo dello stato e pretese le pubbliche scuse di Scotti. Il 19, consultatosi con il capo
della polizia e i vertici militari, Cossiga chiese al governo il consenso a convocare
congiuntamente al Quirinale Cocer, Siulp e Sap.
Andreotti oppose un informale diniego. Il segretario del Siulp Lo Sciuto rispose che
l'interlocutore naturale era il governo, confermò fiducia a Scotti e bocciò l'ipotesi di rendere
autonoma l'Arma, sostenendo che occorreva invece smilitarizzarla e porla alle esclusive
dipendenze del ministero degli Interni. Il Cocer reagì duramente ("giù le mani dall'Arma!"). Scotti
e il capo di stato maggiore dell'esercito (generale Canino) intervennero per difendere la
dipendenza dalla Difesa e dallo Sme. Il 26 febbraio il parlamento capitolò alla piazza in uniforme
approvando il "decreto della discordia".
Il 21 aprile, alla vigilia delle dimissioni, in due lettere al ministro della Difesa (Rognoni) e
al direttore del Mattino (Nonno), Cossiga accusò i generali Canino e Viesti di "comportamento
sleale e scorretto" (la stampa scrisse, ma a torto, che la questione sollevata dal presidente
riguardasse un presunto caso di clientelismo politico nell'avanzamento di un ufficiale superiore).
Nella criptica lettera a Nonno, Cossiga giunse a contrapporre la "tradizione di serietà dei
carabinieri" all'asserita "slealtà" del comandante generale, proveniente da altra arma dell'esercito.
Un comunicato del Cocer chiosò anche quest'ultima esternazione ("chi non è leale, chi non è
corretto, non si identifica con la Benemerita"). Il presidente escluse i due generali dalla cerimonia
di commiato dalle forze armate che concluse il suo mandato.
Forse è possibile collegare a questa brutta stagione di "malessere" e rancori reciproci tra le
forze dell'ordine, se non certo la stessa strage del Pilastro (dove, il 4 gennaio 1991, 3 carabinieri
furono uccisi dalla banda della "uno bianca" formata da 4 poliziotti della questura di Bologna),
almeno qualche involontario ritardo nell’individuazione dei colpevoli.
Nel maggio 1995, quando alla fine furono casualmente arrestati, il comandante generale
Federici dichiarò infatti che già nel 1991 l'Arma aveva raccolto a loro carico un grave indizio.
Tenuto conto che gli indagati erano poliziotti, la procura di Pesaro aveva però ritenuto di
trasferire l'indagine alla polizia, la quale, pur in perfetta buona fede, non aveva trovato riscontri
alla pista seguita dai carabinieri.
Pochi giorni dopo, nell'80° anniversario dell'entrata in guerra, le polemiche innescate dalle
parole di Federici furono acquietate da un grande concerto in onore delle forze dell'ordine,
eseguito nei giardini di Castel S. Angelo dalle tre bande (musicali) riunite.
III - LA BE�EMERITA
Il Santo
Nasce al Vomero, Salvo D'Acquisto, classe 1920. Sono poveri, ma lui le medie le fa lo
stesso, dai salesiani. Nel 1935 va a bottega dallo zio acquisito Giuseppe Pinfildi, fabbricante di
bambole. Sono belle e famose: una incanta il principe Umberto. Nel 1938 arriva Alessandro,
quarto e ultimo fratello. Salvo si arruola nell'Arma, presta servizio a Roma, in via Sallustiana,
presso il ministero degli armamenti (Fabbriguerra). Il 15 novembre 1940 si imbarca volontario
per la Cirenaica con la 608a sezione carabinieri aeronautica, divisione Pegaso. Nel febbraio 1941,
ferito ad una gamba, ottiene 3 mesi di licenza, poi torna in Tripolitania. Rimpatria nell'ottobre
1942, per il corso sottufficiali a Firenze.
Nel settembre 1943 è vicebrigadiere, comandante interinale della stazione di Torre in
Pietra, nell'agro romano. Poco lontano i tedeschi hanno stabilito un corpo di guardia nell'antica
torre di avvistamento costiera di Palidoro, già casermetta della finanza. Il 22 settembre alcuni di
loro, rovistando in una cassetta abbandonata dai precedenti inquilini, fanno esplodere una bomba
a mano. Uno muore, altri sono feriti. Di partigiani, lì, manco l'ombra. Del resto la stessa
meccanica dell'incidente esclude l'attentato. Ma il comando tedesco vuole ugualmente spargere il
terrore. Il mattino del 23 settembre una coppia in sydecar si presenta dai carabinieri intimando al
comandante di rivelare i nomi degli inesistenti attentatori. Minacciano, pestano. Non è che ci
tiene a fare l'eroe. Non deve dimostrare nulla, tanto meno a quelli. Solo che un carabiniere
calunnie non ne fa.
Due ore dopo un camion rastrella 22 ostaggi. Si ferma in piazza per caricare anche Salvo,
poi li scarica tutti sullo spiazzo accanto al lato Sud della torre. Li chiamano uno alla volta,
sperando invano che uno ceda addossandosi la colpa. Arriva un altro camion col plotone
d'esecuzione e i badili per scavarsi la fossa.
Obbediscono per guadagnare tempo, per inerzia, per paura, per stordirsi. Ma nessuna
delazione. Scavano per ore, sudati e gelati, alternando disperazione e speranza. Salvo è pallido,
teso, sempre più assorto. Quando la trincea arriva alla cintola li fanno uscire, allineandoli sul
bordo, spalle al tramonto. Allora Salvo si avvicina all'interprete. Parlano fitto. Poi torna dai
compagni, li rassicura sulla loro sorte. "Tanto una volta si nasce e una si muore", mormora tra sé.
Il tempo rimane sospeso, finchè i tedeschi li chiamano per cacciarli fuori del recinto.
Corrono a casa, senza voltarsi. Salvo aiuta un ritardatario a uscire dalla trincea. Lui resta, in piedi
davanti alla fossa. Prima della raffica grida "viva l'Italia!".
Già, l'Italia. Per una o due settimane giace sotto un po' di sabbia. Poi due donne, aiutate da
altre persone, gli danno sepoltura cristiana nel cimitero di Palidoro. Nel giugno 1947, nonostante
l'opposizione degli scampati alla strage e della popolazione, la madre ottiene la traslazione della
salma nel sacrario militare di Posillipo.
Il 12 agosto 1944 anche i 3 carabinieri di Fiesole sacrificano la propria vita per salvare 10
ostaggi. Ma Palidoro è alle porte di una città scossa dall'attentato gappista di via Rasella e dalla
rappresaglia nazista delle Fosse Ardeatine (23-24 marzo 1944).
Chi non ama comunisti e partigiani ama i paragoni tra Palidoro e via Rasella. L'innocente
che si accusa per carità cristiana e senso del dovere fino all'estremo sacrificio. Gli autori che non
si presentano, lasciando giustiziare altri 335 al loro posto, inclusi 12 carabinieri. Sempre facili i
criteri postumi.
Finisce che a Palidoro, il monumento deve farglielo l'Arma: un semplice cippo di granito.
E soltanto al 17° anniversario, dopo i morti di Reggio Emilia (1960). Nel 1975, per il trentennale
della Liberazione, l'Italia del compromesso storico lo ricorda con un francobollo da 100 lire e con
il film con Massimo Ranieri. Nel 1987 portano il suo nome 397 vie, 80 piazze e 70 scuole. Ma
neanche oggi si può visitare, e neppure guardare da lontano, il luogo del martirio. E' proprietà
privata, una pretenziosa villetta cintata di alta e fitta siepe.
Salvo non è il primo militare di carriera canonizzato come servo di Dio, venerabile, beato
o santo. Tra gli italiani lo precedono Francesco Faà di Bruno (1825-88), Felice Prinetti
(1842-1916), Carlo Amirante (1852-1934) e 7 cappellani militari, tra cui papa Giovanni XXIII
(1881-1963).
Postulatore di Salvo è il francescano Germano Cerafogli, piazza san Francesco d'Assisi
88, Roma. Nel 1982-83 conduce le prescritte indagini canoniche assieme a monsignor Salvatore
Cipolla. Chi vuole può sostenere la postulazione con un versamento in conto corrente postale. Il
23 settembre 1983, a Palidoro, dopo il discorso di Spadolini, l'arcivescovo castrense monsignor
Gaetano Bonicelli annuncia il processo canonico per la beatificazione.
Il 4 novembre 1983, dopo la messa per il 65° della Vittoria nella chiesa castrense di Santa
Caterina, Bonicelli insedia il tribunale diocesano. Presidente e giudice delegato, monsignor
Marcello Costalunga, sottosegretario della congregazione per i vescovi. Promotore di giustizia,
cioè "avvocato del diavolo", monsignor Nicola Labella, notaio don Nello Tranzocchi. La prima
sessione si tiene il 22 dicembre, in una sala dell'ordinariato militare d'Italia, con l'ascolto di
Arnaldo Attili, il primo dei 6 ostaggi ancora viventi chiamati a testimoniare. La fase diocesana
termina nel 1988. La postulazione prosegue davanti alla sacra congregazione dei riti, affidata a
padre Molinari e fra Salvatore Nitta.
Nel febbraio 1984 la postulazione presenta istanza all'arcivescovo di Napoli, cardinale
Corrado Ursi, per la traslazione della salma dal mausoleo di Posillipo, decentrato e aperto solo la
domenica, alla basilica di santa Chiara, affidata ai frati minori.
Per il 42° anniversario (1985), inusualmente, il discorso lo tiene il ministro dell'Interno (il
cattolico Scalfaro), anzichè quello della Difesa (il laico Spadolini). A maggior ragione il futuro
capo dello stato tiene anche quello del 22 ottobre 1986, alla calata Trinità Maggiore, per la
cerimonia della traslazione, slittata di un anno in attesa del nulla osta delle Belle arti.
La banda dell'Arma, con gli strumenti listati a lutto, suona la marcia funebre di Chopin. A
tamburo battente e passo cadenzato, le spoglie avvolte nel tricolore sfilano tra una folla
strabocchevole, su un affusto di cannone scortato da 6 carabinieri e 8 bersaglieri. Il 23 ottobre
viene tumulato fra le regali tombe di Roberto d'Angiò e Ferdinando II di Borbone.
Il ,avigatore
Ugo Luca nasce il 24 maggio 1892 a Feltre, da un sottufficiale dell’Arma. Lui, come tanti
colleghi, prosegue idealmente la carriera paterna. Durante la prima guerra mondiale per ben tre
volte è decorato sul campo con la medaglia d'argento al valor militare.
Nel 1919, al comando della compagnia di Costantinopoli, entra presto nel "grande gioco"
mediorientale. Le sue attività di intelligence e le varie missioni speciali (di cui si sa ancora poco o
nulla) gli guadagnano sicuramente vaste entrature nella nuova dirigenza kemalista e il
soprannome di "Lawrence d'Anatolia". Impiegato in operazioni antibanditismo nel Dodecaneso,
dicono che abbia decapitato il famoso capo brigante Alekos, detto "berretto di pelo", terrore
dell'Egeo.
In Spagna Luca comanda i reparti carabinieri addetti al corpo truppe volontarie del
generale Roatta. Durante la seconda guerra mondiale svolge altre delicate missioni in Asia
Minore, poi comanda i Carabinieri addetti all'Aeronautica. A Roma, nel settembre 1943,
organizza il servizio informazioni del fronte clandestino di resistenza carabinieri, e segue poi il
comando della 5a armata americana.
Nell'immediato dopoguerra è impiegato in Sicilia. Anche per oscure collusioni con la
mafia e gli agrari, lo speciale ispettorato della Ps si rivela incapace di contrastare il movimento
indipendentista e la banda di Salvatore Giuliano, che in 4 anni uccide 120 appartenenti alle forze
dell'ordine, due terzi dei quali carabinieri.
La rivalità tra polizia e carabinieri assume presto anche risvolti politici. Subito dopo la
strage di Portella della Ginestra (1° maggio 1947) il comandante del gruppo carabinieri di
Palermo, maggiore Angrisani, guadagna l'apprezzamento del Pci ipotizzando per primo la pista
politica (la attribuisce infatti ad "elementi reazionari in combutta con la mafia"), mentre
l'ispettorato di Ps accredita la tesi riduttiva di un mero atto di banditismo, esposta alla camera dal
ministro degli Interni Scelba.
Finalmente, a seguito dell'attentato di Bellolampo contro un autocarro dei carabinieri (7
caduti e 11 feriti), il 26 agosto 1949 Scelba scioglie l'ispettorato di Ps. Presidente della regione,
prefetto e questore di Palermo sono Franco Restivo, futuro ministro dell'Interno (1968-72),
Angelo Vicari, futuro capo della polizia (1960-73), e Carmelo Marzano, coautore dell'arresto di
Mussolini, futuro capo dell'ispettorato di Ps del Quirinale nel settennato di Gronchi e infine
questore di Roma.
Gli speciali gruppi squadriglie di Ps e dei carabinieri vengono unificati in una formazione
di polizia interforze, il corpo forze repressione banditismo (Cfrb), analogo a quello impiegato nel
1924-28 contro la mafia dal prefetto Cesare Mori. Il comando lo danno a Luca, ormai in
promozione a generale. Pochi giorni dopo sfugge ad un agguato tesogli da Giuliano, in cui cadono
2 carabinieri di scorta.
Il Cfrb, con giurisdizione su un'area di oltre 4.000 kmq, include 3 raggruppamenti
(Alcamo, Montelepre e Corleone), 70 squadriglie (alcune a cavallo), 1 compagnia di riserva, 1
nucleo polstrada, 1 autodrappello, 1 nucleo di Pg, 1 servizio radio, 1 rimorchiatore della marina e
natanti leggeri. Conta 27 ufficiali dell'Arma, 16 della polizia, 1.500 carabinieri e 500 poliziotti, in
gran parte volontari, il doppio degli uomini di Mori (800) e dell'attuale Dia (945).
Il disciolto ispettorato di Ps non trasmette al Cfrb nessun documento e nessun
informatore. Luca deve ricostruire da capo una propria rete informativa, avvalendosi di 4
collaboratori di fiducia: il colonnello Giacinto Paolantonio, il capitano Antonio Perenze (veterano
di controguerriglia e antibanditismo in Libia ed Etiopia) e i marescialli Giovanni Lo Bianco e
Giuseppe Calandra.
In oltre 10 mesi di attività il Cfrb effettua 473 arresti e 25.000 perquisizioni e sostiene 24
conflitti a fuoco, con 7 banditi morti e 4 feriti. Ma soprattutto stringe Giuliano nel cerchio di una
capillare rete informativa e di controllo del territorio.
La notte del 5 luglio 1950 il bandito è sorpreso a Castelvetrano. Luca scrive nel rapporto
di averlo personalmente ucciso in conflitto a fuoco, ma la versione ufficiale è demolita da una
inchiesta dell'Europeo e da varie testimonianze.
L'ipotesi più verosimile, mai ufficialmente provata, è che ad uccidere Giuliano sia stato
invece il suo stesso luogotenente, Gaspare Pisciotta. "Collaborante" ante litteram, avrebbe tradito
il suo capo in cambio dell'impunità e della protezione offertagli dal capitano Perenze, e avrebbe
ucciso Giuliano di propria iniziativa, in violazione dei patti.
Il questore Marzano, anch'egli proveniente dai carabinieri, da un contributo fondamentale
a demolire la versione di Luca dando la caccia a Pisciotta e arrestandolo il 5 dicembre 1950. Il 9
febbraio 1954 Pisciotta muore nel carcere giudiziario di Viterbo, dopo aver bevuto un caffé
avvelenato con stricnina nella cella divisa col padre.
L'interpretazione oggi prevalente, politicamente fatta propria dalle Sinistre, ma non
provata, è che la localizzazione di Giuliano e l'omicidio di Pisciotta fossero opera della mafia, alla
quale settori della sicurezza o addirittura lo stesso Scelba avrebbero garantito in cambio
l'impunità.
Il Cfrb è sciolto cinque giorni dopo la morte di Giuliano. Luca si chiude nel più assoluto
riserbo. Dopo il passaggio in ausiliaria, è presidente del museo storico dell'Arma. Muore il 4
luglio 1967 per incidente stradale. Lo stesso anno il comando generale istituisce un ufficio
storico, dove vari anni dopo è trasferito l'archivio del museo.
L'Eroe
Al Cfrb appartiene anche il capitano Carlo Alberto Dalla Chiesa, nato a Saluzzo il 27
settembre 1920 da una famiglia di origine parmense e da un padre carabiniere di incrollabile fede
sabauda. Lui e il fratello minore Romolo lo seguono nelle varie sedi di servizio (Agrigento,
Ravenna) e poi anche nell'Arma.
Carlo Alberto però comincia la carriera in fanteria, sottotenente di complemento (1°
ottobre 1941). Col 120°, divisione Emilia, per 10 mesi fa controguerriglia in Montenegro: 2 croci
di guerra al valore. Il 12 ottobre 1942 passa nell'Arma, comandante della tenenza di San
Benedetto del Tronto, con alloggio privato a Villa Sorge.
Nel settembre 1943 entra in clandestinità, organizzando partenze di motopescherecci da
Martinsicuro, con una base a Nereto in casa della prima crocerossina della sua vita, Emma Lappa,
conosciuta a San Benedetto. In novembre forma 4 nuclei partigiani tra il litorale e la Val d'Aso.
Il 16 dicembre li guida oltre le linee. Il padre, comandante della legione di Bari, ha già
costituito il comando provvisorio dell'Arma in territorio libero, e dal 18 novembre ne è capo di
stato maggiore, in sottordine al generale Pièche. Resta nell'incarico fino al 6 giugno 1945, quando
passa al comando brigata di Milano.
Nei mesi successivi Carlo Alberto comanda una tenenza a Bari, frequenta il corso di
diritto penale tenuto da Aldo Moro e si laurea in giurisprudenza (110 e lode). Dal 1° giugno 1944
comanda il nucleo sicurezza della presidenza del Consiglio e dal 18 luglio la tenenza Parioli.
Il 12 aprile 1945 è aggregato alla 5a armata col compito di ricostituire i comandi a Parma.
Il 7 giugno, alla stazione di Milano, con Romolo riabbracciano il padre. Lui ricambia, poi li sbatte
agli arresti perchè l'hanno fatto in uniforme.
Tanto Carlo Alberto ha altro per la testa. E' Dora Fabbo, quindicenne napoletanina di Bari,
la mamma dei famosi (Ferdi) Nando e (Marghe) Rita, ma anche di Maria Simona. Il 10 giugno
1946 comanda la compagnia di Casoria, nel 1948 quella di Corleone, dove malgrado l'omertà,
assicura alla giustizia gli assassini del sindacalista Rizzotto e di un giovane testimone. Nel 1949
passa al Cfrb.
Negli anni '50 presta servizio a Firenze, Como, Milano, Roma e di nuovo a Milano, dove
rilancia l'immagine dell'Arma anche con le conferenze stampa (Vittorio Feltri sostiene che sia
stato lui a coniare il titolo "brillante operazione dei carabinieri" e "a rendere quasi una
competizione sportiva la rivalità" con la Ps).
Nel 1966 ritorna in Sicilia, comandante della legione di Palermo. Anche qui restaura una
ferrea disciplina e cura abilmente il rapporto con la stampa, ma anche il colonnello è in prima
linea (una pallottola in una gamba durante un conflitto a fuoco).
Sono gli anni in cui il procuratore generale dichiara che "la mafia, quale forma di
delinquenza organizzata, è in netto, accentuato e progressivo declino", e in cui i boss vengono
assolti a Catanzaro (1968) e Bari (1969). Invece la commissione parlamentare antimafia,
costituita nel giugno 1963 dopo la strage di Ciaculli, denuncia (1968) il controllo mafioso delle
aree fabbricabili e dello sviluppo edilizio di Palermo.
Ricostruendo il ruolo di Michele Cavataio, ucciso nel 1969 con altri mafiosi nell'ufficio di
un costruttore edile, Dalla Chiesa da un contributo fondamentale all'interpretazione della nuova
mafia. Lo affianca il capitano Giuseppe Russo, che per la prima volta riesce a infiltrarla. E' Dalla
Chiesa, nel 1971, a coniare il termine "collaboratore di giustizia", protestando con la stampa per
l'uso di un termine spregiativo ("informatore"). Nel 1973 invia alla commissione antimafia un
ampio rapporto sugli interessi mafiosi nel contrabbando di tabacchi e nel traffico di stupefacenti.
Russo cade il 20 agosto 1977. Dopo di lui cadono a Monreale i capitani Emanuele Basile
(4 maggio 1980) e Mario D'Aleo, quest'ultimo insieme a 2 carabinieri di scorta (13 giugno 1983).
L'ultimo caduto è il maresciallo Giuliano Guazzelli (1992).
Il 1° ottobre 1973 Dalla Chiesa assume il comando della I brigata di Torino. Crea uno
speciale nucleo antiterrorismo, e anche qui un infiltrato gli consente il primo arresto di Renato
Curcio (1974), fondatore e capo delle Br. Sono ancora gli uomini di Dalla Chiesa a intercettarlo
nella sparatoria (1975) in cui muore la moglie che l'ha liberato dal carcere, e a riacciuffarlo
definitivamente a Milano (1976). Questi successi chiudono le polemiche per l'assalto al carcere di
Alessandria, con 7 vittime tra ostaggi e rivoltosi, ordinato da un altro piemontese di ferro, il
procuratore Reviglio della Venaria.
Nel 1976 il comando generale (Mino) scioglie il nucleo antiterrorismo di Torino,
creandone altri 3 presso le divisioni territoriali (Milano, Roma e Napoli). In una successiva
deposizione alla procura di Milano (12 maggio 1981), Dalla Chiesa collega lo scioglimento del
nucleo alla sua decisione di impiegarlo anche contro il terrorismo di destra.
Nel 1977 il governo gli affida comunque il coordinamento del sistema di sicurezza delle
carceri (Sicurpena). E' lui a proporre il concentramento di terroristi e mafiosi in 7 carceri di
massima sicurezza (Fossombrone, Trani, Palmi, Novara, Asinara, Termini Imerese, Bad'e Carros
e Messina), e a creare (1978) il gruppo interventi speciali (Gis), che esordisce domando la rivolta
nel supercarcere di Trani con una fulminea operazione senza vittime (dicembre 1980).
Lo affianca e poi gli subentra in questo incarico il coetaneo, compagno di corso ed amico
Enrico Galvaligi, già ai suoi ordini quale comandante del gruppo di Palermo e poi della legione di
Torino.
Nel maggio 1978, dopo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro, il governo affida a Dalla
Chiesa il coordinamento interforze dell'antiterrorismo e scarta Galvaligi quale capo del
controspionaggio. La Sinistra insorge contro quell'incarico "sottratto ad ogni controllo". Lui la
rassicura in parlamento.
Dalla Chiesa dispone di 190 carabinieri (di cui 20-30 provenienti dal vecchio nucleo
torinese) e 40 poliziotti (tra cui alcune donne). Restano tuttavia sorde rivalità del Sisde e
dell'Ucigos che si acutizzano nel 1979 a proposito della collaborazione spontanea di Patrizio Peci.
Nel 1988 la commissione parlamentare sul caso Moro accerta che gli uomini di Dalla Chiesa
erano pedinati dalla polizia.
Il 1° ottobre 1978 Dalla Chiesa recupera nel covo di via Monte Nevoso la trascrizione
delle risposte rese da Moro all’interrogatorio dei suoi carcerieri e lo consegna ad Andreotti (per il
tramite del ministro dell’Interno ovvero, secondo una testimonianza di Franco Evangelisti
smentita da Andreotti, in un colloquio diretto e notturno). Altra trascrizione dattiloscritta
dell’originale (distrutto dai brigatisti assieme ai nastri), molto più ampia ma priva di ulteriori
rivelazioni sconvolgenti, spunta casualmente il 9 ottobre 1990, durante lavori di trasformazione
dell'appartamento di via Monte Nevoso. Una dettagliata analisi del testo (Biscione) ipotizza che
anche questa seconda versione abbia subito rimaneggiamenti rispetto all’originale, se non altro
nello schema espositivo.
Durante il sequestro di Moro, il giornalista Mino Pecorelli incontra cinque volte il
colonnello dei carabinieri Antonio Varisco. Dopo un presunto colloquio con Dalla Chiesa, scrive
su Op del 17 ottobre 1978 di aver appreso dal generale dei carabinieri "Amen" che la prigione di
Moro era stata tempestivamente localizzata, ma che il veto di un superpotere massonico aveva
impedito di salvarlo, e predice che "Amen" finirà ammazzato.
Secondo la successiva testimonianza (gennaio 1997) di Eugenio Scalfari, Galvaligi
racconta a Repubblica (off the record) che Dalla Chiesa ha trattenuto vari documenti rinvenuti nei
covi Br per avvalersene a scopo di autodifesa nei confronti di Andreotti.
L'uccisione di 4 brigatisti nel covo genovese di via Fracchia (28 marzo 1979) suscita
nuove polemiche. Alla vigilia della scadenza del mandato di Dalla Chiesa all'antiterrorismo (10
settembre) circolano voci che il governo non intende rinnovarlo. Secondo la testimonianza resa da
Cossiga alla Commissione Gualtieri (dicembre 1993), è proprio Dalla Chiesa a chiedere lo
scioglimento del reparto. Il governo Cossiga lo accontenta e lo destina al comando della 1a
divisione di Milano, in contrasto col parere espresso dal comando generale dell’Arma, mal
disposto verso individualismi e personalità di spicco.
Nel frattempo si susseguono gli omicidi di Pecorelli (20 marzo 1979), Varisco (14 luglio
1979) e Galvaligi (dicembre 1980). Il primo è (dal 30 luglio 1993) formalmente imputato ad
Andreotti, attualmente sotto processo a Perugia. Gli altri due sono attribuiti alle Br. A Brinzio, ai
funerali privati di Galvaligi, Dalla Chiesa abbraccia la vedova e il figlio Paolo, ufficiale dell'Arma
(nel 1997, dopo la testimonianza di Scalfari, gli esprime solidarietà Nando Dalla Chiesa).
Il 5 giugno 1980, dopo l'assoluzione di 17 brigatisti liguri, Dalla Chiesa denuncia
l'"ingiustizia che assolve". A seguito delle polemiche suscitate dalla frase, Dc e Pci si oppongono
alla proposta del Psi di affidargli il coordinamento dei servizi segreti. Ormai al culmine della
popolarità, il 13 febbraio 1981 lancia in Tv una sfida personale agli irriducibili delle Br.
Il 17 marzo, nella villa di Licio Gelli a Castiglion Fibocchi, viene sequestrato l'elenco
degli iscritti alla loggia massonica deviata P2. Figura tra gli iscritti anche Romolo Dalla Chiesa. Il
12 maggio il generale Picchiotti dichiara alla stampa che il 28 ottobre 1976 anche Carlo Alberto
ha presentato domanda di iscrizione. Il generale conferma, chiarendo di aver ceduto alle pressioni
dello stesso Picchiotti, ma di aver poi rifiutato (fine 1979) di incontrare Gelli. Nel dicembre 1981
lascia Milano per assumere l'incarico di vicecomandante generale dell'Arma.
Il 27 marzo 1982 la stampa anticipa la notizia che il governo, non senza contrasti,
intenderebbe nominarlo prefetto di Palermo con poteri straordinari, e ricorda il precedente del
prefetto Mori (1925-28). L'omicidio di Pio La Torre affretta la decisione. Il 1° maggio Dalla
Chiesa si insedia a Palermo. Nel primo discorso ufficiale ribadisce che l'unico potere legittimo è
quello dello stato e non sono concepibili deleghe a poteri occulti e ambienti criminali. Ma non ha
poteri definiti, né dispone di una propria struttura operativa. Rinuncia alla scorta. Il 21 agosto,
commemorando Russo, afferma: "L'hanno eliminato perchè non era garantito".
Vedovo dal 19 febbraio 1978, nell'autunno 1980 ha conosciuto a Milano Emanuela Setti
Carraro, crocerossina come sua madre Antonia. Lei ha trent'anni di meno. Solo nella primavera
del 1982 lui osa dichiararle il suo amore. Il 10 luglio la sposa nella cappella del castello di Ivano
Faceno (Trento).
Guida lei l'"A 112" privata, quella sera del 3 settembre a Palermo. Lui le fa invano scudo
del suo corpo contro le raffiche della Skorpion usata dal commando mafioso. L'agente-autista, che
segue sull'Alfetta di servizio, resta ferito. Ancora nel 3° anniversario, 30.000 persone lo ricordano
in corteo.
Il maresciallo Rocca
Durante la seconda guerra mondiale (1940-43) il cinema italiano dedicò almeno 15 film
alle varie componenti delle forze armate, ma nessuno ai carabinieri, trascurati perfino dai 20
cinegiornali Luce di soggetto militare.
I brigatisti che si dispiacciono di dover bucare l'uomo dentro alla divisa, l'hanno succhiata
col latte materno la famosa battuta in simil-barbaricino pronunciata da Amedeo Nazzari nel
Bandito di Alberto Lattuada (1946): "briggaddierre, non ce l'ho con llei, mma sse mmi costringge
sparro".
Tuttavia i carabinieri diventano protagonisti del grande schermo solo nel 1949,
contemporaneamente ai gendarmi francesi. Ma il film Gaumont-Actualité sulla gendarmeria,
Maréchaussée de France, è solo un laico documentario con commento di Paul Guimard,
distribuito a Natale in coda al film Parade des temps perdus.
Invece La fiamma che non si spegne, di Vittorio Cottafavi, è un tipico prodotto della
cinematografia cattolica, appropriato al patronato mariano appena concesso all'Arma da Pio XII.
Ecco la trama. Poco prima della grande guerra, i due figli di un contadino (Gino Cervi) lo
schiantano di dolore abbandonando la zappa, uno per diventare prete (Tino Buazzelli), e l'altro
carabiniere (Leonardo Cortese). Questo qui, prima di cadere sul Podgora (1915), fa appena in
tempo a consumare la prima notte di nozze e a lasciare una vedova e un figlio che poi, spinto e
aiutato dallo zio prete, rinuncia a seguire le orme paterne ed entra in seminario.
Ma un generoso intervento contro un ladro di sacrestia gli rivela che buon sangue non
mente. Così lascia la tonaca per l'uniforme, del resto nera anche quella. Durante l'occupazione
nazista è comandante di stazione, e compie lo stesso gesto di Salvo D'Acquisto. L'eroismo
militare svela a posteriori il disegno provvidenziale che lo riguardava. Il suo vero sacerdozio è
quello cui ogni uomo è chiamato secondo l'ordine di Melchisedech.
Ma per gli italiani i carabinieri veri sono quelli di Pane, amore e fantasia (1953) e Pane,
amore e gelosia (1954) di Luigi Comencini, con tanto di "bersagliera" (Gina Lollobrigida),
maresciallo (Vittorio De Sica), brigadiere (Memmo Carotenuto) e giovane carabiniere veneto
(Roberto Russo), che dice sempre "signorsì" e "conforme" (alla fine dimostra che non è affatto
scemo, ma soltanto limpido e onesto). Altri carabinieri delle nostre fiabe attendono Comencini
nel 1972 (Le avventure di Pinocchio).
De Sica interpreta splendidamente la figura sociale del sottufficiale, gentiluomo popolare,
mediatore tra stato e paese, in cui l'innata signorilità si definisce attraverso la scrupolosa
dedizione al servizio e un'ombra di maliconica solitudine simile a quella del parroco. Il suo
legame col ritmo biologico della comunità è sottolineato dal platonico e sentimentale flirt con la
prosperosa levatrice nubile (Lea Padovani).
Il successo dei due film (primo e secondo in classifica, con 1.374 e 1.418 milioni di
incasso, pari a 56 miliardi attuali), ne induce altri due, Pane, amore e ... (1955) di Dino Risi, e
Pane, amore e Andalusia (1958) di Xavier Setò. In questi ultimi De Sica, lasciata l'Arma, diventa
comandante dei vigili urbani, e la Lollobrigida è rimpiazzata da Sofia Loren e Carmen Sevilla.
Analogo successo (6-7 milioni di spettatori) i francesi tributano alla serie di Jean Girault,
con Louis De Funès: Le gendarme de Saint-Tropez (1964), Le gendarme se marie, Le gendarme à
,ew York, Le gendarme et les extra-terrestres (1978). L'ultimo è Le gendarme et les
gendarmettes (1982), dedicato all'arrivo dei primi gendarmi in gonnella nella mitica brigata di
Saint-Tropez.
Emulo di Comencini e Risi, Carlo Ludovico Bragaglia ottiene meno successo
rimpiazzando De Sica con Peppino De Filippo (Tuppe tuppe, marescià?, 1958). Dopo la
splendida interpretazione de Il generale Della Rovere (1959), De Sica torna carabiniere ne I due
marescialli (1961) di Sergio Corbucci, bonaria contaminatio tra il film tratto dal racconto di Indro
Montanelli e Guardie e ladri (1951), giocata sul doppio scambio di ruoli tra il carabiniere e il
truffatore in abito talare (Totò). Negli anni '70 De Sica sarà ancora maresciallo, ma delle guardie
di città nella Roma umbertina.
La censura di stato si innervosisce invece per Il carabiniere a cavallo (1961) di Carlo
Lizzani, con Nino Manfredi e Peppino De Filippo (stavolta brigadiere). Molte battute e situazioni
scabrose vengono tagliate. Premio speciale del VII Festival internazionale del film comico e
umoristico, incassa 370 milioni (6 miliardi attuali). Ma la stampa lo collega alle polemiche
seguite alla sparatoria di Ceccano (28 maggio 1962) in cui i carabinieri uccidono un operaio in
sciopero e ne feriscono sei (tra l'altro il governo coglie a pretesto quell'episodio per attuare la
sostituzione, già decisa, del comandante generale dell'Arma Renato De Francesco con Giovanni
de Lorenzo).
E' tuttavia significativo che, almeno sul grande schermo, la contestazione risparmi i
carabinieri, a differenza della polizia. Indagine su un cittadino al disopra di ogni sospetto (1970),
di Elio Petri, con Gian Maria Volonté e Florinda Bolkan, allude infatti vagamente all'immagine
negativa che la sinistra extraparlamentare ha diffuso del commissario Luigi Calabresi (poi
"assassinato da mani eversive", come ancor oggi recita la targa che lo commemora sul muro della
caserma Garibaldi di Milano).
I carabinieri sono anche i primi a beneficiare del nuovo clima ideologico prodotto dal
compromesso storico e dall'unità nazionale antifascista contro l'eversione. E' infatti del 1975
Salvo D'Acquisto, di Romolo Guerrieri, con Massimo Ranieri e Lina Polito. Accurato nei dettagli
e attento a umanizzare la figura dell'eroe, il settimo film sull'Arma forza tuttavia la verità storica,
attribuendogli anacronistici contatti con la Resistenza, che invece al 23 settembre 1943 non si era
ancora organizzata.
Anche i cortometraggi amatoriali servono a fare terra bruciata attorno ai "compagni che
sbagliano". Uno di 18', prodotto dall'Archivio nazionale cinematografico della Resistenza
(Cooperativa 28 dicembre di Torino), ricorda l'eccidio di Cudine (17 novembre 1944), dove
caddero 27 carabinieri e 6 garibaldini della 46a brigata piemontese.
La propaganda indiretta batte però altre strade. Nel 1977, in sole due settimane, vanno a
ruba 25.000 copie di una raccolta di barzellette sui carabinieri con introduzione di Sandro Medici
(Bertéllier, Carabinieri, Roma, Savelli). La Tiger Press (Milano) ne stampa almeno altre 5 (Il
primo...il quinto libro delle barzellette sui carabinieri), una all'anno (1978-83). Nel 1988 ne esce
un altro, curato da Danilo Aquisti (Carabinieri. La Superbarzelletta, Libreria Vecchia Roma).
Raccolte di barzellette, anche se filmate, sono I carab(b)inieri di Francesco Massari
(1981) e I carab(b)imatti di Giuliano Carnimeo (1982), entrambi con Giorgio Bracardi e Leo
Gullotta, il primo anche con Diego Abatantuono. Escono a cavallo della prima e unica comparsa
televisiva dei vertici dell'Arma (13 febbraio 1981). Replica nel 1985 Mariano Laurenti con
Carabinieri si nasce (Medusa distribuzione). Quest'ultimo è però un adattamento dell'analoga
serie americana Scuola di polizia, con tanto di carabiniera poppo-cosciuta.
Melodramma nazionalpopolare è invece Il carabiniere (1982), di Silvio Amadio. Un
camorrista (Enrico Maria Salerno), non resistendo all'onta, fa ammazzare il giovane carabiniere
(Massimo Ranieri) che amoreggia con la figlia. Finisce giustiziato dal capitano mammone (Fabio
Testi).
Già sergente nella Cisalpina (Fra diavolo) e di marina (Marinai, donne e guai), anche
Ugo Tognazzi, prima di cambiare genere (Madame Royale, Il Vizietto), ha fatto in tempo a fare il
carabiniere (I nostri mariti, 1966). E Renato Rascel, ovviamente, Il corazziere (1961: di Camillo
Mastrocinque).
Invece Alberto Sordi è stato fante (La grande guerra), sottotenente in Aoi (I due nemici) e
nell'artiglieria costiera (Tutti a casa), due volte partigiano e due volte vigile urbano (Guardia,
guardia scelta, brigadiere e maresciallo e poi Il Vigile), persino dragone francese (Le grandi
manovre): ma carabiniere mai.
Infatti è toccato all'allievo superare il maestro. Prodotto da Mario e Vittorio Cecchi Gori, I
due carabinieri è il regalo natalizio (1984) di Carlo Verdone, attore-regista in coppia con Enrico
Montesano. Qui la comicità sfuma abilmente nell'elegia: dal quotidiano all'eroismo, senza
ignorare il dramma della morte in servizio (è Massimo Boldi il carabiniere nevrotico e
ipocondriaco, "la sera leone, la mattina coglione", che salta in aria in un attentato, con allusione a
quello di Peteano).
Maurizio Ponzi replica con Il tenente dei Carabinieri (1986), anche questo con Boldi e
Montesano (il tenente anticonformista e pasticcione) e con Manfredi promosso colonnello.
Verdone gira invece, nel 1989, Un poliziotto per amico.
In vari film drammatici il personaggio del carabiniere inflessibile e coraggioso ha un ruolo
di spicco, come nel Gobbo (del Quarticciolo) di Carlo Lizzani (1960). Ma non si presta al
poliziesco all'italiana né al cinema di denuncia politica. Inseguimenti, sparatorie, confessioni
estorte, prove fabbricate, bassifondi sociali impongono figure meno moralmente definite e più
ambigue. Calzano meglio al commissario i ruoli di antieroe filosofo (Pietro Germi) o sgualcito
(Ugo Tognazzi), sbirro paranoico (Gian Maria Volonté), cane sciolto (Michele Placido).
La riprova è la scarsa credibilità di Luca Barbareschi e Silvio Orlando nel ruolo di capitani
dei carabinieri, uno nel Tv movie (Rai2) La tenda nera di Luciano Manuzzi (1996), una storia
"nera italiana" tratta da un racconto di Carlo Lucarelli, e l'altro ne La mia generazione di Wilma
Labate (1996).
Del resto, come accerta il sondaggio Consulting Unit 1990, gli italiani preferiscono
Magnum P.I, Derrick, il tenente Colombo, Maigret, Poirot, Sherlock Holmes e Marlowe a Miami
Vice, Starsky e Hutch, Chips e Baretta.
Gli antieroi del filone giustizialista dell'ultimo ventennio sono più spesso (La Piovra,
Palermo-Milano sola andata) poliziotti (sporadicamente di sesso femminile, come in Corpi
speciali). Del resto non a caso è il duro cinismo del poliziotto indurito a disilludere l'innocenza
del giovane carabiniere calabrese (Enrico Lo Verso) nel Ladro di bambini di Gianni Amelio
(1992), il più autentico tributo cinematografico al valore etico che gli italiani investono
nell'Arma.
Eppure anche l'Arma è protagonista nel cinema antimafia: Salvatore Giuliano (1961) di
Francesco Rosi, Il giorno della civetta (1968) di Damiano Damiani, Cento giorni a Palermo
(1983) di Giuseppe Ferrara e La scorta (1993) di Ricky Tognazzi (testi di Simona Izzo e
Graziano Diana). Quest'ultimo, liberamente ispirato alla vicenda del giudice Taurisano, è
contestato al festival di Cannes dopo un trafiletto di Marcelle Padovani, corrispondente romana
del ,ouvel Observateur, che lo accusa di "speculare sul sangue dei poliziotti uccisi".
Nei tre ultimi film, il capitano (Franco Nero), il generale Dalla Chiesa (Lino Ventura) e la
giovane moglie caduta al suo fianco (Giuliana De Sio), i giovani carabinieri di scorta a Taurisano
(Claudio Amendola, Enrico Lo Verso, Ricky Memphis, Tony Sperandeo), pur nello studio dei
caratteri, sono tutte figure moralmente definite ed esemplari. Ci voleva un regista americano
come Michael Cimino per rappresentare i carabinieri come guardie di Somoza (Il Siciliano, 1987,
con Christofer Lambert e Giulia Boschi).
Il 10 aprile 1996 va in congedo Salvatore Careddu, il maresciallo vero che ha ispirato il
personaggio letterario dello scrittore (ma anche regista) Mario Soldati, e che nel 1984 è stato
impersonato in Tv da Arnoldo Foà con l'aggiunta di una pipa alla Maigret (I nuovi racconti del
maresciallo, diretti da Giovanni Soldati).
Largo adesso a Gigi Proietti, Il maresciallo Rocca (Giorgio Capitani e Lodovico
Gasparini), in onda su Rai2 con Stefania Sandrelli. Alla presentazione del primo episodio (12
gennaio 1996) intervengono il presidente della Rai Letizia Moratti (governo Berlusconi) e il
comandante generale Federici (governo Amato). Consulenza tecnica e impiego dei mezzi,
infrastrutture e personale dell'Arma incombono al colonnello Baldassarre Favara, capo ufficio
propaganda.
Però non gli taglia, il colonnello, quella improbabile e sfottente barbetta fuori ordinanza.
Infatti ci vuole, rende più riconoscibile l'implicito messaggio nuovista che promana dai due
protagonisti. Comunque, in campagna elettorale, meglio parlar chiaro: "il maresciallo Rocca?
Voterebbe Ulivo..." (La Repubblica, 12 aprile).
Per emulazione, la polizia arranca con Eros Pagni (Ferri investigazioni, 1997). Ma, come
poliziotto, resta decisamente più attraente Nancy Brilli. Comunque meglio Linda e il brigadiere
(1996), dove il commissario Linda (Klaudia Koll) conquista il pubblico grazie anche al padre
(Manfredi) bonario e protettivo (retrocesso da colonnello a brigadiere dell'Arma in pensione).
Giovanni, carabiniere paracadutista
A Milano, in piazza Diaz, il 13 dicembre 1981 Spadolini, presenti il cardinal Martini e il
sindaco Tognoli, inaugura il monumento al carabiniere. E' di Luciano Minguzzi, una fiamma
d'acciaio alta 10 metri. Un altro monumento, ad iniziativa di un comitato civico, sorge ad Ostiglia
il 26 maggio 1985.
Sempre nel 1980-82 l'ente editoriale dell'Arma pubblica una pregevole storia dei
carabinieri a fascicoli curata da Giorgio Maiocchi e corredata da un ricco e spesso inedito
apparato iconografico, da raccogliere in 4 volumi, più un quinto con 30 testi letterari dedicati ai
carabinieri (Mario Soldati, Edmondo De Amicis, Luigi Barzini, Marino Moretti, Renato Fucini,
Giuseppe Boella, Ferdinando Paolieri, Giancarlo Grossardi, Cesare Quarenghi, Franco Di Bella, e
9 "racconti veri" tratti dal Carabiniere).
Nel 1985 l'ufficio pubbliche relazioni del comando generale aggiunge al consueto
calendario un'agenda con la raccolta delle migliori barzellette, e affida all'agenzia romana Ayer le
campagne pubblicitarie dell'Arma. Solo quelle della marina e della finanza reggono il confronto.
La campagna 1987 esibisce un testimonial d'eccezione. "Giovanni, carabiniere
paracadutista", è solo uno dei nove che illustrano altrettante specialità dell'Arma. Il volto non è
ancora noto, e la didascalia non dice il cognome, ma le agenzie diffondono la notizia che si tratta
proprio del figlio di Umberto Agnelli, che sta svolgendo il servizio di leva come carabiniere
ausiliario.
Gli slogan degli anni '80 sono: "carabiniere, professione sociale", "un posto a pieno merito
nella società", "un futuro di tecnico preparato ed efficiente. Con o senza divisa", "in ogni città,
quartiere o paese e nel cuore della gente", "tra la gente, per la gente", "dove la gente chiama",
"l'attualità del pennacchio rosso e blu".
Anche la pubblicità commerciale utilizza l'immagine dell'Arma: "che differenza c'è tra le
(scarpe) Primigi e i carabinieri? Nessuna: queste e quelli vanno sempre in coppia".
L'arresto di Pinocchio
Accade talvolta che perfino gli operatori di giustizia subiscano una sorta di "sindrome di
Stoccolma", affezionandosi ai clienti più famosi delle loro manette e capestri. E' toccato anche ai
carabinieri, che hanno amorevolmente conservato e pubblicato le raccapriccianti foto color seppia
coi cadaveri dei briganti messi in posa per farli sembrar vivi e pimpanti, come si usava in quel
feroce Far West italiano che fu la repressione del brigantaggio meridionale. Varie in bianco e
nero (5 luglio 1950) tramandano la vendetta per la strage di Bellolampo (19 agosto 1949), col
cadavere di Turi Giuliano in sandali e canottiera.
Ma i carabinieri si commuovono davvero a ricordare gli arresti dei grandi italiani, non
solo per farci sapere che non guardano in faccia a nessuno (come quei due carabinieri che pochi
anni fa, usciti fuori strada e soccorsi da un samaritano, lo multarono perchè sprovvisto di bollo).
Ovviamente qualche volta, essendo italiani anche loro, ci mettono un pizzico di
sfacciataggine, come nel 1987, quando, nel cinquantenario della morte, il calendario dell'Arma si
intenerì sul doloroso arresto di Antonio Gramsci. Ma più spesso la contrizione è sincera, come
nella battuta che Giorgio Bracardi pronuncia nel film I Carab(b)inieri (1981): "certo, di aver
arrestato Pinocchio gli italiani non ci perdoneranno mai".
Purtroppo furono i bersaglieri a ferire Garibaldi all'Aspromonte (1862). Ma l'onore di
arrestarlo toccò ai carabinieri, addirittura per tre volte. La prima (5 settembre 1849) a Chiavari, su
ordine del generale Lamarmora, regio commissario straordinario a Genova, per impedirgli di
fomentare nuove insurrezioni dopo quella schiacciata nel sangue in aprile.
Gli altri due arresti, piuttosto ossequiosi, avvennero nel 1867 a Sinalunga (24 settembre) e
Figline Valdarno (4 novembre), in connessione con la fallita spedizione garibaldina contro lo
stato pontificio, che il governo italiano sconfessò per evitare la guerra con la Francia, garante del
dominio temporale del papa. I carabinieri lo bloccarono sul treno dove viaggiava con Crispi e
buon numero di volontari, e stavolta il generale fece resistenza passiva, pestando i piedi che
voleva un brodo. Ma il suo ciclopico raffreddore fu nulla a confronto della bufera politica
scatenata dal sacrilegio.
Ma ancora, piuttosto, appassiona un altro arresto eccellente. Accanto alla famosa
ambulanza che il mattino del 25 luglio 1943 aspettava nel giardino di Villa Savoia, sul lato destro
dell'edificio, c'erano tre gruppi. Più indietro i dirigenti, tenente colonnello Frignani e questore
Marazzini. Più avanti i capitani Aversa e Vigneri scortati da 3 vicebrigadieri, con il compito di
arrestare Mussolini. Ma in caso di resistenza, sparargli toccava a 3 poliziotti. La scorta aspettava
dietro la villa: 50 carabinieri e un autocarro pesante.
Faccia il nostro carabiniere carabiniera ancora te
La polizia femminile nacque nel 1959, a carattere civile e con compiti limitati alla tutela
della donna e dell'infanzia, poco più che assistenti sociali. Ma già all'epoca del sequestro Moro
qualcuna operava nell'antiterrorismo, mentre le vigilantes dell'Europol, in tacchi a spillo,
pistolone e gagliardetto nero, si esercitavano al tiro lungo la via Appia e sorvegliavano case sfitte
e supermercati.
Con la smilitarizzazione del 1981 le donne furono ammesse senza limiti di organico e di
compiti nella polizia di stato. Lo stesso avvenne nel 1991 per la polizia penitenziaria (sorta dal
"matrimonio" tra agenti di custodia e vigilatrici) e nel 1993 per il corpo forestale dello stato (ben
lieto di poter archiviare la notte di Tora Tora contrapponendo Deborah Compagnoni al
carabiniere Alberto Tomba). La Dc lo predisse invano che ci voleva il tetto del 20 per cento. Però
la costituzione vieta le discriminazioni, e la commissione per le pari opportunità vigila. Ma le
donne, proprio perchè discriminate dal sistema produttivo, sono disposte ad accettare i lavori
disdegnati dagli uomini di pari istruzione e capacità. Infatti, ai primi concorsi ambosessi per la
polizia (di fatto avviati solo nel 1985) le concorrenti, col 40 per cento delle domande, vinsero il
60 per cento dei posti. Oggi, nella polizia di stato, le donne sono già il 9.8 per cento (10.139,
inclusi 27 dirigenti e 729 commissari), pari tuttavia a metà del personale arruolato nell'ultimo
decennio. Terrorizzati, sindacati e amministrazione tamponarono la falla con geniali restrizioni
(due centimetri in più nel bando di concorso falcidiano le domande femminili) e concorsi riservati
a categorie maschili (poliziotti ausiliari di leva e volontari a ferma prolungata delle forze armate).
Indubbiamente l'ingresso delle donne ha contribuito a rilanciare l'immagine della polizia,
ovviamente senza modificarne sostanza e mentalità (generalmente le donne hanno capacità
mimetica e di introiezione valoriale superiore a quella degli uomini e quindi rafforzano
ulteriormente la chiusura corporativa). Ma in qualche modo ha messo a nudo la sua vera natura,
laica e profana.
E così ha giovato paradossalmente soprattutto ai carabinieri, svelando per contrasto il
fondamento sacerdotale della loro diversità dalle altre polizie. I lip service alla parità dei sessi del
comando generale non incantano nessuno. Prima la Chiesa cattolica molli sul sacerdozio
femminile, poi si vedrà.
Nel 1987, quando già ci stavamo riprendendo dallo shock delle prime poliziotte, la stampa
si occupò di una delle ragazze che avevano presentato domanda d'arruolamento nell'Arma, Ariella
Roccasecca, sedicenne livornese abbonata al Carabiniere. La vicenda ispirò una story del fumetto
Alt. Storie di gente in divisa (n. 1, febbraio 1988, pp. 139-186). Guido Buzzelli le dedicò una
vignetta nel Satyricon di Repubblica (22-23 novembre): una bellissima carabiniera che si trucca
in alta uniforme, con ai piedi un malizioso diavoletto ammanettato.
Nella ricorrenza dell'8 marzo (1992) le donne del Siulp distribuirono un questionario sulle
molestie sessuali in polizia. I ministri della Difesa (Rognoni) e degli interni (Scotti) ne
approfittarono per proporre le donne carabiniere. "L'Arma corteggia le donne: 'abbiamo bisogno
di voi...", titolava Repubblica del 9 marzo. Gente del 10 marzo chiarì l'equivoco, pubblicando la
foto in divisa del carabiniere Carlo Barbato e dell'agente Gloria Redaelli, novelli sposi a Brescia.
In fondo i maschi italiani alle donne carabiniere ci sono abituati. Almeno quelli sposati. E
le mogli dei carabinieri hanno pure preminenza gerarchica. Una si rivolse a Rita Dalla Chiesa
invocando la punizione disciplinare del marito fedifrago, la cui infedeltà coniugale "ha infangato
anche la divisa che indossa" (Epoca, 18 gennaio 1994, p. 82).
Eppure vere donne carabiniere, senza bandoliera, ma con gli alamari, ci sono state. Per
fortuna è stato possibile decretarne la damnatio memoriae, dato che fu il governo di Salò a
costringere i carabinieri della Gnr a prendersi la loro aliquota di ausiliarie.
Generalmente i marescialli si arrangiarono dando bracciali ed alamari alle mogli già
alloggiate in caserma. Le utilizzavano da sempre per le perquisizioni su individui di sesso
femminile, e lo stesso mitico regolamento generale prevede che in caso di emergenza le chiavi
della caserma siano consegnate alla moglie del sottufficiale più giovane (galateo: l'età delle
signore non si chiede, si presume da quella del marito).
Ho conosciuto un giovane tenente colonnello, impazzito per aver scoperto quel tremendo
segreto nelle carte a lui affidate. La notte sognava Il nome della rosa, il cieco ghigno di Jorge che
avvelena gli angoli dei fogli. Ora vive a Camaldoli, cercando la pace.
PRIMA E DOPO PORTA PIA
Costantino Nigra, La Rassegna di ,ovara (1861)
Calma, severa, tacita, compatta,
Ferma in arcione gravemente incede
La prima squadra e dietro al Re s'accampa
In chiuse file. Pendono alle selle
Lungo le staffe nitide, le canne
Delle temute carabine. Al lume
Delle stelle lampeggiano le guainate
Sciabole. Brillan di sanguigne tinte
I purpurei pennacchi, erti ed immoti
Come bosco di pioppi irrigidito.
Del Re custodi e delle leggi schiavi
Sol del dover, usi obbedir tacendo
E tacendo morir, terror de' rei
Modesti ignoti eroi, vittime oscure
E grandi, anime salde in salde membra;
Mostran nei volti austeri, nei securi
Occhi, nei larghi lacerati petti,
Fiera, indomata la virtù latina.
Risuonate tamburi; salutate
Aste e vessilli. Onore, onore ai prodi
Carabinieri.
Preghiera del Carabiniere (1949)
Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi carabinieri d'Italia a Te eleviamo
reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore!
Tu, che le nostre legioni invocano confortatrice e protettrice col titolo di Virgo Fidelis, Tu
accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la Patria nostra.
Tu accompagna la nostra vigilanza. Tu consiglia il nostro dire, Tu anima la nostra azione,
Tu sostenta il nostro sacrificio, Tu informa la devozione nostra!
E da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimonianza, con la
fedeltà fino alla morte, l'amore a Dio e ai fratelli italiani. E così sia!
1. L'Albo d'Oro dell'Arma (1996)
------------------------------------------------------------------
| Perdite | Caduti | Feriti | Decorati |
|----------------------------------|--------|---------|----------|
| Guerre del Risorgimento 1848-70 | 9 | .. | .. |
| Antibrigantaggio 1860-70 | 308 | 516 | 850 |
| Insurrezione di Palermo 1866 | 53 | .. | .. |
| Eritrea 1887-1918 | 27 | .. | 44 |
| Terremoto di Messina 1908 | 11 | .. | (114) |
| Guerra italo-turca 1911-12 | 26 | .. | .. |
| Terremoto di Avezzano 1915 | 30 | .. | .. |
| Guerra 1915-18 | 1.411 | 5.254 | 1.941 |
| Caccia ai disertori 1915-19 | 22 | 189 | .. |
| Ordine pubblico 1919-22 | 43 | 474 | 119 |
| Riconquista della Libia 1923-30 | 74 | .. | .. |
| Campagna antimafia (Mori) 1926-7 | 11 | 350 | 67 |
| Servizio ordinario 1815-1935 | 1.023 | .. | .. |
| Guerra italo-etiopica 1935-36 | 208 | 800 | 596 |
| Servizi di istituto 1936 | 38 | 241 | 41 |
| Guerra di Spagna 1936-39 | 9 | 33 | 163 |
| Aoi e serv. di istituto 1937-45 | 312 | .. | .. |
| guerra 1940-43* | 1.883 | 8.603 | 1.968 |
| guerra 1943-45** | 2.735 | 6.521 | 753 |
| Servizi di istituto 1946-73*** | 805 | 57.802 | 1.966 |
| Servizi di istituto 1974-79*** | 127 | 17.574 | 308 |
| Servizi di istituto 1980-96*** | 298 | 40.143 | 923 |
|----------------------------------|--------|---------|----------|
| Totale | 9.463 | 150.984 | 18.045 |
|----------------------------------------------------------------|
| * Più 578 dispersi (1940-43). Escluso personale straniero. |
| ** Di cui 29 caduti e 136 feriti delle unità regolari della |
| guerra di liberazione e 620 morti nei lager. |
| *** di cui 11 caduti in scontri di piazza (1946-49), 80 nella |
| lotta contro il banditismo siciliano (1943-50), 4 contro il |
| terrorismo altoatesino (1964-67), 26 contro l'eversione (1974- |
| 82), 7 contro la mafia siciliana (1977-92), 4 in operazioni di |
| pace all'estero (1952, 1993 e 1995). |
| N.B. Polizia (1848-1992): 2.663 caduti e 65.334 feriti. |
|----------------------------------------------------------------|
| Ricompense | Collettive | Individuali |
|-------------------------------------|------------|-------------|
| Croci dell'Ordine militare d'Italia | 4 | 20 |
| Medaglie d'oro al valor militare | 3 | 110 |
| Medaglie d'oro al v. dell'esercito | 3 | 2 |
| Medaglie d'oro al v. di marina | - | 1 |
| Medaglie d'argento al v. militare | 5 | 3.152 |
| Medaglie d'argento al v. esercito | - | 10 |
| Medaglie d'argento al v. di marina | - | 22 |
| Medaglie di bronzo al v. militare | 4 | 5.721 |
| Medaglie di bronzo al v. esercito | - | 14 |
| Medaglie di bronzo al v. di marina | - | 42 |
| Croci di guerra al valor militare | 2 | 3.612 |
| Medaglie d'oro al valor civile | 3 | 68 |
| Medaglie d'argento al v. civile | 1 | 2.007 |
| Medaglie di bronzo al v. civile | - | 3.264 |
| Medaglie d'oro al merito d. sanità | 3 | - |
| Medaglie d'oro di benemerenza | 5 | - |
| Medaglia d'oro della Rep. S.Marino | 1 | - |
------------------------------------------------------------------
2. Il Corpo dei carabinieri reali (1814-61)
------------------------------------------------------------------
| Anni | Uffi-| Truppa | Divi- | Compagnie | Brigate | Corpi di |
| | ciali| | sioni | e tenenze | | Sardegna* |
|------|------|--------|-------|-----------|---------|-----------|
| 1814 | 27 | 776 | 6 | - .. | .. | 748 |
| 1816 | 69 | 1.999 | 6 | 19 28 | 355 | 748 |
| 1819 | 69 | 1.999 | 6 | 19 28 | 355 | 681 |
| 1822 | 100 | 2.900 | 9 | 23 28 | 355 | - |
| 1832 | 61 | 1.993 | - | 9 32 | 320 | 419 |
| 1833 | 61 | 2.119 | 7 | 7 32 | 320 | 675 |
| 1843 | 68 | 2.190 | 7 | 19 52 | 351 | 675 |
| 1852 | 69 | 2.983 | 7 | 19 30 | 400 | 1.126 |
| 1853 | 69 | 2.983 | 7 | 19 30 | 400 | 857 |
| 1858 | 75 | 2.800 | 7 | 23 53 | 400 | 882 |
| 1860 | 120 | 4.600 | 19 | 47 87 | 1.060 | 882 |
|----------------------------------------------------------------|
| * 1814 Cavalleggeri e moschettieri. 1819 Cacciatori reali. |
| 1822 aliquota cc. rr. in Sardegna. 1832 Cavalleggeri. 1853 Ca- |
| rabinieri reali di Sardegna. 1861 Legione cc. rr. di Cagliari. |
------------------------------------------------------------------
3. Gli organici dell'Arma dei carabinieri (1861-1995)
----------------------------------------------------
| Anni | Uffi- | Truppa || Anni | Uffi- | Truppa |
| | ciali | || | ciali | |
|------|-------|---------||------|-------|---------|
| 1861 | 428 | 17.958 || 1939 | 2.610 | 58.695 |
| 1862 | 553 | 19.363 || 1940 | | 92.871 |
| 1867 | 563 | 22.549 || 1941 | | 117.059 |
| 1868 | 456 | 19.294 || 1942 | | 135.455 |
| 1870 | 417 | 18.000 || 1943 | | 143.194 |
| 1880 | 519 | 19.708 || 1945 | | 63.238 |
| 1887 | 622 | 24.004 || 1947 | | 73.238 |
| 1899 | 576 | 25.027 || 1960 | 1.590 | 77.188 |
| 1910 | 685 | 30.008 || 1963 | 1.764 | 75.292 |
| 1915 | 810 | 30.705 || 1967 | 1.940 | 78.967 |
| 1916 | 903 | 33.313 || 1970 | 2.012 | 79.580 |
| 1917 | 1.077 | 51.313 || 1975 | 2.102 | 80.417 |
| 1919 | 1.361 | 60.000 || 1978 | 2.184 | 82.144 |
| 1923 | 1.536 | 75.000 || 1980 | 2.143 | 89.430 |
| 1926 | 1.247 | 60.000 || 1989 | 2.442 | 105.185 |
| 1929 | 1.112 | 50.000 || 1990 | 2.568 | 105.866 |
| 1935 | 1.111 | 46.568 || 1992 | 2.568 | 107.804 |
| 1936 | | 56.766 || 1994 | 2.684 | 110.636 |
| 1938 | 1.169 | 50.810 || 1995 | 2.847 | 111.551 |
----------------------------------------------------
4. Forza dei comandi superiori carabinieri al 1° giugno 1940
------------------------------------------------------------------
| Comandi | Uff.li | Sott.li | Carabinieri | Zaptié | Totale |
|-------------|--------|---------|-------------|--------|--------|
| Asi (Libia) | 50 | 294 | 471 | 1.505 | 2.320 |
| Aoi | 76 | 811 | 2.085 | 6.086 | 9.058 |
| Albania* | 164 | 883 | 3.922 | - | 4.969 |
| Marina | 28 | 281 | 1.089 | - | 1.398 |
| Aeronautica | 48 | 264 | 4.295 | - | 4.607 |
|----------------------------------------------------------------|
| * Forza al 1° agosto 1940. |
------------------------------------------------------------------
5. Effettivi dei corpi di polizia dal 1861 al 1996
-------------------------------------------------------------
| Anni | Carabinieri | Polizia | Finanza | Altri* | Totale |
|------|-------------|---------|---------|--------|---------|
| 1861 | 18.461 | 4.963 | 14.153 | .. | 40.000 |
| 1867 | 23.112 | 6.151 | 16.331 | .. | 50.000 |
| 1901 | 25.603 | 9.238 | 18.267 | 7.320 | 60.428 |
| 1921 | 60.000 | 50.000 | 26.694 | .. | 140.000 |
| 1927 | 60.000 | 20.000 | 28.664 | 20.000 | 125.000 |
| 1938 | 51.979 | 19.498 | 30.000 | 40.000 | 135.000 |
| 1945 | 55.000 | 31.000 | 35.000 | 10.000 | 131.000 |
| 1949 | 75.000 | 70.000 | 40.000 | 18.000 | 203.000 |
| 1961 | 76.432 | 84.121 | 40.600 | 18.100 | 219.253 |
| 1975 | 80.496 | 82.795 | 43.213 | 22.940 | 229.444 |
| 1996 | 114.398 |103.101 | 66.256 | 46.188 | 329.943 |
|-----------------------------------------------------------|
| * milizie speciali, corpo forestale, polizia carceraria |
-------------------------------------------------------------
6. Gli ordinamenti dell'Arma (1862-1980)
------------------------------------------------------------------
| Anni | Divi- | Ispett. | Legioni | Leg.All.| Batt.ni| Stazioni |
| | sioni | Brigate | territ. | e Scuole| mobili | |
|------|-------|---------|---------|---------|--------|----------|
| 1862 | - | - | 13 | 1 - | - | 2.199 |
| 1868 | - | - | 10 | 1 - | - | 2.199 |
| 1887 | - | - | 11 | 1 1 | - | 2.100 |
| 1917 | - | 5 | 14 | 1 2 | - | |
| 1919 | - | 7 | 21 | 1 2 | 18 | |
| 1923 | - | 8 | 21 | 1 2 | 12 | |
| 1926 | - | 5 | 21 | 2 1 | 12 | |
| 1934 | - | 6 | 20 | 1 1 | 3 | |
| 1938 | 3 | 6 | 20 | 1 1 | 2 | 5.053 |
| 1940 | 3 | 7 | 28* | 1 1 | 4 | |
| 1945 | 3 | 6 | 21 | 1 1 | 12 | |
| 1947 | 3 | 9 | 21 | 1 1 | 13 | |
| 1959 | 3 | 10 | 24 | 2 2 | 13 | 5.280 |
| 1963 | 3 | 11 | 24 | 2 2 | 14 | |
| 1980 | 3 | 11 | 24 | - 4 | 14 | 4.671 |
|----------------------------------------------------------------|
|* incluse 2 legioni in Albania, 2 in Libia e 4 in Aoi. |
|----------------------------------------------------------------|
| Legioni territoriali (* trasformate in Regioni carabinieri) |
| Legioni allievi cc (trasformate nel 1971 in Scuole allievi cc) |
|----------------------------------------------------------------|
| Genova 1861-65 e 1916-93* | Palermo 1861-1993* |
| Torino 1861-1993* | Roma 1873-1993* |
| Milano 1861-1993* | Messina 1916-93 |
| Ancona 1861-66 e 1885-1993*| Livorno 1919-93 |
| Bologna 1861-1993* | Alessandria 1919-93 |
| Firenze 1861-1993* | Perugia 1927-29 e 1957-93* |
| Cagliari 1861-1993* | Lazio 1927-93 |
| Catanzaro 1861-77 e 1916-93* | Padova 1927-93* |
| Napoli 1861-1993* | Bolzano 1929-93* |
| Salerno 1861-68, 1919-27 e | Udine 1950-93* |
| 1951-93 | Parma 1953-93 |
| Bari 1861-1993* | Brescia 1953-93 |
| Chieti 1861-69, 1919-29 e | All. Roma 1861-1943 e 1944-71|
| 1949-93* | All.Torino 1926-34 e 1951-71 |
|----------------------------------------------------------------|
| Enti e istituti culturali e assistenziali dei carabinieri |
|----------------------------------------------------------------|
| Associazione nazionale carabinieri (1885/1926). |
| Banda dell'Arma dei carabinieri (1862/1885/1920). |
| Ente editoriale per l'Arma dei carabinieri (1975). |
| Museo storico dell'Arma dei carabinieri (1925). |
| Opera nazionale assistenza orfani militari dell'Arma (1959). |
| Rassegna dell'Arma (1961). |
| Rivista Il Carabiniere (1872). |
| Ufficio storico del Comando generale (1967). |
------------------------------------------------------------------
7. L'ordinamento attuale (1996)
-----------------------------------------------------------------
| Comando generale dell'Arma |
| - 1 sala operativa carabinieri |
| - 1 raggruppamento operativo speciale (Ros) su 28 sezioni |
|---------------------------------------------------------------|
| Ispettorato scuole carabinieri (Roma) |
| - Scuola ufficiali carabinieri (Roma) |
| - X Brigata carabinieri (Roma) |
| . 1° reggimento allievi marescialli e brigad. (Velletri) |
| . 2° reggimento allievi marescialli e brigad. (Firenze) |
| . 3 scuole allievi cc (Torino, Roma, Benevento) |
| . 8 btg: 1° Torino, 2° Fossano; 1° Roma, 2° Campobasso, |
| 3° Iglesias; 1° Benevento, 2° Chieti, 3° Reggio C. |
| - 1 centro cc addestramento alpino (Selva Val Gardena) |
| - 1 centro cc perfezionamento al tiro (Roma) |
| - 1 centro cc psicologia applicata (Roma) |
|---------------------------------------------------------------|
| Divisioni carabinieri: 1. Pastrengo (Milano) |
| 2. Podgora (Roma) 3. Ogaden (Napoli) |
| 4. Culqualber (Messina) 5. Vittorio Veneto (Padova). |
| - 18 comandi regione carabinieri (28 sez. anticrimine/Ros) |
| - 95 comandi provinciali e 95 reparti operativi |
| - 11 gruppi, 516 compagnie e 4.664 stazioni |
|---------------------------------------------------------------|
| 6. Divisione unità mobili e speciali Palidoro (Roma) |
| - XI Brigata carabinieri (Roma) |
| . Reggimento corazzieri (Roma) |
| . Reggimento carabinieri a cavallo (Roma) e centro ippico |
| . 1° Reggimento carabinieri (Milano) |
| . 2° Reggimento carabinieri (Roma) |
| . 1° Reggimento cc paracadutisti Tuscania (Livorno) con |
| 1 Gis e 2 squadroni cc cacciatori (Vibo e Abbasanta) |
| . 13 battaglioni cc (1° Piemonte, 2° Liguria, 3° Lombardia|
| 4° Veneto, 5° Emilia-Romagna, 6° Toscana, 7° Trentino|
| Alto Adige, 8° Lazio, 9° Sardegna, 10° Campania, 11° |
| Puglia, 12° Sicilia, 13° Friuli-Venezia Giulia) |
| - XII Brigata carabinieri (Roma) |
| . nuclei carabinieri |
| - presidenza repubblica - presidenza del consiglio |
| - consiglio di stato - corte dei conti |
| . reparti carabinieri |
| - gabinetto difesa - stato maggiore difesa |
| - stato maggiore esercito - segreteria generale difesa |
| - servizi magistratura - servizi sicurezza carceri |
| . comandi carabinieri |
| - marina militare - aeronautica militare |
| - corte costituzionale - senato della repubblica |
| - camera dei deputati - ministero affari esteri |
| - banca d'Italia (Noaf) - per la sanità (Nas/Nad) |
| - tutela ambientale (Noe) - tutela patrim. artistico |
| - tutela norme agroaliment. |
| . centri carabinieri |
| - cinofili (Firenze) |
| - subacquei (Voltri) con 5 nuclei (Nos) |
| - elicotteri (Pratica di mare) con 13 nuclei (Ne) |
| - investigazioni scientifiche (Roma) con 2 sottocentri |
| . centro sportivo carabinieri - banda dell'Arma |
-----------------------------------------------------------------
8. I 54 comandanti generali dell'Arma (1814-1997)
------------------------------------------------------------------
| Giuseppe Thaon di Revel 1814 | Giacomo Ponzio 1921-25 |
| Giorgio Des Geneys 1814-15 | Enrico Asinari 1925-35 |
| Carlo Lodi di Capriglio 1815-16 | Riccardo Moizo 1935-40 |
| G.B. d'Oncieu dela Batie 1816-19 | Remo Gambelli 1940-43 |
| Alessandro Saluzzo di M. 1819-20 | Azolino Hazon 1943 |
| Giovanni M. Cavasanti 1820-22 | Angelo Cerica 1943 |
| G.B. d'Oncieu dela Batie 1822-30 | Giuseppe Pièche 1943-44 |
| Giovanni M. Cavasanti 1830-31 | Taddeo Orlando 1944-45 |
| Luigi M. Richieri di M. 1831-35 | Brunetto Brunetti 1945-47 |
| Mich. Taffini d'Acceglio 1835-47 | Fedele De Giorgis 1947-50 |
| Fabrizio Lazari 1848 | Alberto Mannerini 1950-54 |
| Federico Lovera di Maria 1849-67 | Luigi Morosini 1954-58 |
| Antonio Massidda 1867-69 | Luigi Lombardi 1958-61 |
| Luigi Incisa di Beccaria 1869-77 | Renato De Francesco 1961-62 |
| Ignazio Genova di Pettin 1877 | Giovanni de Lorenzo 1962-66 |
| Leonardo Roissard de B. 1878-91 | Carlo Ciglieri 1966-68 |
| Luigi Taffini d'Acceglio 1891-96 | Luigi Forlenza 1968-71 |
| Francesco Carenzi 1896-97 | Corrado San Giorgio 1971-73 |
| Bruto Bruti 1897-00 | Enrico Mino 1973-77 |
| Felice Sismondo 1900-04 | Pietro Corsini 1977-80 |
| Federigo Pizzuti 1904-05 | Umberto Cappuzzo 1980-81 |
| Giuseppe Bellati 1905-08 | Lorenzo Valditara 1981-84 |
| Paolo Spingardi 1908-09 | Riccardo Bisogniero 1984-86 |
| Giuseppe Del Rosso 1909-14 | Roberto Jucci 1986-89 |
| Gaetano Zoppi 1914-18 | Antonio Viesti 1989-93 |
| Luigi Cauvin 1918-19 | Luigi Federici 1993-96 |
| Carlo Petitti di Roreto 1919-21 | Sergio Siracusa 1997- |
------------------------------------------------------------------
Bibliografia
A., J., La verità intorno agli uomini e alle cose del regno d'Italia. Rivelazioni per J. A., antico
agente segreto del conte di Cavour, traduzione dal francese dell'"Osservatore romano", Roma, s.
d.
Ancarani, U., La Gendarmeria cretese organizzata dai RR. Carabinieri Italiani, Atene, Tip. P.
D., 1903.
Artieri, G., I Carabinieri, Roma, Edizioni d'Arti, 1964.
Barengo, U., I Carabinieri Reali nell'Esercito e nel Paese, in Un secolo di progresso scientifico
italiano 1839-1939, III (scienze militari), Roma, Società italiana per il progresso delle scienze,
1939.
Bau, A., Alla fronte col Reggimento CC.RR. e Con i carabinieri nelle retrovie, Udine, Stab.
Tipografico Friulano, 1916.
Bertocci, Indagine sull'arma dei carabinieri, in "Il Ponte", 1960, n. 7, pp. 1060 ss.
Besson, gén. e P. Rosière, Gendarmerie nationale, Paris, Editions Xavier Richer, 1982.
Boatti, G., L'arma. I carabinieri da De Lorenzo a Mino 1962-1977, Milano, Feltrinelli, 1978.
Boi, E. e R. Romano, Storia del Corpo della guardia di finanza, (Bergamo), Centro stampa
dell'Accademia della Guardia di finanza, 1988.
Brunero, R., L'Arma dei Carabinieri in Africa (Memorie storiche), Antignano, 1960.
Butticé, A., Forze dell'ordine e comunicazione, Roma, Bariletti, 1990.
Calanca, A., Storia dell'Arma dei Carabinieri, Foggia, ed. Bastogi di Angelo Manuali, 1983,
1985 e 1988.
Caniggia, A., Salvo D'Acquisto. Poema italico, Roma, tip. L. Morara, 1970.
Canosa, R., La polizia in Italia dal 1945 ad oggi, Bologna, Il Mulino, 1975.
Capecelatro, G. D., Una fucina d'eroi. L'Arma dei carabinieri, Napoli, Gallina, 1978.
Carabinieri, Roma, a cura dell'Istituto del nastro azzurro, Roma, ed. Istituto storico divulgativo,
1956 e 1974.
Castaldi, M. V., L'Arma dei Carabinieri, Milano, Arti grafiche milanesi 1961.
Comune di Milano (cur.), Il Carabiniere nell'Arte, Milano, ed. Ente manifestazioni milanesi,
1959.
Davis, J. A., The Army and Public Order in Italian Cities after Unification, in Antonelli, G.
(cur.), Esercito e città dall'Unità agli anni Trenta, Atti del convegno nazionale di studi, Spoleto,
11-14 maggio 1988, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia - Spoleto, Arti grafiche
Panetto & Petrelli, 1989, pp. 483-498.
Denicotti, R., Delle vicende dell'Arma dei Carabinieri reali in un secolo dalla fondazione del
Corpo (13 luglio), Roma, Tip. dell'Unione Editrice, 1914.
Di Terlizzi, P., Quando frammenti di storia si ricompongono. Alle origini culturali e formative
dell'Arma dei Carabinieri, Bari, Levante Editori, 1991.
Donati, L., La Guardia regia, in "Storia contemporanea", 1977, n. 3, pp. 441-487.
D'Orsi, A., La polizia. Le forze dell'ordine italiano, Milano, Feltrinelli, 1972.
Dunnage, J., Le forze di polizia a Bologna di fronte al fascismo 1920-22, in "Italia
contemporanea", n. 186, marzo 1992, pp. 63-89.
Ferrante, E., I carabinieri e l'ordine pubblico a Creta nel 1897-98, in "Rassegna dell'arma dei
carabinieri", 1984, n. 1, pp. 97-103.
Ferrari, G., La Polizia Militare. Profili storici, giuridici e d'impiego, Roma, "Rassegna dell'Arma
dei Carabinieri", supplemento al n. 2, 1993.
Ferreri, U., Carabinieri, Tortino, Soc. Superga, 1953.
Fiorentino, F., Ordine pubblico nell'Italia giolittiana, Roma, Carecas, 1978.
Fucci, F., Le polizie di Mussolini, Milano, Mursia, 1985.
Gallucci, C., Arma segreta. Dietro la crisi dei carabinieri, in "L'Espresso", 12 e 19 febbraio
1989, pp. 6-11 e 23-25.
Galluzzo, L., Meglio morto. Storia di Salvatore Giuliano, Palermo, S. F. Flaccovio, 1985.
Gandini, T., I Carabinieri Reali nel Mediterraneo Orientale e particolarmente nelle Isole Italiane
dell'Egeo, Roma, Tip. Agostiniana, 1934.
Girlando, R., PAI: Polizia Africa Italiana, Campobasso, Italia Editrice, 1996.
Grisi, F., Storia dell'Arma dei Carabinieri, Casale Monferrato, Piemme, 1996.
I Carabinieri nella Resistenza e nella Guerra di liberazione, Roma, Ente Editoriale per l'Arma
dei Carabinieri, 1978.
I Carabinieri 1814-1980, Roma, Ente Editoriale per l'Arma dei Carabinieri, 1980.
Ilari, V., Il generale col monocolo. Giovanni de Lorenzo (1907-73), Ancona, Nuove ricerche,
1995.
Magnani, E. (cur.), Oltremare. Le missioni dell'esercito italiano all'estero, Roma, Stato maggiore
esercito (Laterza), 1992.
Magri, U., I carabinieri dopo la tempesta, in "L'Espresso", 18 dicembre 1991, pp. 36-44.
Maiocchi, G., (cur.), Carabinieri. Due secoli di storia, Comando generale dell'Arma, Milano,
Compagnia Generale Editoriale, 1980-81.
Manassero, G., Oltre un secolo di storia dell'Arma dei carabinieri reali, 1814-1927, Milano,
Bonfiglio, 1929.
Marinelli, M., ,ote sull'evoluzione della struttura della polizia italiana, in "Studi bresciani",
1983, n. 10-11, pp. 169-185.
Masi, R., L'Arma dei carabinieri in Cirenaica, Bengasi, Soc. arti grafiche, 1929.
Materiali per un lessico politico europeo: "polizia", in "Filosofia Politica", 1988, n. 1, pp. 7-147.
Meta, A., I carabinieri nella letteratura italiana, Bologna, Cappelli, 1922.
Miozzi, G., I carabinieri nella repressione del brigantaggio 1860-1870, Firenze, ed. Aldo
Funghi, 1923.
Morreni, A., Culqualber, Roma, 1954.
Murat, M., Il Carabiniere. Storia del Corpo, Piacenza, ed. Apuane, 1935.
Museo nazionale di Castel S. Angelo (cur.), Il carabiniere nell'arte, Milano, ed. Amilcare Pizzi,
1961.
Nese, M. e Serio, E., Il generale Dalla Chiesa, Roma, Adnkronos, 1982.
Oliva, G., Storia dei Carabinieri. Immagine e autorappresentazione dell'Arma, Milano, Rizzoli,
1992.
Pagano, M. ed E. D'Alessandro, L'Arma dei carabinieri dalla fondazione ai nostri giorni, Roma,
Scuola di applicazione dei Carabinieri, 1972.
Paloscia, A., I segreti del Viminale. La prima storia dell'ordine pubblico nel nostro paese dal
1860 ad oggi, Roma, Newton Compton, 1989.
Paloscia, A., Polizia. Oltre la riforma, Roma, Editalia, 1992.
Pappalardo, A., La vera storia dei carabinieri, Roma, Il Pediatra Editore, 1992.
Pepe, G., Il disagio dei carabinieri, in "La Repubblica", 11, 15 e 20 febbraio 1992.
Pizzinelli, C., Scelba, Milano, Longanesi, 1982.
Quilichini, S., Polizia 1852-1952, Parma, E. Albertelli, 1995.
Riege, P., Die Polizei aller Laender in Wort und Bild, Dresden, Metro verlag, 1928.
Sannio, A., Le forze di polizia nel secondo dopoguerra 1945-50, in "Storia contemporanea",
1985, n. 3, pp. 427-485.
Sapegno, Pasquale e Marco Ventura, Generale. Carlo Alberto dalla Chiesa, un caso aperto,
Arezzo, Limina, 1997.
Saurel, L., Peines et gloires des gendarmes, Paris-Limoges, Lavauzelle, 1980.
Scandone, G. e P. Atzori, Le Polizie d'Europa, Roma, Laurus Robuffo, 2a ed., 1991
Soldati, M., I racconti del maresciallo, Milano, Mondadori, 1967.
Verri, P., La polizia militare attraverso i tempi, Roma, Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, 1975.
Violante, L., Apologia dell'ordine pubblico, in "Micromega", n. 4, 1995, pp. 124-140.
Viviani, A., I servizi segreti italiani 1815/1985, Roma, Adnkronos, 1985.