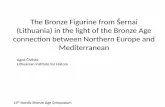Figurine fittili Benzi
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Figurine fittili Benzi
Φιλική Συναυλία Studies in Mediterranean
Archaeology for Mario Benzi
BAR International Series 24602013
Edited by
Giampaolo GraziadioRiccardo Guglielmino
Valeria LenuzzaSalvatore Vitale
Published by
ArchaeopressPublishers of British Archaeological ReportsGordon House276 Banbury RoadOxford OX2 [email protected]
BAR 2460
Φιλική Συναυλία: Studies in Mediterranean Archaeology for Mario Benzi
© Archaeopress and the individual authors 2013
ISBN 978 1 4073 1068 8
Articles written in English by non-native speakers were edited for language by Teresa Hancock Vitale
Printed in England by Information Press, Oxford
All BAR titles are available from:
Hadrian Books Ltd122 Banbury RoadOxfordOX2 7BPEnglandwww.hadrianbooks.co.uk
The current BAR catalogue with details of all titles in print, prices and means of payment is available free from Hadrian Books or may be downloaded from www.archaeopress.com
239
FIGURINE FITTILI ANTROPOMORFE NEL BRONZO FINALE ITALIANO
PAOLA CÀSSOLA GUIDA
ABSTRACT anThropoMorphIC Clay fIgurInes In The ITalIan fInal bronze age. The anthropomorphic clay figurines dating to the end of the Italian Bronze Age are here gathered and reexamined. About thirty in number, most of them were found at Frattesina in the Po Delta. For the most part devoid of any detailed information as to the circumstances surrounding their discovery, they nevertheless pertain to settlement areas and seem to be the expression of domestic cults. Although in general seriously battered, the statuettes may tentatively be placed in groups on the basis of iconography: their remarkable variety suggests multifarious connections, especially with the Aegean, Cyprus, and the coasts of the eastern Mediterranean, and they may be added to the already considerable evidence of the intense circulation of people, ideas and goods that is a distinctive feature of the middle phase of the Final Bronze Age.
KEYWORDS Italian Protohistory, anthropomorphic clay figurines, Final Bronze Age, Frattesina, international relationships
Nell’ambito dell’Età del Bronzo italiana – che, com’è noto, è assai parca di rappresentazioni figurative – quello delle statuette fittili a figura umana potrebbe essere posto tra gli argomenti ‘minori’, da relegarsi fra le tante questioni ancora irrisolte di questo periodo. Oggi, peraltro, alcuni ritrovamenti recenti, la riproposizione di vecchi esemplari e, soprattutto, la perdurante stagione di interesse scientifico verso la tarda Età del Bronzo, e in particolare il Bronzo Finale (BF),1 hanno concorso a rilanciare lo studio e promuovere l’approfondimento di una piccola serie di immagini, a integrazione di tanti temi ancora in discussione quali la cronologia, lo straordinario incrocio di influenze, la molteplicità degli scambi, gli aspetti dell’organizzazione socio-politica e, segnatamente, le concezioni religiose e le pratiche del culto.
La monumentale opera sulla piccola plastica fittile antropomorfa dell’Italia continentale dalla fine dell’Età del Bronzo all’Orientalizzante edita nel 2008 da Andrea Babbi ci ha offerto un’utile serie di schede relative a poco meno di una ventina di figurine per lo più riconducibili al BF,2 corredate di tutti i dati possibili e integrate da confronti ad amplissimo raggio (Babbi 2008: 30-40, 43-52, 78-87, 100-107 e passim, schede 1-10, 13-20). La serie si è considerevolmente accresciuta in seguito alla pubblicazione di un articolo di Cecilia Colonna (datato 2007 ma diffuso nel 2008), che ha illustrato una decina di esemplari trovati negli ultimi anni a Frattesina in Polesine (Colonna 2007).
Dati i dubbi che persistono su origine, datazione e valore storico dei reperti e la carenza di precisi contesti di rinvenimento, non è forse superfluo oggi riunire tutte le statuette finora venute in luce, per esplorare la possibilità di distinguervi dei filoni riconducibili a tradizioni culturali diverse e proporre qualche elemento di discussione.
1 Il fervore di studi sul BF, iniziato più di trent’anni fa, quando venne dedicata a questo periodo una seduta dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (Il Bronzo Finale in Italia 1977), non sembra mai venuto meno: vedi da ultimo lo stimolante quadro delineato recentemente da A.M. Bietti Sestieri (Bietti Sestieri 2008).2 Prima di questa pubblicazione l’argomento aveva suscitato uno sporadico interesse: vedi ad esempio Damiani 1992: 91; Bettelli 1997: 721; Zanini 1999: 317-318.
L’unico complesso cospicuo, ma tutt’altro che omogeneo tipologicamente e stilisticamente, è oggi quello di Frattesina: nell’ambito della protostoria italiana questo insediamento si conferma eccezionale anche per la quantità di figurine antropomorfe provenienti dall’area del villaggio – da poche unità siamo giunti oltre la quindicina –, purtroppo mai legate ad un contesto.3 Alcune delle figurine sono di un impasto giallognolo o grigio-beige molto depurato che è stato considerato estraneo al contesto locale (Bellintani 1992: 255, tipo 37b, tav. 16.15); altre sono modellate nell’argilla compatta, farinosa e priva d’inclusi, che nella classificazione del Bellintani è indicata come impasto B ed è comune ad altre classi di manufatti come piccoli quadrupedi stilizzati e palline di argilla (Bellintani 1992: 246, cf., ad esempio, i tipi 33, 34a, 36a) affiorati a più riprese nel corso delle varie ricerche di superficie insieme a ruote di carretti, vasetti miniaturizzati e altri oggetti con funzione cultuale come un ‘vaso presentatoio a carro zoomorfo’, un bacino rettangolare posto sulla groppa di un cavallino stilizzato.4
Prendendo le mosse dalla serie di Frattesina, che comprende esemplari talora molto diversi l’uno dall’altro anche per le misure, e semplificando un po’ la classificazione in cinque tipi della Colonna (Colonna 2007: 33), propongo una distinzione in tre gruppi, basata su differenze iconografiche e dimensionali. Va premesso che le condizioni spesso assai frammentarie e lacunose limitano la possibilità di ricostruire gli aspetti formali
3 Le figurine descritte dalla Colonna (Colonna 2007, fig. 3) si sono aggiunte al piccolo numero di esemplari già precedentemente noti, per i quali si veda Antico Polesine 1986: 119, tav. 1, nn. 4-5; Bellintani 1992: 255, tav. 16.14, tipo 37a (allo stesso tipo viene ipoteticamente riferito il frammento di arto inferiore di tav. 16.16), e n. 15, tipo 37b; Babbi 2008: 33-36, schede 4-7.4 Bellintani 1992: 255, tipi 36a, 35a, 39, 33a e b: figurine di animali, piccole ruote, vasetti miniaturizzati, palline fittili lisce o decorate; Antico Polesine 1986: 119, tav. 2, nn. 2-3: figurine di animali (il n. 3 ha sulle zampe fori passanti in cui probabilmente si inserivano delle asticelle che erano parte della base dell’oggetto); tav. 1, n. 1: vaso presentatoio (il cavallino stilizzato presenta anch’esso fori passanti all’estremità degli arti). Cf. ora anche Il villaggio di Frattesina 2010: 58. Sulla diffusione di questi elementi simbolici e sulla loro importanza nel processo di formazione delle culture regionali tra BF e iniziale Età del Ferro, vedi Zanini 1999: 314-320, fig. 4; Zanini 2004; Bietti Sestieri 2008: 11 e seguenti.
240
Paola Cassola Guida
delle figurine e ne rendono talora difficile l’attribuzione all’una o all’altra serie. Ad un primo gruppo possiamo assegnare alcune statuette di sagoma cruciforme [Figura 1.1-5: per i nn. 2-5, vedi Colonna 2007: 33, nn. 7, 9-11], alte in media circa 4-4,5cm e fino ad un massimo di ca. 6cm, molto stilizzate e asessuate, con testa e braccia a contorno triangolare su un corpo breve privo di notazioni anatomiche e con arti inferiori non distinti; la base, quasi sempre frammentata, poteva essere piana o leggermente incavata, come nell’esemplare d’impasto depurato giallo illustrato dal Bellintani (Bellintani 1992: 255, tipo 37b, tav. 16.15): la figurina, alta 4,3cm, presenta due fori
passanti che lo studioso con qualche titubanza interpreta come occhi [Figura 1.1].5
Da questa serie si distinguono nettamente alcune statuette meno schematiche e di dimensioni maggiori che possiamo annoverare in un secondo gruppo. In un caso [Figura 2.4] una gamba, unica parte conservata, suggerisce un’altezza originaria di ben 16-17cm (cf. Babbi 2008: 35-36, scheda 7, tav. 2B). Mentre la testa continua ad essere allungata e stilizzata, le braccia sono abbassate e articolate, talora in
5 Per le descrizioni dettagliate di tutte le figure citate rimando alle pubblicazioni citate e in particolare alle esaurienti schede di Babbi.
241
Figurine Fittili antropomorFe nel Bronzo Finale italiano
modo abbastanza naturalistico, e le spalle arrotondate; gli arti inferiori, ben modellati, sono separati o distinti da un solco [Figura 2.1-3 e 2.6] (Colonna 2007: 31-32, nn. 1, 4-6). Qualche dettaglio anatomico – seno appena rigonfio o con pastiglie di argilla applicate – a mio parere permette in vari casi l’attribuzione al genere femminile, sia pure non senza qualche dubbio, dato lo stato di conservazione assai mediocre delle figure. Di una delle più grandi [Figura 2.5, h conservata 7,5cm] (cf. Antico Polesine 1986: 119, tav. 1.4; Babbi 2008: 34-35, scheda 5, tav. 3B, fig. 2C), di impasto fine, resta la parte superiore del corpo, con la testa allungata forse a profilo ornitomorfo e il braccio
destro arcuato, la mano poggiata sul fianco; la statuetta ha il braccio sinistro spezzato all’attacco della spalla e sotto i seni, indicati da pastiglie d’argilla, presenta un foro non passante (ombelico?). Per la posizione delle braccia possiamo classificare nella stessa serie una minuscola figurina d’impasto semifine, priva del capo, con arti brevissimi e informi, seni rilevati e foro passante al di sotto [Figura 2.7, h conservata 3,2cm] (Antico Polesine 1986: 119, tav. 1.5; Babbi 2008: 33-34, scheda 4, tav. 2C, fig. 2A), e un frammento di torso con testa a becco [Figura 2.6, h conservata 4,1cm] (Colonna 2007: 32-33, n. 6). Altre due statuette, acefale, con braccia aperte a sagoma
242
Paola Cassola Guida
triangolare ma con gambe ben tornite e seni e ombelico rigonfi come nel gruppo 2 sembrano il risultato di una fusione tra gli schemi delle prime due serie [Figura 3.1-2, h. conservata 5,5cm e 4,4cm] (Colonna 2007: 31, nn. 2-3): possiamo pertanto considerarle delle varianti del gruppo 2.
Un terzo raggruppamento, definibile di tipo ‘schematico-grossolano’, è rappresentato a Frattesina da un unico esemplare, integro, alto 8,9cm, che ad un impasto fine
coniuga un modellato estremamente dozzinale [Figura 5.1] (Bellintani 1992: 255, tipo 37a, tav. 16.14; Babbi 2008: 35, scheda 6, tav. 3A, fig. 2B).
Sulla base dell’impostazione generale e di alcuni dettagli si può tentare di distribuire fra queste tre serie le altre immagini di diversa provenienza. Al primo gruppo va ascritta una figurina dall’abitato di Montebello Vicentino, purtroppo priva di dati [Figura 1.6] (Ruta Serafini 1984:
243
Figurine Fittili antropomorFe nel Bronzo Finale italiano
767 in basso, senza scala: ‘figuretta femminile in impasto, probabilmente un idoletto’). Di due esemplari d’impasto semifine rinvenuti presso la costa molisana, in località Arcora di Campomarino (Campobasso), uno, integro, alto appena 4cm, con braccia aperte e brevissimi arti inferiori, è contraddistinto da una resa stilizzata che induce ad inserirlo nella stessa serie [Figura 1.7]: la figura si trovava in una capanna absidata presso un’area a fuoco da cui provenivano un vasetto miniaturistico con foro sul fondo e un piccolo quadrupede (Babbi 2008: 43-44, scheda 13, tav. 5B, fig. 4B, con la bibl. prec.). I medesimi caratteri si riscontrano in due statuette con brevi arti inferiori distinti, rinvenute sul versante francese delle Alpi, a Grésine sul lago di Bourget [Figura 1.8-9].6 Del tutto estranee all’ambito locale, queste figurine potrebbero essere giunte nella zona grazie ai contatti di Frattesina con l’entroterra, ben documentati fino all’arco alpino occidentale.
Il gruppo 2, caratterizzato da minore stilizzazione, appare limitato a Frattesina e al contiguo ambito euganeo. Vi si può ascrivere una piccola immagine frammentaria trovata nel primo ’900 a Lozzo Atestino presso Este [Figura 2.8] (Babbi 2008: 32-33, scheda 3, tav. 2A, con bibl.), in un contesto di abitato che conteneva anche una o forse due figurine di quadrupede. Un bizzarro esemplare da Montagnana-Borgo S. Zeno, d’impasto semidepurato, con braccia aperte, seni e ombelico rigonfi, attributi maschili, terminante con una base piana [Figura 3.3], sembra il corrispettivo maschile (o androgino) dei due di Frattesina classificati come varianti del gruppo 2 (Bianchin Citton 1998: 335, fig. 199.2; Babbi 2008: 31-32, scheda 2, tav. 1B, fig. 1B). Anche quest’esemplare proviene da un’area abitativa ricca di vasetti miniaturistici, palline e ruote fittili.7
Quanto al terzo gruppo [Figura 5.1-9], vi rientrano varie figure per lo più maschili, alte da 7 a 11cm circa, caratterizzate, come si è detto, da un modellato talmente rozzo e semplificato – con arti brevi brevissimi, teste informi e rari dettagli incisi o a rilievo – da suscitare l’effetto di bozzetti non rifiniti. Una figurina di incerta datazione (Bronzo Recente-Finale), da Villa Cassarini a Bologna, alta 8cm, d’impasto semifine, sembra fosse
6 Chevillot e Gomez 1979: 442, fig. 6.5; Bocquet e Lebascle 1983: 98, fig. 23A5 (il confronto con bronzetti schematici del ‘tipo Marzabotto’ proposto da queste due studiose è del tutto spiegabile, dato che ai tempi della pubblicazione mancavano termini di confronto); Montjardin e Roger 1993: 100-101, fig. 12.5; Babbi 2008, fig. 92L. Dalle rive del lago di Bourget provengono anche alcuni animali fittili e, ancora da Grésine, due statuette antropomorfe del tipo ‘schematico-grossolano’, affini a quelle del nostro gruppo 3, di tipologia non ignota in altre regioni della Francia tra BF e prima Età del Ferro: cf. Chevillot e Gomez 1979: 438 e 441, fig. 6.1-2; Zanini 2004: 212; Babbi 2008: 106, fig. 92I.7 Mi sembra da scartare un secondo esemplare da Montagnana, fornito di gonnellino a pieghe, per il quale E. Bianchin rileva strette analogie con una statuetta atestina di VI sec. a.C. (Bianchin Citton 1998: 335, fig. 199.1; Babbi 2008: 30-31, scheda 1, tav. 1A, fig. 1A; Càssola Guida 2009: 184). Per la difficoltà di definirne l’iconografia sulla base dell’unica immagine pubblicata di cui sono a conoscenza, escludo dalla trattazione anche una figurina molto mutila rinvenuta a Treviso, in una zona d’abitato dalla quale provengono quadrupedi, ruote di carretti, una pallina di terracotta e vasetti miniaturizzati (Bianchin Citton 2004: 47, fig. 1).
connessa con un’area abitata: l’esemplare ha braccia aperte e mani disposte di taglio, con dita grossolanamente incise, e una sorta di treccia o coda di capelli rilevata sul dorso [Figura 5.2] (Babbi 2008: 37-38, scheda 9, tav. 4C, fig. 3C, con bibliografia). Non molto diversa per dimensioni (h conservata 8cm), schema compositivo e resa sommaria è una figurina maschile (umana o animale?) anch’essa d’impasto semifine, trovata all’esterno della cosiddetta ‘casa-laboratorio’ di Scarceta di Manciano (Grosseto) [Figura 5.3]: anche in questo caso da livelli contigui rimaneggiati sono emerse due figure di quadrupedi e una ruota fittile (Poggiani Keller 1999: 106-108, figg. 88, 11 e 91-92; Babbi 2008: 38-40, scheda 10, tav. 4B, fig. 3B). Allo stesso gruppo sembra attribuibile la seconda statuetta da Arcora di Campomarino [Figura 5.4]: simile alla prima nell’impostazione [Figura 1.7], ma più grossolana e di dimensioni maggiori (h 6,8cm), fu rinvenuta in prossimità di una figurina fittile di suino e di altri manufatti di carattere cultuale (Babbi 2008: 44-45, scheda 14, tav. 5A, figg. 4A, 5 e 6, con bibl.).
Altre immagini non meno rozze provengono da siti della costa pugliese. Una, trovata all’inizio del ’900 dal Quagliati nell’abitato di Coppa Nevigata sul Gargano, h. 11,2cm [Figura 5.5] (Babbi 2008: 45-46, scheda 15, tav. 6, fig. 7, con bibliografia), è fabbricata con un impasto definito ‘a tessitura molto fine’ ed appare assai vicina anche per il modellato alla figurina di Scarceta. Due esemplari da Rocavecchia (Melendugno, Lecce), alti 8,8 e 9,8cm, di identico schema iconografico ed entrambi presumibilmente maschili [Figura 5.6-7] (Babbi 2008: 49-52, schede 19 e 20, tavv. 8 e 9, fig. 10A-C, con bibliografia), sono tozzi e semplificati come gli altri del gruppo ma presentano superfici ingubbiate e lisciate; insieme ad una figurina di quadrupede, sono stati rinvenuti in un contesto ricco di tracce di attività cultuali. Chiudono la serie due presunti ‘idoletti’ antropomorfi, di sesso maschile [Figura 5.8-9] (De Siena 1986: 47, figg. 22-23; Babbi 2008: 46-49, schede 16-17, tav. 7A-B, fig. 8A e D, con ulteriore bibliografia), dall’abitato di Termitito (Montalbano Ionico, Matera), anch’essi a quanto pare associati ad un quadrupede: uno, di impasto grossolano, è privo di testa e frammentato all’attacco delle gambe (h conservata 8cm), l’altro, d’impasto semifine, è ridotto ad un frammento di bacino con l’attacco delle gambe. In entrambi i casi gli arti inferiori leggermente divaricati e flessi in avanti fanno pensare a figure sedute, forse su uno sgabello o trono oppure su un carretto cerimoniale. Per le due figure, che sono prive di un contesto ben definito, è stato proposto con molte riserve un inquadramento nell’ambito del BF (De Siena 1986: 47, figg. 22-23).
Riepilogando, delle figurine fittili antropomorfe del BF italiano va innanzi tutto ribadita l’appartenenza a complessi insediativi, con rare, apparenti, eccezioni dovute alla mancanza di informazioni precise.8 Quando sono
8 Date le incertezze su luogo e circostanze del rinvenimento e l’indeterminatezza della cronologia preferisco escludere da questa disamina una figurina schematica, molto mutila, recuperata a Scoglio del
245
Figurine Fittili antropomorFe nel Bronzo Finale italiano
dotate di notizie sul rinvenimento, le statuette risultano associate o almeno trovate in contiguità con altri manufatti propri di piccoli depositi votivi; in un caso (Rocavecchia) provengono da un contesto esplicitamente cultuale. I caratteri sessuali talora accentuati, maschili o femminili, dei gruppi 2 e 3 alludono con verosimiglianza a riti di fecondità (cf. Chevillot e Gomez 1979: 442; Montjardin e Roger 1993: 101).
I tre gruppi qui proposti sembrano derivare da diverse tradizioni. La serie popolaresca del gruppo 3 con le sue manifestazioni grossolane – di gran lunga, e significativamente, la meno rappresentata a Frattesina – appare radicata nella preistoria del nostro continente: figurine simili per stile e dimensioni sono diffuse in Italia e in Europa in tutte le fasi dell’Età del Bronzo. Tra le più arcaiche, una, alta circa 10cm, è stata rinvenuta a Nola, in località Croce del Papa, in una capanna del Bronzo Antico (cf., da ultimo, Babbi 2008: 22, fig. 82A, con bibliografia): alcuni dettagli quali le mani aperte, disposte di taglio, con le dita rese ad incisione, e una sorta di lunga treccia ricadente sul dorso permettono di accostarvi l’esemplare di Bologna-Villa Cassarini [Figura 5.2]. Altre figurine fittili antropomorfe e zoomorfe, di varia tipologia, sono documentate in contesti abitativi dall’Europa centrale al bacino danubiano-carpatico e alla penisola balcanica fino alla Grecia (Primas 2008: 177-179; Babbi 2008: 22-27 e passim, con bibliografia).
Quanto alle figure delle prime due serie, d’impasto depurato o semifine, le loro caratteristiche iconografiche non sembrano aver radici profonde nella preistoria italiana. Le statuette molto stilizzate ma né rozze né primitive del gruppo 1 sono peculiari di Frattesina, donde si può presumere che abbiano tratto origine anche i rari esemplari trovati in altri siti. Per esse si può forse additare un termine di confronto vicino, nel tempo e nello spazio, in una piccola figura schematica d’impasto semifine con seni a pastiglia (h conservata 3,7cm), dal Villaggio Grande di S. Rosa di Fodico di Poviglio, che sembra ispirata ad una figurina micenea a ‘Psi’ [Figura 4.1] (cf. Babbi 2008: 25, fig. 83D). Anche per il gruppo 2, ugualmente circoscritto a Frattesina e zone limitrofe, si nota qualche assonanza con figurine stanti o sedute di ambito terramaricolo, caratterizzate da arti inferiori modellati con cura [Figura 4.2-3] (S. Rosa: Babbi 2008: 24, fig. 83E; Oratorio di Fraore, Babbi 2008: 24, fig. 83A). Qui, in livelli del BR, si riscontra la presenza di cavallini e altri quadrupedi fittili,9 ruote e vasetti miniaturistici, indizi del diffondersi – con intensità particolare nel sito di S. Rosa, vivace e aperto
Tonno insieme con due esemplari dipinti di tipo miceneo (Babbi 2008: 49, scheda 18, tav. 7D, fig. 9B, con la bibliografia precedente), e una da Montindon, una collina isolata presso S. Giorgio di Valpolicella (Verona), allo sbocco della Val d’Adige in pianura, dove furono individuate tracce di un abitato del Bronzo Recente (Brugnoli e Salzani 1992: 27, fig. 2); quest’ultima figura, anch’essa molto schematica e di sesso maschile, è munita di una basetta allargata: Cecilia Colonna, citandolo per confronto con le immagini stilizzate di Frattesina, ne proponeva la pertinenza ad ‘una piccola struttura, forse un carrettino’ (Colonna 2007: 33 e 35).9 In queste figure Säflund notava l’uso di un impasto depurato che assume talora l’aspetto di vera e propria argilla figulina (Säflund 1939: 148).
alle novità – di una religiosità di tipo nuovo (Bettelli 1997: 724-725).
Com’era stato proposto (Càssola Guida 1999: 493) e come Babbi ha recentemente illustrato con ampiezza e con dovizia di citazioni (Babbi 2008), nella piccola plastica antropomorfa non dipinta del mondo egeo postpalaziale, soprattutto cretese, e di quello cipro-orientale si riscontrano le maggiori affinità: queste si riferiscono in particolare ai caratteri della stilizzazione del gruppo 1 e ad alcuni tratti riscontrati nel gruppo 2. Figurine schematiche alte talora solo pochi centimetri, con base piana o con brevissimi arti inferiori, teste appuntite e braccia a profilo triangolare, sono largamente diffuse da Creta a Cipro alla Siria (Rethemiotakis 2001; Courtois 1971; Karageorghis 1993; Badre 1980, ad esempio tav. XIX, 34: cf. Babbi 2008, fig. 91D): è lecito supporre che le corte braccia aperte triangolari, in apparenza simili a moncherini (la definizione – ‘moignons’ – è della Badre), siano l’estrema stilizzazione della ben nota, caratteristica, postura minoica delle ‘mani al petto’ con i gomiti sollevati lateralmente (Rethemiotakis 2001: 54, figg. 59 e 64). Frequentemente documentato è anche l’uso di indicare seno e ombelico con pastiglie applicate. Un altro elemento che si riscontra su vari esemplari italiani [Figure 3.3, 5.2-3, 5.5, 5.8-9] è la vistosa raffigurazione degli attributi maschili: la troviamo in molte figure di santuari di ambiente egeo periferico, della Creta tardominoica, in particolare a Poros, ad Haghia Triada (cf. Rethemiotakis 2001: 143; Babbi 2008, fig. 92 F), nella Grotta di Psychrò (Watrous 1996: 39 e 100, tav. 14c), e delle Cicladi, a Phylakopì (Shelton 2009: 127, tav. 20a).
La presenza, documentata già nel BR nell’ambiente delle terramare, di piccole immagini antropomorfe in vari gradi di stilizzazione, dotate di particolari caratteristiche che conferiscono loro una ben precisa individualità, potrebbe dunque essere annoverata tra i sintomi di cambiamento radicale dovuti alla vivace interazione col mondo egeo e cipro-orientale, che nell’ambito sociale come in quello ideologico e simbolico-religioso stava producendo effetti non meno determinanti di quelli che si colgono nel campo delle tecnologie e delle produzioni artigianali (cf. ad esempio Borgna 2003: 526). Alla vigilia del collasso che avrebbe modificato radicalmente la geografia politica del Mediterraneo, erano ormai consolidate le relazioni di scambio fra le terramare emiliane, i grandi abitati arginati dislocati nel territorio tra Adige e Po e l’ambito egeo-orientale, facilmente raggiungibile grazie al ‘corridoio adriatico’ da tempo attivo (Bietti Sestieri 2008: 10-11; Cazzella 2009). In questa rete di rapporti, tra BR e BF va ad inserirsi Frattesina, che, ereditando le funzioni dei centri terramaricoli, diventa il terminale tanto degli scambi interregionali, sulla costa come nell’interno, quanto delle relazioni a lunga distanza responsabili della distribuzione di oggetti di ‘carattere internazionale’ quali spade di bronzo tipo Allerona, fibule con arco a gomito e con ‘cappi ad otto’, teste di spillone a rotella e altri manufatti di osso o corno (Càssola Guida 1999: 490-491), prodotti tessili e attrezzi per la filatura e la tessitura
246
Paola Cassola Guida
(Borgna 2003: 525-531), ambre tipo Tirinto (recentissime ricerche della Soprintendenza Archeologica di Padova, condotte da Luciano Salzani, hanno portato in luce tracce di fabbricazione di vaghi d’ambra in Polesine nella tarda Età del Bronzo).
Nel pieno BF le funzioni economiche di Frattesina si moltiplicano: la nuova situazione determinatasi nel Mediterraneo e in particolare nel mondo egeo-orientale, con la libera circolazione di merci e persone propria dell’epoca postpalaziale, dà il via, com’è noto, ad una fase di grande produttività, largamente rivolta al soddisfacimento di esigenze esterne, ed esalta le capacità mercantili del ceto dominante nell’emporio alla foce del Po. Anche per quanto riguarda il tema delle statuette antropomorfe Frattesina si distingue da tutti gli altri siti di rinvenimento: il numero considerevole – una quindicina di reperti, ossia più della metà del totale – e la notevole varietà iconografica e stilistica ci forniscono una significativa conferma del ruolo di eccezionale rilevanza svolto da questo centro e dell’ipotesi che anche in questo caso potremmo trovarci di fronte ad indicatori di contatti transmarini, come per le ben note categorie di oggetti fabbricati con sostanze esotiche, quali avorio, guscio d’uovo di struzzo, pasta vitrea, o caratterizzati da particolari lavorazioni, estranee al contesto locale (figurazioni a rilievo su dolî, raffinati motivi su manufatti di materia dura animale, ecc.).
Per concludere, non sembra casuale il fatto che l’area di diffusione delle figurine antropomorfe descriva una sorta di ampio arco che congiunge l’Italia centrale tirrenica con il territorio padano-veneto e questo con la costa adriatica fino alla Puglia: un vastissimo ambito in cui perdurò nell’Età del Bronzo una circolazione assidua di beni, di idee e di credenze, che nel BF si intensificò in particolare lungo il versante adriatico-ionico, sia via terra, da regioni a regione, sia a distanza, via mare, da un capo all’altro della Penisola (Bietti Sestieri 2008; Cazzella 2009). Analogamente, non è un caso se molte delle località di rinvenimento di figurine fittili hanno prodotto frammenti di ceramica micenea o miceneizzante delle fasi più tarde: da Frattesina e Montagnana nel NE a Scarceta di Manciano in area mediotirrenica, a Coppa Nevigata, Rocavecchia, Termitito lungo la costa adriatico-ionica (Jones et al. 2002; Bettelli et al. 2006; Vagnetti 2010). Quanto ai rimanenti siti, vi sono pochi dubbi sul fatto che nel BF essi fossero immessi in una rete di rapporti economici e culturali che faceva capo a Frattesina. I numerosi collegamenti interni e la molteplicità delle relazioni a lunga distanza gestite con particolare intensità e regolarità dal centro polesano hanno ricevuto nel corso degli anni continue conferme e sono stati convalidati scientificamente dalle analisi condotte sui frammenti micenei o italo-micenei del TE III B e C rinvenuti non solo a Frattesina e a Montagnana, ma in numerose altre località della zona compresa tra l’Adige e il Po, e in numero rilevante soprattutto a Fondo Paviani presso Legnago (Jones et al. 2002; Salzani et al. 2006; Leonardi e Cupitò 2008 e 2009).10 Sull’origine dei vasi
10 Dopo le acquisizioni più recenti i frammenti di tipo egeo ammontano
cui i frammenti sono pertinenti è stato possibile formulare diverse ipotesi: dall’importazione dalla Grecia occidentale o dal Peloponneso alla produzione in ambito peninsulare italiano fino alla manifattura locale (Jones et al. 2002: 254-255).
Nel pieno BF erano dunque maturi i tempi per la svolta che vide l’affermarsi in Italia delle raffigurazioni antropomorfe, destinate ad occupare ben presto una posizione di primo piano nella documentazione archeologica. È plausibile che da alcune delle statuette del BF – verosimilmente da quelle del gruppo 3, di antica tradizione locale – siano derivate più tardi, in una fase iniziale dell’Età del Ferro, quelle funerarie del ben noto gruppo Roma-Colli Albani (su questo tema vedi da ultimo Babbi 2008 e 2010).
Non sarebbe stato possibile affrontare in questa sede un problema arduo qual è quello del significato delle figurine fittili a figura umana, considerate di volta in volta ex voto, amuleti o talvolta idoletti di culto. Una più approfondita analisi potrebbe in futuro permettere di rispondere affermativamente al quesito col quale R. Peroni nel suo manuale di protostoria italiana (Peroni 1996: 406) chiudeva il capitolo dedicato al BF: esistono, accanto alle protomi taurine e alle altre figurazioni di valore sacrale, ‘anche vere e proprie immagini di divinità antropomorfe’?
BIBlIogrAFIA
Antico Polesine 1986. L’antico Polesine. Testimonianze archeologiche e paleoambientali. Catalogo delle esposizioni di Adria e Rovigo, Febbraio-Novembre 1986, Rovigo.
Babbi, A. 2008. La piccola plastica fittile antropomorfa dell’Italia antica dal Bronzo Finale all’Orientalizzante (Mediterranea Supplemento 1), Pisa-Roma.
Babbi, A. c.s. ela, upne, kai pare to .... Clay Human Figurines from Early Iron Age Italian Children’s Tombs and the Aegean Evidence. In N. Stampolidis, A. Kanta e A. Giannikouri (a cura di), IMMORTALITY: the Earthly World, the Celestial World and the Underworld in the Mediterranean from Late Bronze Age to Early Iron Age, International Archaeological Conference, Rhodes.
Badre, L. 1980. Les figurines anthropomorphes en terre cuite à l’âge du bronze en Syrie, Paris.
Bellintani, P. 1992. Il materiale ceramico proveniente da Frattesina di Fratta Polesine. Padusa 28, 245-297.
Bettelli, M. 1997. Elementi di culto nelle terramare. In M. Bernabò Brea, A. Cardarelli e M. Cremaschi (a cura di), Le terramare. La più antica civiltà padana. Catalogo della Mostra, 720-725, Modena.
ormai ad alcune decine, di cui ben 23 provengono da Fondo Paviani (Leonardi e Cupitò 2009: 92, nota 3), il grande insediamento arginato situato poco a W di Frattesina la cui funzione va rivelandosi cruciale per il passaggio dal sistema territoriale delle terramare a quello che vede lo spostamento dell’asse economico verso le coste adriatiche.
247
Figurine Fittili antropomorFe nel Bronzo Finale italiano
Bettelli, M., Levi, S.T., Jones, R.E. e Vagnetti l. 2006. Le ceramiche micenee in area medio tirrenica: nuove prospettive. In Studi di Protostoria in onore di Renato Peroni, 399-406, Firenze.
Bianchin Citton, E. 1998. Montagnana tra Bronzo Finale e prima età del ferro. In E. Bianchin Citton, G. Gambacurta e A. Ruta Serafini (a cura di),‘presso l’Adige ridente’... Recenti rinvenimenti archeologici da Este a Montagnana, 233-433, Padova.
Bianchin Citton, E. (a cura di) 2004. Alle origini di Treviso. Dal villaggio all’abitato dei Veneti antichi, Treviso.
Bietti Sestieri, A.M. 2008. L’età del Bronzo finale nella penisola italiana. Padusa 44, 7-54.
Bocquet, A. e Lebascle, M.C. 1983. Metallurgia e relazioni culturali nell’età del Bronzo finale delle Alpi del Nord Francesi, Torino.
Borgna, e. 2003. Attrezzi per filare nella tarda età del Bronzo italiana: connessioni con l’Egeo e con Cipro. Rivista di scienze preistoriche 53, 519-548.
Il Bronzo Finale in Italia 1977. Atti della 21a Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze.
Brugnoli, P. e Salzani, L. (a cura di) 1992. S. Giorgio di Valpolicella. Scavi archeologici e sistemazioni museali, Verona.
Càssola Guida, P. 1999. Indizi di presenze egeo-orientali nell’alto Adriatico alla fine dell’Età del Bronzo. In V. La Rosa, D. Palermo e L. Vagnetti (a cura di), epì ponton plazòmenoi. Simposio italiano di Studi Egei dedicato a L. Bernabò Brea e G. Pugliese Carratelli, 487-497, Roma.
Càssola Guida, P. 2009. Recensione a Babbi 2008. Origini 30, 183-187.
Cazzella, A. 2009. Exchange Systems and Social Interaction during the Late Bronze Age in the Southern Adriatic. In E. Borgna e P. Càssola Guida (a cura di), Dall’Egeo all’Adriatico: organizzazioni sociali, modi di scambio e interazione in età postpalaziale (XII-XI sec. a.C.) / From the Aegean to the Adriatic: Social Organisations, Modes of Exchange and Interaction in Postpalatial Times (12th-11th BC). Atti del Convegno internazionale, 159-169, Roma.
Chevillot, C. e Gomez, J. 1979. Roues de char et statuettes en terre cuite de Chalucet (Saint-Jean-Ligoure, Haute-Vienne). Leur signification culturelle. Bulletin de la Société Préhistorique Française 76, 435-444.
Colonna, C. 2007. Fratta Polesine. Le figurine antropomorfe di Frattesina. Quaderni di Archeologia del Veneto 23, 31-35.
Courtois, J.-C. 1971. Le sanctuaire du dieu au lingot d’Enkomi-Alasia (Alasia 4), Paris.
Damiani, I. 1992. Elementi figurativi nell’artigianato della tarda età del bronzo. In L’arte italiana dal Paleolitico superiore all’età del bronzo. Atti della 28a Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 81-94, Firenze.
De Siena, A. 1986. Termitito. In M. Marazzi, S. Tusa e L. Vagnetti (a cura di), Traffici micenei nel Mediterraneo. Problemi storici
e documentazione archeologica. Atti del Convegno di Palermo (1984), 41-54, Taranto.
Il villaggio di Frattesina e le sue necropoli XII-X secolo a.C. 2011, Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine, Rovigo.
Jones, R.E., Vagnetti, L., Levi, S.T., Williams, J., Jenkins, D. e De Guio, A. 2002. Mycenaean Pottery from Northern Italy. Archaeological and Archaeometric Studies. Studi Micenei ed Egeo-Anatolici 44, 221-261.
Karageorghis, V. 1993. The Coroplastic Art of Ancient Cyprus II. Late Cypriote II - Cypro-Geometric III, Nicosia.
Leonardi, G. e Cupitò, M. 2008. Il sito arginato dell’età del bronzo di Fondo Paviani-Legnago. Notizia preliminare sulla campagna di indagine 2007. Quaderni di archeologia del Veneto 24, 90-93.
Leonardi, G. e Cupitò, M. 2009. Campagna di indagini 2008 nel sito arginato dell’età del bronzo di Fondo Paviani-Legnago (Verona). Notizia preliminare. Quaderni di archeologia del Veneto 25, 92-96.
Montjardin, R. e Roger, J.-M. 1993. Les figurations anthropomorphes, zoomorphes ou végétales du Néolithique ancien au Bronze Final dans le Midi méditerranéen. In Les représentations humaines du Néolithique à l’âge du fer, Actes du 15e congrès national des sociétés savantes sous la direction de J. Briard et A. Duval, 85-106, Paris.
Peroni, R. 1996. L’Italia alle soglie della storia, Bari.
Poggiani Keller, R. 1999. Scarceta di Manciano (GR). Un centro abitativo e artigianale dell’età del bronzo sulle rive del Fiora, Manciano (Grosseto).
Primas, M. 2008. Bronzezeit zwischen Elbe und Po. Strukturwandel in Zentraleuropa 2200-800 v. Chr., Bonn.
Rethemiotakis, G. 2001. Minoan Clay Figures and Figurines. From the Neopalatial to the Subminoan Period, Athens.
Ruta Serafini, A. 1984. Gli abitati su altura tra l’Adige e il Brenta. In L. Salzani (a cura di), Il Veneto nell’antichità, preistoria e protostoria, Età del ferro, 753-776, Verona.
Säflund, G. 1939. Le terramare delle province di Modena, Reggio, Parma e Piacenza, Lund.
Salzani, L., Vagnetti, L., Jones, R.E. e Levi, S.T. 2006. Nuovi ritrovamenti di ceramiche di tipo egeo dall’area veronese: Lovara, Bovolone e Terranegra. In Materie prime e scambi nella Preistoria italiana, Atti della 39a Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 1145-1157, Firenze.
Shelton, K.S. 2009. Gender Choices in Mycenaean terracotta figurines. In K. Kopaka (a cura di), ΦΥΛΟ. Engendering prehistoric ‘stratigraphies’ in the Aegaean and the Mediterranean. Proceedings of an International Conference, University of Crete (Aegaeum 30), 125-129, Liège-Austin.
Vagnetti, L. 2010. Western Mediterranean. In E.H. Cline (a cura di), Handbook of the Bronze Age Aegean (ca. 3000-1000 BC), 890-905.
248
Paola Cassola Guida
Watrous, L.V. 1996. The Cave Sanctuary of Zeus at Psychro. A study of extra-urban sanctuaries in Minoan and Early Iron Age Crete (Aegaeum 15), Liège.
Zanini, A. 1999. Rapporti fra Veneto e area medio-tirrenica nel Bronzo Finale. In Protostoria e storia del Venetorum angulus, Atti del 20o Convegno di Studi Etruschi ed Italici, 307-343, Pisa-Roma.
Zanini, A. 2004. Protomi vascolari e ceramica rituale. Elementi di identità culturale nella formazione delle comunità protostoriche medio-tirreniche.In N. Negroni Catacchio (a cura di), Miti Simboli Decorazioni. Ricerche e scavi, Preistoria e protostoria in Etruria, Sesto Incontro di Studi, vol. I, 209-220, Milano.