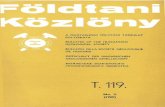F. Carinci - V. La Rosa, Revisioni Festie, Creta Antica 8, 2007, pp. 11-119
Transcript of F. Carinci - V. La Rosa, Revisioni Festie, Creta Antica 8, 2007, pp. 11-119
Creta Antica 8, 2007
REVISIONI FESTIE
Ricordiamo Lucia Guerrini,
riconoscendola serena, fra registri ed inventari
1. - Introduzione
La straordinaria quantità di materiali recuperati dal Levi nelle sue intensissime campa-gne di scavo a Festòs dal 1950 al 1966 (con due appendici nel 1969 e 1971), costituisceancora un complesso dalle potenzialità largamente inesplorate. Quasi soltanto i vasi interihanno trovato posto nella monumentale edizione dello scavo, limitata sostanzialmenteall’età dei Primi Palazzi 1, con larghi riferimenti ai periodi precedenti. Gli ineguagliabiliprodotti «dell’arte festia» sono stati classificati e proposti secondo il ben noto e originaleschema elaborato dal Maestro, schema che già sul nascere aveva suscitato qualche perples-sità, e non soltanto per il suo eccesso di ribassismo 2. Lo studio sistematico dei motivi deco-rativi della ceramica Kamares permetterà di entrare nel merito di quella classificazione 3.Resta invece il grande problema della lettura delle rovine e della loro articolazione cronolo-gica, elementi entrambi piegati dal Levi ad una stratigrafia ‘virtuale’4, frutto di un’erratainterpretazione delle vicende costruttive del quartiere sud-occidentale del Primo Palazzo 5.
Da un’esigenza di revisione di quella stratigrafia, e, in genere, dall’ineludibile neces-sità di una rilettura delle rovine festie, ha preso le mosse, a partire dal 2000 6, una serie di
1 LEVI 1976. Studio tipologico e sviluppo cronolo-gico delle forme: LEVI - CARINCI.
2 ZOIS 1965; PLATON 1968; in anni più recenti: F.CARINCI, The «III fase protopalaziale» at Phaestos.Some observations, in Aegaeum 3, 1989, pp. 73-80;L. GIRELLA, Towards a definition of the Middle Mi-noan III Ceramic Sequence in South-Central Crete:Returning to the Traditional MM IIIA and B divi-sion? in Middle Helladic Pottery and Synchronisms(Intern. Workshop, Salzburg 2004), F. FELTEN et al.edd., Wien 2007, pp. 233-255. Ringraziamo ildott. Girella per averci messo a parte delle sue con-clusioni.
3 In corso di preparazione da parte di F. Carinci. Vediintanto F. CARINCI, Sistemi decorativi nella ceramicaprotopalaziale di Festòs, in Studi in memoria di L. Guer-rini, a cura di M.G. PICOZZI e F. CARINCI (Studi Miscellanei30, 1991-92), Roma 1996, pp. 23-37.
4 Per i termini del problema: V. LA ROSA, Le mythe
des fouilles stratigraphiques dans l’archéologie minoen-ne, in Mythos. La préhistoire égéenne du XIXe au XXIe siècleaprès J.-C. (Table ronde Intern., Athènes, 21-23 novem-bre 2002), P. DARCQUE ed. (BCH, suppl. 46), Paris 2006,pp. 97-105.
5 F. CARINCI -V. LA ROSA, Le ceramiche e i nuovidati di scavo, in Cento anni, pp. 477-524.
6 Il programma, sotto l’egida della Scuola Archeo-logica Italiana di Atene, era stato avviato allo scorciodella direzione Di Vita, ed è proseguito con quellaGreco. Cogliamo l’occasione per ringraziarli entrambi.Al secondo dobbiamo in particolare il permesso di con-tinuare ad accedere alla documentazione di scavo con-servata negli archivi della Scuola. Per la consultazionedi essa siamo grati alla dott. I. Symiakaki, responsabi-le dei medesimi. È inutile aggiungere che nessun pro-gramma si sarebbe potuto concretare senza la strettacollaborazione ed intesa con la KG’ Eforia di Iraklionnelle persone della direttrice dott. E. Grammatikaki e
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA12
saggi all’interno dell’area già indagata, secondo quella formula del ‘riscavare lo scavato’fruttuosamente applicata ad H. Triada7. La nuova cronologia ellenistica della strada c.d.geometrica, una più precisa ed articolata datazione (nell’ambito del periodo protopalazia-le) per i diversi battuti della Strada del Nord, la retrodatazione al MM IIB della Casa a Suddella rampa, l’esistenza di una vera e propria, differenziata, sequenza prepalaziale sono alcu-ne delle acquisizioni più significative di questo lavoro di revisione sul campo 8.
Accanto ai saggi finalizzati alla verifica delle stratigrafie e delle cronologie di singo-li complessi, il programma prevedeva un doppio ordine di interventi: la pubblicazioneintegrale dei materiali recuperati nelle diverse strutture abitative 9; il riesame, in chiaveesclusivamente cronologica, di alcuni depositi ‘strategici’, legati a strutture di granderilievo nella storia e nella topografia dell’insediamento, depositi che consentissero, cioè, diriproporre un confronto più serrato (dopo l’impasse determinato dalla ricostruzione levia-na) fra la situazione festia e quella degli altri centri dell’isola. Si è pensato, in concreto, adun riesame dei soli frammenti ceramici rimasti nei magazzini dell’acropoli festia, tenendoconto, quando necessario, dei vasi interi o inventariati che, dal 1981, arricchiscono imagazzini del Museo di Iraklion. Parallelamente si è proceduto ad una rivisitazione delmateriale edito, o per una sua ricollocazione nelle tradizionali e meglio individuabili clas-sificazioni evansiane (ed è stato il caso del ricco corredo della Casa a Sud della rampa) 10,oppure per una presa di posizione su qualche vexata quaestio della ricostruzione leviana(come è successo con la ripresa dei materiali recuperati nel quartiere sud-occidentale delPrimo Palazzo) 11.
Una condizione ottimale appariva, infine, quella nella quale le nuove acquisizioni deisaggi sul terreno e la revisione dei frammenti dai vecchi scavi potessero, procedendo di paripasso, rispondere a domande comuni. In questa prospettiva effettuammo, nel 2002, il rie-same dei materiali recuperati fra le tre rampe ascendenti al Piazzale I 12.
Il nostro approccio vuole essere, in altri termini, minimalista e ‘positivo’, nell’alveo diun’esigenza tradizionalmente avvertita nelle ricerche della missione italiana. Si proponeinfatti di considerare un’esatta definizione cronologica come insostituibile premessa per lainterpretazione dei contesti e delle fasi architettoniche: principio universalmente professato,ma spesso sacrificato alla brillantezza delle nuove, proliferanti e accattivanti metodologie.
della ispettrice di zona dott. I. Antonakaki: a loro vatutta la nostra riconoscenza. I materiali cui si fa riferi-mento nel testo non sono certamente gli unici utili perle revisioni cronologiche qui proposte; l’enorme quan-tità dei frammenti conservati nei Magazzini di Festòs ela difficoltà spesso incontrata nel decodificare le indi-cazioni di rinvenimento (per non dire dei cartellini car-tacei nel frattempo deterioratisi), rendono taloraimpossibile la completezza dell’indagine. È utile inol-tre aggiungere che nel caso di non perfetta identifica-zione dei luoghi di rinvenimento abbiamo preferitoescludere i materiali dalla rassegna. La ricerca si è svol-ta nell’ambito di un progetto finanziato dal MIUR,coordinato dall’Università di Catania e con la parteci-pazione delle Università di Venezia e di Pisa.
7 V. LA ROSA, Xanaskàvontas to skammeno: epistimonikì
sinìdisi i asinidisia? I empiria tis Aghias Triadas (Kriti),in The prehistoric research in Greece and its Perspectives.Theoretical and methodological Considerations (Proceed.Intern. Symp. in the memory of D.R. Theocharis), Thessa-loniki 2003, pp. 165-169.
8 LA ROSA 2002.9 Già concluso può considerarsi l’esame dei mate-
riali per: la Casa dei vani LXXXI-LXXXV e XCIV-XCV; la Casa a Sud della rampa; i diversi vani succe-dutisi ad Ovest della Strada dal Nord. È stato inizia-to lo stesso lavoro per i materiali al di sotto del livel-lo pavimentale del vano CVII.
10 F. CARINCI, La casa a Sud della rampa e il MM IIIa Festòs, in Cento anni, pp. 203-238.
11 CARINCI, in Cento anni, pp. 477-515.12 CARINCI -LA ROSA 2002.
Creta Antica 8, 2007
REVISIONI FESTIE 13
Così è nata l’idea delle Revisioni festie: come affettuoso colloquio a distanza con unMaestro, che alla critica delle altrui ricostruzioni e alla strenua difesa delle proprie (con lanecessaria vis polemica) ci aveva abituati nelle lunghe estati sulla veranda di Festòs.
2. - Il momento di fondazione del Primo Palazzo
Un’ottima occasione di Revisione ci si è presentata in seguito ai saggi del 2004, quan-do un deposito sotto un livello pavimentale all’interno del vano 13 ed un filare di fonda-zione della verisimile prima facciata del palazzo (proprio al di sotto di quella delSecondo!)13, hanno riproposto il problema della data di messa in opera dell’edificio origi-nario, problema sul quale ci eravamo già interrogati riesaminando i frammenti dei saggifra le rampe 14. Al riguardo, una voce isolata tendeva a retrodatare al MM IA l’esistenza dispazi pubblici (che non equivalevano comunque alla presenza di un edificio monumenta-le 15), sulla scorta di alcune suggestioni degli scavatori di Mallia. Proprio per quest’ultimopalazzo, come è noto, viene proposta una retrodatazione al MM IA16. Si era sviluppato, fral’altro, un recente dibattito sulla genesi socio-politica dei palazzi cretesi, sulla specificaimportanza attribuita ai contrasti (competitions) fra gruppi emergenti (factions) per la con-quista e il controllo del potere, persino con la proposta di sostituire al termine ‘palazzo’la meno impegnativa espressione di court compound 17.
Al momento di fondazione del Palazzo, il Pernier non prestò specifica attenzione,avendo interamente demandato ad Evans il tema della determinazione cronologica dellefasi. I diversi saggi effettuati dallo scavatore di Festòs al di sotto dei pavimenti del primoPalazzo e del lastricato del Piazzale I tendevano infatti, sostanzialmente, ad accertare l’e-sistenza di strutture e fasi anteriori al Palazzo medesimo. Nel caso in cui sotto il lastrica-to del Piazzale il Pernier si era imbattuto nei resti di uno più antico, pensò che «già avan-ti alla costruzione del palazzo primitivo […] vi fosse un’area lastricata innanzi a qualcheabitazione»18. Unica indiretta proposta cronologica per il problema in questione sembre-rebbe ricavarsi da un saggio al di sotto dei Magazzini XXXIV, laddove si precisa che«sopra lo strato neolitico, v’erano abitazioni minoico-primitive rimaste in uso fino al MPIII; allora sulle macerie di esse sorsero i magazzini del primo palazzo, usati durante ilMM»19. La conseguenza, alla quale il Pernier non dovette dare molto peso, sarebbe quelladi una messa in opera del primo Palazzo durante il MM IA. Lo stesso autore fra l’altro,come si riesce faticosamente a ricostruire dalla relazione definitiva, indica come prove-niente dallo strato su cui sorsero i Magazzini XXXIV 20 (quindi anteriore alla costruzione
13 Vedi infra, pp. 42-46; V. LA ROSA, I saggi dellacampagna 2004 a Festòs?, in ASAtene LXXXII, II,2004, in c.d.s.
14 CARINCI -LA ROSA 2002; vedi anche V. LA ROSA,Perché il palazzo a Festòs?, in Creta Antica 5, 2004,pp. 43- 49.
15 DAMIANI INDELICATO 1982, pp. 85-120; vedi an-che infra, nota 131.
16 O. PELON, Un dépôt de fondation au palais deMalia, in BCH 110, 1986, pp. 3-19.
17 Cfr. Y. HAMILAKIS, Too many chiefs? Factional
competition in neopalatial Crete, in Monuments ofMinos: Rethinking the Minoan Palaces, ed. by J. DRIES-SEN, I. SCHOEP and R. LAFFINEUR (Aegaeum 23), Liège2002, pp. 179-199; J. DRIESSEN, ‘The King must die’.Some observations on the use of Minoan Court com-pounds, ibid., pp. 1-13.
18 PERNIER 1935, p. 125; vedi anche pp. 70 s., 199,241.
19 PERNIER 1935, pp. 319-320.20 PERNIER 1935, p. 327.
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA14
del Palazzo) un piccolo complesso di tre vasetti interi, tutti chiaramente riferibili al MM IA:una teiera e uno skouteli del tipo Patrikiès ed un bricchetto su piede 21. Che l’affidabilità del-le classificazioni del Pernier vada verificata caso per caso, è ben evidente, per esempio, dal-l’attribuzione a «costruzioni anteriori al primo palazzo» delle strutture sottostanti ai vaniXXV e XXVII, con materiali chiaramente del MM IB e persino del MM II 22.
Decisamente paradossali risultano le proposte cronologiche di L. Banti 23, che aveva inanimo di condurre una serie di saggi di verifica sia a Festòs che ad H. Triada, iniziatisi e con-clusisi nel 1939. Si ponevano in tal modo le basi di quel confronto ‘dialettico’ fra le strati-grafie di Festòs e di Cnosso, proseguito poi con D. Levi. Il metodo seguito è quello di mostra-re l’associazione nei livelli festii di materiali attribuiti a fasi diverse nella stratigrafia cnossia;il pericolo evidente consiste nella discutibilità dei confronti addotti. In questa sede esula dainostri interessi la proposta relativa alla distruzione del primo palazzo («avvenuta quando aKnossòs si usava la ceramica attribuita a MM IIIb»24); meritano invece di essere ricordate leosservazioni sul momento di costruzione dell’edificio, basate sui trovamenti effettuati dalPernier al di sotto dei livelli pavimentali (che avremo modo di esaminare nel dettaglio): lerelative strutture tuttavia, come osservato dalla stessa Banti, non possono essere con certezzariferite «ad un tutto unico o di uguale epoca»25. Come terminus ad quem per la costruzione delpalazzo vengono infatti presi in considerazione vasi come quelli sotto il vano XXVII, chiara-mente riferibili ad una delle distruzioni dell’edificio: con l’aberrante risultato che esso sareb-be stato «eretto durante il MM IIb»26. Ma un paio di decenni dopo, la Banti si era già alli-neata con le interpretazioni correnti, proponendo addirittura una retrodatazione al MM IA27.
Dal canto suo, il Levi non ebbe ad insistere sulla cronologia di fondazione, preferendoenfatizzare la sequenza di quelle che egli riteneva le tre fasi architettoniche del Palazzo,distinte e sigillate dalle gettate di calcestruzzo e ritenute fondanti, come già accennato, perl’interpretazione di tutte le stratigrafie del sito 28. Una delle affermazioni più rilevanti risul-tava quella che l’intero settore del Palazzo corrispondente al Piazzale I fosse da riferire soloall’ultima delle tre fasi protopalaziali, con evidente difficoltà a giustificare la presenza dimateriali come i pithoi del Magazzino XXXIV, praticamente identici a quelli dallo stessoLevi rinvenuti nei vani della I fase 29.
Gli accenni più significativi al momento di messa in opera dell’edificio palazialeriguardano alcuni saggi nel Piazzale LXX. Il primo è relativo ad uno svuotamento del«riempimento a sacco della facciata davanti al vano LVIIIa», attribuibile, sulla base del-la foto di rimando, allo scavo nello spessore della parete ovest dell’ambiente 30. Pur non
21 PERNIER 1935, pp. 134-135, fig. 59, 1 e 8; MonAntXIV, 1902, col. 453, fig. 65a-c.
22 PERNIER 1935, pp. 139-150.23 BANTI 1939- 40. Versus N. PLATON, I chronolo-
ghia ton minoikòn anaktoron tis Festoù, in KritChron3, 1949, pp. 150-166; ZOIS 1965, pp. 30-31.
24 BANTI 1939-40, p. 35.25 BANTI 1939-40, loc. cit.26 BANTI 1939-40, p. 38. Discutibile è anche l’af-
fermazione che la data tradizionalmente accettata perla costruzione del nostro edificio sarebbe «la fine delM M I o l’inizio del MM II» (ivi).
27 L. BANTI, Minoico-micenea arte, s.v. , in EAA V,
1963, p. 51: «I tre grandi palazzi […] costruiti nelMinoico Medio I»; p. 52: «La fase detta dei primipalazzi (MM Ia - MM IIIb)».
28 LEVI 1976, pp. 15-28.29 LEVI 1976, p. 26. Versus vedi già PLATON 1968,
pp. 37-39.30 LEVI 1976, p. 36. L’accenno alla localizzazione del
saggio potrebbe ingenerare confusione, dal momentoche lo svuotamento, deve essere stato effettuato subitodietro la facciata ad ortostati nello spessore del muro,come risulta dalla fig. 21 a p. 34; la foto non si riferi-sce tuttavia al momento dello scavo, poiché si intrave-de uno dei pali metallici della copertura in plastica.
Creta Antica 8, 2007
illustrando il materiale, il Levi fa riferimento a ceramiche di vari periodi a partire dalNeolitico e, a giudicare dalle descrizioni, fino al MM IA. Proprio questi frammenti piùrecenti dovrebbero poter «offrire un prezioso dato per il momento preciso della fondazio-ne del Palazzo»31.
Il secondo accenno è invece relativo ad un saggio del 1957 sotto il lastricato delPiazzale LXX, con la deduzione della «contemporaneità della stesura del lastricato mede-simo e della prima costruzione palaziale»32. Il riferimento ai materiali, non sempre pun-tuale 33, autorizza a supporre che, secondo il Levi, tale stesura debba essere avvenuta contem-poraneamente al deposito di Patrikiès, ivi comprese le prime sperimentazioni della tecnicaà la barbotine, deposito classificato appunto come «momento di transizione tra l’età prepa-laziale e l’inizio di quella palaziale»34.
Una esplicita adesione ad una cronologia MM IA sembrerebbe, infine, arguibile dallarisposta polemica del Levi alle contestazioni mossegli dal Platon 35: il riferimento riguarde-rebbe addirittura i materiali dello strato di distruzione della sua I fase 36.
In parziale disaccordo, ma in qualche caso solo nominalmente, con la ricostruzionedel Levi risulta quella di E. Fiandra, pure collaboratrice dello scavo, alla quale si deve laproposta di una sequenza di quattro «periodi struttivi»37. Comune ai due studiosi, in ognicaso, è l’affermazione di un’anteriorità del settore sud-occidentale del Palazzo rispetto allafacciata ad ortostati del Piazzale I. Esiste tuttavia, fra i due, una notevole divergenza cro-nologica: la costruzione della facciata superiore viene infatti attribuita dalla Fiandra al 2°periodo struttivo (corrispondente al MM IIA di Evans), laddove il Levi la assegna alla suaIII fase, che dovrebbe rappresentare il MM IIIA della classificazione corrente.
Per quel che riguarda specificamente il momento di messa in opera dell’originarioedificio palaziale, la Fiandra fa riferimento ad una trincea di fondazione che colloca inun’area «soprastante la casa prepalaziale del cortile LXX»38, la quale dista tuttavia oltre1,50 m dall’unico ortostate collocato in corrispondenza dell’angolo sud-est del saggio: nel1° periodo struttivo non esistevano infatti le murature della «portineria» LVII 39. Comeprovenienti da questa non esattamente localizzabile trincea di fondazione vengono ricor-dati frammenti del «tipo rinvenuto negli scavi di Paterikiès e della grotta di Kamares»( fig. 1), i quali sono considerati come terminus post o eventualmente ad quem per la messa
31 LEVI 1976, loc. cit. Non è stato possibile rin-tracciare nei cassetti del museo stratigrafico i mate-riali in questione.
32 LEVI 1976, p. 291.33 Nel nostro caso soprattutto quelli riprodotti al-
la fig. 454.34 LEVI 1976, loc. cit.35 Vedi infra, p. 17s.36 D. LEVI, La critica degli archeologi. In margine
al 1° Congresso Internazionale di Studi Cretesi, in PP96, 1964, p. 169: «La costruzione del palazzo diFestòs andrebbe datata al M.M.I b, a giudicare dallesuppellettili (del tipo di H. Fotinì) rinvenute neglistrati pavimentali del momento iniziale della primafase: quando mai, dal momento che le suppellettilidello strato superiore, quelle del momento finale del-
la prima fase, trovano invece una diretta rispondenzain quelle rinvenute nella primissima fase struttiva delpalazzo di Cnosso, nel ‘Vat Room Deposit’, nelle giàcitate case sottostanti alle kulure, e in tutte le altresuppellettili classificate dall’Evans nella fase M.M. I a».
37 FIANDRA 1961-62; vedi anche EAD., Cultura escambi commerciali nella civiltà minoica, in Le Scienze176, Aprile 1983, pp. 30-43. I «periodi struttivi»furono dal Levi frettolosamente liquidati con un «nesutor ultra crepidam»: cfr. LEVI, La critica degli archeo-logi cit., p. 175, nota 24. Per i termini del problemaV. LA ROSA, A hypothesis on earthquakes and politicalpower in Minoan Crete, in Annali di Geofisica XXX-VIII, 5-6, November-December 1995, pp. 881-891.
38 FIANDRA 1961-62, p. 114.39 Cfr. LEVI 1976, fig. 450.
REVISIONI FESTIE 15
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA16
40 FIANDRA 1961-62, pp. 114 -115, tav. IQ .́41 Vedi infra, pp. 25-27.42 Sulla questione, vedi infra p. 23.43 FIANDRA 1961-62, p. 117, tav. KST´.44 Ben poco utile a risolvere le questioni relative è
il contributo della stessa A. sul MM IIA: E. FIANDRA,Precisazioni sul MM IIA a Festòs, in Atti IV Conv.
Intern. Studi Cretesi (Iraklion 1976), I, Atene 1980, pp.169-196. Sull’argomento è tornato CARINCI, in Centoanni, p. 509 s., nota 113. Un complesso MM IIA po-trebbe essere il deposito sotto le lastre pavimentali delvano CVII, per il quale era già stata proposta una col-locazione in un momento di transizione tra le fasi Ia eIb del Levi. Cfr. LEVI -CARINCI 1988, p. 300.
in opera dell’edificio 40. Siamo stati in grado di identificare alcuni dei frammenti presen-tati dalla Fiandra, materiali recuperati tuttavia in complessi e a profondità diversi, soprat-tutto in un saggio al di sotto del vano geometrico F 41. Tra di essi appaiono ben riconosci-bili almeno due frammenti MM IB, che dovrebbero costituire l’autentico riferimento cro-nologico per la fondazione dell’edificio. Si tratta, in ogni caso, di materiali in rapportonon con la facciata del palazzo, ma con la messa in opera del Piazzale LXX 42.
A indagini condotte a livello di fondazioni allude espressamente la stessa Fiandraanche a proposito della facciata ad ortostati del Piazzale I, attribuita al suo 2° periodo,laddove ricorda genericamente «frammenti rinvenuti sotto il piano dell’euthynteria degliortostati», non riprodotti e senza una specifica localizzazione, solo stilisticamente appa-rentati a quelli del Bastione II e della banchina del vano LXIII 43. I contesti cui si fa rife-rimento andrebbero assegnati ad un orizzonte non iniziale del MM IB, piuttosto che alMM IIA richiamato dalla Fiandra nella tabella cronologica, anche se a Festòs, come altro-ve, la definizione di quest’ultimo periodo è ben lungi dall’essere definitivamente chiari-ta 44. In ogni caso, come per il tratto di facciata meridionale, non viene specificato se imateriali cui si fa riferimento vadano considerati come terminus ad o post quem. Lo spettrocronologico delle proposte Fiandra oscillerebbe dunque, secondo le sequenze ceramichecomunemente accettate, tra il MM IA -IB per il settore del Piazzale LXX e il corso delMM IB per quello del Piazzale I.
La documentazione addotta dalla Fiandra (soprattutto per quel che riguarda l’asseri-ta posteriorità della facciata superiore) ci è parsa insufficiente per la ridefinizione crono-logica dei lastricati occidentali (e quindi delle diverse terrazze del palazzo), anche alla luce
FIG. 1 – FRAMMENTI CERAMICI INDICATI DA E. FIANDRA COME PROVENIENTI DALLA «TRINCEA DI FONDAZIONE»DEL PRIMO PALAZZO (DA FIANDRA 1961-62).
Creta Antica 8, 2007
45 Vedi supra, nota 16.46 CARINCI -LA ROSA 2002.47 F. TOMASELLO, Gli ingressi al quartiere sud-ovest
del primo palazzo di Festòs, in epi ponton plazomenoi,Simposio italiano di studi egei in onore di L. Bernabò Breae G. Pugliese Carratelli, V. LA ROSA, D. PALERMO e L.VAGNETTI edd., Roma 1999, pp. 75-89 e specialmen-te figg. 5 e 6.
48Art. cit., p. 89. Sulle tematiche relative alla pro-gettazione architettonica del quartiere sud-occidentaledel Palazzo di Festòs l’autore è tornato nel contributo:L’architettura. Considerazioni preliminari sull’articola-zione degli spazi, in Cento anni, pp. 407-423.
49 ZOIS 1965.
50 ZOIS 1965, pp. 86-87 e tav. fuori testo B.51 ZOIS 1965, pp. 76-77. Per la «fase di H. Photinì»:
p. 77 ss.52 N. PLATON, Synkritikì chronologhia ton triòn
minoikòn anaktoron, in KritChron. 15-16, 1961-62,pp. 127-136; PLATON 1968. Al primo lavoro il Leviebbe modo di replicare: LEVI, La critica degli archeo-logi cit. a nota 36, pp. 166-173.
53 PLATON 1968, p. 3.54 PLATON 1968, p. 22, nota 1.55 PLATON 1968, p. 29.56 PLATON 1968, p. 30, nota 1 (con alcune chiose ai
‘periodi struttivi’ della Fiandra).
REVISIONI FESTIE 17
degli elementi emersi altrove (v. per es. il deposito di fondazione di Mallia 45). È dunquenecessario reperire nuovi dati, alla luce della recente revisione delle sequenze della rampaascendente 46, cercando di ricostruire i diversi momenti di sviluppo di un sistema archi-tettonico su un doppio se non un triplo livello, quello del Cortile centrale XXXIII- 40,del Piazzale I e del Piazzale LXX.
Non molto diversa da quella della Fiandra, per quel che riguarda il rapporto cronolo-gico tra il Piazzale LXX e il Piazzale I ed i rispettivi settori di facciata, appare l’ipotesi diF. Tomasello 47, il quale preferisce parlare di «momenti progettuali» basati sulle articola-zioni interne delle strutture e sulle relazioni reciproche, senza tuttavia escludere «apriori-sticamente sincronismi negli episodi edilizi»48.
La critica più serrata alla lettura delle rovine festie venne da due studiosi greci, A. Zoise N. Platon, provocando una vera e propria querelle, articolatasi in repliche e controrepliche(che esulano dai limiti del presente lavoro), dal momento che il Levi tenne fede fino all’ul-timo alle sue ricostruzioni.
Lo Zois 49, riesaminando partitamene i diversi depositi ceramici, ne stabilisce una suc-cessione e propone di fissare la fondazione del palazzo alla fine del MM IA, corrisponden-te al momento delle ceramiche à la barbotine della grande tholos di H. Triada («fasis tra-chotòn Aghias Triadas») 50, di poco anteriori a quelle dello stile di Haghia Photinì indivi-duato dal Levi, ma appena posteriori al deposito di Patrikiès (all’incirca contemporaneo algruppo di Drakones) 51.
Del problema della datazione dei palazzi minoici, e specificamente di quello diFestòs, N. Platon si era occupato a più riprese 52. La cronologia di fondazione agli inizi delMM IB era stata da lui sostenuta fin dall’inizio, in risposta al citato lavoro della Banti,sulla base dei pochi resti di ceramica del tipo Messara Kultur (corrispondente all’AM III -MM IA53 ed equivalente, nel sistema leviano, al momento di Patrikiès), rinvenuta al disotto dei pavimenti più antichi. Il riferimento ad una serie di indicazioni cronologiche(non sempre, per la verità, coerenti) nelle diverse relazioni preliminari del Levi, porta tut-tavia il Platon a fraintendimenti come quello che l’inizio dei Primi Palazzi fosse da por-re, per lo scavatore di Festòs, nel periodo corrispondente al MM IA54. L’archeologo grecoriprende, comunque, tutti i dati disponibili dai diversi saggi in profondità sia del primoche del secondo ciclo di scavi, per ribadire la sua originaria proposta (inizi del MM IB) 55,ma anche per affermare la contemporaneità fra le due terrazze della facciata occidentale 56
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA18
e per criticare con abbondanza di documentazione la lettura proposta dallo scavatore perle rovine del quartiere sud-occidentale del Primo Palazzo.
La ricordata necessità di una revisione per un problema di notevole rilevanza, non puònon partire dalla «decodificazione» del testo leviano; il riesame autoptico del materialearcheologico dovrebbe poi consentire di proporre precisi ancoraggi cronologici, indispen-sabile premessa per qualsiasi analisi architettonica e funzionale e per ogni ricostruzione sto-rica. La mole dell’edizione dello scavo e la quantità dei materiali conservati nei magazzinidi Festòs, per tacere delle migliaia di vasi che arricchiscono le collezioni candiote, ha richie-sto un preciso progetto di insieme che con il presente contributo intendiamo inaugurare.
Nell’ottica di tale progetto abbiamo considerato di preponderante interesse il riesame deilivelli al di sotto del Cortile centrale e dei due piazzali occidentali (il mediano e l’inferiore). Atali dati saremo in grado di aggiungere le conclusioni ricavate da saggi effettuati nel 2004.
2.1 I saggi sotto il Cortile centrale XXXIII/40È inutile sottolineare che alle risultanze dei saggi in quest’area andrà attribuito un
valore preminente, dal momento che il Cortile centrale è unanimemente inteso come lospazio costitutivo e identificativo della struttura palaziale 57. Già nel 1902 e poi nel 1906il Pernier vi aveva effettuato diversi saggi 58, alcuni lungo la fascia ovest non sigillata dalastre (e quindi non di particolare interesse per il nostro problema), ed un altro «nell’areacentrale del cortile dove le lastre del pavimento mancavano»59. L’assenza di livelli sigilla-ti risultava evidente dal rinvenimento di «materiale tardo-ellenico a contatto con lo stra-to neolitico e la roccia a solo 0,30 m. di profondità». Il lastricato, in altre parole, sarebbestato rimosso in età storica, in occasione della costruzione di case immediatamente sullelastre MM, con l’asportazione di alcune di esse per l’alloggiamento di pithoi, uno dei qua-li il Pernier aveva messo in luce proprio al centro del cortile 60. L’assenza di uno stratoKamares portava infine il primo scavatore a dedurre che il «pavimento non fu rialzatoall’epoca del secondo palazzo»61. Situazione praticamente simile viene dichiarata per sag-gi del 1928-29, con «in superficie materiale ellenico a contatto con il neolitico»62.
Assai più complesso è il quadro prospettato dal Levi, in relazione all’esteso saggio lun-go il lato occidentale dello stesso Cortile, dove egli aveva identificato le sottofondazioni diun colonnato 63: in un’area, cioè, nella quale furono messi in luce resti di vani al di fuori eal di sotto dello spazio interessato dalla pavimentazione a lastre, sistemati già lungo il pen-dio della collina. Specifica rilevanza per il nostro problema ha una sua osservazione a pro-posito del Corridoio III/7, lì dove egli attribuisce alla III fase protopalaziale la sistemazio-
57 Opinione diversa in DAMIANI INDELICATO 1982,pp. 95-99. L’A. non sembra addirittura certa sull’e-sistenza di un cortile centrale nella prima fase di vitadel nostro palazzo; nega che l’edificio avesse fin dal-l’inizio «una struttura organica e unitaria».
58 PERNIER 1935, pp. 120-121, con indicazione deisaggi alla fig. 14. Vedi anche RendLinc XVI, 1907, pp.268-271.
59 PERNIER 1935, p. 80.60 PERNIER 1935, pp. 80-81.61 Loc. cit.62 PERNIER 1935, nota 15 a p. 110. Cfr. Taccuino
Pernier 16 giugno 1928.63 LEVI 1976, p. 262 ss. Ridiscutendo i dati relati-
vi a questo saggio ed il diverso orientamento delcolonnato rispetto alle murature del Primo Palazzo,il Platon era giunto alla conclusione che «la sistema-zione del cortile era avvenuta agli inizi del primoperiodo neopalaziale, MM III secondo Evans»; pensa-va quindi che il cortile originario, del quale si sareb-be ignorata l’estensione, avesse avuto un calpestioleggermente più basso rispetto a quello delle lastreneopalaziali (PLATON 1968, pp. 45- 46).
Creta Antica 8, 2007
REVISIONI FESTIE 19
ne del lastricato conservatosi fino a noi, affermando inoltre che «edifici delle due prime fasiprotopalaziali si estendono fin sopra alla metà meridionale del Piazzale centrale, mentre tut-ta la metà settentrionale era stata bensì abitata in età neolitica, ma da allora lasciata a cor-tile aperto o aiuola, fino alla posa del lastricato della III fase protopalaziale»64: affermazio-ne questa che potrebbe indirettamente essere addotta a favore di un ridimensionamento,quanto meno architettonico, del palazzo nelle sue prime due fasi di vita. Nella stessa dire-zione sembrerebbe muovere l’altra osservazione che il lastricato del Cortile centrale fosse didimensioni diverse, assai più grande ed accurato che quello del Piazzale LXX 65.
L’ultimo e più significativo saggio nell’area è quello del 197166, effettuato a circa m2,50 dal limite ovest del lastricato, in corrispondenza dello sbocco del Corridoio 7: un’a-rea sufficientemente ampia (4,20 !3,80 m) e tutta sigillata dalle lastre all’uopo rimosse.Dei cinque strati della sequenza ( fig. 2) il solo che qui interessa è il superiore (I), termi-nante su un battuto a -0,30 m dal livello delle lastre, giustamente considerato come pre-paratorio per la loro posa. Insieme con materiali AM e neolitici furono rinvenuti diversicocci MM 67, sui quali solo converrà fissare la nostra attenzione. Frammenti AM I - II e neo-litici aveva ormai lo strato II, ricco di ceneri e carboni, caratterizzato come riempimento 68.
I cocci dello strato I 69 appaiono senza attacchi tra di loro e molto sminuzzati (certointenzionalmente, dato l’esiguo spessore dello strato e la sua funzione di piano di alletta-mento). Assai scarsa è la percentuale di quelli recanti una superficie verniciata, mentre dimaggiori dimensioni sono solo larghi tratti del fondo di un vaso acromo non meglio clas-sificabile. Tra i frammenti assegnabili a specifiche forme vascolari abbiamo contato 55 trat-ti di fondi (di cui 7 verniciati) e 21 di orlo con attacco di parete (di cui 2 dipinti) di skou-telia MM IA. I nove fondi riprodotti nella fig. 3 sono tutti del tipo a parete spessa, convistose tracce di ditate, segni evidenti delle manipolazioni tipiche della lavorazione degliskoutelia MM IA. Nella fig. 4 vengono invece presentati tre fondi e due orli dello stessotipo, con verniciatura all’interno e all’esterno, sia in nero sia in rossastro (in due casi il fon-do esterno è risparmiato), e doppia fascetta bianca sotto l’orlo, un tipo dal Levi comune-mente indicato come caratteristico della stazione di Patrikiès. I sette frammenti di orli diesemplari acromi sono tutti del tipo lisciato alla estremità superiore, sia all’interno sia all’e-sterno, con caratteristiche striature orizzontali, che formano all’esterno una fascia bendistinta dal resto della parete.
In questo orizzonte tipicamente MM IA si distinguono soltanto tre frammenti ( fig.5), due dei quali con superficie esterna increspata trattata nella tecnica à la barbotine (alme-no uno con tracce di vernice nera, di un tipo abbastanza evoluto). Il terzo frammento èinvece probabilmente il resto di un’applicazione di un minuscolo vasetto aperto, in argillafine rosata, tutto verniciato di nero e fissato ad altro supporto (forse un elemento simile, dimaggiori dimensioni), mediante una porzione di argilla meno depurata, granulosa, di colo-re grigiastro: dettaglio, questo, che si ritrova in alcuni vasetti multipli della iniziale pro-duzione Kamares 70.
64 LEVI 1976, p. 253.65 LEVI 1976, p. 33.66 Cfr. L. VAGNETTI, L’insediamento neolitico di
Festòs, in ASAtene 50-51, 1972-73, pp. 12-15, fig.2 a-b; LEVI 1976, pp. 413- 414.
67 VAGNETTI, art. cit., p. 12.68 A cocci MM, che non siamo stati in grado di ri-
scontrare, si fa in effetti riferimento anche per questostrato: cfr. VAGNETTI, loc. cit.
69 Collocazione: Museo Stratigrafico (in seguito abbre-viato MS) col. 22/2. Indicazioni: «28-30 agosto 1971Fra il lastricato e un battuto AM da -0,15 a -0,30».
70 LEVI - CARINCI 1988, tav. 104 f -g.
Creta Antica 8, 2007
Tutti e tre i frammenti sembrano difficilmente riferibili ancora all’orizzonte MM IAe potrebbero dunque rappresentare il dato più recente dello strato I. L’abbondanza dimateriale MM IA in questo livello di riempimento sotto le lastre lascia supporre un cospi-cuo sbancamento per la messa in opera della pavimentazione, e dunque un’intensa fre-quentazione della collina del palazzo. Un’indiretta conferma sarebbe offerta dai tre citativasetti interi MM IA segnalati dal Pernier in un’area poco distante 71.
71Vedi supra p. 14.
FIG. 4 – SAGGIO SOTTO LE LASTRE DEL CORTILE CENTRALE
XXIII/40. FRAMMENTI DI SKOUTELIA DALLO STRATO I.
FIG. 2 – SAGGIO SOTTO LE LASTRE DEL CORTILE CENTRALE XXIII/40. SEZIONE (DA VAGNETTI, ASATENE 1972-73).
FIG. 3 – SAGGIO SOTTO LE LASTRE DEL CORTILE CENTRALE
XXIII/40. FONDI DI SKOUTELIA DALLO STRATO I.
FIG. 5 – SAGGIO SOTTO LE LASTRE DEL CORTILE CENTRALE XXIII/40.FRAMMENTI VEROSIMILMENTE DEGLI INIZI DEL MM I B DALLO STRATO I.
Creta Antica 8, 2007
REVISIONI FESTIE 21
In conclusione, agli inizi del MM IB ci sen-tiremmo di attribuire la pavimentazione del Cor-tile XXXIII/40.
2.2 Il Piazzale occidentale LXXIl saggio più importante in quest’area è
quello effettuato sotto il lastricato, in corrispon-denza del vano LVI, in un tratto in cui le lastreerano largamente lacunose ( fig. 6). Il Levi, oltread un sottile livello di allettamento immediata-mente al di sotto di esse, aveva già distinto unostrato superiore da uno inferiore e notato come ilprimo presentasse una prevalenza di materialeMM IA; ne concludeva che fosse quest’ultimo«lo strato del momento di fondazione del primo
palazzo»72. Di questi materiali più recenti lo stesso Levi fornisce alcuni riferimenti, men-tre la loro documentazione grafica si è ora arricchita grazie alla presentazione preliminaredei depositi, in vista di un’edizione esaustiva 73. In tale presentazione si accenna al caratte-
72 LEVI 1957-58, pp. 167-182, specialmente p.170. Osservazioni generali sui materiali del saggio inZOIS 1965, pp. 56-59.
73 M. BENZI, Il periodo prepalaziale a Festòs: unaricognizione preliminare, in Cento anni, pp. 135-147.
FIG. 6 – SAGGIO SOTTO IL PIAZZALE INFERIORE LXX. DA SUD-OVEST (DA LEVI 1976).
FIG. 7 – SAGGIO SOTTO IL PIAZZALE INFERIORE LXX.FRAMMENTI MM II DALLO STRATO SUPERIORE.
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA22
FIGG. 8-9 – SAGGIO SOTTO IL PIAZZALE INFERIORE LXX. FRAMMENTI MM I B DALLO STRATO SUPERIORE.
Creta Antica 8, 2007
REVISIONI FESTIE 23
re transizionale del deposito e, a proposito delle diverse varietà della ceramica à la barboti-ne, viene notato che alcuni frammenti appartengono già alla «prima fase palaziale»74. Nonsi può minimamente dubitare sulla prevalenza, nello strato superiore 75, di ceramica delMM IA. Il problema diventa, semmai, quello di individuare frammenti più tardi, che pos-sano costituire un terminus ad quem per la messa in opera delle lastre del Piazzale LXX, equindi del settore sud-ovest del Primo Palazzo.
Tra i materiali dello strato superiore 76 è stato possibile isolare un gruppetto di frammen-ti MM IB, ed un altro per il quale la distinzione tra MM IA e MM IB è parsa problematica.Manifesta intrusione abbiamo considerato in quel contesto omogeneo due frammenti MM II( fig. 7), cioè un tratto di ansa a nastro schiacciato di olletta con beccuccio a ponte sicuramen-te MM IIB ed uno di fondo e parete di coppa o tazza carenata con decorazione a zig-zag all’e-sterno e tracce di colore bianco e ocra all’interno, forse ancora MM II iniziale. Per la precisio-ne, abbiamo contato quaranta frammenti MM IB, mentre dieci restano di più incerta colloca-zione. Nelle figg. 8-9, che riteniamo di materiali sicuramente assegnabili al MM IB, si posso-no osservare minuti frammenti di pareti con decorazione à la barbotine; beccucci di ollette sen-za ponte; tratti di parete con il motivo delle fasce verticali risparmiate sul fondo naturale del-l’argilla e marginate di rosso; un tratto di parete di olletta con fascia bianca pure marginata dirosso; metà di un’ansetta a cordone con trattini obliqui bianchi; orli di bacini con ingubbia-tura rossa lustrati; un frammento della parte inferiore di una grande tazza cilindrica con fascet-te orizzontali bianche e sovradipintura in rosso; resti di un paio di ansette a bastoncello sotti-le, del tipo ad arco ogivale; un tratto di orlo e parete di bricco o teiera con decorazione a fascein scuro su chiaro. Nella fig. 10, dove abbiamo raccolto alcuni frammenti verosimilmente dipassaggio fra MM IA e MM IB, sono da segnalare due frammenti di collo e becco di broc-chette, con decorazione a fascette bianche 77. Interessante, per la forma, un frammento di vas-soio ( fig. 11) con una o più aperture circolari sul fondo 78, verosimilmente MM IB.
Nello stesso 1957 il Levi effettuò un secondo saggio nel settore sud-est del PiazzaleLXX, presso l’ortostate a Nord del pilastro d’angolo della facciata del primo Palazzo, in una
74 BENZI, art. cit., p. 147, fig. 6b (con rimando a LEVI
1957-58, fig. 351 a sin. al centro e in basso e fig. 355).75 Oggetto di studio, come tesi di diploma presso la
Scuola Archeologica Italiana di Atene, da parte delladott. V. Lenuzza (A.A. 2005), nell’ambito del proget-to scientifico ricordato alla nota 6 (Università di Pisa).
76 I materiali relativi agli strati immediatamentesottostanti al lastricato sono raccolti nel MS alla col.60/2-6.
77 Si tratta, in particolare, di: colli di brocchettaper dimensioni e forma simili alla brocche a pelta,ma verniciati di nero con fascette bianche (transizio-ne MM IA/IB?); un frammento di grande vaso diforma chiusa con fascia scura marginata di bianco(ancora MM IA?); un beccuccio con fascetta rossa efascette bianche, aperto, alquanto corto; un orlo divaso chiuso con decorazione rosso arancio e puntina-tura bianca; un tratto di orlo e parete di un’olletta/teiera; un fondo di forma aperta cilindrica; un altroframmento di fondo.
78 F. 8096, con basso bordo obliquo all’esterno,curvilineo all’interno, dall’orlo appiattito superior-mente e con margine aggettante, sollevato e ondula-to. Il fondo sembra essere caratterizzato dalla presen-za di una o, forse, più aperture circolari, non concen-triche con il perimetro della base e dell’orlo. La deco-razione sulla vernice scura è costituita da due fasceorizzontali rosse presso la base all’interno e una pres-so l’orlo all’esterno; una fascetta bianca era superior-mente sull’orlo. A questo frammento può esserneaccostato uno dal Propileo II, senza specifiche indica-zioni (F. 8112), dal quale si evince che le aperturedovevano essere 4, e di dimensioni adatte ad alloggia-re piccoli vasi del tipo degli skoutelia. Per un esemplareanalogo da Haghia Triada di età neopalaziale: V. LA
ROSA, Nouvelles données du Bronze moyen au Bronzerécent à Haghia Triada, in Transition. Le monde égéen duBronze moyen au Bronze récent, R. LAFFINEUR ed. (Aegaeum3), Liège 1989, p. 89, tav. XVIIIc.
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA24
FIG. 10 – SAGGIO SOTTO IL PIAZZALE INFERIORE LXX. FRAMMENTI FRA IL MM IA e il MM I B DALLO STRATO SUPERIORE.
FIG. 11 – COME SOPRA. FRAMMENTO F. 8096 DALLO STRATO SUPERIORE (DIS. G. MERLATTI).
Creta Antica 8, 2007
REVISIONI FESTIE 25
79 LEVI 1957-58, pp. 268-269.80 LEVI 1976, p. 287; già LEVI 1957-58, p. 269, fig.
108h. Si tratta della brocchetta frammentaria F. 2034, ilcui punto di rinvenimento, nella scheda inventariale, ri-sulta essere «vano G, ai piedi della base della colonnina».
81 Nessun elemento rilevante si ricava dalla relazionedella dott. L. Guerrini 1957, p. 13.Collocazione: MS col. 13/24. Indicazioni: 30/07/57. «Sag-gio ortostate a NO del pilastro d’angolo del I palazzo».Materiali: pochi MM IB; altri MM IA e anteriori (AM II).Collocazione: MS col. 13/26. Indicazioni: 27/11/57. «Asud dell’ultimo ortostate sul filo delle fondazioni verso ilcanale». Materiali: qualche MM IB - MM IA e anteriori.Collocazione: MS col. 13/27. Indicazioni: 31/07/57. «ANO del pilastro d’angolo lungo il muro tra la zona F e M».Materiali: orizzonte MM IA; fr. teiera a ocarella MM IB (?).Collocazione: MS col. 14/1. Indicazioni: 31/7/57. «ANO del pilastro d’angolo del I palazzo I fase». Materiali:MM IA uniforme, con molti skoutelia.Collocazione: MS col. 14/2. Indicazioni: 31/7/57. «ANO del pilastro d’angolo del I palazzo I fase». Materiali:MM IA, con fr. di ansa a trattini bianchi e fr. à la barbo-tine di un tipo ancora iniziale; 1 fr. MM IB (?).Collocazione: MS col. 14/3. Indicazioni: 31/7/57. «A NOdel pilastro d’angolo del I palazzo I fase». Materiali: in mag-
gioranza MM IA; alcuni frammenti incerti (uno MM II?).82 LEVI 1957-58, pp. 265-266, figg. 86a-b e 102.
Nella didascalia della fig. 102 il vano è però indicatocome geometrico. Nella stessa relazione preliminare, a p.267, si fa cenno a «tre gradini di blocchetti rettangolariaccuratamente connessi posanti su un ripiano di pietruz-ze», rinvenuti in quella stessa zona «sotto l’euthynteriadegli ortostati». Nella planimetria generale in LEVI
1976, tav. B, la struttura, senza indicazione della letterache la contrassegnava, è attribuita al periodo miceneo,mentre l’ipotesi del ripostiglio viene accantonata a favo-re di «muri di contenimento di resti della gettata diastraki»: LEVI 1976, p. 287.
83 Probabilmente a campagna di scavo già conclu-sa, ad opera dell’arch. E. Fiandra, come risulta dallagrafia delle indicazioni cartacee allegate ai frammen-ti e dalla sua lodevole abitudine di siglare, con cifrecorrispondenti agli strati, tutti i cocci dei medesimi.
84 Collocazione: MS col. 81/16. Indicazioni: 27/09/60.«Saggio sotto il lastricato della F. I primi 10 cm sotto lelastre. Terra dura con piccole pietre e molti cocci».
85 Collocazione: MS col. 81/17. Indicazioni: 28/09/60.«Saggio sotto il lastricato nella F. Da -10 a -20 dalla ci-ma della fondazione degli ortostati. Terra battuta congrossi ciottoli e cocci».
zona nella quale non sembra conservato il livello del lastricato 79. Nell’edizione definitiva èinvece il ricordo di una brocchetta à la barbotine recuperata «entro a un rincalzo di piccoliblocchi collocati sotto alla base quadrata terminale della facciata a ortostati verso est», vasola cui posizione stratigrafica rispetto a tale facciata non risulta purtroppo perspicua 80.
Nonostante l’impossibilità di ricostruire le vicende precise del saggio, abbiamo rite-nuto utile esaminarne i materiali, che lasciano intravedere una sorta di sequenza dal MMIA al MM IB e ci siamo limitati a prendere nota della composizione dei diversi livelli,come propostici dalle collocazioni nel Museo Stratigrafico 81.
Un terzo saggio di un certo interesse riguarda la zona sotto le lastre del tratto meri-dionale della facciata, in corrispondenza del vano LXI. Qui fu isolato un muro a squadra(F) considerato resto di una struttura di contenimento, oppure di un ripostiglio «di etàsubmicenea», impiantato direttamente sul lastricato 82. Nella relazione preliminare (dove èdescritto il ‘vano’), non si fa cenno a saggi di approfondimento sotto le lastre, che furonoalmeno in parte effettuati alla fine di settembre del 1960 83.
Da questi saggi risulta una serie di livelli contrassegnati da brevi indicazioni dei carat-teri morfologici del terreno, con doppio riferimento al livello delle lastre ed a quello della«fondazione degli ortostati». Abbiamo qui preso in esame soltanto alcuni gruppi di fram-menti, fino ad una quota di -0,55 m. Il generalizzato e costante materiale MM IA, con qual-che frammento MM IB, conferma la proposta cronologica già illustrata per il primo saggio.In dettaglio, il gruppo fino a -0,10 m sotto le lastre 84 ( fig. 12) presenta diversi frammentidi vasi à la barbotine, con decorazione sia in bianco sia in rosso vino e rosso arancio e alcuniin ceramica fine verniciata di nero e sovradipinta, oltre a skoutelia del tipo ripreso manual-mente (acromi e dipinti). Il taglio successivo, fino a -0,20 m 85 ( fig. 13), conteneva parecchi
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA26
FIG. 12 – SAGGIO SOTTO LE LASTRE DEL TRATTO MERIDIONALE DELLA FACCIATA DELL’ALA SUD-OCCIDENTALE DEL PALAZZO,IN CORRISPONDENZA DEL VANO LXI. FRAMMENTI FINO A QUOTA -0,10 M SOTTO LE LASTRE.
FIG. 13 – COME SOPRA. FRAMMENTI DA QUOTA -0,10 A -0,20 M SOTTO LE LASTRE.
Creta Antica 8, 2007
86 Cfr. FIANDRA 1961-62, tav. IQ’, seconda fila,terzo da sinistra. Cfr. qui, fig. 1.
87 Collocazione MS col. 82/4. Indicazioni: 3/9/60.«Saggio sotto le ultime due pietre del lastricato verso l’ul-timo ortostate, fino a -55 dalla linea della fondazione».
88 Cfr. FIANDRA 1961-62, tav. IQ’, in alto a sinistra.89 LEVI 1976, p. 161.90 LEVI 1976, fig. 151. «Bastione II. Frammenti di
ceramica neolitica e H. Onouphrios da saggi attornoalla scalinata micenea a Ovest dell’ingresso al Bastio-
REVISIONI FESTIE 27
skoutelia del solito tipo, compreso uno scarto difornace, e materiale à la barbotine, fra cui un trat-to d’orlo di olletta ricoperta all’esterno di verni-ce nera, con decorazione a dischetti bianchi, fa-scette rosse ed archetti bianchi, riprodotto nellatavola pubblicata dalla Fiandra 86.
Da un ulteriore, piccolo saggio nella stessaarea, localizzato presso l’ultimo ortostate della fac-ciata, e fino a una profondità di -0,55 m 87, provie-ne un altro dei frammenti pubblicati dalla Fian-dra 88 ( fig. 14), decorato con elementi a S su fondoverniciato di nero, assieme a uno à la barbotine e ad
altri con semplici motivi lineari in bianco su fondo nero, tra cui i soliti skoutelia.Ancora un sondaggio fu effettuato dal Levi nell’area del Bastione II, al di sotto dei
resti di lastricato che battevano contro la parete del Bastione I; da qui vengono segnalati«solamente cocci pre-palaziali, assieme a pochissimi dell’inizio dell’età palaziale»89. Lafigura di rimando, tuttavia, propone soltanto frammenti di tipo Neolitico e di H. Onou-phrios, con una didascalia non pertinente, la quale rende dunque inutilizzabile la preziosaindicazione cronologica, dal momento che non siamo stati in grado di identificare, nelleraccolte del Museo stratigrafico, il gruppo di materiali in questione 90.
FIG. 14 – SAGGIO PRESSO L’ULTIMO ORTOSTATE VERSO SUD DELLA FACCIATA DELL’ALA SUD-OCCIDENTALE DEL PALAZZO.FRAMMENTI FINO A QUOTA -0,55 M DALLA LINEA DI FONDAZIONE.
FIG. 15 – PULIZIA ALL’ANGOLO NORD-EST DEL
PIAZZALE LXX, IN CORRISPONDENZA DEL VANO L.SKOUTELI F. 7367.
Creta Antica 8, 2007
Elementi utili per la datazione del Piazzale LXX e dell’adiacente settore del Palazzovengono infine da recenti lavori di pulizie o di restauro. In particolare, nel 1997, all’ango-lo nord-est del Piazzale, in corrispondenza del vano L, in un punto in cui mancavano lelastre ed al di sotto del loro livello, sono stati notati diversi tratti di stucco rosso, proba-bilmente scaricati in occasione della costruzione della portineria LVII e della possibileripresa del piano di lastre. Tra i materiali, oltre a un paio di intrusioni MM II, sono diver-si frammenti MM IB, ma anche MM IA. Merita di essere segnalato uno skouteli, quasi inte-ro, ma ricomposto da molti e minuti frammenti ( fig. 15), che proprio per questo potevaessere stato in rapporto con la collocazione delle lastre 91. Le caratteristiche del piccolo vasosono tipiche di un momento iniziale del MM IB e lo collegano all’interessante gruppo dimateriali recuperato nella banchina del vano lastricato sotto il Corridoio 7 92.
Un ultimo dato da connettere con la più antica vita dei vani disposti lungo la faccia-ta a ortostati sul Piazzale LXX abbiamo potuto acquisire nel 2004 93, sotto al livello dellelastre del pavimento del vano LVIII a, dove è stato recuperato un piccolo deposito di cera-mica 94 ( figg. 16-18). Esso comprende, tra l’altro, una serie di frammenti decorati, consuperficie à la barbotine o con l’uso della policromia, nonché un tratto di skouteli (F 8097;fig. 19) del tipo con vasca a carenatura pronunciata e fondo fortemente ristretto, che sem-bra aver avuto il suo sviluppo nel corso del MM IB. L’orizzonte ceramico si estende anchea residui AM I - II, virtualmente senza MM IA (forse solo il fondo di skouteli di fig. 20): cir-costanza alquanto atipica, considerato il quadro generale dei rinvenimenti nell’area e vero-similmente da riconnettersi a un episodio locale di risistemazione di qualche tratto delpavimento, in un momento (non più iniziale) del MM IB.
Perché l’assenza del MM IA in questa stessa area non risulti fuorviante, basti tuttaviaricordare i resti di un lastricato, forse di una piccola rampa, recuperati solo qualche annoprima al di sotto del vicino vano LXIV 95.
In conclusione, pur non essendo stati in grado di rintracciare i frammenti messi in rap-porto dal Levi direttamente con il momento di fondazione della facciata a ortostati anti-stante al Piazzale LXX, possiamo ragionevolmente assegnare agli inizi del MM IB la co-struzione di questo settore sud-ovest dell’edificio, sulla base delle risultanze del saggio sot-to le lastre. Proprio tale saggio, assieme a quello nell’area del ‘vano’ F, nonché il dettaglioriferito a proposito del vano LXIV, confermano l’intensità della frequentazione MM IAanche in questo settore basso della collina del Palazzo.
ne». Con didascalia praticamente identica lo stesso grup-po di frammenti è riprodotto in LEVI 1957-58, fig. 141.Nel testo, alla p. 288, si ricordano i residui di lastre del Piaz-zale LXX a ridosso dell’angolo nord-est del Bastione,ma non si fa alcun esplicito cenno a un saggio sotto diesse, laddove si legge: «dal livello del residuo di pavi-mento entro al Bastione, lo scavo ha ridato materialeassai primitivo, cioè – assieme sempre ad alcuni cocciMM – un buon numero di frammenti della categoria di H.Onouphrios e neolitici». Poco più sotto vengono attri-buiti a uno strato sopra un piano lastricato al limite ove-st del Bastione, e quindi assolutamente non in rapportocon il saggio sopra ricordato, «soltanto cocci MM me-scolati a una quantità di bei cocci pre-palaziali soprattut-
to del tipo H. Onouphrios, nonché neolitici» (p. 296).91 F. 7367, recuperato a m 1,50 dall’angolo ester-
no nord-ovest e a m 1,90 da quello sud-ovest delvano LVII, ad una quota di -0,40 m dal livello dellasoglia del vano LVI.
92 Vedi infra, p. 96s.93 Grazie alla cortese segnalazione della dott.ssa I. An-
tonakaki, della KG’ Eforia, responsabile dei lavori di re-stauro nel Palazzo, coadiuvata dalla dott.ssa A. Michelaki.
94 Collocazione: Mag. 7, cass. 869 p. Indicazioni (inNeogreco): «26/11/2004. Vano LVIIIa. Frammenti sot-to al livello del pavimento di lastre. Condotto di sco-lo delle acque piovane e pozzetto (gruppo 58)».
95 LA ROSA 2002, p. 714, fig. 749.
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA28
REVISIONI FESTIE 29
Creta Antica 8, 2007
FIGG. 16-18 – SAGGIO NEL VANO LVIII A. FRAMMENTI SOTTO AL LIVELLO DELLE LASTRE DEL PAVIMENTO.
FIG. 20 – SAGGIO NEL VANO LVIII A. SKOUTELI FRAMMENTARIO
RECUPERATO SOTTO AL LIVELLO DELLE LASTRE DEL PAVIMENTO.
FIG. 19 – SAGGIO NEL VANO LVIII A. SKOUTELI FRAMMENTARIO
F. 8097, RECUPERATO SOTTO AL LIVELLO DELLE LASTRE DEL PAVIMENTO.
FIG. 17
FIG. 18
2.3 I saggi lungo e presso la facciata ad ortostati del Piazzaleoccidentale I
Già il Pernier nel 1908 aveva effettuato un saggio nel-l’area del Piazzale I subito ad Ovest del dente della facciatain corrispondenza dei vani XI e XII, mentre di un altrosaggio «eseguito poco più a Sud, lungo il plinto del muro aortostati» fa solo un breve cenno descrivendo il primo 96.Appena a 0,10 m al di sotto delle lastre, il Nostro segnala-va i resti di un lastricato più antico. I «cocci dipinti conmotivi geometrici di epoca minoico primitiva» recuperatifra i due livelli, lo portarono ad attribuire a una qualche abi-tazione privata anteriore al Palazzo i resti del lastricato infe-riore. Sotto le lastre più basse viene segnalato materiale «di
impasto grossolano, fatto a mano, non levigato», tipico degli strati neolitici, che il Pernier pre-ferisce qui attribuire all’Eneolitico 97 per la presenza di un punteruolo di rame. L’impossibilitàdi controllare i materiali citati non consente, ovviamente, di esprimere alcuna ipotesi.
Ben più numerosi sono i dati ricavati dallo stesso Pernier sulla base dei saggi effettuatial di sotto dei livelli pavimentali del gruppo di ambienti del Palazzo subito a Est della fac-ciata a ortostati 98. A proposito del vano VIII non si fa, al riguardo, alcuna menzione 99; inuna foto con materiali di diverse provenienze ( fig. 21) viene tuttavia ricordata, a proposito
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA30
96 PERNIER 1935, p. 125.97 Loc. cit.98 Per una discussione su questo gruppo di dati,
vedi D. LEVI, Per una nuova classificazione della civil-tà minoica, in PP 71, 1960, pp. 85-89.
99 PERNIER 1935, p. 196.
Creta Antica 8, 2007
FIG. 21 – CERAMICHE DI DIVERSE PROVENIENZE DAI VECCHI SCAVI DI FESTÒS (DA PERNIER 1935).
FIG. 22 – VANO XII. OLLA SOTTO
IL PAVIMENTO (DA PERNIER 1935).
del nostro vano, una teierina ad ocarella, probabilmente già MM II, recuperata «nell’ap-profondire lo scavo sotto il pavimento del sacello VIII»100.
Per il vano IX sono invece menzionati due pavimenti sovrapposti, il superiore in stuc-co («coperto da uno strato di calce di color cinereo»), l’inferiore fatto a piccole lastre, 0,10m al di sotto del precedente 101. Una situazione parzialmente simile viene descritta per ilvano X, laddove, in riferimento ad una «fossa di saggio» sotto il livello pavimentale, siricorda la messa in luce delle fondazioni dei muri perimetrali, compreso l’ortostate, chescendevano fino a -0,40 m dal pavimento, ma che poggiavano «su lastre di calcare spesse0,05 m e sullo strato tardo-neolitico»102. Il dato assume particolare importanza se si consi-dera che le lastre conservate del Piazzale I legano certamente con la facciata ad ortostati,mentre quelle ricordate dal Pernier sotto un blocco di essa devono riflettere una sistema-zione più antica.
Resti di un pavimento «a più strati di calce dipinto in rosso lucente», ad una quotadi -0,10 m sotto il pavimento più tardo a stucco «cinereo» vengono segnalati all’internodel vano XII, munito di banchina e canale. La deduzione proposta è che, anteriormente allasua costruzione, esistesse «un piano uniforme, rivestito di stucco rosso, che fu più volte rin-novato»103. In un elenco di materiali «trovati nello strato minoico-primitivo», il Pernierattribuisce al vano in questione anche la nota olla con beccuccio aperto ( fig. 22), decorataa gruppi di trattini obliqui bianchi sulla spalla, tipicamente MM IA, trovata «nell’ap-profondire lo scavo sotto il pavimento del vano XII»104. Che si tratti di un’indicazionerispetto al piano di calpestio superiore, è dimostrato dal fatto che lo stesso Pernier procla-mava altrove l’appartenenza del pavimento di stucco rosso a «un edificio anteriore al pri-mo palazzo»105. L’indicazione appena ricordata, dato anche l’irrisorio dislivello tra i duepavimenti di stucco, autorizza dunque ad attribuire l’olla, e quindi il livello di calpestioinferiore, almeno al MM IA. Ci troveremmo, in altri termini, in una situazione analoga aquella già citata per il piccolo complesso di vasi al di sotto dei Magazzini XXXIV 106.
Un doppio piano pavimentale viene ricordato anche per il vano XIII, di color «cine-reo» il superiore con il suo corredo MM II, e dipinto in rosso l’inferiore, quest’ultimo a -0,28 m e con banchine 107.
Un riferimento ad un pavimento a lastre, al di sotto dei livelli MM II, riguarda i vaniXV e XVI, ad una quota di -0,80 m, lastre che «accennano ad aree scoperte»108.
Il pavimento lastricato dei vani XVII -XVIII sembrerebbe invece riferirsi all’ultimomomento di vita degli ambienti, «ad un livello di poco inferiore a quello degli altri pavi-menti» attigui 109.
Riprendendo complessivamente i dati dei diversi saggi sotto il Piazzale I e nei vanidell’ala ovest del Primo Palazzo, il Pernier li attribuisce senz’altro a «ruderi di uno o più
REVISIONI FESTIE 31
100 PERNIER 1935, p. 136, fig. 59, 4; già riprodottasenza specifiche indicazioni di provenienza in MALXIV, 1904, col. 490, fig. 93.
101 PERNIER 1935, p. 199.102 PERNIER 1935, p. 241.103 PERNIER 1935, p. 250.104 PERNIER 1935, p. 136, tav. XIII.105 PERNIER 1935, nota 50 a p. 393.106 Vedi supra, p. 13s.107 PERNIER 1935, pp. 251-252. La situazione stra-
tigrafica del vano è riproposta a p. 152.108 PERNIER 1935, p. 152. La profondità indicata
per questo piano di lastre appare in effetti quasi dop-pia rispetto a quella delle lastre del vano X, anche acausa del leggero pendio del terreno. È utile tuttaviaricordare che nel recente saggio al di sotto dell’atti-guo vano XIX, una tale quota corrisponderebbe già alivelli AM, se non addirittura neolitici.
109 PERNIER 1935, p. 268.
Creta Antica 8, 2007
edifici preesistenti», non escludendo che potessero appartenere ad «un unico fabbricato»,con il richiamo alla situazione di Vasilikì, dove era noto «un edificio abbastanza complesso,per abitazione signorile, già nel periodo minoico-primitivo»110. Egli si spinge ad ipotizzareche tale edificio si estendesse fino ai vani XXV e XXVII, attribuendogli anche il lastricatoinferiore rinvenuto nel saggio ad Ovest degli ortostati. Ne risulterebbe una sorta di pre-palazzo con un suo cortile ad Ovest, come appunto a Vasilikì. La pur scarsa suppellettilerestituita dai pavimenti nel livello inferiore, autorizzerebbe a far «risalire l’edificio all’età
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA32
110 PERNIER 1935, p. 151.
Creta Antica 8, 2007
FIG. 23 – PIAZZALE I. SAGGIO SUBITO A RIDOSSO DEGLI ORTOSTATI, IN CORRISPONDENZA DEI VANI X E XI,PIANTA E SEZIONE (DA LEVI 1976).
«minoico-primitiva avanzata»111. L’indicazione, per quanto generica, dovrebbe dunque costitui-re un immediato terminus post quem per la messa in opera del palazzo vero e proprio.
I diversi saggi Pernier nel settore ovest del Palazzo e subito al di fuori di esso propongo-no, in sintesi, una doppia situazione stratigrafica, nella quale i livelli al di sotto dei pavimentiMM II sono in qualche caso rappresentati da piani di stucco rosso e in altri da lastre (queste ulti-me a diverse profondità). Quanto ai materiali citati al di sotto dei livelli di calpestio superiori,l’unico vaso che sembrerebbe lecito mettere in rapporto con il pavimento di stucco sarebbe lacitata olla MM IA del vano XII ( fig. 22). Per la teierina ad ocarella del vano VIII ( fig. 21) restail dubbio se considerarla terminus ad quem per la messa in opera del livello superiore o per ladistruzione di un ipotetico inferiore, o addirittura per il rimaneggiamento in occasione dell’ag-giunta, subito ad Ovest, del sacello V.
Stucco e lastre insieme vengono segnalati nel saggio Levi del 1964, subito a ridosso degliortostati, in corrispondenza dei vani X e XI, e dunque in un’area assai vicina a quella del sag-gio Pernier 1908, ma in una stretta fascia all’interno del dente nell’allineamento della facciata,
dove il lastricato era assente ( fig. 23). La sequenza propo-sta 112 prevedeva, subito allo stesso livello del lastricato, uno«strato di calce grigiastra steso su un pavimento (scarsa-mente conservato) in stucco rosso, a sua volta posante su unasorta di lastricato a irregolari lastre e pietruzze»113. La rela-zione della responsabile di trincea consente di fissare rispet-tivamente a -0,05 m e a -0,10 m dal livello del lastricatosuperiore la profondità dei due livelli in questione 114. Per lasuccessione stratigrafica il Levi richiamava quella riscontra-ta dal Pernier nel saggio all’interno dell’attiguo vano IX,identificando in tal modo il livello di stucco «cinereo» conil suo di colore rosso: comparando, in definitiva, una sequen-za di tre strati con una di due. Sulla natura di questo lastri-cato inferiore il Levi dovette probabilmente nutrire qualche
perplessità, dal momento che nella relazione preliminare si legge di un «sottofondo a irregola-ri lastre e pietruzze», steso in funzione del soprastante stucco rosso 115. La «interdipendenza» frai due livelli di stucco e di lastre appare assente nella relazione definitiva, nella quale tuttavia loscavatore non afferma che il piano di lastre potesse riferirsi ad una sistemazione dell’intero piaz-zale. Le perplessità sembrerebbero riflettersi nella didascalia della fig. 527, nella quale il lastri-cato, dichiarato come sottostante a quello della III, non viene però attribuito a nessuna delle al-tre fasi protopalaziali. Un dato di grande interesse è rappresentato dalla menzione di una teieri-na à la barbotine ( fig. 24), «vaso rinvenuto immerso proprio nello stucco pavimentale» (rosso) 116,che appare tipica del MM IB, e dunque anteriore a quella già citata, al di sotto del vano VIII 117.
REVISIONI FESTIE 33
111 PERNIER 1935, pp. 151-152.112 Ripresa in DAMIANI INDELICATO 1982, pp. 103-105.113 LEVI 1976, p. 335, figg. 526 (con pianta e
sezione in scala assai ridotta) e 527; cfr. LEVI 1965-66, pp. 345-346, fig. 37, dove la tessitura del lastri-cato è meglio apprezzabile, con la sequenza dei livellisuperiori del saggio (calce grigia/stucco rosso/lastrine).
114 Relazione dott. A. Vaccaro 1964, p. 7.115 LEVI 1965-66, p. 345.
116 F. 4555: LEVI 1976, p. 335, tav. 30 g. A propositodello stesso vaso, già in PLATON 1968, non si escludeva,nonostante l’attribuzione stilistica (alla categoria di H.Photinì), che potesse assegnarsi all’ultimo momentodella fase di Patrikiès (p. 22, nota 1; vedi anche p. 27,nota 2). K. Polinger Foster (Minoan Ceramic Relief, Gö-teborg 1982, pp. 40 e 69), lo inserisce in un gruppodatato al MM IB.
117 Vedi supra, p. 31.
Creta Antica 8, 2007
FIG. 24 – PIAZZALE I. SAGGIO SUBITO A RI-DOSSO DEGLI ORTOSTATI, IN CORRISPON-DENZA DEI VANI X E XI. TEIERINA À LA
BARBOTINE F. 4555, DALLO STRATO DI
STUCCO ROSSO (DA LEVI 1976).
La mancanza, nell’area saggiata, del lastricato superiore potrebbe non essere casuale,dal momento che già il Pernier notava tra il vano VII e il dente della facciata corrispon-dente all’ XI (e quindi in una fascia comprendente anche il saggio Levi) «sul lastricato delpiazzale una zona ricoperta da uno strato di calce e sabbia, spesso tanto che, aderendo alplinto degli ortostati, ne ricopre per circa metà lo spessore»118. Egli proseguiva escludendoche tale livello di calce potesse rappresentare il resto di un pavimento per un vano, di cuisi sarebbero completamente perduti i muri perimetrali. Non abbiamo difficoltà a identifi-care lo «strato di calce e sabbia» del Pernier con quello di calce grigiastra del Levi. Saràforse il caso di pensare o ad una differente sistemazione del Piazzale in questo punto, oppu-re ad un rifacimento in occasione della messa in opera dei sacelli V-VII, quando forse si pre-vedeva di aggiungerne altri, fin quasi presso il dente della facciata. Il Pernier non segnalaun prolungamento del lastricato al di sotto dei vani VI e VII, come ci si sarebbe potutoattendere, trattandosi di locali aggiunti alla facciata ad ortostati 119. Nella pianta generaleStefani del primo ciclo di scavi l’area priva di lastre appare rettangolare, a parte l’appenairregolare delimitazione sul lato nord, dovuta alla forma trapezoidale del vano VII. Si trat-ta di uno spazio di 4,90/4,95 ! 1,50 m, il quale potrebbe anche suggerire l’idea, appuntoa causa della sua regolarità, che fosse stato deliberatamente lasciato privo di lastre, ondeospitare un qualche apprestamento subito adiacente alla base degli ortostati. La presenzadel lastricato inferiore nell’area del saggio Levi ci assicura (se di un livello dell’intero piaz-zale si fosse trattato) che analoga preoccupazione non dovette esserci in origine. Lo stuccorosso al di sopra del lastricato inferiore potrebbe allora indicare la sopravvenuta esigenza didelimitare un’area (risultata poi adiacente alla facciata), proprio nel momento della costru-zione di questa, o, più probabilmente, in corso d’uso del lastricato inferiore. Il danneggia-mento dello stucco rosso avrebbe poi comportato la sua sostituzione con quello «cinereo»,sicuramente già in presenza della facciata a ortostati.
Indipendentemente dall’esistenza e dalla funzione di un qualche apprestamento inquesto settore del Piazzale (tribuna o altare?), è opportuno ora passare in rassegna i mate-riali degli strati superiori del saggio Levi. Il livello superficiale 120 risulta caratterizzato daceramica del MM II apparentemente non finale, che dovrebbe datare la stesura della calcegrigiastra, dal momento che alcuni cocci erano addirittura incastrati dentro di essa. Nellafig. 25 sono riprodotti frammenti di tazze cilindriche, con fondo a spigolo ben definito; ditazze carenate; di orli di tazze emisferiche a parete sottile. Si segnalano, in particolare: unframmento di parete di tazza troncoconica con resti di decorazione a dischetti rosso aran-cio collegati da trattini obliqui con sovradipinture in bianco e con due fascette in basso,recante picchiettature bianche all’interno; un’ansa a nastro sottile di grossa tazza, o coppa;un tratto di orlo di olletta con resti del beccuccio, verosimilmente a ponte. Non mancaqualche residuo di materiale più antico, come un tratto di orlo ondulato, pertinente a unatazza con decorazione à la barbotine.
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA34
118 PERNIER 1935, p. 199.119 Per il pavimento del vano VII si fa riferimento
a «strati di calce» senza tuttavia precisare se si fossetrattato dello stesso impasto di calce e sabbia segna-lato all’esterno del vano (PERNIER 1935, p. 199). Peril vano VI si ricorda un pavimento «di lastre poligo-nali in calcare e schisto turchino coperte in origine
con intonaco di calce», ma si precisa che si tratta diun livello più alto di quello del vano VII e del piaz-zale lastricato (ivi, p. 203). Il vano V, infine, era or-mai nell’area della gradinata teatrale.
120 Collocazione: MS col. 68/18 (18a). Indicazioni:«Saggio 5. 10/9/64. Fino al battuto con stucco».
Creta Antica 8, 2007
REVISIONI FESTIE 35
Creta Antica 8, 2007
FIG. 25 – PIAZZALE I. SAGGIO SUBITO A RIDOSSO DEGLI ORTOSTATI, IN CORRISPONDENZA DEI VANI X E XI.FRAMMENTI DELLO STRATO SUPERFICIALE.
FIG. 26 – COME SOPRA. FRAMMENTI DELLO STRATO DAL LIVELLO DELLO STUCCO ROSSO FINO A QUELLO DEL LASTRICATO.
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA36
Creta Antica 8, 2007
FIG. 27 – PIAZZALE I. SAGGIO SUBITO A RIDOSSO DEGLI ORTOSTATI, IN CORRISPONDENZA DEI VANI X E XI.FRAMMENTI NELLO STRATO DAL LIVELLO DELLO STUCCO ROSSO FINO A QUELLO DEL LASTRICATO.
FIG. 28 – COME SOPRA. FRAMMENTI AL DI SOTTO DEL LASTRICATO INFERIORE.
I materiali dal livello dello stucco rosso 121 fino a quello del lastricato inferiore presen-tano un orizzonte in prevalenza MM IB ( fig. 26), con qualche MM IA ( fig. 27), parecchioAM e molto Neolitico. Questi frammenti datano l’abbandono del lastricato inferiore e lamessa in opera dello stucco rosso. Non è casuale che la loro cronologia si accordi con quel-la della teierina ricordata dal Levi come incastrata in tale stucco ( fig. 28). Un piccolo fram-mento eggshell (qui non riprodotto) con impressioni a punzone a forma di losanga conte-nente un ramoscello con fogliette, del MM II iniziale, assieme ad altri due più dubbi conresti di decorazione sovradipinta in bianco su fondo nero, potrebbe essere un’intrusione dallivello soprastante.
Nella fig. 26 sono illustrati: un frammento di orlo e parete di una lampada con feston-cini rilevati sulla faccia superiore dell’orlo 122; un fondo di skouteli parzialmente malforma-to e ripreso a mano; un tratto di bacino con decorazione sovradipinta in rosso su fondo nero(tre fascette orizzontali e motivo curvilineo non intelligibile) sulla superficie interna, soloparzialmente verniciato all’esterno; frammenti di due vasi (uno di forma aperta, l’altrochiusa, e precisamente un orlo di olletta) decorati nella tecnica a zone di vernice nera mar-ginata di rosso, con sovradipinture bianche.
Lo strato successivo 123 conteneva i frammenti al di sotto del lastricato inferiore, i qua-li pertanto ne datano la messa in opera. La maggioranza di essi è costituita da materialeneolitico, con molti cocci AM, un numero più limitato di MM IA, e, a parte alcuni incer-ti, almeno uno MM IB, che rappresenta dunque il terminus ad quem per il lastricato infe-riore. Qualsiasi deduzione cronologica va tuttavia confrontata col fatto che la tessitura pococompatta del lastricato inferiore potrebbe aver determinato un’intrusione dal soprastantelivello con tracce di stucco rosso, questo già assegnato al MM IB. Andrebbe altresì verifi-cata l’affermazione del Levi, il quale ricorda che al «livello più alto dei due battuti neoli-tici che concludevano la sequenza del saggio» si raccolsero «ancora frammenti ceramici del-la prima fase protopalaziale»124.
La fig. 28 riproduce quattro tratti di orlo di skouteli con le consuete striature orizzon-tali e un fondo con segni di ditate, assieme a un largo tratto del fondo di una teiera tipoPatrikiès ricoperto all’esterno di vernice rossiccia. Un unico frammento a parete spessa, conresti di vernice nera e fascia bianca sovradipinta all’esterno, sembrerebbe avvicinabile a pro-duzioni già del MM IB.
Prima di pronunciarci sul rapporto cronologico fra quest’unico coccio ed il lastricatopiù basso è forse meglio prendere in considerazione un altro saggio aperto dal Levi 125 sot-to il livello della pavimentazione del Piazzale I, ad una distanza di m 2,80 a Sud della gra-dinata del Teatro e a poco più di 21 m dalla facciata ad ortostati, entro una lacuna del lastri-cato stesso già indicata sulla pianta Stefani ( fig. 29).
REVISIONI FESTIE 37
121 Collocazione: MS col. 68/18 (18b). Indicazioni:«Saggio 5. 10/9/64. Dal livello inferiore del battuto a-0,05 fino al livello del placostrato di quota -0,10».
122 Cfr. un esemplare dai saggi sotto il vano 11 (L.MERCANDO, Lampade, lucerne, bracieri di Festòs, inASAtene 52-53, 1974-75, p. 35, n. 10, fig. 27) e, perla forma, uno del vano IL («piccole lampade» n. 5, p.47s., figg. 42 e 130).
123 Collocazione: MS col. 68/19 (19). Indicazioni:
«11/9/64. Saggio a W facciata 3° fase, da sotto il 1°lastricato trovato fino a -0,30 dal lastricato di 3° fase»[cartacea]. «F 64 Pz1/N. Sotto il livello del lastricatodi -0,10 (da -0,10 a -0,30 sotto il lastricato di III fase)»[lignea]. Grande quantità di frammenti neolitici,molti AM, numero più limitato di MM IA, pochissi-mi MM IB, alcuni incerti.
124 LEVI 1976, p. 336.125 LEVI 1976, pp. 333-334, figg. 523-524.
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA38
Creta Antica 8, 2007
FIG. 29 – PIAZZALE I. SAGGIO SOTTO IL LIVELLO DELLA PAVIMENTAZIONE A SUD DELLA GRADINATA DEL TEATRO (DA LEVI 1976).
FIG. 30 – PIAZZALE I. IL SAGGIO DELLA FIGURA PRECEDENTE, SECONDO LA RICOSTRUZIONE DI S. DAMIANI INDELICATO (DA AJA 1984).
Il Levi segnalava un lastricato inferiore con lastrine «di dimensioni minori […] limi-tato da un grosso muraglione di andamento arcuato», che si impostava direttamente sullaroccia 126. La profondità del lastricato inferiore, a quota -0,20 m dal superiore, si ricava dal-la relazione della responsabile di trincea 127. Questo tratto di lastricato e il suo muro di limi-te arcuato rappresenterebbero quanto resta di una sistemazione di I fase protopalaziale,meno estesa della successiva, la quale dalla svolta sul pianerottolo dell’angolo sud-ovest delPiazzale 128 sarebbe salita in ripido pendio fin presso la gradinata del Teatro 129. La cronolo-gia del lastricato inferiore sarebbe suggerita dal fatto che gli «strati superiori accanto almuro» avrebbero restituito «frammenti ceramici della I fase protopalaziale», mentre «piùsotto», si sarebbe raccolta ceramica prepalaziale e neolitica 130.
Qualche anno dopo la pubblicazione del Levi, S. Damiani Indelicato è tornata sull’ar-gomento 131 e, ritenendo il rilievo delle lastre effettuato da Stefani più attendibile di quel-lo di R. Oliva (il disegnatore degli scavi Levi, che si trovò a rilucidare anche le strutturegià comprese nella pianta precedente), ha ipotizzato che il tratto di muro arcuato rappre-sentasse il resto di una kouloura più antica, da porsi in relazione con uno spazio unpaved, poisigillata dal lastricato inferiore ( fig. 30). Quest’ultimo, simile come livello e come compo-sizione a quelli dei saggi Levi presso la facciata ad ortostati e Pernier sotto il vano IX,sarebbe anteriore al MM IIA (sulla base della proposta cronologica della Fiandra per il set-tore superiore della facciata a ortostati) e assegnabile al più tardi al MM IA (sulla scorta diun’approssimativa interpretazione delle indicazioni del Levi relative al lastricato inferioredel saggio presso gli ortostati). Con questa sistemazione coinciderebbe la messa in opera del-la gradinata teatrale, che dovrebbe confermare l’ipotesi della Damiani Indelicato circa l’e-sistenza di un centro civico (agorà) anteriormente alla costruzione del palazzo, rappresen-tata quest’ultima dalla facciata ad ortostati. Ma una cronologia al MM IA del lastricato cheavrebbe colmato la presunta kouloura costringerebbe a proporre per quest’ultima una data-zione ancora più antica, nella migliore delle ipotesi sempre all’interno del MM IA, propo-sta difficile da sostenere. È necessario dunque entrare nel merito delle diverse affermazio-ni, sia dal punto di vista cronologico che stratigrafico e funzionale.
Il rilievo planimetrico della fig. 523 del Levi ( fig. 29), certamente corsivo, propone inmaniera netta soltanto la faccia esterna del muro arcuato; assai meno decisa è infatti l’in-dicazione della faccia interna, per uno spessore ricostruibile intorno a 0,60 m. Quanto poial supposto lastricato circoscritto dal muro, la sua resa grafica richiamerebbe piuttostoquella di un livello di pietre o al massimo di un acciottolato, come risulterebbe anche dal-la foto di fig. 524. Il rendimento per le supposte lastre nella ricordata planimetria Olivaequivarrebbe a quello del sacco interno del muro arcuato. Il confronto, poi, fra la foto dellastricato inferiore presso la facciata a ortostati e quella del presunto tratto presso il muroarcuato, evidenzia una maggiore regolarità del primo e rende per lo meno problematico uncollegamento dei due tratti. Il riempimento di una costruzione circolare preesistente avreb-be certamente, a livello sommitale, consentito di distinguere l’originaria faccia interna,
REVISIONI FESTIE 39
126 LEVI 1976, p. 334; cfr. LEVI 1965-66, p. 344,fig. 36.
127 Relazione dott. A. Vaccaro 1964, p. 6. Nella pub-blicazione definitiva il valore proposto è «di solo unadiecina di centimetri o poco più» (LEVI 1976, p. 333).
128 Vedi infra, p. 50.
129 LEVI 1976, p. 334.130 Loc. cit.131 S. DAMIANI INDELICATO - M. CHIGHINE, A New Kou-
loura at Phaistos, in AJA 88, 1984, pp. 229-230, figg.1-2 (con una nuova proposta planimetrica); DAMIANI
INDELICATO 1982, pp. 101-102.
Creta Antica 8, 2007
come non sembra invece essere avvenuto. Lanostra ipotesi è dunque che il muro arcuato nonpossa essere interpretato come resto di una kou-loura e che il livello di pietre al suo interno nonfosse stato un canonico lastricato. Elementi stra-tigrafici sui quali sarà utile ritornare 132 rendonoimpossibile una contemporaneità tra il suppostolastricato inferiore e la gradinata teatrale. Il muroarcuato (la cui curva dovrebbe essere meglio deter-minata sulla base di un nuovo e più accuratodisegno) poggiante, come già detto, sopra la roc-cia, potrebbe allora rappresentare il limite di unasorta di piattaforma o più ampia area in terra
battuta, con un piano di allettamento costituito dal livello di pietre e ciottoli.Sarebbe stato essenziale, in una tale prospettiva, poter determinare la cronologia del-
l’apprestamento collegabile al muro arcuato: ma il fatto che nessuna distinzione stratigrafi-ca fosse stata fatta nella raccolta dei cocci, rende vana l’aspettativa. Per l’unico gruppo diframmenti disponibile i livelli di riferimento sono ai due lastricati, in un contesto con mol-to MM IA, un paio di cocci MM IB ed altri più antichi 133. Abbiamo potuto distinguere, fra
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA40
132 Vedi infra, p. 41.133 Collocazione: MS, col. 68/18 (17). Indicazioni: «7-
8 settembre 1964. Piazzale I -Nord. Saggio davanti al tea-tro, dal placostrato di III fase al placostrato di I fase».
Creta Antica 8, 2007
FIG. 31 – PIAZZALE I. SAGGIO SOTTO IL LIVELLO DELLA PAVIMENTAZIONE A SUD DELLA GRADINATA DEL TEATRO.FRAMMENTI NELLO STRATO TRA I DUE LIVELLI DI LASTRICATO.
FIG. 32 – COME SOPRA. DUE FRAMMENTI MM I BCON DECORAZIONE À LA BARBOTINE.
i materiali MM IA ( fig. 31): un tratto della parte inferiore di grande bacino verniciato solointernamente in nero, con fascia bianca attorno al fondo; due frammenti di orlo, sempre digrande piatto o bacino, uno con archetti incrociati e doppia fascetta orizzontale all’iniziodella vasca, un altro con decorazione bianca su fondo rossiccio (costituita da trattini obliquisull’orlo e doppia fascetta all’inizio della vasca); un orlo di vaso aperto, a vasca profonda, contracce di decorazione lineare in bianco (coppie di tratti obliqui combinati con dischetti); unframmento di parete di brocca con nervature oblique a rilievo seghettate e resti di policro-mia (fascette oblique rosso vino marginate di bianco, che seguono l’andamento delle nerva-ture); due orli di skoutelia del tipo con coppia di fascette in bianco su fondo verniciato scu-ro; un frammento di teiera con decorazione in rosso su fondo nero; un altro di parete, pro-babilmente anche questo di teiera, con zona à la barbotine (di argilla più fine applicata e deco-rata a costolature verticali e lasciata risparmiata su un fondo nero); alcuni frammenti di ollae di olletta con decorazioni lineari bianche oblique e incrociate su fondo bruno rossiccio.
Databile al MM IB ( fig. 32a) è un tratto di grande vassoio decorato internamente confasce in rosso e puntini in bianco, recante sul fondo esterno non verniciato e lasciato grez-zo i resti (due tratti paralleli) di una marca da vasaio del tipo a rilievo. Un altro frammento( fig. 32b) di parete di vaso di forma chiusa (verosimilmente brocchetta) presenta una super-ficie increspata con fondo nero e resti di decorazione sovradipinta in rosso. Quest’ultimaindicazione cronologica (MM IB) costituisce dunque, pur in assenza delle lastre superiori,un terminus post quem per il tratto di lastricato non conservatosi, mentre potrebbe rappre-sentare il momento di obliterazione per l’«acciottolato» inferiore. L’irrisoria presenza dimateriale di questo periodo potrebbe forse autorizzare a supporre cha la messa in opera dellivello più antico risalisse già al MM IA.
Un impianto di quest’ultima fase si riferirebbe, come avremo occasione di vedere 134,ad una situazione anteriore alla creazione del piazzale del palazzo; una datazione al MM IB,invece, prospetterebbe una sistemazione iniziale non unitaria del piazzale stesso, a causadella notevole differenza di tessitura con il lastricato dell’angolo sud-ovest. Un’interpreta-zione come piattaforma o area circoscritta di terra battuta, infine, dovrebbe far pensare auno spazio destinato a specifiche liturgie, ereditate poi dal Piazzale del Teatro.
Riprendendo adesso le osservazioni cronologiche a proposito del saggio presso la fac-ciata ad ortostati, ci si avvede che le incertezze sopra manifestate 135 riguardano gli stessiambiti cronologici di quelli del saggio presso la gradinata del Teatro.
Se l’unico coccio sicuramente MM IB segnalato al di sotto del lastricato inferiore pres-so gli ortostati fosse stato in giacitura primaria, dovremmo ritenere questo livello di cal-pestio come la prima sistemazione relativa al palazzo più antico. Se invece esso fosse da con-siderare un’intrusione attraverso le maglie larghe della tessitura delle lastre, potremmoassegnare al MM IA questo settore del Piazzale, forse insieme con l’acciottolato presso ilmuro arcuato. Entrambi gli apprestamenti occupano il lato settentrionale del Piazzale erisultano molto meno curati rispetto ai tratti di lastricato all’angolo sud-ovest di questo.Una generalizzata datazione al MM IA coinvolgerebbe da un lato i già citati livelli di inten-sa frequentazione nell’area al di sotto dell’ala occidentale del primo Palazzo, e dall’altro ilraddrizzamento della rampa inferiore ascendente dall’area del Piazzale LXX, raddrizzamen-to per il quale abbiamo già avuto modo di prospettare una tale indicazione cronologica 136.
REVISIONI FESTIE 41
134 Vedi infra, p. 111.135 Vedi supra, p. 33.
136 CARINCI -LA ROSA 2002, pp. 874-875.
Creta Antica 8, 2007
2.4. Il saggio all’interno del vano XIXIndipendentemente dalla cronologia appena discussa del lastricato inferiore presso gli
ortostati o dell’acciottolato presso la gradinata teatrale, visto che nessuna di queste duesistemazioni può essere collegata con la facciata monumentale, è necessario a questo puntochiedersi quale fosse la situazione della fronte occidentale del primo Palazzo in un momen-to anteriore a quella realizzazione.
Un’inattesa e fortunata risposta viene da un saggio effettuato nell’estate del 2004all’interno del vano XIX, a ridosso delle fondazioni (a grossi blocchi appena sbozzati) del-la facciata occidentale del secondo Palazzo 137.
Il Pernier ne aveva portato in luce quattro filari, da lui appunto attribuiti all’edificiopiù recente 138. Le assise si sono invece rivelate cinque, le due inferiori certamente più scon-nesse ed aggettanti rispetto alle superiori. L’individuazione di tre tagli di fondazione e deirispettivi riempimenti ha rivelato la successione di tre differenti edifici che, a giudicaredalle dimensioni più o meno equivalenti dei blocchi, vanno attribuiti a strutture monu-
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA42
137 V. LA ROSA, I saggi della campagna 2004 a Festòs,in ASAtene LXXXII (sr. III, 4), II, 2004, p. 611ss.
138 PERNIER 1935, pp. 271-275; blocchi di fonda-zione: ivi, sez. a tav. III.
Creta Antica 8, 2007
FIG. 33 – SAGGIO NEL VANO XIX. SEZIONE A-A’ (RIL. B. SALMERI).
REVISIONI FESTIE 43
Creta Antica 8, 2007
FIG. 34 – SAGGIO NEL VANO XIX. FRAMMENTI DALLO STRATO 20.
FIG. 35 – COME SOPRA. FRAMMENTI DALLO STRATO 19.
mentali ( fig. 33; sez. A-A’). La trincea T/1, colmata con gli strati 3, 9 e 6, si riferisce ai trefilari di fondazione del secondo Palazzo, con materiali prelevati da livelli più antichi, dalmomento che i frammenti più tardi non scendono oltre il MM IIB. La trincea era stata rica-vata in un possente strato di calcestruzzo-astraki (strati 8a-d), del tutto simile e verosi-milmente coevo (con frammenti del MM IIB) a quello riscontrato dal Pernier nei vani aridosso della fronte ad ortostati e dal Levi nel quartiere sud-occidentale del primo Palazzo.
Il taglio T/4, colmato dallo strato 19, era in funzione del quarto filare (con il piede aquota 0,00), separato dal superiore mediante una sottile (0,10/0,18 m) intercapedine diterra corrispondente agli strati 12 e 10. La sua trincea di fondazione aveva tagliato un livel-
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA44
Creta Antica 8, 2007
lo pavimentale (nell’interfaccia fra gli strati 18/20), relativo al vano XIX, originariamentein stucco, con un rifacimento in lastre e con l’aggiunta di banchine, proprio come segnala-to nel vano VIII 139. All’ultimo rifacimento del pavimento vanno riferiti i pochi vasi del cor-redo MM IIB recuperati dal Pernier. Un paio di frammenti MM II raccolti nel livello sot-tostante (strato 20; fig. 34) rappresentano invece un preciso terminus ad o post quem per laprima stesura del pavimento (fase nella quale forse XV e XIX costituivano un unico, gran-de vano) ed, indirettamente, per la facciata ad ortostati sulla quale l’ambiente fin dall’ini-zio si apriva.
La terra della trincea di fondazione (strato 19; fig. 35) relativa al quarto filare prove-niva da livelli assai più antichi: restituì infatti materiali neolitici, diversi AM, e molti MMIA, con pochi MM IB fra cui uno skouteli quasi intero ( fig. 36), ed un unico coccio di taz-zina carenata MM II, che costituisce l’indicazione cronologica più recente (da aggiungere,ovviamente, a quella della rimozione del pavimento con il corredo MM IIB dello scavoPernier).
Il quarto filare di sottofondazione risulta addirittura più cospicuo di quelli del secon-do Palazzo. L’ipotesi avanzata dallo scavatore è che esso fosse in rapporto con un momen-taneo progetto di ricostruzione del palazzo, dopo la distruzione della facciata ad ortostati,lungo una linea assai più ad Est, la quale sarebbe poi stata ripresa per l’edificio più recen-te. Il progetto sarebbe stato abbandonato in corso d’opera e, con lo stesso cantiere, si sareb-be deciso di riproporre la vecchia fronte ad ortostati, provvedendo, come segno di un’avve-nuta «restaurazione», ad aggiungere ad essa i sacelli V-VII. Saremmo, in altri termini, nel-l’ambito di quella ristretta fase cronologica che è stata, appunto, chiamata «dei Sacelli»140.
La trincea di fondazione T/4 aveva tagliato, oltre al pavimento del vano, anche unsemplice piano di calpestio (interfaccia strati 20/22), la cui datazione è fornita dai pochiframmenti del sottostante strato 22 (con materiali ancora una volta assai più antichi, neo-litici ed AM I, e con un solo coccio MM IB).
Il quinto filare di fondazione, in rapporto con il taglio T/5, era costituito da un pos-sente blocco angolare, alto 0,65 m, appena inclinato e sporgente dal quarto, con sommitàa quota 0,00. Data la ristrettezza dell’area saggiata si poté accertare solamente che esso con-tinuava con alcune zeppe e riprendeva con un secondo blocco verso Nord, tanto da far sup-porre un sicuro allineamento.
La trincea di fondazione T/5 era stata colmata con gli strati 24 e 26 (e con l’equiva-lente 48, lungo la faccia sud); sulla terra di quest’ultimo il blocco angolare in parte pog-giava; aveva attinto livelli neolitici e parzialmente asportato un muro AM I.
Lo strato 24 restituì materiale particolarmente abbondante, in prevalenza neolitico,con diversi AM, alcuni MM IA e qualche MM IB (come un tratto di orlo e spalla di broc-chetta à la barbotine ed un’ansa verniciata di nero con resti di decorazione sovradipinta inbianco) ( fig. 37). Agli inizi del MM IB vanno probabilmente collocati tre skoutelia (F 8031,8037, 8038; fig. 38 ), uno dei quali praticamente integro, che hanno precisi confronti conil gruppo di quelli rinvenuti nella banchina all’interno della grande sala lastricata sotto ilCorridoio 7 141. Sotto al 24, lo strato 26 (fino alla base di T/5), era caratterizzato da fram-menti in egual misura neolitici ed AM, con due larghi tratti di skoutelia MM IA e con unframmento di orlo (sempre di skouteli) MM IB.
139 Vedi supra, p. 30s.; PERNIER 1935, p. 196.140 Vedi infra, p. 86.
141 Vedi infra. p. 96s.
Le risultanze stratigrafiche consentono, inconclusione, di assegnare ad un momento inizia-le del MM IB la messa in opera del monumenta-le edificio cui si riferivano le sottofondazioni delquinto filare.
Tale edificio non poteva non essere, secondol’ipotesi dello scavatore, che il primo Palazzo nellasua sistemazione originaria, contemporanea a quel-la del settore meridionale. Il livello identificato fragli strati 20 e 22, coincidente in maniera sorpren-dente con la base dell’euthynteria della facciata adortostati, avrebbe potuto rappresentarne, in teoria,il calpestio esterno: ma il dislivello di quota rispet-to alla sommità del blocco di sottofondazione (unaventina di cm), rende l’ipotesi piuttosto improba-bile, essendo il blocco superstite solo il più basso diuna fondazione, per la quale è lecito prevedere
almeno un filare superiore di eguale altezza. Il battuto 20/22 potrebbe dunque rappresentarela situazione subito anteriore alla messa in opera del quinto filare di sottofondazione.
Le alternative all’ipotesi ‘palaziale’ per il filare in questione non sono sembrate piùconvincenti. Una costruzione massiccia del tipo dell’Early Keep di Cnosso 142 avrebbe posto
REVISIONI FESTIE 45
142 Cfr. K. BRANIGAN, The Early Keep, Knossos, in BSA 87,1992, pp. 153-163 (che ne propone una datazione alMM IB); J.A. MACGILLIVRAY, The Early History of the Pa-
lace at Knossos (MM I-II), in Knossos. A Labyrinth of Histo-ry. Papers in honour of Sinclair Hood, D. EVELY, H. HUGHES-BROCK and N. MOMIGLIANO edd., London 1994, p. 49 ss.
Creta Antica 8, 2007
FIG. 36 – SAGGIO NEL VANO XIX. SKOUTELI
F. 8030, DALLO STRATO 19.FIG. 37 – SAGGIO NEL VANO XIX. FRAMMENTI
DALLO STRATO 24.
FIG. 38 – COME SOPRA. SKOUTELIA F. 8031, 8037 E 8038, DALLO STRATO 24.
FIG. 39 – SAGGIO SOTTO IL VANO NEOPALAZIALE 13.BROCCA F. 8036, DA UN DEPOSITO DI FONDAZIONE.
il grave problema del rapporto con la facciata del palazzo del cortile inferiore LXX sicu-ramente già esistente.
Resta l’impossibilità di accertare, data la limitatezza dell’area saggiata, se il progettofosse stato realizzato. Non è in ogni caso ragionevole pensare che esso fosse stato abbando-nato in favore della assai più tarda facciata ad ortostati, dal momento che parecchi dati con-cordano, in questa terrazza superiore, a favore dell’esistenza di sistemazioni monumentalidurante il MM IB. Una testimonianza significativa in tal senso verrebbe anche da un depo-sito di fondazione identificato recentemente al di sotto del vano 13 143: la brocca F 8036,recuperata integra, rappresenta un bell’esempio del primo affermarsi della ceramicaKamares in un momento fra la fine del MM IA e gli inizi del MM IB ( fig. 39).
3. - Le fasi architettoniche e cronologiche del Piazzale occidentale I
Le possibilità di sistemazione prospettate per la fascia settentrionale del Piazzale I nelsuo momento più antico, spingono adesso ad affrontare un’altra vexata quaestio della rico-struzione leviana, quella dell’angolo sud-ovest del medesimo e del suo raccordo con laRampa ascendente dal Piazzale LXX. Il nostro punto di partenza è rappresentato, per que-sto settore, proprio dalla revisione cronologica recentemente effettuata sulle fasi di talerampa, la più antica già della fine del periodo AM III, poi ripresa e leggermente rialzata
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA46
143 LA ROSA, I saggi della campagna 2004, cit. a nota 137, p. 644, figg. 141-142.
Creta Antica 8, 2007
FIG. 40 – PANORAMICA DELL’AREA DALLA VASCA XXX ALLA KOULOURA I. Da Nord.
REVISIONI FESTIE 47
Creta Antica 8, 2007
FIG. 41 – PIAZZALE I, ANGOLO SUD-OVEST. VEDUTA DELL’AREA INTORNO ALLA KOULOURA I, CON I MURI 35 E 37,L’APPRESTAMENTO DEL BETILO E TRATTI DI LASTRICATO PERTINENTI ALLE DIVERSE FASI. DA SUD-EST.
FIG. 42 – PIAZZALE I, ANGOLO SUD-OVEST. PARTICOLARE DEI MURI 35 E 37. DA SUD.
nell’ambito del MM IA. Il piano argilloso, o di stucco, sovrapposto alla rampa inferiore puòessere assegnato al MM IB; nel corso dello stesso periodo sarebbe stata costruita la rampamediana, mentre in un momento non finale del MM II sarebbe stata sistemata la superiore 144.
Un altro punto di riferimento è costituito dai risultati dei saggi del 2001 nell’area del-la cosiddetta Strada dal Nord, dove è stato possibile proporre un livello stradale già forsein un momento di passaggio fra MM IA e MM IB, una serie di almeno quattro battuti stra-dali nel corso del MM IB e di almeno tre durante il MM II, con possibilità di raccordo traquesti livelli stradali, i resti di lastricato al di sotto della fornace e le varie fasi della ram-pa ascendente dal Piazzale LXX 145.
Il settore in questione ( fig. 40; piante quotate di tavv. A e B) costituiva l’estremo limi-te occidentale dello scavo del Pernier, che aveva già messo in luce la Vasca XXX, «con ilfondo più basso di 70 cm rispetto al lastricato del piazzale», definendola vasca per ablu-zioni piuttosto che abbeveratoio, con le pareti e il fondo intonacati in stucco di calce finebianca146. La Kouloura XXIX (poi dal Levi indicata come «Kulura I»), denominata ora«bacino» ora «pozzo», risultò costruita su livelli di «cocciame rozzo, monocromo, di aspet-to neolitico», mentre all’interno apparve riempita «alla rinfusa di frammenti di vasi mediominoici», con qualche sporadico «coccio dipinto di epoca minoico-primitiva». Questoriempimento dovette essere effettuato «tutto in una volta, o per la costruzione dell’adia-cente cisterna, o per la ricostruzione del palazzo, verso la fine del periodo medio minoico».In quella stessa occasione sarebbe stata interrata anche la Vasca XXX con «cocciame mediominoico, come quello trovato tra il lastricato del piazzale primitivo e la gettata di calce-struzzo con cui si sollevò il livello del piazzale stesso per il secondo palazzo»147.
Tra le strutture scavate dal Pernier, coinvolgenti la sistemazione del settore sud-ovestdel Piazzale I, è necessario ricordare anche il tratto occidentale del muro nord-ovest/sud-est ( figg. 41- 42) che dalla Vasca XXX muoveva verso la Kouloura (XXIX), da lui conside-rato ellenico 148.
Ripulendo la Vasca XXX, il Levi mise in luce per intero questo muro, oltre ad una ram-pa di stucco bianco (subito a Nord della vasca, fig. 43) che andava stranamente a perdersilungo la faccia sud del Bastione occidentale 149. La ricostruzione delle fasi in questo angolosud-ovest del Piazzale da lui proposta era ancora una volta in linea con la sua tripartizionedel periodo protopalaziale. In dettaglio, le conclusioni del Levi 150 sono basate su tre saggi discavo del 1964 e su uno (o due) preparatori del 1963, tra loro strettamente collegati.
Già nella relazione preliminare, le sue proposte riflettono un’elaborazione articolata eargomentata, con affermazioni volte a rivoluzionare, secondo gli intenti dello studioso, lecorrenti formule evansiane 151. Riassumendo le sue osservazioni sulle vicende dell’area, con-
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA48
144 CARINCI -LA ROSA 2002.145 LA ROSA 2002, pp. 716-736 (tabella riassuntiva
alla p. 735).146 PERNIER 1935, pp. 179-181.147 PERNIER 1935, pp. 181-183. Il Pernier non
escludeva che potesse risalire ad età minoica anche lacisterna attigua alla Kouloura (XXIX) e ad essa poste-riore per motivi di sovrapposizione, utilizzata comun-que «in epoca ellenica». Si tratta, come è noto, di unapprestamento del periodo ellenistico. Altrove, la«piccola cisterna rotonda» viene senz’altro annovera-
ta fra le strutture «elleniche o ellenistiche» (p. 179).Sulla composizione del riempimento nella Vasca XXXe nella Kouloura XXIX il Pernier ritorna esplicita-mente alla p. 214: «in grande prevalenza materialemedio minoico II e III il quale attestava non differen-ti scarichi a intervalli di tempo, ma un unico scaricoper colmata, simultaneo a quello del piazzale».
148 PERNIER 1935, p. 179.149 LEVI 1976, p. 331 e fig. 497.150 LEVI 1965-66, pp. 338 e 342-346.151 LEVI 1965-66, pp. 336-337.
Creta Antica 8, 2007
REVISIONI FESTIE 49
Creta Antica 8, 2007
FIG. 43 – PIAZZALE I. VEDUTA DELLA FASCIA OCCIDENTALE CON IL MURO DI LIMITE, IL TRATTO DI RAMPA STUCCATA,LA VASCA XXX E I MURI 33, 34, 36 E 37. DA SUD.
FIG. 44 – PIAZZALE I. VEDUTA DELL’INTERA SPALLETTA 36, COMPRESO L’ANGOLO SUD-EST DELLA VASCA XXX. DA SUD-EST.
siderata da sempre nevralgica per la funzionalità del palazzo, egli ipotizza che nella I fasepiazzale e rampa ascendente avessero formato «un tutto unico» con dimensioni minoririspetto alle realizzazioni successive e con un possibile limite nord rappresentato dal muroarcuato di cui si è già detto 152. Nella II fase, quella della Vasca XXX, ma anche delle Kou-loures, ci sarebbe stato il grande ampliamento del Piazzale, con la creazione dei gradini delTeatro e (si dovrebbe dedurre) anche con la facciata a ortostati, che difficilmente può esse-re disgiunta da quei gradini e che tuttavia, nella ricostruzione leviana, è assegnata alla IIIfase. Nell’angolo sud-ovest del Piazzale sarebbe stato creato un secondo livello di lastre perattenuare il pendio, con un nuovo muro di spalla al limite sud. Nella III fase si sarebbe infi-ne realizzata, sempre all’angolo sud-ovest, una breve gradinata, con un restringimento del-l’ingresso e con un nuovo «divisorio», che ne avrebbe sostituito uno più basso, nel trattotra la vasca e la Kouloura.
Maggiori dettagli vengono forniti nell’edizione definitiva 153, come quello di un muret-to di spalla o divisorio, anche per la I fase: si tratterebbe di una modesta struttura 154 conandamento Sud-Ovest /Nord-Est, meglio conservata in corrispondenza dell’angolo sud-estdella Vasca XXX ( fig. 44). Il discorso, perspicuo ed esplicito per quel che riguarda le spal-lette ed il pianerottolo all’angolo sud-ovest, non lo è altrettanto per i lastricati dell’interopiazzale. Chiara appare l’identificazione di quello inferiore, sia nella zona della rampa, siain quella del muro arcuato. Più sfuggente è la situazione del lastricato di II fase, che nonviene mai ricordato al di sopra dello sbocco meridionale della lacuna nel tessuto delle lastre( fig. 45), già identificata e restaurata dal Pernier (che la aveva considerata un canale dideflusso delle acque 155). In un saggio al di sotto delle lastre restaurate e di un muretto dilimite moderno costruito dal primo scavatore, la responsabile di trincea dell’anno 1964afferma esplicitamente che «il cosiddetto canale di scolo non è tale, ma il lastricato che necostituisce il fondo è precedente e sottoposto a quello di III fase, come mostrano alcune pie-tre che si infilano al di sotto»156.
L’elemento di maggiore evidenza per il lastricato mediano di II fase è comunque rap-presentato dal «pianerottolo» proprio allo sbocco della rampa ascendente ( fig. 46), rimastoin uso nella fase successiva con la semplice sovrapposizione dei tre gradini 157.
Parte della documentazione fotografica proposta per la II fase (come quella di fig. 518)lascia il ragionevole dubbio che tratti del lastricato intermedio siano la continuazione diquello superiore a Nord ed a Sud del marciapiede soprelevato che dovette, per necessitàcostruttiva, essere messo in opera per ultimo. Lo stesso può dirsi per i tratti di lastricatoriprodotti alla fig. 520, in corrispondenza del settore restaurato dal Pernier, lì dove il livel-lo di II fase dovrebbe essere comprovato dalla semplice sovrapposizione del marciapiede.Alla fig. 521, poi, il supposto tratto di II fase non tiene conto del rapporto stratigrafico conla Kouloura (I) e lascia quindi sospettare un’assimilazione con il livello superiore delle lastre.
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA50
152 Vedi supra, p. 39.153 LEVI 1976, pp. 329-333; piante e sezioni: tavv.
X, Y, W.154 Probabilmente quella lasciata senza indicazio-
ne del colore di fase (per una svista redazionale) nel-la tavola X, per cui cfr. LEVI 1976, p. 333.
155 PERNIER 1935, p. 177.156 Relazione della dott. A. Vaccaro 1964, p. 2. L’af-
fermazione dell’esistenza di lastre in questo saggio
sembrerebbe in netto contrasto con quella in LEVI
1976, p. 333 ( «qui non esisteva più alcun lastricato,né della rampa né di un adiacente piazzale»), sempreche si tratti del riferimento allo stesso saggio. Le deno-minazioni dei muri alle nostre tavv. A e B ripropongo-no quelle stabilite dalla stessa dott. Vaccaro e dal pre-cedente responsabile di trincea, dott. F. Nicosia.
157 LEVI 1976, p. 331.
Creta Antica 8, 2007
REVISIONI FESTIE 51
Creta Antica 8, 2007
FIG. 45 – PIAZZALE I. AREA DELLA LACUNA NEL TESSUTO DELLE LASTRE, RITENUTA DAL PERNIER UN CANALE
DI DEFLUSSO DELLE ACQUE. DA SUD.
FIG. 46 – PIAZZALE I, ANGOLO SUD-OVEST. AREA ALLO SBOCCO DELLA RAMPA ASCENDENTE DAL PIAZZALE LXX:IL «PIANEROTTOLO» E I TRE GRADINI SOVRAPPOSTI; IN BASSO IL MURO 33. DA NORD.
Rimane, infine, l’incertezza sulla datazione del lastricato superiore dell’intero piazza-le (della III fase), da verificare non solo in rapporto alla facciata ad ortostati, ma anche alleKouloures, che Levi assegna alla II fase con un riuso nella III: come avremo occasione divedere, le Kouloures sono invece strettamente legate, per motivi stratigrafici e di rapporticostruttivi, al piano superiore delle lastre 158. Si dovrebbe dunque essere costretti ad ammet-tere che anche il livello superiore del lastricato fosse della II fase, il che contrasterebbe conle proposte leviane appena ricordate. L’impressione generale, insomma, è che i livelli lastri-cati dell’intero piazzale possano essere stati tre, ma che l’estensione di tali lastricati o alme-no dei tratti conservatisi vada accertata analiticamente per i diversi momenti, senza esclu-dere parziali riusi nei differenti settori. Delle insidie stratigrafiche il Levi deve essersi resoconto, se afferma appunto che «tratti del lastricato precedente possono essere stati preser-vati o restaurati»159.
Per quel che riguarda l’aspetto cronologico egli ricorda sul «pianerottolo» della II fasea Sud della Vasca XXX (pianerottolo rimasto in uso anche dopo la creazione dei tre gradi-ni attribuiti alla III fase) tre skoutelia frammentari 160 non riprodotti, che, a giudicare dalledescrizioni inventariali, potrebbero essere del tipo semiovoide, corrente nel MM IIB. Talimanufatti, in ogni caso, essendo stato il pianerottolo in funzione anche nella III, datereb-bero l’ultimo momento di vita del piazzale, se non facevano addirittura parte del «riempi-ticcio» MM gettato sopra quel livello in occasione della costruzione del secondo Palazzo.Scarsi frammenti quasi esclusivamente della I fase protopalaziale a (e quindi, da presume-re, del MM IB) vengono indicati come provenienti da un saggio in profondità, proprio allimite nord di quel pianerottolo, a contatto con la spalletta di III fase, lì dove venne rin-venuto, a 0,60 m più in basso, un lastricato «che deve dunque appartenere alla I fase»161.Per il saggio sotto il secondo gradino, il Levi si limita a ricordare l’esistenza di un lastri-cato inferiore «ad un livello di poco più alto del tratto testé menzionato» (scilicet di quellosegnalato a -0,60 m sotto il pianerottolo di II fase) 162. L’attribuzione delle lastre sotto ilsecondo gradino al calpestio del lastricato inferiore è quanto meno dubbia, dal momentoche, per motivi di livello e per quanto si intravede nella fig. 515, è molto più verosimileche le lastre del secondo gradino legassero con il pianerottolo tuttora conservato (a quota -1,64 m; tav. B) e fossero pertanto da attribuire al lastricato mediano. Per il saggio al di sot-to del pianerottolo il Levi indica, come già detto, materiale «non posteriore alla fase Ia»,che nel sistema evansiano dovrebbe corrispondere al MM IB 163. I due ultimi saggi venne-ro effettuati nel 1963 in due tratti privi di lastre e sarebbe stato del massimo interesse veri-ficare le affermazioni cronologiche del Levi: ma la confusione o lo smarrimento dei cartel-
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA52
158 Vedi infra, p. 66s.159 LEVI 1965-66, p. 344. Per una critica alla rico-
struzione del Levi vedi DAMIANI INDELICATO 1982, p.99 ss. (con ripresa complessiva dei dati alle pp. 117-119). L’A. crede all’esistenza di due soli livelli lastri-cati sovrapposti; il terzo proposto dal Levi all’angoloSO sarebbe invece da riferire alla rampa ascendente.Il lastricato superiore, contemporaneo alla facciata adortostati, avrebbe potuto esserle anche leggermenteanteriore (eventualmente in rapporto con la messa inopera della gradinata teatrale, alla quale l’A. tende-rebbe a conferire una sua autonoma funzione, in rap-
porto alle strutture ‘civico-politiche’ dell’insedia-mento). Il lastricato più antico, anteriore alla faccia-ta ad ortostati, lo sarebbe stato anche al quartiere SO;andrebbe infatti assegnato «fra la fine dell’Antico Mi-noico e gli inizi del M.M. I» (p. 106). La ricostru-zione di dettaglio qui presentata ci esime dal discu-tere le diverse proposte.
160 F. 4604 a-c; LEVI 1976, p. 330, nota 2.161 LEVI 1976, pp. 330-331, fig. 513.162 LEVI 1976, p. 331, fig. 515.163 LEVI 1976, p. 331.
Creta Antica 8, 2007
lini di scavo al momento dell’archiviazione nel Museo Stratigrafico ha fatto sì che tutti imateriali dei saggi proprio in corrispondenza dell’ingresso sud-ovest al piazzale fossero uni-ficati, e come tali inutilizzabili nella nostra prospettiva 164.
I frammenti di I fase a /MM IB daterebbero ovviamente la messa in opera del «piane-rottolo» di II fase. Materiale dello stesso periodo viene, tuttavia, segnalato anche al di sot-to del lastricato di I fase, in un tratto appena più ad Est dei tre gradini ed a ridosso dell’o-riginario limite sud del piazzale, relativamente ad un saggio (i cui contorni sono eviden-ziati a tratteggio nella planimetria di tav. W Levi), effettuato in un tratto in cui mancava-no comunque le lastre 165. L’inevitabile conseguenza di quest’ultima indicazione cronologi-ca dovrebbe essere un periodo di vita relativamente breve per il lastricato inferiore, vistoche materiali simili verrebbero a trovarsi in riempimenti al di sopra e al di sotto di esso.
Un ultimo saggio per il quale viene fatto riferimento a materiali è quello a Nord del-la spalletta di I fase (verosimilmente nell’area del c.d. canale di deflusso) che sembrerebbeil muro n. 36 della tav. B; cfr. fig. 64 166. Vi si fa distinzione tra «strati più alti e più bas-si»: nei primi si sarebbe registrata «un’abbondanza di cocciame proprio della I fase proto-palaziale e in maggioranza del suo momento iniziale»; nei secondi, invece, si sarebberoriscontrati frammenti «assai più radi risalenti dai primi inizi di questa fase all’età pre-palaziale». Vengono poi ricordati alcuni vasi interi o frammentari, la cui profondità di rin-venimento, nelle schede inventariali, è molto eterogenea: diventa dunque impossibile attri-buirli agli strati «più alti» o «più bassi». Così, il bel vaso a tartaruga con superficie deco-rata à la barbotine, risulta recuperato nello «strato superficiale»167; l’elemento centrale di unvaso a grattugia o un beccuccio di olletta a doppio canale sarebbero invece stati raccolti «a-1,30/-1,50» m 168; la parte superiore di un’olletta con beccuccio aperto, anche questa à labarbotine, giaceva tra -0,40 e -0,60 m rispetto allo stesso piano di riferimento 169. Una broc-chetta globulare, recuperata già nel 1963 nei saggi preliminari 170, porta infine un’indica-zione inventariale ancora meno coerente, dal momento che le quote sono riferite non allastricato di III fase, ma alla spalletta dello stesso periodo, considerata ancora ipotetica-mente ellenistica (come nella proposta dei primi scavatori). Non è stato possibile rintrac-ciare, invece, le «due teierine quasi complete del tipo di Patrikiès»171. A parte queste ulti-
REVISIONI FESTIE 53
164 Scavo sorvegliato dal dott. F. Nicosia. Dalla suarelazione del 1963, p. 5, si evince che quello sotto ilpianerottolo è il saggio 63a; con 63a è invece indi-cato l’approfondimento sotto il secondo gradino delpianerottolo. Per il saggio 63a, vedi infra, nota 165.
165 LEVI 1976, p. 331. Si tratta del saggio 63a del-la relazione Nicosia 1963, p. 6. «Un saggio (saggioa) effettuato lungo la faccia N del muro 63.1a in unvuoto del lastricato, diede solo materiali prepalazialie della fase Ia del I palazzo (cass. 70a); anche i mate-riali immediatamente a contatto con il tratto dilastricato superstite non andavano oltre la fase I a delprimo pal.».
166 La localizzazione del saggio («subito a nordovest del muretto di spalla») e il rimando alla figuranon sono esenti da perplessità: cfr. LEVI 1976, p. 333.Nella didascalia della figura 522, a proposito delpunto di rinvenimento di un frammento ceramico, il
saggio è indicato come «a Nord del muro di spallet-ta della rampa di prima fase».
167 F. 4557; LEVI 1976, tav. 32 e. Indicazione dellascheda inventariale: «Saggio ad Ovest della Kouloura 1,sopra la rampa di 1° fase. Strato superficiale». Sul vasoin questione e sulla sua collocazione stratigrafica (sul-la base delle indicazioni fornite dal Levi, vedi PLATON
1968, p. 22, nota 1 e pp. 30-31, nota 3).168 F. 4552a-b; LEVI 1976, p. 333, nota 4.169 F. 4551; LEVI 1976, fig. 522 (definita «teiera»).170 F. 4487; LEVI 1976, tav. XIVb. Indicazioni inven-
tariali: «Fra il placostrato inferiore e il livello del II (a m3,50 dal muro 30 e a m 2 dal muro ellenistico (?), che vadalla Koul. I alla vasca rettangolare). Profondità -0,70dalla sommità muro ellenistico». Da tali indicazioniappare evidente che la brocchetta non può essere rife-rita al saggio a Nord del muro 36.
171 LEVI 1976, p. 333.
Creta Antica 8, 2007
me, da attribuire verosimilmente al MM IA, gli altri materiali inventariati sembrerebberotutti, indipendentemente dalla loro profondità di rinvenimento, del periodo MM IB. Unamaggiore o minore concentrazione di frammenti di tale periodo nei diversi livelli, cheavrebbe potuto fornire un’ulteriore indicazione cronologica, risulta appena adombrata nel-l’edizione definitiva dello scavo. L’assenza di precisi livelli o piani di calpestio consented’altro canto di supporre, limitatamente a quest’area, che tutti i materiali citati si riferi-scano ad un unico riempimento fra due soli lastricati.
Una qualche indicazione cronologica viene infine proposta dal Levi per il settore a Norddella Vasca XXX e segnatamente per il muro di limite del piazzale lungo la Strada dal Nord( fig. 47), muro nel quale distingueva due fasi segnate da una sutura e da un leggero agget-to della parte superiore 172. Facendo cenno ad alcuni saggi «praticati presso alla sostruzionedel muro lungo posante direttamente sulla roccia», egli ricorda «frammenti di fine ceramicaKamares», fra i quali un bicchiere frammentario chiaramente attribuibile al MM II 173. Questaprecisazione sembrerebbe contrastare con quella ricavabile dai frammenti conservati nelMuseo Stratigrafico, fermo restando che la genericità dell’indicazione dei livelli e della stes-sa provenienza dei frammenti ne rende problematico l’uso per la datazione delle strutture.
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA54
172 LEVI 1976, figg. 494- 495.173 LEVI 1976, p. 318, tav. LVIa (F. 4556). L’indica-
zione inventariale è assai più generica: «Saggio lungo lafaccia est del muro di margine ovest del Piazzale», sen-za specificazione di profondità. La data (28.VIII.1964)corrisponde con quella del saggio eseguito dalla Vaccaro
(cfr. infra, nota 175). Secondo la sequenza proposta nel-la relazione per i materiali da lei raccolti lungo il muro,il bicchiere dovrebbe essere riferito al taglio superiore,da -0,50 a -1,00 m, o al massimo a quello sottostanteda -1,00 a -1,80 m, e quindi in nessun caso in rapportocon la «sostruzione del muro».
Creta Antica 8, 2007
FIG. 47 – PIAZZALE I, FASCIA OVEST. SETTORE A NORD DELLA VASCA XXX CON IL MURO DI LIMITE
LUNGO LA STRADA DAL NORD (MURO 38). DA NORD-EST.
Accennando a scavi a Nord della Vasca XXX e lungo la fascia est del muro di limitedel Piazzale, la responsabile di trincea propone delle precise divisioni, con riferimenti diquota al «ciglio superiore del muro», senza che sia tuttavia possibile localizzare il tratto cuisi allude. Ricorda inoltre «un riempimento di astraki», che avrebbe caratterizzato lo spaziocorrispondente ai filari inferiori del muro (al di sotto della ricordata sutura), aggiungendoche la quota di essa coinciderebbe con il piano delle lastre superiori del Piazzale. Per la par-te inferiore del muro si afferma, infine, che «essa poggia su un riempimento di prima faseprotopalaziale piuttosto antica, con molto materiale prepalaziale»174. Quest’ultima indica-zione va intesa verosimilmente nel senso che i livelli subito a contatto con il piede del murosono stati considerati cronologicamente non diversi da quelli che si trovavano sotto di esso.Quanto ai frammenti, il primo gruppo, che sarebbe stato raccolto fra -0,50 e -1,00 175,mostra un orizzonte MM II maturo, per il quale non possiamo non pensare al riempimentodella grande colmata (c.d. Grande Frana) legato alla ricostruzione del secondo Palazzo 176.Non a caso la stessa responsabile di trincea ricorda, come già detto, che il livello della su-tura coincideva con quello delle lastre superiori del Piazzale, sulle quali appunto si erasistemato quello stesso «colmaticcio» ricordato dal Pernier 177. Il taglio successivo da -1.00
REVISIONI FESTIE 55
174 Relazione dott. A. Vaccaro 1964, p. 5.175 Collocazione: MS col. 68/16 (10 a). Indicazioni:
«8/9/64. Piazzale SO a ridosso muro Alì (scilicet muro38) da -0,00 a 1 m (sopra l’astraki)» [cartacea]. «F 64
Pz 1/N. Saggio sotto muro 38, da -0,60 a -1,00 sot-to ciglio muro 38» [lignea].
176 Cfr. V. LA ROSA 1998-2000, pp. 43-50.177 PERNIER 1935, pp. 210-211.
Creta Antica 8, 2007
FIGG. 48-49 – PIAZZALE I. SAGGIO A NORD DELLA VASCA XXX E
LUNGO LA FASCIA EST DEL MURO DI LIMITE DEL PIAZZALE I. FRAMMENTI
DAL TAGLIO DA -1,00 A -1,80 M.
a -1,80 m178, si riferirebbe proprio ai filari inferiori del muro fino alla sua base: l’orizzonte deiframmenti è in netta prevalenza MM IB, anche maturo ( figg. 48-49), come dimostrano, inparticolare, i tratti di vasi cilindrici, con decorazione a spirale di protuberanze à la barbotine, o
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA56
178 Collocazione: MS col. 68/16 (10b). Indicazioni:«26/8/64. Piazzale SO Nord. Saggi a ridosso del muroAlì, strato da m 1 a m 1,30 (astraki)» [cartacea]. «10/9/
64. A ridosso muro Alì (scilicet muro 38) da -0,30 a -1,70sotto ciglio muro Alì» [cartacea]. «F 64 Pz1/N. Saggiomuro 38, da -1 a -1,80 sotto ciglio muro 38» [lignea].
Creta Antica 8, 2007
FIGG. 50-51 – PIAZZALE I. SAGGIO A NORD DELLA VASCA XXX E LUNGO LA FASCIA EST DEL MURO DI LIMITE DEL PIAZZALE I.FRAMMENTI DAL TAGLIO DA -1,80 A -2,00 M.
con scanalature combinate a motivi a scacchiera e trattini. Alcuni frammenti MM II, quali untratto della parte inferiore di una tazza cilindrica con resti di decorazione a spirali bianche (fig.48) potrebbero riferirsi all’interfaccia con il livello superiore. Poiché risulta stratigraficamentepoco probabile attribuire questi frammenti al momento di messa in opera del muro, non restache considerarli indicativi per il riempimento al di sotto della rampa di stucco: nonostante nonsia espressamente affermato dagli scavatori, essa doveva certamente raccordarsi con il muro inquestione e nell’area di raccordo era stata forse sacrificata dagli «sterri» preliminari per il pro-filamento del muro 179. Un’analoga indicazione cronologica varrebbe, quasi certamente, ancheper la costruzione della Vasca XXX. Il gruppo di frammenti da -1,80 a -2,00 180 m potrebbe es-sere quello relativo ai livelli al di sotto del muro; esso documenta un momento apparentementeiniziale del MM IB, con parecchio materiale MM IA e qualche coccio anche AM. Nella fig. 50sono presentati alcuni dei frammenti più antichi, tra cui un orlo di piattello decorato a feston-cini bianchi ed altri che ricordano motivi e sistemi decorativi della ceramica di Patrikiès. Iframmenti più chiaramente attribuibili al MM IB sono illustrati nella fig. 51, e comprendonoun ampio tratto di una classica brocchetta à la barbotine, con decorazione in scuro su chiaro,nonché due interessanti resti di orlo di bacinelle o pissidi, con sporgenza interna per appoggiodi un coperchio, pure decorati à la barbotine, con decorazioni sovradipinte in bianco e rosso. Aduna datazione al MM IB iniziale del momento di messa in opera del muro in questione si eradel resto già giunti sulla base dei recenti saggi condotti nell’area della Strada dal Nord 181.
Dopo la conclusione degli scavi Levi, un piccolo intervento è stato effettuato nel 1992,nella stretta fascia fra la parete occidentale della Vasca XXX ed il muro di limite della Stradadal Nord, in corrispondenza della fornace, nell’ambito dei lavori di rilevamento e studio diquest’ultima 182. Lavori di restauro sono stati infine realizzati nel 2004 a cura del Servizioarcheologico greco, con recupero di frammenti in qualche caso stratigraficamente significativi.
Per cercare di orientarsi nella decodificazione di quest’area nevralgica, è opportuno proce-dere su un doppio binario: quello della verifica delle quote delle diverse strutture 183 (riportatenelle piante di tavv. A e B), per accertarne la reciproca compatibilità, e quello della cronologiadei frammenti dai diversi saggi, soltanto nei casi in cui essi risultino sicuramente localizzabili.
Una terza prospettiva sarebbe quella di evidenziare strutture o apprestamenti passatisotto silenzio o non correttamente interpretati. La sorpresa maggiore, in quest’ultimo caso,nasce dalla presenza, finora mai segnalata, a ridosso della Kouloura I 184, di un apprestamen-to costituito da un elemento a pilastrino approssimativamente ellissoidale 185 ( fig. 52)
179 Effettuati quasi sicuramente dal restauratore edassistente di scavo della Scuola di Atene Alì Cara-vella, a giudicare anche dalla denominazione (nei do-cumenti di scavo e di archiviazione del materiale, ol-tre che nella tradizione orale) di «muro Alì» per ilmuro 38 (cfr. tav. B e fig. 47).
180 Collocazione: MS col. 68/16 (11). Indicazioni:«10/9/64. Saggio a ridosso del muro Alì (scilicet muro38), da -1,80 a -2,00 sotto ciglio del muro Alì» [carta-cea]. «F64. Pz1/N. Saggio muro 38, da -1,80 a -2,00sotto ciglio muro 38» [lignea]. Un ultimo gruppo dimateriali [Collocazione: MS col. 68/16 (12). Indica-zioni: «F 64 Pz1/N. Saggio muro 38, da -2,00 sottociglio muro 28 fino a roccia»] conteneva cocci in net-
ta prevalenza MM IA, che esulano dalle problemati-che qui affrontate.
181 LA ROSA 2002 (riepilogo dei dati: pp. 734-736).182 F. TOMASELLO, Fornaci a Festòs ed Haghia Triada
dall’età mediominoica alla geometrica, in Keramikàergastiria stin Kriti apo tin archeotita os simera (Margarites30 sept. 1995), Rethymno 1996, pp. 29-30, fig. 2.
183 Operazione da noi curata nell’estate del 2005,con riferimento allo 0,00 della pianta pubblicata dalPernier (adottato dal Levi); vedi infra, nota 243.
184 Esattamente a Sud/Sud-Ovest, al di sotto dellaquota di spiccato dell’anello che la delimitava.
185Alt. m 0,70 ca.; diam. 0,18/0,27 m; diam. inca-vo 0,07 m; prof. 0,028 m.
Creta Antica 8, 2007
REVISIONI FESTIE 57
Creta Antica 8, 2007
FIG. 52 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. APPRESTAMENTO BETILICO PRESSO LA KOULOURA I. DA NORD-OVEST.
FIG. 55 – PIAZZALE I, LIMITE MERIDIONALE. APPRESTA-MENTO PROBABILMENTE DI TIPO BETILICO PRESSO LA
KOULOURA II, IN CORRISPONDENZA DEL MARGINE
DELLA RAMPA ELLENISTICA. DA SUD-EST.
FIG. 53 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. PARTICOLA-RE DELLA SOMMITÀ DELL’ELEMENTO BETILICO. DA NORD.
FIG. 54 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. APPRESTA-MENTO BETILICO PRESSO LA KOULOURA I, VEDUTA DAL-
L’ALTO. DA NORD-EST.
recante un incavo sull’estremità superiore ( fig. 53) e da un blocco cubico irregolare (ormaisotto il filo della Kouloura, presso il quale il pilastrino è tuttora visibile). Il blocco presen-ta, al centro della faccia superiore, una cavità conica dai contorni poco netti, ma alquantoprofonda ( fig. 54); una lastra quadrangolare, subito a Sud-Est di tale blocco, indica unlivello di calpestio (a quota -0,98 m), del quale non sapremmo rendere conto 186. Nellasituazione attuale, ma anche nella sezione G-H alla tav. Z del Levi, il pilastrino, che nonesiteremmo a definire un betilo, poggia sul lastricato più basso, a quota -1,37 m, mentrela sommità cade a quota -0,71 m, corrispondente all’incirca a quella dell’ultimo lastricato(assegnato dal Levi alla III fase). Il betilo si vede chiaramente in una foto di scavo, acco-stato a un allineamento poggiante su terra, forse ritenuto un crollo o di epoca posteriore eper questo rimosso dallo scavatore 187. La presenza del blocco retrostante (per non dire del-la lastra di quota -0,98 m) induce a supporre che in questo settore fosse stato sistemato unapprestamento più complesso di un semplice betilo, per il quale non siamo in grado di sug-gerire confronti 188. Un altro apprestamento apparentemente analogo ( fig. 55), racchiusoentro altre pietre più basse che gli fanno da sostegno, si trova presso la Kouloura II, in cor-rispondenza del margine della rampa ellenistica: si intravede, insieme con il primo, in unafoto di scavo 189, ma è anche riproposto (ad una quota non corretta e con una sistemazionesemplificata in maniera prospettica) nella già citata sezione di tav. Z. La quota della som-mità (-0,63 m) non differisce di molto da quella del primo, ma è necessaria una serie dicontrolli per definire meglio la natura di questo secondo, possibile elemento betilico.
Per quel che riguarda i lastricati, rimane assodata l’esistenza di tre livelli nell’area aSud della Vasca XXX: quello inferiore (I fase Levi), a quota -2,24 m circa, corrispondentealla rampa ascendente mediana; il mediano, a quota -1,64 m (II fase Levi), in rapporto conla rampa superiore, rimasta in uso anche in periodo successivo; quello più alto, con som-mità dei tre gradini a quota -1,11 m (III fase Levi) (tav. B).
Nella rimanente area tra la Vasca XXX e la Kouloura si distinguono agevolmente iresti del lastricato inferiore, in pendio da -1,62 a -1,27 m ( fig. 56; tav. B) e del superiore,anch’esso in pendio da -1,11 a -0,59/49 m, con il marciapiede soprelevato a quota -0,31m. Attribuiremmo con buona probabilità al lastricato mediano uno spicchio triangolare dilastre a quota -0,87 m, nell’area subito a Sud-Ovest del marciapiede soprelevato, fra que-sto e la Kouloura I ( fig. 57; tav. B). Il sistema avrebbe potuto inglobare l’apparente termi-nale est del muro 36, a quota -0,65 m, che poteva forse costituire un elemento (ad unadistanza di poco più di 0,50 m ad Ovest rispetto all’estremità conservatasi del marciapie-de) di codesto lastricato mediano. La lastra subito sotto il marciapiede (ad Ovest), a quota-0,61 m, potrebbe far parte dello stesso lastricato, certamente in rapporto con una di -0,65m a Sud. Immediatamente ad Est di quest’ultima, in corrispondenza del secondo lastronedel marciapiede e ad esso addossate, si conservano tre lastre con sommità a -0,57 m, chepotrebbero dunque rappresentare il livello del lastricato ultimo ( fig. 58). Se quest’ipotesifosse corretta, dovremmo dedurne che la sovrapposizione fra terzo e secondo lastricato, inquesto settore, fosse stata immediata.
REVISIONI FESTIE 59
186 Il blocco misura 0,54 ! 0,41 m, con uno spes-sore di 0,25 m, ad una quota di -0,94 m. Diam. del-la cavità centrale 0,16/0,20 m; prof. 0,10 m. Quotadella lastra attigua -0,98 m.
187 LEVI 1976, figg. 521 e 533 (dopo la demolizio-
ne dell’allineamento).188 Sulla tipologia del betilo vedi da ultimo M.
GALLO, Per una riconsiderazione del betilo in ambitominoico, in Creta Antica 6, 2005, pp. 47-58.
189 LEVI 1976, fig. 486.
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA60
Creta Antica 8, 2007
FIG. 56 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. AREA TRA LA VASCA XXX E LA KOULOURA I CON AL CENTRO I MURI 35, 36, 37E I RESTI DEL LASTRICATO INFERIORE; IN ALTO IL LASTRICATO SUPERIORE. DA SUD.
FIG. 57 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. SPICCHIO TRIANGOLARE DI LASTRE A QUOTA -0,87 M, NELL’AREA
SUBITO A SUD-OVEST DEL MARCIAPIEDE SOPRELEVATO, FRA QUESTO E LA KOULOURA I. DA OVEST.
Il livello delle lastre superiori riprendeva, subito a Nord del marciapiede, a quota -0,40m e proseguiva a -0,22 m, a circa 1,50 m di distanza in corrispondenza della ripresa diquelle conservate nell’area del c.d. canale di deflusso. Proprio presso la lastra di -0,22, unaa -0,43 m subito a Nord-Ovest, ben si accorderebbe con il livello del lastricato mediano.Riteniamo infatti l’ipotesi del canale di deflusso (in rapporto, ovviamente, con l’ultimolastricato) proponibile soltanto in funzione di un riutilizzo di quello di II fase, arricchitoda una spalletta, tuttora visibile, rappresentata da una sorta di allineamento Sud-Ovest/Nord-Est, impostato su lastre del II livello (della spalletta occidentale non sarebbe, pare,rimasta traccia). Un’ipotesi alternativa è quella proposta dalla Marinatos, che considera l’al-lineamento in questione come apprestamento di base per un terzo marciapiede soprelevatoin rapporto con il lastricato superiore, in maniera da chiudere a triangolo i due attualmen-te conservati, con chiaro riferimento agli schemi attestati a Cnosso e a Mallia 190. Esiste, teo-ricamente, la possibilità che l’allineamento assolvesse ad entrambe le funzioni (limite dicanale e base di marciapiede).
Altro problema è quello della natura delle c.d. spallette e delle altre strutture trasver-sali nell’area tra la Vasca XXX e la Kouloura I. Spallette in senso proprio possono essere con-siderate le due subito a Sud della vasca (muri 34 e 33; fig. 59; tav. B). La più vicina (muro34) appare strutturalmente collegata ad essa e va pertanto considerata contemporanea; pog-gia altresì direttamente su un piano di lastre che, a giudicare dalle quote, sembrerebbequello inferiore: con la conseguenza che la Vasca XXX dovrebbe essere stata messa in ope-ra in un momento successivo a quel lastricato, ma contemporaneamente alla sistemazionedel pianerottolo di -1,64 m, la cui continuazione sembrerebbe arrestarsi contro la spallet-ta in questione 191. Con un riuso di tale pianerottolo e soprattutto con la costruzione dei tregradini relativi all’ultima sistemazione del piazzale va invece sicuramente messa in rap-porto la spalletta meridionale (muro n. 33), la quale fa a sua volta angolo con la strutturadi limite della Strada dal Nord nel suo momento più tardo ( fig. 60).
In effetti, la Vasca XXX ( fig. 61) rappresenta un nodo cruciale per la determinazionedelle fasi architettoniche di questo settore del Piazzale. Verosimilmente priva di facceesterne sui quattro lati, dà l’idea, anche a causa della sua collocazione, di essere stata rac-cordata a strutture o apprestamenti preesistenti o pensati assieme con essa, i quali avreb-bero reso non necessaria la realizzazione della faccia esterna dei muri di limite. Abbiamogià considerato contemporanea alla vasca la spalletta sud (muro 34); altrettanto abbiamofatto per la rampa di stucco bianco, alla quale si poteva comunque accedere, oltre che dallato ovest del Piazzale, dalla porta che si apriva nei filari inferiori del muro 38, di confinedella Strada dal Nord 192. Per quel che riguarda il limite occidentale della vasca è inevita-bile pensare alla preesistenza di tale lungo muro, al cui allineamento essa si sarebbe ade-guata e raccordata, magari con un piano in stucco. Meno chiara appare la situazione sul latoest, dove vediamo sovrapporsi alla parete il muretto di limite del lastricato superiore a quo-ta -0,50 m circa ( fig. 62; tav. B). Al di sotto di tale muretto, presso l’angolo sud-est, sidistingue un blocco angolare a quota -0,88 m, in rapporto con la sistemazione della vasca,ma anche possibile terminale di un muro di limite Nord-Sud, a sua volta probabilmente
REVISIONI FESTIE 61
190 N. MARINATOS, Public Festivals in the West Courtsof the Palaces, in The Functions of the Minoan Palaces, R.HÄGG, N. MARINATOS edd., Stockholm 1987, pp. 135-143 (specialm. p. 137, fig. 1a). Sui marciapiedi del
nostro piazzale vedi anche DAMIANI INDELICATO 1982,pp. 115-116.
191 LEVI 1976, fig. 513.192 LEVI 1976, p. 318, figg. 495- 496.
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA62
Creta Antica 8, 2007
FIG. 58 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. LE TRE LASTRE CON SOMMITÀ A -0,57M, IN CORRISPONDENZA DEL SECONDO
LASTRONE DEL MARCIAPIEDE SOPRELEVATO E AD ESSO ADDOSSATE. DA SUD-OVEST.
FIG. 59 – PIAZZALE I, ANGOLO SUD-OVEST. I MURI 34 E 33, SUBITO A SUD DELLA VASCA XXX;SULLA DESTRA I MURI 36 E 37. DA SUD.
REVISIONI FESTIE 63
Creta Antica 8, 2007
FIG. 60 – PIAZZALE I, ANGOLO SUD-OVEST. I MURI 33 (A SINISTRA) E 34 AL LIMITE MERIDIONALE DELLA VASCA XXX,E, SULLO SFONDO, IL MURO 38. DA SUD-EST.
FIG. 61 – PIAZZALE I, ANGOLO SUD-OVEST. LA VASCA XXX; SULLO SFONDO I GRADINI DEL PIANEROTTOLO
E L’ESTREMITÀ DELLA RAMPA ASCENDENTE. DA NORD.
collegabile ad un lastricato: in tal senso de-porrebbero infatti almeno due lastre rimaste insitu subito accanto, ad una quota di -0,86 m( fig. 63). La loro continuazione era stata quasicertamente interrotta dalla messa in opera delsovrastante, citato muretto di limite dellastricato superiore, sporgente a mo’ di risegadi circa 0,30 m rispetto alla presunta facciaorientale della parete della vasca, che avrebberaggiunto la larghezza di 0,45 m. Se questaipotesi cogliesse nel vero, avremmo per un ver-so lo stesso accorgimento costruttivo riscon-trato lungo la parete sud (parziale sovrapposi-zione alla vasca) e per l’altro un piano di posaper un lastricato intermedio. La vasca si collo-cherebbe stratigraficamente, in questo caso,fra il primo e il secondo livello di lastre; lasistemazione di quest’ultimo potrebbe, anzi,essere stata condizionata proprio dalle neces-sità di impianto della vasca.
Delle tre rimanenti strutture, che sa-rebbe improprio definire spallette, tutte diorientamento diverso ( figg. 56 e 64), duepoggiano direttamente sopra al lastricatoinferiore (muri 35 e 36), mentre la terza(muro 37) è praticamente a livello di quel-lo superiore. Non è difficile supporre chequest’ultima rappresenti una spina di con-tenimento per il terreno, spina destinataprobabilmente a segnare una sorta di gran-de gradino che aiutasse a colmare la diffe-renza di livello tra la quota di -1,11 m dellastricato alla sommità della scaletta diingresso al piazzale e quello di circa -0,50/0,60 m in corrispondenza di tale spina. Inquesta sistemazione ultima rientra sicura-mente la costruzione della Kouloura I, con-tro la quale battono sia le lastre superioriche il muro 37. Non si è conservata, proba-bilmente, l’estremità ovest di tale muro, la
quale tuttavia, se è giusta l’interpretazione funzionale proposta, non poteva che arrestarsiin corrispondenza del muretto di limite del lastricato superiore. Tale muretto ricalcasignificativamente, come già detto, l’andamento di quello del lastricato mediano, a ripro-va che la vasca era ancora in uso con il superiore. Con questa stessa sistemazione, inoltre,risulterebbe coperto il betilo, mentre sarebbero stati realizzati i marciapiedi a rilievo nel-l’area del piazzale.
L’obliterazione del betilo coinciderebbe significativamente con quella dell’altareaddossato alla parete est del vano C, nell’area della vicina Strada dal Nord: ma è ancor più
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA64
Creta Antica 8, 2007
FIG. 62 – PIAZZALE I, ANGOLO SUD-OVEST. LATO EST
DELLA VASCA XXX. DA SUD.
FIG. 63– PIAZZALE I, ANGOLO SUD-OVEST. LATO EST DELLA
VASCA XXX. PARTICOLARE DEL BLOCCO ANGOLARE A QUOTA
-0,88 M, POSSIBILE TERMINALE DI UN MURO DI LIMITE NORD-SUD, A SUA VOLTA PROBABILMENTE COLLEGABILE CON LE DUE LA-STRE RIMASTE IN SITU SUBITO ACCANTO, A -0,86 M. DA SUD-EST.
Creta Antica 8, 2007
FIG. 64 – PIAZZALE I, ANGOLO SUD-OVEST. AL CENTRO, AL LIVELLO DEL LASTRICATO INFERIORE, IL MURO 36;SUL RETRO IL MURO 37 CHE BATTE CONTRO LA KOULOURA I. DA NORD-OVEST.
FIG. 65 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. I MURI 35 E 37 A RIDOSSO DELLA KOULOURA I. DA SUD-OVEST.
significativo che l’originaria sistemazione del betilo corrispondesse alla messa in operadell’altare medesimo 193.
In rapporto con il lastricato mediano, che si conserva nel pianerottolo a quota -1,64 me al limite est della vasca a -0,86 m ed al quale si riferiscono altresì le lastre superstiti nel-l’area del c.d. canale di deflusso, va sicuramente posto il muro 35 ( figg. 56 e 65), che deveaver avuto funzioni simili a quelle del 37. Dal punto di vista stratigrafico il 35 si impostadirettamente sul lastricato inferiore (come la spalletta sud della vasca); è parzialmentecoperto ad Ovest dalla più recente spalletta 33; va al di sotto del piede della Kouloura I edell’estremità est dal muro 37: poteva dunque estendersi ancora in entrambe le direzioni.
Proprio il muro 35 consente di pensare che al momento di costruzione della vasca edel lastricato mediano fosse rimasto ancora in uso, nella fascia sud del piazzale, quello infe-riore. Il dislivello rispetto al piano di -1,37 m di quest’ultimo lastricato nei pressi dellaKouloura I sarebbe stato superato con un gradino di una ventina di centimetri proprio incorrispondenza del muro 35, conservato ad una quota massima di -1,16 m. A partire dalsuo allineamento sarebbe stato dunque realizzato ex novo un tratto del lastricato mediano.La funzione di contenimento del muro 35 rende ragione della presenza di pietre più gros-se e regolari lungo la faccia sud. Secondo questa proposta di ricostruzione sarebbe rimastoin uso il tratto meridionale del lastricato inferiore, per cui potremmo ipotizzare che il beti-lo fosse ancora in vista al tempo del piano di lastre intermedio. Dal momento poi che lavasca sarebbe stata realizzata in concomitanza con tale piano, vasca e betilo sarebbero rima-sti, per un certo periodo, contemporaneamente in uso.
Resta da collocare stratigraficamente il muro 36 (il più precario come costruzione econservazione), che il Levi aveva indicato come spalletta del lastricato di I fase, precisando,come già ricordato, che a Nord di esso, nei pressi della vasca, non furono trovate le lastredi pavimentazione194. Il muro si sovrappone, però, lungo la faccia sud, al lastricato inferio-re, mentre non è chiaro, purtroppo, il rapporto con la spalletta sud della vasca (muro 34).Se i recenti lavori di restauro non traggono in inganno, è probabile che le due strutture fos-sero collegate, indipendentemente dal loro allineamento, il quale risulta, in pianta, nonproprio corretto. La lectio facilior potrebbe essere che il muro 36, costruito insieme con lavasca, rappresentasse una sorta di sottofondazione (di contenimento del terreno) proprio peril settore di lastricato mediano che muoveva dall’angolo sud-est di essa. In tal caso diven-terebbe contemporaneo al muro 35, con una funzione probabilmente analoga.
In conclusione, resterebbero determinate nel settore sud-ovest del Piazzale I, tre fasistrutturali caratterizzate da altrettanti lastricati, tuttavia non esattamente identificabilicon quelle del Levi. Alla prima apparterrebbero, oltre alla rampa mediana ascendente, illastricato più basso sotto la fornace, quello sotto il pianerottolo di quota -1,64 m, il limi-te orientale della Strada dal Nord (muro 38, filari inferiori sotto la sutura) e anche l’ap-prestamento con il betilo. Nella seconda sarebbero stati sistemati il pianerottolo, la vascacon la rampa di stucco a Nord, la sua spalletta sud e i muri di contenimento/rialzamento(35 e 36). Sarebbero ancora rimasti in uso la fascia meridionale del lastricato più basso, lastruttura originaria del muro 38 e l’apprestamento con il betilo. A questo stesso momentorisalirebbero il lastricato superiore sotto la fornace e la rampa ascendente superiore. Nellaterza fase, rimanendo in funzione il pianerottolo, quest’ultima rampa, il lastricato superio-re sotto la fornace, la vasca e la rampa di stucco, sarebbero stati creati i tre gradini con rela-
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA66
193 LA ROSA 2002, pp. 726-727 e 735. 194 Vedi supra, p. 50.
Creta Antica 8, 2007
tiva spalletta, obliterato il betilo, messe in opera la/le Kouloura/es, creata la spina di conte-nimento 37 e, al di sopra della sutura, il nuovo muro 38.
A queste tre fasi architettoniche tocca ora dare un contenuto cronologico, partendo dalmomento di obliterazione del lastricato superiore. Un uso del Piazzale I durante il MMIIIA, pur dopo la distruzione della facciata a ortostati, è assicurato sia dalla costruzione del-la Garitta CIV ( fig. 66) 195, sul cui pavimento giacevano un’olletta con beccuccio a ponte euno skouteli al suo interno 196, sia dal rifacimento della spalletta della rampa superiore ascen-dente nella zona del vano LXXX 197. Dobbiamo però pensare che il settore occidentale, aldi là della Garitta CIV, Vasca XXX e rampa di stucco comprese, potesse essere già abban-donato, dal momento che uno strato di macerie con crolli dai piani superiori del Bastioneovest e diversi vasi della fine del MM II, ricostruiti quasi per intero, si raccolsero propriofin sopra le lastre della pavimentazione superiore 198.
Per quel che riguarda saggi con indicazioni cronologiche proposte dal Levi, converràribadire l’impossibilità di verificare i due sondaggi, teoricamente risolutivi, sotto il pia-nerottolo e sotto il secondo gradino della scala 199. Quanto al saggio al limite sud del
REVISIONI FESTIE 67
195 LEVI 1976, pp. 346-347.196 Per l’olletta con beccuccio a ponte F. 5457a e
per lo skouteli-coperchio 5057b, vedi anche V. LA ROSA,Liturgie domestiche e/o depositi di fondazione? Vecchi e nuo-vi dati da Festòs e Haghia Triada, in Creta Antica 3,2002, p. 36, fig. 57. Va in ogni caso tenuto presente,a proposito della Garitta, che le sue pareti sud e ovest
erano sistemate su uno strato di terra che raggiungevaad Ovest lo spessore di circa 0,20 m.
197 LA ROSA 2002, p. 737.198 LEVI 1976, fig. 535 (crollo) e fig. 543; tav. 177a-d,
con materiali della fase MM IIB finale.199 Vedi supra, p. 53, nota 164.
Creta Antica 8, 2007
FIG. 66 – PIAZZALE I, SETTORE NORD-OVEST. LA GARITTA CIV A RIDOSSO DEL C.D. BASTIONE OCCIDENTALE. DA EST.
Piazzale I, quasi a metà fra il pianerottolo e la Kouloura, anche questo, essendo stato ese-guito nel 1963, ha subìto la medesima sorte di mescolamento dei materiali 200.
Restano pertanto solo i frammenti dei due saggi, entrambi del 1964, per i quali èchiara una localizzazione generale, senza tuttavia che risultino sempre perspicui gli speci-fici punti di rinvenimento. Il primo, indicato dalla responsabile di trincea come «Saggio1», fu eseguito a Nord del muro 37, ma può forse ulteriormente precisarsi come area aNord del muro 36. Il secondo («Saggio n. 2») ha come indicazione generale «tra i muri 36,37 e vasca XXX» e sembrerebbe alludere ad uno stretto triangolo rettangolo con l’ipote-nusa di un’ottantina di centimetri ( fig. 56).
In particolare, nel Saggio 1 un gruppo di materiali si riferisce alla fascia immediata-mente attigua al muro 37 fino al margine del 36 (tratto est). Tale fascia costituiva l’inter-ro fin sopra al lastricato inferiore, in un’area nella quale non viene segnalata la presenza dilastre mediane: è legittimo, tuttavia, il riferimento dei relativi materiali proprio al lastri-cato mediano, dal momento che l’interro in questione sarebbe quello compreso fra i muri35 e 36 201. In questi frammenti abbiamo potuto riscontrare un orizzonte in larga prevalen-za MM IB, con cocci più antichi e almeno due (fondo di tazzina cilindrica tutta verniciatadi nero con fascette orizzontali bianche; piccolo tratto di parte inferiore di tazzina carena-ta parimenti verniciata in nero) riferibili a un momento probabilmente iniziale del MM II.Tra i materiale MM IB abbiamo riprodotto ( fig. 67) la metà di un beccuccio di olletta conmargine dentato à la barbotine e resti di decorazione sovradipinta in bianco e rosso vino; untratto di coppa a orlo ondulato con decorazione a festoncini bianchi e triangoli rossi; unodi orlo e parete di grande coppa globulare schiacciata con decorazione à la barbotine e restidi un becco; un tratto di basso bacinetto quadrangolare con beccuccio a ponte e decorazio-ne a sottile tratteggio puntinato bianco, inquadrato da fascette rosse; un frammento di orlodi olla a pareti spesse in argilla più grezza, decorato a fascette rosse e bianche; uno di gran-de vaso chiuso con elementi spiraloidi in bianco e fascette rosse. Questi materiali consen-tirebbero, come terminus post quem, di datare agli inizi del MM II la messa in opera dellastricato superiore.
Il resto dei frammenti si riferisce invece ad un’estensione del saggio a Nord del muro36 (tratto est), previa asportazione di una serie di lastre di restauro dello scavo Pernier 202,con un approfondimento fino alla roccia. I materiali di questi tagli possono quindi esserecollegati, in teoria, a tre operazioni diverse: l’interro per la messa in opera del lastricatosuperiore; il riempimento a Nord del muro 36 per la sistemazione del lastricato mediano;i livelli anteriori alla messa in opera del lastricato inferiore (attestato almeno nella fasciasubito a Sud del muro 36). Gli unici elementi di discrimine sono rappresentati oggi dal-la sommità conservata del 36 (quota -1,27 m all’estremità ovest e -0,65 m a quella est) edal piede del medesimo, purtroppo apprezzabile oggi solo sul lato sud, coincidente con ilpiano di posa delle lastre inferiori (-1,35 m a Ovest) 203 ( fig. 56).
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA68
200 Vedi supra, p. 53, nota 165.201 Collocazione: MS col. 68/13 (1b). Indicazioni:
«24/8/64. Piazzale SO (teatro). Zona a N della rampa.Trincea di saggio presso culura I, strato da -0,17 a -0,30sotto il placostrato di 3° fase» [cartacea]. «F 64 PZ1/NSaggio ad ovest Kulura 1 e a Nord rampa 1° fase. Ma-teriale sopra la rampa 1a fase» [lignea]. Nella relazio-ne Vaccaro 1964, p. 1, per la cassetta 1b, è usata l’in-
dicazione «sopra alla rampa»; nella stessa relazione,alla p. 2, si legge: «è stata asportata una piccola zonadi lastricato di III fase al limite ovest del diadromo(scilicet marciapiede soprelevato) che attraversa il piaz-zale 1/I in direzione est-ovest».
202 Relazione Vaccaro 1964, p. 2; vedi supra, p. 50.203 In effetti la relazione Vaccaro propone una dop-
pia equivalenza fra il livello del lastricato di III fase
Creta Antica 8, 2007
REVISIONI FESTIE 69
Creta Antica 8, 2007
FIG. 67 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. SAGGIO 1. FRAMMENTI DALL’INTERRO TRA IL LASTRICATO SUPERIORE E QUELLO INFERIORE.
FIG. 68 – COME SOPRA. ESTENSIONE A NORD DEL TRATTO EST DEL MURO 36. FRAMMENTI DAL I TAGLIO.
FIG. 69 – COME SOPRA. FRAMMENTI DAL II TAGLIO.
I materiali del primo taglio 204 potrebbero riferirsi alla preparazione del lastricato supe-riore, anche se le lastre mancanti non mettono al riparo da intrusioni e lo spessore dell’in-terro appare decisamente eccessivo per un settore nel quale doveva già esistere un livello dicalpestio precedente. L’orizzonte risulta MM IB - II, con materiali più antichi (H. Onouphrios,Pyrgos, Neolitico). Nella fig. 68 sono presentati alcuni dei frammenti più significativi. DelMM IB si possono segnalare: un tratto di vaso aperto (a cestello?) con decorazione à la bar-botine (fasce di piccole protuberanze dentate, alternate a coppie di dischetti collegate datrattini); un altro con rosetta di dischetti e coroncina di punti al centro; due tratti di taz-za carenata con parete a scanalature orizzontali. Del MM II sono un frammento di orlo eparete di tazza emisferica eggshell, con motivo a squame, recante, all’interno di ogni ele-mento, un puntino rosso arancio circondato da quattro bianchi, molto simile a un esem-plare già noto 205; un beccuccio a ponte con decorazione in bianco. Assegnabili a un momen-to più maturo (MM IIB) ci sono sembrati: un tratto di orlo e spalla di olletta del tipo conbeccuccio, decorata con motivo a «corallo»; un frammento di orlo e spalla di pitharakiminiaturistico ricoperto di vernice rossa; un tratto di parete, verosimilmente pertinente auna grande coppa skyphoide, con decorazione a ramoscello obliquo 206. A questo taglioandrebbe attribuita l’olletta à la barbotine F. 4551 menzionata dal Levi 207.
La presenza di tre frammenti del MM II maturo, nel caso che la loro giacitura non fos-se stata condizionata dalle lacune del lastricato, dovrebbe spingere ad assegnare la posa inopera delle lastre superiori ad un momento del pieno MM II: bisognerebbe allora dedurreun periodo di vita relativamente breve per l’ultima sistemazione del Piazzale. Nel casoinvece di giacitura non primaria dei quei frammenti, sarebbe inevitabile pensare ai resti delgrande riempimento sopra al lastricato superiore effettuato con materiali dello strato didistruzione MM IIB al momento della costruzione del secondo Palazzo 208.
Il taglio successivo 209 conteneva materiali MM IB e MM IA, con residui più antichi (H.Onouphrios) e dovrebbe rappresentare il riempimento contenuto dal muro 36 per la siste-mazione del lastricato mediano. Nella fig. 69 si vedono due tratti di skoutelia MM IA del con-sueto tipo a fondo lavorato a mano con segni di ditate, ricoperto di vernice e decorato da unacoppia di fascette bianche sotto l’orlo; un frammento di orlo e parete di grossa ciotola conmotivo a ramoscello verticale stilizzato in rosso su fondo nero, con resti di altre decorazioniin bianco. Nella fig. 70 è illustrato un tratto di skouteli con segni di manipolazione e di tor-
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA70
in ascesa da Sud verso Nord: la quota di -0,90 m sot-to il lastricato corrisponderebbe in un caso a -1,30 ein un altro a -1,50 m dallo 0,00. Il riferimento eraprobabilmente ad una sezione citata in tale relazione,che non siamo riusciti al momento a rintracciare.
204 Collocazione: MS col. 68/13 (1a). Indicazioni:«21/8/64. Zona a N della Rampa presso «muro Pernier»strato superficiale (trincea… sa /..???) [cartacea 1];«28/8/64. Piazzale SO Zona a N rampa Saggio a Nmuro 36 da -0,30 a -0,60 sotto placostrato 3° fase[cartacea 2]; «F 64 PZ1/N. Saggio ad ovest Kulura aNord rampa 1° fase, dal placostrato 3° fase a -0,60[lignea]; «26/8/64. Piazzale SO (teatro). Zona a N d.Rampa. Saggio sotto le lastre di restauro; strato da -0,25a -0,45 sotto il livello del placostrato di 3° fase» (assie-
me a lamella di ossidiana) [cartacea 3].205 Cfr. LEVI 1976, tav. XVLVII b-c (F. 521, dal
vano XXVII-XXVIII).206 I due frammenti trovano confronti per la forma
o per la decorazione con materiali del vano LIII -LVsottoscala: cfr. LEVI 1976, tavv. 118 b, d (F. 1423 e F.1425) e 131d (F. 1431).
207 Vedi supra, p. 53, nota 169.208 Vedi supra, p. 48.209 Collocazione: MS col. 68/13(2). Indicazioni:
«29/8/64. Piazzale SO (Teatro). Saggio sotto le lastredi restauro (scilicet Pernier) da -0,60 a -0,80 sotto pla-costrato di 3° fase» [cartacea]; «F 64 PZ1/N. Saggio aN rampa 1° fase. -0,60 a -0,90 sotto il placostrato di3 a fase [lignea].
Creta Antica 8, 2007
sione, ma con parete meno spessa e profilo più regolare, assegnabile a un momento inizialedel MM IB, periodo inoltre rappresentato da diversi frammenti nelle varie tecniche à la bar-botine e di forme caratteristiche (coppa, olletta cilindrica, brocchetta). Da segnalare è anche uncalice miniaturistico lavorato a mano, tutto verniciato di nero; fra i materiali più recenti risultaun tratto della parte inferiore di una tazza carenata parimenti in nero (g), forse già del MM II.
REVISIONI FESTIE 71
Creta Antica 8, 2007
FIG. 70 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. SAGGIO 1. ESTENSIONE A NORD DEL TRATTO EST DEL MURO 36. FRAMMENTI DAL II TAGLIO.
FIG. 71 – COME SOPRA. FRAMMENTI DAL III TAGLIO FINO A QUOTA -1,50 M.
Con l’approfondimento fino a una quota di -1,50 m 210, i materiali del saggio mostranouna situazione solo in parte diversa, con una sostanziale equivalenza di frammenti MM IBe MM IA, insieme a cocci anteriori. Nella fig. 71 sono presentate ceramiche riferibili almomento più antico del MM, come un largo tratto di teiera tipo Patrikiès con serie di fascet-te oblique rosse affiancate da gruppi di tre linee parallele bianche; un frammento della par-te superiore di un’olletta con beccuccio aperto, verniciata di nero a superficie largamentescheggiata; uno di parete di brocchetta a costolature tipo Drakones; un tratto di parete dipiccola brocchetta globulare, con decorazione a fascette bianche oblique, alternate ad altre,più larghe, di colore rosso; una parte di fondo di vaso chiuso su piede a disco cavo, verni-ciato di nero all’esterno. Già al MM IB possono assegnarsi, illustrati nella fig. 72, un trattodi brocchetta askoide con serie di crescenti in scuro su chiaro; uno di grossa olla conservan-te un largo e corto becco in corrispondenza di quattro fori passanti, con decorazione in bian-co e in rosso; un frammento di orlo e parete di vaso verniciato di bruno all’interno e all’e-sterno, con fitti gruppi di tratti bianchi alternati ad altri rossi. Nella fig. 73 sono ben rap-presentati i materiali con superficie trattata à la barbotine, tra cui un elemento di vaso «agrattugia»; un tratto di orlo e parete di ampia coppa con parti della superficie interna incre-spate e con all’esterno serie di protuberanze sotto l’orlo, accompagnate da una costolaturamolto aggettante, a margine frastagliato; un frammento di orlo e parete di un’olla; l’orlo, ilcollo e la spalla di una tipica brocchetta, con zone increspate a rilievo ben marcato sulla spal-la e all’interno del collo, ricoperta di vernice nera e decorata in bianco e in rosso (fascettebianche e rosse sul collo, linee di puntini all’attacco della spalla, tratti obliqui bianchi alter-nati alle zone increspate, ecc.). Tra i materiali non trattati à la barbotine sono presentati, sem-pre nella fig. 73, un tratto di orlo e parete di coppa o tazza a parete curvilinea, con serie dicoppie di fascette verticali rosse congiunte da trattini obliqui e affiancate da più sottilifascette bianche; un frammento di vaso a secchiello con becco ed orlo piatto dai marginiaggettanti e frastagliati su entrambi i lati, decorato in bianco e in rosso. Alla fig. 74 è illu-strata ancora la parte inferiore di una brocchetta decorata con fasce verticali in rosso, alter-nate a gruppi di tre fascette bianche più sottili. Nella stessa figura gli skoutelia sono rappre-sentati da un esemplare di grande formato (F. 8094), mancante solo di un tratto di orlo, deltipo con fondo ristretto manualmente a formare una sorta di rudimentale carenatura, carat-teristico dei contesti MM IB, e da poco meno della metà di un altro di forma analoga, madi piccolo formato, del tipo con parte superiore dipinta per immersione (in bruno rossastro,all’interno e all’esterno). A questi materiali si possono associare un elemento di grattugia (F.4552a) e un beccuccio di olla con doppio canale (F. 4552b) 211.
Ormai verosimilmente in rapporto con il piano di preparazione per la stesura dellastricato inferiore andrebbe considerato il quarto taglio tra -1,50 e -1,80 m 212, anche senella relazione della responsabile di trincea non è fatto alcun riferimento a tale lastricato 213.Ne conseguirebbe, apparentemente, che la rampa di I fase dovesse arrestarsi in corrispon-denza con il muro 36, ma la circostanza sembrerebbe contraddetta dalla modesta qualitàdella muratura (che non pare avesse avuto una faccia nord, neanche nel tratto meglio con-servato, presso la vasca XXX) e dall’andamento irregolare dell’intera struttura 36. È quin-
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA72
210 Collocazione: MS col. 68/14 (3). Indicazioni:«29/8/64. Piazzale SO (Teatro). Zona a Nord delmuro 36, sotto le lastre Pernier da -0,90 a -1,50».
211 Vedi supra, p. 53, nota 168.
212 Collocazione: MS col. 68/14(4). Indicazioni: «29/8/64. Piazzale SO (Teatro). Zona a Nord del muro36, sotto le lastre Pernier, da -1,50 a -1,80».
213 Relazione Vaccaro 1964, p. 3.
Creta Antica 8, 2007
di verosimile che il lastricato inferiore proseguisse anche verso Nord e che in quest’area ofosse andato distrutto o le lastre fossero state recuperate in occasione della sistemazione delmediano. L’orizzonte dei frammenti risulta ormai fondamentalmente MM IA e più antico,con la presenza solo di qualche coccio MM IB.
I due skoutelia della fig. 75 sono rappresentativi della produzione MM IA, a paretealquanto spessa, con ampia zona manipolata all’esterno e superficie lisciata presso l’orlo e
REVISIONI FESTIE 73
Creta Antica 8, 2007
FIGG. 72-73 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. SAGGIO 1. ESTENSIONE A NORD DEL TRATTO EST DEL MURO 36.FRAMMENTI DAL III TAGLIO FINO A QUOTA -1,50 M.
FIG. 74 – COME SOPRA. SKOUTELI F. 8094 E ALTRI FRAMMENTI.
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA74
Creta Antica 8, 2007
FIGG. 75-76 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. SAGGIO 1.ESTENSIONE A NORD DEL TRATTO EST DEL MURO 36. MATERIALI
DAL IV TAGLIO FINO A QUOTA -1,80 M.
FIG. 77 – COME SOPRA. FRAMMENTI DAL V TAGLIO.
all’interno. Nella fig. 76 sono illustrati, assieme a frammenti tipici del MM IA (orli ed ansedi olle, orlo di piattello), alcuni cocci MM IB, tra cui un tratto di parete, forse di broc-chetta à la barbotine con zona barnacle, delimitata da una fascetta rosso arancio e un piùampio tratto di orlo e parete di coppa a orlo ondulato con resti di decorazione in bianco.Significativo è un frammento di rhytòn plastico del tipo a figura bovina, conservante partedella testa (attacco delle corna e resto di un occhio, indicato con una piccola incisione cir-colare), con foro di alimentazione 214.
L’ultimo taglio 215 rispecchia la situazione anteriore al progetto di sistemazione dell’a-rea ed offre, insieme con materiale più antico, un magnifico orizzonte MM IA, a confermadell’intensa frequentazione, in questo periodo, dell’intera sommità della bassa collina poioccupata dal palazzo. A tale collina ascendeva, come già detto, la più antica delle rampelastricate, mentre anche nella fascia subito ad Ovest, sotto il vano CIX, erano sicuramentelivelli di abitazione 216.
La presenza di ceramiche più antiche è documentata nella fig. 77 in cui, assieme aframmenti di stile H. Onouphrios dell’ AM IIA, fine (a-b) e grezzo (c), e ad altri avvicina-bili a un orizzonte MM IA (g-k), ne vediamo alcuni caratterizzati da una decorazione inbianco-crema che sembrerebbero ricondurre al c.d. stile bianco dell’AM IIB -III (d-f).Esempi tipici di un MM IA maturo sono, nella fig. 78, un tratto di spalla e collo di broc-chetta del tipo «a pelta», largamente attestato in contesti ben databili di Haghia Triada;un frammento di orlo e parete di grande piatto (b), verniciato di bruno all’interno e all’e-sterno e decorato in bianco solo all’interno, con coppie di archetti concentrici a festone ecerchi parimenti concentrici sulla vasca. Allo stesso orizzonte appartiene il frammento diuno skouteli medio-piccolo (c), completamente ricoperto di vernice bruno rossiccia, con leconsuete fascette bianche all’esterno, sotto l’orlo. Decorazione sovradipinta in bianco (ellis-si attorno all’attacco dell’ansa; fascetta e dischetto tra linee oblique e puntini) presentaancora un frammento di brocchetta (d), mentre un tratto di orlo e parete di vaso più gran-de (e), di impasto grezzo, forse un pitharaki, caratterizzato da un orlo arrotondato, appiat-tito alla sommità ed aggettante sia all’interno che all’esterno, mostra una decorazione inbianco e rosso (trattini obliqui alla sommità dell’orlo; fascetta rossa sotto l’orlo da cui sidipartono altre fascette verticali, leggermente oblique, alternate a un motivo in bianco,costituto da una coppia di sottili linee verticali parallele, contenenti una fila di puntini).
Nella ristretta zona del Saggio 2, le indicazioni di profondità si riferiscono al «cigliodel muro 37», oppure alla sua base. I materiali del livello più alto occupavano in parte lospessore del muro, ma andavano anche al di sotto della quota della sua base 217. Pur non par-ticolarmente significativi, essi consentono di delineare un orizzonte MM IA, con qualchecoccio MM IB 218. Il taglio successivo si riferisce già sicuramente a livelli tutti al di sotto
REVISIONI FESTIE 75
214 Il frammento è pertinente a un tipo analogo aquelli dal bancone del vano IL (F. 21, 27, 28: LEVI
1976, tav. 161; cfr. LEVI - CARINCI 1988, tav. 64d), inquel caso attribuiti, ma solo per le associazioni delcontesto, a un momento iniziale del MM II. Di fatto,il tipo può risalire al MM IB. Cfr. S. XANTHOUDIDES,The Vaulted Tombs of Mesarà, London 1924, tavv. 30(4986) e 37 (5053).
215 Collocazione: MS col. 68/14 (5). Indicazioni: «5/9/64. Piazzale SO. Saggio a N muro 36; strato da m 2
alla roccia sotto placostrato di 3° fase [cartacea]. «F64 Pz1/N. Saggio a N rampa 1° fase; -1,80 sotto pla-costrato 3° fase fino a roccia [lignea].
216 LA ROSA 1998-2000, pp. 73-74.217 Le quote del piede del muro 37 variano da -1,85
ad Ovest a -1,12 m ad Est.218 Collocazione: MS col. 68/15 (6). Indicazioni: «25/
8/64. (Teatro). Zona a N della rampa. Saggio tra vascaXXX, muro 36, muro 37; strato da m -0,50 a m 1,20 dalciglio del muro 37» [cartacea]. «F 64. Pz1/N. Saggio
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA76
Creta Antica 8, 2007
FIGG. 79-80 – COME SOPRA. SAGGIO 2. FRAMMENTI DAL II TAGLIO.
FIG. 78 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. SAGGIO 1. ESTENSIONE A NORD DEL TRATTO EST DEL MURO 36. FRAMMENTI DAL V TAGLIO.
della base del muro e può quindi fornire indicazioni per l’interro trattenuto dalla struttu-ra 36 219, interro che, a sua volta, potrebbe provenire dallo sbancamento per la sistemazio-ne dell’attigua e contemporanea Vasca XXX. Il materiale presente ( fig. 79) è in buona par-te MM IA (caratteristici gli orli di skoutelia verniciati con doppia fascetta bianca, quelli diollette con trattini obliqui bianchi su fondo nero; un tratto di brocchetta con nervatureoblique ecc.), con poco AM (notevole un beccuccio di teiera H. Onouphrios decorata sulcorpo con motivo a reticolo) e solo tre frammenti MM IB ( fig. 80), con decorazioni sovra-dipinte in bianco e in rosso. L’ultima indicazione si riferisce a materiali fino a -0,90 m sot-to la base del muro, con l’aggiunta di un dato in parte fuorviante, relativo ad un livelloinferiore alla rampa di I fase. I frammenti potrebbero collegarsi sia al riempimento dietroil muro 36, sia all’interro per la messa in opera del lastricato mediano, lì rappresentato dalmuretto di limite occidentale di quota -0,86 m (tav. B) 220. Ben documentato è il MM IB( figg. 81-82), in larga misura del tipo con superficie à la barbotine, come un frammento dibacino pithoide con orlo sagomato e appiattito superiormente, decorato in rosso e in bian-co; tratti di orlo e parete di forme aperte (bacinelle o piatti) con superficie increspata e bar-nacle anche all’interno; orlo di olletta con fascette oblique rosse e protuberanze coniche;tratto di brocchetta del tipo a zone alternativamente increspate e lisce e con gruppi di lineeoblique, decorata nella tecnica in scuro su chiaro. Tra i frammenti a superficie liscia il piùnotevole appare un tratto di piatto parzialmente verniciato all’esterno e decorato all’inter-no con fascette bianche e rosse, che delimitano linee ondulate e file di puntini bianchi. Gliskoutelia risultano del solito tipo con riprese manuali, ma già con un profilo tendente al cur-vilineo. La ceramica semigrezza decorata in scuro su chiaro è rappresentata da un orlo distamnos con largo sgrondo (sotto il quale è una coppia di festoni), che presenta diversi gru-mi di calce sia all’interno che all’esterno; interessante è infine un tratto di fondo di vaso diforma chiusa (brocchetta?) con piede a disco pieno aggettante e fascetta rossa poco più inalto sull’attacco della parete (di importazione?).
Nell’ambito dello stesso Saggio 2, fu eseguito un allargamento lungo il tratto occi-dentale del muro 37, al di sotto della sua base. I materiali dovrebbero pertanto ancora rife-rirsi all’interro trattenuto dal muro 35, per l’innalzamento del livello delle lastre nella fasemediana 221. Nel piccolo gruppo di cocci ( fig. 83), oltre a materiali più antichi (orlo di cop-
REVISIONI FESTIE 77
tra muro 36, muro 37 e vasca XXX. Strato da -0,50 a-0,70 dal ciglio del muro 37 [lignea]. Il registro delMS di Festòs in riferimento alla cassetta 6 dell’«ElencoVaccaro», reca l’indicazione: «da -0,50 a -1,20 sotto ilciglio del muro 37».
219 Collocazione: MS col. 68/15 (7a). Indicazioni:«4/9/ 64. Piazzale SO; saggio sotto muro 37, da -015 a-0,30 sotto la base del muro [cartacea]. «4/9/64.Piazzale SO; saggio sotto muro 37, da -0,30 a -0,55sotto la base del muro [altra cartacea]. «F 64 Pz1/N.Saggio sotto muro 37; dalla base d. muro a -0,90[lignea]. Registro del MS: «dal ciglio inferiore del muroa -0,55». L’indicazione «fino a -0,90» del cartellinoligneo è visibilmente un errore, dal momento che laquota raggiunta dal taglio era quella di -0,55 m.
220 Collocazione: MS col. 68/15 (8). Indicazioni: «4/
9/64. Saggio sotto muro 37; da -0,55 a -0,90 sottomuro 37, sotto la base del muro (livello inferiore allarampa di I fase) [quest’ultima indicazione, aggiunta amano con diverso inchiostro sul cartellino cartaceo,dovrebbe far pensare che fino a -0,55 non era segnala-to alcun rapporto con il livello della rampa inferiore].«F 64 Pz1/N. Saggio tra muro 36 muro 37 e vascaXXX; da -0,55 a -0,90 [lignea]. Nel registro del MS:«da -0,55 a -0,90, sotto il ciglio inferiore d. muro».
221 Collocazione: MS col. 68/15 (7b). Indicazioni: «5/9/64. Sotto il muro 37 (2) (a m 4,50 dal limite Ovestdel muro), dalla base del muro alla rampa di 1a fase»[cartacea]. «F 64 Pz1/N. Saggio sotto muro 37 (2a)[lignea]. Registro del MS: «Tratto del muro 37 nondisegnato dal Pernier».
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA78
Creta Antica 8, 2007
FIGG. 81-82 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. SAGGIO 2. FRAMMENTI DAL III TAGLIO, SOTTO LA BASE DEL MURO 36, FINO A -0,90 M.
pa Pyrgos pattern burnished, a fascette e tratti obliqui) è rappresentato il MM IA (skouteli equalche altro frammento non classificabile), mentre due cocci à la barbotine e uno a super-ficie liscia, decorati in rosso e in bianco, sembrano riferibili al MM IB. Minuti frammenti(due orli di tazza, uno con decorazione a fascette verticali rosse e bianche, l’altro con trac-ce di fascetta bianca, e un piccolissimo tratto di tazza carenata) possono appartenere già alMM II iniziale e costituiscono pertanto il materiale più recente.
Un utile elemento di datazione per l’impianto della Vasca XXX può venire da un vasoquasi intero rinvenuto nel 1992, nel corso dei lavori presso l’attigua fornace da vasaio, pro-prio nella stretta fascia, inzeppata con pietrame, che separa il limite ovest della vasca daiparalleli filari inferiori del muro 38. Si tratta di un esemplare in formato medio-piccolo di
REVISIONI FESTIE 79
Creta Antica 8, 2007
FIG. 83 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. SAGGIO 2. FRAMMENTI DALL’ALLARGAMENTO LUNGO IL TRATTO OCCIDENTALE
DEL MURO 37, AL DI SOTTO DELLA SUA BASE.
FIG. 84 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. VASO F. 7343, RECUPE-RATO NELLA STRETTA FASCIA TRA IL LIMITE OVEST DELLA VASCA XXX EI FILARI INFERIORI DEL MURO 38.
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA80
Creta Antica 8, 2007
FIG. 85 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. RESTAURI 2004. FRAMMENTI DALLA TERRA SOTTO IL MURO 37.
FIG. 86 – COME SOPRA. FRAMMENTI DALLA TERRA SOTTO LA SPALLETTA
DEI TRE GRADINI A SUD DELLA VASCA XXX (MURO 33).
giaretta con ampia imboccatura e sgrondo (F. 7343; fig. 84), per la quale confronti calzan-ti sono possibili in contesti MM IB maturo /MM II iniziale 222.
Gli ultimi dati in nostro possesso si riferiscono ad alcuni frammenti recuperati inoccasione dei restauri greci del 2004 tra la terra al di sotto sia del muro 37 223, sia dellaspalletta dei tre gradini a Sud della Vasca XXX 224. I materiali del primo gruppo, che pos-sono essere messi in rapporto con l’interro trattenuto dal muro 35 (dal momento che il 37poggiava direttamente, al limite est, sulla sommità conservata dell’altro), mostrano unchiaro orizzonte MM IB, a conferma del fatto che il muro 37 aveva appunto sfruttato ilriempimento del lastricato mediano. Nella fig. 85 si distinguono: un tratto di piccoloskouteli a parete lievemente carenata, con segni di lavorazione manuale e di distacco dalpiano di lavoro, tipico del MM IB; uno di bacino con superficie interna rivestita da fineingubbiatura, decorato a fasce orizzontali; un frammento di orlo di olletta con elemento«frangiato» rosso. Nel secondo gruppo, in un orizzonte sempre del MM IB ( figg. 86-87),rappresentato da frammenti di vasi di forma chiusa o aperta con decorazioni lineari in
REVISIONI FESTIE 81
222 Cfr. p. es. LEVI 1976, tav. 20d (F. 2213, dallivello inferiore del vano LXV). Numerosi esemplari an-che dal Bastione II: cfr. LEVI -CARINCI 1988, tav. 17 f, g(F. 2216-2224, F. 1918, F. 2220, questi rappresenta-tivi di un momento iniziale del MM II).
223 Collocazione: Mag. 7, cass. 868 e. Indicazioni (inNeogreco): «6/2/2004. Muro di III fase protopalazia-le; frammenti dalla fondazione di terra dietro all’e-stremità orientale del muro (gruppo 3)».Collocazione: Mag. 7, cass. 868 f. Indicazioni (in Neo-
greco): «9/2/2004. Muro di III fase protopalaziale;frammenti dalla fondazione di terra ad Est e ad Ovestdella canaletta (scilicet quella realizzata durante i re-stauri all’angolo del muro 36 e del tratto ovest con-servato del lastricato superiore) (gruppo 4)».
224 Collocazione: Mag. 7, cass. 867 e. Indicazioni (inNeogreco): «19/2/04. Muro a Sud del bacino di purifi-cazione XXX della II fase protopalaziale; frammentidalla terra sotto il muro (gruppo 13)».
Creta Antica 8, 2007
FIG. 87 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. RESTAURI 2004. FRAMMENTI DALLA TERRA SOTTO LA SPALLETTA
DEI TRE GRADINI A SUD DELLA VASCA XXX (MURO 33).
bianco e rosso, e di brocchette con superficie à la barbotine, assieme ai soliti skoutelia confondo rastremato ed accenno di carenatura, si osserva la presenza di due tratti di pareti divasi in ceramica fine (probabilmente ollette) verniciati di nero con motivi curvilinei sovra-dipinti in bianco e rosso e di uno pure verniciato di nero (fondo di grande tazza cilindri-ca) con sottili solchi da tornitura. Questi ultimi possono attribuirsi a un momento leg-germente più avanzato, con ogni verosimiglianza all’inizio del MM II. Tali indicazionicostituiscono un’utile conferma per la datazione dell’apprestamento della spalletta con irelativi gradini, nell’ultimo rifacimento dell’ingresso sud-ovest del Piazzale I.
Possiamo, a questo punto, tentare una ripresa conclusiva dei dati stratigrafici e cro-nologici relativi al settore sud-ovest del nostro piazzale. Per comodità e chiarezza caratte-rizzeremo le tre fasi individuate facendo ricorso, anche in uno sforzo di semplificazione,agli apprestamenti o alle strutture di carattere cultuale-liturgico che le hanno caratteriz-zate in successione 225.
Fase del betiloÈ il momento dell’impianto originario del lastricato, la cui area di estensione non è
agevolmente precisabile ( fig. 88). Non concorderemmo con il Levi nel limitarla, in ognicaso, alla spalletta del muro 36. È anche quello della collocazione dell’apprestamento beti-lico, dei filari inferiori del muro di limite orientale della Strada dal Nord, della rampaascendente mediana, del lastricato inferiore al di sotto della fornace da vasaio, del vano Ce del suo altare, nonché del raddrizzamento del tracciato della Strada dal Nord, sistemataanch’essa a lastricato nel suo settore meridionale (con l’abbandono dell’originaria spallet-ta trasversale). La costruzione del muro di limite di tale strada sancisce compiutamente laseparazione tra piazzale e asse viario, soppiantando il muro obliquo lungo il margine estdi quest’ultimo. Tale muro-spalletta dovrebbe piuttosto appartenere al momento dellarampa in stucco o argilla ascendente dall’area del Piazzale LXX, momento in cui è stataipotizzata l’esistenza dei primi vani nella fascia subito ad Ovest della spalletta in que-stione, la quale avrebbe potuto addirittura segnare un primo, provvisorio limite dell’areapoi destinata al Piazzale I. Occorre altresì ribadire le perplessità sull’appartenenza a que-sta fase dei remoti tratti di lastricati o acciottolati presso la facciata ad ortostati e la gra-dinata teatrale.
Dal punto di vista cronologico i pochi elementi raccolti autorizzerebbero a collocarela fase del betilo agli inizi del MM IB. Questo dato sarebbe apparentemente in contrad-dizione con la assai più ricca successione stratigrafica e cronologica documentabile per l’a-rea della vicina Strada dal Nord. Nel quadro riassuntivo a suo tempo proposto 226, infatti,la rampa ascendente mediana, da noi ritenuta coeva al betilo, si collocherebbe nel terzodei quattro momenti MM IB distinti, e dunque subito prima di quello finale. Non aven-do alcun dato cogente per rimettere in discussione quella ricostruzione, non resta che con-siderare i primi tre episodi del MM IB come molto ravvicinati nel tempo, ed in definiti-va tutti appartenenti ad una fase iniziale di questo periodo. In tal modo riusciremmoaddirittura ad integrare la pur dettagliata sequenza della Strada dal Nord, grazie ai datiapparentemente lacunosi dall’angolo sud-ovest del Piazzale I.
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA82
225 Cfr. anche F. CARINCI, Per una diversa interpre-tazione delle kouloure nei cortili occidentali dei palaz-
zi minoici, in Creta Antica 2, 2001, pp. 43-62.226 LA ROSA 2002, p. 735.
Creta Antica 8, 2007
Creta Antica 8, 2007
FIG.8
8 –
PIA
ZZ
ALE
I, SE
TT
OR
ESU
D-O
VES
T. P
IAN
TAC
ON
L’IN
DIC
AZ
ION
ED
ELLE
SUC
CES
SIV
EFA
SID
IIN
TER
VEN
TO
(ELA
BO
RA
ZIO
NE
DA
LEV
I19
76).
REVISIONI FESTIE 83
Fase della Vasca lustrale XXXÈ questo il momento del lastricato mediano (ma con riuso di tratti di quello inferio-
re nella fascia meridionale), e dell’impianto della vasca con la spalletta sud ( fig. 88).Rimane in uso anche il muro di limite est della Strada dal Nord ed in vista il betilo, men-tre la rampa di ascesa dal Piazzale LXX è certamente quella superiore (insieme con illastricato più alto dentro la fornace). Un pianerottolo con gradino dell’alzata di circa20/25 cm 227 doveva raccordarsi con la quota del muretto di limite ovest presso la vasca (lacui costruzione fu responsabile dell’innalzamento del livello) e con quella del tratto dilastricato tra la Kouloura I e il marciapiede soprelevato.
Il punto di forza per la datazione di questa fase è rappresentato dall’identità di trac-ciato e di livello tra il pianerottolo di ingresso e la rampa ascendente superiore, che ave-vamo già avuto modo di collocare agli inizi del MM II 228. Una cogente coincidenza è rap-presentata dallo stamnos relativo al momento di messa in opera della Vasca XXX. Ad abun-dantiam potremmo anche far riferimento al frammento di tazzina carenata rinvenuto aNord del muro 36, messo in rapporto con l’interro del lastricato mediano 229. Agli inizi delMM II proponiamo dunque di assegnare la fase della vasca. È significativo che la grandequantità di ceramica MM IB impiegata nei riempimenti di tale fase trovi un precisoriscontro nei tanti livelli della vicina Strada dal Nord 230.
È indispensabile a questo punto chiedersi cosa si riferisse al nostro periodo nel restan-te settore del piazzale, soprattutto in relazione alle due macroscopiche realizzazioni, fra diloro sicuramente da collegare, della facciata a ortostati e della gradinata teatrale. I pochidati disponibili per il saggio Levi presso la facciata consigliano di considerare terminus adquem i materiali nello strato di calce cinerea ad essa addossata, già riferiti al MM II. In talcaso, lo stucco rosso, con la sua teierina à la barbotine, corrisponderebbe come livello allastricato inferiore (senza che questo debba necessariamente comportare un’assegnazioneal MM IA del tratto di lastricato/acciottolato ancora al di sotto). Nuovi dati saranno poinecessari per collocare più precisamente, tra la fase della vasca e quella successiva della/eKouloura/Koloures, il grandioso episodio della facciata a ortostati e dell’area teatrale.
Fase della/e Kouloura/KoulouresAppartengono a questa terza fase i tre gradini e la relativa spalletta, il muro 37 e la/le
Kouloura/Kouloures. Rimane in uso la Vasca XXX, viene obliterato il betilo e si ricostruisceil muro di limite est della Strada dal Nord, raccordandolo con la spalletta dei gradini diingresso al Piazzale I. Si solleva il livello del lastricato fino al limite del muro 37, mentreviene ancora calpestata, dopo il necessario raccordo, la gran parte del lastricato precedente.Parimenti in uso restano la rampa ascendente superiore e lo sbocco sul pianerottolo ( fig. 88).
Non sarà forse più possibile accertare se l’intera fascia adiacente alle Kouloures, anchead Est della strada ellenistica (lì dove le lastre del piazzale sono completamente scompar-se), fosse stata coinvolta nella ripresa-rialzamento di questo terzo momento. È in ogni casoutile notare che la Kouloura più orientale (ed anche la meno conservata), presenta, sotto l’a-nello superiore di restauro moderno, almeno tre o quattro filari di grandi blocchi sbozzati
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA84
227 Il valore si ottiene considerando la differenza diquota tra il livello del lastricato inferiore nell’angolonord-est presso la Kouloura I e la sommità conserva-ta, sempre ad Est, del muro 35.
228 CARINCI -LA ROSA 2002.229 Vedi supra, p. 71.230 LA ROSA 2002, pp. 734-736.
Creta Antica 8, 2007
( fig. 89), in una tecnica nettamente diversa da quella usata nelle altre, in cui blocchi qua-si dello stesso tipo risultano impiegati soltanto nei filari più bassi. Una tecnica abbastanzasimile caratterizza anche il muro 37; qualche blocco, assai meno regolare, è presente nelfilare basso del muro 35. Il dettaglio, se non indica un momento cronologico diverso dimessa in opera, può forse essere giustificato da una funzione di contenimento della paretedella Kouloura orientale, dato anche il fatto che la sua porzione conservata è quella a ridos-so del terrapieno del Piazzale I. Va infine tenuta presente, per la Kouloura in questione, l’os-servazione del Platon che il muro di spina orientale facente sistema con quello di conteni-mento del Piazzale I (nel settore andato distrutto) sembra proseguire oltre il contorno del-la Kouloura, facendo supporre un abbandono di quella costruzione circolare anteriormentealla messa in opera del sistema di terrazzamento-contenimento 231.
REVISIONI FESTIE 85
231 PLATON 1968, p. 31, nota 1. Una revisione del-le quote ed un riesame (già in programma) dei mate-riali relativi a quel possente gruppo di murature,
potrebbe consentire di riprendere in esame il proble-ma e di valutare le eventuali conseguenze cronologi-che e costruttive per le vicende del Piazzale I.
Creta Antica 8, 2007
FIG. 89 – PIAZZALE I, LIMITE MERIDIONALE. LE KOULOURES III e IV. DA EST.
A questa fase dovrebbe appartenere anche il tratto di marciapiede soprelevato che cor-re a Nord delle Kouloures ( fig. 90) e che risulta sovrapposto alle lastre, laddove quello prin-cipale, che raggiungeva anche i gradini del teatro ( fig. 91), era certamente raccordato conle lastre stesse (con una canaletta di deflusso lungo la faccia nord) e potrebbe teoricamenteriferirsi anche alla fase di costruzione della Vasca XXX.
L’indicazione cronologica più probante si ricava dai pochi frammenti MM II recupe-rati nella terra sotto la spalletta dei gradini; ma possiamo anche richiamare il gruppetto dimateriali della fascia fra Kouloura I e marciapiede soprelevato, dove il MM II è ben rappre-sentato. Assegnando dunque a tale periodo anche la fase della/e Kouloura/Kouloures, non pos-siamo non evidenziare il lasso di tempo relativamente breve intercorso dalla sistemazionedella Vasca XXX.
In conclusione, i tre livelli di lastricato proposti a suo tempo dal Levi risulterebberoconfermati: con la sola, paradossale differenza che le relative fasi costruttive si sarebberotutte consumate nell’arco della I fase protopalaziale (visto che il momento di distruzionedella sua Ib è caratterizzato da ceramica del MM IIB finale).
Pur esulando dai limiti che ci eravamo proposti, è opportuno, per completare la rico-struzione delle vicende all’interno del Piazzale I, far cenno ad un altro paio di episodi, for-se da promuovere al rango di fasi.
Fase dei sacelliAvevamo altrove così indicato un periodo di tempo abbastanza breve fra due successi-
vi episodi sismici, concomitanti alla fine del Primo Palazzo. Ad una tale fase avevamoappunto attribuito, oltre ai tre ambienti addossati alla facciata ad ortostati, l’impianto ori-ginario della casa a Sud della Rampa e la più volte citata fornace, subito ad Est del nostropianerottolo 232. La presente rilettura consente forse di proporre una verifica cronologica peril momento di messa in opera dei sacelli, nel quale era in uso il piano di calpestio funzio-nale anche alla vita della/e Kouloura/Kouloures. Il dato proviene indirettamente dalla citatateierina Pernier al di sotto del vano VIII 233, proprio quello messo in comunicazione con isacelli tramite la rimozione di un ortostate. Il silenzio del primo scavatore riguardo ad unlivello pavimentale più basso, come invece da lui riferito per altri vani della stessa ala delpalazzo, non impedisce di supporre almeno un rifacimento dell’unico piano pavimentalesegnalato, lì dove si ricorda l’alternanza di lastre alabastrine e di stucco bianco e, soprat-tutto, la sovrapposizione di un rivestimento di lastre sull’intonaco di calce al di sopra del-le banchine. L’isolata, ma intera, teierina di un momento maturo del MM II 234 rinvenutasotto il livello del pavimento, potrebbe allora essere messa in rapporto con il rifacimentoed il rivestimento in lastre alabastrine, e dunque con la rimozione dell’ortostate e la costru-zione dei sacelli.
Il loro momento di distruzione, ben collocato alla fine del MM IIB sulla base dei cor-redi pavimentali 235, potrebbe non aver avuto specifiche conseguenze per la frequentazionedi questo settore del Piazzale. Non si può dire lo stesso, come già ricordato, per l’estremafascia ovest, adiacente alla vasca, sicuramente obliterata dai crolli di una fase architettoni-ca del Bastione ovest 236.
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA86
232 LA ROSA 2002, pp. 716-717.233 Vedi supra p. 30s.234 Cfr., per il tipo, F. 1447, dal vano LVIII: LEVI-
CARINCI 1988, tav. 43 p.235 PERNIER 1935, pp. 219-234.236 Vedi supra, p. 55.
Creta Antica 8, 2007
Creta Antica 8, 2007
FIG. 90 – PIAZZALE I, SETTORE SUD-OVEST. TRATTO DI MARCIAPIEDE SOPRELEVATO
A NORD DELLE KOULOURES SOVRAPPOSTO ALLE LASTRE. DA OVEST.
FIG. 91 – PIAZZALE I. TRATTO DEL MARCIAPIEDE SOPRELEVATO PRINCIPALE DIRETTO AI GRADINI DEL TEATRO RACCORDATO CON
LE LASTRE DELLA PAVIMENTAZIONE E FORNITO DI UNA CANALETTA DI DEFLUSSO. DA SUD.
Fase della Garitta CIVLa secolare storia del Piazzale I si conclude con la costruzione della Garitta CIV, ormai
nel MM IIIA, contemporanea a una ripresa della spalletta della rampa ascendente, ma conla facciata ad ortostati ormai rasata e colmata di calcestruzzo. Dovremo attendere gli inizidel TM IB 237 perché un’ennesima colmata, questa volta del «riempiticcio» costituito daastraki sbriciolato, nasconda per sempre le belle lastre e i cinque gradini inferiori dell’im-ponente gradinata teatrale 238.
Future ricerche, a cominciare dalle fasi cronologiche e funzionali del Bastione ovest,dovranno consentire un riesame dell’intera area del Piazzale I, ma ci sentiremmo di sotto-lineare, fin da adesso, almeno tre aspetti, confermati dalla presente indagine:
a) la specifica destinazione religiosa dell’area in questione, verosimilmente delimitataab origine sui diversi lati ed il suo stretto rapporto con l’edificio palaziale;
b) le «variazioni» delle forme di religiosità palatina esemplificati dagli apprestamen-ti delle diverse fasi e dal gioco delle loro coesistenze (betilo-vasca/vasca-Kouloures). Questasuccessione sembrerebbe adombrare un percorso verso forme partecipative sempre più com-plesse, solenni ed aggreganti del rituale e della religiosità protopalaziale 239;
c) la teorica possibilità di una sorta di pre-piazzale, o comunque di una piattaformaper liturgie, identificabile nella zona del muro arcuato, precedente ma contigua alla gradi-nata teatrale, in un contesto non funerario, ma abitativo 240.
4. - Il raccordo tra il Piazzale I e il Cortile centrale XXXIII/40
Il riesame finora condotto sia del Cortile Centrale che del Piazzale I rende indispensa-bile anche una rivisitazione della fascia di raccordo tra queste due aree, corrispondente nelsuo insieme al Corridoio III/7 e al Propileo II.
4.1 Corridoio III/7La comunicazione tra il Piazzale I e il Cortile centrale si realizzava, al di là dell’acces-
so monumentale rappresentato dal Propileo II, attraverso un corridoio (III) messo in luceper il tratto occidentale già negli scavi del Pernier e ulteriormente indagato dal Levi, nel-l’ampio saggio effettuato sotto il lastricato neopalaziale del Corridoio 7 241.
Dei molteplici livelli e strutture architettoniche messi in luce in questo saggio ( fig.92), è di precipuo interesse per la nostra indagine il grande e lungo muro a 242 (figg. Levi388-391). Era di direzione Est-Ovest, largo m 1,30/1,40 ed aveva il piede, all’estremitàorientale, a quota -0,70 m rispetto alle lastre della soglia verso il Cortile centrale 243. Fu
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA88
237 V. LA ROSA, Pour une révision préliminaire duSecond Palais de Phaistos, in Monuments of Minos: Re-thinking the Minoan Palaces, J. DRIESSEN, I. SCHOEP andR. LAFFINEUR edd. (Aegaeum 23), Liège 2002, pp. 81-83.
238 L. PERNIER, Teatro e arena nel palazzo di Festo all’e-poca di Minosse, in Dioniso III, 5-6, 1933, pp. 289-294.
239 Cfr. V. LA ROSA, Minoan Baetyls: between Fu-nerary Rituals and Epiphanies, in Potnia. Deities and re-ligion in the Aegaean Bronze Age, R. LAFFINEUR-R. HÄGG
edd. (Aegaeum 22), Liège 2001, pp. 221-226.
240 Cfr. F. CARINCI, Priests in action: considerazionisulla fine dell’età prepalaziale ad H. Triada, in CretaAntica 5, 2004, pp. 25- 41.
241 LEVI 1976, pp. 246-262, tav. T.242 LEVI 1976, figg. 388-391.243 LEVI 1976, p. 260. Lo 0,00 del saggio dovreb-
be corrispondere alla quota di +1,98 m rispetto aquella di riferimento generale del Pernier, adottatadal Levi e nei saggi degli anni recenti, equivalentealla quota s.l.m. di 93,54 m.
Creta Antica 8, 2007
REVISIONI FESTIE 89
Creta Antica 8, 2007
FIG.9
2 –
CO
RR
IDO
IOII
I/7.
PLA
NIM
ETR
IAG
ENER
ALE
ESE
ZIO
NE
OV
EST-
EST
(DA
LEV
I19
76).
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA90
Creta Antica 8, 2007
seguìto per l’intera lunghezza del saggio (circa 18 m); la sua sommità, in pendio da Ovestverso Est, variava da quota -1,14 a -0,41 m. La struttura proseguiva oltre il limite ovestdel saggio, fino all’angolo con un muro Nord-Sud, già individuato dal Pernier, ormai nel-l’area del vano XXI 244. Sarebbe all’uopo di grande interesse disporre di dati più precisi aproposito di un saggio eseguito da Halbherr nel 1904, proprio al di sotto della pareteorientale del vano in questione. In quell’occasione vennero infatti segnalati i resti di unmuro più antico (con direzione Nord-Est/Sud-Ovest, e quindi forse appena divergenterispetto alla sovrastante parete), che fu attribuito dallo scavatore ad una casa anteriore alPalazzo, «distrutta o coperta dalle costruzioni di esso»245.
Il muro a costituiva il limite nord di due livelli lastricati sovrapposti (quello inferio-re molto mal ridotto), che salivano verso il Cortile centrale, assegnati dal Levi rispettiva-mente alla III ed alla II fase protopalaziale; il muraglione a sarebbe stato, cioè, messo inopera per un corridoio della II fase e «riadattato nella costruzione della III»246. Presso illimite ovest del Corridoio viene addirittura riferita, al di sotto dei lastricati, l’esistenza diun «terzo piano pavimentale, costituito questo da un livello di piccole pietre accostate leune alle altre»247. Per lo strato fra il lastricato inferiore e tale acciottolato di pietruzze sono(solo) ricordati frammenti à la barbotine, insieme con materiale più antico, mentre al di sot-to sarebbero stati raccolti, insieme con ceramica neolitica, alcuni frammenti di skoutelia.Tali materiali consentirebbero, secondo il Levi, di assegnare l’acciottolato 248 alla prima faseprotopalaziale, con la conseguenza, sopra anticipata, di un’automatica attribuzione alla IIe alla III dei lastricati soprastanti.
La fascia nord del saggio era occupata in larga parte da un elegante ambiente pamen-tato in lastre alabastrine (lungo 11,5 m in direzione Est-Ovest e largo almeno 2,60 inquella Nord-Sud 249), comunicante ai due estremi con vani più piccoli 250. L’ingresso princi-pale era tuttavia ricavato sul lato sud, attraverso il muro a, in corrispondenza con il lastri-cato superiore. Il collegamento con questa struttura muraria è ribadito da una larga ban-
244 LEVI 1976, p. 257, fig. 401.245 F. HALBHERR, Scavi eseguiti dalla Missione
Archeologica Italiana ad Haghia Triada ed a Festo, inMemIstLomb XXI, 1905, p. 253 ([…] si riscontraro-no gli avanzi di un muro appartenuto ad una stanzadel palazzo primitivo e sotto di questo, in direzionediversa, i resti di un altro muro, probabilmente diuna casa privata più antica distrutta o coperta dallecostruzioni del primo palazzo. Ambo gli strati eranoaccompagnati da materiale di Kamares; sotto di que-sti eravi un metro di depositi neolitici»); ID., Lavorieseguiti dalla Missione archeologica Italiana in Creta,in RendLinc XIV, 1905, pp. 399- 401, fig. e; cfr. PER-NIER 1935, p. 153. L’unica indicazione ulteriore, neltaccuino di scavo (10 maggio-2 giugno 1904), riguar-da il fatto che materiali del tipo Kamares si trovava-no anche in associazione con quelli del riempimentoneolitico.
246 LEVI 1976, p. 257, figg. 388-389.247 LEVI 1976, p. 257.248 L’acciottolato viene attribuito ad «una stradina
prepalaziale» in DAMIANI INDELICATO 1982, pp. 95 e 116.249 Un calcolo approssimativo, sulla base di una
serie di comparazioni con diversi rilievi della zona aNord del vano, consentirebbe forse di ricostruire l’e-stensione dell’aula lastricata, attigua all’ambientescavato sotto il vano neopalaziale 25. Attribuendoalla parete sud di quest’ultimo uno spessore corri-spondente a quello del muro ovest, ne deriverebbe,per l’aula lastricata, una larghezza nord-sud di circa4 m, per un’estensione in superficie di circa 44 mq.L’importanza del vano sarebbe indirettamente con-fermata, oltre che dalla grandezza delle lastre di pavi-mentazione, da «una graziosa bacinella di pietra a bas-sa scodella con due larghe e sottili prese laterali», inca-strata tra le lastre (LEVI 1976, p. 253, fig. 386). Den-tro di essa, che potrebbe anche essere rimasta in situ, sta-va, a giudicare dalle indicazioni rintracciate nel MS(col. 30/11 - «19.9.1959. Dentro al vaso in pietra») unampio tratto, ricomposto da 5 frr. con un sesto nonreintegrabile, di piatto di fruttiera MM II.
250 LEVI 1976, figg. 386-392.
REVISIONI FESTIE 91
Creta Antica 8, 2007
china 251, che correva lungo il lato sud dell’ambiente, rivestita anch’essa di lastre alabastri-ne, pure in corrispondenza dell’elevato di a. Il ricco materiale recuperato all’interno dellabanchina, del quale viene offerta soltanto un’immagine della giacitura 252, è ritenuto utile«per fissare un termine post quem alla costruzione» dell’aula lastricata. Il sommario elencodei trovamenti porta alla generica conclusione che nessuno dei reperti possa essere consi-derato «posteriore all’inizio della terza fase protopalaziale»253.
Sempre per quel che riguarda la cronologia delle strutture e dei livelli, altre indicazioniprovengono da un saggio sotto l’ambiente con pavimento in terra battuta ad Est dell’aulalastricata ed in rapporto con una soglia a quota -0,80 m. Due boccaletti del tipo a foglie,numerosissimi nel deposito dell’attiguo vano 25 254 e quindi di un momento maturo del MMII 255, vengono associati a ceramica Kamares di I fase e riferiti a livelli al di sotto del piede delmuraglione a, per il quale dovrebbero quindi costituire un terminus ad quem. Il controllo delleschede inventariali dei due boccaletti in questione e dei cartellini del Museo stratigrafico cer-tamente relativi ai frammenti ad essi associati, non sembra tuttavia offrire una corrispondenzacon le indicazioni appena ricordate 256. La verifica, per quanto possibile, delle quote porta adammettere che lo strato con i due vasi facesse parte già del «riempiticcio» neopalaziale siste-matosi al di sopra del pavimento in terra battuta in questo vano attiguo all’aula lastricata. Laprossimità col vano 25 e le tracce di bruciato autorizzano inoltre a supporre che parte di quelriempimento costituisse il corredo della nota stanza dell’archivio. I boccaletti, in altri termini,rappresenterebbero soltanto un terminus post quem per la sistemazione di età neopalaziale.
L’esame dei frammenti significativi rapportabili alle strutture ( figg. 93-103) ha per-messo, anche in questo caso, di precisare le cronologie delle fasi architettoniche e, segnata-mente, delle due rampe lastricate sovrapposte che correvano lungo la fascia sud.
In particolare, il saggio a Nord-Est ha fornito indicazioni circa il momento di messain opera del muro a, ricavabili da diversi livelli tutti sicuramente al di sotto del suo piede.Si tratta di un orizzonte sostanzialmente MM IA ( figg. 93-95), con molto materiale pre-cedente e con pochissimi frammenti MM IB, che diventano dunque il plausibile terminusad quem per la messa in opera di a 257.
251 La larghezza di 0,65 m ca. si ricostruisce sullabase dell’allineamento delle lastre del pavimento del-la grande sala rispetto al muro a; l’altezza di 0,15 msi ricava invece dalla differenza di quota tra le lastree il gradino della soglia est.
252 LEVI 1976, fig. 392.253 LEVI 1976, p. 252.254 LEVI 1976, fig. 403 (F. 2575 e 2576).255 Cfr. P. MILITELLO, Amministrazione e contabi-
lità a Festòs. II. Il contesto archeologico dei docu-menti palatini, in Creta Antica 3, 2002, pp. 55-62.
256 Indicazioni inventariali di F. 2575 e 2576: «17 ago-sto 1959 - Corridoio 7- nell’angolo fra i muri g e d; pro-fondità: -0,35 dalla sommità del muro a». Indicazionemuseale dello strato: MS col. 28/1. «Tra i muri gammae delta da -0,20 a -0,40».
257Fig. 93. Collocazione: MS col. 28/12 A. Indicazioni:«Corridoio 7 Saggio NE Z - 21.VIII.1959. Dalla demoli-zione del muro gamma, da -0,05 a -0,40». Diversi skou-
telia del solito tipo verniciato (Patrikiès) e con riprese ma-nuali; tratto di orlo di skouteli sottile e acromo, in argilla de-purata, con tracce di tornitura (almeno MM IB, ma piut-tosto MM II), quasi sicuramente un’intrusione; frammen-to di parete di vaso non classificabile, con tracce di ele-menti curvilinei bianchi completamente evanidi e restidi una fascetta rossa; all’interno fascia nera e gocciolaturebianche e rosse sul fondo naturale dell’argilla, del MM IB.Il gruppo conteneva altresì frammenti quasi esclusiva-mente neolitici, tranne due di stile H. Onouphrios.Fig. 94. Collocazione: MS col. 28/12 A. Indicazioni:«Corridoio 7 Saggio NE Z - 22.VIII.1959. Da -0,48 a-0,56 vicino al muro a». Orlo e tratto di spalla di pis-side decorata con una fascetta orizzontale da cui sidipartono due gruppi di tre fascette oblique conte-nenti un motivo a zig-zag; tratto di parete di grandevaso chiuso con fascetta bianca e rossa.Fig. 95. Collocazione e indicazioni c.s. Larga parte deltratto inferiore di vaso chiuso (brocchetta) decorato con
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA92
Creta Antica 8, 2007
FIGG. 93-95 – CORRIDOIO III/7. SAGGIO NORD-EST. FRAMMENTI DA -0,05 A -0,40 M.
FIG. 96 – CORRIDOIO III/7. SAGGIO NORD-EST. FRAMMENTI DALLA ZONA TRA MURO G E MURO D, DA -0,35 A -0,56.
REVISIONI FESTIE 93
Creta Antica 8, 2007
FIG. 97 – CORRIDOIO III/7. SAGGIO SUD-OVEST. FRAMMENTI SOTTO LE PRIME DUE LASTRE DA SUD-OVEST DEL LASTRICATO SUPERIORE.
FIGG. 98-99 – COME SOPRA. FRAMMENTI SOTTO LE TRE LASTRE DEL LASTRICATO SUPERIORE
IN CORRISPONDENZA DELLA BASE ROTONDA SOPRA IL MURO a.
La revisione dei materiali dal saggio nel settore sud-ovest ha consentito invece di proporredelle cronologie per i diversi livelli dei lastricati e di confermare, indirettamente, il momentodi messa in opera del muro a. In breve, al MM II conviene assegnare il lastricato superiore che,come abbiamo visto, deve essere collegato con la facciata ad ortostati del Piazzale occidentaleI e con la sua ultima pavimentazione. La rampa alabastrina inferiore può farsi risalire al MMIB ed essere collegata con il lastricato inferiore dello stesso Piazzale. L’acciottolato più basso vainvece rapportato ad un qualche complesso o semplice abitazione del MM IA.
Gli elementi per la cronologia del lastricato superiore si ricavano, come terminus adquem, dai materiali recuperati al di sotto delle lastre, in occasione dei lavori invernali direstauro delle medesime 258, e così pure quelli per la datazione delle lastre più basse e mol-
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA94
coppie di fasce bianche sul fondo rossiccio chiazzato.Fig. 96. Collocazione: MS col. 28/13. Indicazioni: «Corri-doio 7 Saggio NE Z - 14.VIII.1959 -Tra muro g e muro d,da -0,35 a -0,56». Fondi e orli di skoutelia e orlo di piattoMM IA.
258 Dati di dettaglio su questi lavori si ricavano dauna serie di appunti manoscritti dell’ arch. E. Fiandraresponsabile dei medesimi. Le principali deduzionistratigrafiche sono state riassunte in LEVI 1976, p. 257.Fig. 97. Collocazione: MS col. 29/20. Indicazioni: «22/11/59. Sotto le prime due lastre da Sud Ovest». Frammen-to di olletta MM II con spirale bianca affiancata dafoglietta e sovradipintura in rosso arancio; orlo di gran-de skouteli del tipo semiovoide MM II. Qualche fram-mento MM IB: tratto di parete di brocchetta con cop-pie di fascette rosse oblique; frammento di parete digrande vaso chiuso con elementi a vela in bianco margi-nati di rosso e contornati da palline bianche. Qualcheframmento di Kamares rustico (parete di anfora con spi-rale); orlo di piatto con decorazione a trattini e fascettebrune (forse più antico).
Figg. 98-99. Collocazione: MS col. 30/1. Indicazioni:«Febbraio 1960. Sotto le tre lastre (4a, 5a e 6a) in cor-rispondenza della base rotonda sopra il muro di primafase (scilicet a)». Tratto di un boccaletto con marcati se-gni di tornitura all’interno, apparentemente acromo,MM II; parte inferiore di vaso chiuso (olletta), con fascet-ta bianca presso il fondo, MM II ( fig. 98). Del MM IBsono invece un tratto di orlo e parete con attacco delbecco di teierina a ocarella a corpo piriforme allungatoed attacco di beccuccio tubolare, decorata con motivi inbianco completamente evanidi (cerchio con reticolato) efascia bianca alla base del beccuccio; tratto di piatto ver-niciato di nero con fascette bianche e rosse, vele a trat-teggio in bianco sull’orlo, tutto scrostato ed evanido;grande vaso (brocca?) decorato a fasce verticali nere,su fondo naturale dell’argilla, con fascette sovradipinte inbianco e rosso; orlo di olletta à la barbotine, con fascettarossa e linea ondulata bianca sotto l’orlo ( fig. 99).Fig. 100. Collocazione: MS col. 30/8. Indicazioni: «25/2/60.Sotto la seconda lastra da Est». Fondo e tratto di parete infe-riore di tazza troncoconica tutta verniciata di nero, MM II.
Creta Antica 8, 2007
FIG. 100 – CORRIDOIO III/7. SAG-GIO SUD-OVEST. FRAMMENTO DI TAZ-ZA SOTTO LA SECONDA LASTRA DA EST
DEL LASTRICATO SUPERIORE.
FIG. 101 – COME SOPRA. AREA
DELLE PRIME DUE LASTRE DA OVEST.FRAMMENTI SOTTO AI RESTI DI LA-STRE PRECEDENTI, NEL SETTORE DI
DI QUELLE RESTAURATE.
REVISIONI FESTIE 95
Creta Antica 8, 2007
FIG. 102 – CORRIDOIO III/7. SAGGIO SUD-OVEST. AREA DELLE LASTRE IX E X DA OVEST. FRAMMENTI SOTTO AI RESTI
DI LASTRE PRECEDENTI, NEL SETTORE DI QUELLE RESTAURATE.
FIG. 103 – COME SOPRA. FRAMMENTI SOTTO L’ACCIOTTOLATO PIÙ BASSO.
to malridotte 259. Un margine di dubbio solo teorico permane, infine, per la datazione del-l’acciottolato più basso, dal momento che in un contesto omogeneo del MM IA260 abbiamoriscontrato un unico frammentino (qui non riprodotto) probabilmente già del MM IB, cheabbiamo ritenuto verosimile considerare come un’intrusione, dato anche il tipo di lavori incui era stato effettuato il recupero.
Un cenno a parte merita il materiale contenuto all’interno della banchina sud dell’au-la lastricata, perché consente di inserirla nel sistema complessivo di quest’area di passaggiotra i due grandi spazi all’interno e immediatamente all’esterno del complesso palaziale. Sitratta di un gruppo di materiali molto omogeneo dal punto di vista sia tipologico sia cro-nologico, costituito quasi esclusivamente da skoutelia. È stato possibile contarne 92 più omeno frammentari o fondi, tutti del tipo ripreso a mano; ad essi vanno aggiunti 9 esem-plari da noi inventariati ( fig. 104) 261 ed un decimo del tipo detto di Patrikiès (F. 8106; fig.105), con parte superiore verniciata di rosso e due fascette bianche all’esterno e una all’in-terno, sotto l’orlo. Sempre tra i vasi di piccole dimensioni segnaliamo, variamente fram-mentari, una lattierina con sgrondo e presine amigdaloidi (F. 8107; fig. 106), un vasettocon presine e orlo a collarino (F. 8108; fig. 107), ed il tratto inferiore forse di una broc-chetta miniaturistica (F. 8110; fig. 108). Tra i frammenti abbiamo individuato: il becco diuna brocca con fascette bianche e una rossa su fondo nero; un secondo becco, con «occhio»a rilievo, decorato in scuro su chiaro; un beccuccio di olletta senza ponte, con fascia rossaalla base e due all’esterno, verniciato di nero; un frammento di parete di vaso à la barboti-ne con decorazione a dischetti bianchi e fascetta rossa; due tratti di piattelli acromi con fon-do esterno lavorato a mano, uno con evidenti tracce di bruciato; un gruppo di frammentidi grandi contenitori, tra cui almeno tre di anfore bilobate (tratti di collo, spalla con ansa),due verniciate di nero e una di rosso; un tratto di parete di grande vaso con decorazione inscuro su chiaro (fascia obliqua, con sezioni di disco dipinte in colore marrone rossiccio); unframmento di fondo di grande vaso chiuso, con fascia rossiccia attorno alla base; un trattodi orlo e parete di grande stamnos acromo; due frammenti di pentole; un token ricavato daun vaso AM II. Assieme alle ceramiche erano numerosi resti ossei di suini, ovicaprini, bovi-
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA96
259 Fig. 101. Collocazione: col 29/22. Indicazioni:«22/12/59. Sotto le prime due lastre da Ovest. Sottoi resti di lastre in gesso al di sotto delle altre lastrerestaurate». Tratto di orlo e parete di bacino vernicia-to di rosso con decorazione in bianco (archetti pen-duli sull’orlo, grande fascia sotto l’orlo e altre duefascette all’inizio della vasca), attribuibile al MM IA.Parete di vaso chiuso con decorazione a fasce incro-ciate perpendicolari (del tipo detto «scozzese») delMM IB; due tratti di skoutelia del tipo a parete carena-ta (MM IB), uno di piccole dimensioni, parzialmenteverniciato con fascetta nera sotto l’orlo all’interno epiù ampia zona all’esterno e l’altro con forti tracce dibruciato all’esterno e all’interno (usato come lucerna?).Fig. 102. Collocazione: MS col. 30/5. Indicazioni: «Sottole lastre IX e X da Ovest. Al di sotto dei resti di lastreprecedenti che si trovano a 15 cm al di sotto della super-ficie delle lastre restaurate». Diversi frammenti MM IA:
pitharaki con cordonature, con tratti obliqui incisi, ver-nice rossastra e decorazione a fascette orizzontali bian-che; skoutelia parzialmente dipinti del solito tipo Patri-kiès; orlo e parete di bacino con fasce, all’interno, brune.Almeno quattro frammenti MM IB: due di brocchettebarnacle; un tratto di orlo e parete di skouteli del tipo care-nato con decorazione a immersione e due fascette bianchesotto l’orlo; frammento di ansa a nastro con trattini oriz-zontali bianchi su vernice nera lucente (verosimilmentedi olletta a secchiello).
260 Fig. 103. Collocazione: MS col. 29/21. Indicazioni:«20/1/60. Sotto le piccole pietre (Kalderim)». Resti diskoutelia ripresi a mano con o senza vernice; tratto diparete di grande vaso con fasce nere.
261 F. 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8109,8111. I materiali dalla banchina sono conservati nel MSalle coll. 29/5 («11/8/59: banchina») e 29/6 («8/59: sot-to il seguito ovest della banchina e pulizia banchina»).
Creta Antica 8, 2007
ni, che documenterebbero una sorta di suovetaurilia 262. I materiali sono riferibili, soprattutto perla forma degli skoutelia (che pur ridotti nelle dimensioni e nello spessore delle pareti, ancorariflettono tradizioni MM IA), ad un momento iniziale del MM IB.
Dato che all’aula in questione si accedeva direttamente dal lastricato superiore a Suddel muro a, è inevitabile assegnare la banchina allo stesso MM II, anche in assenza di uncorredo pavimentale (se uno ve ne era, a parte il vaso in pietra sopra ricordato) 263 e di sag-gi al di sotto del pavimento dell’aula stessa. I materiali dentro la banchina varrebbero sol-
REVISIONI FESTIE 97
262 Per gentile indicazione del dott. Stefano Masala,che ha in corso di studio i reperti ossei animali dagli
scavi vecchi e nuovi di Festòs.263 Vedi supra, nota 249.
Creta Antica 8, 2007
FIG. 104 – CORRIDOIO III/7. AULA LASTRICATA A NORD DEL MURO A, ALL’INTERNO DELLA BANCHINA SUD.SKOUTELIA F. 8099, 8100, 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8109, 8111.
FIGG. 105-108 – COME SOPRA. SKOUTELI F 8106; LATTIERA F. 8107; VASETTO F. 8108; TRATTO DI BROCCHETTA F. 8110.
tanto come terminus post quem e lascerebbero aperta la possibilità che analogo collegamentoesistesse fra la rampa inferiore a sud di a ed un eventuale ambiente al di sotto dell’aulalastricata. Di un tale ambiente il complesso dei materiali dentro la banchina avrebbe potu-to rappresentare, data la sua particolare natura, un deposito di fondazione. Non andremoin ogni caso lontani dal vero ipotizzando, per il nostro complesso ceramico, un contestocerimoniale collettivo, probabilmente in giacitura non primaria, che si era ritenuto oppor-tuno in qualche modo conservare all’interno di una banchina, in un ambiente particolar-mente prestigioso, quale doveva essere, per la posizione, le dimensioni ed i rivestimenti ala-bastrini, l’aula in questione.
Essa sarebbe dunque vissuta contemporaneamente al lastricato superiore della rampaascendente attraverso il corridoio, riferibile cioè al momento di massima monumentalizza-zione dell’edificio protopalaziale. In altri termini, la situazione stratigrafica e cronologicaall’interno del Corridoio III/7 si accorderebbe perfettamente con quella del Piazzale I (e,come vedremo subito dopo, del Propileo II), ivi compresa la presenza di livelli di abitazio-ne MM IA fin presso il cortile centrale.
4.2 Propileo IIMessa in luce dal Pernier, questa struttura di accesso monumentale al primo Palazzo
si riconnette architettonicamente alla sistemazione della facciata ad ortostati sul Piazzale Ie rappresenta la definitiva soluzione di raccordo tra questo e il Cortile centrale, oltre acostituire un disimpegno per un gruppo di ambienti (XXII-XXIII e XXV-XXVI), ai qua-li da essa direttamente si accedeva. Già il primo scavatore aveva profilato la bocca di unpithos neopalaziale affiorante tra le lastre del pavimento e si era approfondito in un saggiodi m 1,50 ! 1,50, senza tuttavia rimuovere il manufatto264, riferendolo ad una manomis-sione dei tempi «ellenici»: ipotesi questa, condivisa dal Levi, il quale attribuisce inoltre aquel saggio pesanti intrusioni («fino a un paio di pezzi bizantini») 265.
Egli assegnava la struttura alla sua III fase protopalaziale 266. Rimuovendo completa-mente la pavimentazione a lastre di calcare, aveva effettuato un saggio fino alla roccia,profondo oltre 5,20 m. Riferendo delle possenti murature sui quattro lati ( fig. 109), nota-va che quella sud, la più profonda (ed in comune con il vano IL, nei suoi vari livelli) nonammorsava con le pareti ovest ed est e che addirittura proseguiva verso Est. Del muro nordsi conservava, per una lunghezza di circa 1 m, solo un tratto al limite ovest, che facevacanonicamente angolo con la parete occidentale. La funzione di contenimento, che si sareb-be portati a proporre per i muri, sulla base anche del mancato ammorsamento, apparireb-be clamorosamente contraddetta dall’esistenza, lungo la parete ovest, di un’apertura, inter-pretata dallo scavatore come porta o finestra. Tale apertura appariva occlusa, al momentodello scavo, da un ammasso irregolare di pietrame, sicuramente in rapporto con la sot-tofondazione della base della colonna del Propileo, la quale cadeva praticamente nel mez-zo dell’apertura, con il margine della circonferenza circa 0,30 m più ad Ovest rispettoall’allineamento del muro. Il limite inferiore di tale apertura, che avremmo non poche dif-ficoltà a definire una soglia, si trova a quota -1,60 m circa 267. Prova evidente della difficoltà
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA98
264 PERNIER 1935, pp. 73-74, 289 e 291, figg. 168-170.
265 LEVI 1976, p. 172, figg. 261-262.266 LEVI 1976, pp. 170-187, tav. R.
267 LEVI 1976, p. 173. Nella sezione pubblicata, laquota di -1,41 m dovrebbe infatti corrispondere a -1,59m nel sistema generale, laddove il Levi, nel testo, fariferimento a una quota di -1,35, equivalente dunque
Creta Antica 8, 2007
di lettura di questa lacuna come passaggio aperto nel muro è la maniera in cui essa è resadal disegnatore in una seconda sezione, dove appare il prospetto del muro occidentale 268.Anche i supposti stipiti di tale apertura danno piuttosto l’impressione di una rovina delmuro, dal momento che, almeno sul lato sud, si vede tuttora una pietra sporgere netta-mente rispetto alla linea del presunto stipite ( fig. 109). La nostra impressione è pertantoche il muro ovest non avesse alcuna apertura e che quella oggi visibile sia il frutto dei lavo-ri per le sottofondazioni della grande base di colonna, lavori che avrebbero dunque com-portato una parziale ed intenzionale rovina della struttura. La logica di una tale operazio-ne potrebbe essere ricercata nel fatto che lo spessore di tale parete era lungi dal poter copri-re, come piattaforma, la luce della colonna, per la quale sarebbe stato necessario un basa-mento di oltre 1,50 m a partire dal filo del muro ovest: da qui la necessità di creare un’ade-guata sottofondazione, usando magari le pietre della precedente struttura.
Descrivendo una serie di riseghe sui diversi lati, il Levi prendeva le mosse dall’esi-stenza della porta o finestra, per ipotizzare, al di sotto del Propileo, degli ambienti cheattribuiva, sulla base di tali riseghe, alle sue tre fasi protopalaziali. Nella terza vi sarebbe
REVISIONI FESTIE 99
a -1,53 m. Bisogna inoltre tener presente che mentrenella citata sezione schematica di tav. R la quota èindicata a -1,41 m , in quella stratigrafica di fig. 263(altrove, p. 178, definita «provvisorio schizzo strati-grafico»), viene riportata una quota di -1,35 m (cheviene arrotondata a -1,30 m a p. 179). Lo 0,00 del sag-gio dovrebbe corrispondere alla quota di +0,18 m
rispetto a quella di riferimento generale del Pernieradottata dallo stesso Levi, alla quale continuiamo afare, per comodità, riferimento.
268 LEVI 1976, tav. S (la prima è, ovviamente, quel-la di tav. R, appena citata). Si tratta di una sezioneNord-Sud, colorata con l’indicazione delle fasi masempre molto schematica.
Creta Antica 8, 2007
FIG. 109 – AREA DEL PROPILEO II. SAGGIO AL DI SOTTO DEI LIVELLI DEL LASTRICATO. DA NORD.
stato un passaggio a Sud, verso il vano IL,all’incirca in corrispondenza con la risegadel muro meridionale, a quota -0,58 m, asancire il definitivo raccordo tra l’ala set-tentrionale e le costruzioni della terrazzainferiore. La «soglia» o il «davanzale» a quo-ta -1,59 m (o -1,53) avrebbe indicato il pia-no pavimentale della II fase, mentre in cor-rispondenza della risega del muro ovest, acirca -2,57 m, sarebbe stato da collocare ilcalpestio della I fase 269. Una conferma all’e-sistenza delle tre fasi sulla parete est (la su-periore rappresentata, ovviamente, dalle so-glie verso i vani XXII e XXV), sarebbe co-stituita da un «modesto muretto»270 ( fig. 110)con direzione Nord-Est/Sud-Ovest (come ri-sulta, del resto, dal rilievo di tav. R), ad unadistanza di circa 5,50 m dall’angolo sud-est,muretto le cui condizioni di rinvenimento(o comunque quelle risultanti dopo lo scavo)non sembrano molto adattarsi alla descrizio-ne che ne viene data. Esso viene infatti rite-nuto perpendicolare alla parete est, nono-stante si presentasse «un po’ contorto», cioè«volto in direzione Sud-Ovest/Nord-Est»271.Quanto alla sua consistenza, è probabile chela faccia sud fosse andata distrutta, dal mo-mento che un grosso blocco alla base ed unoormai all’interno della parete est suggerireb-
bero l’esistenza di un paramento canonico, ammorsato con la medesima parete est, comesembra in fondo credere lo stesso Levi. Un terzo elemento da mettere in rilievo è che ilmuretto coincideva, in pratica, con la fine della parete orientale e che proseguiva tuttavia,in direzione Est, al di là di quella. Per tal motivo egli pensava, in ogni caso, che il murettocontinuasse verso la parete ovest e che rappresentasse o l’apertura di un corridoio verso Est,oppure un divisorio dell’ambiente di II fase sotto il Propileo. Noi non escluderemmo di con-siderare come testata il tratto residuo della faccia nord, anche perché essa coinciderebbe inmaniera significativa con la linea della risega (piuttosto che banchina) di quota -2,07 m del-la stessa parete est. In altri termini, il muretto potrebbe costituire solo una sorta di con-trafforte, come limite nord-est, del terrapieno compreso fra le pareti est, sud ed ovest sottoil Propileo.
Le giustificazioni cronologiche addotte dal Levi sono piuttosto generiche, nel sensoche egli si limita ad affermare che, al di sotto del lastricato del Propileo II, a parte le intru-
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA100
269 I tre livelli corrisponderebbero rispettivamentealla base degli strati B, C e D della sezione stratigra-fica di fig. 263.
270 LEVI 1976, pp. 176-178, fig. 270.271 LEVI 1976, p. 178.
Creta Antica 8, 2007
FIG. 110 – AREA DEL PROPILEO II. SAGGIO AL DI SOTTO DEI
LIVELLI DEL LASTRICATO. MURETTO DI DIREZIONE NORD-EST/SUD-OVEST A UNA DISTANZA DI CIRCA 5,50 M DALL’ANGOLO
SUD-EST. DA OVEST.
sioni relative al ricordato saggio Pernier, non fu rinvenuto alcun frammento che potesse«appartenere ad un’età posteriore alla II fase protopalaziale»272. L’assenza di qualsiasi corre-do pavimentale veniva giustificata con l’interramento dei ruderi successivo ad ogni distru-zione, «mediante una gettata di terra, attinta da punti diversi nei dintorni del Propileo»273.
Per quel che riguarda la cronologia del presunto piano di calpestio della I fase, l’unicoriferimento è a rarissimi pezzi di «Kamares primitivo» rinvenuti «lungo le fondazioni delmuro» sud, al di sotto del livello della I fase (= -2,57 m), in associazione con materiali di tipoAM. Non è possibile, purtroppo, verificare un simile dettaglio, dal momento che i materialisono stati raccolti con tagli che non coincidono con i supposti livelli pavimentali 274. Nel casoin specie, frammenti assimilabili a quelli descritti dal Levi si riferiscono a terra sia al di soprache al di sotto della risega del muro ovest, assunta come quota di riferimento del pavimentopiù basso. Tali materiali, comunque, potrebbero anche essere riferiti alla messa in opera deifilari inferiori sia della parete sud che della ovest, seguiti fino a circa -3,70 m. In un contestoa prevalenza di materiale neolitico e AM, abbiamo ritrovato diversi frammenti MM IA edalmeno un paio à la barbotine, ormai del MM IB, che dovrebbero costituire il terminus ad quemper la costruzione delle murature 275 ( figg 111-112). Quanto poi alla risega ovest, appare per-lomeno ipotetico che essa possa avere avuto una qualche funzione in rapporto con livelli pavi-mentali, anche se nella sezione schematica di fig. 263 viene data in corrispondenza di un’in-terfaccia fra gli strati D ed F. La corrispondente risega sulla parete est cade circa 0,50 m piùin alto rispetto a quella ovest e nessun’altra a quote omologhe se ne riscontra sulla parete sud.Appare quindi più probabile che la risega ovest, lungi dal costituire elemento utile per unlivello pavimentale, rappresentasse solamente un accorgimento costruttivo. Di un livellopavimentale di II fase in corrispondenza con la supposta soglia non sarebbe poi lecito parlarese, come crediamo, nessuna apertura doveva esser presente sulla parete ovest.
Se dunque risega ovest e presunta soglia appartenevano ad un’unica fase costruttiva, ipochi frammenti appena citati di «Kamares primitivo», all’interno del più basso dei dueenormi tagli effettuati, dovrebbero costituire un terminus ad quem per la messa in opera del-le sostruzioni ovest e sud, che vanno perciò collocate agli inizi del MM IB. È utile inoltrenotare che sia nel riempimento inferiore sia in quello superiore il materiale MM IB risul-ta relativamente scarso. Escludendo le già citate manomissioni del MM IIB (messa in ope-ra della base di colonna) e posteriori (interramento del pithos), si può ipotizzare ragione-volmente che l’intero terrapieno all’interno delle strutture avesse un carattere unitario e chela sua gettata, avvenuta agli inizi del MM IB, fosse rimasta immutata fino alla costruzionedel Propileo II. Non è certo casuale che l’indicazione cronologica del MM IB per la messain opera dell’interro vada a coincidere con quella della posa dei filari di fondazione del pri-mo momento del palazzo, come ricordato a proposito del saggio nel vano XIX 276.
REVISIONI FESTIE 101
272 LEVI 1976, p. 179. Sulla cronologia del Propi-leo II, in contrapposizione alle ipotesi cronologichedel Levi, PLATON 1968, p. 24, nota 2 («tutti […] iframmenti al di sotto del Propileo sono di epoca pre-palaziale»); vedi anche DAMIANI INDELICATO 1982, pp.93-94 (le sue affermazioni sono indirettamente con-futate nelle osservazioni che seguono; lo stesso valeper quelle relative al Corridoio III).
273 LEVI 1976, p. 179.274 Ciò risulta evidente dalla sistemazione dei ma-
teriali dello scavo nei cassetti del MS, dove i fram-menti ceramici sono ordinati seguendo la successionedei tagli: i primi due, che più direttamente ci inte-ressano, vanno da 0,00 a -1,83 e da -1,83 a -3,24 m.
275 Collocazione: MS col. 82/13. Indicazioni: «1959.Propileo II, da -1,83 a -3,24». Frammenti prevalente-mente MM IA, con qualche pezzo à la barbotine forseMM IB, selezionati da un insieme con grande maggio-ranza di frammenti neolitici e AM I-II.
276 Vedi supra, p. 45.
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA102
Creta Antica 8, 2007
FIGG. 111-112 – AREA DEL PROPILEO II. SAGGIO AL DI SOTTO DEI LIVELLI DEL LASTRICATO. FRAMMENTI DAL TAGLIO DA -1,83 A -3,24 M.
Che gli strati individuati rappresentassero solo episodi successivi di un unico interro,disgiunti da livelli pavimentali, è dimostrato non solo dal ricorrere di frammenti dello stes-so tipo in tagli o strati diversi, ma anche dalla grande hydria F. 970, che il Levi attribuisceal livello di I fase (equivalente allo strato D di fig. 263), precisando tuttavia che alcuniframmenti di essa si erano «infiltrati… sotto al livello del pavimento di I fase nella terraentro alla fossa di fondazione per la costruzione del muro occidentale», indicazione cheequivarrebbe addirittura alla base dello strato F 277.
Un’indiretta conferma al fatto che nessun ambiente fosse previsto al di sotto delPropileo II, potrebbe essere fornita dall’assenza di aperture sulla parete orientale, nono-stante subito ad Est fossero sistemati dei vani di cronologia compatibile con gli interri sot-to il Propileo stesso. La presenza di un attiguo corpo di fabbrica con corredi pavimentalirendeva necessaria una struttura muraria più solida e a tale scopo si costruì, verosimilmen-te, la spessa risega («banchina» a -1,89 m nella sezione di tav. R).
All’interno del vano XXV già il Pernier 278 aveva individuato una più antica fase pavi-mentale, a quota -0,95 m. Rilevanti agli effetti del nostro discorso sono i materiali sicura-mente MM IB 279 e possibilmente MM II iniziale 280 rinvenuti nel saggio e attribuiti a«costruzioni anteriori al primo palazzo», in un livello altrove definito «protominoico»,«minoico primitivo III o minoico medio I»281. Lo strato di distruzione è certamente di unvano protopalaziale, probabilmente al limite ovest dell’area poi occupata dal Propileo. Dalmomento che sotto il Propileo II non pensiamo vi fosse alcun ambiente, dobbiamo ritene-re il limite occidentale del vano XXV come la fronte ovest, in questo settore, della siste-mazione originaria del Primo Palazzo.
Diverso è il discorso per la risega sulla parete sud, che il Levi poneva in relazione conun passaggio verso il vano IL, funzionante in un momento nel quale era già in uso il lastri-cato del Propileo II insieme con la facciata a ortostati.
Per tornare al discorso sui materiali, significativi dal punto di vista cronologico sareb-bero quelli dalla quota delle lastre superiori fino alla linea della presunta soglia di -1,53/59(-1,35) m, rappresentati dagli strati B e C della sezione a fig. 263. Ma, come già osserva-to, le indicazioni per i frammenti degli strati superiori includono una quota finale ben oltrequella della «soglia». Tra i materiali riferibili a questi livelli vengono ricordati diversioggetti inventariati, in genere di piccole dimensioni o frammentari, alcuni anche ripro-dotti. Le loro profondità di rinvenimento, tuttavia, non sempre si accordano con la quotadel supposto livello pavimentale; appare inoltre chiaro che essi non si riferiscono ad un uni-co momento, variando cronologicamente dal MM IA al pieno MM II. La situazione risul-ta evidente nella fig. 274 Levi, nella quale i due grossi frammenti MM IA (F. 314 a e b) sitrovano associati con cocci Kamares, in qualche caso chiaramente del MM II maturo.
Nel caso specifico di materiali rinvenuti fra il lastricato del Propileo e la quota del-la supposta soglia del muro ovest, vengono ricordati una statuetta maschile, proprio pocosopra la «soglia»282, e la metà di una salierina, la cui descrizione inventariale consiglie-rebbe di apparentarla a tipi del MM II 283; uno skouteli miniaturistico, citato insieme con
REVISIONI FESTIE 103
277 LEVI 1976, p. 179, tav. 78a, c.278 PERNIER 1935, pp. 139-142.279 Brocchetta e scodellone: PERNIER 1935, tav. XIVa
e fig. 62.280 Brocchettina, tavola di offerta, testina e tavola
di libagioni in steatite: PERNIER 1935, tav. XIVb, fig.
63; tav. XV, fig. 60.281 PERNIER 1935, pp. 146 e 303.282 LEVI 1976, p. 179, tav. 163b (F. 296).283 LEVI 1976, p. 179 (F. 316); profondità indicata
nella scheda inventariale: «-1,15/-1,30 (riempimento)».
Creta Antica 8, 2007
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA104
Creta Antica 8, 2007
FIGG. 113-114 – AREA DEL PROPILEO II. SAGGIO AL DI SOTTO DEI LIVELLI DEL LASTRICATO. FRAMMENTI DAL LIVELLO SUPERIORE.
la saliera, era stato invece raccolto già al di sotto della supposta linea di soglia, lungo laparete sud 284.
L’esame dei frammenti del livello superiore appare preliminarmente inficiato dalladoppia manomissione dello «scasso» ellenico per la positura del pithos e del saggio Pernier.Tra i frammenti conservati nel Museo Stratigrafico è possibile, in effetti, riscontrare un’in-trusione TM I 285; al MM IIB si riferisce un gruppetto di frammenti in bello stile Kamares( figg. 113-114), i quali tuttavia, a causa delle segnalate manomissioni, non possono toutcourt essere considerati terminus ad o post quem per il lastricato del Propileo II 286. La crono-logia di tale lastricato va dunque ricercata con altri mezzi.
Una prima osservazione può riguardare il corredo pavimentale recuperato dal Perniersul pavimento della fase più recente del vano XXV 287, comunicante con il Propileo II. I vasisegnalati sulle lastre di tale pavimento appartengono sicuramente ad un momento evolutodel MM II, lo stesso periodo, cioè, al quale può essere attribuito il gruppo appena citato diframmenti dall’interro al di sotto del Propileo II. Considerando questi ultimi come termi-nus ad quem per la messa in opera delle lastre, ne deriverebbe tuttavia per il Propileo unperiodo d’uso eccessivamente breve.
Una seconda considerazione concerne l’inoppugnabile collegamento, tramite un pre-ciso nesso architettonico, tra il Propileo II e la facciata a ortostati sul Piazzale I, a sua vol-ta connessa con le vicende del definitivo allestimento monumentale del piazzale stesso, giàpreso in esame nei dettagli 288. Sembra infine di grande utilità, al riguardo, l’osservazioneche doveva assolutamente esistere un collegamento tra la sistemazione del Propileo II e lapavimentazione della rampa superiore all’interno del Corridoio III/7, che è opportuno asse-gnare agli inizi del MM II 289.
Per questa serie di motivi proponiamo di considerare come intrusioni, dovute alladoppia manomissione, i citati frammenti MM IIB dall’interro superiore sotto il PropileoII e di porre la messa in opera di quest’ultimo agli inizi dello stesso periodo.
A proposito del collegamento tra Propileo II e Corridoio III/7, con la sua doppia ram-pa lastricata, è di grandissimo interesse il dettaglio che nell’area del Propileo II, subito aNord del marciapiede soprelevato che segnava il percorso processionale di collegamentonella sua fase ultima, e fino alla facciata ad ortostati del vano XIX, il Levi mise in luce «unsecondo lastricato, di pietre assai più piccole di quelle del Propileo», per il quale proposeun collegamento con quello già noto dal saggio Pernier presso la facciata, al limite est delPiazzale I 290. A giudicare dalla fig. 264 (i lavori di restauro rendono oggi impossibile qual-siasi verifica sul posto) tale lastricato inferiore si estendeva anche a Sud del marciapiedesoprelevato. Dalla fig. 270, inoltre, sembrerebbe di poter dedurre che resti di lastre netta-mente al di sotto del marciapiede soprelevato esistessero anche in corrispondenza dell’alli-neamento della parete est del saggio, a Nord del muretto-contrafforte a suo tempo ricor-dato. Sorprende, in ogni caso, che il rimando proposto dal Levi per tale lastricato inferio-re, indipendentemente dalla sua reale estensione, sia solo a quello dell’area del Piazzale I e
REVISIONI FESTIE 105
284 LEVI 1976, p. 179 (F. 315); profondità indicatanella scheda inventariale: «sotto -1,40».
285 MS col. 82/8.286 Collocazione: MS col. 82/9. Indicazioni: «Propi-
leo II 1952. Da 0,00 a -1,83». Frammenti di Kama-res fine, fra cui sono rappresentate soprattutto ollet-te e tazzine troncoconiche, globulari e carenate, alcu-
ne anche eggshell, le più tarde MM IIB maturo.287 PERNIER 1935, pp. 303-305, figg. 178-180 e
226, 4.288 Vedi supra, p. 84.289 Vedi supra, p. 94.290 LEVI 1976, pp. 172-173, fig. 264. Vedi supra,
p. 30.
Creta Antica 8, 2007
Creta Antica 8, 2007
FIG. 116 – AREA DEL PROPILEO II. IPOTESI
RICOSTRUTTIVA DELLA FORMA ORIGINARIA
DEL PASSAGGIO DALL’AREA DEL PIAZZALE I AL
PALAZZO. SCHIZZO ASSONOMETRICO.
FIG. 115 – AREA DEL PROPILEO II. IPOTESI RI-COSTRUTTIVA DELLA FORMA ORIGINARIA DEL PAS-SAGGIO DALL’AREA DEL PIAZZALE I AL PALAZZO.
PLANIMETRIA.
non anche alla rampa inferiore del Corridoio III/7. Del nuovo lastricato egli non precisa laprofondità rispetto al Propileo II: dalla fotografia pubblicata sembrerebbe che il suo livel-lo coincidesse con il piede dello zoccolo degli ortostati (l’ultimo di essi corrispondenteall’ingresso del vano XIX) e che addirittura qualcuna di queste lastre terminasse al di sot-to di quell’allineamento.
La coincidenza di un doppio livello lastricato nell’area del Piazzale I, del Propileo II edel Corridoio III/7, induce a questo punto a chiedersi se non sia possibile precisare il rac-cordo tra queste tre aree nella fase del lastricato inferiore del Piazzale I.
Appare legittimo, in via preliminare, supporre che proprio in corrispondenza dell’areadel Propileo II vi fosse uno spazio di raccordo tra il Piazzale I e la rampa verso il Cortilecentrale. I limiti di questo possibile spazio, che dobbiamo immaginare più a Nord delPropileo II, sono in qualche modo definibili ( figg. 115-116). Per la fascia nord il blocco difondazione angolare del saggio sotto il vano XIX propone un preciso allineamento, che saràricalcato dai costruttori del secondo Palazzo; tale allineamento avrebbe potuto piegare ver-so Sud, in corrispondenza del moncone di parete orientale del vano XXI, che abbiamo vistoa sua volta fare angolo con il muro a sotto il Corridoio 7. Per quanto riguarda il marginemeridionale, gli elementi sono meno perspicui. La verisimile esistenza di lastre a Sud delmarciapiede soprelevato costringe ad escludere qualsiasi riferimento al muro nord sotto ilPropileo II, che dovrebbe cadere abbondantemente al di sotto del lastricato, anche se talemuro non è adeguatamente evidenziato nella planimetria di tav. R. L’unico elemento dispo-nibile si riferisce dunque al muretto-testata sistemato sulla risega della parete orientale,che abbiamo detto continuare verso Est ( fig. 110). Questa modesta struttura potrebbe addi-rittura costituire il tratto terminale del muro, parallelo ad a, che doveva rappresentare illimite meridionale della rampa attraverso il Corridoio III/7, con una luce in questo caso dicirca 3 m, appena più ampia rispetto a quella della fase successiva. Lo spazio fra l’allinea-mento dello stesso muretto e l’angolo sud-ovest del primo momento del Palazzo risulte-rebbe invece di m 7,50 e potrebbe costituire la luce di un originario propileo, con un’even-tuale colonna centrale. Nessuna proposta concreta è possibile avanzare circa l’estensione insuperficie di questo propileo, dal momento che non sappiamo se e di quanto rientrasse lafronte ovest di esso rispetto all’angolo sud-ovest del palazzo.
Bisogna a questo punto chiedersi come fosse sistemata la sommità del terrapieno al disotto del Propileo II, nella larga fascia a Sud del muretto-testata, tenendo anche presente ilfatto che il dislivello tra il lastricato del primo propileo e quello del secondo poteva essereal massimo di una ventina di centimetri. Non possiamo escludere, pur non possedendoalcun indizio per sostenerlo, che anche questa fascia meridionale fosse lastricata; è certo, inogni caso, che la sistemazione, con pavimentazione in pietra o in terra battuta, dovesse assi-curare una qualche impermeabilizzazione a difesa della parete nord del vano IL. Va inoltreconsiderato che il piano di calpestio soprastante al terrapieno sotto il Propileo II, se a Nordveniva a trovarsi allo stesso livello del propileo originario, a Sud-Ovest risultava certa-mente più elevato rispetto alla quota della rampa LII, che è già stata proposta come ele-mento di raccordo, in quanto anche via brevis, tra il Piazzale LXX e il Piazzale I nel suomomento iniziale 291. La sommità della rampa LII nel suo stato attuale comunicava con illivello pavimentale del secondo piano del vano IL (II fase per il Levi). Bisogna quindiimmaginare una sistemazione a rampa battuta, o meglio ad ampi gradoni, che superasse il
REVISIONI FESTIE 107
291 LEVI 1976, pp. 155-160; TOMASELLO, Gli ingressi al quartiere…, cit. a nota 47, pp. 82-86.
Creta Antica 8, 2007
dislivello da -3,42 m al lastricato del primo propileo, da porre all’incirca a una quota di0,00. Una rampa unitaria porterebbe ad una pendenza di circa il 40%, più agevolmentesuperabile attraverso una sistemazione per ampi gradoni o pianerottoli ( fig. 116).
Difficile da proporre rimane la funzione della piattaforma che si sarebbe venuta a crea-re a Sud del primo Propileo, esattamente nell’area di quello successivo, con estensione cal-colabile tra i 18 e i 20 mq. Si tratta di uno spazio sufficientemente ampio e in una zona«strategica» come quella attigua da un lato al Piazzale occidentale e dall’altro all’accessoprincipale al Palazzo. La tentazione di ipotizzarlo destinato a speciali liturgie (epifania enplein air?) risulta forse condizionata dai dati della vicina Haghia Triada: pensiamo al c.d.avancorpo orientale, subito a Est dell’ingresso principale della c.d. Villa Reale 292, o almodellino con figure femminili dalle braccia alzate (in uno spazio circolare piuttosto cherettangolare!) assegnabile al MM II 293.
In conclusione, le vicende relative all’area d’ingresso al primo Palazzo e al corridoio diaccesso al Cortile centrale possono essere raggruppate in due grandi momenti, assegnabiliagli inizi del MM IB ed a quelli del MM II.
5. - Osservazioni conclusive
5.1 Il sistema delle fasi levianeLa prima e più pregnante osservazione conclusiva ci sembra quella che la periodizzazio-
ne del Levi per l’età protopalaziale è risultata purtroppo fuorviante, anche perché fondata suun automatismo strutturale considerato valido per le diverse aree dell’insediamento, automa-tismo che egli credeva di fondare sulle presunte diverse colate di astraki nel settore sud-occi-dentale del primo Palazzo. È dunque preferibile che alle sue tre fasi si faccia riferimento solocome una tappa storiografica nella vicenda centenaria dell’archeologia festia, testimonianzadello sforzo solitario e possente di imbrigliare in un sistema coerente una quantità di dati avolte contraddittori e comunque senza confronti. Del pari imbarazzante, nella ricostruzionedel Levi, è la parallela e puntuale corrispondenza fra fasi ceramiche ed architettoniche (peredifici e strade lastricate!) scandite da successivi eventi sismici. Il riferimento alla vecchiaclassificazione evansiana (avvertito come esigenza già dalla Fiandra 294) diventa allora una solu-zione inevitabile, ferme restando le specificità areali, con la consapevolezza, comunque, chequella classificazione va rivisitata, evitando sia il puro criterio evoluzionistico dello sviluppodegli stili, sia l’automatica attribuzione cronologica delle ceramiche a strutture stratigrafica-mente e autonomamente collocate, con la conseguenza paradossale, in quest’ ultimo caso, chele ceramiche risulterebbero datate dalle strutture e non viceversa. Nella prospettiva dunquedella datazione delle strutture sulla base delle ceramiche, pur nel rigoroso rispetto dellesovrapposizioni architettoniche, abbiamo cercato di muoverci, utilizzando un consolidato
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA108
292 V. LA ROSA, La ‘Villa Royale’ de Haghia Triada, inThe Function of the «Minoan «Villa» (Athens, 6-8 June1992), R. HÄGG ed., Stockholm 1997, pp. 85-87.
293 V. LA ROSA, Le campagne 1986-1991 e la conclusio-ne del primo ciclo dei lavori ad Haghia Triada, in Atti VIICongr. Intern. Studi Cretesi (Rethymno, agosto 1991),A/2, Rethymno 1995, p. 542, fig. 7. Una recente rico-struzione, ad opera del restauratore F. Cecchi, prevede
cinque anziché sei figure femminili, come appare in-vece nella proposta grafica già resa nota.
294 FIANDRA 1961-62, p. 113, nota 1. Per le attese inquesto senso da parte dei colleghi non italiani, più divent’anni dopo, cfr. J. SHAW, in A Great Minoan Trianglein Southcentral Crete: Kommos, Hagia Triadha, Phaistos(Scripta Mediterranea VI - special Issue), Toronto 1985,p. 56.
Creta Antica 8, 2007
codice di riferimento che, se rischia di non tutelare, talvolta, la specificità del nostro sito, con-sente tuttavia di reimmetterlo nell’alveo di quella rete di rapporti infrainsulari, condizioneindispensabile per qualsiasi ricostruzione di tipo storico.
Una rapidissima rassegna, per quel che riguarda strutture e ceramiche, consentirà dimeglio valutare la necessità di un aggiornamento della classificazione leviana.
La I fase protopalaziale (a e b)La I fase appare già polivalente nella formulazione leviana ed è quella nella quale la
necessità di collegare strutture architettoniche e rinvenimenti ceramici rivela tutta la suainadeguatezza. Ad episodi costruttivi relativamente modesti, come quelli indicati per ilpassaggio dalla fase Ia alla Ib (aggiunta dei vani LVI e LVII) corrisponderebbero infatti deiradicali cambiamenti nella produzione ceramica, cambiamenti che più logico sarebbe sta-to indicare con una denominazione autonoma: con il risultato, tra l’altro, che una determi-nazione nata come legata alle strutture si autopromuove a momento stilistico autonomo. Sipensi, ad esempio, allo «stile di H. Photinì», indicato come caratteristico della I fase a, masolo con tenui agganci ai livelli più antichi all’interno del Palazzo; viceversa le tantissimeceramiche dei livelli di distruzione dei vani dell’ala sud-ovest dell’edificio indicate comefase Ib, risulterebbero associabili a limitati episodi architettonici. Nel caso del Bastione IIsorprende non tanto l’enorme riempimento assegnato alla I fase b all’interno di una strut-tura di II fase, quanto il fatto che tale struttura debba essere contemporaneamente in rela-zione con il Piazzale LXX (come livello di calpestio) e con la presunta ricostruzione, a quo-ta assai più alta, del quartiere del Palazzo (come riferimento di fase architettonica).
Per quel che riguarda le ceramiche, alla I fase protopalaziale a vanno attribuite quel-le del MM IB, in genere maturo (come nel vano LXV e nel vano b di H. Photinì). Dal pun-to di vista architettonico questa è una grande fase che prevede l’impianto dell’intero palaz-zo sulle due diverse terrazze e varie strutture in quartieri di abitazione come la citata casadi H. Photinì o il vano CIII ad Ovest della Strada dal Nord.
Occorre infine aggiungere che il Levi sembra incline a dar diritto di cittadinanza a una«fase di Patrikiès», dai contenuti puramente stilistici e senza reali agganci architettonici,come momento di transizione fra la fine del prepalaziale e l’inizio del protopalaziale: conl’aggravante di un’oscillazione fra terminus post quem e ad quem, nel rapporto tra queste cera-miche e le strutture.
La fase Ib sostanzialmente corrisponde, per le ceramiche, all’intero MM II, senza pos-sibilità di vere e proprie sub-distinzioni, nonostante la grande abbondanza dei depositi. Laatipicità della situazione non dovette sfuggire allo stesso Levi, lì dove isolò una «fase Ib ini-ziale» diversa da quella del momento di distruzione del Palazzo 295.
Sul piano architettonico, oltre ai citati rifacimenti parziali dell’ala sud-occidentale(vani LVI e LVII), egli fu in grado di proporre solo il riutilizzo di murature della fase prece-dente nei quartieri di abitazione situati soprattutto nell’area ad Ovest della Strada dal Nord.
La II fase protopalazialeL’esiguo quantitativo di ceramica proveniente quasi totalmente da alcuni vani del
Palazzo non presenta, come è già stato osservato 296, differenze da quella della fase Ib «fina-
REVISIONI FESTIE 109
295 LEVI - CARINCI 1988, pp. 301-302.296 F. CARINCI, Le ceramiche e i nuovi dati di scavo, I.,
in Cento anni, pp. 477-512 (specialmente pp. 510-512).
Creta Antica 8, 2007
le» e corrisponde pertanto al MM IIB maturo. Al di fuori del Palazzo, l’attribuzione delleceramiche è effettuata sulla base della giacitura al di sopra di livelli o strutture attribuitialla I fase, o al di sotto di quelli assegnati alla III. Un esempio è quello del citato gruppettodi materiali dal crollo del Bastione occidentale 297, finiti sul lastricato del Piazzale I e attri-buiti alla II fase, pur essendo assolutamente identici a quelli della distruzione della fase Ib.
Per quel che riguarda le architetture, la II fase corrisponderebbe a quello che invece èsolo il secondo piano dei vani del quartiere sud-ovest del Palazzo. Per le strutture al di fuo-ri dell’edificio palaziale vale, invece, quanto già detto a proposito delle ceramiche, con ilrisultato che alla fase in questione vengono attribuite, come abbiamo visto, architetture dicronologie diverse.
La III fase protopalazialeLa ceramica assegnata dal Levi ad architetture di questa fase risulta appartenere (sulla
base dei corredi della Casa a Sud della Rampa e non dello stranamente vuoto quartiere sud-occidentale del Palazzo) soprattutto al MM IIIA. Il riferimento alla tomba di Kamilari ead alcuni vani sottostanti a strutture TM I (LXXI e LXXIII) autorizza anzi ad estenderel’indicazione anche al momento finale del MM III, come risulta ormai chiaro dalle recentiricerche 298.
Una palese contraddizione è rappresentata dalla attribuzione alla III fase dell’interosettore del Palazzo scavato dal Pernier, associato a un supposto arretramento della facciatanel settore sud-occidentale 299. Con evidenti forzature nella lettura dei dati forniti dal pri-mo scavatore, il Levi cerca di metterne in risalto presunte aporie, magari non collegatedirettamente alla fase in questione, ma ritenute atte ad inficiare l’intera ricostruzione del-lo scavo precedente 300.
In realtà, almeno a livello delle strutture del Palazzo e delle aree aperte immediata-mente adiacenti (con rare eccezioni, come la Garitta CIV, che diverrebbe contemporaneadella facciata a ortostati, pur avendo restituito materiali completamente diversi), quantoattribuito dal Levi alla III fase coincide con l’akmé del complesso palaziale e con il MM II(soprattutto B).
5.2 Cronologia ed estensione del Palazzo e delle aree ad esso collegate al momento della fondazioneLa nostra revisione ha consentito non solo di confermare la cronologia di fondazione
del Palazzo agli inizi del MM IB, ma soprattutto di affermare che esso non fu originaria-mente limitato al solo quartiere sud-ovest 301. I resti relativi a questo primo momento sonocertamente meno perspicui e più difficilmente individuabili nella terrazza superiore.Esiste, tuttavia, una serie di dati, a partire dalla nuova proposta per la facciata occidentale,che consentono (pace Levi e Fiandra), di sostenere una tale affermazione. Ci riferiamo anzi-tutto alla sistemazione del Cortile centrale ed alla sua funzione di focus topografico e fun-zionale dell’intero edificio. Ad esso collegato ed altrettanto importante è l’impianto dellungo muro a al di sotto del Corridoio 7 (fin presso l’area del Propileo II) ed, indiretta-
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA110
297 LEVI 1976, pp. 345-346. Vedi supra, p. 67.298 F. CARINCI, La casa a Sud della Rampa e il Medio
Minoico III a Festòs, in Cento anni, pp. 203-238; oraL. GIRELLA, Towards a definition, cit. a nota 2.
299 LEVI 1976, pp. 237-238.
300 LEVI 1976, pp. 26-27; cfr. pianta tav. E.301 Non si vuole comunque escludere l’auspicio
che nuovi saggi possano essere nell’immediato futu-ro realizzati con i criteri metodologici ora in uso,lungo i due settori della facciata.
Creta Antica 8, 2007
mente, anche il nuovo deposito di fondazione sotto il vano 13. Va inoltre richiamata la pri-ma sistemazione del Piazzale I (Fase del betilo) e della sua via di accesso, con l’interessan-te dettaglio della spalletta trasversale della Strada dal Nord, che in un momento subito pre-cedente alla sistemazione del lastricato inferiore del Piazzale costituisce, in qualche modo,il limite di un’area già destinata ad un uso pubblico.
Sembra infine da non trascurare l’eventuale, scarsa funzionalità di un gruppo di vanicome quelli del quartiere sud-ovest, incassati entro un avvallamento del terreno, senza pre-vedere un collegamento strutturale con la terrazza mediana, nella quale abbiamo credutodi individuare i resti dell’ingresso principale alla costruzione (pre-propileo).
Se dunque la Fiandra era nel giusto considerando la facciata ad ortostati posteriore aquella del Piazzale LXX, errava, a nostro parere, limitando alla terrazza inferiore l’estensio-ne del Palazzo originario. Il Levi, dal canto suo, si contraddiceva identificando un vero e pro-prio livello lastricato nell’area del Piazzale I, riferibile alla I fase, non essendo però in gradodi proporre, per lo stesso periodo, nessuna struttura del Palazzo nella terrazza mediana.
5.3 I disiecta membra del momento subito anteriore al Palazzo Abbiamo avuto a più riprese occasione di far riferimento a livelli pavimentali ed a
manufatti certamente della fase MM IA, al di sotto delle strutture del Palazzo e nelleimmediate adiacenze, a partire dagli orizzonti chiaramente di questo periodo che, come nelcaso del Cortile centrale, hanno preceduto la costruzione dell’edificio. Un gruppo di trevasetti abbiamo ricordato sotto il magazzino XXXIV ( fig. 21) e un’olla sotto il vano XII( fig. 22); c’era un acciottolato più antico della fondazione del Palazzo sotto il CorridoioIII/7, per non dire del muro trovato da Halbherr sotto la parete est del vano XXI, conorientamento divergente. Siamo stati incerti se attribuire a questo stesso momento l’ac-ciottolato presso il muro arcuato sotto il Piazzale I, ma una rampa ascendente dal settoredel Piazzale LXX viene ripresa e addolcita sempre nel MM IA, mentre un minuscolo trat-to di acciottolato abbiamo segnalato proprio sopra la roccia nell’area sotto il vano LXIV. Èil caso di ricordare, ancora, il ricco orizzonte MM IA negli strati subito sottostanti allelastre del Piazzale LXX 302 ed i livelli di abitazione MM IA isolati in anni recenti a Sud del-la Rampa ascendente 303, ma anche nell’area ad Ovest della fornace 304; un livello di taleperiodo rappresentava, infine, un piano di calpestio nell’area della Strada dal Nord ancorprima della messa in opera della spalletta trasversale 305.
Un semplice cenno merita anche il grande deposito della vicina stazione di Patrikiès, peril quale è stata proposta di recente un’interpretazione di carattere rituale 306. Una tale abbon-danza di indizi non ci sembra tuttavia sufficiente, al momento, per risolvere il quesito a suotempo posto dal Pernier circa l’esistenza di un «pre-palazzo»307, ma è lecito supporre che ungrande centro quale dovette essere la Festòs del MM IA avrebbe potuto disporre almeno di un’a-rea di riunione, come quella ben attestata nella necropoli di Haghia Triada 308. Non andremo for-
REVISIONI FESTIE 111
302 Vedi supra, p. 13.303 LA ROSA 2002, pp. 741-742; v. ora S. TODARO,
EM I - MM IA ceramic groups at Phaistos: towards thedefinition of a Prepalatial ceramic sequence in SouthCentral Crete, in Creta Antica 6, 2005, pp. 11-46.
304 LA ROSA 1998-2000, p. 108.305 LA ROSA 2002, pp. 724 e 735 (livello 28).306 V. LA ROSA, Perché il palazzo a Festòs?, in Creta
Antica 5, 2004, pp. 43- 49.307 Vedi supra, p. 13s.308 Cfr. CARINCI, Priests in action… cit. a nota 240. Per i
dati sul territorio festio vedi ora L. V. WATROUS -D. HADZI
VALLIANOU-H. BLITZER, The plain of Phaistos. Cycles of So-cial Complexity in the Mesara Region of Crete (MonumentaArchaeologica 23), Los Angeles 2004, pp. 253-276.
Creta Antica 8, 2007
se lontano dal vero concludendo che la somma dei dati consente di ipotizzare una sorta di scel-ta preventiva del sito del palazzo, il che accrescerebbe l’enfasi sulla gradualità del fenomenopalaziale, enfasi eventualmente religiosa, piuttosto che «civica», come pure è stato proposto 309.
5.4 La fine del MM IB e i problemi connessi: distruzione o/e programma edilizio?La situazione della fine del MM IB risulta apparentemente contraddittoria. Alla gran-
dissima quantità di materiale ceramico di un momento maturo di questa fase, si oppone latotale assenza di classici livelli di distruzione, sia nell’area del Palazzo che nelle immediateadiacenze. L’esempio più probante di un episodio di distruzione potrebbe essere fornito dalcedimento del Bastione I e dalla necessità di ricostruzione del II, ma non va dimenticato chela sua particolare collocazione come struttura di contenimento della terrazza superiore loesponeva a specifici rischi di collasso. Proprio in occasione di un tale cedimento potrebbeessersi verificata una risistemazione dell’area limitrofa, con l’edificazione del complesso deivani LVI-LVII e la conseguente creazione di un nuovo ingresso sul Piazzale LXX. Restaaltresì il sospetto che in questa ripresa del settore sud-ovest possa inserirsi anche la modifi-ca della dinamica dei percorsi interni a quell’ala del Palazzo e delle comunicazioni tra i suoidiversi piani 310.
Il fatto che la grande maggioranza delle strutture costruite agli inizi del MM IB abbiarestituito livelli di distruzione della fine del MM IIB, nel Palazzo come nell’abitato (quar-tiere ad Ovest del Piazzale I), lascia ipotizzare che le murature non abbiano subìto particolaridanni. Il grandioso programma edilizio, che usa nei suoi riempimenti ceramiche del MM IBmaturo (a cominciare dall’area sotto il Piazzale I, ma anche sotto i livelli della Strada dalNord e quelli adiacenti dei vani IC-C e CIII), potrebbe indicare una volontà indipendenteda grossi eventi distruttivi. Ma con ipotesi di tal genere siamo già agli eventi successivi.
5.5 La grande ricostruzione del MM II e l’akmé del Palazzo La costruzione della facciata a ortostati, il nuovo lastricato del Piazzale I e la relativa
rampa ascendente, la gradinata teatrale (con i suoi tanti kernoi 311), la grande aula lastricataa Nord del muro a, il Propileo II, costituiscono gli esempi più significativi di una gran-diosa ripresa architettonica, che abbiamo assegnato agli inizi del MM II e che si concludecon il doppio episodio sismico della fine di quel periodo. La Vasca lustrale XXX in un pri-mo momento, seguita dall’allestimento delle Kouloures, ma anche i piattelli contrappostisotto il piano di lastre del Vano LVIII a 312 e forse pure il vaso in pietra incastrato nel pavi-mento dell’aula lastricata a Nord del Corridoio III, documentano non solo la rilevanza, maanche una possibile, progressiva trasformazione, a livelli diversi, di alcune pratiche litur-giche nell’ambito delle strutture palaziali, durante il corso del MM II. Alla monumenta-lizzazione della terrazza superiore potrebbe corrispondere un’accresciuta importanza, dalpunto di vista religioso, degli ambienti della terrazza inferiore 313. C’è da chiedersi quanto,
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA112
309 DAMIANI INDELICATO 1982, passim.310 F. CARINCI, Circolazione interna e funzioni del set-
tore sud dell’ala occidentale del primo Palazzo di Festòs,in Atti IX Congr. Intern. Studi Cretesi (Elounda, ottobre2001), A2, Iraklio 2006, pp. 23-35.
311 C. FERRARI -N. CUCUZZA, I cosiddetti kernoi diFestòs, in Creta Antica 5, 2004, pp. 53-95.
312 LA ROSA, Liturgie domestiche… cit. a nota 196, pp.
20-27; ID., I piattelli celati: una liturgia fra l’egalitarioe il domestico nella Creta di età protopalaziale, in Ciboper gli uomini, cibo per gli dei. Archeologia del pasto ritualenel mondo greco (Atti della Riunione scientifica, PiazzaArmerina, 5-8 maggio 2005), D. PALERMO ed., in c.d.s.
313 CARINCI, Per una diversa interpretazione... cit. anota 225; ID., Circolazione interna… cit. a nota 310.
Creta Antica 8, 2007
nel nuovo programma edilizio, possa essere stato influenzato dal modello cnossio, conside-rando anche le nuove acquisizioni archeometriche relative alla presenza di ceramica festiacerimoniale nei livelli MM II del Palazzo di Minosse 314.
Un problema tuttora aperto è se e come sia stato coinvolto in questo grandioso pro-getto il terzo piano del quartiere sud-occidentale del Palazzo, di cui andrà indagato ilmomento di costruzione, ma per il quale è certo un uso durante il MM II.
Le revisioni qui proposte non possono rappresentare che un primo episodio di un dise-gno più vasto nel quale ci sentiamo deontologicamente impegnati, disegno attuabilesoprattutto attraverso la rilettura dell’edizione a stampa leviana (ma anche dei taccuini edella documentazione di scavo) ed il riesame dei cocci recuperati, conservati nei magazzi-ni della Missione Italiana di Festòs. Lì dove la documentazione disponibile dovesse risul-tare del tutto inadeguata, si renderebbe necessario qualche saggio di controllo sul campo.
Molto resta ancora da fare, a cominciare da un rilievo analitico (magari realizzato conl’ausilio delle moderne tecnologie), delle strutture del Palazzo e delle adiacenze, rilievo chegià manca dagli scavi del Pernier: in maniera da giungere in tempi ragionevoli a una rie-dizione della planimetria generale a colori delle rovine, con una risistemazione delle diver-se fasi costruttive. Risistemazione da organizzare per gradi, ancorando le revisioni di det-taglio a singoli problemi architettonici o poleodomici, a partire, per esempio, dal raccordofra le diverse terrazze occidentali nelle differenti fasi.
Non una pausa di riflessione, insomma, ma un contributo fortemente partecipato alperpetuarsi di un’esperienza ultracentenaria la quale, rimasta forse ai margini dell’archeo-logia nazionale, ha invece costituito un costante punto di riferimento (non esente da qual-che fraintendimento… ‘linguistico’) nell’agone internazionale che ha sempre caratterizza-to l’isola di Minosse.
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA
REVISIONI FESTIE 113
314 P.M. DAY-D.E. WILSON, Consuming power: Ka-mares ware in Protopalatial Knossos, in Antiquity 72
(276), 1998, pp. 350-358.
Creta Antica 8, 2007
ABBREVIAZIONI
BANTI 1939- 40 = L. BANTI, Cronologia e ceramica del palazzo minoico di Festòs, inASAtene n.s. I-II, 1939- 40, pp. 9-39.
CARINCI -LA ROSA 2002 = F. CARINCI -V. LA ROSA, Festòs: per un riesame della cronologiadelle rampe minoiche, in ASAtene 80 (sr. III, 2 ), II, 2002, pp. 870-879.
Cento anni = I cento anni dello scavo di Festòs (Atti dei Convegni Lincei, 173), Roma 2001.
DAMIANI INDELICATO 1982 = S. DAMIANI INDELICATO, Piazza pubblica e palazzo nella Cretaminoica, Roma 1982.
FIANDRA 1961-62 = E. FIANDRA, I periodi struttivi del primo palazzo di Festos, in KrChron15-16, 1961-62, pp. 112-126.
LA ROSA 1998-2000 = V. LA ROSA, Festòs 1994: saggi di scavo e nuove acquisizioni, inASAtene 86-87, 1998-2000, pp. 27-134.
LA ROSA 2002 = V. LA ROSA, Le campagne di scavo 2000-2002 a Festòs, in ASAtene 80 (sr.III, 2 ), II, 2002, pp. 635-745.
LEVI 1957-58 = D. LEVI, Gli scavi a Festòs nel 1956 e 1957, in ASAtene 35-36, 1957-58,pp. 7-192.
LEVI 1965-66 = D. LEVI, La conclusione degli scavi a Festòs, in ASAtene 43- 44, 1965-66,pp. 313-399.
LEVI 1976 = D. LEVI, Festòs e la civiltà minoica, I, Roma 1976.
LEVI-CARINCI 1988 = D. LEVI -F. CARINCI, Festòs e la civiltà minoica, II, 2 (L’arte festia nell’etàprotopalaziale. Ceramica ed altri materiali), Roma 1988.
PERNIER 1935 = L. PERNIER, Il palazzo minoico di Festòs, I, Roma 1935.
PLATON 1968 = N. PLATON, Ta problímata chronologhíseos ton minoikòn anaktoron, inArchEph 1968, pp. 1-58.
ZOIS 1965 = A. A. ZOIS, Festiakà, in ArchEph 1965, pp. 27-109.
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA114
Creta Antica 8, 2007
ABSTRACT
PHAISTIAN REVISIONS
This article is part of a major project of re-evaluation of the results of the Levi exca-vations (1950-66), both in terms of stratigraphy and the chronological subdivision of theProto-palatial period (Fasi I a, Ib, II e III), which has mainly been carried out through a re-examination of the ceramic materials that are stored in the stratigraphic museum inPhaistos.
The approach adopted, which is minimalist and positivist, considers the exact chrono-logical definition as an irreplaceable preface for the interpretation of the archaeologicalcontexts and of the architectural phases.
1.- The foundation of the First PalaceThe strata beneath the central and the two western courts (the lower and the middle)
have been reconsidered. Re-examination of the material has resulted in a date for the con-struction of the building at the beginning of MM IB, and has also confirmed the intensi-ty of the MM IA frequentation in all the areas that were later occupied by the Palace andby its open courts. A similar chronological proposal is deduced from the stratigraphydetected in 2004 within room XIX, in correspondence with the foundation courses of thelatest building.
2.- The architectural and chronological phases of Piazzale I (middle west court)a) The baetyl phase (named after a baetyl located near the western Kouloura but
unrecognised by the previous excavators)In this phase, besides the placement in situ of the baetyl, the paving of the court is
also laid down in an area whose extension is not easily determinable. The lower courses ofthe eastern wall of the Strada dal Nord are also set up, together with the paving of a ramp,the paving identified beneath the pottery kiln, room C with its altar, and the new lay outof the Strada dal Nord that received a paved surface in its southern tract. The small amountof data collected suggests that this phase should be dated to the beginning of the MM IBperiod.
b) The lustral bath (Vasca XXX) phaseIn this stage the middle paving of Piazzale I was laid down (with a partial reuse of
tracts of the inferior paving in the southern part), and bath XXX was built with thesouthern shoulder. The wall that delimited the east side of the Strada dal Nord was stillin use, while the ramp from Piazzale LXX was repaves (an event that is connected withthe paving detected beneath the kiln). A small landing should have been located at thesame level of the wall that delimited the bath on the west side (the construction of whichdetermined the rise in level of the court). This modification can be assigned to the begin-ning of the MM II period. At this stage of the project it is not possible to determine whenthe orthostate façade and the theatre staircase (which are clearly closely related to oneanother) were built, but it is possible to propose a date between the bath and Koulouresphases.
Creta Antica 8, 2007
REVISIONI FESTIE 115
c) The Kouloura/es phaseBesides the Kouloures, the three steps of the landing that leads to Piazzale I with its
shoulder were also constructed in this stage. Bath XXX remained in use, but the baetylwas obliterated and the wall that delimited the east side of the Strada dal Nord was re-built so as to enable a connection with the shoulder of the three steps that leads to PiazzaleI. The level of the paving rises until wall 37, while a large part of the previous pavingremains in use, after the necessary adjustment has been made. Similarly, the superiorpaving of the ramp and the entrance to the landing are still in use. The tract of the raisedwalkway that runs to the North of the Kouloures should also be attributed to this stage.This tract of the walkway, in contrast to the main tract of the walkway that reached thesteps of the theatre staircase that was built at the same time as the paving (with a waterpipe along the northern side), overlay the paving and, in theory, could be correlated withthe construction of bath XXX. A few sherds allow the attribution of the Kouloures phaseto the MM II period; it is therefore important to underline that only a short span of timepassed between the construction of bath XXX and that of the Kouloures.
The three superimposed paving levels that Levi had identified with reference to histhree proto-palatial phases are therefore confirmed, with only one paradoxical difference:they all belong to the first Protopalatial phase.
d) The sacelli phaseThis phase coincides with the short period of time between two successive seismic
events that led to the end of the First palace. It is possible to attribute not only the threerooms built against the orthostate façade, but also the original lay out of the Casa a Suddella Rampa and the pottery kiln located immediately to the east of bath XXX to the samephase. A Late MM II teapot retrieved by Pernier could be correlated with the removal ofone of the orthostates of the façade, and therefore with the construction of the Sacelli(shrines). The destruction of the shrines can be dated to the end of the MM IIB period onthe basis of the floor deposits.
e) The Garitta CIV phaseThe long history of Piazzale I is concluded with the construction of Garitta CIV that
is located in the NW sector of the court, and which can be assigned to the MM IIIA peri-od, i.e. at the same time as the remaking of the shoulder of the ramp. The orthostate façadewas erased and filled in with calcestruzzo. Only at the beginning of the LM IB were theslabs and the five inferior steps of the theatre staircase definitely obliterated, after anotherpouring of calcestruzzo which this time consisted of pulverised astraki.
From a more general point of view, the re-evaluation of the area of Piazzale I has ledto the following interpretations:
– it was a specific religious destination; the area was probably delimited ab originealong all the sides, and was in strict relationship with the palace building;
– the ‘varieties’ of the forms of palatial religiosity exemplified by the constructions ofthe various stages and by the interplay of their co-existences (baetyl-bath/bath-Kouloures).This succession overshadows a climax of complex forms of participation, solemn and aggre-gating, of the ritual of Proto-palatial religious action;
– the possibility of a kind of early court, or of a large platform for liturgies (identifi-able on the north side, near the staircase), earlier but contiguous, and in a habitation con-text.
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA116
Creta Antica 8, 2007
3.- The connection between Piazzale I and Central Court XXXIII/40Within Corridoio III/7 a stratigraphic and chronological situation was identified,
similar to the one detected for Piazzale I, which included the presence of MM IA habita-tion levels up to the central court. Propileo II, instead, presents two different lay-outsassignable to the beginning of MM IB and to MM II respectively.
4.- Levi’s system of classificationLevi’s chronological proposal for the Proto-palatial period was shown to be mislead-
ing, because it was based on a structural automatism that was considered valid for everysector of the settlement. Similarly embarrassing, in Levi’s reconstruction, is the paralleland punctual correspondence between ceramic and architectural phases (for buildings andpaved roads!) detected by successive seismic events. Reference to Evans’ system of classifi-cation therefore becomes an inevitable solution, once the local peculiarities have beenrecognised.
The first proto-palatial phase (a and b)The first phase is already polyvalent in Levi’s definition, and it is in this phase that
the correlation between architectural structures and ceramic deposits appears inadequate.Modest architectural changes, such as those indicated at the transition from phase Ia tophase Ib (the addition of rooms LVI and LVII) are correlated to such a radical change inceramic production that would have required an autonomous indication, rather than asimple sub-phase definition. As far as the pottery is concerned, the late MM IB deposits(such as those from room LXV and in room B at H. Photinì) should be attributed tophase Ia of the proto-palatial period. As far as the architecture is concerned, this is animportant phase during which the palace was laid out on both terraces, and various struc-tures were built in habitation quarters such as the house in H. Photinì or room CIII tothe west of the Strada dal Nord. It is necessary to add that Levi seemed willing to recog-nise a Patrikies phase, detected only on stylistic ground and without architectural struc-tures, as a transitional phase between the end of the Pre-palatial and the beginning of theProtopalatial periods.
Phase Ib substantially corresponds to the entire MM II period, on account of the pot-tery, without the possibility of further subdivisions in spite of the large quantity ofdeposits. The oddness of the situation was probably felt by Levi, who distinguished an ini-tial phase Ib as different from the destruction phase of the Palace.
Regarding the architecture, aside from the partial remaking of the SW wing (roomsLVI and LVII), Levi only proposed the re-use of structures of the previous phase in the habi-tation quarters located in the area to the West of the Strada dal Nord.
The II protopalatial phaseThe small amount of pottery that was mainly retrieved from a few rooms of the Palace
is not different from the pottery of the phase Ib final, and therefore corresponds to a maturephase of MM IIB. Outside of the Palace, the attribution of the pottery is made on the basisof the retrieval from upper levels or structures attributed to the I phase, or beneath thoseassigned to the III phase.
As far as the architecture is concerned, the II phase should correspond to the secondfloor of the rooms of the SW wing of the Palace.
REVISIONI FESTIE 117
Creta Antica 8, 2007
The III proto-palatial phaseThe pottery assigned by Levi to the architecture of this phase belongs (on the basis of
the floor deposits from the Casa a Sud della Rampa), mainly to MM IIIA. Reference to theKamilari tomb and to some rooms beneath LM I structures (LXXI and LXXIII) allows anextension to the final stage of the MM III period, as has been clearly shown by recentresearches.
An evident contradiction is represented by the attribution to the III phase of theentire sector of the Palace excavated by Pernier, which was associated with a supposedback-warding of the façade in the SW sector. At least as far as the structures of the Palaceand the unroofed area located in its vicinities are concerned (with rare exceptions such asGaritta CIV), what Levi had assigned to the III phase actually belonged to the acme of thepalatial complex, and therefore with MM II (mainly MM IIB).
5.- Chronology and extension of the Palace and of the connected area at the moment of itsfoundation
This revision has confirmed the dating of the foundation of the Palace to the begin-ning of the MM IB period, but mainly to say that it was not limited to the S -W wing inorigine. The remains of this early phase are definitely less conspicuous and are more diffi-cult to identify on the upper terrace. There, however, a series of data, starting from a newproposal for the western façade, allows (pace Levi and Fiandra), the proposal of such a state-ment. If, however, Fiandra was right in considering that the orthostate façade was laterthan the façade of Piazzale LXX, she was wrong, in our opinion, in limiting the extensionof the original Palace to the inferior terrace. Levi, on the other hand, contradicted himselfby identifying a real paving in the area of Piazzale I, attributable to the first phase, but notbeing able to propose for the same period any structure of the Palace in the terrace that cor-responded to the theatre staircase.
6.- The disiecta membra of the moment that preceded the construction of the PalaceThe data that has been gathered with enormous difficulty does not seem sufficient, at
the moment, to solve the problem raised by Pernier about the existence of a Pre-Palace; itis however possible to suppose that a great centre such as Phaistos was in the MM IA peri-od could have had at least a n open gathering area, such as that attested in the necropolisat H. Triada. We could even hypothesise a kind of pre-choice of the site of the Palace,which would emphasise the gradual nature of the Palatial phenomenon.
7.- The end of MM IB and related problems: destruction and/or building program? The situation at the end of the MM IB seems to be contradictory. The huge amount
of pottery of a mature phase of this period contrasts with the total lack of destruction lev-els, both in the area of the Palace and in its vicinity. The fact that most of the structuresbuilt at the beginning of the MM IB period had destruction levels attributable to the endof MM IIB, in the Palace as well as in the habitation quarter (such as the quarter to thewest of Piazzale I), leads to the hypothesis that the architectural structures did not suffermajor damage in the course of this period. The great building program, which uses pot-tery of a late MM IB in the make up of the floors and in other fillings (see the situationbeneath Piazzale I, but also beneath the Strada dal Nord and the adjacent rooms IC-C andCIII), could indicate a motivation independent from major destruction events.
FILIPPO CARINCI - VINCENZO LA ROSA118
Creta Antica 8, 2007
8.- The great MM II reconstruction and the acme of the PalaceThe construction of the orthostate façade, the new paving of Piazzale I and the rela-
tive ramp from the south, the theatre staircase (with its many kernoi), and the great pavedarea to the north of wall alpha, Propileo II, represent the most significant examples of agreat architectural resumption which has been assigned to the beginning of the MM IIperiod, and which is concluded by the double seismic event of the end of that period. Thelustral bath XXX and the lay out of the Kouloures, which followed in a second moment,document not only the relevance but also a possible progressive transformation, at variouslevels, of some liturgical practises that occurred within the Palace in the course of MM II.The monumentalization of the upper terrace could have coincided with a major impor-tance, from a religious point of view, of the rooms of the SW wing. It is not clear, howev-er, how much of the new building program could have been influenced by the Knossianmodel, considering the new archaeometric acquisition regarding the presence of Phaistianceremonial pottery in MM II strata of the Minos Palace. It is still an open problem if, andhow, the third floor of the SW wing of the Palace, which was in use during MM III, butwhose construction date is still uncertain, was involved in this large project.
REVISIONI FESTIE 119
Creta Antica 8, 2007