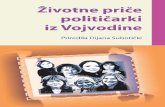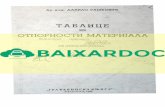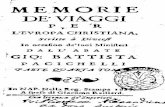D IZ ION ARIC - BIblioteca NApoletana
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of D IZ ION ARIC - BIblioteca NApoletana
D IZ IONARICRAGIONATO UNIVERSALE
D 1
STORIA NATURALE
CONTENENTE LA STORIA
pEGLI ANIMALI, vEGETABILI, E MINERALI
E quella de'Corpi celesti, delle Meteore, e degli
altri principali Fenomeni della Natura: e
coLLA STORIA, E DESCRIZIO?NE
DELLE DRooHE sEMPLtor TRATTE DAI TRE RECNI
E l'esposizione dei loro usi nella Medicina,
nella domestica, e campestreEconomia, -
e nelle Arti, e ne' Mestieri:
con uNA TAvoLA DEI NoMI LATIN1, 1TALIANI ,
E FRANCESI DE1 vAR7 ARTIcoLI :
OPERA DEL SIGNOR
VALMONT D I BOMARE
MEMBRo DELLE PRINCIPALI AccADEMIE ec. ec.
TRADOTTA DAL FRANCESE
Sulla quarta edizione dell'Autore, e di nuovo accresciuta -
ToMo TRIGEsIMoNoNo.
VO N .- ZY Z
V
»
e'-
R O MIA MI DCCC IV.
Presso Michele Puccinelli a Tor Sanguigna.
con licenza de' Superiori.
DizioNAR 1o RAGIoNATo
DI STORIA NATURAL E.
3333333
v o N
V OND-SIRA . Animaletto dell'isola di Ma
dagascar, simile alla donnola, di un color ros
so bruno; ama molto il miele ed esala un forte
odore di muschio . Il Vond-Sira è il Vansiro;
Vedete quest'ultima parola .
---
VONTACA . Grand' albero delle Indie Orien
tali, il frutto del quale porta il nome di coto
gno di Bengala . E'l'Arbor cucurbitifera di Ray.
Il Vontaca è guarnito di una quantità grande di
ramoscelli spinosi ; le foglie, unite a tre per tre
sopra una medesima coda, sono rotonde , denta
te nel giro , rilucenti e odorose: i fiori sono at
taccati , in numero di sette, sopra un pedunco
lo, composto di cinque petali bislunghi , ed han
no un grato odore : a questi fiori succedono frut
ti composti di due corteccie ; la prima è verda
stra e sottile; la seconda è dura, lignea e quasi
ossea : la polpa del frutto è viscosa, giallastra,
di un sapore agro dolce ; e vi si trovano semi
bislungi, bianchi e pieni di un sugo gommoso
trasparente. Questo frutto, tanto maturo quanto
acerbo , si fa in confezione con lo zucchero o
B.om.T.XXXIX. A COI
2 V O R
con l'aceto, si mangia con piacere, e si usa an
cora contro lo scioglimento di ventre ,
VORACE , Lat, Vorax . Si disegnano con
questo nome gli animali che l'appetito induce a
mangiar carne di ogni sorte, anche quella degli
animali della propria specie . Nella specie deipe
sci, i lucci e principalmente tutti i cani di mare,
sono animali Voraci per eccellenza. Vedete ades
so l'articolo Carnivoro .
VORTICE , Lat. Vortex . Franc. Tourbillon
d'eau . E' un gorgo, o una quantità grande di
acqua che si osserva in alcuni mari, e che si av
volge rapidamente, formando una specie di vuo
to nel mezzo. La causa ordinaria di questi Vor
tici viene da una cavità grande, dalla quale l'ac
qua del mare viene assorbita e si precipita in
qualche altro serbatoio . Vedete gli articoli Cor
renti, Mare, ragdno, Tempesta, Venti, Gorgo,
Aria, Acqta . ..
Nella Filosofia di Cartesio, s'intende perVor
tici una collezione di particelle di materie tenuis
sime, che si muovono tutte insieme intorno a
un'asse ad esse comune , mentre ciascuna in par
ticolare gira separatamente intorno a un centro
che ad essa è proprio . Per esempio, il Vortice
nel quale noi siamo è composto del sole , dei
pianeti che gli girano intorno e delle lune parti
colari che girano intorno alla Terra, a Giove ed
- a Saturno , Consultate la Filosofia di Descartes e
gli articoli Pianeta ed Elementi del presente DizioIlarIO .
-
. .
VORTICELLO, Vedete all'articolo zoofito.
VO
U O V 3
VOSAKAN o VOSACAN . Vedete all'articolo
Erba del Sole.
VOSSE. Specie di tasso di Madagascar. Vede
te Tasso .
VOTOMITO dei Galibi, Lat,, Votomita Guia
mensis , Aubl. Pretendono alcuni Autori che il
Votomito sia il Clusia Venoso , Clusia Venosa .
Vedete Clusia, e Paletuviere di Monte .
VOTOMOS dell'Isola di Scio, Pistacia Chia,
Juss. è il pistacchio di Scio. Vedete l'articolo Pistacchio.
UOVA DIMARE, Lat, Carnumi , Fran, Oeuf
de Mer. Vedete Microscomo .
zova di Pesce o Frega , Lat. TPiscium soboles ,
Fran. Fray ou Frai. Vedete l'articolo Pesce .
2ova di TPietra o TPietra Ovaria , Fran. Oetfs
de pierre ou Pierre ovaire . Nome che si dà a
una pietra composta di granelletti, grossi come
capi di spille ; Vedete Cencriti, Meconiti , e Pi
soliti, e principalmente la parola Oaliti. Vi sono
Autori che hanno dato il nome di Uovo di pie
tra a un riccio fossile o petrificato. Vedete Echi
miti .
2ova di Vacca e di Camozza, Fran. Oeuf de
Vache et de Chamois. Vedete Egagropilo.
UOVO, Lat. Ovum, Fran. Oeuf. Si dà questo
nome a un corpo composto ed organico, general
mente di una forma ellittica, e che fanno le femmi
ne degli uccelli, dei pesci, delle lucertole, della
maggior parte dei serpenti e degl' insetti . Si dice
ordinariamente : 2'ovo di gallina, 2ovo di testuggi
ne, 2ovo di carpione, 2ovo di formica, 2ovo di
A 2 Str
4 U O V
serpente, 2ovo di cocodrillo, etc. Tutti gli anima
li ovipari producono un corpo organico simile ;
ed è una specie di scrbatojo che contien l' em
brione e la sostanza destinata a servirgli di pri
mo alimento ; ma alcuni covano le proprie Uo
va fecondate nel seno , della madre , e le fanno
schiudere , mediante il calore della incubazione ;
tali sono gli uccelli : altri le depongono in fon
do alle acque , per essere in progresso vivificate
dai maschj e perfezionate nello stesso elemento;
tali sono i pesci propriamente detti : altri final
mente fanno l'Uova fecondate , nel seno della
madre , in un luogo in cui , quando vengono a
schiudersi pel calore dell'atmosfera, l'animale re
centemente nato trova di che alimentarsi ; tali
sono, per la maggior parte, gl' insetti che nasco
no rettili e finiscono coll'esser volatili; tali sono
ancora le lucertole, le testuggini e la maggior
parte dei serpenti.-
La parte della femmina in cui si forma l'Uo
vo, si chiama Ovaja. Le femmine di tutti gli ani
mali ovipari possono deporre l'Uova, come i
gallinacei, o spargerle sull'acqua, come i pe
sci, o covarle; ma quest'Uova non produrranno
nulla se non sono fecondate dall'approssimazio
ne più o meno immediata del maschio : così la
gallina fa comunemente Uova sterili, le quali col
la medesima forma e colla medesima struttura ap
parente , hanno ciò non ostante differenze gran
di nell' interno ; spesse volte certe gallinette fan
no Uova piccole, che non hanno torlo, e che
il volgo superstizioso o ignorante, portato al
lIl2
U O V 5
saranzana
maraviglioso , o per pregiudizio dicducazione ,
attribuisce falsamente al gallo. Quest'Uova si
chiamano vova bianche, e benchè covate » non
danno alcun prodotto. Vedete all'articoloGallo ,
l'estratto di una Memoria del Sig. della l'eyronie»
stampato nella Storia dell'Accademiadelle Scien
ze , anno 171o , sotto il titolo diosservazioni
sull’ vova di gallina senza torlo, che si chiamano
volgarmente 2ova di gallo.
L'Uovo d'uccello, fecondato o non fecondato»
si distacca sotto la forma di un globetto giallo
dal grappolo che si chiama Ovaja , acui era
dapprincipio attaccato, per mezzo di unpedun
colo: è esso allora unicamente composto del gial
lo contenuto nelle membrane, e della cicatri
la; vien ricevuto in un canale , posto sottol'Ova
ja, e noto sotto il nome di oviductus :mediante
il soggiorno che fa in questo canale, siforma in
esso un sedimento successivo dell'umore albumi
noso, che costituisce il bianco, e vi si ricopre
della crosta calcare che costituisce il guscio : tal
volta quest'ultimo non si forma completamente
e allora l'Uovo è senza crosta e molle; e sareb
be inutile il tentar di farlo covare . Pretendono
alcuni che le galline che fanno l'Uovo senza gu
scio, siano o inferme o troppo feconde o trop
po grasse ; ma succede egli per lamedesima ca
gione che esse facciano quell'Uova grosse che
hanno due bianchi e due torli, ova gemellifica ?
E' stato osservato che sono ordinariamente il
frutto delle galline giovani , vigorose elascive .
Simili Uova gemelle, e formate sonodistinte e
A 3Se
6 U O V
separate nell' ovaja c nell' oviductus o condotto
dell'Uova . Che dovrà poi dirsi di quell'Uova
che contengono corpi estranei, come spille, etc.
o di quell'Uova che contengono un'altr'Uovo,
ovum in ovo; che ha ugualmente il suo guscio ?
Quest'ultimo fatto , che è in favore dell'uno
dentro l'altro, è stato attestato dai Signori Tetit
e Winslovv , Storia dell'Accademia 1742 , pag.
42 . ( Riguardo ai feti trovati in altri feti, le re
lazioni intorno a questo capo sono troppo sospet
te . ) Si chiama Zovo nano, ovum centeninum ,
l'Uovetto che fa la gallina perultimo nella sta
gione . Anche questo è senza torlo . Il Signor
Wolff ha fatto vedere all'Accademia delle Scien
ze di Pietroburgo un'Uovo semplice che conte
neva, in un sol bianco ed in un solo giallo, due
embrioni, sviluppati in sei giorni d'incubazione.
Si legge nella Storia dell'accademia Reale delle
Scienze, anno 1775, un'osservazione sopra un'
Uovo mostruoso, del Signor Marcorel, Barone
d'Escalles. E' questo un'Uovo di gallina picco
lissimo, che quando si lasciava abbandonato a se
stesso, si rialzava costantemente sull'estremità più
appuntata ; quando colla mano si toglieva da que
sta posizione , si sentiva che si sforzava di ripi
gliarla : l'Uovo medesimo racchiudeva, nella par
te opposta a quella sulla quale si riposava, la
metà di un guscio molto simile a una tazza e
coperto di una membrana sottilissima che lo iso
lava nell'interno dell'Uovo . Si conserva nel Ga
binetto di Chantilly, un Uovo di gallina di Ca
ux, grosso come un'Uovo di pollo d'India; il
gu
---------------
U O V7
guscio bianco, sottile e poco duro , è coperto
di una sostanza in qualche maniera coriacea, e
della grossezza di quattro linee ; il torlo era di
color pallido, grossissimo , e nuotava in un
siero poco abbondante , e fluidissimo : del rima
nente gli accidenti che può provar l'Uovo nell'
oviductus, sono la cagione per cui ha forme co
sì varie, per cui è dritto, curvo,liscio, scabro,
solcato , o esibisce le stravaganze delle quali ab
biam poc'anzi fatto menzione; e fenomeni tali
meritano di esser posti nel numero dei fatti più
rari: quanto alla forma dell'Uovo, già nota a tut
ti, dipende essa dalla graduata ed alternativa pres
sione che prova nell' oviductus .e nell' intestino ;
la differenza dei due capi o estremità non ha al
tra origine che la diversa compressione alla qua
le è sottoposto, secondo i punti della superficie
esposti successivamente alle contrazioni dell'inte
stino che lo caccia fuori .
Per completare la storia dell'Uovo in genera
le, Vedete gli articoli Insetto , Pesce e 2ccello :
Si vedrà in quest'ultimo ciò che l'Uovo contie
ne, e la maniera nella quale vi si forma , e
n'esce il pulcino . Alcuni Autori, ed anche il
maggior numero de Moderni, sono di opinione
che tutti gli animali, non eccettuati neppur gli
Uomini , siano prodotti da un'Uovo . Ciò che
gli Antichi chiamavano testicoli nelle donne , por
ta presentemente il nome di ovaja. Si trovano
le ovaje nelle fanciulle , e varj Autori riferiscono
donne che hanno partorito una quantità d'Uova
più o meno considerabile ; ciascuno di quest'Uo
A 4V2
8 U O V
va è ordinariamente della grossezza di un pisel
lo, ed è fecondato, organizzato, ed animato
mentre ancora esiste nel seno della donna. Vede
tc l'articolo 2'omo, e leggete ancora gli articoli
Generazione, Seme, Viviparo.
Noi preghiamo istantemente i nostri lettori di
consultar le Considerazioni su i corpi organizzati,
e la Contemplazione della TNatura. Vi troveranno
essi le idee le più sublimi e le più profonde sul
la maniera con cui si può concepire la nutrizio
ne e l'accrescimento dei germi prima della fecon
dazione , nell' ipotesi dell' uno dentro l'altro .
( Queste dotte ed immortali Opere del celebre
Sig. Bonnet di Ginevra, ben degne dell'accogli
mento che hanno ricevuto dal Pubblico, sono
fatte apposta per fissare tutta l'attenzione dei Fi
sici, dei Naturalisti, e dei Filosofi, e per dar
materia alle meditazioni di chiunque si applica a
scandagliare le profondità della Natura : l' esten
sione e la sagacità delle vedute dell'Autore, coll'
aprire all' immaginazione la più vasta carriera,
sollevano l'anima, ingrandiscono il pensiere ed
esibiscono la più sublime idea che l' intelletto
possa formarsi della potenza e dell' intelligenza
dell'Autore , che ha presieduto alla costruzione
degli Esseri organizzati (a) . L'Uova sono più o
In e
(a) Secondo ilSigEon
net, il germe deve cre
scere prima della fecon
dazione, perchè l'zova
crescono nelle galline ver
gini; se si ammetta l'ipo
6
U O V' Q)
***
meno saporite e benefiche. Tra i pesci, ve ne
sono alcuni l' Uova dei quali sono velenose , e
che purgano violentemente per lo meno . Tali
sono quelle del luccio, del barbo , etc. Negliuc
tesi dell'uno dentro l'al
tro (ipotesi impugnatis
sima dagli Epigenesisti
moderni ), questo accre
scimento o sviluppo ha
cominciato dalla creazio
ne : si deve operare per
mezzo dei sughi alimcn
tarj più sottili della ma
dre; tai sughi, presi nel
fluido nervoso, sono nuo
vamente elaborati, ed in
una maniera più sottile
ancora dal germe, che è
il primo a riceverli; li
trasmette esso al germe
della seconda generazio
ne, che va elaborandoli
come quello della prima
generazione, e che n'es
trae sughi nutritivi mol
to più sottili ancora, e
questi sono altrettanti ato
zmi alimentari che tras
mette al germe della ter
za generazione, etc.etc.
In questa opinione,quan
to più s'impiccoliscono i
germi in una tal serie di
generazioni, tanto èmag
giorc la finezza che ac
quistano gli organi se
cretorj : diminuiscono i
calibri, in una propor
zione esattamente relati
va all'aumento di picco
lezza dei germi. 2uìla
materia è divisibile all'
indefinito . Quante non
sono mai le variazioni
che soffrono la potenza e
la resistenza in questi di
versi periodi della vita
animale !
Abbiamo consigliato ai
nostri Lettori, all'arti
colo Generazione , di
leggere e di meditare,
sopra quest' importante
oggetto, non meno che
sul
O U O V
==ramma
ticcelli, le prime Uova che da questi si fanno,
sono meno grosse delle seconde e delle terze .
Si chiamano 2'ova, fresche quelle che sono sta
te recentemente fatte, e quelle ancora che non
sulla fecondazione , le
Considerazioni su i cor
pi organizzati. Invitati
dall'Autore, Signor Bon
met, a darne un estrat
to, noi abbiamo inseri
to, all'articolo Genera
zione , il ristretto del
capitolo VII del secondo
volume di sua Opera, e
diamo quì il ristretto del
capitolo IX del primo vo
lume ; e sicuramente ci
saprà buon grado chi
legge, della nostra de
ferenza .
, L'istancabile Sig. de
Haller, avendo interro
gato la Natura, come
essa esigeva di esserlo,
sulla formazione dei cor
pi organizzatl, ne ha
ottenuto risposte che e
stendono i limiti delle
nostre cognizioni; e le
han
viscere di un' 2ovo di
gallina sono state il luo
go da cui essa ha rendu
to i suoi oracoli . Ei gli
ha trasmessi alla posteri
td, in un dotto scritto
che ha per titolo; Me
morie sulla formazione
del cuore nel pulcino,
sull'occhio, sulla strut
tura del torlo, e sullo
sviluppo . 2uesto Auto
re haposto in seguito di
sue osservazioni alcuni
corollarj misti, che ne
sono come i risultati ;
ed il Sig. Bonnet ha di
staccato da questi corol
larj le verità più impor
tanti . ,,
, Primo fatto . La
membrana che riveste in
teriormente il torlo dell'
2ovo, è una continua
zione di quella, che ri
CO
U O V 11
hanno perduto la parte che si chiama latte, e
che vi si trova dapprincipio nell'aprirle, quando
non sono troppo cotte. E'cosa non solo curio
sa il conservar fresche, per le qualità che han
nO ,
copre l'intestino sottile
del pulcino . E' essa con
tinua collo stomaco , la
faringe, la bocca , la
pelle e l'epiderme. La
membrana esterna del tor
lo è un'espansione della
membrana esterna dell'
intestino; e si lega al
mesenterio , ed al peri
tonèo. Il torlo èprovve
duto di arterie e di ve
ne , che nascono dalle ar.
terie e dalle vene mesen
teriche del feto. Il san-
gue, che circola nel tor
lo, riceve dal cuore il
principio del proprio mo
to; dunque il torlo dell'
2ovo è una parte essen
ziale del pulcino ,.
, Secondo fatto . Le
parti solide del pulcino
sono dapprincipio fluide:
questo fluido si conden
sa a poco a poco e divie
ne unagelatina; e le os
sa medesime passano suc
cessivamente così anch'es
se perquesto stato di flui
dità e di gelatina. TNel
settimo giorno dell' incu
bazione, la cartilagine è
ancora gelatinosa. Il cer
vello, nell' ottavo gior
no , altro ancora non è
che un liquor trasparen
te e senza dubbio orga
nizzato . Ilfeto governa
già le sue membra, il
che prova l'esistenza de
gli spiriti animali .
Il fluido organizzato è
così condotto gradatamen
te alla mucositd: divien
membrana, cartilagine,
osso, perpassaggi imper.
cettibili, senza miscuglio
di altre parti. TNel la
voro dell'evaporazione
17
I2 U O V
no, l'Uova già invecchiate pel tempo ; ma vi è
ancora un vantaggio reale nel procurarsi sempre
in buono stato un'alimento che spesse volte divie
ne equivoco quando si conserva lungo tempo -
- Nei
insensibile delle parti, in
qualche maniera aquee,
si accostano gli elementi
per formare i solidi, e
quanto più cresce la pros
simità degli elementi, tan
to è maggiore la forza
che acquista l'attrazione,
i vasi divenuti più lar
ghi, ammettono sempre
più una maggior quanti-
td di molecule gommose
ed albuminose ,, Si di
ce all'articolo Uovo , che
se si prevenga, per mez
zo d' intonachi, l'evapo
razione del superfluo ,
si conserva il feto nell'
2'ovo .
, Terzo fatto . La
graduata approssimazio
ne degli elementi dimi
nuisce sempre più la tra
sparenza delle parti, il
che ce le rende visibili.
- Al fine del secon
do giorno dell'incubazio
me, si distinguono benis
simo le pulsazioni del
cuore .– Gli accre
scimenti dell'animaletto
mai non sono più rapidi
. che in questi primi gior
ni. – Il polmone non
può esser distinto prima
del sesto giorno ; allora
ha dieci centesimi di pol
lice di lunghezza. - Il
fegato è anche più gran
de quando comincia a
comparire ; e si scopre
il quarto giorno. - Lo
stomaco e i reni diven
gono visibili il quinto e
il sesto giorno: – Final
mente gl' intestini compa
riscono il settimo giorno3
la vessichetta del fiele,
l'ottavo; e i tegumenti,
a quest'epoca, non sem
bra
U O.VI 3
=
Nei viaggi di mare e nelle stagioni nelle quali le
galline o non fanno Uova o le fanno rarissime
volte , è una vera risorsa, una provvisione d'Uo
va che siano, non meno buone - che se
bra che esistano ancora.
, Quarto fatto. I va
si , sempre più dilatati
dall'impulsione del cuo
re, ammettono particel
le più grosse più etero
genee, e per questo ap
punto più coloranti del
le particelle diafane. 9uin.
di hanno origine i diver
si colori che adornano suc- ,
cessivamente l' animale ;
ai quali sembra ancora
che contribuiscano il ca- ,
lor naturale e quello del
clima. - Nei vegetabi
li, il Sig. de Haller pre
tende che il solo calore
possa bastar per colorir
li; ma il Signor Bonnet
crede che sia piuttosto
l'effetto della luce ,.
, Quinto fatto. A mi
sura che l'embrione si
sviluppa, le parti di es
fossero
fre
so rivestono nuove for
me e prendano nuove si
tuazioni, e queste muta
zioni, unite all'opacità,
concorrono a far ricono
scere ciascuna parte . Il
primo giorno, il feto mal
non somiglia a un giri
no, o cazzuola; ha la
testa grossa , e la spina
dorsale, che è molto sot
tile, sembra che gli com
ponga una piccola coda
o una corta appendice .
Escono finalmente da que
sta codetta e da questo
filo, quasi invisibile, e
membra e visceri , e la
testa divien viceversa un'
appendice . Nei primi
giorni dell' incubazione ,
gl' intestini del pulcino
sono invisibili; ma sono
allora provveduti di un'
appendice enorme, attac
CA
14 U O V
fresche . Ognuno sa che l'Uovo esposto all'aria
vi si corrompe col lasso del tempo; e che sotto
la machina pneumatica si conserva senza guastar.
si . Inerendo a questi principi noti, il fu Signor
di
cata all' animaletto per
mezzo di un canale di
comunicazione; ed il tor
lo é quest'appendice si
tuata così fuori del cor
po del pulcino. Al fine
dell'incubazione, e prin
eipalmente dopo la nasci
ta, tutto quì si mostra
sotto un nuovo aspetto :
gl'intestini sono divenu
ti grandi; il canale di
comunicazione si è obli
terato, il torlo è sparito,
e non vi è più nulla,
fuori del corpo del pollo,
che ad esso appartenga .
così il torlo e gl' inte
stini restano fuori del pul
eino quasi fino al fine
dell' incubazione . Sem
bra dunque in questi pri.
mi tempi il pulcino un
animale con due corpi;
la testa, il tronco e le
estremità compongono uno
di questi corpi; il torlo
e le dipendenze di esso
compongono l'altro . Ma
al fine dell'incubazione
si secca la membrana um
bilicale, sono rispinti il
torlo e gl' intestini den
tro il corpo del pulcino
dall' irritabilità che ac
quistano i muscoli del bas
so ventre, e l'animalet
to altro più non ha che
un corpo solo ,.
, Sesto fatto. Lo sta
to di fluiditd in cui so
no dapprincipio tutti gli
organi, punto ad essi non
impedisce di esercitare le
proprie funzioni essenzia
li; digeriscono , prepara
no e filtrano gli umori,
come lo faranno per tut
ta la vita del pollo; ed
i reni invisibili separa
16
U O VI 5
di Réaumur ci ha proposto un mezzo semplicis-
simo, facile e sicurissimo: ha egli consigliato di
chiudere i pori del guscio dell'Uovo con un, in
tOnaCOindissolubile all'acqua, come sarebbero
due
no gid l'orina. - 9uan
to alla maniera con cui
si operano le secrezioni,
è stato osservato che cer
ti vasi filtrano in diver
si tempi umori che sem
brano diversi . TNelpul
cino di nove giorni, la
bile è fluida, trasparen
te e senza amarezza, cd
una pura linfa diversis
sima dalla bile dell'ani
male adulto. Lostesso ac
cade del liquor seminale,
che altro non è dapprin
cipio nel bambino che una
sierosità , .
Tali sono le importan
ti conseguenze di questi
fatti, dice il Sig. Bon
net; la prima origine del
germe appartiene alla fem
mina, Il torlo dell'Zo
vo è una parte essenzia
le del pulcino : ora, il
-
torlo esiste nell'2'ova che
non sono statefecondate;
dunque il pollo esiste nell'
2ovoprima della fecon
dazione . Vi è fondamen,
to di dire , che le ova
je di tutte le femmine
contengano originaria
mente embrioni prefor
mati, che aspettano uni
camente, per comincia
re a svilupparsi, il con
corso di certe cause . Le
ovaje dei vivipari con
tengono vere zova. Il
germe, dapprincipio flui
do e trasparente, divien
gelatinoso, e finalmente
solido e più o meno opa
co. Il germe , benchè
fluido, è già organizza
to; ha i suoi vasi ; ma
l'estrema delicatezza dei
quali ce li esibisce sotto
l' ingannatrice apparenza
di
6 U ovN
-
due o tre mani della vernice più comune, o un
leggiero strato di grasso di pecora, o di olio ,
o di cera liquefatta. Ha insegnato l'esperienza
che un Uovo, in tal guisa preparato, e conser
vato cinque o sei mesi, fa ancora il latte, e
non ha il minimo cattivo sapore : ciò non ostan
te, quando si vogliono conservar l'Uova con
maggior sicurezza, e per più lungo tempo, si
debbono scegliere Uova che non siano state fe
condate; altrimente il germe soffocato sotto la
vernice non mancherà di corromperne una par
te : dunque l'Uova infeconde non hanno il me
desimo principio di corruzione, che risiede nell'
Uova feconde ; queste si corrompono ben presto
sotto la gallina o esposte a un calore equivalen
te , quando l'embrione non perviene a sviluppar
visi : L'Uova infeconde reggono a questo calore
per
di un fluido. La forma
e la situazione concorro
no colla quiete e colla
trasparenza ad ingannar
la nostra vista . Si sten
ta a riconoscere il pul
siste alla fecondazione;
e tutte le sue parti essen
ziali hanno coesistito nel
tempo medesimo: sembra
che lo sviluppo delle une
preceda quello delle al
cino sotto la forma di
un piccolo filetto bianca
stro, immobile ; esteso in
linea retta e terminato
da una escrescenza . Fi
nalmente il germe pree
tre; la consistenza , le
proporzioni relative, la
forma e la situazione di
esse subiscono a poco a
poco mutazioni grandis
si me .v
U O V17
per trenta, quaranta o anche cinquanta giorni,
quasi senza alterarsi; e ciò prova che la fecon
dazione , occasionando un moto intestino negli
umori dell'Uovo, procura il principio di corru
zione .
Hanno creduto alcuni ; ma senza ragione, che
l'elettricità sia un fluido fecondatore : abbiamo
detto, all'articolo Generazione, che l'elettricità è ,
al più, un mezzo di sollecitare lo sviluppo dell'
Uova che sono state fecondate secondo le leggi
ordinarie della Natura . -
L'Uova feconde e inverniciate non hanno il
solo vantaggio di conservarsi buone per esser
mangiate come fresche; ma hanno inoltre quello
di poter esser covate con tutta sicurezza , pur
chè non si lascino passare le sei settimane , e
purchè l'organizzazione ( i ligamenti che tengo
no il torlo sospeso possono esser rotti), non
sia stata sconcertata dalle scosse in terra e dal
moto del vascello in mare; effetti che si preven
gono sospendendo in una rete la canestra che
contiene l'uova, nella quale si deve aver usato
la diligenza di fermarle esattamente dentro il co
tone o la segatura di legno ; si toglie in segui
to , per l' incubazione, la vernice che è sul gu
scio dell' Uovo fecondato, per mezzo dello stes
so dissolvente che ha servito per comporla; il che
ci esibisce ancora il mezzo di allevare uccelli
stranieri, che non si possono trasportar vivi
senza un grande impaccio, e che ordinariamente
non si accoppiano fuori del paese natìo. Queste
diverse maniere d' intercettare la traspirazione c
Bom,T.XXXIX, B l'ac
18 U C) V
r
l'accesso dell'aria esteriore nell'Uova e in tutti i
corpi che si vogliano preservare da corruzione
o da alterazione , spiegano nel tempo stesso la
causa che ha potuto conservare per trecento an
ni, tre Uova in un muro di Chiesa nel Milane
se, ed in cui sono state trovate ottime dopo un
tal tempo : in fatti uno di quest'uova, aperto
nel momento stesso, non aveva perduto nulla di
sua freschezza, colore e sapore ; le altre due ,
aperte otto giorni dopo, cominciavano a guastar
si . I contadini si contentano di conservare le lo
ro Uova nella segatura di legno , nella semola,
o nella cenere , ben premuta in una botte ; san
no parimente che ogni Uovo vecchio ha una ca
vità interiore quando è cotto, e che questo vuo
to è la misura della quantità del liquido che ha
traspirato attraverso al guscio ; così un'Uovo
fresco dev'esser pieno, il che si conosce speran
dolo a un lume ; l'Uovo cotto , per essere un
commestibile salutare, non dev'essere nè gluti
noso , nè duro, ma di una sostanza “ molle ed
umida, come lo dice la Scuola Salernitana:
Si sumas ovum, molle sit atque novum.
Il Sig. Bourgeois riferisce un fatto singolare,
relativamente alla conservazione di un'Uovo di
gallina, e di cui è difficile il rendere una ragio
ne fisica e soddisfacente ; questo fatto è che
l'Uova fatte nel mese di agosto, si conservano
molto meglio e non si corrompono come quel
le fatte negli altri mesi dell'anno; ciò non ostan
te, il mese d'agosto è quello in cui più presto
e più facilmente che in tutti gli altri, le sostanZe
U O V I 9
ze animali ed anche vegetabili tendono alla cor
ruzione . Le contadine della Svizzera conserva
no quasi tutte l'Uova del mese d'agosto, per
venderle in inverno nelle fiere e nei mercati;
perchè sono molto più rare e più care : benchè
quest'Uova non siano così buone come l'Uova
fresche, è caso raro ciò non ostante che vi se
ne trovino alcune corrotte e che non possano
farsi servire agli usi della cucina . Vӏ chi le
conserva nei vasi , empiendoli alternativamente
di strati di cenere e d'Uova . L'Uova della mag
gior parte degli uccelli e forse di tutti, sono
un' alimento fino e sano generalmente, ristora
tivo , grato , delicato , tali sono quelle di galli
na, di fagiano, di pernici , quando si mangia
no fresche .
Tra gli animali ovipari , ve ne sono alcuni
che, all'uscir dall'Uovo, si trovano sotto la for
ma perfetta che ad essi conviene, e che più non
lasciano per tutta la vita; tali sono, per la mag
giorparte, i pesci e quelle specie di animali chia
mati anfibj loricati ( armati di corazza) , le lu
mache che escono dall' Uovo colla casetta ados
so, i ragni che mutano la pelle, siccome anco
ra i crostacei; altri passano per diversi stati,
come gl' insetti che si trasformano; la ranocchia
che ha dapprincipio la coda senza piedi, e poi
i piedi senza coda . Gli uccelli escono dall'Uovo
con una specie di peluria ; ma acquistano ben
presto le penne che li difendono dal freddo,
dall'umido e servono ad essi per volare. Vede
te ciò che abbiamo detto sull'Arte di fare schiu
B 2 de
2O U O V
dere in qualunque stagione l'zova degli uccelli do
mestici, in seguito all'articolo Gallo .
L'Uova hanno generalmente una forma ellitti
ca, più o meno allungata, secondo le specie ; e
differiscono le une dalle altre pel volume, per
la consistenza del guscio e pel colore di questo
esterno inviluppo; differiscono altresì pel sapore
della sostanza interiore . L'Uova dei serpenti so
no rotonde; quelle distruzzo, bislunghe edugual
mente ellittiche alle estremità : quelle della galli
na e della maggior parte degli ugcelli hanno un'
estremità grossa ed una piccola, o un'estremità
ritondata e l'altra che più si avvicina alla pun
ta: finalmente ve ne ha di lunghe e rotonde co
me un cilindro: cert'Uova d'insetti sono fioccu
te, ovvero adorne di una specie di corona di pe
lo : quelle dei pesci si coprono di una specie di
corpo muccoso, che le difende dall'acqua, quando
sono fuori del corpo della madre .
L'Uova della maggior parte,degli uccelli han
no un color dominante, e sul quale sono spar
se macchie più o meno numerose, più o meno
grandi, più o meno varie: in un numero assai
grande di altre specie di uccelli , l'Uovo hasem
plicemente un colore uniforme e senza macchie;
il colore più ordinario e che più comunemente
serve di fondo, è il bianco, o puro, come nell'
Uovo di gallina, o alterato di una tinta bigiccia
o verdiccia : così l'Uova del pollo d'India, dell'
oca, dell'anatra, del fagiano, non sono di un
bianco puro, ma si distinguono alla tinta onde
sono coloriti, non meno che alla grossezza e alla
U O V 2 I
la forma. Alcune specie di uccelli, come il gros
so tinamou, producono Uova di un tnrchino as
sai cupo; altre, Uova verdiccie ; e quelle del fa
giano bianco della China hanno una tinta rossi
gna, pallida ed uniforme: quanto all'Uova che
hanno il guscio screziato, le macchie sul color
dominante del guscio, sono bigie , cenerine,
brune, nericcie , rossigne, talvolta turchiniccie o
verdiccie; sono esse comunemente più larghe,
più fitte ed in maggior numero verso l'estremi
tà più grossa . Hanno creduto alcuni, ma senza
fondamento, che vi fosse qualche corrispondenza
tra il fondo del colore e le macchie dell'Uo
va, e il fondo del colorito e degli scherzi del
la piuma; ma tutti sanno che la gallina nera fa
l'Uova ugualmente bianche che la gallina di quest'
ultimo colore, etc.; etc.
zovo conchiglia. Si dà questo nome a un te
staceo del genere delle porcellane : quelli che
sono grossi hanno il labbro esteriore rigonfio e
dentato, e l' interno di color d'arancio ; i sot
tili e i fragili, sono papiracei .
2ovo Marino. Nome dato da alcuni a una spe
cie particolare di riccio di mare (Brissus). Ve
dete all'articolo Riccio di mare .
2ovo di Serpente o 2ovo dei Druidi. La super
stizione di questi Sacerdoti dell'antica Gallia, gl'
induceva a spacciare che l'Uova di serpente era
no formate dalla propria bava di questi animali.
Vedete all'articolo Serpente . Boezio di Boot ha
dato il nome d'Uovo di serpente o d'Uova di
mare a certi echiniti o ricci di mare, divenuti fos
sili . Vedete Riccio di mare . UOU
ts
si
2 V O U
VOUDROU-DRIOU. E' il gran cucù di Ma
dagascar, del Sig. Brisson e delle Tav. Col. 587 ,
il maschio ; 588, la femmina . Gli abitanti di Ma
dagascar chiamano Voudroug-driou il maschio, e
la femmina cromb. Questa differenza di nome,
dice il Sig. Mauduyt, è fondata sopra quella del
la piuma e sopra quella della grandezza: la fem
mina ha diciassette pollici e mezzo di lunghezza
totale, e il maschio non ne ha più di quindici :
l'uno e l'altra hanno dodici penne alla coda, in
vece di dieci, che è il numero ordinario nel cucù .
Il maschio o il Voudrou - Driou ha come la
femmina, il becco di un bruno cupo e i piedi,
rossigni ; la piuma superiore è di un verde can
giante in color di rame purificato, con una tin
ta nericcia sulla testa; le penne maestre delle ali
sono di un nero verdastro : quasi tutta la piuma
inferiore è di un bigio bianco; l'occipite , la go
la e il collo sono cenerini ; e vi è un tratto ne
ro , situato obliquamente tra l'occhio e il becco .
La femmina o il'cromb ha quasi tutta la piu
ma superiore di un bruno uniforme ; la testa,
la parte sotto il collo e la gola sono trasversal
mente rigate di bruno e di rossiccio : vi è una
tinta di verde oscuro sulle guarnizioni maggiori
delle ali ; le penne di questa parte sono come
nel maschio ; quelle della coda sono di un bru
no lustro; il rimanente della piuma inferiore è
di un rossiccio chiaro, variato di nericcio .
VOULOU. Sorte di canna d' India della spe
cie di quella che gl' Indiani chiamano mambou e
Sacar- mambou. Vedete Legno di Bambou.
Il
U P E 23
Il Voulou della Guiana porta anche il nome
di cambrouze , Arundo, Indica, Clus. ; et exoti
ca, Barr. 18 . E' una canna vuota e grossa come
la gamba in fondo, i nodi della quale, che so
no distanti un piede uno dall'altro , non hanno
alcuna prominenza esteriore ; ma sono interior
mente separati gli uni dagli altri da una pellico
la grossa tre linee . Questa canna si trova nel
paese di Cajenna sulla riva degli aquitrini ; get
ta molti rami dalla radice che crescono all'altez
za di otto o dieci piedi e talvolta più : le foglie
sono sparse in cima ; e il fusto è armato di lun
ghi pungiglioni.
-
Si taglia questa canna di una lunghezza suffi
ciente per farne aste da amache, uso a cui, al
dire del Signor di Prefontaine, riesce meglio di
qualunque altro legno, a cagione di sua legge
rezza. I Selvaggi dipingono ed inverniciano il
Voulou . Un altro uso che fanno del fusto di
cambrouze, è di servirsene a modo di corno o
di tromba parlante ; il suono che ne traggono
serve d'avviso su i fiumi a quelli ai quali vo
gliono far noto il loro arrivo . Se ne servono
ancora per chiamare il vento ; questa è la loro
espressione ; perchè suonano questa specie di cor
no, e credono che il vento , che loro manca ,
ubbidisca al loro comando, per empir le vele
dei loro canot . I Negri coloni vi si provano in
un'altra maniera, chiamandolo col fischio .
UPEROTE, 2perotus. Il Sig. Guettard dà que-
sto nome a un genere di vermicolare , l'anima
le del quale è , per quello ch'ei dice , ignoto .
B 4
24U P U
-eaaaaaa
Il tubo è in forma di pestello, cioè molto più
grosso a una delle estremità che all'altra . Vi si
osservano nell'interno molte piccole valve : la
sostanza tiene il luogo di mezzo tra quella dei
tubi duri e quella dei tubi membranosi : ha la
durezza del cuojo; è calcare, ed è più o meno
contornato all'estremità fatta a pestello. Questo
verme non è solitario .
UPUPA o BUBBOLA, Lat. 2pupa, Fran. Hup
pe, ou Putput, ou Pupu, ou Lupoye; è la bec
caccia di albero di alcuni . L' Upupa, Tav. Col.
52, è un bellissimo uccello di passo, chiamato
dai Francesi huppe a cagione del ciuffo di piu
me che ha sulla testa, o dell'ordinario verso che
fa ; pesa tre oncie incirca , e non arriva a tutta
la grossezza del merlo ; ha, dalla punta del bec
co fino all'estremità della coda, undici pollici di
lunghezza; la stesa delle ali è di diciassette pol
lici; il becco è di due pollici, affilato, appunta
to, un poco arcuato e nericcio; l'iride degli
occhj è di color di nocciuola ; la testa è adorna
o coronata di un bellissimo ciuffo, amplissimo,
alto vicino a due pollici, composto di due ordi
ni di piumette, il color delle quali è di un ros
siccio lustro, più chiaro verso l' estremità , nero
verso la punta, e che può alzare ed abbassare
a suo piacere; il rimanente della testa, la gola,
il collo e il petto sono di un bigio vinoso ; la
schiena in cima e le guarnizioni minori delle ali
sono di un bigio puro, e senza miscuglio; la
schiena in fondo, le piume scapulari, le guarni
zioni mezzane e grandi delle ali sono alternati
--- ---
V2e
U p U 25
vamente diversificate da larghe liste, le une di
un bruno nericcio, le altre di un bianco rossa
stro ; il groppone è bianco, la parte superiore
della coda è nericcia ; il ventre, i lati , le co
scie e la parte inferiore della coda sono di un
bigio bianco e rossastro; il nero è il color do
minante sulle penne delle ali e della coda ; ma
sono esse traversate da macchie bianche, che for
mano sulle ali piegate, cinque zone, e una sola
sulla coda, ma larghissima; i piedi e le ugne so
no di color bruno.
L'Upupa arriva nei nostri climi in primavera,
e parte al fine dell'estate o al principio deli'autun
no, per passar l'inverno nei paesi Meridionali :
questi uccelli sono allora in gran numero in Egit
to; sono stati osservati al Capo di Buona Spe
ranza e a Madagascar; ma sono ivi più piccoli .
Noi abbiamo veduto nella bella stagione, l'Upu
pa in Inghilterra e in Germania; e sembra che
quest'uccello si porti, in estate, nelle regioni
avanzatissime verso il Nord dell' Europa ; non si
vede mai volare in torme, neppur quando arri
va o quando parte ; cerca i prati e le terre fre
sche ed irrigate , ove trova più facilmente i ver
mi e gl'insetti che gli servono di alimento; fre
quenta ancora i luoghi elevati, quando vi trova
o cadute di acqua e melma nella quale vivono in
setti , o terreni sabbionacei e leggieri, confacen
ti ad alcune specie di scarabei, pei quali è por
tato : fa l'uova nelle cavità degli alberi, o nelle
fenditure delle muraglie, o nei buchi dei massi.
Dice Aristotile che l'Upupa costruisce il nido
d' im
26 U p U
-
d'immondezze , e che lo intonaca di escrementi
umani. Forse queste indicazioni, trasmesse fino
ai nostri tempi, l' hanno fatta chiamare in Francia
putput, pupù, gallo merdoso, e puzzolente,nomi
i quali a noi sembra che non meriti per nessun
titolo. Nei nostri climi, la femmina depone l'uo
va sulla polvere, o sul terriccio, i buchi dei qua
li sono ordinariamente coperti , ed è caso raro
che essa vi aggiunga altracosa ;
fa comunemente
quattro o cinque uova, di color bigiccio, ed al
cuni Autori pretendono che le faccia fino a tre
volte l'anno. La carne dell'Upupa, per ciò che
assicurano quelli che sono senza prevenzione, è
di un sapore grato e delicatissimo -
--
L'Upupa è un' uccello diffidente e che difficil
mente si prende a qualunque insidia si voglia ;
ma le si può andar vicino, e le si tira facilmen
te; le giovani si allevano senza molta diligenza,
mantenendole a carne cruda ; divengono familia
rissime e sono suscettibili di qualche attacco .
Il celebre Aldrovando, curioso di sapere per
qual meccanismo l'Upupa possa alzare ed abbas
sare il ciuffo , fece la sezione della testa di uno
di questi animali, e vi trovò un muscolo che gli
sembrò unico , cutaneo e fibroso , a modo di
panicolo carnoso , nascente dalla base del cra
nio , più carnoso nel principio alla parte inferio
re verso la fronte , più membranoso alla parte
superiore verso la cima della testa, nel quale le
piume della testa medesima sono impiantate assai
profondamente : quando tirava questo muscolo
verso la cima della testa , raddrizzava il ciuffo ,
e quan
U R. A 27
e quando lo tirava dalla parte opposta verso il
becco, lo abbassava .
Gli Autori danno una sola proprietà rimarche
vole all'Upupa, che è di essergiovevolissima con
tro la colica, presa in sostanza o in brodo .
Si distinguono due altre Upupe. Vi è: l'Upu
pa nera, che è il buverone col ciuffo di Ameri
ca, del Sig. Brisson; Vedete all'articolo Buverone.
L'altra è del genere dell'Upupa, e si chiama
l' Upupa nera e bianca , che si trova a Madaga
scar, al Capo di Buona Speranza e all' Isola di
Borbone . Quest'uccello è più grande dell'Upupa
nostrale ; ma ha il becco a proporzione più cor
to; le gambe, al contrario, sono più lunghe e
molto più grosse, non meno che il becco ; il
ciuffo ha pochissimo diametro , ed è di un bian
co bigio; la piuma anteriore e quella della parte
inferiore del corpo , è di un bianco lavato di
bigio; il rimanente è di un bruno nericcio ; vi
è una macchia bianca sul mezzo dell'ala piegata;
il becco, i piedi e le ugne, sono di un giallo
cupo. Riguardo all'Upupa di monte; Vedete all'
articolo Suonatore .
URAGANO, Lat. Procellosa tempestas, Fran.
Ouragan. Questo fenomeno, che produce talvol
ta la desolazione e lo spavento, tanto nella cit
tà quanto nella campagna, è un turbine o un
moto vorticoso dell'aria per tutte le direzioni,
prodotto da venti contrarj, violentissimi, che si
eccitano improvvisamente, e che si dissipano ben
presto in seguito . Gli Uragàni sono comuni nei
mari della China. e del Giappone, in quelli del
le
28 Uj R. A
-
le isole di Borbone e delle Antille , ed in molti
altri luoghi del mare, principalmente vicino alle
terre avanzate e alle coste elevate ; ma sono an
cora più frequenti sulla terra, e ne sono tal
volta prodigiosi gli effetti; si capisce per lo più
che è vicino da un fischio che si fa sentire dal
le montagne , e succedono a questo fischio la
pioggia e turbini di vento orribili . Dice il P. .
Fournier, nella sua Idrografia , che i segni di
questi venti e tempeste sono: 1 , Una nuvola ros
sa sull' orizonte, al nascere o al tramontar del
sole ; 2 , Un cerchio turchiniccio o nero intor
no al sole quando tramonta : 3 , Il pallor del
sole, quando tramonta e quando nasce, indica la
pioggia: 4, Il color rosso del sole che tramon
ta: 5 , I raggi che escono di mezzo alle nuvo
le che coprono il sole nascente ; perchè se il
sole vibra i raggi per di sotto , non vi sa
rà altro che pioggia: 6, Le nuvole che vengo
no da tutte le parti e che si radunano intorno
al sole : 7, Una nuvola che il sole si strascina
dietro nel tramontare : 8, Molti cerchj bianca
stri e interrotti intorno alla luna, quando com
parisce rossigna: 9, Finalmente, è segno di una
lunga e dura tempesta , quando il mare compa
risce nericcio e quando la densa spuma di esso,
sparsa quà e là, sembra che si sollevi in bolle
sopra l'acqua . Si può anche dire che gli Uragà
ni abbiano una corrispondenza col sistema dei
tifoni, dei mussoni e dei gorghi; quest' ultimi
altro non sono che vortici di acqua , prodotti
da opposte correnti. Vedete Venti, Gorgo, Cor
e
U R A 29
*=ts
renti , e ciò che ne abbiamo detto all'articolo
Mare .
Il Signor di Chanvalon , nel suo Viaggio alla
Martinicca, dà la descrizione di un furioso Ura
gàno che devastò una parte di quest'isola, ai
12 di settembre 1756 , Quest'Uragàno portò se
co la desolazione e la morte , e le traccie che
lasciò furono le traccie del fuoco : dovunque
passò tutto disparve , e questo cangiamento fu
non meno rapido che terribile : rimasero distrut
te in un momento le case, nè restarono di es
se altri vestigi che gli avanzi sparsi da tutte le
parti ; furono schiantati dalle radiche , alzati da
terra e rovesciati da capo a fondo, alberi forse
non meno antichi degli stabilimenti di questa Co
lonia, e l'enorme grossezza dei quali aveva fino
allora sfidati tutti gli sforzi degli elementi; quel
li che resisterono furono spezzati come deboli
canne , e restarono distrutte e sovvertite le pian
tagioni di ogni specie ; l'erba stessa era calcata e
seccata, come se fosse stata riarsa dal fuoco : si
vedevano da ogni lato spaccature e caverne, sca
vate sul pendìo delle colline, per lo smottamento
delle terre che si strascinavano dietro la caduta
degli alberi e i torrenti delle pioggie . Non si
può non fremer d'orrore nel veder luoghi sem
pre rivestiti di verdura , spogliati in un' istante
da una mano invisibile , Succedettero immediata
mente alle delizie delle primavera, gli orrori dell'
inverno; sembrava che la terra scossa vacilasse
sotto i piedi; era quasi ecclissata la luce del gior
no da un'oscurità che velava tutto il C
C1C
3oU R. A
-=====
che dappertutto esibiva la spaventevole immagine
della notte : gli animali, sbigottiti cercavano da
tutte le parti un'asilo ove sottrarsi alla violenza
dell'aria, che ne soffogava un gran numero : tut
to spirava il terrore e la costernazione : sembra
va che la Natura spaventata fosse vicina all'ulti
ma sua dissoluzione ; e in questo momento in
cui regnava il silenzio universale del terrore , il
vento solo era quello che si faceva sentire con
un fracasso simile al fragore del tuono : il ma
re , nel tempo stesso, metteva sotto gli occhj lo
spettacolo lacrimevole di tutte le devastazioni di
una tempesta: la riva e le acque erano semina
te degli avanzi dei naufragi , e galleggiavano quà
e là i bastimenti fracassati e battuti dai cavallo
ni, confusi colle membra e coi cadaveri sfigura
ti degl'infelici che n'erano stati le vittime . Di
ce il Sig. di Chanvalon, spettatore di questo di
sastro, che la sua abitazione subì la mcdesima
sorte, e che i colori di questa pittura non so
no nè impastati nè caricati dal dolore .
La disgraziata isola della Barbada ha sofferto ,
aì 1o ed 1 1 di Ottobre 178o, un Uragàno co
sì furioso, che mai, a memoria d'uomini, non
si è veduto nulla di più terribile in questo gene
re : rimasero per la maggior parte fracassati i
vascelli del porto, schiantati gli alberi, svelte le
piantazioni, rovesciate le case, rovinate in parte
le fortificazioni, abbattuti i pubblici edifizj , e vi
perirono più di mille persone.
Questi Uragàni sono fenomeni così comuni in
America , che essi soli sarebbero stati sufficienti
per
U R. A 31sa
per farla disertare o per renderla inabitabile da
più secoli; ma o agitazioni così violente lacerino
il seno della terra solamente per disporla alla fe
condità, o l'Uragàno porti seco corpuscoli accon
ci alla vegetazione delle piante , il fatto è che
questi Uragàni, così terribili nell' istante dell'azio
ne , conducono raccolte più abbondanti, e solle
citano la riproduzione dei terreni ; ed è stato
osservato che questo passeggiero ed apparente di
sordine era non solo una conseguenza dell'ordi
ne costante che provvede alla generazione per
mezzo della distruzione medesima; ma un mezzo
ancora di conservar questo tutto , che mantien la
sua vita e la sua freschezza unicamente in virtù
di una fermentazione interiore, che è il princi
io del mal relativo e del ben generale .
URANosCOPo, o TOPO DI MARE, del
Signor Daubenton; 2ranoscopus scaber, Linn.;
Trachinus cirris multis in maxilla inferiore, Ar
ted, Callyonymus, vel 2ranoscopus, Willughb. ;
A Venezia, Lucerna, Pesce Prete, Bocca in ca
po ; Fran. Raspecon, ou Rat de Mer. Pesce co
mune nel Mediterraneo , che forma da se solo
un genere nel sistema di Linneo, sotto il nome
di 2ranoscopus ( cali speculator). Gli “Antichi lo
avevano così chiamato, perchè ha gli occhi si
tuati sulla parte superiore della testa, e diretti
in alto, in guisa che sembra che contempli il
Cielo . Altri pesci, come il diavolo di mare , la
razza , etc. hanno parimente gli occhi sopra la
testa; ma lo sguardo rivolto da un lato .
L'Uranoscopo è lungo un piede : secondo Wil-
lu
32U R. A
lughby, ha la testa voluminosa, piana sopra , di
una forma quasi quadrata, e coperta di un cuojo
osseo e seminato di scabrizie ; la bocca è assai
ampla e situata in sù, come gli occhj ; la ma
scella inferiore è prolungata dall'ingiù all' insù,
in guisa che la bocca verso il sito in cui si apre,
è in una direzione verticale ; la parte inferiore
del muso forma uno sporgimento come un men
to; il labbro inferiore è circondato di piccoli bar
bigli che lo fanno comparir frangiato, e dei qua
li forse si serve il pesce per adescare i pescioli
ni che vuol divorare; le mascelle sono armate
di denti aguzzi; il palato esibisce parimente mol
ti gruppi di denti: vi è sotto la lingua un' osso
che si divide in tre spine : escono dal mezzo
dell'occipite due ossicini ottusi e ritondati, che
si estendono verso gli occhj in forma di semicir
colo; si veggono ugualmente sotto gli operculi ,
nel sito in cui la testa si unisce al tronco , due
spine forti ed aguzze , inclinate addietro, e rin
chiuse in certe specie di guaine , che il pesce
stende e ritira a suo arbitrio, in guisa che puó
scoprire e nascondere le spine poc'anzi accenna
te, dietro alle quali se ne trovano due altre più
piccole .
-
L'Uranoscopo ha il corpo un poco ritondato ;
la schiena e il ventre, piani : la parte superiore
del corpo è di un bigio cenerino; il ventre è
biancastro; le scaglie sono appena sensibili; le
linee laterali formano un'arco verso la parte po
steriore della prima natatoja dorsale ; la prima
dorsale è piccola, nera e guarnita di tre raggi
2Cll
U R. I 33
acuti, senza essere spinosi; la seconda dorsale 2
che è più elevata, ne ha quattordici, le petto
rali ne hanno sedici per ciascheduna; si vede
da ambedue i lati e su gli angoli del petto , tra
gli operculi, una spina con una guaina mobile ,
simile a quelle che abbiamo più sopra descritte ;
le natatoje abdominali sono più vicine al muso
delle pettorali, ed hanno cinque raggi per cia
scheduna; quella dell'ano ne ha tredici ; quella
della coda, dodici. Secondo Rondelet, la carne
di questo pesce è dura, e di un' odor disgusto
so. Secondo altri, non ha odore alcuno, ed è di
un sapor delicato . Hanno creduto alcuni che l'Ura
noscopo sia “il pesce di Tobia ; si pretende che
il fiele di esso sia buono per purgar la vista ,
ed è stato anche adoprato per la cataratta degli
occhj . ”
URIA, Lat. 2ria, Fran. Guillemot . Genere di
uccello aquatico, di cui si distinguono due spc
cie , e il carattere di cui è di avere unicamente
tre dita anteriori e palmate, il becco dritto e
aguzzo. Vi è: l'Uria volgare, Tav. Col. 9o3 .
Gl'abitanti delle isole Feroe lo chiamano Comvvia;
è quasi della grossezza dell'anatra domestica ;
tutta la piuma è di un bruno nericcio ; ma il
ventre e l'estremità della maggior parte delle
penne dell'al2 sono di color bianco; i piedi, il
becco, le dita , le membrane di esse e le ugne
sono di color nero .
L'Uria minore, che impropriamente è stata
chiamata colomba di Groenlandia, Tav. Col. 917,
è appresso a poco della grossezza di un piccio
Bom.TXXXJX, C . Il C e
34U R. I
ne . In estate , la piuma superiore è più o me
no variata di nero, e l'inferiore tutta bianca :
è quasi totalmente bianca in inverno , secondo
le regioni più o meno fredde nelle quali soggior
na questo uccello ; , così n'è varia la piuma se---
condo l'età, le stagioni e il luogo: il becco è
nero; i piedi e le dita sono di color rossigno;
le membrane delle dita stesse sono nericcie .
Le Urie, al dir del Sig. di Buffon, abitano i
mari che bagnano il Nord dell' Europa : si tro
vano alla punta della Scozia , sulle coste dello
Spitzberg, dell' Islanda e delle isole di Feroe;
lasciano queste latitudini nel cuor dell' inverno,
e si rifugiano sulle coste d' Inghilterra, e talvol
ta ancora su quelle di Brettagna e di Norman
dìa. Questi uccelli hanno le ali troppo strette
per reggere a un volo di qualche durata; non
possono far altro che spiccarsi di punta in pun
ta sugli scogli ; nidificano nelle spaccature di quel
li che sono poco elevati (particolarmente la spe
cie minore) , d'onde i pulcini possono gettarsi
nell'acqua ed evitare di divenir la preda delle
volpi, segnatamente degl'isati, che ne stanno in
cessantemente in agguato ; fanno due sole uova
per volta, grossissime a proporzione della cor
poratura , appuntatissime da un'estremità, scre
ziate di neriecio sopra un fondo turchiniccio ; si
trovano alcuni nidi sulle coste dei paesi di Gal
les e di Scozia; ma le famiglie vi si trattengo
no poco, e il numero grande delle nidate si fa
in terre molto più settentrionali, allo Spitzberg,
e in Groenlandia, ove sta permanentemente la
-
spe
U RO 35
specie dell'Uria sì maggiore che minore .
URILI, o MANI, o VITICCI, o CIRRI.
Vedete l'Alfabeto secondario dell'articolo Pianta .
URINARIA. E' il lino selvatico: Vedete que
sta parola. -
URITE, Fran. Hcurite. E'un pesce delle iso
le dell'Africa, di cui parla Dapper, e di cui si
fà un consumo grande a Madagascar . Il pesce
Urite che noi abbiamo veduto in casa di un Di
lettante in Zelanda, è molto simile a un'eperla
no che fosse macchiato di turchino .
URLANTI, SCIMMIE URLANTI. Vedete gli
articoli, Ovarino, ed Aluate .
URLO, ULULATO, Lat. 2lulatus, Fran. Hur
lement. Si dice del grido lugubre e prolungato
che mandano alcuni animali carnivori sanguinarj,
e specialmente i lupi, quando gli stimola la fa
me , e talvolta quando sono in foja ; i lupi ur
lano principalmente la notte; e le notti dell'in
verno sono quelle nelle quali si sentono più ur-
lare. Il cane , quando ha perduto il padrone,
manda parimente un grido gemebondo e doloro
so, che è una specie di Urlo. Vedete gli articoli
Cane e Lupo.
URNE. Vedete Vasi.-
UROCERO, Lat. 2rocerus, Fran. 3rocere .
Insetto che sembra particolare ai paesi freddi;
si dice ciò non ostante che ne siano stati tro
vati alcuni intorno a Parigi . Questo insetto si
rende osservabile per una specie di corno o di
punta che porta alla coda . Ha le antenne fili
formi e composte di ventitrè articolazioni: il cor-
C 2 IlO
36 U R S
no forma una specie di canale in cui si trova na
scosto l'aculeo dell' insetto; questo aculeo bifor
cato in cima , è dentellato intorno come quello
delle mosche a sega, e racchiuso tra due lame
o stucci, come nelle icneumoni . L'Urocero è
stato descritto dal Sig. di Réaumur, sotto il no
me d' icneumone di Lapponia .
UROCHS , Vedete 2 ru; .
URSONE, Hystrix dorsata, Linn., Fran. 2r
son. Specie di animale che abita le terre deser
te del Nord dell'America , e che non deve con
fondersi col riccio, nè col coendù, ai quali è si
mile per alcuni caratteri; ma dai quali ciò non
ostante differisce abbastanza per altri capi, onde
si debba riguardare come una specie particolare.
L' Ursone è il porco spino della Baja d'Hud
son, quello di Ellis, di Edwards e del Sig. Bris
son . E' della grandezza del castoro, ed ha il
corpo appresso a poco della medesima forma :
ha, come il castoro, due denti incisivi , lunghi,
forti e taglienti, e come esso un doppio pelo,
il primo lungo e morbido, ed il secondo è una
peluria o feltro, anche più gentile e morbidet
to ; ma indipendentemente da queste due sorti
di pelo, è tutto coperto di pungiglioni cortissi
mi e quasi nascosti sotto il pclo medesimo. Nei
giovani, i pungiglioni sono a proporzione più
grandi, più apparenti, ed il pelo è più corto e
più rado che negli adulti o nei vecchj.
L'Ursone dorme molto, e il suo alimento pre
diletto è la corteccia di ginepro . Fugge e teme
di bagnarsi; abita sotto le radiche degli alberi-
Ca
U R U37
cavi ; nell' inverno, la neve gli serve di bevan
da; in estate, l'acque, e lambisce come il cane .
I selvaggi ne mangiano la carne, e dopo aver
ne svelto i pungiglioni dalla pelle, dei quali si
servono ad uso di spille e di aghi, se ne fan
no buone pelliccie .
URUBITINGA, Marcgr.pag. 2 14. I Brasiliani
hanno dato questo nome a un bellissimo uccel
lo , che si mette nell' ordine delle aquile . Dice
Ruischio che ne ha la somiglianza, e che è del
la grandezza di un' oca di sei mesi; ha il bec
co e le ugne di color nero . Differisce dall'uru
taurana , altra specie di aquila del Brasile ; 1 ,
pel suo color bruno e nero; 2 , per gli occhi di
aquila; 3 , per le gambe che hanno una tinta di
giallo e sono sguarnite di piume ; 4, per la co
da dì due colori, la parte inferiore della quale
è bianca fino ai due terzi della lunghezza ; il ri
manente è nero e terminato di bianco; 5 , non
ha ciuffo ; e 6, è la metà più piccolo dell'aqui
la col ciuffo del Brasile o dell'urutaurana.
URUBU'. E' l'avvoltojo del Brasile, del Sig.
Brisson, e delle Tav. Col. 187; bozzago della fi
gura del pavone , di Catesby. Hernandez e Nie
remberg gli danno il nome di aura, e France
sco Ximenes, quello di tzopiloth o tropillot; è il
cosquauth della Nuova Spagna . Marcgrave dice
che i Brasiliani lo chiamano Urubù . Questo uc
cello, al dire del Sig. Mauduyt, si trova nelle
diverse regioni dell'America . I Selvaggi della
Guiana lo chiamano ourouva; i Creoli ed iViag.
giatori lo hanno chiamato mercante : si trova an
C 3 co
38 U R U
cora in Africa , e Kolbe lo chiama aquila del
Capo .
L'Urubù è quasi grosso come la femmina del
pollo d'India : l'iride è rossigna : le palpebre
sono di un giallo di zafferano; il becco è bian
castro, talvolta con una tinta rossigna alla pun
ta; la pelle che ne copre la punta è turchinic
cia , le gambe e i piedi tirano al color di car
ne ; le ugne sono nere: la testa e i due terzi
del collo sono coperti di una pelle nuda , che
l'animale aggrinza e distende in certe circostan
ze; è essa variata di turchiniccio , di rossiccio e
di biancastro; vi sono alcuni peli neri ricci ; tut
ta la piuma è di un nero cangiante in porpori
no, e in verde cupo poco rilucente .
Dice il Sig. Mauduyt che questo uccello è mol
to comune a Cajenna, e che ne ha egli ricevu
ti molte volte sotto il nome di couroumou , è
stato ancora mandato dalla Luigiana : viene assi
curato che è abbondantissimo al Perù, e che
ogni mattina, al levar del sole, discende nelle
strade delle città, prima che la gente esca di ca
sa, per cercarvi le immondezze . Desmarchais,
Aeosta, ed altri Autori dicono che gli Urubù so-
no uccelli utilissimi, perchè vanno dietro ai cac
ciatori che lasciano in abbandono i cadaveri degli
animali che hanno scorticato, e le carni dei qua
li infetterebbero l'aria, se gli Urubù non li con
sumassero. Questi uccelli volano in torme gran
di, e sentono o scoprono la preda a una distan
za grandissima ; purgano in una parola, i luo
ghi abitati dagli avanzi degli animali morti. Kol
be
U R U 39
be conferma queste relazioni ; ma è l'i
re che gli Urubù piombano su i buoi o sulle
vacche che trovano a giacere nella campagna sen
za bifolchi: questo fatto èpoco credibile e contra
rio alle abituazioni degli avvoltoi . Dice Catesby
che i bozzaghi della figura del pavone (gli Uru
bù ) hanno il volo leggerissimo , che piombano
in gran numero sulla medesima carogna , e che
spessissimo insieme si azzuffano nel divorarla ;
che sono spesso prevenuti da un'aquila, e che
stanno lontani finchè questa è presente : la cita
zione di un tal fatto è a vicenda contraria alle
abituazioni delle aquile che sdegnano le carogne.
Aggiunge Catesby che i serpenti servono ugual
mente ad essi di pascolo ; che sogliono posarsi
in molti insieme sopra i pini e i cipressi vecchi,
ove si trattengono la mattina per più ore, colle
ali spiegate; che lasciano che si vada vicinissimo
ad essi , senza temere il pericolo, specialmente
quando mangiano .
Gli Urubù sono uccelli schifosissimi : tutti gli
Autori dicono che esalano, come la maggior par
te degli avvoltoi, un'odore infetto, che è un mi
scuglio di muschio e di odor di carne corrotta ;
la pelle e la piuma conservano questo odore, che
si comunica per contatto agli oggetti vicini, mai
non si perde , e dura, al dire del Sig. Mauduyt,
quanto gli ultimi avanzi di questi uccelli. Ciò
non ostante , prosiegue lo stesso Ornitologista,
sono utilissimi, e non si deve trascurar di osser
vare che abitano i luoghi nei quali gli altri ani
mali sono più abbondanti , e nei quali i corpi-
C 4 mOr
4o U RU
morti sarebbero più pericolosi pel calore del cli
ma, e spesse volte per l'umidità unita al calore .
URUS, o URO . Animale quadrupede , bisul
co ed ungulato, che frequenta le montagne della
Lituahia e della Prussia: se ne allevano nella
Russia bianca , che sono stati presi nella Selva
Ercinia . Questo animale , specie di toro selvati
co , è grande e feroce .
L' Urus è il tur o thour dei Polacchi, l' auro
chs o urochs degli antichi Germani; ed alcuni gli
hanno dato anche il nome di bisonte . L' odore
muschiato che si trova nei maschj dell'Urus, e
che i Tedeschi esprimono colla voce di bisem,
lha senza dubbio prodotto la voce di bisonte nel
le lingue straniere . Ora, quest'odore, come os
serva il Sig. Pallas, non sembra che sia molto
sensibile se non quando i tori selvatici sono in
una età avanzata, principalmente nel tempo del
la foja; l'età parimente è quella che produce quel
pelame ispido sulle parti anteriori dei tori selva
tici e che li rende più gobbi e più robusti nelle
parti medesime. Lo stesso Osservatore, Signor
Pallas, pretende che i nomi rus e bisonte abbia
no originariamente disegnato , non due varietà
della specie , ma lo stato diverso del medesimo
animale secondo l'età e il sesso ; ma siccome i
Romani trovarono per la prima volta i tori sel
vatici nelle foreste della Germania, può presu
mersi ugualmente che il nome Urus altro non sia
che il nome Celtico aurochs o piuttosto urochs,
colla terminazione o desinenza latina . Vedete gli
articoli Tur e Aurochs.
URU
j S N 4I
URUTARI, etc. Vedete all'articolo 2rutaurana.
URUTAURANA di Marcgrave. Specie di aqui
la coI ciuffo del Brasile , Aquila Brasiliensis cri
stata: il ciuffo che si alza e si abbassa ad arbitrio
di questo animale, è composto di quattro piume
nere; le due di mezzo sono alte due dita, quel
le dei lati sono più piccole : l'Urutaurana ha il
becco nero e i piedi gialli; tutta la piuma supe
riore è bruna ; ma l' inferiore è biancastra , il
tutto variato di piume nere, disposte in forma
di scaglie . Sembra che quest'aquila col ciuffo del
Brasile sitrovi anche in Africa , uno spazio di
quattro o cinquecento leghe, qual è la distanza
tra il Brasile e l'Africa, non è così grande per
chè un'uccello di un volo così potente non pos
sa superarlo . I Brasiliani, al dir di Marcgrave ,
chiamano la loro aquila col ciuffo 2rutari cuqui
chù carivivi . E' l'yzaquauhtli dei Messicani . Il
Sig. di Buffon è di opinione che sia lo stesso uc
cello che i Viaggiatori Francesi hanno chiamato
aquila dell'orenoco, e che Garcilasso chiama aqui
la del Perù. -
USIGNUOLO. Vedete Rosignuolo .
USNEA COMUNE oUSNEA PIANTA , Usmèa
officinarum , C. B. ; aut communis, Franc. 2snée
commune ou 2snée plante . Sorte di lichen o di
musco arboreo, che ha la forma di un cespuglio
elevato, di fusti cilindrici, pieni , seminati di
scudi orbiculari, attaccati pel centro . La sostan
za n'è fungosa, molle e arrendevole quando è
umida , e fragile quando è asciutta . Vedete l'ar
ticolo Musco . --
-
-
2
42 U S N
*===arma
2snèa Fuggitiva . Vedete Nostoch .
2snèa 2mana, o Musco di cranio umano, Lat.
2snèa humanorum. L'Usnèa umana, secondo Le
mery, è il musco ordinario : è di color verdic
cio , alta due o tre linee, senza odore, di un
sapore un poco salato. Si trova questa pianticel
la principalmente in Inghilterra ed in Irlanda sul
cranio degli appiccati, e pendenti da lungo tem
po dal patibolo; perchèsi pensa a collegarne co
sì bene le membra col fil di ferro, che vi riman
gono appese le ossa molti anni dopo che n'è
stata intieramente consunta la carne dalla putre
fazione e dall'aria. Nasce talvolta l'Usnèa anche
sulle altre ossa dei cadaveri umani , che sono
stati lungo tempo esposti all'aria ; ma non viene
stimata così buona come quella del cranio .
Secondo altri, vi sono due sorti di Usnèa uma
na: la prima di cui si fa uso nelle nostre spezie
rìe, ci viene dall'Irlanda, ed altro non è che
una piccola specie di Muscus vulgaris terrestris,
adianti aurei capitulis, che non differisce in nul
la dal musco che cresce su i tegoli , su i sassi e
sugli alberi. Il Sig Doody, bravo Speziale di
Londra e celebre Botanico , ha osservato che cre
sce ugualmente sulle ossa dei cavalli e dei buoi,
portati alle carognaje ; si trova principalmente
sulle teste o cranj che giacciono sul terreno in
luoghi umidi : La seconda è incrostata sui i cranj
unani, nella stessa maniera che il lichen saxati
lis o lichen petraeus nasce su i sassi nei luoghi in
colti e campestri . Dicono gli Autori che vien
preferita quest'ultima alla precedente, come quel
la
U S IN 43
staaaaaaaaa
la che è dotata di una virtù particolare per la
guarigione di diverse infermità.
L'Usnèa umana, dice Lemery , contiene mol
to sal volatile e molt'olio . Questa pianta è ra
rissima nei nostri paesi, perchè non vi si espon
gono all'aria, così comunemente come nei paesi
del Nord, i cadaveri dei condannati : l'Usnèa è
moltissimo in uso ln Germania, ove si adopra
come astringente nell'emorragia del naso, met
tendola nelle narici: si può ancora farne uso per
l'epilesìa . L'Usnèa umana entra nelle polveri
simpatiche, ed in molte composizioni che tendo
no tutte a fermar l'uscita del sangue da qualsi
voglia parte del corpo. Si trova nell'Effemeridi
di Germania, Decur. 1 , ann.2 . pag. 96 e seguen
ti, una dotta Dissertazione del Dottor Martino
Bernhardi di Bernitz, nella quale si estende mol
to sulle virtù di questa pianta; noi rimettiamo
ad essa il nostro Lettore che vi vedrà, tralle al
tre cose curiose , diversi metodi per farla cresce
re su i cranj umani .
Varj Autori, come Grube e Junchers, assicu
rano che l'Usnèa umana non ha altra virtù spe
cifica che quella la quale alcune persone credule
o superstiziose si sono compiaciute di attribuirle.
Quindi è che Marck, famoso Droghista di No
rimberga, dice che tutto il merito di questa Us
nèa consiste semplicemente nella rarità; così la
celebrità particolare dell'Usnèa umana non ha al
tra origine che l' impostura attinta nella dottrina
di Paracelso . Abbiamo ciò non ostante veduto
più di una volta stagnate emorragie considerabi
li
US Q
li del naso, per mezzo dell'Usnèa umana: del
rimanente , avrebbe forse l'emorragia ugualmente
cessato coll'applicazione del musco ordinario.
USQUIEPATLI o YSQUIEPATLI, o IZQUE
POLT dei Messicani . Animale quadrupede della
provincia di Guatimala nella Nuova Spagna, e
delle Indie Occidentali, simile alla volpe per
l'astuzia e per la finezza . Questo animale è lun
go sedici pollici incirca, compresa la testa e il
corpo : ha le gambe corte , il muso assottiglia
to; le orecchie piccole , il pelo di un bruno cu
po, le ugne nere, appuntate , ed in numero di
quattro ; abita nei buchi e nelle spaccature delle
rupi, nelle quali alleva i suoi parti; vive di sca
rafaggi, di vermi di terra, di uccelletti, e quan
do può entrare in un pollajo, strozza i polli dei
quali mangia solamente il cervello; quando viene
irritato o spaventato, sparge un liquore di un
fetore insopportabile, a segno che nè gli uomi
ni , nè i cani ardiscono di accostarglisi, e l'ori
na che verimilmente si meschia con questo liquor
pestilenziale , macchia ed infetta in una maniera
indelebile . Sembra del rimanente che questo puz-
zo non sia una qualità abituale, perchè si giun
ge talvolta ad addomesticar l'animale ; Si dice che
vanno allora dietro ai padroni, come gli anima
li domestici, e che non lasciano andare quest'
orina puzzolentissima se non quando sono messi
alle strette o battuti. Il gaz perfido che essa esa
la , è in qualche maniera l'unic'arme di cui si ser
vono per difendersi contro i cacciatori . Quando
i Selvaggi ne ammazzano alcuno, gli tagliano laVeS
U V A45
vessica, affinchè la carnc , che essi trovano buo
na a mangiarsi, non conservi questo fetore appe
stato . Non si fa conto alcuno della pelle dell'
Ysquiepatli, a cagione di sua spessezza e della
lunghezza del pelo ; ma i Selvaggi la fanno ser
vire a diversi usi , come di sacchi , borse, etc.
Sembra che l' Usquiepatli abbia alcune relazio
ni col tasso puzzolente del Capo di Bnona Spe
ranza, e che poco differisca dalla bestia puzzo
lente della Luigiana - Vedete queste parole. Sospet
ta il Sig. di Vosmaer che sia una puzzola . L'Ys
quiepatli altro non è che il coaso, prima specie
delle moffette. Vedete l'articolo Moffette .
USUN . Specie di ciliegio del Perù, di un sa
pore dolce e grato, ma che, come alcune specie
di funghi della Provenza, ha la proprietà singo
lare di tinger l'orina di color di sangue. Questa
proprietà spaventa vivamente quelli che non ne
sono prevenuti : ma in capo a dieci o dodici ore,
tutto è cessato .
UTIAS, OUTIAS, COUTIAs. Nomi che so.
no stati dati alla specie minore dell'aguti, che è
l'Acouchi . Vedete questa parola.
L'2tias di Aldrovando èl'alagtaga. Vedete que
sta parola.
UVA. Lat. 2va, Fran. Raisin. E' il frutto del
la vite, che viene in grappoli, e che è buono
a mangiarsi e a fare il vino . Vedete all'articolo
Vite .
2va di America , o Erba della Lacca. Ne ab
biamo parlato sotto il nome di solano in grappo
li. Vedete questo articolo.
Za
46 U V A
va Barbata, 2va di Corinto, di Damasco, etc.
Vedete in seguito all'articolo Vite.
2va Marina, Lat. Ephedra. Pianta curiosa di
cui si distinguono quattro specie .
1. Quella che si chiama particolarmente zva
marina maggiore, Ephedra maritima major, To
urn. ; Polygonum bacciferum maritimum majus,
sive zva maritima major, C. B.; et , Tragos,
Lob. Giov. Bauh . Arbusto senza foglie che cre
sce all'altezza di un'uomo: ha la radice bislun
ga e nodosa ; il tronco, grosso talvolta come il
braccio, mette molti ramoscelli delicati, sottili
quasi come quelli del giunco, separati da nodi
come quelli dell'asperella ossia coda cavallina,
di color nericcio, che si dividono in più altri
ramoscelli , l'estremità dei quali sono armate di
spine dure; i fiori escono dai nodi dei rami , e
sono disposti in grappoletti di color erbaceo bian
castro; succedono ad essi bacche ossia coccole pie
ne di sugo, sostenute da un calice in forma di
coppa, che giunte alla maturità e schiacciate,
tingono le dita di rosso ; sono di un sapore aci
do e grato; e racchiudono semi triangolari, ap
puntati, duri ed astringenti. Questa pianta cre
sce nei luoghi sabbiosi e marittimi in Provenza
ed in Linguadoca.
2 . L'2va marina scandente (Anabaso) (a),
Ephe
() il Sig. Cavalier de sis un genere di piante
la Mark fa dell'Anaba- erbacee o sitblignee, e
che-
U V A 47
Ephedra, sive Anabasis, Bell , Dodon., Tourn;
Polygonum bacciferum scandens, C. Bauh. , Rai
Hist ; cancon et Ephedra Plini . E' meno alta del
la precedente ; ha i rami scandenti ; i fiori, pic
coli, muscosi e pallidi; i frutti, rossigni. Que
sto arbusto cresce particolarmente lungo certe val
li del monte Olimpo e nell'Illiria.
3 . La terza specie è l'Ephedra (va) mari
tima minor,Tourn.; CrotonTNicandri, Ang. E' an
cora meno alta della precedente; il fusto è ligneo
e mette molti rami verdi , scannellati, facili a
rompersi, nodosi , pieni di midolla viscosa che
divien rossa seccandosi ; i fiori nascono alle ci
me dei rami , sono piccoli , gialli e raccolti in
molti insieme; succedono ad essi frutti simili a
quelli del tasso, rossi , di un sapor dolce, e
che contengono semi bislunghi, uniti a due a
due . Si trova questa pianta in Linguadoca, vi
cino al porto di Cette, verso Frontignano, nei
luoghi sassosi e vicini al mare .
4. Quest'ultima specie di Uva marina differi
sce dalle altre , per le molte sue minutissime fo
glie; si trova in Ispagna, Ephedra Hispanica ar
borescens, tenuissimis et densissimis foliis, Tourn.
Le
che ha relazioni grandi li, e l'anabasis di foglie
colle sode . Vi è l' ana- a clava, delle vicinanze
basis non frondoso, del- di Astracan ; l'anabasis
le rive del mar Caspio dalle foglle di tamarisco
o dei contorni di Tripo- , di Spagna .
48 U V A
Le cime di questi arbusti e i frutti di essi so
no detergenti , astringenti, buoni per l'ernie, e
per fermare ogni sorte di flusso .
2va Marina. E', secondo Lemery, un'insetto
marino , che si può mettere tra le specie delle
lumache; dice egli che è di figura bislunga , in
forme, tutto coperto di glandule rosse e turchi
ne , che rappresentano in qualche maniera un
grappolo di Uva ; ha la progressione lenta , e
due corna alla testa, come la lumaca . Si trova
talvolta quest' insetto sulla riva del mare.
Dice lo stesso Autore che vi è un'altra specie
di Uva marina, proveniente dall'uova di seppia
che si ammucchiano e si agglutinano insieme in for
ma di grappolo di Uva, e che sono tinte di ne
ro dal liquore che esce dalla seppia . Si dà final
mente ancora il nome di Uva marina alla sapo
netta marina, di cui si distinguono più colori:
è essa ordinariamente bislunga, con una specie di
peduncolo, e si trova nell'Oceano. Pretendono
alcuni Osservatori di avervi scoperto un moto
progressivo, come in certe specie di zoofiti mol
luschi . Vedete Saponetta di mare, in seguito all'
articolo Corallina. Vedete ancora l'articolo Seppia .
2va Orsina , o d' Orso , Lat. 2va ursi aut ur
sina, Fran. Raisin d' Ours ou Bousserole . E' un
piccolo arbusto che cresce nei paesi caldi, in
Ispagna , etc. Si trova ancora nelle Alpi e nei
Pirenei, ed in Isvizzera nel Cantone di Berna ,
appie del monte Suchet : prende il nome dalla
somiglianza che ha coll'Uva, e dall'esserne ghiot
ti gli orsi, per ciò che si pretende . Questo ar
bu
U V A 49
busto è simile alla mortella . Vedete questa paro
la ; ma ne sono più spesse o grosse le foglie ,
bislunghe , ritondate , si accostano a quelle del
busso, più strette, rigate dai due lati, nervose
di un sapore astringente , accompagnato da ama
rezza ; queste foglie sono attaccate a ramoscelli
lignei , lunghi un piede , rivestiti di una cortec
cia sottile e facile a separarsi : i fiori nascono in
grappoli all'estremità dei rami ; sono fatti a so
magli; e succedono ad essi bacche ritondate, mol
li , rosse , ciascuna delle quali racchiude cinque
ossicini , disposti ordinariamente in costa di po
pone ,ritondati sulla schiena ; le bacche hanno
un sapore stittico : tutte le parti della pianta so
no moltissimo astringenti , e buone , secondo il
Sig. Levvis, a tingere in bruno .
-
Il Sig. De Haen , gran Pratico nel Collegio
di Vienna in Austria , ha riconosciuto da alcuni
anni le virtù di questa pianta , come dichiaratis
simamente specifiche per distruggere il calcolo ,
i bruciori di orina che ne dipendono, e contro la
colica nefritica ; se ne adopra l'infusione delle
foglie nell' acqua , unendovi un poco di nitro .
Si può consultare un Trattato su questa materia,
del Sig. Quer, Regio Professor di Botanica a
Madrid. Questo trattato, stampato a Strasburgo,
si trova presso Durand , nipote, a Parigi. Que
ste medesime foglie nella Baja di Hudson , servo
no di tabacco per fumare .
zva Selvatica. Si da questo nome e quello di
mirtillo, alla mortella . Vedete quest'ultima parola .
B.om.T.XXXIX,D UVA
5o U V A
UVA SPINA (a), o GROSSULARIA SPINO
SA. Grossularia spinosa sativa, C. B. Pin. 455 ;
vva crispa, Linn. 292; Trag.; Grossularia sim
plici acino, vel spinosa, sylvestris, Pitt. Tourn,
Fran. Groseillier épineux . Si dà generalmente il
nome di Grossularie a molte specie di arbusti
spinosi e non spinosi, e che sono inoltre gli uni
dagli altri diversi per la diversità dei frutti : do
vendo noi dunque parlare dell'Uva spina o Gros
sularia spinosa , sembra naturale che trattiamo
nel tempo stesso delle principali e più note spe
cie delle Grossularie , che comprendono anche i
Ribes, pei quali abbiamo rimandato all' articolo
presente.
.
Cominciando pertanto dalla Grossularia spino
sa o Uva spina , se ne distinguono due specie ;
una selvatica, l'altra domestica o coltivata . L'Uva
spina bianca o Grossularia bianca selvatica, è la più
comune : viene spontaneamente vicino alle siepi,
nei boschi . Questo arbusto è alto cinque piedi o
incirca ; ha la radice lignea ed un poco fibrosa ;
mette essa fusti numerosi e ramosi, ed armati da
tutte le parti di spine forti vicino all' origine
delle foglie . La corteccia è porporina nei rami
Vec
(a) Alla parola Ber- è uno dei due nomi
beri è stato rimandato italiani del Berberi,essen
per isbaglio aquesto arti- do l'altro Crespino, che
colo;ma si deve guardare è il più comune.
l'articolo Spina acida che
U V A 5 I
vecchj, biancastra nei giovani. Il legno è di co
lor di busso pallido ; le foglie sono larghe come
l'ugna del pollice, quasi rotonde , un poco fra
stagliate, verdi , pelose , di un sapore agretto e
sostenute da code corte . I fiori sono piccoli e
di un soave odore ; nascono molti insieme nelle
ascelle delle foglie , due, al più, sopra ciascun pe
duncolo , spesso uno solo; sono belli, pendenti ,
tutti composti di cinque foglie disposte in giro ,
ed attaccate alle pareti del proprio calice , che è
inciso in cinque parti , ed a cui sono attaccati
gli stami in numero di cinque . Succedono ai fio
ri frutti o bacche rotonde , o ovali , separate ,
molli, piene di sugo , della grossezza di un'aci
no di Uva , rigate dal peduncolo o gambo fino
all'umbilico , a guisa di meridiani ; verdi dap
principio ed acide al palato; giallastre quando so
no mature , di un sapor dolce e vinoso , piene
di molti granelletti biancastri.
La specie di Uva spina o Grossularia domesti
ca non differisce dalla precedente se non perchè
è meno spinosa , e perchè ne divengono le fo
glie e gli acini più grandi e più aromatici.
Questi acini o bacche sono quelli che si chia
mano Uva spina bianca o Uva spina dolce; quan
do sono acerbi, se ne fa uso nelle salse e negl'in
tingoli a modo di agresto. Sono refrigeranti ed as
tringenti, eccitano l'appetito , e sono ordinaria
mente graditi dalle donne incinte , quando nau
seano gli altri alimenti; guariscono le nausee e
fermano il flusso di ventre, ed anche l'emorra
gie; cotte nel brodo, sono giovevoli ai febbrici
D 2 tan
52U V A
tanti . Si mangiano le mature appena cotte ; ma
si corrompono facilmente nello stomaco . Ne di
viene un poco vinoso il sugo per la fermentazio
ne. Se ne consuma una quantità grande in Olan
da e in Inghilterra, ove è molto coltivato questo
arbusto .
Dice Ray che gl' Inglesi fanno un vino di que
sti frutti , mettendoli in una botte e versandovi
sopra l'acqua bollente ; turano bene la botte, e
la lasciano in un luogo temperato, pertre o quat
tro settimane, finchè il liquore sia impregnato del
sugo spiritoso di questi frutti, che restano allora
insipidi. S'imbottiglia in seguito il liquore mede
simo , mescolandovi zucchero; si turano bene le
bottiglie , e si lasciano finchè il liquore si sia
mescolato intimamente con lo zucchero per la
fermentazione, e sia cangiato in un liquor pene
trante , grato e simile al vino
La Grossularia in grappoli ossia Ribes , Fran.
Groseillier agrappes:Se ne distinguono due specie.
1. La Grossularia Rossa o Ribes Rosso , Ribes
rubrum , Linn. 29o; Grossularia hortensis, majo
re fructu rubro, C. B. Pin.455; Ribes vulgaris,
flore rubente, aut Acidus ruber, Gio. Bauh. 2 , 98.
Fran. Groseillier rouge . E' un'arbusto non spino
so , che si coltiva comunemente negli orti e nei
- giardini ; ha le radici ramose , fibrose ed astrin
genti ; i fusti o i ramoscelli sono numerosi, du
ri , storti , flessibili ciò non ostante e alti cinque
piedi o incirca , coperti di una corteccia bruna -
Il legno n'è verde , e contiene molta midolla;
le foglie sono quasi rotonde , lobate , verdi e
den
U V A53
-
dentellate ; i fiori sono corti, disposti in grappo
letti pendenti, i gambi dei quali escono dalle
ascelle delle foglie . Ciascuno di questi fiori è
composto di molte foglie disposte in rosa, e at
taccate alle pareti del calice : succedono ad essi
coccole grosse come quelle del ginepro , verdi
dapprincipio , rosse nella maturità , sferiche e
piene di un sugo acido, moltograto al palato, e
all' odorato, e di molti semetti . Queste coccole
sono il Ribes rosso . L'Arbusto del Ribes rosso,
trapiantato, esige un terreno grasso , ben conci
mato , e se ne fanno le bordure dei parterre .
2. L'altra specie di Grossularia in grappoli o
di Ribes ha i fiori bianchi; ma la maggior parte
dei Botanici lo riguarda piuttosto come una va
rietà del precedente, che come una vera specie .
Queste coccole si chiamano Ribes bianco piccolo,
Ribes vulgaris, fructu albo, Clus. Hist.: non sono
esse così comuni come le rosse ; ma hanno il
medesimo sapore e la medesima virtù; sono an
che più stimate, meno acide e ne sono più gros
si i grappoli . Questo arbusto è meno elevato
del Ribes rosso; ha le foglie piccole, peziolate,
senza pelo , trilobate e dentate; i fiori, in grap
poli dritti, e guarniti di brattee . La Grossularia
bianca o Ribes bianco e perlato, detto di Olan
da , Grossularia hortensis, fructu margaritis simili,
C. B., richiede un terreno forte ed umido:si pian
ta di distanza in distanza, e si potano pochissimo
questi piantoni i due primi anni, ma nei seguenti si
potano cortissimo . .Generalmente i Ribes si mol
tiplicano di rimessiticci radicati o di barbatelle, ta
D 3 gia
54 U v A ,
gliate dalla pianta vecchia . Se si voglia la molti
plicazione per rimessiticci, si scelgono i più for
ti, si sotterrano a otto piedi di profondità, e si
piantano in distanza di tre piedi uno dall'altro .
Questi rimessiticci danno frutto al second' anno .
L'Olanda è il paese in cui s'intende meglio che
in qualunque altro la coltivazione e la potatura
del Ribes: tutti i Ribes, del rimanente, lasciano
la corteccia esteriore .
Si trova nelle Alpi e nei Pirenei un Ribes di
frutto bianco e dolce , Ribes alpinum dulce ,
Linn. 291 ; Gio. Bauh. ; Grossularia vulgaris ,
fructu dulci, C. B. Pin.; Tourn.-
Si mangiano le coccole bianche e rosse delle
Grossularie o Ribes quando ancora sono attacca
te ai graspi , e vi si aggiunge un poco di zuc
chero; i fanciulli e specialmente le fanciulle sog
gette ai pallidi colori, le donne stesse attaccate
dalla pica, e dalla malacia, siccome ancora i feb
bricitanti le ricercano con avidità, a cagione del
sapore acido, vinoso e grato che hanno; si fan
no in confezione i grappoli intieri con lo zuc
chero, come le ciliege . Si fa parimente col fuo
co o senza, una conserva di Ribes, che è bellis
sima , tremula e gratissima al palato , mettendo
il sugo di Ribes con lo zucchero fino a una con
veniente consistenza; ed è questa una confezione
che serve non solo al dessert, ma che si con
serva altresì per sollevar gl' infermi , principal
mente quelli che hanno la febbre . E' ottima nel
le convalescenze delle malattie acute; e sommi
nistra un'alimento leggiero, temperante e vera
IlCIl
U V A55
mente rinfrescativo . Si prepara nelle Spezierie
un siroppo col medesimo sugo , ossia un robbo
o mosto , facendolo condensare fino alla consisten
za del miele . Questo sugo, stemperato in tre o
quattro parti d'acqua, e edulcorato con una suf
ficiente quantitá di zucchero, è noto sotto il no-
me di acqua di Ribes. Il grato sapore di questa
bevanda l' ha fatta passare dalla bottega dello
Speziale a quella dell'Acquacedratajo, ed una tal
bevanda è esattamente analoga alla limonata . Si
fa ancora col Ribes rosso perfettamente maturo ,
dopo averne distaccati gli acini dai graspi, un
vino gratissimo: bisogna, per tal' effetto, coglie
re il Ribes verso il mezzogiorno, metterlo in
una botte sfondata da una parte , che servirà di
tino , poi schiacciarlo coi pestoni quanto sarà
posssibile, gettarvi unpoco di acqua, per darpiù
fluidità al sugo naturalmente viscoso, ed affinchè
si operi una fermentazione tumultuosa , principio
dello sviluppo del corpo spiritoso , che è l'ani
ma di tutti i vini . Se il sugo destinato a fer-
mentare, è al contrario troppo fluido, e se non
contiene a sufficienza corpi muccosi dolci , vi si
aggiunga un poco di zucchero che si agiterà,
per incorporar bene il tutto .
Tutti sono d' accordo intorno alla bontà del
Ribes rosso, per temperare l'interno ribollimen
to del sangue , e per reprimere i moti. della bi
le : è esso moderatamente astringente, fortifica
lo stomaco, toglie l'inappetenza, e calma il mal
di gola. E'buono ancora neivomiti, nelle diarree,
nelle emorragie, nelle febbri maligne e nelle ma-
D 4 lat
56 U V A
lattie contagiose; ne diviene ciò non ostante pre
giudicievole l'uso, se se ne prenda troppo e mal
a proposito; perchè l'uso continuo degli acidi
nuoce allo stomaco, eccita la tosse, è pernicioso
al petto, e principalmente quando si teme l'in
fiammazione dei visceri -del basso ventre.
Vi sono ancora altre specie di Grossularie ,
come il cassis o il cassier des Poitevins , altri
menti Grossularia nera ; Vedete Cassis . La Gros
sularia spinosa delle Antille, della quale i Creoli
mangiano il frutto, che è piccolo, rosso, pieno
di semetti e di un sapore acidetto ; è il Solanum
scandens aculeatum , flore intus albo, extus pur
pureo, Rum.; Barr. Ess. pag. 1 o5.
2va Turca Amarante. E' la Fitolacca . Vedete
Fitolacca.
zva di Volpe, Herba Paris , Dod. Pempt. 444,
Solanum quadrifolium, bacciferum, C. B. Pin. i 67;
Paris quadrifolia, Linn. 527. Pianta di un odo
re puzzolente ed ingrato , e che cresce sponta
neamente nei boschi folti o ombrosi , principal
mente nei terreni grassi ; ha la radice perenne;
fina, lunga, articolata e strisciante ; mette un fu
sto rotondo all'altezza di mezzo piede , dritto ,
semplice , rosso alla base e verde in cima , che
sostiene in mezzo quattro foglie disposte in cro
ce , talvolta cinque , opposte , in verticilli , bis
lunge , ovali, intiere, crespe, venate , lucide sot
to , nericcie sopra ; la sommità sostiene un fio
retto erbaceo di quattro petali verdi, disposti pa
rimente in croce: a questo fiore succede una bac
ca o coccola molle, grossa come un'acino d'uva »
por
V U L 57
-
***
porporina, rilevata in quattro angoli, e divisa in
quattro cellule piene di semi fini, ovali e bianchi .
Tutta questa pianta è di uso , e passa per ce
falica, risolvente ed anodina ; è buona inoltre
per la peste e pei veleni, e segnatamente per le
vertigini. Noi consigliamo ciò non ostante di
non prenderla interiormente se non in piccolissi
ma dose, altrimente l'uso ne sarebbe troppo pe
ricoloso . Se ne applicano le foglie sui buboni
pestilenziali .
UVEA , Lat. vea Fran. vée . E' una mem
brana dell' occhio , così chiamata dal colore che
è stato paragonato a quello dell'acino dell'Uva
nera in maturità .
VULCANO, Lat. Volcanum , Fran. Volcan . Si
dà questo nome alle voragini montuose ed ar
denti, che, nelle eruzioni che fanno , coprono
l' orizonte di fiamme o di tenebre ; che vomita
no impetuosamente e in tempi diversi , fiumi di
materie bituminose, sulfuree, infuocate , o get
tano come una grandine di pezzi di sassi, altri
calcinati , altri più o meno vetrificati ed in isco
rie, o vortici di vapori, nuvole di ceneri, tor
renti di fumo in globi o in colonne ritorte che
oscurano la luce del sole ; o che scagliano da
tutte le parti, all' incerto splendore dei lampi, i
fulmini e le saette , e finalmente l'effetto dei
quali, più violento di quello della polvere e del
fulmine, ha in ogni tempo empiti gli uomini di
stupore e di spavento, e desolato la terra.
Tra le montagne ignivome più spaventevoli e
più formidabili, bastano i Monti Vesuvio, Etna
ed
58 V U L
ed Ecla in Europa, per darci un'esempio palpabi
le di questi abissi distruttori, seminati sul nostro
globo. Nulla è paragonabile ai disastri che sono
le conseguenze dell'eruzione di essi ; attaccano
tutto insieme l'aria , la terra, il mare, e porta
no dappertutto il timore, il terrore , la desola
zione e la morte .-
Guardiamoci bene dal pronunziare , dal silen
zio del nostro ritiro e nella calma che vi godia
mo , troppo severi e precipitati giudizj su gli
Autori che ci dipingono questi fenomeni dei qua
li sono stati testimoni oculari ; nè prendiamo
sempre per esagerazioni la vivae forte espressione
che ne anima le relazioni e che le rende spaven
tevoli . I fenomeni grandi della Natura non sono
mai ben dipinti e neppur mai descritti, se non
quando sono vivamente sentiti, ed allora solo lo
storico è veramente fedele, quando hasaputo
trasmettere all'anima di chi legge il sentimento
che ha provato ei medesimo .
Le vaste e profonde convulsioni che accompa
gnano l' eruzione di un Vulcano , esibiscono a
tutti i filosofi che studiano le maraviglie della
Natura, uno spettacolo maestoso, degno ugual
mente di ammirazione e di stupore . Questi di
sastrosi fenomeni hanno origine da certi fuochi
che racchiudono in seno le montagne, delle qua
li minano le volte : sono eccitati dall' aria , e
l' acqua ne raddoppia la forza : le materie più
resistenti, più apìre, più refrattarie, non possono
reggere alla violenza di questi fuochi , come si
vede dalla natura di certi pezzi di lave di sostan
Ze
V U IL 59
ze minerali di diversi colori, ed una parte delle
quali è vetrificata , mentre l'altra che è calcina
ta , resiste alla violenza del fuoco ordinario dei
nostri fornelli. Vedete alle parole Lava e TPomi
ce . E' così grande l'azione di questo fuoco e
n'è così violenta la forza dell' esplosione , che
produce colla sua reazione scosse forti abbastan
za, per commuovere efar tremar la terra , per
agitare il mare, rovesciar le montagne, distrug
ger le città e gli edifizj più solidi, a distanze anche
considerabilissime . Questi effetti, benchè natura
lissimi , sono stati riguardati, al dir del Sig. di
Buffon, come prodigj; e gli abitanti dell'Islanda
riguardano l'apertura dell'Ecla come la bocca
dell'inferno; i muggiti che fa sentire sonole gri
da dei dannati ; finalmente l'eruzioni sono, se
condo questo popolo, gli effetti del furore e del
la disperazione degl'infelici . Quanti altri paesi
esibiscono il medesimo fenomeno e la medesima
superstiziosa opinione ! Eppure tutto si riduce a
fracasso, a fuoco, a fumo.
L' eruzioni dei Vulcani sono ordinariamente
precedute da rumori sotterranei, simili a quelli
del tuono ; si sentono fischj orribili, ed uno spa
ventevole fracasso ; sembra che la terra provi
una lacerazione intestina , e che si scuota fino
dai fondamenti : sembra che bollano le materie
contenute nel recipiente, si gonfiano talvolta fino
al segno di sollevarsi sopra gli orli della bocca
del Vulcano , e scorrono in seguito lungo il
pendio della montagna, ove raffreddandosi conser
vano la forma delle onde che ad esse aveva
ol' ef
6o v U L
l'effervescenza , nel tempo della fusione. Altre .
volte le materie vulcaniche si fanno strada attra
verso ai massi di una rocca dura, e le parti cir
costanti a queste pietre , sollevate dalla forza
della lava, si drizzano in piede , e formano una
centina elevata di molti piedi intorno al cratère,
o pico vulcanico .-
Quindi i luoghi circonvicini dei Vulcani sono
seminati di una enorme e confusa congerie di
ceneri e di tutte le materie scagliate in aria dalle
esplosioni : vi si trovano ammontate lave più o
meno porose e più o meno compatte e dure ,
allume , sale ammoniaco , piriti , scorie , pozzo
lana , rena abbrustolita , terre di pomici caldissi
me . I cavalli , camminando sopra la maggior
parte di queste terre , le fanno rimbombare co
me se il terreno fosse vuoto . Si osservano an
cora nelle vicinanze dei Vulcani molte spaccatu
re . Queste specie di camini aprono un passo li
bero all'aria o all'acqua che sono state messe in
espansione dalle fornaci che sono alla base . In
tempo di giorno si vede uscire il fumo; e que
sti stessi vapori compariscono infiammati o fosfo
rici in tempo di notte. Senza tali sfiatatoj, que
sti agenti produrrebbero sul nostro globo rivolu
zioni molto più terribili di quelle che vediamo
nei terremoti , e sarebbero esse sempre accompa
gnate da una total sovversione dei paesi nei quali
si facessero sentire . Sono dunque i Vulcani un
benefizio della Natura ; quindi è che vediamo
che la Provvidenza ne ha situati in tutte le par
ti del Mondo, ed il Naturalista che viaggia può
S
V U L 61
fissare i suoi sguardi sulle montagne a cratére,
osservare , interrogare i monumenti antichi e
moderni degl' incendj del nostro globo. Sembra
che i vestigj dei Vulcani coprano due zone con
siderabili, parallele all' Equatore , che stendono
alcuni rami fin verso le regioni delle zone gla
ciali dell'uno e dell' altro Polo.
Nci paesi nei quali sono Vulcani , si trovano
in abbondanza ferro , scorie di diversi minerali,
sali o bianchi o tinti di giallo e di verde , sassi
vetrificati o riarsi o alterati, zolfo , realgal, schi
sto alluminoso, petrolio, acque più o meno cal
de e minerali, e vapori mefitici . E' stato rico
nosciuto, in virtù di esatte osservazioni, che nei
paesi esposti al furor dei Vulcani, le acque sono
spesse volte guaste o dall' alcali minerale o dalla
calce nativa e dallo zolfo , il che fa un hepar
sulphuris (fegato di zolfo ) . Nell'isole dell'Ascen
sione e di S. Elena, non meno che alle Azore ,
s'incontrano etiope marziale, terre sulfuree e
scorie simili ai rosticci del ferro o alla pietra di
Perigord . L'analisi che il Sig. Cadet ha fatto ,
nel 1761 , della lava del Vesuvio, fa vedere che
vi entra il ferro, il vitriolo marziale , l' allu
me, &c. Il Giappone e la catena delle Cordeglie
re al Perù , ove sono sedici Vulcani, abbondano
parimente di zolfo e di ferro. Spesse volte l'eru
zioni sono accompagnate da acqua bollente che
esce in grande abbondanza e che forma torrenti
di lave di un liquido più o meno fangoso , ed
in seguito innondazioni . Nel giorno medesimo
del terremoto di Lisbona ( primo di Novem
62 V U IL
bre 1755), dopo un rumor sotterraneo, si aprì
la terra a una lega di distanza da Angoulemme ,
e ne uscì un torrente carico di rena di color
OSSO , - -
Alcuni Fisici moderni , testimonj del rumore
improvviso e della prodigiosa ebullizione che
hanno luogo quando cade un poco di acqua so
pra un metallo in fusione, hanno creduto di do
ver sospettare che l' apertura di molti Vulcani,
ed anche le nuove eruzioni più violente dei Vul
cani antichi siano cagionate , dall' incontro delle
acque che sono sotterra , con materie metalliche
abbondanti , che la violenza di una infiammazio
ne ha messe in fusione .
I Vulcani più terribili non si trovano comune-
mente che sulle alte montagne , verso i luoghi
marittimi ; bastano per prova di ciò quelli che
già abbiamo accennati , cioè il Monte Vesuvio,
nel Regno e vicinanze di Napoli , l'elevazione
o altezza perpendicolare del quale, non è , se
condo alcuni, maggiore di seicento settantasette
piedi sopra il livello del mare ( il dotto Sig. Ha
milton pretende che sia di seicento diciassette
tese , o di tre mila settecento due piedi ) ; il
Monte Etna in Sicilia, il Monte Ecla in Islan
da, &c. Vedete l'enumerazione che la Martiniere,
nel suo Dizionurio Geografico , ha fatto dei Vul
cani sparsi per tutta la terra. Ciò non ostante ,
siccome si trovano pietre pomici in abbondanza,
non solo sulle piagge delle Isole, ma ancora in
alto mare , si può dire ugualmente che vi sono
Vulcani marini, che escano veramente dagli sco
- gli
V U IL 63
gli, che altro probabilmente non sono che la cre
sta delle montagne esistenti nel letto del mare.
Quante volte non si sono veduti di questi Vul
cani vomitar dal seno rivi d'acqua bollente, pe
sci, conchiglie ed altri corpi marini? Nel 163 1,
nel tempo di una eruzione del Vesuvio, il mare
di Napoli rimase asciutto, e sembrò che fosse as
sorbito da quesso Vulcano , che poco dopo in
nondò d'acqua salsa le campagne . Del rimanen
te, se i prodotti dei Vulcani di mare sono simi
li a quelli dei Vulcani di terra , queste corrispon
denze debbono far presumere in favore dell'uni
tà delle cause e dei fenomeni di esse .
Le montagne che vomitano fuoco , o che sono
state altre volte in eruzione , sono più numero
se di quello che ordinariamente si crede , ( ne
sono a nostra notizia più di cinquecento). Spes
se volte sono esse appoggiate a congerie confu
se di rupi enormi , più o meno dure e di di
verse tinte , come spezzate, scheggiate, distrutte
ed assai irregolarmente ammontate le une sulle
altre : le cime di queste montagne sono aride ,
troncate e largamente strombate in crogiuolo o
in imbuto , o come smottate o dirupate : vi si ri
conoscono dappertutto visibilmente le traccie che
vi hanno lasciate le cataratte del fuoco e l' eru
zioni di diverse materie ; in una parola, vi si
- vede la pittura del disordine e della distruzione,
l'operazione dei fuochi più violenti e più attivi.
Più dunque non si ammira in questi luoghi la Na
tura semplice e primitiva, cioè, quell'uniformità
di strati che indicano una lenta operazione nel
tCI
64V U IL
tempo in cui furono formati ; ma è la Natura.
che patisce ed in uno stato di lutto; in conclu
sione sono questi gli avanzi di uno spettacolo
chimico , degno di esser osservato in tutto il
suo complesso . Si osserva parimente che vi è
un maggior numero di caverne nelle contrade
soggette ai Vulcani ed ai terremoti, che in qua
lunque altro luogo. Sembra ancora che l'immen
sa quantità delle Isole dell'Arcipelago, tutto il
terreno delle quali è cavernoso come quello del
monte Ararat, altro non sia che le cime di al
trettante montagne elevate dalla violenza deiVul
cani marini . Questa idea di cui abbiamo già
detto qualche cosa più sopra, diverrà anche più
probabile per le particolarità che si troveranno
verso il fine dell'articolo presente . Esponiamo
adesso gli effetti dell'eruzione di un Vulcano.
Ogni espolsione agisce nella sfera di sua atti
vità, e ilfuoco che n'è la causa efficiente, sfug
ge quasi sempre da quella parte nella quale è
minore la resistenza: imprime alla produzione che
esce dal Vulcano tutta la celerità di cui è suscet
tibile, nel suo primo sforzo . Riferisce il Sig. di
Buffon che quando il Vesuvio comincia a mug
gire e a scagliare le materie dalle quali è arso,
la prima scarica che fa ha minor velocità della
seconda, questa meno della terza , e così in
progresso : le onde pesanti di bitume, di zol
fo, di ceneri, di metallo fuso, di lave, sembra
no , dice egli , nuvole massiccie; e benchè si
succedano sempre nella medesima direzione, non
lasciano perciò di cangiar molto quella della prima- (31 ll- "
V U IL65
/
eruzione e di spingerla altrove, e più lungi di
quello che non avrebbe fatto da per se sola.
Un Vulcano , nel tempo di una violenta eru
zione ( dice il Sig. Faujas di Saint-Fond , Gior
nale di Fisica , Maggio 178o ) , scaglia inces
santemente lave più o meno compatte , che ele
vandosi verticalmente e ricadendo nel focolare
ardente , vi si calcinano nuovamente ; ne sono
rispinte fuori , vi ritornano , provano alternati
vamente l'azione del fuoco e dell'aria, scoppia
no , si urtano, si confricano, si dividono, si ri
ducono in sabbione, in rena, e formano in certe
circostanze, ammontamenti, monticelli che em
piono il cratère, : il fuoco che si trovaconcen
trato, diventa per questo appunto più formidabi
le; e togliendosi con fracasso l'impaccio di que
sti mucchj di rovine , li fa volare in aria e pro
duce quelle grandini di sassi , quelle pioggie di
sabbione, di rapillo , di rena, che sembravano
una volta così maravigliose. In altre circostanze,
abbandonando il Vulcano il suo cratére ordina
rio, rivolge il furore verso altre parti; ma tro
vando nelle antiche lave , puna troppo forte resi
stenza, vengono a rinforzarlo , in qualità di au
siliarj, i fumi acidi , sulfurei ricalcati sopra se
stessi, l'azione caustica dei quali attacca, mina,
ammolisce le lave più dure, ne distrugge il glu
tine , e le converte in una specie d' ocra o di
calce basaltica , più o meno colorita, a propor
zione dei diversi gradi di alterazione che ha su
bìto. Scuotendo allora il Vulcano la montagna ,
ne rompe gli ostacoli, scoppia l'esplosione, sca
Bom,T.XXXIX. glia
66 V U L
glia lungi nuvole di fumo, miste con una sostan
za.pulverulenta che oscura talvolta la luce del
giorno, e che trasportano i venti a rimote di
stanze . Tale è la teoria , ( secondo il Sig. di
Faujas) di quelle pioggie di polvere fina di color
di mattone o di tabacco di Spagna , che potreb
bero anche essere di color bianco, se le lave su
bissero la medesima alterazione che alla solfata
ja . Finalmente è stata veduta talvolta l'azione
sostenuta di fuochi sotterranei cangiar la lava in
fritta della natura dello smalto, in pietra galli
nacea, dividerla in seguito in polvere e sparge
re in aria una polvere di vetro, o convertir que
sta lava denaturata in filamenti giallastri, flessibi
li è rilucenti, simili a quelli che il Vulcano dell'
Isola Borbone produsse nel 1766 che furono tra
sportati alla distanza di sei leghe dal cratère in
un sito chiamato, lo stagno salso ove ne rimase
intieramente coperto il terreno .-
Può accadere che i fuochi, che si accendono
nelle viscere della terra e che non sempre si mo
strano fuori, siano soffocati appena nati, per
mancanza di sfiatatoi pei quali possa uscire il fu
mo; e sarebbe forse da desiderarsi che vi fosse alla
superficie del nostro globo un maggior numero
di Vulcani . Per mancanza di simili sfiatatoj , lei
caverne piene di una esalazione densissima , pe
gliano fuoco improvvisamente, si dilatano, e lè
scosse sotterranee non cessano di agire finchè
abbiano sollevati ed anche sovvertiti tutti gli strati
che le coprono. Consumata in seguito la materia
dell'esalazione, ciò che si trova sollevato nella di
lata-
V U L 67
latazione , ricade spesse volte pel proprio peso .
Sarebbe ugualmente da desiderarsi , che le boc
che dei Vulcani o i cratéri fossero al coperto
dalla pioggia , perchè si sono veduti Vulcani i
quali, dopo aver perlungo tempo cessato di get
tar fuoco , hanno ricominciato a far esplosioni
terribili, cagionate da nuove acque chevi erano
cadute (a). Questa è forse la ragione per cui la
montagna Fesi al Giappone, che una volta vo
(a) Il Sig. Grignon ,
Cavaliere dell'Ordine del
Re , è di opinione che
torrenti di lave in fusio
ne si precipitino dalle boc
che dei Vulcani in laghi,
fiumi e nel mare, senza
sollevarne le acque, nè
cagionar tuono sotterra
neo, perchègli ammassi
di acqua che ricevono
queste lavc sono superiori
in quantità a quelli del
calore ; ma non accade
lo stesso, dice egli, quan
do l'azione del fuoco di
un Vulcano aspira per ca
nali sotterranei, l'acqua
di alcuni ammassi vicini :
quest'acqua è rarefatta in
parte dal calore sotto una
E 2 mi
massa enorme di materia
in fsione pastosa , che
resiste dapprincipio alla
pressione; ma quando lo
sforzo è divenuto superio
re alla resistenza, allora
si fa un' esplosione che
porta masse prodigiose di
materie confuse a distan
ze infinite , e cagiona
nell' interno delle catene
dei monti,commozioni che
si propagano in una parte
del globo.Si deve confes
sare che nulla èparago
nabile all'effetto dei va
pori aquei in espansione,
se alcuni ostacoli si oppon
gano alla dilatazione di
essi; noi abbiamo sempre
detto, trattando dei Vul
(l
68V U L .
mitava fuoco, ha cessato di gettarlo dappoichè
si è formata un'apertura sul. fianco più declive da
questa montagna. Del rimanente , la maggior
parte dei paesi nei quali sono Vulcani, non la
scia di provar terremoti , come avanti alle pri
me eruzioni dei Vulcani medesimi .
Nel tempo di Seneca, l'isola di Thera nell'Ar
cipelago, che ha dodici leghe di Francia di cir
cuito, si è sollevata dal fondo del mare, alla vi
sta dei Marinaj, per la violenza di un Vulcano,
che ha poi prodotto altre sei isole nel suo gol
fo. Questo Vulcano che, secondo Plinio, spin
se fuori dal Mare l' isola di Therasia, duecento
trentatrè anni prima di Gesù Cristo, non è an
cora estinto ; perehè nel 17o7, ai 23 di Maggio ,
al nascer del sole , si riaccese con più furia che
mai, e diede a una lega di distanza lo spettacolo
in mare di una nuova isola di sei miglia di cir
cuito . Vi andarono alcuni Curiosi e trovarono
che questo scoglio cresceva loro sotto i piedi ;
ne riportarono pietra pomice ed ostriche che lo
scoglio il quale si era elevato dal fondo del ma
re , teneva ancora attaccate alla superficie . Due
giorni prima che nascesse questo scoglio, vi era
stato un piccolo terremoto. Ai sedici del Luglio
-
Se
---
- -
cani , nelle nostre lezio- piacere abbracciata questa
ni, che sembra, che gli idea da molti Fisici e par
effetti dei Vulcani abbiano ticolarmente dal Sig. C. D.
connessioni evidentissime L. Consultate il Giornale
con quelli della tromba di Fisica ,Agosto 1785.
da fuoco , e vediamo con
V U L. 69
seguente, uscirono con un fracasso spaventevole
molti scogli ardenti dal fondo del mare, che era
allora caldo, agitatissimo , torbido e coperto di
fiamme in questo luogo , e si unirono all' isola
galleggiante . Questo fenomeno fu accompagnato
per due mesi da vapori puzzolentissimi, dafiam
me continue , da un rumore spaventevole, e da
nuove esplosioni che vomitarono scogli neri e
sassi a più di sette miglia di distanza . In una
parola , tutta la terra è stata così capovolta nel
le spiaggie dell' isola di Thera , che non vi si
trova più fondo per l'ancoraggio dei vascelli .
Rodi, Delo, Hiera o Vulcanella , sono isole
prodotte dalla medesima causa. Il Vulcano di San
torino, non ha quasi mai cessato di essere in eru
zione fino ai 14 di Settembre del 1711 . Quest'isola
fa parte di quella che si chiama presentemente
Santorino o Sant' Erini, perchè Santa Irene n'è
la Protettrice . Queste contrade abbondano di la
ve submarine .
Tra i 1o e i. 19 di Ottobre 172o, fu veduta
formarsi vicino all'isola di Terzèra un'isola nuo
va che non esibiva alla vista altro che fuoco e
fumo ; il mare intorno era coperto di ceneri e
di pomici , e si sentivano successivamente esplo
sioni simili al rumore del tuono . La notte dei
7 agli 8 Decembre seguente , vi fu un nuovo
terremoto tra le Azore, e sembrò che il mare
bollisse per lo spazio di due terzi di lega. Il
piloto del Sig. di Montagnac, Console a Lisbo
na, gettò un sasso in mare , ed osservò che l'ac.
qua immediatamente zampillò ; il fondo, benchè-
E 3 a quin
7o V U L
a quindici braccia, era così caldo, che liquefece
due voltc di seguito il sego che era all'estremi
tà del piombo dello scandaglio ; dopo quest'epo
ca, l'isola è molto cresciuta, ed è in seguito di
minuita . Fu inoltre osservato che la cima del
Vulcano del Pico di S. Giorgio, nell'isola di Pi
co, si abbassò quando si elevò la nuova isola
delle Azore, altra prova della comunicazione sub
marina di questi due Vulcani ; e siccome vi so
no esempi alle Azore e nell'Arcipelago che il
Vulcano ha cacciato eruzioni da una profondità
incommensurabile del mare, risulta da ciò, al di- .
re del Sig. Forster, che le cime delle più alte
montagne non sono sempre e sole la sede dei
fuochi vulcanici . Il Vulcano di Tanna, nelle
Nuove Ebridi, è sul lato Sud-Est di una catena
di colline, dominata da alte montagnè, alcune del
le quali hanno una elevazione che è per lo me
no doppia di quella in cui risiede il Vulcano.
Il Monte Vesuvio, la cima del quale era una
volta elevata sopra il golfo seicento cinquanta
tese, e nel quale la profondità della voragine in
cui bolle la materia, può essere attualmente di
cinquecento quarantatrè piedi , vomita fiamme da
più di due mil'anni, come lo provano i fonda
menti di molti edifizj dell'antica e sventurata cit
tà d' Ercolano , nuovamente scoperta appiè del
Vesuvio, che sono, per quello che si dice , di
una lava pura, simile al rimanente della famosa
via Appia, il Monte Vesuvio, io diceva , non
esenta dai terremoti il rimanente delle coste ma
rittime dell' Italia .
Sem
V U L 7 i
N Sembra che alcuni Vulcani estinti facciano fede
che il nostro globo è stato devastato fin dalle
prime età. Si naviga , diceva Seneca , sopra le
città che i nostri Antenati hanno veduto .. . . .
Quanti non sono mai stati i popoli sepolti da que
ste orribili convulsioni della Natura; qual fonda
mento non abbiam noi di dire, con un'antico Au
tore, che camminiamo sulla testa dei cadaveri
delle città ! Il Filosofo testè citato (Seneca ) ri
ferisce che sotto il Consolato di Regolo e Vir
ginio, il giorno delle None di Febbrajo , da
ta che concorre coll' anno 63 dell' Era Cristia
na , vi fu un terremoto violento che si fece sen
tire nelle vicinanze del Vesuvio: Pompeja, cele
bre città, fu inghiottita nel seno della terra;
Erculèa fu in parte distrutta e Nocera soffrì mol
to, siccome ancora tutta la Campania. Sedici an
ni dopo, cioè l'anno 79 della nostra Era, ai 24
d'Agosto a 7 ore della mattina , nn nuovo in
cendio del Vesnvio, che era stato preceduto nel
la notte da terremoti, fu accompagnato da quel
la violenta eruzione, divenuta così celebre per
la morte di Plinio il vecchio . Questo martire
illustre della Scienza era allora al Capo Miseno,
in qualità di Comandante della flotta dei Roma
ni : spettatore di un fenomeno inaudito e terri
bile, andò aStabbia, si accostò alla riva di Erco
lano per osservar più da vicino il fenomeno,
e , indubitatamente, perporger soccorso allevit
time di questi convulsivi sforzi della Natura ; ri
mase, per quello che si dice, soffogato dal fumo
che esalava dalla voragine ; le fiamme, i vapori,
E 4 le
72 V U L
=
le ceneri , le lave distrussero indistintamente,
anche in lontananza , gli uomini , i bestiami, i
pesci e gli uccelli . Così esiste uno spaventevo
le monumento delle rapide devastazioni che pos
sono cagionare le innondazioni infuocate, nella
città di Eracléa ( Ercolano, Erculèa ), che è sta
ta ritrovata in quest'ultimi tempi, e che rima
se intieramente sepolta sotto più di sessanta pie
di di una lava fangosa e di una specie di cene
re, una parte della quale fu gettata sì a Roma
che in Egitto .-
/ Dice il Signor di Buffon esser probabile che
la città di Napoli sia situata sopra un terreno
vuoto e pieno di minerali ardenti; poichè ilVe
suvio e la solfatara (tra i quali si trova Napo
li quasi ad ugual distanza) sembra che comuni
chino all'interno; perchè, quando arde il Vesu
vio , la solfatara manda fiamme , e quando ces
sa il Vesuvio, cessa anche la solfatara (a) . Se
debba giudicarsi in coerenza dei fenomeni che si
osservano nel tempo stesso nei mari Tirreno ed
Egèo, vi è ragione di sospettare che posino l'uno
e l'altro sopra fuochi sotterranei . Questi feno
(
(a) Il Signor Giovanni cui si elevò il liquore
Hovvard salendo la mon- del termometro , fu il
tagna del Vesuvio, affon- 1 14; avendo osservato
dò nel terreno la palla lo strumento di due o di
di un termometro di Fa- tre in tre minuti, finchè
reneit ; il primogrado a giunse alla cima del cra
tea
V U L73
meni dureranno quanto durerà la causa che li
produce, e cesseranno nella stessa contrada subito
che questa causa medesima sarà esaurita, o pren
derà un'altra strada . Così il ritorno degl'incen
dj dei Vulcani non estinti, non ha alcun perio
do fisso .
Dall'Era Cristiana fino al 1694, sono acca
dute ventuna eruzioni memorabili del MonteVe
suvio. Nella seconda e quarta di queste eruzio
ni , ne furono spinte le ceneri fino a Costanti
nopoli . Sividdero, nel 1631 , scorrere da questa
montagna ignivoma fiumi di fuoco ; furono ro
vesciati dai terremoti molti villaggi, e vi peri
rono più di trentamila persone, al riferire di
Teodoro Valle , testimonio oculare.
Una delle più violente eruzioni del Vesuvio
(era la vigesima seconda di questo Vulcano) è
stata quella dei 1o di Maggio t737; vomitava
il monte da molte bocche grossi torrenti di ma
terie metalliche, fuse e ardenti, che si spargeva
no nella campagna e andavano a gettarsi nel ma
re , Il Sig. di Montallegro che comunicò questa
relazione all'Accademia delle Scienze di Parigi,
OS-
tere, trovò allora ehe co ai seguenti di Rèau
il liquore si era succes- mur, 55 , 64,71 ,88,
sivamente elevato a 122, a più di 1 1 o); all'in
137, 147, 164, e 172 gresso della voragine, il
gradi.(9uesti gradi cor. liquore segnò24o gradi -
rispondono appresso a po
74 .V U L
osservò, con orrore, uno di questi fiumi di fuo
co, e vide che aveva un corso di sei , o sette
miglia dalla sua sorgente al mare; una larghez
za di cinquanta o sessanta passi ; una profondi
tà di venticinque o trenta palmi ed in certi fon
di o valli, di cento venti . La materia che por
tava era simile alla schiuma che esce da una for
nace di fucina; si volle, più di un mese dopo
questa grande eruzione, sgombrare la strada mae
stra, innondata dalla lava; ma i lavoratori furo
no ben presto costretti ad abbandonar l' impre
sa, perchè trovarono che l'interno della lava era
ancora così infuocato , che arroventava ed am
molliva gli stromenti di ferro dei quali si servi
vano pel lavoro .
-
L' eruzione che accadde ai 16 di Novembre
1767, è stata parimente una delle più violente
delle quali si sia conservata la memoria: si ele
vò dalla montagna un fumo densissimo in colon
na verticale , e coprì tutto l'orizonte di una piog
gia di ceneri; e si sentirono poco dopo scosse
violentissime: ai 2o dello stesso mese, un torren
te di lava che si sentiva muggire e che aveva
sette miglia di lunghezza e due di larghezza,
esibì un corso di un miglio per ora, e riempì
un vallone di sessanta tese di profondità.
Verso l'autunno del 1778, il Vesuvio rigettò
molti frammenti di grossi prismi di basalto re
golarmente cristallizzati. Nel Maggio 1779, que
sto Vulcano vomitò lava per lo spazio di dieci
giorni; e il fuoco si manifestò nel cratère supe
riore . Il Sig. Cavaliere Hamilton, Inviato stra
Or
V U IL 75
ordinario d'Inghilterra alla Corte di Napoli, pas
sò una notte sulla montagna, per osservar l'an
damento e le operazioni della lava che usciva
da canali aperti nei dirupi del monte; ed ebbe
per ciò bisogno di perseveranza ed anche di un
certo grado di coraggio: la lava liquida, arden
te, rossa , bollente, e che faceva un rumore simi
le al fischio e agli scoppj di un fuoco artificiale,
scagliava continuamente getti di materie vetrifica
te ed in fusione : dopo avere abbandonato i suoi
canali regolari, si sparse nella città, ove scor
reva lentamente, carica di scorie e simile a un
fiume che porta seco ghiaccioni , e questo fiume
di lava aveva appresso a poco cinquanta o ses
santa piedi di larghezza. Il Signor Hamilton ed
una persona che lo accompagnava, erano vici
nissimi alle sponde del torrente , ed essendosi
improvvisamente mutato il vento, rimasero tal
mente molestati dal caldo e dal fumo sulfureo
che ne esalava, che sarebbero stati costretti a
ritornarsene addietro , senza veder nulla di più ,
se la loro guida ( Bartolomeo , chiamato per so
prannome il Ciclope del Vesuvio) non avesse
loro proposto l' espediente di passare dall'altra
parte, cioè di valicare a piedi la corrente di la
va, al quale infatti si appigliarono; è ben da
credersi che soffrissero ai piedi e alle gambe un
calore vivissimo : la crosta della lava era così
spessa o grossa , e carica di tante ceneri e sco
rie, che il peso del corpo di tre persone non vi
fece la minima impressione. Quindi in un caso
di necessità, come quello in cui si avesse la di
sgra
76 V U IL
sgrazia di trovarsi tra due correnti di una lava
simile , si può tentar questo mezzo per salvarsi.
Il Vesuvio continuò le sue devastazioni nei
mesi di luglio ed agosto seguenti. I sintomi or
dinari di una prossima eruzione , come i rumo
ri sordi (le rombe ) e le esplosioni nelle visce
re del Vulcano, una quantità grande di fumo
che usciva con forza dal suo cratère, ed accom
pagnata di tanto in tanto da getti di scorie e da
ceneri arroventate ed ardenti, si manifestarono
per tutto il mese di luglio , e crebbero verso il
fine di questo mese a segno di metter sotto gli
occhj nell'oscurità della notte, il più bel fuoco
artifiziale che possa immaginarsi . Queste mate
rie vulcaniche che compariscono allora così lu-
minose e così brillanti, si mostrano alla piena
luce del giorno , come altrettante macchie nere
in un fumo bianco .
Ai 3 d'agosto, due ore prima di notte , fu
veduto il fianco del Vulcano coperto di quattro
o cinque rivi di lave che scaturivano da certe
piccole aperture, fatte ai due terzi dell'altezza
della montagna ; ed erasi allora fatto sentire un
gran fracasso interno simile alle cannonate ri
petute .
Ai 4, uscì la lava in così grande abbondanza
dal cratère , che si unì a quella che usciva dal
fianco e ne turò l'apertura.
Ai 5 , verso due ore dopo mezzo giorno, il
Vulcano era in una violentissima agitazione; ne
usciva continuamente e con impeto il fumo dal
cratère, e l'aggregazione dei globi successivamen
te
V U L 77
te gettati, che gli uni agli altri rapidamente si
univano, formava nuvole simili alle balle del
cotone più bianco. Se ne radunò ben presto un
volume così grande sulla cima del Vulcano, che
questa nuvola divenne in grossezza e in altezza
più del quadruplo della montagna medesima:ve
niva scagliata in mezzo a questo fumobianco, ad
un'altezza sorprendente, una quantità immensa
di pietre, di scorie e di ceneri . Al fine del
giorno, la montagna comparve tutta infiamma
ta, ma senza fumo ; partiva dal cratère e si ele
vava in linea perpendicolare e ad una straordi
naria altezza, una fontana di fuoco simile a quel
le dei fuochi artifiziali ; si sollevava tanto una
lava liquida sopra l'orlo del cratère, da poterlo
passare e precipitarsi quindi impetuosamente e
come un fiume di fuoco, pel dirupamento del
Vesuvio, che guarda la montagna di Somma; il
vapore infuocato che usciva da questo torrente,
rifletteva sulle montagne, sulle campagne dei luo
ghi circonvicini, e formava una delle pitture più
luminose . Nel tempo di questa eruzione , cadde
a Somma e ad Ottajano, una densissima pioggia
di minute ceneri ancora infuocate, con lunghi
filgmenti di materia vetrificata, simile ai fili del
vetro artificiale .
Ai 6 di agosto, la fermentazione della mon
tagna fu meno viva; ma verso mezzo giorno, si
fece sentire un gran rumore, e fu supposto che
in questo momento fosse caduta la piccola mon
tagna che era nell'interno del cratère .
Ai 7, verso mezza notte , crebbe molto la for
InnC'Il
78 V U L
mentazione, ed a questo momento si può fissar
l'epoca del secondo accesso; scorse di nuovo la
lava, ed avanzandosi una grossa nuvola sulla
montagna , fece l' effetto della spranga di ferro
che si accosta al tubo elettrizzato; coprì la mon
tagna di fiocchetti e di lampi solcanti o serpeg
gianti in linee rette; la lava faceva riflettere dal
la parte inferiore della nuvola un color rosso
oscuro, e il getto di fuoco della cima tingeva
le nuvole superiori di color di sangue, il che
cominciava a spaventare gli abitanti di Napoli:
questi effetti pittoreschi sono superiori a qualun
que descrizione .
. La giornata degli8 sarà sempre celebre : dalla
mattina il fuoco del cratère indicava una gran
fermentazione interiore , ed il mare di queste
spiaggie fu agitatissimo ; sul far della notte, la
bocca del Vulcano scagliò grosse pietre infuocate
che ruzzolavano dalla cima fino al fondo della
montagna : a un'ora e mezza di notte, il mare
si calmò; ricomparve e divenne così considera
bile il getto di fiamme che usciva dalla cima ,
che al lume di esso, si distinguevano chiaramen
te gli oggetti minuti alla distanza di sei miglia ;
si facevano sentire i muggiti ; si distese ben pre
sto in aria unfumo nero come un velo lugubre,
succedette il fuoco, si spaccò la montagna , la
bocca divenne immensa , e si elevò da essa una
colonna di materia liquida in forma di fumo , di
un fetore insopportabile e di pietre infuocate : le
fiamme che vi si unirono formarono ben presto
un nuovo getto di fuoco, che fu stimato appres
SO
V U L79
so a poco di diciotto mila piedi di elevazioue
sopra il livello del mare; in un momento, altro
più non sembrò la montagna che un globo in
fiammato di due miglia e mezzo di diametro,
fulmini simili alloscherzo dei razzi volanti, ta
gliavano per tutte le direzioni e con molta viva
cità il getto di fuoco e la colonna di fumo ; ve.
nivano scagliati in aria sassi grossi come botti,
e tardavano venticinque secondi a ricadere nella
Valle di Somma che ne sembrava tutta riempita,
e le prunaje e i boschi circonvicini ( d' Ottaja
no ) improvvisamente s' infiammarono . Questo
incendio , il calore del quale si fece sentire alla
distanza di sei miglia in giro , sparse la coster
nazione e lo spavento, facendo conoscere il pe
ricolo di un fenomeno , di cui andava sempre
crescendo l'effetto : piovevano, fino alla distanza
di un miglio e mezzo, il fuoco e l'acqua bollente
(così si chiama la pioggia che cade dal cielo nel
tempo del fumo e della caduta delle ceneri) , Il
popolaccio di Napoli, scapigliato e tremante, si
abbandonò a tutto lo spavento di cui è suscetti
bile, ed altro più da tutte le parti non si senti
va che grida e che gemiti; la strada di Portici
era tutta piena di abitanti vicini che fuggivano,
portandosi dietro i figli e quanto avevano di più
prezioso. La luce dell'immenso getto era così
viva e così forte, che si poteva leggere a Napo
li qualunque sorte di caratteri ; ed il Sig. Mor
ris, Gentiluomo Inglese, stando a Sorrento, che
è dodici miglia lontana dal Vesuvio , lesse il fron
tispizio di un libro al solo lume diquesta
luce vnl
C
N
8e V U L
--
canica. Dopo che la colonna di fuoco ebbe sus
sistito nella sua gran forza per lo spazio di qua
si mezz'ora e trentacinque minuti dopo l'eruzio
ne, il Vesuvio restò cupo ed in silenzio; lasciò
veder la montagna che si credeva inghiottita o dis
sipata in aria; aveva essa appresso a poco la
medesima forma che innanzi , e rimase coperta
di fuoco per una parte della notte. Questo lu
minoso, vario, maestoso e sempre stupendo spet
tacolo, era stato così straordinario, così sorpren
dente, così sublime, che quando ebbe cessato,
sembrava un sogno a quelli che n'erano stati te
stimonj .
Il giorno seguente 9, si sentirono i guasti ca
gionati nell'antecedente ; Ottajano era stato schiac
ciato e per metà bruciato. Una pianura , ove il
Re aveva fatto costruire un padiglione per far al
to alla caccia, era divenuto un mucchio di pie
tre e di ceneri ; la terra era seminata dei cada
veri degli animali e degli uomini; e secondo la
direzione del vento, le pietre, il rapillo e le ce
neri erano stati trasportati alla distanza di cin
quanta miglia, e ne furono mandate da Grotta
Minardo e da Monte Fusco, del peso di dueCICIG ,
Dicono gli abitanti di Ottajano di aver osser
vato nella pioggia di fuoco da cui furono assali
ti, pietre che avevano dai quattro fino ai sette
piedi di diametro . Ai 9 , a mezzo giorno, rico
minciarono il fracasso delle esplosioni sotterranee,
e l'eruzione quasi con ugual forza e vivacità, e
con un poco d'intermittenza. Agli 11 , i medeSl
V U L 8
simi effetti che ai 9, e la medesima sensazione.
Soffiando sempre il vento a levante , impedì ogni
giorno che la cenere e i sassi non andassero a
portare lo spavento a Napoli. Ai 12 la matti
na, la montagna fece uno strepito grande e ne
furono terribili le scosse . Ai 13 , la sera , si
scorse nelle nuvole che si aggiravano sulla cima
del Vulcano, il riverbero del fuoco interno del
cratère . Ai 14, esalava dalla montagna un fu
mo nero abbondante . Tale è la fedele relazione
di questa spaventevole e terribile esplosione o
eruzione delVesuvio , nel 1779. Consultate ades
so la Storia dell'Accademia, anno 1737, pag. 7
e 8; le Relazioni dell'eruzione del Vesuvio, 1779
dei Signori Duca di Belforte, Duchanoy e Ca
valier Hamilton , Giornale di Fisica, Tom. XV e
XVI, 178o , e Tem.XVII, 1781 . Consultate an
cora la Storia del Monte Vesuvio, e l'esposizione
dei suoi fenomeni , del P. della Torre, Religioso
Somasco, e la Descrizione di questo Monte, del
Sig.Marchese d'Orbessan.
Non si sà quanto tempo sia che arde l' Etna :
ciò non ostante l' eruzioni di questa voragine
prodigiosa sono violentissime, e così abbondan
ti le materie che getta, che vi si può scavare
fino a settantotto piedi di profondità : le inter
missioni sono più o meno lunghe . Si veggono
le fiamme e il fumo di questo Vulcano fino a
Malta, che n' è sessanta leghe lontana. Si vuole
che si siano trovati sassi scagliati da esso fino
alla distanza di sessantamila passi, e ceneri por
tate dal vento fino a più di cento leghe, e che
Bom.TXXXIX, nel
8 V U L
nel 1683 ( 1669 secondo alcuni) accadde un ter
remoto in Sicilia , a cui succedette una violenta
eruzione di questo Vulcano, che distrusse intie
ramente la città di Catania, e fece perire più
di sessanta mila abitanti in questa sola città,
senza contar quelli che perirono nelle altre cit
tà e villaggi vicini . I fasti della Sicilia moderna
hanno principalmente perpetuata la memoria del
le devastazioni cagionate da questo terribile Vul
cano, negli anni 1537, 1554, 1556, 1579, 1669,
1693, 1753 , 1755, 1757, 1766; Vedete all'ar
ticolo Terremoto , ciò che abbiamo detto del disa
stro quasi generale accaduto a Messina e nella
Calabria Ulteriore, per l'azione di questo Vulca
no, nel 1783 .
Tutta la Grecia, nel 1667 soffrì commozioni
grandi, e nell'istante medesimo, Ragusi, città
di Dalmazia, quasi intieramente si sprofondò , per
l'effetto di questa scossa e del fuoco . Così le
viscere della terra , che sono i soli archivi che
possano da noi consultarsi, conservano appena
gli avanzi delle Città dell'Antico Mondo . Co
me mai dunque avrebbero potuto conservarsi i
nomi di quelli che le hanno abitate, essendo
comparsi un momento solo essi medesimi sulla
superficie della terra che gli ha ingoiati !
Il Monte Ecla in Islanda, che parimente da
tempo immemorabile getta fuoco, vomita le sue
fiamme attraverso ai ghiacci e alle nevi di una
terra congelata, e ne sono così violente l'eru
zioni come quelle dell'Etna e degli altri Vulca
ni dei paesi Meridionali, Scaglia talvolta oltre le
Ce
V U L 83
ceneri e le pomici, un diluvio di acqua bollen
te : non si può abitare a sei leghe di distanza
da questo Vulcano; l'acqua che n'esce è densa,
di color di fuligine ed insipida. La più terribi
le eruzione di questa voragine di fuoco, fu quel
la del 1726, che cessò solamente nel 173o .
La materia fusa che scorreva da questo Vulca
no , si estese più di tre miglia lungi dalla mon
tagna, e non solo circondò le abitazioni e la
Chiesa che era sopra un'eminenza, ma riempì
inoltre il letto del lago vicino. Non è caso ra
ro che si provi intorno a questo Vulcano ed
agli altri, una pioggia fresca: sembra in fatti che
i vapori dei Vulcani ascendano ad un'altezza as
sai considerabile, che attraggano verso l'asse del
Vulcano le nuvole e ne cagionino la secrezione
in pioggie, più o meno abbondanti che formano
ben presto diluvj ed innondazioni .
Secondo il Sig. Horrebow, le diverse eruzio
ni del Monte Ecla, dacchè l' Islanda è abitata ,
sono accadute nel 1 1o4, 1 157, 1222 , 13oo,
1341, 1362, 1389, 1158, 636, 1693, ( quest'
ultima eruzione cominciò ai 13 di febbrajo e
continuò fin verso gli ultimi giorni del mese di
agosto seguente ). Quella del 1726 fu di una
assai più lunga durata. ll terreno intorno alla
cima di questo Vulcano, brucia le scarpe ; e
l'acqua di alcune fontane che vi s' incontrano,
bolle continuamente a grossi bollori , talvolta
schizza in aria come un getto , a guisa delle
fontane orarie. Vedete all'articolo Fonti. Dac
chè l' Ecla ha cessato di gettar fiamme, altre
F 2 nQIl
84 V U L
--------
montagne dell'Islanda hanno avuto eruzioni ugual
mente forti; tali sono i Monti di Aecraise , di
Krafle, di Portlantsboukht, di Westerioekel e di
Kotlegau. Simili eruzioni, ripetute nel medesimo
luogo, accrescono lo stupore. Sembra che l'Islan
da altro non sia che un Vulcano coperto delle
proprie lave ; sempre arde , sempre innonda; la
cima del Monte Ecla è ordinariamente coperta
di nevi e di ghiacci. E' stato osservato che que
sto .monte ha manifestato ventitrè forti incendi
in settecento cinquantatrè anni; il Vesuvio, tren
ta, in mille seicento novantanove anni; e l'Etna,
diciotto, in mille novecento cinquant'anni.
Vi sono molte montagne principali che ardo
no al Kamtschatka , e che gettano continuamen
te fumo ed interpolatamente fuoco . Vi accado
no di tanto in tanto eruzioni violente che co
prono di ceneri le campagne vicine, e sono tal
volta accompagnate da terremoti . Il Vulcano
chiamato Apalikaja - Sopka si vede da una di
stanza grandissima in mare, ed esibisce nel giro
e nella cima, una quantità grande di ossa di ba
lena ; vi si trovano parimente parti vitree, delle
quali i Kamtscadali armano le loro freccie. L'eru
zione più terribile che si riferisca, è quella del
Vulcano chiamato . Kamtschatka- Goraela-Sopka,
nel 1737. Arse la montagna per un'intiera set
timana, ed era simile ad una rupe infuocata;
uscivano con violenza le fiamme per diverse
aperture, dalle quali si precipitavano con uno
spaventevole fracasso, torrenti di materie ardenti
e fetide, e si sentivano nel seno della montagna
esplo
V U L 85
esplosioni frequenti e terribili, simili agli scro
sci o agli scoppi del fulmine : le acque del ma
re erano visibilmente agitate ; uscirono dai natu
rali confini, innondarono il paese e si ritiraro
no alternativamente a perdita di vista, lasciando
a secco la riva; alcuni prati furono cangiati in
colline, ed alcuni campi in laghi e in baje . Que
sto Vulcano è forse la sola montagna che sia
impossibile a salirsi, a cagione delle congerie di
materie pulverulente e mobili , miste di fram
menti di lave difformi, o bernoccolute o taglien
ti, che coprono le groppe inaccessibili è più
scoscese .. . A questi Vulcani debbono indubitata
mente attribuirsi tutte le sorgenti calde del pae
se; una bollente n'esce dal fiume di Cssernaia,
verso la metà del suo corso . I Kamtscadali ,
quasi tutti superstiziosi, riguardano parimente i
Vulcani e i luoghi nei quali si trovano le acque
calde, come l'abitazione degli spiriti maligni.
Le eruzioni sono spesse volte per essi un segna
le di rivolta .-
OttoVulcani, sparsi sulle diverse contrade del
Giappone hanno sconvolto la superficie della ter
ra di questo Impero. Ma il più famoso vulcho
dell'Asia è il monte Albours, vicino al monte
Tauro , a diciotto leghe da Herat : fuma esso
continuamente, e getta spesse volte fiamme ed
un'estrema abbondanza di ceneri e di lave . Nel
1693 , l'isola di Sorca, una delle Molucche, cra
ancora popolatissima ; ma l'alta montagna che si
vedeva in mezzo a quest' isola, era un Vulcano
che vomitava bitume e materie infiammate in quan.
F 3 ti
86v U L
tità così grande, che si formò un lago ardente,
il quale si estese a poco a poco , e subissò
finalmente l' isola intiera e la fece sparire .
Uno dei più terribili Vulcani delle isole dell'
Oceano Indiano e nel tempo stesso uno dei più
nuovi, è quello di Panarucan nell' isola di Giava .
Nel 1722 , agli 11 del mese di Agosto , un
Vulcano produsse devastazioni spaventevoli nella
provincia di Cheribù e di Palimban. Questa pro
vincia, la capitale della quale è situata alla di
stanza di quaranta leghe incirca all' E . da Batavia,
sulla costa settentrionale di Giava, è una delle
più preziose possessioni della Campagna Olande
se in quest'isola . Era abbondante la predetta
contrada di riso, caffè, zucchero, indaco, coto
ne , areca, prima del disastro che vi ha, non
sono molti anni, portata la desolazione. Si vid
de a mezza notte una nuvola trasparente che copri
va tutta la montagna ; si sentirono nel tempo stesso
rimbombi simili allo scoppio di replicate canno
nate: gli abitanti spaventati cercavano la salvez
za nella fuga, quando si sprofondò loro sotto i
piedi una parte della montagna, di tre leghe in
circa di circonferenza , e gl'ingojò . Affondandosi
e risollevandosi alternativamente questo masso
enorme, come le onde di un mare agitato, lasciò
sfuggire una quantità prodigiosa di globi di fuo
co, che si vedevano da una grandissima distan
za, e che diffondevano una luce viva come quel
la del giorno. Rimasero inghiottite tutte le pian
tagioni, con trentanove abitazioni di Negri ; e vi
perderono la vita più di due mila abitanti, sen
Z2
V U L 87
za contar gli stranieri. Vi sono ugualmente pe
riti, in una immensa quantità, animali cornuti,
cavalli ed altri animali .
-
IlVulcano che si è elevato alle Manille in mez
zo a un lago, nel 1754, dopo un terremoto di
tre mesi, è quasi ugualmente recente, e talvol
ta ugualmente terribile. Quello del monte di
Gonapi nell' isola Gumanapi o Gounong-Api
( chiamato dai Francesi la Granata di Banda) vi
cino a quella di Banda, non è gran fatto meno
terribile ; l'eruzioni di esso sono spesse volte
accompagnate da innondazioni le quali sembra
che debbano inghiottire la maggior parte delle
isole vicine. -
Gli abitanti delle Isole di Banda hanno ulti
mamente provato un nuovo esempio del disastro
accaduto in questa contrada dell'Arcipelago Asia
tico, al Sud delle Isole Molucche, contrada in cui
nascono gli alberi delle noci moscate. Si distaccò
una sera dalVulcano o montagna ardente di Gona
pi, un masso di pietre infuocate,e cadde sul magaz
zino degli equipaggi; spaccò pel mezzo un trave
di sedici pollici con un cordaggio di diciotto
pollici di grossezza. Il calor grande che i pezzi
di questa pietra avevano conservato, malgrado
la quantità grande di acqua che vi era stata ver
sata sopra, impedì dapprincipio di dissotterrarli,
e se ne venne a capo soltanto sei giorni dopo;
molti di questi pezzi pesavano trecento libbre
( di sedici oncie l'una). Nell'eruzione del seco
lo decimo settimo, furono portati via moli in
tieri, e disparvero i cannoni della cittadella sot
F4 to
88 V U L
to un diluvio di ceneri che furonovomitate dal
e viscere delVulcano, con una grandine di sas
si ; ogni scossa era preceduta da uno spaventevol
mormoreggiare, simile a quello del muggito che
si sentiva uscir dalla terra .
Ci sono stati trasmessi i più funesti ragguagli
delle devastazioni, che il Vulcano dell' Isola di
Ternate, una delle Molucche, vi ha fatte in ot
tobre 1773 . L'eruzione cominciò ai 25 di que
sto mese ; la montagna vomitò , tutto misto in
sieme alla rinfusa, una immensa quantità di pie
tre, di ceneri, di rene, di terre, di materie
iù o meno denaturate in questa fucina parti
colare della Natura ; poco dopo , all' orribile
fracasso dei tuoni e dei lampi che ne uscivano ,
rimase avvolta in una nuvola nera, foltissima, ed
il cielo si oscurò a segno , che il giorno si can
giò nella più profonda notte. Quando questa
oscurità si fu insensibilmente dissipata , si vide
il terreno seminato di un' infinità di lumicini ,
che si conobbe in seguito essere avanzi di albe
ri e di piante incendiate. La quantità delle lave
e dei massi infuocati che vomitò il Vulcano, fu
così abbondante e terribile, che vedendosi i non
tanari di questo cantone, ogni momento in ris
chio di esser arsi, schiacciati o inghiottiti in
quest' oceano di fuoco, si rifugiarono tutti nel
le pianure dalla parte del mare; anzi un nume
ro grande di essi credè di trovar la salvezza
in quest'ultimo elemento ; ma in mezzo alla co
sternazione e allo spavento, si gettarono con tan
ta confusione e precipitazione nei loro canot,-
che
V U IL8g
che essendo questi troppo carichi, andarono per
la maggior parte a fondo, colla gente che vi si
era imbarcata. In questa orribile situazione, fu
rono sentite, nello spazio di ventiquattr'ore, ot
tanta scosse incirca di terremoto, tutte fortissi
me, ma due così violente , che l'Isola sembrò
vicina a sprofondarsi in un momento. Le piog
gie di sassi e di ceneri durarono per tre ore
consecutive; e se questo orribile fenomeno aves
se durato un giorno di più, è probabile che
niun' abitante dell' Isola si sarebbe salvato. Tut
to ciò conferma che ovunque sono stati Vulca
ni, nazioni intiere hanno potuto essere in un mo
mento ingojate in questi vasti abissi di fuoco.
I Vulcani delle Isole di Borbone e dell'Ascen
sione ci esibiscono parimente eruzioni terribili;
e gli abitanti della prima di queste Isole si ri
corderanno un pezzo dell' eruzione del 1733 , e
di quella del 1766.
Il Sig. Pallas ha veduto, nel 177o nel distret
to dei Baschkires, Mursalarskiens in Persia, una
montagna ardente , le fiamme della quale, che
escono da certe spaccature, infiammano presto i
boschi e calcinano le pietre .
La caverna chiamata Beniguazaval, vicino a Fez
in Africa, è anch'essa un Vulcano che getta con
tinuamente fumo e spesse volte fiamme . . Nell'
isola di Fuego, al Capo Verde, vi è un Vulca
no gli effetti del quale hanno obbligato i Porto
ghesi a non farvi più abitazioni. Il Pico di Te
nariffa alle Canarie, e che si vede in mare alla
distanza di più di 4o leghe , getta
p LlQ
9ò . V U L
-eeniana
fuoco , e dalla cima, verso la parte del Sud,
scorrono rivi di zolfo liquefatto attraverso alle
nevi. Questozolfo si coagula ben presto, e for
ma nella neve vene che si possono distinguere
da una distanza grande . Il Sig. Heberden , dot
to Medico, stabilito nell'isola di Madera , dice
che i contorni di questa montagna ardente sono
composti di sabbie e di precipizj, e che quanto
più si va vicino alla bocca di fuoco ossia Vulca
no, tanto più si crede di vedere i rottami del
mondo , e le rovine medesimc della Natura, bel
lezze spaventevoli, lo spettacolo delle quali im
prime l'orrore e l'ammirazione, e spesse volte
si riproduce nella storia deiVulcani. La terra è
in questo sito mista di bitume e di fenditure ,
dalle quali si esalano vapori; si sentono gorgo
gliar sotto i piedi le materie liquefatte dal fuo
co : queste materie bollenti sono talvolta riversa
te intiere dalle volte sotterranee nel fondo del-
la voragine, altre volte si attaccano a questevol
te medesime e da esse distillano, il che cagiona
un continuo moto di azione e di reazione . Que
sto fuoco arde e si fa vedere attraverso alle ac
que agghiacciate, ed ambedue gli elementi, con
fusi nell'azione reciproca che hanno l'uno sull'
altro , mettono sotto gli occhj l' immagine del
CaOS e-
In America vi è un numero grandissimo diVul
cani i quali non impediscono che vi si sentano
i terremoti più spesso che altrove , principalmen
te nelle montagne del Perù e del Messico . ll
Vulcano più celebre del Perù è quello di Are
qui
V U . 91
quipa, a novanta leghe di distanza da Lima. Nel
16oo, vomitò tante ceneri e tanta rena calcina
ta, da coprire tutti i terreni posti all'intorno per
trenta e quaranta leghe di giro: si riferiscono in
seguito i Vulcani di Carappa e di Malahallo , il
Cotopaxi e il Pitchinca . I Sigg. dell'Accademia,
spediti al Perù , determinando gli angoli per la
misura della terra , erano continuamente scossi
dall' incendio che romoreggiava loro sotto i pie
di . In tutta l'estensione di uno spazio di sessan
ta leghe in lunghezza, mai non poterono assicu
rarsi di trovare al suo posto, uno solo dei loro
segnali. Il Sangai vomita un fuoco continuo; si
sente da Pintan che è lontano quaranta leghe, e
da Quito stessa, quando il vento è favorevole .
Al Messico i Vulcani più considerabili sono Po
pocampeche e Popocatepec. Si trovano parimen
reVulcani e montagne di zolfo alla Guadalupa .
Vi sono nelle montagne chiamate Cordelliere ,
molti precepizj e larghe aperture, che sono altret
tanti avanzi di fornaci estinte, ma che il tempo
non ha scancellato, le pareti delle qualisono ne
re e riarse , come nel precipizio del monte Ara
rat in Armenia, che si chiama l'Abisso, e di cui
Tournefort ha veduto , sul principio del secolo
XVIII, le spaventevoli rovine. ( Il monte Ara
rat è famoso nella storia, essendovisi posata so
pra l'Arca di Noè . ) Questi abissi sono, al dir
del Sig. di Buffon , antichi Vulcani estinti. Sem
bra che le alte montagne, al Nord del Perù, sia
no le fucine Vulcaniche più formidabili. Questa
immensa catena è senza contrasto lo spettacolo
Vul
92 V U IL
Vulcanico più grande , che esista nella natura -
E' essa la sede abituale dei terremoti, delle esplo
sioni più orribili, più ostinate e quasi più quo
tidiane . Ricerche sui Vulcani estinti, pagina 82 .
Il Capitan Cook ed il Sig. Forster, parlando
dell'eruzione del Vulcano di Tanna, che è l' iso
la più meridionale delle Nuove Ebridi ( l'Arci
pelago delle grandi Cicladi ), dicono che ai 5
di Agosto 1774, sulla sera, videro risplender la
fiamma di questo Vulcano; e che di cinque in
cinque minuti , si sentiva una forte esplosione ,
il fragore della quale era talvolta uguale ai più
violenti scoppj di fulmine, ed un sordo fracas
so , simile a quello di una mina profonda nel
momento in cui scoppia, che rimbombava per
un mezzo minuto . L'aria era piena di parti
celle di fumo e di ceneri che cagionavano loro
molto dolore , quando cadevano ad essi negli oc
chj : i ponti, gli attrezzi, e tutte le parti del
vascello sul quale navigavano , rimasero coperti
di ceneri nere per lo spazio di alcune ore, e
questa medesima rena , mista di particelle di car
bone e di pietra pomice, copriva la costa del
mare. Questo Vulcano era lontano dal porto dei
nostri osservatori , cinque o sei miglia. Duran
te la notte dci 6, lo stesso Vulcano sembrò an
cora più attivo e più terribile ; e cadeva in quel
tempo una pioggia abbondante . ( Anche il Sig.
Cavalier Hamilton ha ugualmente osservato che
l'attività del Vesuvio aumentava dopo la piog
gia): i torrenti di fuoco che vomitava esibivano
uno spettacolo bellissimo ; scagliava pietre di una
pro
vU L 93
prodigiosa grossezza ; il fumo che ne usciva in
grossi e densi vortici, era tinto di diversi colori,
di giallo, d'arancio, di cremisi e di porpora, e
terminava in bigio rossigno e bruno: ad ogni
esplosione i campi e le foreste di tutto il paese
prendevano ugualmente una tinta d'arancio e di
porporino, secondo la distanza, o la maniera
con cui erano esposti alla luce del Vulcano .
Ai 12, questa voragine, sempre agitata da
convulsioni, continuò a farsi sentire pertutto il
giorno ; le ceneri che vomitava col fuoco, oscu
ravano l'aria: la pioggia che cadde in un mo
mento delgiorno , sembrava un composto di ac
qua, di rena e di terra ; in guisa che poteva
chiamarsi un rovescio di melma . Tra le ceneri
nere e in una prodigiosissima quantità, che gettò
il Vulcano in questo medesimo giorno fino alla
distanza di più di quattro miglia ( n'erano semi
nati gli abiti dei nostri Csservatori in mare , e
tutto il paese), si riconobbe che tutte, o quasi
tutte erano schorl in forma di aghi semitrasparen
ti . I contorni di questo Vulcano sono pieni di
sorgenti caldissime, di terre sulfuree ; ed il ca
lore di questi terreni fumanti e sulfurei fa salire
il termometro molto sopra il grado dell'acqua
bollente. Fecero attenzione i nostri Csservatori che
gli stromenti aratori dei quali si servono gli abi
tanti , non meno che quelli delle Isole degli
Amici, della Società, e delle lsole
del Sud, quasi tutte vulcanizzate, sono fatti di ba
salti duri, nei quali si scorgono grani di schorl
lamellosi,-
Fi
94V U L
Finalmente, i Vulcani Idraulici debbono essere
riferiti anch'essi ; poichè esibiscono un fatto ge
nerale e che comparisce sempre singolare . Quan
do si stà sotto il rombo del vento, che viene
da questa specie di Vulcani, si soggiace a una
pioggia; ed il Sig. Forster ne ha fatto in se stes
so la prova: è difficile a persuadersi che un' in
cendio produca un diluvio edinnondazioni abbon
dantissime ; ed i Fisici i quali, sopra tante osser
vazioni e tante relazioni , hanno riguardato
questo fenomeno come costante , si sono tutti
lambiccato il cervello per ispiegarlo. Consultate
la Memoria sulle innondazioni Vulcaniche del Sig.
Ducarla, Giornale di Fisica, Agosto 1782 .
Parliamo prima del Vulcano Idraulico di Gey
ser, vicino a Skallot in Islanda . E' questo un
getto d'acqua bollente, fatto per fissar l'atten
zione; il calore di esso è di più di cento gra
di al termometro di Svezia: la colonna d'acqua
ha diciannove piedi di diametro, e si alza spes
se volte sopra novanta e cento piedi : l'apertu
ra che vi si è prodotta, ha la forma di unagran
tazza il diametro della quale è di vicino a 6o
piedi, e la massima profondità, di 9 ; in mez
zo a questa tazza, è aperto un canale del dia
metro di diciannove piedi, e la profondità del
quale non è stato possibile di determinare : la su
perficie della tazza è incrostata d' una materia
silicea in forma di cavolo fiore. Vedete l' artico
lo Fonte .
Il Vulcano Idropirico, noto sotto il nome di
fontana ardente, vicino a Boseley nella provincia- di
V U L95
ne
di Shrop, esibisce uno dei più sorprendenti fe
nomeni. La fontana di Boseley fece la sua pri
ma eruzione ottant'anni sono, immediatamente
dopo un forte uragano. Appena cessò la tempe
sta, che nel mezzo della notte, un terribile fra
gore svegliò tutti gli abitanti i quali, vedendo
la terra agitatissima e come capovolta , credet
tero di accostarsi al momento della universal di
struzione . Molti tra loro furono coraggiosi ab
bastanza o ebbero tanto sangue freddo, per uscir
dalle case , e per andare verso una piccola mon
tagna , bagnata dal fiume di Severne, e d' onde
sembrava chevenisse il rumore : vi si alzava e vi
si abbassava molte volte la terra nello spazio di
un minuto. Il più intrepido degli spettatori pre
se uno strumento di ferro tagliente, col quale
fece nel terreno un buco di alcuni pollici di dia
metro, ne uscì immediatamente con impeto un'
acqua di scaturigine, l'eruzione della quale fu
così violenta, che quest'uomo ne fu gettato per
terra . Un momento dopo, essendo l'uomo stes
so passato vicino alla sorgente con un lume ,
s'infiammò l'acqua e vomitò fiamme : fu impe
dito l'accesso dell'aria, e la fiamma disparve .
Dopo questo tempo, la fontana ha sempre con
servato le medesime proprietà , s' infiamma cioè
appena le si avvicina una candela accesa, ed è
tale l'attività di questo fuoco, che riduce in ce
nere in un momento i grossi pezzi di legno
fresco . Ma ciò che vi è inoltre di singolarissimo
si è, che malgrado la violenza della fiamma ,
l'acqua non ha il minimo grado di calore , ed
è co
96 v U L
-a
è così fredda come quella delle altre,fontane .
Vicino a Velleja in Italia, vi è una sorgente
l'acqua della quale s'infiamma sulla superficie ,
quando le si accosta un lumicino o una miccia
accesa; e questa fiamma dura finchè non la estin
gua qualche ventata. Vicino a questo luogo vi
è un piccolo terreno che passa per ardente, co
me quello del Delfinato , di cui facciamo men
zione all'articolo Fonte, e sul quale si fanno ve
dere le fiamme, quando il tempo è coperto .
Si crede parimente che molti cantoni della
Francia abbiano una volta provato devastazioni
cagionate dall'effetto dei fuochi sotterranei; ma
s' ignora in qual tempo abbiano arso questi Vul
cani , e qual generazione . ne abbia provato lo
spavento o il pericolo ; i nostri padri non ne
hanno conservate le tradizioni , e i cratèri che
fanno fede dell' esistenza dei Vulcani medesimi
nel seno delle provincie di Francia, sono una sco
perta recente . E' stato ultimamente conosciuto che
la maggior parte delle città dell'Alvernia, del Ve
lese e del Vivarese posano sopra gli avanzi di
antichi Vulcani, in una estensione di più di ot
tanta leghe. Consultate le Memorie dell'Accade
mia delle Scienze, anni 1752 , 1768 . Vedete la
Dissertazione sugli avanzi dei Vulcani di Alver
nia, etc. delSig. Monnet, canonico , etc. inserita
nel Giornale di Fisica e di Storia TNaturale, Lu
glio 1744; la Descrizione dei Vulcani estinti del
Vivarese e del Velese, del Sig. Faujas di Saint
Fond, e l'Estratto di una Memoria sulla deter
minazione di alcune epoche della Natura, pei prodot
V U IL97
dotti dei Vulcani , e sull'uso di queste epoche,
nello studio dei Vulcani, del Sig. Desmarets (a).
Consultate ancora, nel presente Dizionario, gli ar
ticoli Terra, e Terremoto, la teorìa dei quali è
connessa con quella dei Vulcani.
Bom.T.XXXJX. G Vul
(a) La Memoria da noi
quì sopra citata, indica
che essendosi l'autore de
dicato allo studio deiVul
cani estinti, ha capito la
necessità di ordinare e di
classificare i diversi pro
dotti del fuoco, secondo
il grado di cottura, e se
condo le prime materie
che avevano servito di
base alla fusione, nei Vul
cani infiammati . Fatto
questo primo passo, si è
egli applicato alla distri
buzione delle materie vul
cariche alla superficie dei
cantoni devastati dalfuo
co; ha indicato i cratèri
ed i trasporti e le cor
renti delle lave uscite da
questi cratèri o centri di
eruzione : il risultato di
sue osservazioni sull'eru
zioni dei Vulcani,gli ha
esibito epoche ed età del
le quali ha fissato nel
tempo stesso l'ordine, la
successione ed i limiti .
Intende per epoche la
combinazione di certe cir
costanze e di certi stati
nei quali si trovano le
produzioni della Natu
ra, in coerenza delle
quali si può determina
re, non la data precisa
ma l' ordine successivo
degli avvenimenti che
hanno eoncorso a tali
produzioni, che sono al
trettanti monumenti 9ue
ste rivoluzioni della Na
tura sono evidentemente
attestate dalle traccie e
dai vestigj tutt'ora sus
sistenti di essc .
La prima epoca, ch'
98 VU L
Vulcano. Fran. Vulcain . Vedete questa parola
all'articolo Ammiraglio (Farfalla).
VULNERARIA dei Contadini, Vulneraria ru
stica, Tourn.39 I . Giov. Bauh. 2 , 373; Anthyl
lis Vulneraria, Lin. 1 o 12 . Loto affinis Vulneraria
pratensis, C. B., Fran. Vulneraire des Paysans.
ei distiugue, è quella che
racchiude nei suoi limiti
i prodotti dei Vulcani in
fiammati, o i più recen
temente estinti. Intorno
a queste bocche, ancora
aperte, si può facilmen
te osservar la distribu
zione delle materie fuse, i
diversi stati di esse, i
miscugli che vi s'incon
trano, ed avvezzarsi a
riconoscer la disposizione
di tutti i pezzi di que
sti grandi e vasti labo
ratorj -Gl'indizj ed i ca
ratteri di quest'epoca so
no : 1. La forma delle
montagne rotonde, e che
esibiscono nella cimatron
ra un cratère o bocca
larga e profonda ; l' in
terno del cratère e le
Pian
groppe esteriori sono co
erti di scorie o lave
crivellate di buchi e leg
giere, e di materie cotte
e spugnose, 2 . Le cor
renti di lave che si so.
no fatto strada pei fian
chi spaccati della monta
gna, e si sono sparse
nelle pianure vicine;que
ste correnti sono compo
ste di una lava compat
ta nel centro, spugnosa
e piena di convessità vuo
te alla superficie : oltre
a ciò, sono esse accom
pagnate ed involte in tut
ta l'estensione, da scorie,
da terre cotte e da po
mici simili a quelle che
coprono il cratère, 3 .
Vi si osserva che queste
correnti sono sottoposte a
tu
v UL 99
Pianta che cresce nei luoghi montuosi , ari
di, sabbionacei e nei pascoli cretacei, esposti al
sole: ha la radice perenne, semplice, lunga ,
dritta, lignea e nericcia, e di un sapor legumi
noso ; mette fusti all'altezza di un piede incirca ,
semplici, fini, rotondi, leggermente pelosi, un
G
--
2 po
tutte le disuguaglian
ze attuali della super
ficie del suolo dei luo
ghi circonvicini,
La seconda epoca non
esibisce più alla superficie,
nèscorie, nè materie cot
te spugnose: i cratéri so
no totalmente spariti ;
le correnti sono situate
sulla superficie delle pia
nure elevate , e finalmen
te diverse porzioni di que
ste correnti sono separa
te da valloni larghi e
profondi; le bocche dei
cratèri sono state riem
pite dall'acqua, che vi
ha deposto i frantumi di
diversi prodotti del fuo
co , rottami di lave leg
giere, mescolate alle la
ve compatte, oppure al
tro non si scopre che mas
si di lave compatte, le
quali non essendo state
versate fuori, neltempo
dell'estinzione del Vulca.
no, si sono raffreddate in
questi vasti crogiuoli, e
vi hanno formato fondi
più o meno considerabili;
e questi fondi, dei qua
li sono spariti i fornelli
ed i crogiuoli, esibisco
no massi elevati e diru
pati da tutte le parti.
Dice il Signor Desmarets
che tutte le correnti che
hanno la data di que
sta etd, hanno ugualmen
te coperto,principalmen
te verso le estremità in
feriori, i massi di gra
nito, e la superficie degli
strati orizontali più ele
'
oco V U L
Poco rossigni, ordinariamente distesi per terra:
"a la foliole disposte a paja, lungo una costa
Semplice, terminata da una sola foliola più gran
de , simili a quelle delle ruta capraria, ma più
midollose , pelose sotto e che tendono al bian
co, di un verde giallastro sopra, di un sapor
-
vati . 2uando ha avuto
luogo quest'ultimo caso,
è visibile che le corren
ti sonoposteriori alla for.
mazione degli strati ori
zontali.
TPassiamo alla terza
epoca, per la distinzio
ne della quale d'altro
non ha bisogno il Signor
Desmarets che della di
sposizione relativa degli
strati orizontali . TNella
seconda, sono essi sem
pre coperti dai prodotti
del fuoco; nella terza al
contrario, sono essi che
coprono questi prodotti,
o sono mescolate con es
si . I cantoni nei quali
dominano i prodotti del
fuoco, appartenenti alla
terza epoca, hanno esi
dol
bito da ogni parte al no
stro osservatore , massi
di lave sepolte sotto una
congerie di strati orizon
tali, composti di sostan
ze calcari ed argillose ,
non alterate dal fuoco,
o pure formate di mate
rie vulcanizzate che il
mare ha deposte in ban
chi , frammischiati con
istrati di materie intat
te . Si veggono parimen
te tra questi strati, letti
molto profondi di ciotto
li rotolati, che sono la
ve di molte specie.
Rovesciando l' ordine
dell'epoche, ne risulta che
la più antica è la terza.
Prova questo ad eviden
za che molte eruzioni di
fuochi sotterranei hanno
fuso
V U L 1o I
“aaaaaaaaaaa
dolce misto di asprezza. Le foliole che sostengo
no i fiori ( le brattee ) sono più larghe delle al
tre , bislunghe , digitate e membranose : i fiori
nascono in maggio e in giugno alle cime dei ra
mi, disposti in mazzetti, leguminosi, gialli, so
stenuti ognuno da un calice fatto a tubo , rigon
fuso massi enormi di la
ve prima della formazio
ne degli strati orizonta
li 3 e prima dell'invasio
ne del mare medesimo;
che per di più,questi fuo
chi hanno avuto accessi
e riprese, nel tempo per
cui ha durato questa in
vasione. TNella seconda
epoca,si vede che le mas
se hanno camminato sen
za ostacolo alla superfi
cie dei macigni di granito
e degli strati orizontali,
e si sono distribuite so
pra tutta l'estensione del
le pianure elevate. L'epo
ca che viene in seguito,
la meno antica di tutte,
e la prima nell'ordine
analitico che abbiamo es
posto, ci riconduce, col
G 3 fio,
ristabilire le alterazioni
dei fenomeni , fino allo
stato primitivo dei Vul
cani e fino ai nostri gior
ni: quest'epoca occupa
tutto il tempo che si deve
accordare all' acqua plu
viale per iscavare i vallo
ni : ci fa vedere essa an
che i varj progressi di
questo lavoro, mettendo
ci sotto gli occhj le cor
renti e tutti i livelli pos
sibili sulle groppe incli
nate dei valloni, ed indi
candoci per tal manie
ra, che ogni punto che
serve di base e di letto
alle correnti , èstato suc
cessivamente un fondo di
vallone, nel tempo dell'
eruzione dei Vulcani che
hanno prodotto questedi-
ver
IO2 V U L
fio, lanuginoso, e di color d'argento. Quando
il fiore è passato, si gonfia anche di più questo
calice, e diviene una vessica che contiene una
capsula membranosa piena ordinariamente di uno
o due semetti giallastri che maturano in luglio ed
in agosto - --
Questa Vulneraria, coltivata nei giardini, dà due
varietà, una di fior bianco, l'altra di fior por
porino: tutta la pianta è vulneraria, consolidan
te , buona per guarir le piaghe recenti, pestata
che sia ed applicatavi sopra in cataplasmo.
Vulneraria di Svizzera. E'un miscuglio di er
be, di cui si fa uso per guarir le piaghe, e di
cui abbiamo parlato alla parola fallirack e Piante.
VULVA y Lat. Vulva 5 Fran, Vulve . Si dice
verse correnti. Finalmen
te, nei cantoni che co
prono i prodotti del fuo
co, appartenenti alla me
no antica delle epoche,
mai non si scopre nè sor
gente, nè rivò di acqua
corrente che circoli alla
superficie delle materie
vulcanizzate, e i cratèri
sono tutti all'asciutto .
Facilmente si comprende
che le congerie di scorie
che involgono le corren.
l'ori
ti di lave, aprono dap
pertutto uscite che age
volano la filtrazione dell'
acqua pluviale attraver
so di tutte le correnti :
quest'acqua è raccolta in
seguito sul suolo intatto
che serve di basealle
correnti, e più non com
parisce che all'estremità
di esse, d' onde esce,
formando abbondantissi
me sorgenti.
W HI I1o3
l'orifizio esteriore delle parti sessuali nelle fem
mine degli animali . .
VULVARIA, ERBA CONNINA. E' l'atri
plice fetido. Vedete questa parola. -
W, o DOPPIO V. Nome dato a una falena
che ha le ali bianche e cenerine sopra . Provie
ne da un bruco di color giallo verde, picchet
tato di nero; si trova sulla grossularia spinosa
Vedete all'articolo Doppio CC del presente Di
21OlldIC) ,- - - - - - - - - -
WALRUS oWALROS, in Tedesco e in Olan
dese. E' la morsa, Vedete l'articolo Vacca Ma
dina. I Groenlandesi ne vendono i due gross
renti o zanne o difese ; sotto il nome di tor-i
vivac . -
WALVHORA. Nome che si dà a Ceilan al
manucodiata di coda lunghissima ; è un'uccello
di paradiso. Vedete questa parola.
WANDEROU a Ceilan . E' l'uanderù, Vede
te questa parola in seguito all'articolo Babbuino.
WENDHOVER, in Inghilterra, è il canibel
lo . Vedete questa parola.
WHIP-POUR-WIL . Così pronunziano i Sel
vaggi della Virginia . E' il caprimulgo della Vir
ginia, del Sig. Brisson; è di un terzo più pic
colo del nostro caprimulgo : ha il becco nero ;
i piedi e l'ugne di color di carne : la piuma su
periore è di un bruno scuro , rigato trasversal
mente e punteggiato di bruno rossastro , misto
in qua e in là di cenerino; la piuma inferiore
è di un bianco lavato di una tinta di arancio e
rigato trasversalmente di nericcio ; vi sono da
G 4 all
1 o4W7 I T
ambedue le parti dell'occhio e sul collo alcune
macchie di color d'arancio; le guancie sono di
un bruno chiaro; evvi sulla gola una macchia
bianca in forma di luna falcata ; le penne mae
stre delle ali sono nericcie ; le cinque prime esi
biscono verso il mezzo una larga lista bianca; le
mezzane sono variate delle medesime tinte della
schiena, siccome ancora le penne della coda, le
due più esteriori delle quali hanno da ambedue le
parti, una macchia bianca verso l'estremità.
Il Wihp-pour-will arriva in Virginia verso i quin
dici del mese di aprile ; preferisce le montagne
e i luoghi scoscesi . Dice il Signor Mauduyt che
quando tramonta il sole e per tutta la notte ,
quest'uccello, malgrado la sua piccolezza, manda
un grido così acuto e così penetrante, che è in
comodissimo ; fa due uova per volta di un ver
de scuro , variate di macchiette e di tratti neric
ci; la femmina le depone con negligenza sul ter
reno, in mezzo a un sentiere battuto, senza rac
cogliere intorno ad esse alcuna sostanza per com
porne un nido , e cova ciò non ostante con at
tacco; perchè si può allora andarle vicinissimo
senza che voli via .
WIANAQUE. Nome che, al dir diWood, si
dava una volta alle grosse pecore selvatiche che
s' incontrano nelle terre del Porto Desiderato, a
qualche distanza dallo stretto di Magellano. So
no i lamas. Vedete all'articolo Paco .
WITFISCH. I Groelandesi danno questo no
me tedesco alla specie di balena che ha i denti
di sotto soltanto, secondo che dice Anderson,
Sto
W O L
Storia Naturale di Groenlandia pag. 148. Questo
pesce ha la testa appuntata, non ha natatoie sul
la schiena ; ma ne ha una, da ambedue le parti
che è passabilmente lunga ; ha una sola apertura
per rigettar l'acqua; i fori sulla base del cranio
sono due; ma si riuniscono in uno solo, per
produrre un'unico getto d'acqua. Il Witfisch è
di un bianco giallastro; è lungo quindici o sedi
ci piedi: non dà gran fatto più di due botti di
grasso : edè così molle che l'arpone non vi fa qua
si niuna presa e facilmente si distacca; il che fa
sì che rare volte si dia la caccia a questo pesce
ma s' incontra con piacere, perchè se ne riguar
da l'arrivo come il presagio di una pesca abbon
dante di balene. Martens, nel suo Viaggio di
Spitzberg, Parte IV, cap. 6, num.5, parla anch'
esso di questa balena .
WITLEPOOLE. Gl' Inglesi danno questo no
me all'orca. Vedete Orca, in seguito all'articolo
Balena.
WITLING-POLLACK. Vedete all'articolo Baccalà.
WOLFRAM o WOLFART. Nome che alcuni
minatori Tedeschi e Svedesi danno a una specie
di miniera di ferro arsenicale, che alcuni spesse
volte confondono, male a proposito, con la mi
niera d'antimonio e con lo schirl. E' essa simile
talvolta alla galena di piombo; ma più dura di
essa; altre volte è molto simile alla miniera di
stagno cristallizzata ; non è caso raro l' incontrar
la nelle miniere di questo metallo, ed anche as
sai spesso ne contiene un poco. Si trova molto
Wol
N. 66 W O R
Wolfram in cristalli rossigni nelle miniere dell'
Isola degli Orsi in Russia ; e ad Eibenstock in
Sassonia , etc. Si pretende che il Wolfram , do
po essere stato polverizzato ed in seguito abbru
stolito, sia attrattibile dalla calamita . Il Wolframi
è la Spiima lupi aut Jovis dei Naturalisti Latini.
Vedete all' articolo Miniera di ferro Arsenicale,
in seguito alla parola Ferro. - -
Comunemente il Wolfram è una miniera di
ferro all'ultimo segno refrattaria ; di una difficile
fusione ; pesante , dturo, e compatto, cristalliz
zato in lame o in raggi divergenti. Il Wolfram
è la blenda di ferro , o la miniera di ferro in
blcnda, o una sorte di tungstene di un nero bru
niccio ed opaco .
WOLVERENNE; Lupacchiotto di Edwards.
E' il ghiottone del Canadà. Vedete Carcajù.
WORABEO . Nome di una nuova specie di
uccello ; che si trova in Abissinia , e che il Sig.
di Buffon riporta al canario, di cui ha appresso
a poco la grossezza: la piuma superiore e il bas
so ventre sono di color giallo ; ciò non ostante
la parte superiore del collo esibisce una specie
di collana nera ; quest'ultimo colore è parimen
te quello della piuma inferiore, dei lati, della
testa , del becco, delle ali e della coda ; le pen
ne di quest'ultima parte sono orlate di giallo
verdiccio; i piedi sono di un bruno nero . Que
sto uccello va in torme; e dice il Sig. di Buffon
che preferisce a tutti gli altri grani quello del pa
nico, e che non si allontana mai molto dalla
pianta che lo produce .
XA
io7
x A G
y
. Vedete all'articolo anipaba. ,
XANDARUS. E'lo stesso animale che il ta
rando, che è il renne della Lapponia . Vedete
Renne
XANXUS. Secondo Lemery, è in grosso con
chiglio, simile a quelli che i Pittòri danno or
dinariamente per attributo ai Tritoni. GliOlan
desi lo fanno pescare verso l'isola di Ceilan, o
alla Costa della Pescheria, dipendente dal regno
diTravancor; quelli che si pescano su questaCo
sta hanno le volute dalla destra alla sinistra; se
se ne trovasse alcuno le volute del quale fossero
disposte naturalmente da sinistra a destra, gl' In
diani lo stimerebbero infinitamente, perchè cre
dono che uno dei loro Dei si nascondesse una
volta in uno Xanxus di questa specie. Si vuole
che sia proibito a questi Indiani di vendere un
tal conchiglio ad altri che alla Compagnia Olan
dese la quale, avendoli per tal mezzo a buon
mercato, li rivende molto cari nel regno di Ben
gala, ove si segano per farne braccialetti. Ci
sono state fatte vedere in Olanda alcune di que
ste conchiglie, che erano semplicemente buccine
grandi. --
XAXABES. Vedete Sassebè. -
XE o XERCHIAM dei Chinesi o ANIMAL
MUSCHIATO; Lat. Animal moschiferum . Dice
Linneo che è una specie di cervo che non ha
corna, e i denti canini superiori del quale sono
sCQ
l
oS X È
scoperti . Se ne conserva uno, per quello che si
dice, nel Gabinetto della Società Reale di Lon
dra, e sembra diverso dall'animal del muschiò
o dal porta muschio propriamente detto.
-
Il Xe, dice il Sig. Grew , è lungo tre piedi
ed alcuni pollici ; ha la testa lunga mezzo pie
de, e la fronte molto più larga ; il muso appun
tatO ,COTC tra i cani da caccia che gl'In
glesi chiamanó grey hound; le orecchie sono si
mili à quelle dei conigli; sono lunghe tre polli
ci e dritte; ha i piedi benissimo fenduti, armati
di ugne lunghissime e larghe; il pelo della testa
e delle gambe è lungo mezzo pollice , siccome
anche quello di sotto al ventre, e non è folto;
ma sulla schiena e alle natiche, è lungo tre pol
lici, bianco e bruno, come quello della testa e
delle coscie; quello del ventre e della coda è
bianco e come riccio ; ad ambedue i lati della
mascellà inferiore evvi una ciocca di grossi peli,
corti e ruvidi, uguali , lunghi vicino a un pol
lice; il pelo della vessica in cui è rinchiuso il
muschio, è lungo tre pollici.-
Il Xè è timido; e siccome ha l' udito delica
tissimo, sente da unagrandissima distanza, efug
ge appena gli si va vicino. Questo animale si
trova alla China nelle provincie di Kensì e di
Sachuen ,ed ha le dimensioni del capriuolo . Se ne
ritrae un buon muschio, che si trova in untumo
re che gli viene , per quello che si dice, sotto
il ventre ogni mese , nel tempo del plenilunio :
questo muschio è il più perfetto e il più odori
fero di tutti, ed i Levantini ne fanno un-
is
X O C 1os
dissimo conto . Vedete adesso ciò che abbiamo
detto del Porta muschio .
XILO-ALOE. E' il legno d'aloes. Vedete que
sta parola. -
XILOBALSAMO, Xilobalsamum . Vedete all'
articolo Balsamo di Giudèa .
XILOCASSIA, CANNELLINA, CANNEL
LA DEL COROMANDEL, FIORI DI CAN
NELLA, FOGLIA INDIANA, MALABATRO,
Vedete quest'ultima parola.
XILOCOLLA. E' la colla forte . Vedete in se
guito all'articolo Toro.
XIRICA. Vedete Ciri-Apoa.
XIRIDE , RICOTTARIA . Vedete Ghiaggiuolo
puzzolente .-
XOCHICAPAL, Albero della provincia di Me
choacan in America, il tronco e la corteccia del
quale sono di un' odore gratissimo , e rendono
un liquore odoroso che ha le proprietà della re
sina coppale; si pretende che ne sia nel tempo
stesso una specie .
XOCHIOCOTZOL .Gl'Indiani Messicani chia
mano così l' albero che dà per incisione la resi
na chiamata liquidambra . Vedete questa parola .
XOCHITENACATL, Vedete Hochicat .
XOCHITOL, in lingua Messicana, Xochitototl.
E' l' ittèro della Nuova Spagna, del Sig. Bris
son . Questo uccello d'America, indicato breve
mente da Fernandez, sembra lo stesso che il costo
tol, ed è forse la femmina di questo; la piuma è
la medesima. Si dice che il canto del Xochito
sia assai grato; che questo uccello viva
e di
Io X O X
-====
e di semi, che sospenda il nido all'estremità dei
ramoscelli, e che sia un boccone delicatissimo.
XOCOXOCHITL, Albero simile al lauro dei
Magellani , che produce ciò che gli Spagnuoli
chiamano pepe di Tabasco. E' un frutto che pen
de in forma di grappoli , gli acini dei quali di
vengono neri e fanno le veci del pepe per gli
abitanti di una contrada del Messico ; si adopra
no anche in medicina .
XOLOIZTCUINTILI. Specie di cane parti
colare al Messico . Vedete all' articolo Cane, sul
fine .
XOMOLT. Specie di anatra del Messico, che
ha la schiena e la parte superiore delle ali di co
lor nero; il petto è bruno. Quando questo uc
cello si stizza, gli si addrizzano le piume della
testa e formano un ciuffo ,
Seba dà la figura di quest'anatra nel suo Thes. II,
Tav. 65 , num. 5 , e dice che questo uccello ha
la testa di un bel rosso e adorna di un ciuffo
grazioso: ha il becco giallo, terminato in punta
acutissima, e con una macchia nericcia sotto, si
mile a quella che regna all'angolo degli occhj :
la schiena e il petto sono di un rosso pallido; le
ali in alto sono di un giallo chiaro ; in fondo, di
un rosso incarnato : la coda spiegata in venta
glio, è dipinta di un rosso lucido e di un bel
giallo all'estremità, Gl'Indiani si servono delle
piume di questo uccello per adornarsi .
XOXOUQUI-HOACTLI , che si pronunzia
bouhouqui-hoactli, è il nome Messicano dell'hou
bou, o airone cenerino del Messico , del Sig.
Bris-
xv T I.Il
-as
Brisson. La parte anteriore della testa è mista
di bianco e di nero; la superiore è porporina e
adorna all'occipite di un ciuffo dello stesso co
lore : le ali sono variate di bigio e di turchinic
cio; il rimanente della piuma è cenerino ; il bec
co è nero .
. XUTAS, Specie di oca delle Indie Occidentali,
facile ad addomesticarsi, e che i Selvaggi della
Provincia di Quito allevano nelle loro abita
zioni .
Y,
IL . Albino chiama così la farfalla che provie
ne da un bruco , che si alimenta di foglie di
menta. Il Dottor Derham è di opinione che la
farfalla alla quale è stato dato il nome d'ygreco,
può benissimq esser quella alla quale Petiver ha
dato il nome di lambda , e che sembra che sia
il gamma dorato; Vedete queste parole .
YABACANI o YACABANI. E' la radice api
nello. Vedete questa parola.
YAGARANDE, E' il jacaranda. Vedete questa
arola. • ,-
YACHANGA, Vedete Gramigna marina.
YACONDA. Pesce intieramente rivestito di
un coperchio e lungo tre piedi ; si pesca nel
mare delle Indie Occidentali . E' tutto rigato di
linee gialle , rosse e bianche. Dizionario degli ani
mali Vol. IV. pag. 579 .
YACOU . E' il fagiano verdiccio di Cajenna .
Vedete Marail .
YAK. Vedete gli articoli Ghainouk e Bufalo da !
la coda di cavallo . YA-
2 Y E C
ga
“YAPOU. E' il cassico giallo del Brasile, del
le Tav. col. 184; la pica del Brasile, di Belon .
I Francesi stabiliti alla Guiana, ove questo uccel
lo è comune , lo chiamano cul-jaune ( culo gial
lo). Tutta la piuma è di un nero lucido , ec
cettuato il fondo della schiena , le guarnizioni
della coda e delle ali, ed anche i due terzi del
la coda, che sono di un bel giallo : l' iride è di
un turchino di zafro ; la pupilla, le ugne e i
piedi sono neri ; il becco è di color di zolfo
pallido .
YAPPE' o CODA CERVINA DISAVANNA,
Aguape, Marcgr; Icape, Iape, dei Caribi. No
me che danno gli abitanti di Cajenna a un'er
ba cattiva, di cui è cosa spiacevole , al dir del
Signor di Prefontaine, che le savanne ( terre
ni coperti d'acqua ) siano piene ; non vi si con
serva, dice egli, se non fino a tanto che vi sia
no i mezzi di piantarvi la gramigna, che in que
sto paese si prende sulla riva del mare . L'Yap
pè non è di alcun vantaggio pei bestiami ; ma
quando si manca assolutamente di foglie per co
prir le capanne , si prende o in cespugli o in
fastelli e si dispone come la paglia . Per quanto
sia mediocre il letto di Yappè, è preferibile a
quello della paglia di canna .
YATTOUHAI. Vedete legno di Agoti.
YCHO . Specie di giunco del Perù, di cui
sono coperte tutte le montagne della Puna. E'
l' ordinario alimento dei Llamas. Vedete l' arti
colo Paco.-
YECOLT o COLT, Vedete Palma di monte.
ER
Y HI A1 13
YERVA-CANIENI. Non possiamo assicurare
se la pianta che gli Spagnuoli stabiliti nel Para
guai chiamano così, sia la stessa che quella nota
sotto il nome di 2'erva de camini, della quale
abbiamo parlato all'articolo The o Cassina del ma
re del Sud. Avrebbero potuto esser pronunziate
diversamente queste due parole per corruzione;
ma checchè ne sia, si legge nei pubblici fogli
d' Inghilterra, che la pianta Yerva-canieni ha la
virtù singolare di purificar tutte le acque , per
quanto amare , salse o corrotte possano essere,
e basta per questo effetto lasciarvela in infusione .
Quando gli abitanti del Perù fanno il viaggio di
Buenos-Ayres o del Chilì, portano sempre seco
loro questa pianta , e bevono senza difficoltà
l'acqua che trovano per istrada, dopo avervela la
sciato in infusione per alcuni minuti ; dopo essere
stata così in infusione , è molto simile la pianta
medesima al nostro thè verde. Si pretende che
la Yerva-canieni sia quella stessa pianta che Mo
sè gettò nelle acque amare di Mara o Amara ;
d' onde può inferirsi che questa pianta cresceva
in ambedue i Mondi .-
YGA ... Vedete Avorio Albero.
YHABOURA o YTTIBOUCA dei Caribi ,
Triumfetta , Plum. , Fran. Cousin grand. Questa
pianta ha la forma della bismalva; le foglie di
essa formano, al dir di Nicoslon, una specie
di pentagono di due pollici e mezzo di diame
tro, sono sottilmente dentellate nel giro, di un
verde cupo, cotonacee e gentili al tatto, soste
nute da un peziolo lungo un pollice; i fiori so
B9m, T.XXXIX. H IlO
14 Y O K
-
no a rosa, composti di cinque petali bislunghi,
piantati sopra un calice diviso in cinque foglie,
dal quale sorge un pistillo circondato di molti
stami o stamine, che diviene un frutto capsu
lare , di quattro celle , sferico , duro, armato
di piccole punte, per mezzo delle quali si attac
ca agli abiti dei passeggieri; si trova in ciascu
na cella un semetto ovoide . Questa pianta si
trova nei siti incolti, e vien riguardata come
astringente. Se ne usa la radica nelle ulceri degl'
intestini, o degli altri visceri ,
Vi è l'Yttibouca o Yhaboura minore che ha
le foglie più piccole del precedente , fatte a cuo
re, sostenute da un peziolo cortissimo. In tut
to il rimanente, queste due piante, dice Nicol
son, si corrispondono .
YOKOLA. Specie di vivanda che serve di pa-,
ne ai Kamtscadali e ai popoli Selvaggi della Si
beria Orientale . Il Yokola si cucina con ogni
sorte di pesci, che gli abitanti pigliano e divi
dono in sei parti : fanno seccare i lati e la co
da sospendendoli in aria; preparano separatamen
te la schiena e la parte più sottile del ventre ,
che sfumano e fanno seccare al fuoco; ammuc
chiano le teste nei cavi degli alberi, ove fer
mentano fino alla corruzione , e le mangiano
malgrado l' odore infetto che esalano : le coste
e la carne che vi restano attaccate, si seccano
e si riducono in polvere . Nella stessa maniera si
seccano le ossa più grosse, che servono pel man
tenimento dei cani. La carne di storione è quel
la che domina nell'Yokola .
YO
Y U C115
YOLITE, Vedete TPietra di Viola .
YOU . Vedete Onice,-
YOUC. Vedete 2'uca
YPAPAPIA . Vedete Tritoni .
YPECACUANHA. Vedete Ipecacuana.
YPREAU o YPEREAU, 2lmus folio latissimo,
scabro, Ger. Emac, Specie di olmo di foglie lar
ghe che prende il nome da Ypres o Ipri in Fian
dra, ove è comune e di una straordinaria bel
lezza. Luigi XIV ne fece piantare a Marly, ove
si veggono ancora . Pretendono alcuni , che sia
una specie di pioppo . Vedete le parole olmo e
Pioppo .
YQUETAYA. Pianta del Brasile, che i Signo
ri Homberg e Marchand vogliono che sia la no
Stramaggiore aquatica; Vedete queste
Ole ,
YSQUIEPATLI o USQUIEPATLI. E' il coa
so, prima specie delle moffette ; Vedete quest'ul-
tima parola all'articolo 2'squiepatli.
YTAHU' . Si dà questo nome, nel Paraguai,
a una specie di pietra cavernosa; Vedeta questa
parola.
YTIU' Vedete caprifoglio del chilì.
YUCA o YOUC. Pianta perenne, originaria
di America, di cui si distinguono molte specie .
Ve ne sono due che si coltivano in Francia nel
suolo comune e che fanno un bell' ornamento
nei boschetti e nei giardini grandi: cioè:
1 . La Tuca gloriosa . 2'ucca gloriosa , Linn,
456. E' originaria del Canadà; ha il fusto drit
o , consistente, ligneo, ed ha all'estremità una
H 2quan
w
116 Y V O
quantità di foglie lunghe, assai larghe, intiere e
che terminano insensibilmente in una punta pun
gente; i fiori sono di un bianco sporcó, dispo
sti in piramide sopra un fusto che esce dal cen
tro della pianta .-
2 . L'altra specie è originaria della Giammaica,
ed è la Yuca dalle foglie di aloes, 2rucca aloifo
lia; Linn. 457. Differisce dalla precedente solo
perchè ha le foglie sottilmente merlate nel giro .
La Yuca si accosta infinitamente all'aloes . La
Yuca dalle foglie di canapa non è della medesi
ma famiglia, e si chiama manihot . Nel sistema
di Linneo, quest' ultimo è della Monoecia -To
lyandria ; laddove la Yuca è dell' Hexandria-
Monogynia . La Yuca non ha calice; ha la co-
rolla campaniforme , esibisce sei filetti o stami,
un germe bislungo, ed in seguito una capsula a
tre celle. Vedete adesso Manihot ed in seguito
l'articolo Aloes. -
YVOUYRA. Vedete all'articolo Legno da Fuoco.
Z A B
Z ABELLA. Vedete Martora zibellina.
ZABO'. In Arabia è la Jena. Vedete questaarola .
ZACCON, TPrunus Hiericonthica, folio angusto,
spinoso, C. B.; Zaccon Hiericuntea, foliis olea,
Gio. Bauh . Specie di susino straniero che cre
sce , per ciò che si dice, vicino alle Chiese di
Zacchèo nella pianura di Gerico. Questo albero
è grande come quello dell'arancio ; ha le foglie-
simi-
Z A F i 17
simili a quelle dell'ulivo; ma più piccole, me
no larghe, più appuntate, verdissime ; i fiori so
no bianchi; i frutti, grossi come le susine e ro
tondi; sono verdi dapprincipio, ma divengono
gialli maturandosi, e contengono un nocciolo per
ciascheduno . Si ritrae da questi frutti un'olio
per espressione, eccellente per discutere e risol
ver gli umori freddi e viscosi.
ZAFFERANO, o CROCO , Crocus sativus,
Tourn., C. B. Pin.65; Linn. 5o., Fran. Safran
Il grand'uso che si fa delloZafferano per la me
dicina; quello che ne fanno molte nazioni pel
condimento delle più ordinarie vivande, e il con
sumo che se ne fa talvolta nella tintura, rendo-
no questa pianta interessante abbastanza, perchè
noi ne parliamo con ispecialità, sulle traccie del
Sig. Duhamel.
La radice dello Zafferano coltivato o domesti
co è tuberosa, carnosa, della grossezzadi una
nocciuola e talvolta di una noce, rivestita di
alcuni filetti aridi, rossastri: da questa radice di
bulbo sorgono cinque o otto foglie , lunghe sei
o otto pollici, strettissime, appuntate, liscie, di
un verde cupo, adorne nella lunghezza di una
linea biancastra, involte alla base in una guaìna
membranosa : si solleva tra queste foglie un fu
sto corto (è un'asta lunga tre o quattro polli
ci) che sostiene un'unico fiore fatto a giglio, di
un solo pezzo, strombato nella parte superiore
e diviso in sei segmenti ritondati, di color gri
dellino assai delicato; i campi che ne sono pieni;
sono bellissimi a vedersi: escono dal fondo delH
3 fio
118 Z A F
fiore tre stami, gli apici dei quali sono gialla
stri, e un pistillo biancastro che si divide come
in tre rami, larghi all'estremità superiore e fra
stagliati in forma di cresta, carnosi, di un ros
so cupo e come di color vivo di arancio ; i
quali sono chiamati per eccellenza col nome di
Zafferano; e la pianta si coltiva unicamente per
la raccolta di questa parte . L'embrione che so
stiene il fiore si cangia in un frutto bislungo , a
tre angoli , diviso in tre celle che contengono
semi ritondati.
Vi sono parimente molte specie di Zafferano
che fioriscono in primavera, e che non si colti
vano nei parterre se non che per averne i fiori
che souo bellissimi a vedersi. La specie di cui
presentemente trattiamo, e che ha gli usi parti
colari dei quali abbiamo parlato, fiorisce in autun
no. Questa specie di Zafferano , al dir del Sig.
Haller, è senza odore .-
Lo Zafferano si moltiplica facilissimamente per
mezzo de' suoi bulbi, che crescono ogni anno in
abbondanza grande. Si piantano questi bulbi in
primavera in una terra ben concimata, in solchi
paralleli, distanti sei o sette pollici; si mettono
i bulbi nel terreno a un pollice di distanza gli
uni dagli altri, e si ricoprono di sei pollici di
terra. Le terre che ama lo Zafferano a preferen
za delle altre sono le nere , leggiere, un poco
sabbionacee, e le terre rossastre .-
Questi bulbi, siccome ancora le cipolle di tut
ti i fiori, si fortificano nei terreni forti che han
no sostanza; ma i fiori divengono più belli nei
CCI
Z A F I 9
terreni leggieri e magri . Si trovano nello stesso
terreno due sorti di cipolle, le une larghe e
schiacciate, danno piùfigliuolame , le altre riton
date danno più fiori. I bulbi danno solamente
foglie nell'anno in cui sono stati piantati, e fio
ri l'anno seguente nel mese di ottobre: questi
fiori durano solamente uno o due giorni dopo
che hanno sbucciato: caduti i fiori, nascono fo
glie che sono verdi per tutto l'inverno ; si sec
cano e si perdono in primavera e mai non com
pariscono nell'estate , in guisa che un campo di
Zafferano, in queste stagioni, sembra un terre
no sodo
Lo Zafferano nasce nella maggior parte dei pae
si, o siano caldi o siano freddi, in Sicilia, in
Italia, in Ungheria, in Germania, in Inghilterr
in Irlanda, in molte provincie della Francia, r
la Guienna, nella Linguadoca, nel Gatinese e
la Normandia . Lo Zafferano coltivato nel G
nese passa a Parigi pel migliore, e si sostituis
con ragione a quello d'Oriente, che si suol pre
ferire nelle Farmacopèe .-
Raccolta dello ZAFFERANo .
I fiori dello Zafferano compariscono più pre-
sto o più tardi, secondo che gli autunni sono
asciutti o umidi, caldi o freddi. Quando verso
il fine di settembre sopraggiungono pioggie dol
ci, e che ad esse si unisce un'aria calda, si mo
strano i fiori con un'abbondanza straordinaria;
tutte le mattine i campi sembrano rivestiti di un-
H 4 tap
I 2) Z A F
“=-
tappeto gridellino, e questo è il tempo in cui i
contadini non hanno riposo, nè giorno nè not
te; ciò non ostante quando sopravvengono piog-
gie o vento , se ne perdono molti. Io mi ricor
do, dice il Sig. Duhamel, che un'anno soprag
giunsero forti gelate, dopo che erano stati colti
i primi fiori, e che scorsero quasi quindici gior
ni senza che se ne vedessero comparir di nuo
vi . Si credeva finita la raccolta ; ma essendosi
raddolcito il tempo, si viddero ricomparire i fio
ri gli uni dopo gli altri. Ordinariamente la rac-
caccolta dello Zafferano dura tre settimane o un
mese . Nel forte della raccolta, si colgono i fio
ri sera e mattina, prima che si siano aperti :
quelli della mattina sono sempre i più consisten
ti , perchè sembra che lo Zafferano, che è una
pianta autunnale, cresca più nella notte che nel
giorno. Quando i fiori sono trasportati in ca
sa, le donne separano diligentemente il pistillo
dal fiore , procurando di non tagliarlo nè trop
po in sù, nè troppo in giù, affine di non la
sciare il bianco, e similmente di non tagliare al
di sopra della divisione degli stimmi . Si distingue
da questa punticella bianca, quando ve ne resta,
il vero Zafferano, dallo Zaffrone o Zafferano ba
stardo, (cartamo) che talvolta vi mescolano i con
. I compratori temono più di ogni cosa di
trovar nello Zafferano i frammenti dei petali,
perchè queste parti, che si ammuffano, gli comu.
nicano un cattivo odore .e
Nel tempo della raccolta, si veggono traspor
tare nelle città e nei villaggi vicini, nei quali-
IlQIl
Z A F Ià i
non si raccoglie Zafferano, carrette di questi fio
ri dà sciegliere o mondare . A misura che si
monda si pensa a farlo seccare al fuoco. Per ta
le effetto, nel Gatinese, si mette in istacci di
crino sospesi, sotto i quali si pone la brace ; la
bellezza dello Zafferano dipende dalla maniera con
cui è seccato . Quando è ben secco, si chiude
in cartocci di carta o in iscatole ; vi vogliono
cinque libbre di Zafferano fresco per farne una
libbra di secco. Quando i contadini stanno per
venderlo , mettono le scatole in cantina per far
lo crescer di peso . Il prezzo dello Zafferano è
diminuito moltissimo da qualche tempo ; perchè
sl vendeva una volta fino a quaranta scudi la lib
bra ( di Francia ), e adesso, comunemente non
val più di ventiquattro o trenta lire. Il primo
anno, un jugéro produce al più quattro libbre
di Zafferano secco; ma il secondo e il terzo, ne
dà fino a venti .
Malattie delle cipolle dello Zarrano.
Se ne distinguono tre principali ; primo quel
la che i Francesi chiamano il fausset; secondo,
il taccone; terzo, la mort. ---
Il fausset è una mostruosa produzione in for
ma di navone , che ferma la vegetazione della
tenera cipolla di cui si appropria la sostanza ;
questa malattia pone in conseguenza ostacolo al
la moltiplicazione delle cipolle ; ma si può to4
gliere il male per l'amputazione, quando si ca
vano le cipolle , in capo a tre anni, per sepa
“ne i bulbi ,- Il
i 22 Z A F
Il taccone è una carie che attacca il corpo me
desimo della cipolla, e che non si manifesta su
gl'inviluppi. Le cipolle sono più soggette a que
sta malattia nelle terre rossastre . Si toglie la par
te ulcerata , quando l'ulcere non ha penetrato
troppo addentro . -
La mort o mors si manifesta per mezzo di sin
tomi assai singolari ; è essa riguardo a molte pian
te ciò che la peste è agli uomini ed agli altri
animali. Attacca dapprincipio gl' inviluppi, che
rende paonazzi e seminati di piccoli filamenti,
ed attacca in seguito la cipolla medesima che fa
perire . E' facile l'accorgersi del disordine che
vi cagiona, perchè se ne veggono ingiallire e
seccar le foglie .
Appena una cipolla è attaccata da questa ma
lattia, divien contagiosa per le cipolle vicine :
il male si attacca di mano in mano dall'una all'
altra, fa perir tutte le cipolle in uno spazio cir
colare, del quale la prima cipolla attaccata e nel
tempo stesso il centro e il fuoco. Se per inav
vertenza si pianti una cipolla infetta in un cam
po sano, vi si stabilisce la malattia in poco tem
po, e vi fa le medesime devastazioni che abbia
mo accennato. Una sola palata di terra presa in
un sito infetto, e gettata sopra un campo, le
piante del quale siano sane, vi porta il contagio.
Per le cipolle attaccate da questo male non si
conosce alcun rimedio, e si sanno unicamente
preservare colla medesima precauzione che si usa
per fermare i progressi della peste. Per tale ef
fetto si fanno intorno ai siti infetti tagli
p
Z A F i 23
di un piede , e sigetta la terra che se ne ne cava
sopra quella in cui sono morte le cipolle . Una
circostanza ben singolare è che l' impressione di
questo contagio resta talmente aderente al terre
no della piantata, che le cipolle sane che vi si
volessero piantare, in capo a dodici, quindici e
vent'anni, si troverebbero in poco tempo attac
cate dalla stessa malattia.
Il Sig. Duhamel, così noto per la sagacità di
sue osservazioni, ha scoperto qual era la vera
causa di questo mal contagioso: ha egli osserva
to certi corpi glandulosi, simili ad altrettanti pic
coli tartufi, ma colla superficie pelosa, la gros
sezza dei quali non eccede quella di una nocciuo
la , e che hanno l'odore del fungo; gli uni so
no aderenti alle cipolle dello Zafferano, e gli al
tri ne sono lontani due o tre pollici. Da queste
glandule partono alcuni filetti, ordinariamente
della grossezza del filo fino , di color paonazzo
e pelosi come i corpi glandulosi; alcuni si esten
dono da una glandula all'altra, altri vanno ad
inserirsi tra i tegumenti delle cipolle, si divido
no in molte ramificazioni e penetrano fino al
corpo del bulbo , senza che compariscano sensi
bilmente di entrarvi. Queste ossservazioni pro
vano che tai tubercoli sono piante parasite le qua
li, come i tartufi , si moltiplicano nell' interno
della terra , senza mostrarsi alla superficie di es
sa. La pianta parasita si alimenta alle spalle del
la cipolla dello Zafferano, perchè le radici di
quella penetrano gl' inviluppi di questa e si attac.
cano alla sua propria sostanza .
i24 Z A F
maremmana
Il Sig. Duhamel si è assicurato della verità di
qùesto fatto, piantando alcuni tubercoli di Zaffe
rano, attaccati dalla malattia contagiosa detta mort;
in certi vasi, nei quali aveva piantato in un terre
no sano, cipolle di diversi fiori; questi tubercoli
in un'anno si sono moltiplicati nel vaso ed han
no attaccato le cipolle . Dopo quel tempo ha egli
cosservato la medesima pianta parasita, che cagio
nava il medesimo danno agli ebbj o ebuli, all'
anonide o arresta bue, e alle piantate di spara
gi . Questo piccolo tartufo parasito non attacca
le piante annue, nè quelle che hanno le radici
alla superficie della terra . .
Queste osservazioni spiegano perchè la malat
tia si stenda circolarmente, poichè le cipolle so
no attaccate solamente dalle radici della pianta
parasita che estende come tutte le piante le sue
radiche circolarmente : si vede parimente che non
vi può essere miglior rimedio perfermare i pro
gressi di questo male, che i tagli fatti anch'essi
circolarmente
Degli usi dello ZAFFERANo
Gli stimmi seccati dello Zafferano sono odoro
sissimi; servono agli abitanti del Nord e di tut
ti i Paesi Bassi, anche della Germania, che ne
fanno un consumo grande, per condimento del
le vivande e del thè . Si fa uso dello Zafferano
anche in Francia nei lavori di credenza, si fa
entrar nelle creme, nelle pastiglie, &c., sicco
me ancora nel famoso liquore che si.
cicitt
AC
A F 25
bac. Se ne fa un'uso frequente in Medicina, ed
alcuni Medici lo hanno chiamato il Re dei vege
tabili e la panacèa vegetabile, per le sue eccel
lenti virtù. Viene stimato carminativo, cefalico,
alessitero, emmenagogo , cordiale , stomatico,
vermifugo, isterico : si usa nei cataplasmi risol
venti, e si fa entrar nei collirj, principalmente
per preservar gli occhi dalle conseguenze del va
juolo . Toglie le ostruzioni del fegato, e si dà
con buon' effetto nell'asma e nell'etisìa .
L' uso dello Zafferano dev' esser moderato ed
a proposito, perchè quando se ne prende inte
riormente una dose troppo grande , cagiona non
solamente la gravezza di testa e il sonno , ma
talvolta ancora risa smoderate e convulsive, e
finalmente la morte . Dicono molti Autori che
tre grossi di Zafferano possono cagionare questi
sintomi e la morte; ciò non ostante l'uso dello
Zafferanio è così famigliare ai Polacchi, che lo
mescolano spesse volte fino alla dose di un' on
cia nei loro alimenti. Sivede abbastanza qual sia
la forza dell'assuefazione nell'uso continuo dell'
oppio, del quale alcuni prendono impunemente
fino a due o tre dramme ogni giorno , dopo es
servisi a poco a poco avvezzati, benchè bastino
talvolta quattro o cinque grani per far morire.
Si può dunque con sicurezza far uso dello Zaf
ferano da uno scrupolo fino a uno scrupolo e
mezzo, purchè quest'uso non sia frequente .
Lo Zafferano somministra ai Tintori una bel
lissima tinta , ma pochissimo adoprata, perchè è
troppo cara, e per altra parte di pessima quali-
tà
126 Z A R
tà. Gli Architetti ne fanno uso parimente per
acquarellare i loro piani ; e delle cipolle di
Zafferano si potrebbe far l'amido; ma costereb
be troppo .
zafferano Bastardo, o Zaffrone, o Grogo, o
zafferano Saracinesco , o di Germania . Vedete
Carta7710 ,
zafferano delle Indie, o curcuma. Vedete Ter
ra Merita .
ZAFFIRO, Lat. Saphirus, Fran. Saphir. Pie
tra preziosa, di un colore turchino nericcio co
me l'indaco, e che è di una figura ottagona o
decaedra, (secondo il Sig. Dutens, lo Zaffiro è
talvolta ottaedro o parallelepipedo obliquango
lo ) : è, dopo il rubino, la pietra che più sì ac
costi al diamante in durezza : lo Zaffiro non è
attaccato dalla lima, ed è difficilissimo a scolpir
si . Essendo suscettibile del pulimento più vivo,
è brillante, risplendente e diafano : se ne distrug
ge talvolta il colore in un fuoco violento, sen
za che ne rimanga alterata la durezza della pie-
tra, ed è simile allora a una specie di diaman
te senza colore . Lo Zaffiro s'incontra nei me
desimi luoghi e nelle medesime matrici che il
rubino. Nel commercio delle gioje si distinguo
no gli Zaffiri in pietre turchine orientali ed in
occidentali. Al Pegù tutte le pietre colorite so
no chiamate impropriamente rubini : lo Zaffiro
è chiamato dai naturali del paese, rubino turchi
no; l'ametisto, rubino violaceo; il topazio rubino
giallo , &c., e così di tutte le altre pietre pre
ziose .
1. Lo
Z A R127
1 . Lo Zaffiro orientale, Lat. Saphirus orienta
lis, è di un magnifico turchin celeste , o di un'
azzurro bellissimo, vellutato , ugualmente distri
buito, senza essere nè troppo carico, nè trop
po chiaro; ed il più prezioso di tutti gli Zaffi
ri: si trova nella montagna di Capelan , nel re
gno del Pegù, nel Calecut, nell' isola di Cei
lan ; e ne vengono ancora da Bisnagar e da Ca
nanor. Questa pietra era così stimata dagli An
tichi, che era consacrata a Giove, ed il sommo
sacerdote di questo falso numc n'era sempre co
perto . Uno Zaffiro orientale perfetto, del peso
di dieci carati , può, al dir del Signor Dutens,
valer cinquanta luigi, ed uno di venti carati,
duecento luigi; pegli Zaffiri che sono sotto i die
cì carati, si può stimare a dodici lire il primo
carato , moltiplicare il numero dei carati l'uno
per l'altro c il prodotto per dodici, ed il risul
tato darà il prezzo dello Zaffiro ,
2 . Lo Zaffiro Occidentale o biancastro. E' di
color bianco chiaro , misto di turchin celeste :
questo color misto, benchèpiacevolissimo, lo ren
de meno stimabile del precedente; è, per altra
parte, caso rarissimo il trovarlo senza difetto :
è troppo soggetto ad esser tenero o pieno di
nebulosità, o calcedonioso, come si vede in quel
li che ci vengono dalla Slesia, dalla Boemia e
dal Val-Saint-Amarin in Alsazia.
3. Lo Zaffiro color d'acqua, Saphirus aqueus.
Quanto meno questo Zaffiro è colorito, tanto è
più bello. Si pretende che quando ha poco o
punto colore, i Qiojellieri lo mettano in un ba
gno
28 Z A F -
gnodi rena, e lo espongano per alcune ore a
un fuoco forte quanto quello delle fornaci di ve
tro, dopo di che lo faccettano, lo lustrano e lo
sostituiscono al diamante ordinario, al quale si
accosta allora per la lucidezza, ma senza aver
ne la durezza : questo Zaffiro ci viene da Ceilan.
4. Lo Zaffiro verdastro, Saphirus prasitis. Si
distingue. attraverso al color turchino di esso
una tinta verdastra, piacevolmente distribuita e
gatteggiante : è lo Zaffiro occhio di gatto; si tro
va in Persia, ed è più o meno ricercato, se
condo che è più o meno bello , -
Ancora non si sa se lo Zaffiro di un bel tur
chino sia debitore del suo colore, o al ferro,
o al rame, o al cobalto ; è però sempre vero
che si può contrafare colla fritta, di cristallo, e
collo Zafre . -
Zaffiro ( lo) . Nome di un uccello mosca, che
si vede alla Guadalupa, ha il becco lunghissimo,
bianco e nero alla punta ; la fronte, la parte
anteriore del collo e il petto sono di un turchi
no di Zaffiro , che riflette il violacea; la gola
è di un rossiccio di marrone ; tutta la coda, di
un rossiccio più o meno dorato; le ali sono di
un bruno violaceo ; tutto il rimanente della piu
ma è di un verde dorato cupo .
Zaffiro Smeraldo . E' una varietà dell' uccello
precedente : quest'ultimo si trova alla Guiana e
alle Antille; è più piccolo dello Zaffiro propria
mente detto ; il becco e i piedi sono neri ; la
testa, la gola e la parte anteriore del collo, di
un bel turchino di Zaffiro ; il rimanente della
piu
Z A E 1 29-
r
piuma è lucido , smaltato di un verde di sme
raldo ; ma le penne delle ali sono brune ; quel
le della coda , di un verde dorato cupo .
ZAFFRONE , GROGO , ZAFFERANO BA
STARDO, ZAFFERANO SARACINESCO. Ve
dete Cartamo .
ZAFRE o SAFRE. Nome dato a una calce
metallica di cobalto al quale sono stati tolti , per
la calcinazione, i mineralizzatori, come lo zolfo,
l'arsenico, e le altre materie volatili . Fuso con
materie vetrificabili , lo Zafre dà un bel turchi
no , misto con un flusso riduttivo; si ritrae dal
lo Zafre un regolo di cobalto , Il più bello, il
meno alterato dà il turchino più bello e il più
solido nella vetrificazione sugli smalti , le porcel
lane, i cristalli delle fornaci; e si adopra pari
mente per imitar le pietre preziose , opache e
trasparenti, come la turchese , il lapis, lo Zaffi
ro, etc. Vedete adesso l'articolo Cobalto.
Nell'arte Vetraria di Neri , Meret, e Kun
ckel , opera tradotta dal Tedesco dal Sig. Baro
ne di Holbach , osserva Kunckel, pag. 52, che
, la prima volta che si mette in fusione. il vetro
, collo Zafre , depone un regolo. Questo rego
, lo colorisce anche il vetro di turchino; ma il
, vetro resta segnato di puntini neri ,. Si pre
tende che questo regolo sia di un gran vantag
gio nella Chimica,
Nel primo volume della Chimica metallica di
Gellert, tradotta dal Tedesco dal Sig. d'Holbach,
si trovano, pag. 44, particolarità interessantissi
me sulla natura e le proprietà del regolo di co
Brm.T.XXXIX. I bal
13oZ AN
balto . Il Sig. Cadet, celebre Chimico, ha pre
sentato all'Accademia delle Scienze una memoria,
nella quale prova di esser pervenuto a ritrarre
un regolo di vetro dal cobalto, chiamato smalto
o azzurro o smalto vetrificato, e ne fa l'inchio
stro simpatico; è egli di opinione che il cobalto
sia un semimetallo. Consultate le Memorie dei
Dotti stranieri. Nel Manuale di chimica del Sig.
Baumè, si troveranno una descrizione metodica
sopra questa materia, e nuove esperienze tenden
ti a far sempre più conoscere le proprietà del
regolo di cobalto.
ZAGOU. E' il Sagù. Vedete questa parola.
ZAIM o ZIM . Vedete zingo .
ZAINO. In molti luoghi dell'America è il pe
cari. Vedete questa parola.
ZAMARUT. Vedete alla parola Smeraldo.
ZANOE'; i Messicani pronunziano tzanahoel .,
E' la pica minore del Messico, del Sig. Brisson ;
è appresso a poco della grandezza della nostra
le : la coda è lunghissima ; il becco, i piedi, le
ugne e tutta la piuma sono neri, eccettuata la
testa e il collo che tirano al falbo .
ZANTURO, Sparus argyrops, Linn.; zanthu
rus Indicus,Willughb . Fran. zanture. Pesce del
genere dello sparo, che si trova nei mari vicini
alla Giammaica e alla Carolina. Secondo Linneo,
è molto simile al porgy; ma è da esso distinto
pei prolungamenti in forma di setole dei tre pri
mi raggi della natatoja dorsale, e pel colore ar
gentino delle iridi degli occhj, laddove quelli del
porgy sono di color d'oro : ha, come questo pesce ,
la
Z A N I3 I
la schiena scavata da una specie di canale, e la
coda incavata in forma di luna crescente; la na
tatoja dorsale ha ventisei raggi, i dodici primi
dei quali sono spinosi ; le pettorali ne hanno di
ciassette per ciascheduna; quelle dell'abdome,sei;
quella dell'ano ne ha quindici; quella della coda.
venti: il color della schienaè di un giallo d'ofo
più o meno cupo,; il ventre è di un bianco con
una tinta di turchino; le natatoje sono rossigne;
la testa è bruniccia. Gli Olandesi danno a que
sto pesce il nome di geelstard, ed è della gros
sezza di un carpio ordinario . Si prende coll'amo
tra gli scogli sulla riva del mare; la carne n'è
sana e di buon sapore .
ZANZARA, Lat. Culex, Fran. Cousin . Piccolo
insetto noto a tutti per l'incomodo ronore che
fa, che turba alcune volte il riposo della notte,
ed anche più noto per le sue crudeli punture .
Le nostre Zanzare possono chiamarsi pacifiche, se
si paragonino a quelle dell'Asia, dell'Africa , e
dell'America , secondo quello che ne riferiscono
tutti i viaggiatori , che sono stati da esse. crudel
mente tormentati ; vengono chiamate nel paese
maringuini. La puntura di questi insetti mette il
fuoco in tutto il corpo, e gli aculei di essi pe
netrano talvolta attraverso ai drappi più fitti. Gli
abitanti sono spesse volte costretti, per difender
sene, d'involgersi in nuvole di fumo, di cui ri
empiono le proprie capanne; altri usano la pre
cauzione di rinchiudersi in tende fatte di lino e di
corteccia di albero . Vedete Maringuino . Noi stessi
nelle campagne dell'Europa, non potremmo sopI 2
por
32 Z A N
portare in una notte di estate, passata in un bo
sco , alla riva di uno stagno o di una palude, il
ronzio e le punture delle Zanzare . Quelli che
hanno percorso le deliziose campagne dell'Italia,
e tutte quelle che sono al mezzogiorno dell'Eu
ropa, si ricorderanno che è forza di dormirvi o
circondati da cortinaggi di velo , se si vogliago
dere il fresco, o chiudersi in fondo alle abita-
zioni , senza lasciare alcun' ingresso o accesso
all'aria esteriore. Anche i Lapponi medesimi so
no crudelmente molestati da, questi insetti , che
non sono più grossi delle pulci, ma di una osti
nazione che non ha uguale . Siccome sembra che
la metamorfosi di questi insetti sia simile a quel
la delle Zanzare, la storia di queste ultime potrà
servire a far conoscer le altre.
La Zanzara ha le gambe lunghe , ed abita a
preferenza lungo le acque e le paludi. Si può
talvolta confonderla con la tipula della specie mi
nore, chiamata quliciforme, insetto molto simile
alla Zanzara, ma questa è molto più grande, ed
ha le gambe lunghissime e proporzionate alla lun
ghezza affilata del corpo . La differenza più es
senziale pel nostro riposo è che la tipula non ha,
come la Zanzara, la testa armata di un aculeo ;
ed un tal carattere distingue benissimo, anche le
specie minori di tipule dalle Zanzare .
Si distinguono nelle vicinanze di Parigi tre di
verse specie di Zanzare , ma noi ci fermeremo
solamente a ciò che vi ha di comune a tutte le
Zanzare in generale, e a ciò che può interessare
la nostra curiosità .
-
Il
Z A N 133
n corpo leggiero delle Tanzare èsostenuto da
sei gambe lunghe; la testa è armatadi un acu
leo, la struttura del quale è una delle piùcurio
se, e questa testa è adorna di belle antenne
pennacchio, le quali, siccome intutti gl'insetti,
sono più belle e più fioccute neimaschj che nel
te femmine; questi insetti sono i meglioprovve
duti di pennacchi di tutti gli animaliconosciuti
Hanno gli occhj a rete e quattro stimmiorgani
della respirazione. Vedete alla parola Insettol'in
teressante descrizione di queste parti
La zanzara ha due ali sole, e dietro queste
ali due piccoli contrappesi che sono ad essa comu
i con tutte le mosche di due ali, ma dei quali
sono prive le mosche di quattroali , il che fa
rebbe pensare che questi contrappesi nella specie
della Zanzara avessero un uso chesupplisse al
paio di ali che le mancano. Questeali, vedute
al microscopio, compariscono trasparenti come
il talco, e coperte di piccole scaglie, in un ora
dine piacevole e regolare .
La tromba o aculeo della Zanzara è composta
di un numero prodigioso di parti di un infinita
delicatezza, e che agiscono tutte insieme per con
correre all'uso che deve farne l'insetto. Ciò che
si scopre coll'occhio nudo , è il solo tubo che
contiene il dardo; tubo che è fenduto, e la fen
ditura del quale è in maniera eseguita, che es
sendo di una materia consistente e non flessibi
le, possa discostarsi dal dardo, e piegarsi “più o
meno aproporzione che il dardo penetra nella
piaga Da questo tubo, che è traforato, esce un
I 3 acu
I 34 Z A N
“======
aculeo, che ha l'azione di una tromba, di una
struttura semplicissima, e per ciò appunto, altret
tanto più maravigliosa. Questo aculeo è composto
di cinque o sei lamelle , simili ad altrettante lan
cette applicate le une sopra le altre; alcune sono
dentate all'estremità in forma di ferro di freccia,
le altre sono semplicemente taglienti. Quando il
fascetto di queste lamelle è introdotto nella ve
na, sale il sangue nella lunghezza delle lame me
desime, come in altrettanti tubi capillari; e sale
tanto più in alto, quanto più sono piccoli gl'in
tervalli . Questa meccanica di costruzione , e que
sta ascensione dei liquori, si osserva meglio nell'
aculeo del tafàno, ch'è più grosso, ma costruito
sullo stesso modello ... Vedete Tafàno .
Nell'istante in cui la Zanzara vibra il suo dar
do nella vena, lascia uscire alcune goccie di un
liquore che cagiona in seguito pruriti insoppor
tabili. Si crede che questo liquore che la Zanza
ra schizza così nella piaga, serva a rendere il
sangue più fluido , onde lo succhj allora più fa
cilmente; se ciò è, noi paghiamo caro il van
taggio che ne ritrae l'insetto. Abbiamo detto es
servi persone che queste punture riducono aduno
stato crudele, e ve ne sono alcune, la pelle del
le quali sembra che abbia un'allettamento mag
giore per questo insetto . Nè vi è da credere
che ciò accada a proporzione della delicatezza
della pelle, perchè si veggono donne, che l'han
no finissima e delicatissima, e pure non ne sono
attaccate. E'di opinione il Sig. di Réaumur che
si possa trovare qualche mezzo di render la no
Z A N. 135
stra pelle disgustosa alla Zanzara, strofinandola,
per esempio, coll'infusione di alcune piante, che
fossero contrarie a questi insetti. Se fosse possi
bile di osservarne alcuna sulla quale le Zanzare
non amassero di riposarsi, sarebbe questoun mez
zo di abbreviare i tentativi. Un rimedio contro
la puntura degl' insetti medesimi, è, per quello
che si dice, l'alcali volatile , in mancanza di que
sto , si può grattare con qualche vigore la parte
recentemente ferita, e lavarla coll' acqua fresca;
ma è cosa essenziale che si faccia immediatamen
te dopo essere stato punto; perchè se non vi sia
stata fatta attenzione, il che accade spessissime
volte , e che sia stato lasciato il tempo di fer
mentare al veleno , ordinariamente altro non si
fa col grattarsi che accresce l'enfiagione e i bru-
ciori; il rimedio è allora di umettarla piaga col
la saliva, e di resistere , se è possibile , alla vo
glia di grattarsi. Pretende il Sig. Bourgeois, che
i migliori rimedi contro la puntura delle Zanza
re, delle vespe, delle api e di ogni sorte d' in
setti, siano gli olj. Se si applichi l'olio di man
dorle o di ulive o anche l'olio di lino o di no
ce sulla puntura di qualche insetto, appena si
sente, e non sopraggiunge nè infiammazione, nè
bolla, nè prurito .
-
Metamorfosi della ZANzARA
La Zanzara è uno di quegli insetti che godo.
no successivamente di due generi di vita, i quali
sembrano molto opposti. Nascono sotto la figura
I 4 di
36 Z A N
di pesciolini, e finiscono coll'essere abitatori dell'
aria. Dal mese di naggio fino al principio dell'
inverno, le acque morte delle paludi e quelle che
si lasciano stagnare nei tini , bulicano di vermet
ti, i quali, siccome la naggior parte degl'inset
ti, debbono subire tre metanorfosi. Questiver
mi sono facilissimi a riconoscersi nell'acqua, per
chè si veggono quasi sempre sospesi colla parte
posteriore alla superficie dell'acqua stessa e colla te
sta in giù. Dalla parte posteriore di questi vermi
esce da un lato una specie di tubetto o di cer
bottana, che si dilata all' estremità come un' im
buto, ed è questo l'organo per cui respirano :
dall'altro lato di questa stessa parte posteriorevi
sono quattro piccole natatoie. Appena si agita
l'acqua, si veggono questi vermi precipitarsi al
fondo colla massima sollecitudine, per mezzo di
queste natatoje; ma si veggono risalire un mo
mento dopo alla superficie, perchè non essendo
l'organo della respirazione atto, come le bran
chie dei pesci, a estrar l'aria dall'acqua , sono
costretti a venire alla superficie per respirare .
Questi vermi sono lunghetti; hanno la testa ar
mata di uncini, che sono in un moto perpetuo,
e che servono ad essi perghermire gl'insetti im
percettibili, e i filetti delle piante, dei quali si
alimentano. Questi insetti restano così nello sta
to di vermi quindici giorni o tre settimane in
circa, secondo che la stagione è più o meno cal
da; ed in tale intervallo mutano tre volte la
pelle .
In capo a questo tempo, i vermi medesimi si
traS
zA N- 13)
trasformano in... ninfa, che è la Zanzara medesi
ma, ma involta in una membrana finissima ; de
stinata a tener fasciate tutte le membra dell' in
setto, le quali si fornano e si fortificano sotto
un simile inviluppo, nel quale resta otto o die
ci giorni . In questo tempo la ninfa non prende
e non ha bisogno di alimento alcuno; gli orga
ni della respirazione hanno mutato luogo e for
ma; respira essa per due specie di cornetti, che
sono vicini alla testa, ma che, passata la ninfa
allo stato d'insetto alato, diverranno stimmi . Sta
essa, cone il verme , alla superficie, dell'acqua
per respirare, ma tutta ravvolta in se stessa. Al
minimo moto , discende nell' acqua svolgendosi,
per mezzo dei remi, dei quali è munita alla par
te posteriore ; l'agilità e la maniera di muover
si di queste ninfe , è uno spettacolo singolare.
E' cosa facilissima, nelle giornate calde dell'esta
-te, il veder passar le ninfe, allo stato di Zanza
ra in un tino d'acqua. La ninfa si svolge; sol
leva una parte del corpo fuori dell'acqua ; si
gonfia e fa crepar l'inviluppo in questo sito. Si
vede allora comparir la testa della Zanzara fuori
dell'acqua; l'insetto continua ad uscire dal suo in
voglio, e ciò che gli serviva un momentoprima
di veste , muta uso, e gli fa presentemente le
veci di battello: voga a discrezione dei venti ; e
serve a se stesso di vela, di albero e di nave .
L'insetto è allora in pericolo; perchè per poco
che si alzi il vento , entra l'acqua nel battello.
lo manda a fondo, e l'insetto si annega. Nei
giorni in cui soffia con violenza il vento, si ve
de
138 z A N
aan-----------------------------
de tra le Zanzare una terribile immagine degli
effetti della tempesta; perchè questi insetti, che
un momento prima sarebbero periti, se si fos
sero tenuti anche per brevissimo tempo fuori dell'
acqua, nulla più hanno da temere allora dell'ac
qua medesima .
Non così tosto la Zanzara è divenuta alata ,
che cerca l'alimento nel sangue degli animali, ed
anche, per quel che si crede, nel sugo delle fo
glie, sulle quali si posa , durante il calore del
giorno. L'accoppiamento di quest' insetti, di cui
non vi era ciò non ostante ragione di dubitare ,
era sfuggito al Sig. di Réaumur, ed agli Osser
vatori più industriosi; nè deve ciò recar mara
viglia, poichè , secondo le osservazioni del Sig.
Godheu, che si leggono nel tomo terzo della par
te straniera delle Memorie dell'Accademia, questa
scena succede in mezzo all'aria , e volando ; e
non era venuto in capo ad alcuno di andarla co
là a cercare. Forse non sono questi i soli in
setti che si accoppino in aria; ma è eosa ben cer
ta chevi si accoppiano, e che anche questo ele
mento fa, come la terra e le acque, una porzio
ne dell' impero di amore .
Si distingue facilmente la Zanzara maschio dal
la sua femmina : quello è più lungo di questa ,
ed ha alla parte posteriore due uncini che gli
servono, come in molti insetti, a ritener la fem
mina: questa ne è priva; ma invece dei due un
cini ha due palette che le servono per disporre
l'uova quando le fa. Il maschio si distingue in
oltre per la bellezza dei suoi pennacchj . Il Si
gnor
Z A N- Il 39
gnor Abb. Poiret dice che la Zanzaracomu
ne in Barbarla, è della grossezza della nostra;
ma così pomposamente adorna, che ei le ha per
donato le sue punture pel piacere di ammirarla ,
Ha tutto il corpo, e particolarmente la schiena,
coperto di scaglie argentine ed orbiculari; e le
gambe listate alternativamente di bruno e di ar
gento .
--
Deposizione dell'uova della femmina
della ZANzARA .
Quando la femmina è stata fecondata, va a
depor l'uova sulla superficie dell'acqua, affinchè
il verme nascente si trovi nell' elemento che gli
sarà allora necessario. Per tale effetto, si attac
ca a una foglia o a qualche altro corpo sulla su
perficie dell'acqua. Incrocia le gambe posteriori,
e colloca nell'angolo che esse formano il prim’
uovo coll'estremità dell'ano, che in quest'inset
ti ha una maravigliosa flessibilità; depone succes
sivamente le altr'uova, che si attaccano le une
alle altre; discostando le gambe dà essa a que
sta congerie d'uova una forma di battello, che
ha la sua prua e la sua poppa . Questa specie
di barchetta voga sulle acque per la propria leg
gerezza ; ma vi rimane talvolta inghiottita a ca
gione delle tempeste . Il numero dell' uova che
fa la Zanzara, va dalle duecento fino alle trecen
to cinquanta, e da ciascuno di queste esce un
verme in capo a due o tre giorni: siccome ba
sta un mese in circa da una generazioneall' al
tr 5
i 45 Z A N
tra, si possono contare sei o sette generazioni
per anno; in guisa che noi saremmo sicuramen
te sepolti in nuvole di Zanzare, se non divenis
sero la preda degli uccelli, e principalmente del
la rondine , siccome ancora di una moltitudine
d'insetti carnivori . Noi diciamo che le Zanza
re depongono l'uova in un'acqua stagnante e
corrotta, ma i piccoli insetti dopo lo sviluppo
si alimentano di questa corruzione; ed è facile
assicurarsene coll'esperienza seguente . Si riempia
no due vasi di acqua corrottà , e si lascino in
uno tutte le piccole Zanzare che vi si trovano,
e si estraggano esattamente dall'altro quelle che
contiene, accaderà che l'acqua piena d'insetti si
purificherà in poco tempo e che l'altra esalerà
un cattivo odore .
Zanzara mosca, Lat. rulex, Fran. moucheron
E' un' insetto lungo e floscio , che è del gene
re delle mosche : ha sei gambe lunghissime, cur
vate in fuori, le ultime due delle quali sono più
alte delle altre; il ventre èformato di nove lame
o ànelli : ha la testa piccola, gli occhi neri, e
sopra, due antenne barbate; ha invece di bocca,
una tromba appuntata, dura e vuota, colla qua
le fora la pelle e succhia il sangue degli anima
li, e principalmente quello dell'uomo, del qua
le sembra più avido, e del quale si riempie fin
chè ne divenga rigido il corpo, a forza di esser
pieno e disteso; il petto è largo ed elevato, e
di un color verdastro .
Questi insetti, al dir di Goedard e Wagnerus,
si ritirano in gran numero nelle cisterne all'avVla
z AN Il 41
vicinarsi dell'inverno, e depongono sulle piante
aquatiche, secondo che dice il Sigd'Hursseau,
certe piccole uova giallastreche essi vi attaccano
con una specie di glutine. Vedetela Micrografia
di Hook. Da quest'uova, riscaldate dalcalor
del sole, nel mese di giugno seguente»escono
vermetti giallastri o rossigni, rotondifini , com
posti di tredici anelli, e che hanno la testa ros
sa; hanno essi due gambe solesituate sotto il
primo anello. Questi vermicciuolisanguinari, si
alimentano probabilmentedi alcuni animaletti che
si trovano sulla superficie delle acqueGoedard
gli chiama pidocchi aquatici. In capo aundici
mesi, si radunano in gran numero, e comein
una pallottola; fanno granmoti nell'acqua; ed
esce in seguito dal corpo di essi un sugovisco
so di cui si servono per costruirsi certibozzolet
ti molli e viscosi, che attaccano alle piante aq
tiche, e nei quali si rinchiudono, come in una
specie di stuccio. Quando hannoacquistato, una
certa grossezza e n'è divenuto il corpo di co
lor bruno verdiccio, come le foglie delle pian
te che hanno ad essi servito di alimento sac
cade la metamorfosi; ed esce da questa conge
rie una prodigiosa quantità di moscheZanzare
che si mettono immediatamente a volare esi
spargono da tutte le parti persucchiare il san
gue degli animali. Quest'insetto fa volando un
rumore assai acuto , ed un tal rumore è propor
zionato alla forza ed all'estenzionedell'ali : così
lo strepito che fa il calabrone è più sensibile di
quello delle mosche, perchè le ali del12
142Z E B
-----
hanno una consistenza maggiore, e per la me
desima ragione, le ali degli scarabei, che sono
crostacee , eccitano col moto che fanno un ru
more anche più forte ; laddove quello delle mo
sche Zanzare che sono più piccole, possono pro
durre nell'aria piccoli suoni acuti soltanto: final
mente, anche per la medesima ragione, il moto
delle ali delle farfalle è assolutamente sordo, per
chè le membrane onde sono formate , sono fari
nose, e rivestite di una specie di peluria . Dice
Goedard che l'aculeo delle mosche Zanzare ma
schj ha più forza di quello delle femmine .
Tutte le sorti di questi insetti, ossiano forniti
di pennacchj, o quelli che si chiamano saltato
ri, i falsi gorgoglioni del fico o del busso, so
no insetti incomodissimi , e si empiono del no
stro sangue fino alla testa. Queste due ultime
specie, delle quali il Sig. di Réaumur ha fatto
menzione, Memoria X, Tom. III, portano le ali
in tetto acutissimo. Le fibre che vi si scorgo
no sembrano composte di quadrati di talco, di
figura irregolare ed intelajati: il mezzo delle due
ultime gambe è ordinariamente posato parallela
mente alla lunghezza del corpo. --
ZAPOTE. E' lo zapote blanco degli Spagnuo
li, di cui abbiamo parlato all'articoio Saponaria
Indiana,' ,
ZARNACH . E' l'orpimento. Vedete questa
arola .
ZEBOA. Serpente dell' isola di Nera, situata
vicino a Banda nell'Oceano Orientale; è magni
ficamente dipinto a moschini rotondi e rossastri-
SO
Z E B I43
sopra tutta l'estensione dei lati; le scaglie falbe
della schiena sono seminate di macchie grandi
di un color di castagna chiaro, che formano
una specie di catena ; la testa , simile a quella
della cerasta, porta come l'impronta di uno scu
do che tira al rosso, e che finisce in due spe
cie di cornetti che vanno fino alla parte poste
riore del collo; ma queste due specie di cor
netti sono schiacciati , e non ispuntano fuori
come falsamente lo hanno creduto gli Antichi
Naturalisti; a tenore di questa idea che ne ave
vano , hanno essi dipinto il serpente in questio
ne con le corna molto prominenti; il che, al
dir di Seba, non ha alcuna verisimiglianza. Se
ba, Thes. II, Tah. 78, num. 1 . Il Rabbino Jo
seph, nel suo libro sulTalmud, cap. 1 , pag. 16,
dice che il serpente Zeboa, è lo tseboa ed il
seboim degli Ebrei. Nicandro pretende , che il
morso di questo rettile sia non solo pericolosis
simo, ma incurabile . Lo Zeboa è una cerasta o
un ammodite.
-
ZEBRO o ASINO LISTATO e SELVATICO
del Capo di Buona Speranza, Lat. Zebra aut
Equus lineis transversis versicolor, Fran. Zebre ou
Ane rayé & sauvage. Animale-quadrupede e so
lipede, più piccolo del cavallo e più grande dell'
asino; e sebbene sia stato spesse volte parago
nato a questi due animali, sebbene sia stato chia
mato cavallo selvatico ed asino listato, non è
ciò non ostante nè cavallo , nè asino; e forma
da se solo la propria specie.
Lo Zebro ha meritato l'ammirazione di tutti
i Viag
44 Z E B
i Viaggiatori. E' robusto, benissimo ha
le orecchie più lunghe di quelle del cavallo, e
più corte di quelle dell'asino; ha sei denti in
cisivi per mascella ; la criniera corta ; la pelle
di una bellezza singolare e tutto il manto è lista
to di striscie parallele che lo circondano, e che
sono alternativamente gialle e nere nel maschio;
e alternativamente nere e bianche nella femmi
na: queste striscie sono disposte con tanta re
golarità e simetria, che sembra che la Natura
abbia adoprato la riga e il compasso -per dipin
gere questo animale : in fatti queste striscie al
ternative di nero e di bianco sono altrettanto
più singolari, quanto più sono strette, parallele
ed esattissimamente separate, come in un drap
polistato, e si estendono, per altra parte, non
solo sul corpo, ma sulla testa, sulle coscie e
sulle gambe, e fino sulle orecchie e sulla coda;
secondano i contorni del corpo e n'esprimono
così vantaggiosamente la forma, che ne disegna
no i muscoli, allargandosi più o meno sulle par
ti carnose e più o meno attondate; queste liste
di diversi colori sono sempre di una tinta viva
e rilucente sopra, un pelo corto , fino, abbon
dante , liscio e morbido, il lustro del quale ren
de ancora il contrasto dei colori più sensibile . I
piedi, l'ugna solida che gli arma e la coda so
no simili a quelli della mula: le gambe sono
svelte e ben proporzionate; la punta del muso
e i piedi sono biancastri.
Questo animale produce ogni anno; va ordi
nariamente in branchi. E' leggiero al corso e co
sì
Z E B 145
sì veloce, che è passato in proverbio tra gli
Spagnuoli e i Portoghesi. Viene anche assicura
to che vi sono pochi animali così difficili a pren
dersi, a cagione della velocità con cui corrono;
e questo è ciò che li rende rarissimi e carissi
mi . Lo Zebro, benchè di un naturale assai dol
ce , è difficile ad addomesticarsi ; ne sono stati
ciò non ostante veduti quattro a Lisbona, presi
nella Bassa Etiopìa e dei quali si serviva talvol
ta il Re di Portogallo per tirar la sua carrozza;
vi si chiamavano questi animali burro domato o
azerbo .
Lo Zebro, al dir del Sig. di Buffon , è forse
il meglio fatto e il più elegantemente vestito di
tutti gli animali quadrupedi; ha la figura e le
grazie del cavallo e la leggerezza del cervo . Lo
Zebrò non è nè cavallo , nè asino; poichè non
è giunto a nostra cognizione , dice il medesimo
storico, che si congiunga e che produca coll'uno
o coll'altro; ma è stato più volte tentato di far
li accoppiare . Song state messe avanti allo Ze
bro, che era nel serraglio di Versailles nel 1761,
alcune asine in caldo; ma non n'è restato in al
cuna maniera commosso; almeno non è compar
so il segno esteriore dell'emozione; scherzava
ciò non ostante con esse e le montava, ma sen
za erezione e senza nitrito, nè si può gran fatto
attribuir questa freddezza ad altra cagione che al
la disconvenienza'di natura o di specie ; perchè
lo Zebro aveva quattro anni , ed era in tutti gli
altri esercizj vivissimo e leggerissimo . Si vede
attualmente questo Zebro in una delle sale del
Bom,T.XXXIX. K Ga
146 Z E B
Gabinetto del Re, ove la bella pelle di esso ri
veste un modello di gesso preso sullo stesso ani
male .-
Il Signor Professore Allamand riferisce, a pro
posito dell'accoppiamento di questi animali con
quelli della specie dell'asino, un fatto singolare ,
se è esatto. , Milord Clive , dice egli , ritornan
, do dalle Indie, aveva seco condotto una fem
, mina Zebro, che gli era stata regalata al Ca
, po di Buona Speranza . Dopo averla tenuta
, per qualche tempo nel suo parco in Inghilter
, ra , le diede un'asino per provare se potesse
, esservi accoppiamento tra questi due animali;
, ma la femminaZebro non volle lasciarsi acco
,, star l'asino . Venne in capo a Milord di far
, dipinger quest'asino come lo Zebro; la femmina
, dice egli, cadde nell'inganno, si fece l'accop
, piamento, e ne nacque un polledro simile al
, la madre , .-
-
Non si deve confonder lo Zebro coll'onagro,
che è l'asino selvatico che si trova in Arabia,
nel Levante, nell'Oriente dell'Asia e nella par
te settentrionale dell'Africa . Questi asini selvati
ci differiscono dai nostrali unicamente per la bel
lezza e per la forza ; hanno lo stesso colore;
ma molto più bello , e le altre qualità di essi
sono tutte abbellite dai doni della semplice Na
tura , Veiete Asino Selvatico. Lo Zebro si tro
va solamente nelle parti più Orientali e più Me
ridionali dell'Africa, dall'Etiopia fino al Capo
di Buona Speranza, e dal Capo fino a Congo .
Quelli che si veggono in altri paesi, vi sono sta-
l
Z E B147
ti trasportati, essendo il vero clima, e il suolo na
tìo di essi la punta dell'Affrica, ove si veggono in
gran numero. Gli Olandesi si sono studiati quan
to hanno potuto, di domar questi animali selvati
ci ed indocili, e di addomesticarli, senza esservi
finora intieramente riusciti. Si era pervenuto a
montare quello che era a Versailles, ma bisogna
va prendere molte precauzioni . Aveva la bocca
durissima; per poco che gli si toccassero le orec
chie, sparava coppie di calci; era ostinato come
un mulo e restìo come un cavallo vizioso . Tale
era ancora lo Zebro che noi abbiamo veduto
nel 1776 a Londra, e che apparteneva alla Re
gina . Vi è per altro tutta la probabilità che, se
si avvezzasse lo Zebro fin dalla prima età alla
domesticità ed all' ubbidienza, diverrebbe man
sueto come il cavallo e l'asino, e potrebbe far
le veci dell' uno e dell'altro .
Il Sig. Forster, che ha avuto occasione di ben
esaminar questi animali al Capo di Buona Spe
ranza, ha conosciuto in questa specie una varietà
che differisce dallo Zebro ordinario , perchè in
vece di striscie brune e nere , delle quali è li
stato il fondo bianco del pelame9 questo al con
trario è di un bruno rossastro, con pochissime
striscie larghe e di una tinta debole e bianca
stra: questi Zebri col pelo più uniforme , di fon
do bruno sono meno ritrosi, e si avvezzano fa
cilmente alla domesticità . Una tal varietà dello
Zebro porta il nome di couagga. Vedete questa
arola .
Zebro ( lo), Chetodon trioslegus, Linn., Bro
K 2 llSS. ,
143 -
Z E B
uss,, Chetodon albescens, lineis quinque transver
sis, nigricantibus, & aculeo laterali utrinque,
Seba : dagl'Inglesi, Angel-fiscb . Pesce del gene
re del chetodonte, che si trova nella parte
Orientale del mar delle Indie, nel mar Pacffi
co vicino all' isola di Taiti, e nei mari del Sud,
verso le isole Sandwich .
Secondo il Sig. Broussonnet, il corpo di que
sto pesce è schiacciato e quasi ovale ; il mezzo
della schiena e la parte posteriore del ventre esi
biscono una leggera curvatura ; le scaglie che co
prono il corpo sono piccole, ovali, ciliate all'
estremità ed imbricate , ma senza tenere alcun'
ordine; dal mezzo delle parti laterali della co
da esce - da ambedue i lati un pungiglione un
poco triangolare, incavato in canale, mobile ed
inclinato verso la testa; le linee laterali sono
parallele alla schiena, la testa è schiacciata ai
lati , grossa come il corpo nella parte posteriore,
più sottile anteriormente , convessa sopra e sot
to , dilatata tra gli occhj : l'apertura della bocca
è stretta ; le labbra coprono da una parte e dall'
altra i sedici denti dei quali sono armate ambe
due le mascelle ; i due denti anteriori sono i
più grossi, e non sono nè tronchi , nè merlati
come gli altri: l'apertura dell'una e dell'altra
narice è doppia ; gli occhj sono situati molto in
alto, e di una forma orbiculare; e le orbite di
essi sono prominenti innanzi e coperte in par
te di una membrana cutanea di color bruniccio
e che sbatte ; le iridi sono di una tinta d'argen
to; ma . offuscata in cima e in fondo da alcune
spe“
Z E B 149
specie di nebulosità; la pupilla è di un nerotur
chiniccio : gli operculi sono leggermente squa
mosi : la natatoja dorsale è lunghissima e guar
nita di trentadue raggi, i nove anteriori dei qua
li sono spinosi , ed il primo , il più lungo ; le
pettorali ne hanno quindici per ciascheduna ; le
abdominali, che hanno una forma quadrangola
re, ne hanno sei per ciascheduna, il primo dei
quali è spinoso; quella dell'ano ne ha ventidue,
i tre anteriori dei quali sono spinosi; quella del
la coda, che è leggermente incavata, ne ha di
CIOttO a- -
Questo pesce è di un color bigio verdiccio ,
dipinto di sci fascie circolari di un bruno gial
lastro: la prima si estende obliquamente dalla
nuca fino alla bocca passando sugli occhj; la se
conda comincia all'origine della natatoja dorsale,
passa alla base delle pettorali e si prolunga fino
alle abdominali ove si oblitera; la terza regna
dal terzo della natatoja dorsale fino alla parte
anteriore della base della natatoja dell' ano; la
quarta striscia comincia ai due terzi della nata
toja della schiena e finisce al mezzo di quella
dell'ano ; la quinta regna dall'una all'altra estre
mità di queste due natatoje ; finalmente , la se
sta è sulla coda e corrisponde al pungiglione di
questa medesima parte negl' individui giovani;
quest'ultima striscia ha due macchie in cima; le
natatoje abdominali sono biancastre, e le altre di
tan verde sporco .
Zebro di Mare, Pleuronectes (Zebra ), oculis
dextris, linea laterali recta, fascis fuscis transver
K 3 sis . "
15c Z E B-
ad
sis. Questa specie è del genere del Pleuronette,
e si trova nei mari delle Indie Orientali: il
corpo è ovale, lunghissimo e coperto di scaglie
dentellate ; ha una narice sola; le natatoje petto
rali sono piccole ; la parte superiore del corpo
è bruniccia, e bianca in mezzo al tronco, con
fascie brune trasversali; le natatoje esibiscono
alcune listarelle ora gialle, ora brune; la mem
brana che congiunge i raggi delle diverse nata
toje, non è guarnita di scaglie come nelle al
tre specie di questo genere. -
zebro. Si dà questo nome, eome anche quel
lo di asino listato, a una conchiglia che si dice
essere o terrestre o fluviatile, quando è sottile
e leggiera; marina, quando è pesante e grossa.
Queste cenchiglie sono della famiglia dei bucci
ni. Vedete Buccina.
ZEBU'. Piccola specie di bisonte o di bue col
gobbo . che si trova comunemente in Numidia,
in Libia ed in alcune altre parti settentrionali
dell'Africa, e particolarmente nelle terre dei Mo
rabitani. Ha la metà della grossezza del nostro
toro domestico; le gambe corte, il pelo morbi
dissimo, bellissimo e biancastro; le corna sono
nere, curvate in giro e pulite; le ugne dei pie
di sono nere e ben fendute : serve questo ani
male di cavalcatura nel paese. E' mansuetissimo
e docilissimo, e velocissimo nel tempo stesso al
corso. Sembra, dalla varietà del pelo e dalla
dolcezza di questo animale, che sia una razza di
bue col gobbo che ha avuto origine nello sta
to di domesticità, e che siano stati scelti g' in
di
Z E C 15 I
mamma
dividui più piccoli della specie per propagarla .
Lo Zebù non può esser riguardato, secondo il
Sig. di Buffon, che come una varietà dell'auro
chs, che è il toro selvatico, come si può vede
re all'articolo Aurochs.
Si danno in Africa allo Zebù i nomi di dant
o lampt . Questo dant, proprio all'antico Conti
nente , non deve esser confuso col dante diAme
rica, che è il tapir. Vedete questa parola. Nel
1774, si vedeva uno Zebù nel serraglio di Ver
sailles. Si prendono questi animali più facilmente
in estate , perchè logorano le ugne sulle arene
infuocate a forza di correre, e perchè il dolore
gli arresta tutto ad un tratto , come accade, al
dir di Marmol, ai cervi e ai daini di questi de
serti . Le pelli concie degli Zebù sono carissime;
e se ne fanno targhe assai belle, le migliori del
le quali sono alla prova delle freccie . Vedete
Bisonte.
ZECCA, Lat. Acarus, Fran. Tique . Genere
d'insetto assai numeroso, ed in cui molte specie
sono troppo piccole per esser facilmente distin
te, anche col microscopio. Generalmente leZec
che hanno otto gambe, la testa piccolissima, due
occhi, le antenne semplici e più corte della trom
ba aguzza, che forma la bocca di questo anima-
letto ; il corsaletto sembra confuso col ventre .
Questi piccoli insetti pullulano molto e proven
gono dall'uovo. Molte specie di Zecche sono car.
nivore, altre vivono di vegetabili . I cani, gli
uccelli, le mosche , i coleotteri sono soggetti a
diverse Zecche , che, alcuni Autori hanno mala
K 4 IIlen
152 Z E C
nente disegnate ( al dir del Sig.Geoffroy, Com
pendio storico degl'insetti ) col nome di pidocchj.
Dice lo stesso Insettologista che una delle più
schifose e delle più insopportabili infermit a cui
vada l'uomo soggetto , sembra che debba unica
mente attribuirsi a certe piccole Zecche o pelli
celli, i quali insinuandosi nella pelle vi cagio
nano quei furiosi pruriti che accompagnano la
rogna.
-
Si distingue : 1 . La Zecca dei cani, Lat. Rici
nus caninus. E' di color bruno giallastro ; quan
do si attacca ai cani , le si gonfia il ventre sol
tanto. Si vede spesse volte pendere dalle orec
chie, e talvolta dagli angoli delle palpebre dei
cani da caccia, che vanno nei boschi ingombri 3
sono da essa crudelmente tormentati; e potrebbe
anche avere conseguenze funeste , se non si di
staccasse sollecitamente .
La Zecca si attacca anche agli uccelli . Ai 28
di maggio del 1779, il Sig. Visconte di Quer
hoent trovò una femmina di passero nella cam
pagna, vicino a Querande, a cui più non resta
va che un soffio di vita; la raccolse , e rimase
all' estremo maravigliato di trovarle attaecata al
collo una Zecca della grossezza di un grosso pi
sello, che indubitatamente l'aveva fatta morire .
2 . La Zecca o Pellicello della rogna, Lat. Aca
rus scabiei , aut subcutaneus , Fran. La Tique ou
Ciron de la gale. E' quasi impercettibile ; s'intro
duce sotto la pelle, produce le piccolevessichet
te che si trovano sui rognosi; e possono estrarsi
von una punta di spilla; resta allora spesse volteInn
Z E C153
--
immobile; ma corre velocissimamente se si risca
di col fiato. Siccome quest'insetti si annidano
talvolta nelle vesti dei rognosi, è facile a com
prendersi che la rogna deve facilissimamente co
municarsi . Vedete Pellicello .
3 . La Zecca o Pellicello del formaggio e della
farina, Lat. Acarus casei et farine. Le si dà co
munissimamente il nome di tarma. Vedete questa
parola.
4. La Zecca, o il Tessitor d'autunno, Lat.
Atcarus fuscus autumnalis, textor. Pretende il Si
gnor Geoffroy che fili una tela come i ragni ,
e che quello che vien chiamato in Francia dal
popolo i fili della Vergine, siano le tele fine ,
ordite da questa specie d'insetto. Vedete ciò non
ostante ciò che ne abbiamo detto all'articolo Ra
gno Falciatere, e a quello di Filo della Vergine.
5. La Zecca dei paesi caldi, e che particolar
mente in America, fa sentire ai piedi e alle
gambe dell'uomo, la sua crudele voracità, è l'in
setto chiamato Chique. Vedete questa parola e
quella di Ningas.
Il Sig. Muller dà il nome di Zecche acquati
che , ovipare , che vivono di rapina, e che han
no qualche somiglianza per la forma colle Zec
che e coi ragni.-
6. La Zecca del Pollame, chiamata karapate.
Nell'isola di Borbone ed in altre isole dell' In
dia , si dà quest' ultimo nome a una specie di
Zecca, ordinariamente nera, che ha sulla schie
na una specie di scaglia con tinte di giallo e di
rosso. I karapati più grossi sono come una len
tC
154 Z E D)
ticchia ; hanno la testa esattamente incastrata nel
la pelle del pollame, e se ne vede solamente il
deretano, sempre grosso e zeppo del sangue che
succhiano. Le galline che l'hanno, lo indieano
coll'imbarazzo in cui sono di accostar le ali al
corpo, che per lo più n'è coperto ; per la di
varicazione delle gambe, etc. Per altra parte ,
l'ispezione è il mezzo più sicuro di convincer
sene, E'cosa molto difficile il distruggere questo
animaletto, entrato che sia una volta nel polla
jo, Si stanzia sotto la scorza del legname che
lo compone, pullula dappertutto e si moltiplica
prodigiosamente. Il Sig. Beauvais, Professore di
Medicina veterinaria, dice non essersi finora tro
vato altro mezzo che quello di bruciare il polla
jo , e di farne uno nuovo, che si trova talvolta
nello stato del primo, in capo a sei mesi . Con
sultate la Memoria del Sig. Beauvais , Giornale
di Fisica, Supplemento, Tomo XIII, 177S.
ZEDOARIA , Lat. Zedoaria, Fran. Zedoaire .
Si distinguono nelle Farmacopèe , sotto questo
nome due sorti di radiche ; cioè, la Zedoaria lun
ga e la rotonda. --
La Zedoaria Lunga, Zedoaria longa, C. B.; ze
doaria Officinarum . E'una radice tuberosa, den
sa, solida, lunga tre pollici e della grossezza del
dito mignolo , terminata alle due estremità da
una punta ottusa, di color di cenere fuori, bian
castro o bigiccio dentro, di un sapore acre, mu
cilaginoso, un poco amaro, aromatico, di un
odor leggiero di Zenzero o di canfora, misto di
odor di lauro ; è quasi grassa al tatto e rare
volte tarlata. La
Z E D I55
-aaaaaa
La Zedoaria Rotonda, Zedoaria rotunda, C. B.
E' simile alla precedente per la sostanza, il pe
so, la solidità, il sapore e l'odore, e ne diffe
risce unicamente per la figura; perchè è orbi
eulare e della grossezza di una noce mezzana ,
un poco bitorzoluta, e che finisce talvolta in
punta piccola , per la quale suol germogliare
quando è ancora nel terreno. Questa è più ra
ra della precedente; ed ambedue vengono dalla
China .-
-- -
Dicono alcuni Botanici, che la Zedoaria è la
radice di una pianta che si chiama malan-kua o
zadura herba, nel Malabar, ( cresce ancora in
altre contrade dell'India, a Ceilan e nelle Mo
lucche; ) aggiungono che questa radica bulbosa
è coperta di una membrana coriacea, e che è ac
compagnata da parecchi altri bulbi ovoidi, in nu
mero di sei , situati a due a due gli uni su gli
altri, lisci e fibrosi. Sorge dalla cima della radi
ce un'asticella terminata da una guaina bianca ,
membranosa, come nello zafferano, e nella quale
sono rinchiusi quattro o cinque fiori di tre o sei
petali, della lunghezza del dito e listati di diver
si colori: questi fiori hanno un' odore anche più
grato di quello della viola e dei gigli ed escono
dal terreno prima delle foglie; caduti i fiori, se
ne gonfia il calice e diviene una capsula che con
tiene i semi: le foglie sono lunghe un palmo, as
sai larghe, appuntate, liscie, piane, di un verde
gajo, di un sapore e di un' odore di zenzeroy
sostenute da una coda grossa e cortissima , che
con una base larga e in certa maniera frondosa
l
156 Z E D
involge il fusto, e dà origine a una costa che
traversa la foglia in tutta la lunghezza : i fusti
hanno appena un braccio di altezza .
Il Sig. Herman, nel suo Catalogo del Giardino
di Leida, parla di un' altra specie di Zedoaria,
che chiama Zedoaria Zeylanica, camphoram redo
lens. E' l'harankaha del Ceilan : ha le foglie da
una parte di un rosso di porpora oscuro; le code
delle foglie , che hanno la forma di una chiglia
di vascello, sono di un rosso oscuro ed un poco
irsute , ed escono immediatamente dalla radice e
non dal fusto . Sembra finalmente che le Zedoarie
siano Zenzeri selvatici. Quella di radice lunga è
strisciante , serpeggiante, a poca profondità, no
dosa e giallastra ; le foglie sono poco larghe ,
ensiformi ed appuntate . Quella di radice, poco
lunga è tuberosa e bianca, ha le foglie grandi ,
ovali, ensiformi .
Si legge nella Materia Medica del Sig. Geof
froy, che la Zedoaria distillata coll'acqua comu
ne, dà un' olio essenziale , denso e spesso, che
si coagula e prende la forma della canfora più
fina. Questa radica è buona contro i veleni , le
morsicature degli animali velenosi e contro la
peste ; ma è uno specifico più certo contro le
coliche isteriche delle donne; è al maggiorsegno
sudorifica , espelle le flatulenze, fortifica lo sto
maco, ferma il vomito e rianima la circolazione
del sangue . E' utilissima nelle malattie scorbuti
che e nelle affezioni che tendono all'apoplesia ed
allaparalisia : si usa mescolandone la polvere con
lo zucchero e colle polveri dell'acoro , della
Il CI
Z E MI 157
nella, dell'ambra grigia e col balsamo del Perù.
Vi è l'usanza nell'isola di S. Lorenzo, di far in
confezione con lo zucchero questa radice ancora
fresca, ed in tale stato se ne fa l'uso che si fa
dello Zenzero .-
ZEMNI o ZIEMNI . Specie di donnola o di
grosso topo delle provincie del Nord , e che si
trova più particolarmente in Polonia e in Russia,
come anche il zizel, al dire del Sig. di Buffon ,
ma lo Zemni.è più grande, più forte e più ma
ligno: è un poco più piccolo del gatto domesti
co; ha la testa assai grossa, il corpo sottile, le
orecchie corte e ritondate, quattro gran denti in
cisivi che gli escono dalla bocca ; e i due denti
della mascella inferiore sono, tre volte più lunghi
di quelli della mascella superiore: i piedi sono
cortissimi e rivestiti di pelo, divisi in cinque di
ta , armate di ugna curve; il pelo è morbidet
to , cortoe di color bigio di sorcio; la coda è
mediocremente - grande; gli occhj piccoli e na
scosti come quelli delle talpe : lo Zemni ha ap
presso a poco il medesimo naturale e le medesi
me abituazioni che l'hamster e lo zizel . Vedete
queste parole : morde pericolosamente ; mangia
con avidità e devasta le messi e gli ortaggi ; si
fa una tana che scava assai profondamente; vive
di grani, di frutti e di legumi , dei quali fa
provvisioni e magazzini che ammucchia nel ri
covero in cui passa tutta la stagione dell'inver
no . Alcuni Autori gli hanno dato il nome di
egnuolo di terra . E' il canicula subterranea di
zaczinsky.
ZEN
158 L E N
*---
ZENDEL, ZINGEL, o KOLEZ, Lat. Lacer
tus (piscis) peregrinus, fluviatilis . Questi nomi
tedeschi ed nngheri disegnano un pesce del Da
nubio che , al riferir di Rondelet, è stimatissi
mo; n'è delicata la carne ese ne veggono molti a
Vienna. LoZendel è della grandezza del carpio,
ma largo , spesso, bianco, simile alla trota sal
mone, ed ha le scaglie come il carpio . Questo
pesce si trova parimente nel fiume Isen ed in
molti laghi e fiumi della Germania,
ZENIT. Vedete il significato di questa parola
all' articolo Globo .
ZENLIE . Al Capo di Buona Speranza, è lo
sciacal. Vedete questa
ZENZERO , Gingiber, C. B. e Pison; An
choas, Hernand. ; Katou- inchi - kua . Hort. Ma
lab. : Amomum, Zingiber, Lin., Fran. Gingem
bre. Nel commercio delle spezie , si dà questo
nome a una radica secca che gl' Indiani chiama
no Zingibel, e che è tubercolosa, nodosa , ra
mosa , un poco schiacciata , lunga e larga come
il dito mignolo; la sostanza n'è resinosa, un
poco fibrosa , rivestita di una corteccia bigia ,
giallastra ; la carne o polpa della radica è rossa
stra, bruna, di un sapore estremamente acre ,
caustico, aromatico, come il pepe, di un' odor
forte assai grato . Ci vien recata secca dalle An
tille , e segnatamente dalla Guadalupa e dalla
Giammaica, ov'è presentemente coltivata con
gran diligenza; ma cresce naturalmente nelle In
die Orientali, al Malabar, al Ceilan, a Amboi
na, alla China , ed in abbondanza specialmente
nel
Z E NI 159
-ro
nelle montagne delle vicinanze di Gingi, d'onde
verisimilmente ha ricevuto il nome che porta .
Lo Zenzero della China passa pel migliore .
La pianta che nasce da questa radice ha gran
dissime relazioni con quella del gran cardamomo,
e per conseguenza con gli amomi . Mette tre o
quattro fusticelli rotondi , e grossi come il dito
mignolo di un fanciullo , rigonfi e rossi alla ba
se, verdastri nel rimanente della lunghezza. Tra
questi fusti, alcuni sono guarniti di foglie, gli
altri terminano in una massa squamosa ; i fusti
frondosi sono alti due piedi incirca, e sono uni
camente formati dalla parte delle foglie che si
abbracciano: le foglie sono in gran numero, al
terne, spiegate per tutte le direzioni, e simili a
quelle della canna , ma più piccole . I piccoli
fusti che terminano in massa hanno appena un
piede di altezza ; sono circondati e coperti di
piccole foglie verdastre e rossigne alla punta .
La massa che termina ogni fusto è di una bel
lezza grande; perchè è tutta composta di squa
me membranose, di un rosso dorato , o verda
stre o biancastre; dall'ascella di queste squame
escono fiori che si aprono in sei pezzi aguzzi,
in parte pallidi, ed in parte di un rosso cupo
e picchettato di giallo: i fiori durano appena un
giorno, e si aprono successivamente uno dopo
l'altro . Il pistillo che sorge dal mezzo termina
in clava, il che ha dato occasione ad alcuni Bo
tanici di chiamar la pianta del Zenzero, piccola
canna col fiore a clava. La base del pistillo di
viene un fiore coriaceo, bislungo, triangolare a
tre
1 6o-
Z E IN
tre celle piene di molti semi nericci, di un sa
pore aromatico, amaro e di un grato odore .
Le masse hanno un'odor penetrante . Questa
pianta non viene in Europa se non che nei giar
dini nei quali è coltivata. Nasce ugualmente, per
la coltivazione in ambedue le Indie . Abbiamo
già detto che non è naturale all'America ; è es
sia stata portata dalle Indie Orientali o dalle
isole Filippine nella Nuova Spagna e nel Brasi
le : non n'è nè difficile , nè dispendiosa la col
tivazione ; basta lasciarne alcuni germogli in
terra affinchè moltiplichi di nuovo; in mancan
za di questi figliuolami,-se ne pianta il seme in
una terra grassa, umida e ben coltivata .
Si raccoglie ogni anno un'immensa quantità
di radiche di Zenzero, sulle quali si sono secca
ti i fiori : quattro mesi dopo che sono stati pian
tati i pezzi delle radiche, se ne toglie la cor
teccia esteriore ; si mettono in una salamoja,
perchè vi macerino per una o due ore ( nei
contorni di Cajenna, si fanno bollire); si cava
no da questa lissiva, e si espongono per altret
tanto spazio di tempo all'aria e al coperto dal
sole, quindi si stendono al coperto sopra una
stuoja , finchè si sia dissipata tutta l'umidità : si
mettono talvolta nelle stufè e si conservano lun
go tempo .
Gl'Indiani rapano la radica di Zenzero nei
loro brodi , intingoli ed insalate, e ne fanno
una pasta contro lo scorbuto . I Madagascariani,
gli Ottentoti e gli abitanti delle Isole Filippine
e mangiano in insalata le radiche fresche , ta-
glian
Z E N 16
gliandole a pezzetti, con altre erbe condite con
sale, olio e aceto . A Cajenna queste radiche ,
colte di fresco, si danno in tavola a modo di
rape, senza altra preparazione che quella di la
varle. I Brasiliani ne usano in masticatorio, co
me un potente prolifico; sogliono ancora farle
in confezione con lo zucchero, quando sonofre
sche , pel dessert; e principalmente per risve
gliar l'appetito ai convalescenti: presentemente
se ne fanno marmellate e paste , e ce ne ven
gono mandate in Europa in tal maniera prepa
rate , che hanno un color giallo , e sono di un
sapore assai grato. Questa confezione è di uso
nella navigazione. Dice il Sig. Bourgeois che lo
Zenzero, stato in infusione nell'aceto , gli dà mol
to risalto, e lo rende grato nelle insalate; vi si
aggiunge ordinariamente il pepe di Spagna, o
pepe grosso, il pepe lungo e il piretro .
Gl' Indiani riguardano lo Zenzero fresco co
me uno specifico per le coliche , la lienterìa,
le diarrèe ostinate, i dolori di ventre, ed altri
mali di questa natura, e lo masticano per facili
tare lo spurgo , quando i reumi sono ostinati .
E' stato riconosciuto che questa radica riscalda i
vecchj, dà ciò che i Medici chiamano pudica
mente magnanimità, chefortifica lo stomaco, che
ajuta la destione , e che fortifica la memoria e
il cervelli. E'un buon carminativo ed alessifar
maco , che eccita potentemente all'amore; ma è
d'uopo moderarne l'uso , quando il sangue è
troppo bollente; perchè lo accende più di quel
lo che non lo calmi,
L
162 Z E O
Lo Zenzero secco è la base delle spezie. Si
dice che molti Droghieri se ne servano per falsifi
care il pepe, e che n'è considerabilmente diminui
to lo spaccio in Francia: sempre èvero però che
se ne consuma annualmente in Europa , quasi un
millione di libbre di Francia. Si dà il nome di Zen
zero selvatico alla Zedoaria . Vedete questa parola -
Generalmente, le piante della famiglia degli
Zenzeri , come il costo, la curcuma, il pacocero
ca, il karatas , l'anana , la musa , &c. Sono
tutte, come le palme, straniere all' Europa , e
particolari ai climi più caldi; sono perenni per
le sole radiche, che sono carnose , serpeggianti
poco profondamente, fibrose, e come genicula
te o anulate . I getti giovani formano, alle estre
mità delle radici una specie di tubercolo coni
co , coperto di scaglie imbricate, e che altro
non sono, come nelle palme e nelle gramigne ,
che appendici di foglie imperfette; il fusto è or
dinariamente semplice e senza ramificazioni; le
foglie sono senza dentature; i fiori, ermafroditi,
disposti in umbella, o in ispiga, o in panico
lo, sostenuti da un peduncolo squamoso e accom
pagnati da scaglie diversissime dalla spata o dal
seme delle palme : la polvere fecondatrice è com
posta di globuli assai grossi, biancastri e rilucenti.
zenzero bastardo. E' il balisiere. Vedete questa
arola .
ZEOLITE , Zeolitus, Il Sig. Cronstedt ha dato
il nome di Zeolite a una nuova sostanza che co
stituisce da se sola un nuovo ordine nelle pietre
che si chiamano semplici, e di cui ha fatto men-
Z1O
Z E O-
163
zione nelle Memorie di Stockolm Tom. XVIII,
anno 1756. Questa sostanza, esaminata col fuo
co , dice quest'Osservatore, esibisce fenomeni
che la distinguono da tutte le pietre conosciute .
Ne ha egli ricevuti alcuni saggi o mostre da due
luoghi diversi: uno che proveniva dalla miniera
di rame di Swapawara nella Lapponia da Tor
nèo , era di un giallo chiaro, e questo pezzo
sembrava formato di piccoli cilindri composti in
teriormente di parti piramidali , o di aghi le som
mità dei quali si univano in un centrò: l'altra
mostra, che veniva dall' Islanda, era biancastra,
in parte composta di particelle compatte come la
creta, ed opache, ed in parte di cunei concentri
ci, disposti senz' ordine e trasparenti.
La Zeolite ha almeno la durezza dello spato or
dinario, non dà scintille quando è percossa coll'
acciarino , e non fa effervescenza con gli acidi :
esposta alla fiamma della lampada degli smaltato
ri, si gonfia e sobolle come il borace, in seguito
si cangia in un vetro bianco trasparente , dopo
avere sparso una luce fosforica . Finalmente la
pietra che più si accosti alla Zeolite è una spe
cie di schorl ; ma la fusione non n'è accompa
gnata dalle medesime circostanze. Vedete Schorl .
Sembra che la Zeolite differisca ancora poco
per l'analisi dalle sostanze minerali, delle quali
abbiamo parlato sotto i nomi di gelata minerale
e pietra spumante. Vedete queste parole. Quando
questi due corpi fanno subitamente effervescenza
con gli acidi o vitriolici o nitrosi , ciò accade
perchè sono intonacati strato di terra cal
2 C2
164 Z E O
aaaaaara
care, o piuttosto di una materia che ha affinità
con questi acidi, che li colorisce di un rosso di
corniola, e dà ad essi in poco tempo una consi
stenza simile a quella dell'amido o di una gela
tina tremula e trasparente . Del rimanente, l'ef
fervescenza cessa ad un tratto, e si vede il li
quore coagulato formare alla superficie certe pic
cole eminenze coniche, composte di raggi che
divergono dal centro alla circonferenza; in una
parola, questa specie di gelatina è molto simile
a quella che si otterrebbe col medesimo processo,
se si versasse l'acido vitriolico allungato sopra
una specie di vetro polverizzato e prodotto da
un miscuglio di argilla bianca e di calce smorzata.
Non insisteremo sulle circostanze chimiche che
il Sig.Swab ha minutamente descritte su questo
soggetto, nel Tomo XX. dei Dotti di Svezia, anno
a758, e ci limiteremo soltanto a dire, che la ge
lata di cui si tratta, e la quale sembra che costi
tuisca il carattere di questo genere di pietre, di
viene sempre più viscosa, tenace e compatta, ed
acquista finalmente la consistenza di una pietrafra
gile e piena di screpoli; nelle fratture, è rilucen
te e si divide in ischeggie , come il vetro o la
ietra focaja : tutto ciò può dar qualche idea sul
formazione delle pietre focaje .
Avendo esaminato le diverse sorti di Zeolite,
che il fu Sig. Presidente Ozier ha portato dal
Nord, e quelle che il Re di Svezia e il Re di
Danimarca hanno mandato a S. A. S. il Signor
Principe di Condè, e la collezione delle quali ,
meno considerabile di quella del Sig. Ozier , è
nondimeno molto varia per le forme e pei co
Z E O 165
lori, ci è sembrato che queste Zeoliti raccolte a
Edelfors in Smolandia, a Gustafs-Grufvan, in
Jemtland, a Swapawara in Lapponia, etc., etc.,
avessero molta somiglianza con gli spati fusibili,
striati e di diversi colori, che noi abbiamo rac
colto nei Vosgi . Molti di questi pezzi di Zeoli
te sono composti di fibre o raggi fittissimi gli
uni addosso agli altri, e distribuiti in più fastel
li, e divergono da un punto comune appresso a
poco come l'asbesto stellato, che altro spesso non
è che una specie di schorl pietroso . Noi abbia
mo parimente osservato, che si trovano molte
Zeoliti sulle rive dell'isola di Schepy, dipenden
te dall'Inghilterra. Alcuni Naturalisti Inglesi dan
no a questa pietra il nome di lusus naturae. La
Zeolite finalmente ci sembra che sia semplicemen
te una specie di spato fusibile, in cresta di gal
lo o in istrìe .
Giunge a nostra notizia che siansi ultimamen
te scoperte Zeoliti anche in una caverna del Mar
graviato di Brandeburgo , vicino a un villaggio
chiamato Gailenreuth , e che il Sig. Pasumot ,
Ingegnere Geografo del Re ne ha riconosciuto
alcune strie nel peperino ( terra bruciata) rac
colto sulla famosa montagna vulcanizzata di Ger
govia , in Alvernia, e crede che la Zeolite sia
una produzione formata dalla decomposizione di
una terra vulcanizzata. -
Risulta finalmente dalle esperienze chimiche, re
centemente fatte sulla Zeolite d'Islanda, dal Sig.
Meyer, che questa sostanza è un composto di
terra quarzosa, di terra calcare e di terra base
-
L 3 dell'
i66 Z E R
dell'allume, nella proporzione del peso della me
tà di terra quarzosa, di due sesti di terra di al
lurne e di un sesto di terra calcare con sale al
cali minerale.
Il Sig. Monnet, che ha fatto anch'egli l'esame
della Zeolite d'Islanda , ha riconosciuto la terra
base di allume che è argillosa , e il quarzo in
parti uguali. Conviene anch'egli che vi è una
perfetta analogia tra la dissoluzione della Zeolite
e quella che si ottiene dal liquor di selci , ( li
quor silicum) dopo avervi sopra versato l'acido :
il precipitato dell'uno e dell'altro è quarzo. Il
Sig. Monnet è d'accordo col Sig. Swal, quando
dice che l'acido nitroso è il vero dissolvente del
la Zeolite, e che agisce molto più presto su que
sta pietra che l'acido vitriolico. Si vede da ciò
che è il contrario di quello che accade allo schorl
pietroso; l'acido vitriolico ha un azione molto
maggiore sopra di esso che non l'acido nitroso.
Finalmente il dotto Sig. Bergman, Chimico Sve
dese , sospetta che la Zeolite sia un prodottovul
canico e che molto se ne trovi nelle vicinanze
delle montagne ignivome . “
ZERUMBETH. Lat.Zerumbethum. E' una radi
ca rarissima nelle Spezierie, tuberosa, genicula
ta, disuguale, grossa come il pollice e talvolta
molto più, un poco ”schiacciata, di un bianco
giallastro, di un sapore acre di zenzero e di
un' odore di zedoaria. Questa radica nasce da
una pianta che si chiama Zingiber latifolium syl
vestre, Herm.; Amomum zerumbeth, Linn. E'
il Wallinghurù di Ceilan, e, secondo alcuni, il
pa
Z E R 167
paco-ceroca del Brasile. ( Dice il Signor Deleuze
che i Botanici fanno un genere particolare del
paco-ceroca, sotto il nome di Alpinia.) Vedete
Paco-c'ergica .-
Quando la radica dello Zerumbeth è ancora
dentro il terreno, è simile, al dire del Signor
Geffroy, Materia Medica, a quella della canna;
ma di una sostanza tenera e rossigna; è fibro
sa; mette un fusto alto cinque piedi incirca ,
grosso un pollice, cilindrico, formato semplice
mente dalle code delle foglie che si abbracciano
alternativamente ; le foglie sono in numero di
nove o dieci, disposte a destra e a sinistra,
membranose, della medesima figura, della mede
sima grandezza e della medesima consistenza che
quelle del balisiere ordinario, rossigne e ondate
nel giro, di un verde chiaro sopra, e di un
verde cupo e rilucente sotto; dalla stessa radice
e vicinissimo a questo fusto, escono altri fusti
celli di color di scarlatto, alti un piede e mez
zo incirca, grossi quattro pollici, e coperti di
piccole foglie, strette ed appuntate, dalle ascelle
delle quali escono fiori di un bel rosso, che
sono disposti come in ispiga o in piramidi, e
composti come di tre tubi posti uno sull'altro :
finalmente, il calice, che portaun pistillo allun
gato, diviene un frutto ovoide della grossezza
di una susina, polputo, cavo in maniera di um
bilico, rosso fuori e pieno di un sugo dello stes
so colore; si apre in cima in tre parti, ed è
pieno di molti semi rossi ed annicchiati dentro
una polpa filamentosa.
L 4 Sem-
68 Z I B
Sembra che questa pianta si trovi in ambedue
i Continenti : cresce alle Indie Orientali, e si
vuole che si trovi abbondantemente anche nelle
foreste umide e lungo i ruscelli nell' Isola di
S.Vincenzo, verso il sito che i Caribi chiamano
olaiou : il frutto di questa pianta è, per quello
che si dice, un alimento gratissimo pei buoi e
per gli altri animali da soma . Il sugo , secondo
il P. Plumier, applicato sulla tela, le dà un co
lor violaceo indelebile .
La radice dello Zerumbeth contiene appresso a
poco i medesimi principi che quella della zedoa
ria ; le sue proprietà medicinali sono quasi le
stesse : si usa principalmente lo Zerumbeth per
la lienteria, e per eccitare i mestrui tardi . La
radica secca e ridotta in farina, perde molto di
sua acrimonia, ed è anche buona per farne una
specie di pane , di cui si alimentano gl' Indiani
in tempo di carestia . La mucillagine che si tro
va negl' interstizi della testa squamosa, si risente
un poco della virtù di questo aroma .
Si vede da ciò che abbiamo finora esposto ,
che lo Zerumbeth è la radica di una pianta che
può riguardarsi come uno zenzero selvatico, e
che è una specie di zedoaria. Vedete questa pa
rola.-
ZIBELLINA . Vedete Martora Zibellina.
ZIBETTA . Vedete l' articolo Zibetto .
ZIBETTO, e ZIBETTA , Lat. Animal Zihethi
cum, Fran. Civette & Zibet. I Naturalisti han
no per la maggior parte creduto che vi fosse una
sola specie di animale che dasse il profumo che
Si
Z I B169
si chiama parimente Zibetto; ma noi abbiamove
duto, siccome anche il Sig. di Buffon , due di
questi animali, che si somigliano veramente, pei
rapporti essenziali della conformazione, tanto all'
interno, quanto all'esterno; ma che differiscono
ciò non ostante l'uno dall' altro per un numero
di altri caratteri, grande abbastanza , perchè pos
sano riguardarsi come costituenti due specie real
mente diverse . -- --
L'animale che in Francia si chiama Civette
(Zibetta), è originario di Africa, e si chiama
Kastor nella Guinèa . Lo Zibetto è verisimilmen
te la Zibetta dell'Asia, delle Indie Orientali e
dell'Arabia. Differisce dalla Zibetta pel corpo più
allungato e meno grosso, pel muso più fino, più
schiacciato, e un poco concavo nella parte supe
riore : ha parimente le orecchie più elevate e più
larghe; la coda più lunga e meglio dipinta di
macchie e di anelli ; il pelo molto più corto e
più gentile ; non ha criniera, cioè, pelo più lun
go sul collo che in altra parte, nè lungo la spi
na del dorso; non ha nero sotto gli occhj , nè
sulle guancie ; caratteri tutti particolari e rimar
chevolissimi nella Zibetta .
La Zibetta è l'animal Zibethi, di Cajus, in
Gesnero; il Viverra cauda annulata, di Linneo;
il meles fascis & maculis albis, nigris & rufe
scentibus variegata, del Sig. Brisson . -
Lo Zibetto sembra al Sig. di Buffon che sia
lo stesso animale che quello che è stato descritto
dal Sig. de la Peyronie , sotto il nome di ani
mal del muschio, nelle Memorie dell'Accademia,
17o Z I B
anno 1731 . Le differenze che egli vi ha osserva
te erano così leggiere che potrebbero benissimo
non esser altro che varietà accidentali, alle qua
li le Zibette debbono essere più sottoposte degli
altri animali selvatici ; poichè si allevano e si
mantengono come gli animali domestici, in mol
ti luoghi del Levante e delle Indie.-
Si chiamano questi animali gatti muschiati o
gati zibette, Felis zibethina ; ciò non ostante
non hanno nulla di comune col gatto, fuorchè
l'agilità del corpo, e sono piuttosto simili alla
volpe, specialmente per la testa; hanno il pela
me segnato a liste e a macchie che li fanno com
parir simili da lungi alle piccole pantere, dalle
quali differiscono per tutti gli altri capi . Hanno
qualche somiglianza colla ginetta, la quale, co
me la Zibetta, ha una borsa in cui si filtra un'
umore odoroso, ma il profumo di cui è debo
lissimo e di poca durata; quello delle Zibette,
al contrario, è fortissimo; e quello dello Zibet
to è ancora più violento e più vivo. Al fine del
presente articolo noi parleremo della ginetta,
onde far meglio conoscere questi animali che
hanno un'analogia così grande, mettendoli sotto
gli occhj, secondo il nostro piano ordinario, sot
to un medesimo punto di vista .
La Zibetta e lo Zbetto sono animali propri ai
climi caldi dell'antico Continente, ed hanno ap
presso a poco le medesime abitudini naturali .
Quelli che si trovano in America, vi sono stati
trasportati ;, perchè questi animali, sensibili al
freddo, non hanno potuto passare da un Conti
nel ,
Z I B171
nente all'altro per le terre del Nord. Siccome
le cose che dobbiamo dire di questi animali so
no ad essi comuni, e sarebbe almeno difficile
l'applicarle ad uno piuttosto che all'altro, noi li
disegneremo più precisamente sotto il solo nome
generale di Zibetto .
Lo Zibetto maschio, all'esterno, non si può
distinguere dallo Zibètto femmina . Sono essi tal
mente simili, per tutto ciò che comparisce fuori,
che non vi è neppure alcuna distinzione apparen
te di sesso . Il maschio ha le parti che ad esso
sono proprie, nascoste e rinchiuse dentro; il va
so o il ricettacolo del liquore odorifero, l'aper
tura del quale era stata presa dagli Antichi per
caratteristica del sesso della femmina, è affatto
simile nell'uno e nell'altra .---
Questo liquore odoroso che dà lo Zibetto, si
trova in una borsa o sacco situato sotto l'ano e
sopra alle parti proprie del sesso di ciascuno di
questi animali. La borsa medesima ha una aper
tura di due pollici o incirca ed è grande quan
to basta per contenere un piccolo uovo di gal
lina : il liquore che vi si contiene è un'umore
della consistenza della pomata, e la fragranza
del quale , benchè forte, è gratissima anche all'
uscire dal corpo dell'animale . Non si deve con
fondere questa materia che danno gli Zibetti, col
muschio, che è un'umore sanguinolento, che
si ritrae da una specie di capriuolo o di capra
senza corna , che non ha nulla di comune con
gli Zibetti , se non che fornisce com'essi un pro
fumo violento . Il vero animale del muschio è
l' Hian
172-
Z I B
4' Hiam della China. Vedete Porta muschio.
Quando si viene a ricercare se vi siano con
dotti particolari nello Zibetto che portino questo
liquore odoroso, si scoprono unicamente alcune
ramificazioni che passano dalle vene, e dalle ar-
terie ipogastriche nei due sacchi che formano la
borsa grande . Questo fenomeno dunque si ese
guisce pel solo mezzo delle glandule che sono rin
chiuse nei sacchi del ricettacolo dello Zibetto, le
quali hanno la facoltà di prendere nelle arterie
ciò che è proprio ad esser convertito in liquore
odoroso, come le glandule delle mammelle s'im
bevono della materia che trovano nel sangue,
atta a ricevere il carattere del latte . I vasi che
vanno al sacco dei ricettacoli, sono grossissimi
nel maschio; ma appena si possono distinguere
nella femmina ; quindi il liquore del maschio ha
un' odore più forte e più grato di quello della
femmina.
Siccome la Natura non fa nulla invano, que
sto liquore odoroso, è senza dubbio per gli Zi
betti di qualche uso che ancora da noi s'igno
ra . Si osservano solamente certi muscoli, la
funzione dei quali sembra quella di chiudere le
porte predette, e di procurare ad esse un mo
to capace di fare uscire il liquore odoroso, la
ritenzione del quale è insopportabile a questi
animali, quando col tempo ha acquistato un'acri
monia piccante ; perchè è stato osservato che
scmbra che gli Zibetti siano agitati e tormentati
da una certa inquietudine, quando si è in essi ra
dunata qualche quantità di questo liquore che si
sforzano di fare uscir fuori. Lo
Z I B-
173
Gli Zibetti, cioè, lo Zibetto e la Zibetta, ben
chè originarj e nativi dei climi più caldi, dell'
Africa e dell'Asia , possono ciò non ostante , al
dire del Sig. di Buffon, vivere nei paesi tempe
rati ed anche freddi , purchè vengano diligente
mente difesi dalle ingiurie dell'aria, e si diano
ad essi alimenti sugosi e scelti. Se ne alleva tal
volta un numero assai grande in Clanda , ove
si fa commercio del profumo di essi. La sostan
za odorosa dello Zibetto , fatta a Amsterdam, è
preferita dai nostri negozianti a quella che vie
ne dal Levante o dalle Indie , che è ordinariamen
te meno pura. Quella che viene dalla Guinèa
sarebbe la migliore di tutte, se i Negri , gl' In
diani e i Levantini non la falsificassero , mesco
landovi sughi vegetabili, come il ladano , lo
storace ed altre droghe balsamiche ed odorose .
Per raccogliere questo profumo , mettono l'ani
male in una gabbia stretta in cui non possa ri
volgersi; aprono la gabbia a una estremita, ti
rano l'animale per la coda, lo costringono a
restare in questa situazione, mettendo un basto
ne attraverso a regoli della gabbia, per mezzo
del quale gli fermano le gambe posteriori; in
troducono in seguito un cucchiaino nella borsa
che contiene il profumo , raschiano diligente
mente le parti interiori della borsa medesima, e
mettono la materia che ne cavano in un vaso
che coprono immediatamente; e si ripete una ta
le operazione due o tre volte la settimana . La
quantità dell'umore odorifero dipende molto dal
la qualità dell'alimento e dall'appetito dell'aniInna
i 74 Z I B
male , che ne rende tanto più, quanto meglio e
più delicatamente è mantenuto; generalmente se
ne possono cavare una dramma e mezza o due
dramme per volta. L'alimento con cui bisogna
mantenerlo, dev' esser carne cruda e tritata, uo
va, riso , piccoli animali , pollame tenero e prin
cipalmente pesce, e si deve variare in maniera
che si mantenga in salute e gli si ecciti l'appeti
to : pochissima acqua gli basta, e ciò non ostan
te orina frequentemente .
Il profumo di questi animali, molto differen
te dal muschio, è così forte, che si comunica a
tutte le parti del corpo di essi : n'è imbevuto il
pelo, e penetrata la pelle a segno, che se ne
conserva lungo tempo l' odore dopo la morte
dell'animale, e che mentre èvivo, non se ne può
sostenerla violenza, principalmente se il luogo
è chiuso . Se si facciano riscaldare questi animali
coll'irritarli , se ne esalta ancora di più l'odore,
e se si tormentino fino a farli sudare , se ne rac
coglie il sudore , che è parimente odorosissimo,
e serve a falsificare il profumo o almeno ad au
mentarne il volume .
Il liquore untuoso che costituisce il profumo
ricavato da questi animali, ha , quandoè nuovo,
la consistenza del miele, ed è di color bianco ;
invecchiandosi ingiallisce ed imbrunisce . Questo
liquore si chiama in italiano Zibetto, come l'ani
male, e Zibet o Algallia in Arabia , alle In
die e nel Levante , ove se ne fa un uso mag
giore che in Europa. S'impiegava anticamente
nei mali isterici delle donne, ma è stato cono
SCILl
Z I B175
sciuto, che questo profumo e gli altri , comeil
nuschio e l'ambra grigia , erano più contrari
che utili a questi stati, e che gli odori fetidi,
come il garbanum, il castoreum , ed altri simili,
producevano un effetto migliore . I Profumieri
ed i Confetteri fanno entrare anch'essi lo Zibet
to nei miscugli dei loro aromi . L'odore di
questo profumo, benchè violento, è più soave
di quello del muschio; ma è caduta la moda di
ambedue, subito che è stata conosciuta l'ambra
grigia, o piuttosto, subito che si è saputo pre
pararla; e l'ambra stessa, che era, non ha mol
to , l'odore per eccellenza e il profumo più
squisito e più nobile , ha perduto la voga, e
non è più di gusto presso quelli che si picca
no di delicatezza. Gli Zibetti sono naturalmente
selvatici e anche un poco feroci; ciò non ostan
te si addomesticano facilmente, almeno quanto
basta per accostarvisi , e per maneggiarli senza
gran pericolo. Hanno i denti forti e taglienti;
ma le ugne deboli e spuntate : sono agili ed an
che leggieri, benchè di corporatura assai massic
cia; saltano come i gatti, e possono anche cor
rere come i cani; vivono di caccia ; sorprenden
do gli animaletti e gli uccelli . Rilucono ad es
si gli occhi la notte, e si può credere che veg
gano nell'oscurità, Quando non possono aver
gli animali, mangiano radiche e frutti. Bevono
poco, e soggiornano volentieri nelle sabbie in
fuocate e nelle montagne aride. Producono in
numero assai grande nel proprio clima ; ma ben
chè possano vivere nelle regioni temperate, eVl
176 Z I B
vi rendano, come nel paese nativo, un liquorc
odoroso, non vi si possono moltiplicare . Hanno
la lingua meno ruvida del gatto, ed un verso
simile a quello del cane , quando è irritato.
Della GINETTA ,
La Ginetta è un' animale un poco più piccolo
degli Zibetti, che hanno il corpo più lungo.
La testa èpiù affilata, e le gambe sono molto più
corte ; è ugualmente sprizzata ; ha parimente sul
collo e sulla schiena una specie di criniera o di
pelo lungo, che forma una striscia nera, e con
tinua dalla testa fino alla coda; ma si distingue
dagli Zibetti per la coda che è lunga quanto il
corpo, e segnata di sette o otto anelli, alternati
vamente neri e bianchi . Le macchie nere del
collo sono in forma di liste , e si vede sotto
ambedue gli occhi un segno biancastro apparen
tlSS1m1Q ,
La Ginetta ha sotto la coda e nel medesimo
sito che lo Zibetto, una borsa nella quale si fil
tra una specie di profumo, più debole e l'odo
re del quale non si conserva. E' un poco più
grande della faìna , che ad essa è molto simile
per la forma del corpo, non meno che pel na
turale e per le abituazioni; sembra soltanto che
la Ginetta si addomestichi più facilmente . Sono
stati dati alle Ginette i nomi di gatto di Costan
tinopoli, di gatto di Spagna, e di gatto Ginetta,
sebbene le Ginette altro non abbiano di comu
ne coi gatti che l'arte di spiare e di prendere i
SO
z I B 17y
sorci, e di addomesticarsi come i gatti. Forse
perchè non si trovano gran fatto fuori di Spa-
gna e del Levante, è stato dato ad esse il so
prannome di questi paesi. Viene assicurato che
la Ginetta abita solamente i siti umidi e le rive
dei ruscelli, e che non si trova nè sulle montagne
nè nei terreni aridi; onde non deve esserne moltissi
mosparsa la specie.Sono state vedute nel Serraglio
di S.A.S. il Sig. Conte di Clermont a Parigi,
due Ginette , maschio e femmlna , che hanno
generato, ed i parti delle quali si veggono attual
mente nel Gabinetto di Storia Naturale nel ca
stello di Chantilly ; il padre e la madre sono
presentemente nel serraglio dello stesso castello.
Della pelle di questo animale si fa una pel
liccia leggiera e graziosissima ; n' è morbido e
gentile il pelo, di un bigio cenerino, rilucente
e segnato di macchie nere , rotonde e nettamen
te separate sui lati del corpo ; ma che si riuni
scono così da vicino sulla schiena , che sembra
che formino striscie nere continue , le quali si
estendono per tutta la lunghezza del corpo. Al
cuni anni sono erano in moda i manicotti di
Ginetta, e si vendevano a carissimo prezzo, ma
siccome è venuto in capo di contrafarli, tingen
do di macchie nere le pelli dei conigli bigi, n'è
passata la moda , e n' è diminuito il prezzo .
Quanto alla Ginetta di Madagascar, alcuni autori
hanno disegnato sotto questo nome la Fossana .
Vedete questa parola .
Zibetto volante. E'il gattovolante. Vedeteque
sta parola.-
Bom.T.XXXIX. Mi ZI
178 Z I G
ZIDRAC. E' l'Ippocampo , Vedete questa pa
rola .
ZIEMNI. Vedete zemni,
ZIGOLO, Tav. Col. 3o , Fig. 1 , Lat. Embe
riza, Fran, Bruant . Lo Zigolo degli Ornitologi
sti è il verdone in lingua volgare; e il verdone
dei Mercanti di uccelli, e della gente di campa
gna, è lo Zigolo degli Ornitologisti,
Lo Zigolo ha la forma, i colori della piuma,
la carne delicata, la quantità di grasso e il bec
co dell'ortolano . E' appresso a poco della gros
sezza del passero domestico: ma è più lungo; la
testa, le guancie e la gola sono più o meno
gialle; la parte superiore del collo è olivastra ;
le piume della schiena e le scapulari sono miste
di rossiccio, di nero e di bianco; il groppone
è di un color di marrone chiaro; il petto ègial
lastro; il ventre di un giallo senza macchia; le
penne maestre delle ali e della coda sono, le une
brune ed orlate di bigio bianco , le altre sono
olivastre ; i piedi, giallastri ; il becco e le ugne,
di color bruno; l'iride è di color di nocciuola;
le gambe sono di color di carne,
LoZigolo fa il nido a terra, in mezzo a qual
che cespuglio di erbe, talvolta lo posa sopra una
pianticella bassissima ; lo compone all'esterno di
fieno, di erbe secche, di musco; l'interno è ri
vestito di crino e di lana : fa quattro o cinque
uova per volta, picchettate di bruno sopra un
fondo bianco; fa molte cove l'anno, e l'ultima
è in agosto o in settembre . In estate, si ritira
in parte nelle macchie ; in inverno si sparge nelle
Z I G179
lepianure, si accosta all' abitato, frequenta le
siepi, le prode delle strade, e questa è la sta
gione in cui si prende ai lacciuoli e colle reti .
Il carattere dello Zigolo è di aver quattro di
ta, tre avanti ed uno dietro, il becco conico ed
aguzzo; gli orli delle due porzioni del becco ,
rivoltati in dentro ; la mascella superiore inte
riormente armata di un piccolo tubercolo osseo
che serve a questi uccelli per istritolare i grani
dei quali si alimentano.
Lo Zigolo è uno di quelli uccelli che , per la
sua educazione domestica, è ammesso nell'inter
no delle nostre abitazioni; ha il canto grato e
sparge la giocondità nei nostri appartamenti. Si
alleva facilmente in gabbia e nelle uccelliere ,
mantenendolo a miglio , a seme di rape e di ca
napa .
Si distinguono molte sorti di Zigoli
Vi è: Lo zigolo delle siepi, o Zizì, Tav.Col.
653 , fig. 1 , il maschio, fig. 2, la femmina; in
latino, Emheriza sepiaria ; non abita gran fatto
che le Provincie Meridionali dell'Europa ; si me
scola volentieri coi fringuelli dei quali imita il
canto; ora si posa su gli alberi, ora corre sulle
terre di fresco lavorate, nelle quali cerca di fo
raggiare; ma i grani sono la base del suo alimen
to. Lo zigolo pratense di Francia, Tav. Col. 3o,
fig. 2 ; si chiama per soprannome zigolo pazzo,
perchè incappa più facilmente degli altri Zigoli
nelle insidie; è il cirlus stultus, di Aldrovando,
e il verdone sonaglio degli Uccellatori Francesi .
Lo Zigolo del Canadà è chiamato per soprannome
M 2 C0
18o Z I G
codi rossetto. Lo Zigolo familiare d'Asia, così di
segnato da Linneo, Familiaris emberiza griseo ma
culata, apicibus rectricum albis, dorso postico fla
vo. Lo Zigolo del Messico , chiamato teresa gial
la, Tav. Col. 386, fig. 1 . Lo Zigolo di Surinam,
indicato sotto il nome digonambouch da Seba. Lo
Zigolo del Brasile , noto sotto il nome di guir
negat; si trova talvolta presso i mercanti di uc
celli di Parigi, che lo chiamano passero paglia ,
nome che ne disegna la piuma - Lo Zigolo dell'iso
la di Borbone , o lo Zigolo mordorè. Lo Zigolo
di S. Domingo, chiamato per soprannome uliva;
il coor dominante di sua piuma è l' olivastro .
Lo Zigolo turchino dcl Canadà, è l'azuroux .
ZIGRINO, Fran. Chagrin . E' il Soghrè deiTar
tari , il Sagrì dei Turchi, ed il koujouchi dei Bu
cari. Si fabbrica a Astracan ed in tutta la Persia
con quella parte delle pelli dei cavalli che si ta
glia a luna crescente sulla groppa . Si concia la
vandola e macerandola nell'acqua chiara ; si pro
cede alla depilazione col raschiarla; si rimette in
altr'acqua, si raschia dalla parte della carne , si
ammollisce di nuovo, e si toglie con istromenti
di taglio più fino, un leggiero strato dalla parte
del pelo, e la pura parte nervosa delle pelli ,
che resta allora , dev'esser ben tesa con gli spa
ghi, in certe specie di telaj. Tese che siano così
le pelli, si pongono una dopo l'altra sopra un
grosso pezzo di feltro , e se ne copre la parte
del pelo , che è perfettamente liscia , col seme
nero di una specie di atrepice o atripice ( che
nopodium ) , che è durissimo , liscio e di una for
112
- Z I (G 181
ma lenticulare : si fa entrar questo seme nella su
perficie delle pelli camminandovi sopra dopo averle
coperte con un'altro feltro. In questo stato, si
fanno seccar le pelli all'ombra, dopo di che, si
battono leggermente per far saltar via i semi . Si
distaccano le pelli dai telaj e si taglia con uno
strumento ben’ affilato la superficie in cui i semi
hanno improntato una infinità di fossette, in gui
sa che tolti gl'intervalli eminenti di queste fos
sette, altro non resta che una leggiera traccia di
queste impronte ; lisciate che siano così le pelli ,
si riammolliscono per alcuni giorni nell' acqua
chiara, poi si passano in una lissiva calda, fatta
col sale nitroso , che abbonda nei terreni salsi
delle lande di Astracan : si ritirano immediata
mente da questa lissiva, e si lasciano riposare
ammucchiate per alcune ore, ed allora la grana,
formata dalla sostanza ancora intiera delle fosset
te, esce fuori e si sollevasopra il rimanente del
la superficie , che ha perduto porzione di sua so
stanza per l'ultima operazione, e lo Zigrino è
in pronto per le tinte che gli si vogliano dare,
dopo averlo passato un'altra volta per alcuni co
lori, in una salamoja fatta col sal marino . Si
tinge di verde, imnergendo le pelli così con
ciate in una soluzione saturata e calda di sale am
moniaco ; poi si spargono tutte, dalla parte che
non ha grana, di limatura di rame passata per
istaccio; si piegano in due, e ciascuna s'invol
ge in un pezzo di lana per rimetterle sotto lo
strettojo . Il guazzo d'indaco, carico di calce e
di alcali di soda col miele, dà lo Zigrino tur
M 3- chi
182
z I G
chino. Le pelli imbiancate al bagno di allume,
bagnate in seguito in una lissiva di kall, ( sal
sola vermiculata) carica di cocciniglia, danno lo
Zigrino di un bel rosso. Così si prepara questo
colore pei marrocchini di Turchia . La forte so
luzione di vitriolo di ferro , versata sulle pelli
cariche di polvere di noce di galla, all'uscir dal
la salamoia, forma la preparazione dello Zigri
no nero. I Bucari passano le intiere pelli di
onagri o asini selvatici alla maniera dello Zigri
no nero per calzarsene; ma gli Zigrini fini di
bei colori che si fanno a Astracan e in Persia,
sono ordinariamente, al dire del Sig. Pallas, nel
le sue osservazioni sul vero onagro degli Antichi,
groppe di cavalli che si mandano crude, in nu
mero grande ai Persiani, pel commercio del mar
Caspio .
Lo Zigrino è un cuojo fittissimo , durissimo ,
seminato di papillette o grani rotondi che ne
fanno la bellezza. Lo Zigrino è durissimo quan
do è asciutto; ma si ammollisce nell'acqua, il
che ne facilita l'uso agli artefici. Quando il seme
del chenopodium non è stato bene applicato, ri
mangono nella pelle alcuni spazi piani che si chia
mano specchj ; difetto che diminuisce il prezzo
dello Zigrino. Si distingue facilmente lo Zigrino
dal marrocchino passato in Zigrino, perchè il pri
mo si spella più difficilmente . I Mercanti fanno
venire lo Zigrino da Costantinopoli, da Tauri
de , da Algeri, da Tripoli, e da alcuni luoghi
della Sorìa. Gli stucciaj ed i legatori di libri
lo adoperano particolarmente per cuoprire i loro
la
Z I M 183
um
lavori più preziosi . Vedete adesso l'articolo Asi
no selvatico .
ZIGZAG o ZIGZAC. Il Sig. di Réaumur dà
questo nome a un bruco orecchiuto, a cagione
delle bizzarre e diverse inflessioni che l'animale
fa prendere al suo corpo ad arbitrio . Si tras
forma in una falena che porta parimente il nome
di Zigzag, per la disposizione delle linee nere
che ha sulle ali, il fondo delle quali è bianco e
bruno . Consultate il secondo Tomo delle Memo
rie di questo Naturalista, per servire alla Storia
degl'Insetti. Si può consultar parimente l'artico
lo Bruco orecchiuto del presente Dizionario .
Si distingue: 1 . LoZigzag di ventre rosso, che
proviene dal bruco orecchiuto del melo . E' il
Monacha di Linneo . 2 . Lo Zigzag che proviene
dal bruco dell'olmo , TPhalaena dispar, Linn. La
femmina differisce molto dal suo maschio .
ZIISS-MUS. E' il topo ragno. Vedete questa
parola . -
ZILATAT, per abbreviazione del nome Mes
sicano hoitzilaztatl. E' l'airone bianco del Mes
sico , del Sig. Brisson . Dice il Sig. Mauduyt
che è un granchjvoro della grossezza al piùdi
un piccione : il becco è porporino; la parte nu
da delle coscie , le gambe e i piedi sono della
medesima tinta; ma più pallida; le ugne sono
brune; lo spazio tra l'occhio e il becco è coper
to di una pelle gialla; tutta la piuma è bianca.
ZIMBIS o SIMBOS. Specie di piccolo conchi
glio univalvo delle coste d'Africa , che si trova
nell'isola di Loanda nel Regno di Angola, e che
M 4 ser
134 7 I N
serve di moneta. La pesca degli Zimbis, al dir di
Merolla, era anticamente un dritto riservato ai
Re di Congo : ma i Portoghesi lohannousurpa
to . Vedete Cauris.
ZIMBR. Nome del bisonte in Moldavia. Ve
dete questa parola.
ZINGEL, TPerch Zingel, Linn.; Perca dorso
dipterygio, capite plagio plateo, squamoso, maxi
la inferiore multo breviore. Gronov . Pesce del
genere del persico, che si trova nel Danubio .
Lo Zingel , secondo Linneo , altro non è che
una varietà dell'aprone : secondo Willughby ,
l' aprone non ha scaglie sul petto : laddove
sembra, stando a Linneo, che questa parte nel
loZingel sia coperta di scaglie. Ecco le differen
ze espresse che si trovano nel confronto di que
sti due pesci , come sono descritti dai due Au
tori citati .-
ZINGI. I Chinesi danno questo nome al seme
di badiana, che è l'aniso della China. Vedete que
sta parola.
ZINGO, Lat. Zincum, Fran. Zinc . Semime
tallo che, nello stato di regolo, è quello che
più si accosta ai metalli per la semiduttibilità o
specie di malleabilità di cui è suscettibile. E' in
fatti il meno crudo e il meno fragile dei semi
metalli; ha ciò non ostante molta durezza ; ne
sono così tenaci le parti che si appianano un po
co sotto il martello , e non si possono ridurre
in polvere, e per dividerle, è d'uopo limarle ,
raschiarle o tagliarle. Il colore dello Zingo è di
un bianco rilucente che tira al turchino: n'è po
CO
Z I N 185
co costante la tessitura; perchè, se si divida quel
lo che ci viene dalla miniera di Rammelsberg vi
cino a Goslar, e da quella di Dalecarlia in Isve
zia, si osserveranno nella frattura fibre o strie ,
come nel bell'antimonio di Ungheria, laddove in
quello che ci viene dalle Indie Orientali , sotto
il nome di tutanègo, le parti sono più fragili e
sembrano composte di una congerie di lame quasi
cubiche, lucide e dure .
Lo Zingo, benchè fusibilissimo , esige per la
sua fusioneun grado di fuoco subitaneo e piùvio
lento che perlostagno,pelpiombo e perl'antimo
nio. Si accende in un fuoco di carboni, vi pro
duce una fiamma luminosissima che abbaglia e di
un bianco giallastro o di un turchinoverdastro,
accompagnata da scoppiettìo e da fumo; si dis
sipa nel tempo stesso sotto la forma di un va
porbianco, verdastro : esposto a un fuoco trop
po grande, fa esplosione , e schizza particelle
ignee; se al contrario, s'infiammi in un crogiuo
lo, si eleverà o sisublimerà verso i lati sotto la
forma di filetti di colorbianco, senza dare un'odo
re di zolfo molto sensibile. Basta questa esperien
za per dimostrare che lo Zingo è infiammabile e
si volatilizza al fuoco : quello della China si su
blima intieramente; ma quello di Europa, come
di Goslar e di Svezia, si volatilizza in parte sol
tanto, perchè contien sempre qualche porzione
di piombo. Un fenomeno singolare è che loZin
go comunica la sua proprietà volatile o sublima
bile a tutti gli altri metalli, cccettuato l'oro ; e
questa è la ragione per cui alcuni Mineralogisti
lo chiamano semimetallo rapace . Ab
785 Z l N
Abbiamo detto nella nostra Mineralogia, che
lo Zingo si unisce prontissimamente con le so
stanze metalliche; basta farle arroventare ed unir
V1 lo Zingo con un flusso: il ferro è il solo a
Ci si assocj difficilissimamente, e il bismut sul
9ale galleggia, quando si fondono insieme . Ri
guardo al rame rosso , vi si unisce a maraviglia
bene, ne cangia il color rosso in un bel giallo
dorato, secondo le proporzioni della lega; ma
se s'immerge questo misto metallico nel mercu
rio , questo allora che ha più affinità col rame ,
fa far divorzio allo Zingo, e forma vicendevol
mente col rame un' altra specie di amalgama. Si
può far questa esperienza sul tombaco , sul me
tallo del Principe Roberto e sull'ottone .v
Lo Zingo si scioglie negli acidi con una vio
lenta effervescenza. Se si abbia fatto uso dell'ace
to, ne esalerà nel momento della dissoluzioneun
grato vapore : sciolto dall'acido vitriolico, pro
duce il vitriolo bianco. Ma un' altro fenomeno
singolarissimo si è che, ridotto in limatura con
una lima da ferro, acquista la proprietà che ha la
limatura di ferro di essere attrattibile dalla calami
ta . Probabilmente questo fenomeno proviene dal
contenersempre tutte le miniere di Zingo particel
le ferruginose in maggiore o minore abbondanza.
Lo Zingo si trova rare volte puro e solo del
la sua specie ; noi ne abbiamo ciò non ostante
trovato nelle miniere di calamina del Ducato di
Limburgo e nelle miniere di Zingo a Goslar ;
era esso in filettini pieghevoli, bigicci, ed ave
va per matrice una terra limosa piena di ocra
fer
Z I N 8
ferruginea. Le più ordinarie miniere di Zingo
sono mineralizzate dallo zolfo solo , talvolta dall'
arsenico, ed unite al ferro o miste con questo
metallo. Tale è la miniera di Zingo vitreo o la
blenda, e segnatamente la pietra calaminare o ca
lamina fossile. Vedete queste parole .
La miniera di Rammelsberg nell'Alta Sassonia,
che ne dà la maggior quantità , è bigia, mista
di piriti sulfuree e marziali, di piombo, di fal
sa galena , talvolta ricca d'argento e di una ma
teria terrea, durissima.
Si trova blenda in abbondanza nelle miniere
di piombo e principalmente in quella di Pont
pean in Brettagna, ove noi abbiamo osservato
chesi getta via come inutile ; se ne trova ancora
nelle miniere di rame di Saint-Bel nel Lionese . Lo
Zingo si trova ancora nella molibdena, nel vitriolo
bianco e nella manganese dei vetraj . Vedete que
ste parole .
Lo Zingo è difficile a estrarsi dal suo mine
rale a cagione di sua volatilità e di sua combu
stibilità, che rendono delicata questa operazio
ne : noi ne abbiamo dato la dettagliata descri
zione nel secondo volume di nostra Mineralogia,
dalla pagina 123 alla 126. Ci contenteremo di
dire in questo luogo che dopo che il minerale
è stato calcinato e schiacciato dalle macine cir
colanti, si mescola con la polvere di carbone,
e se ne separa questo semimetallo per la subli
mazione, in fornelli non aperti e disposti in ma
niera che la sostanza metallica scoli per descen
sum nelle forme di polvere di carbone, Gli ar
tG
133 Z IN
---------------------------------------
tefici danno a questo Zingo il nome di rauli; si
purifica per mezzo di una seconda fusione, e si
cola in pani quadrati. E' lo zincarco dei Mina
tori, e lo Zingo in navetta dei Mercanti con
sultate ancora il Dizionario di chimica, per la ri
duzione di questo semimetallo, e per la forma
zione della cadmia delle fornaci, del pomfolice
otuzia bianca, specie di cadmia .
Lo Zingo che da un secolo e mezzo ci vien
portato dalle Indie Orientali, è in verghette o
lamine quadrate, e si chiama tutanego. S' ignora
la maniera che si tiene in questo paese per pu
rificarlo, solo si sa che gli Olandesi lo compra
no a buon mercato dagl'Indiani, e che lo riven
dono a carissimo prezzo sotto il nome di tin
tenaque è esso allora in lega con un poco di
piombo e di rame . Ne lasciano una piccola quan
tità nella China, e ne passano anche meno in
Europa, e se lo riserbano quasi tutto pel loro com
mercio di cambio in Oriente. Vedete Tutanego ,
Quei che lavorano i piatti o vasi di stagno si
servono dello Zingo ordinario per toglier l'un
tume e per imbrunir lo stagno ; i Fonditori e ì
Calderai lo fanno parimente entrare nella com
posizione di loro saldature : si mescola con mol
tissimo vantaggio col rame rosso per render que
sto metallo meno soggetto al verderame , per
dargli il color d'oro, e per formar l' ottone, il
similoro, il tombaco , il pinchebeck ( princisbec )
e il metallo del Principe Roberto . Lo Zingogial
lo d'Inghilterra contien sempre un poco di ra- -
me . Lo Zingo entra parimente nella composizio
ne del bronzo. Ab
-
Z I S 189
Abbiamo detto qui sopra che lo Zingo s'in
fiamma nel fuoco; ed è effettivamente la sostan
za metallica più combustibile e quella che deto
na più vivamente col salpietra, producendo allo
ra una delle fiamme più luminose. Tanto belle
proprietà, conosciute da quelli che danno spetta
coli pirici , fanno entrare questo semimetallo in
molte composizioni dei Focajoli, nelle quali pro
duce un colpo d'occhio sorprendente, vario, e
gli effetti più belli che si conoscano in questo
enere .
ZINOPEL. Sembra che sia il Sinople di Un
heria. Vedete Sinople.
ZISEL, Lat. Cititius aut éitellus. Questo ani
male , che è una specie di topo, ha il corpo
lungo e fino come la donnola : non ha orecchie
esteriori, ma solamente fori uditivi nascosti sot
to il pelo; è di un bigio più o meno cenerino,
di un colore uniforme : non è simile all'hamster,
col quale molti Naturalisti lo hanno confuso, se
non perchè hanno ambedue la coda corta , le
gambe basse, i denti simili a quelli dei topi e
le medesime abituazioni naturali, come quelle di
scavarsi il ricovero, di farvi il magazzino , di
devastar le biade, etc.; quanto all'esterno, l'ham
ster ha il corpo assai grosso e raccolto come il
topo, le orecchie corte, apparentissime e larghis
sime; ed ha sulla parte anteriore del corpo tre mac
chie grandi bianche. Lo Zisel differisce dunque
quanto basta dall'hamster , perchè debba conside
rarsi come di una specie diversa; per altra par
te non si meschiano mai insieme. Lo Zisel si
tIO
19o Z O C
-
trova in Polonia , in Ungheria e in Austria .
ZITZIL . E' il colibrì picchettato del Sig. Bris
son, e si trova al Messico, ove il nome di es
so, secondo la lingua delpaese, èhoizitziltototl;
è lungo cinque pollici e mezzo in circa: il bec
eo, le ugne e i piedi sono neri; tutta la piuma
è di un verde cangiante in color di rame puri
ficato, con piccole macchie bianche sulla gola ,
sulla parte anteriore del collo e sulle guarnizio
mi della parte superiore delle ali; le penne di
queste sono di un bruno violaceo; quelle della
coda, di un bruno cangiante in verde e termi
nate di bianco . -
ZIZZANIA.E' il gioglio. Vedete questa parola.
ZIZI. E' lo zigolo di siepe . Vedete questa
parola.
ZOCCOLO, Lat. Turbo-cochlea, aut Threhus,
Fran. Sabot. E'una lumaca di mare operculata
colla bocca schiacciata; ed ha la figura di un cono
rovesciato. Questa configurazione e la propor
zione del peso fa sì che questa conchiglia non
possa gran fatto rovesciarsi quando l'animale stris-
cia. Il Sig. d'Argenville disegna diversi Zoccoli
sotto i nomi di tetto Chinese, o pagoda, o culo
di lampade, bottone della China, lampade antica,
pica, sprone e strega. Esaminando ciò che carat
terizza queste diverse conchiglie, troviamo qual
che difficoltà a collocarle nel genere che questo
Autore ad esse assegna . Le trombe e le toupie
sono Zoccoli anch'esse . Ma il Sig. Adanson di
stingue gli Zoccoli dalle toupie . Consultate la
Storia delle conchiglie del Senegal.-
ZOC
Z O ILI 9 I
ZOCCOLO. Si dà questo nome alla specie
di calzatura di corno del piede dei quadrupedi,
tanto solipedi che piefforcuti . Vedete all'articolo
9uadrupedi,
ZODIACO. Vedete costellazione .
ZOLFO o SOLFO, Lat. Sulphur, Fran. Sou,
fre. Sostanza solida, infiammabile, liquefattibile,
e suscettibile di cristallizzazione , quando pel raf
freddamento passa dallo stato di fluidità a quello
di solidità. Lo Zolfo differisce dai bitumi pro
priamente detti, perchè essendo esposto sul fuo
co, in vasi chiusi, comincia dal liquefarsi, e si
sublima in seguito in una polvere rilucente, più
o meno gialla : a fuoco aperto, cioè se la fiam
me tocchi la superficie di esso, si accende facil
mente, e produce una fiamma turchiniccia , che
esala un vapore acido, massimamente acre al pa
lato, e che soffoca o toglie il fiato agli animali
che la respirano. Questa sostanza mineralizza i
metalli e i semimetalli: e si consuma intieramen
te nel fuoco . - - -
Lo Zolfo si trova intieramente formato sotto
diverse figure, ed in istati ben diversi ; ora è
vergine o nativo, trasparente e di diversi colo
ri . Quello di Stiria e di Quito è rosso; quello
delle Indie, di Affinda in Ungheria, di Bex nel
Cantone di Berna , è in masse informi e di un
color citrino. La solfataja di Catolica, alla costa
del Mezzogiorno della Sicilia, a otto miglia den
tro terra, tra Sicoliano e Calta Bellata, esibisce
una immensa quantità di Zolfo, di un giallo di
topazio più o meno cupo ed in massa :-
-
Vol
* o2 ZO IL-
volte questo Zolfo, è seminato sopra di gesso cri
stallizzato, in cresta di gallo, e inglobato in una
terra calcare; vi se ne trova ancora in cristalli
di un bel rosso di rubino e senza miscuglio . La
solfataja vicina a Naro, in distanza di ventiquat
tro miglia da Girgenti in Sicilia , fornisce una
quantità grande anch'essa di Zolfo giallo verdic
cio, d'un rosso senza lustro, di color rossiccio
coperto di gesso, cristallizzato in gugliette esa
gone, etc. Lo Zolfo cristallizzato fossile ha spes
se volte la figura di un' ottaedro romboidale ,
formato da due piramidi quadrangolari oblique
e ottuse , congiunte base con base . Lo Zolfo
dell'Arcipelago e principalmente quello di Conill
vicino a Cadice, è citrino, in cristalli semitraspa
renti. I Negri ne vanno a raccogliere alla bocca
della Solfataja alla Guadalupa in America, che è
di color giallastro, spesse volte opaco. Gli Zolfi
nativi di Roma, di Ancona, di Mareme e di Si
cilia, sono rare volte molto trasparenti. Si tro
va ancora Zolfo nativo, ma in filetti, nelle fen
diture delle terre nelle quali sono vulcani; si tro
va in fiori che imitano talvolta la forma delle
spighe, nelle acque termali di Aix-la-Capelle, di
Bade, di Tivoli . Talvolta lo Zolfo è impuro ,
cioè mescolato colla terra o colla pietra ; e si
chiama allora Zolfo minerale. E' o giallastro, o
verde, o nero . Si trovano nelle vicinanze di
Besangon in Franca Contea, sassi cavi, che sono
di una forma ritondata, irregolare come alcune
pietre cavernose, e che sono internamente pie
ne di uno Zolfo nativo purissimo e polverizza-
tQ ,
z o L 19;
to, molto simile a quello delle acque di Tivoli.
Si pretende che non vi sia Zolfo fossile puro,
di unaprimitiva, perchè si trova co
me cristallizzato e perche forma strati vicini a cer
ti luoghi ove sono , o acque termali, o piriti ,
o carbonaie, o bitumi, o vulcani, &c.; tali so
no segnatamente due cantoni d' Islanda che for
niscono Zolfo : questi distretti sono Huscoin e
Krisevig; ed insieme il luogo ove si dice che pos
sono caricarsi nello spazio di un'ora, ottanta ca
valli di uno Zolfo naturale trasparente. Si rico
noscono spesse volte i siti nei quali si trova Zl
fo, da una elevazione di terra screpolata nel
mezzo, d'onde esce un forte calore; a misura
che si scava, il calore del suolo divien fortissi
mo , e penosissimo il lavoro; anzi vi si può
lavorare la notte soltanto ; perchè il calor del
sole, unito a quello del terreno, incomodereb
be troppo i lavoranti.
E' stato trovato in abbondanza, nel 178o,
Zolfo cristallizzato, citrino , rilucente, in istra
ti, a venti piedi di profondità, negli scavi fatti
alla mezza luna del Baluardo , vicino alla porta
S. Antonio a Parigi. Si vuole cheanticamente
fosse stata in questo luogo una carognaia ( tre
secoli addietro in circa), e che fosse stata a po
co a poco ricoperta dalle macerie e dalle im
mondezze della città . Noi abbiamo raccolto un
buon numero di pezzi di questo Zolfo, semina
ti di cannelletti di paglia , di cuoio di scarpe »
di pezzi di drappi, il tutto assai ben conserva
to, e costituente una porzione di uno strato di
Brm,T.XXXI X. N ter
,
194 Z O L
-====
terra come di argilla grassa, posata sopra fram
menti di gesso vecchio , di rami , di pezzi di
legno, di terre riportate, e ricoperta sopra del
le materie medesime . Questo Zolfo ci è sembra
to ciò non ostante di formazione primitiva, e
non formato , quanto alla sua cristallizzazione
dall'azione del fuoco.
Lo Zolfo si trova ugualmente tutto formato in
alcuni vegetabili. Il Sig. Deyeux, istruito Spe
ziale di Parigi , lo ha riconosciuto nella radica
del rafano selvatico, e nella radica dell'erba del
la Trinità. Vedete quest'ultima parola e l'artico
lo Piante Antiscorbutiche .
LoZolfo fossile, &c. è una combinazione dell'
acido vitriolico col flogisto minerale : quanto più
lo Zolfo è puro, tanto è più bello, giallo e tra
sparente; quanto al contrario vi si trovano mag
giori eterogeneità, tanto più è grossolano, irri
conoscibile ed opaco . Consultate la nostra Me
moria, letta all'Accademia delle Scienze nel 176o,
sulle piriti e la vitriolizzazione ; Dotti Stranieri,
Tom.V, pag. 617.
-
Abbiamo detto che lo Zolfo è spessissimevol
te la materia che mineralizza le sostanze metal-
liche e fa ad esse prender forme che non avreb
bero se esso non v”intervenisse, come si osser
va nel mercurio convertito in cinabro . Dà pari
mente ai metalli talvolta quei bei colori di collo
di piccione che vi si osservano. Vi sono casi nei
quali questo minerale è nocivo alla riduzione dei
metalli; ma comunemente è cosa vantaggiosa che
vi si trovi , perchè agevola la formazione del
S
V
Z O L 195
metallo impuro della prima fusione; si trova
ancora nell'arsenico rosso , nell' orpimento , e
abbondantemente nella pirite, di un giallo palli
do, e più ordinariamente nella miniera di anti
monio .
Ecco una delle maniere con le quali si ricava
nell' Hartz , a qualche distanza da Goslar, una
parte dello Zolfo dalle pirìti . Gli artefici form
no con le pirìti , tanti quadrati lunghi che di
spongono sopra un letto di legna : circondano le
stesse legna di pirìti polverizzate e disposte ad
infiammarsi pel contatto umido dell'aria : si pro
cura l' infiammazione coll'aiuto dell'acqua . Sem
bra che questi ammontamenti di pirìti sulfuree
ardano per tre mesi : in capo ai quindici primi
giorni, si ammollisce la miniera, e lo Zolfo che
non si è decomposto, scola e si aduna nei bu
chi che sono stati fatti espressamente in mezzo
al cumulo , d' onde si ritrae lo, Zolfo fuso con
un grande strumento di ferro, fatto a cucchiaio.
Appena lo Zolfo è tratto fuori di sotto la pirl
te, si forma la vitriolizzazione nel cunulo che
rimane , e per questo mezzo destramente si ri
traggono i prodotti della pirite . Vedete questa pa
rola e quella di Vitriolo .
Abbiamo dato, nel secondo Volume della no
stra Mineralogia, un'assai circostanziato raggua
glio della maniera con cui si ritrae lo Zolfo in
Italia, dalle terre e dalle pietre che lo contengo
no, siccome ancora del processo che si pratica
a Marsiglia per purificarlo, modellarlo e subli
mario . Tutta questa operazione consiste nel rac- ,
2. chiu
196 Z G) IL
chiudere dentro i vasi la pietra dello Zolfo greg
gio o bruto o caballino, raccolta al piede della
solfataja ; evvi sopra questi vasi una fila di altri
vasi nei quali sono incastrati, il che forma una
specie di tubo ; appena agisce lo Zolfo, non s'in
fiamma per mancanza di aria ; ma ascende nello
stato di vapore, poi si condensa nel vaso che
serve di recipiente . Si cava lo Zolfo . da questo
vaso , i cerchj di ferro del quale debbono facil
mente smontarsi ; ed ecco lo Zolfo di prima fu
sione della solfataja ; si manda a Ancona, ove
gli si fa subire una nuova fusione , &c. Si lascia
coagulare, ed è allora in bei pezzi gialli, rilu
centi e friabili ; in questo stato si carica perMar
siglia e per altri luoghi, per l'uso dell'artiglie
ria. Si fa liquefare per la terza volta , sopra un
fuoco dolce lo Zolfo in vasi grandi strombati , e
quando è in fusione, si prende a cucchjaiate che
si versano in forme grandi di legno di busso
fendute in due , o in altre piccole forme di
canna, fendute in quattro ; appena sono piene,
s” immergono nell'acqua, e si aprono le forme ;
tale è la maniera con cui si fa lo Zolfo in can
nelli , un piede cubico del quale pesa cento tren
tanove o cento quaranta libbre di Francia . Ri
mane nei vasi uno Zolfo impuro , dal quale si ri
trae , per mezzo di una lunga colonna di vasi
chiusi , lo Zolfo in fiori . Il capo morto che re
sta nel capo inferiore di quest'ultima operazione
è quello che si distribuisce nel commercio sotto
il nome di Zolfo vivo.
Lo Zolfo serve ai Berrettai, ed ai Fabbricatori
di
Z O L 197
di veli; serve per imbiancare i drappi di lana o
di seta; e per tale effetto è d'uopo infiammar
lo : il vapore dello Zolfo toglie e distrugge le
macchie dei drappi: si adopra ancora per fumiga
re le botti di vino; è la base della polvere da
schioppo e da cannone , ed entra nei fuochi ar
tifiziali ; preso in sostanza, è buono, per quello
che si dice, nell'asma. Lo Zolfo vivo, mescola
to col grasso di porco, forma un'unguento ec
cellente per guarir la rogna e i porri , dopo aver
fatto precedere i rimedi interni; ma macchia la
biancherìa come l'unguento mercuriale ; e per
ciò , al dir del Sig. Bourgeois, non bisogna met
ter questa biancherìa nella lissiva assieme coll’
altra .-
L'acido sulfureo che si disimpegna dallo Zolfo
nel tempo della combustione all'aria libera , dà
l'acido vitriolico ; ma lo Zolfo ridotto in vapori
per la combustione, cioè infiammato in ridotti
poco spaziosi , non perde quasi nulla del suo
principio flogistico , ed è opportunissimo in que
sto stato a far perire gl'insetti, i topi, i sorci,
ed altri animali malefici , e perciò è savjssima
precauzione l' arder lo Zolfo, chiudendo tutto
esattamente, nel fondo di un vascello che ritorna
da un lungo viaggio . E' parimente un mezzo
utilissimo per discacciare i miasmi alcalini, o per
neutralizzare l'aria pestilenziale ; ed è noto che
nella cala di un vascello , l'aria è spesse volte
di un'insopportabile fetore; e che ne sono pre
giudicievolissimi gli effetti alla salute dell'equi
paggio ; si debbono usare le medesime precau
N 3 zio
198 Z O N
zioni per purificar l'aria delle case da lunghissi
mo tempo abbandonate, quando si vogliono abi
tare . L'uomo deve evitare questo vapore imme
diato dello Zolfo in combustione, ed abbastanza
si comprende dal seguente passo di Omero che
gli antichi Greci e gli Egiziani ne facevano un
grand'uso per purificare i luoghi che passavano
per impuri : Sacerdotessa, portami lo Zolfo che
distrugga il germe dei nostri mali, affinchè arden
dolo, io riempia il mio palazzo dei salutari suoi
vapori. Odiss. lib.XXII, verso 481 .
zolfo Vegetabile . Lat.Sulfur vegetabile . Vede
te Musco strisciante a clava e l'articolo Pinò ,
Vedete ancora l'articolo Erba della Trinità.
ZOLFINO. E' l'amaranto Crientale. Vedete
Amaranto .-
ZONE . Lat. Zonae . Fran. Zones . I Naturalisti
usano questo nome per disegnare le striscie di
diversi colori che si osservano sulle agate , gli
alabastri, e segnatamente sulla superficie delle con
chiglie .
I Geografi esprimono colla voce Zone ( nome
tratto dal Greco, che significa tintura ) una por
zione di sfera compresa tra due cerchj paralle
li , &c. Hanno essi diviso la superficie della ter
ra in cinque Zone , cioè una torrida o infuocata;
due fredde o glaciali , e due temperate .
La torrida comprende tutte le regioni tra i tro
pici ; il sole vibra perpendicolarmente i suoi rag
gi due volte l'anno in tutta l'estensione di que
sta Zona, e vi mantiene un'estate continua.
Le due Zone fredde sono situate tra i Cerchi
po
z O O i 99
polari e i Poli, e sono esposte ai rigori di un
inverno perpetuo .
Finalmente , le due Zone temperate provano
l'alternativa dell' inverno e dell'estate, e gli estre
mi dell'uno e dell'altra in alcune regioni ; sono
esse situate tra le Zone glaciali, e la Zona tor
rida, nei due emisferi . Vedete gli articoli Stagio
ni e Globo. - -
ZONECOLINO . E' la quaglia col ciuffo del
Messico, del Sig. Brisson, e delle Tav. Col. 126,
fig. 1 . Si trova alla Guiana e al Messico, ed è
un poco meno grossa della quaglia nostrale . Il
becco , i piedi e le ugne sono di color bruno;
la parte superiore della testa, il ciuffo di cui è
adorna e la gola sono di color falbo; il rimanen
te della piuma è screziato di rossiccio, di bru
no , di nero e di bianco giallastro : le penne
delle ali sono brune; e quelle della coda, varia
te di bruno e di bigio .
ZOOFAGO . Nome che si dà , non meno che
quello di carnivoro, a qualunque specie di ani
mali che vive di carne ; cio non ostante , s' in
tendono comunemente perZoofagi alcune mosche,
che si alimentano sul corpo degli animali, e li
succhiano . Charleton dà il nome di Azoofagi ad
altre mosche, che vivono o del sugo della terra,
o di quello delle piante . Vedete all'articolo Acri
dofaci. Vedete ancora Carnivoro .
ZOOFITI. Lat. Zoopbyta o Zoophyton. Fran.
Zoophytes . Si dà questo nome a certi corpi ma
rini, che non possono riguardarsi nè come in
setti, nè come conchigli, nè come pesci propria
N 4 - men
2CO Z (O O
-
mente detti; ma i quai sembra che per la pro
pria natura partecipino dell'animale e del vegeta
bile; il che li fa chiamare piante animali, o ani
mali piante ; nome di doppio senso dato dai Na
turalisti Greci . Il nome di Zoofito è più consa
crato dall'uso a disegnare quelle specie di vermi
o di corpi animati, che altro , per la maggior
non hanno che un sentimento di vita molto
OSCUlf"O
I Naturalisti chiamano così un'ordine indeter
minato di animali aquatici che non hanno sangue,
e che hanno qualche somiglianza con alcuni cor
pi noti; tali sono l'ortica di mare, il pennello
di mare, il polmone marino, l'oloturia, la thetye,
la verga marina o mentula, la melagranata, il
fungo marino, la pera marina o ficoide, la penna
marina , il grappolo marino o uva di mare, la
mela pazza di mare, l'anemone di mare, la ma
no di mare, e il cetriolo di mare , &c. Tali so
no gli Zoofiti o piante animali, che Ruischio ha
raccolto al fine del primo volume della sua Sto
ria Naturale . Verrebbe la tentazione di dire che
ogni Zoofito è un essere intermedio tra l'anima
le e il vegetabile. -
Linneo, Systema TNaturac, edizione 6, pag.72 ,
divide le diverse specie di Zoofiti in molti gene
ri tra i quali si veggono ancora la thetye o il
granchio di mare, l'oloturia , la scolopendra ma
rina, le diverse specie di lumache di mare , e il
lepre marino. Gli altri Zoofiti, noti sotto diversi
nomi , sono, al dir dello stesso Autore , l' idra
o polipo , la seppia , il tritone ,il physalus, e
- l'afro
Z O O 2 di
l'afrodite , specie di bruchi di mare ; finalmente
sotto il nome di medusa, il Naturalista Svedese
comprende le ortiche di mare e il polmone ma
rino; vengono in seguito le stelle marine e i
ricci di mare; ma il Sig. Lyonnet, nelle sue os
sulla Teologia degli Insetti del Signor
esser, dice parlando del Sistema di Linneo, che
non è in conto alcuno cosa certa che vi siano
animali, ai quali possa convenire il nome di
Zoofito, o almeno che questo è un nome che
Ol alcuna maniera ai ricci , alle
seppie , alle stelle ed alle ortiche di mare , poi
chè tutti questi sono veri animali , di una for
ma, per vero dire, stravagantissima, ma ciò non
ostante tutti capaci di funzioni animali, di un
moto progressivo, e che onninamente non par
tecipano della natura delle piante. - -
Il Sig. Donati, nella sua Storia Naturaledel
Mare Adriatico, pag. 54, dopo aver fatto vede
re la catena che unisce i polipari con quei corpi
marini che egli chiama Zoofiti, divide la classe
degli Zoofiti immobili, cioè che non possono tra
sferirsi da per se stessi da un luogo all'altro, in
tre centurie. La prima abbraccia gli Zoofiti, la
sostanza dei quali è intieramente carnosa ; la se
conda centuria comprende gli Zoofiti che sono
composti di due sotanze, una delle quali è mol
le e carnosa, e l'altra consistente e tendinosa;
la terza centuria contiene gli Zoofiti che sono
carnosi ed ossei. - , -
Il Sig. Mylius, in una lettera scritta al Sig. de
Haller, parla di un nuovo Zoofito che ha in
gan
3&5
z o o
gannato molti Naturalisti, i quali lo prendeva
no pel vero Lylium Lapideum, tanto sembrava
completa la somiglianza tra questi due corpi
Questo nuovo Zoofito è stato preso i vicino al
olo artico, nell'estate del 1753, dalSig.Adrianz
utlandese, Capitano del vascello la Britannia,
impiegato nella pesca della balena . Dice questo
Navigatore che il cordone del piombo, che ser
ve agli scandagli, fu quello con cui furono tira
ti a bordo del suo vascello , dugdi questi corpi
marini da un fondo argilloso, alla profondità
di duecento trentasei tese , verso il sessantesimo
nonogrado di latitudine settentrionale, ed a ottan
ta miglia di distanza dalle coste di Groenlandia .
Si distingue in questo Zoofito un fusto lungo e
senza foglie, una specie di fiore lungo due pol
lici ed un poco solcato come l'Encrinus; il fusto
è rigonfio alle due estremità, quadrato e ador
no da ambedue i lati di un solco; è duro, os
seo, bianco interiormente, di un giallo bruno
esteriormente e flessibile : si ristringe e prende
la forma di una spirale diseccandosi ; ma se s'im
merga in seguito nell'acqua, si spande e ripiglia
la prima forma.
Questo preteso fiore è composto di trenta cor
pi irregolarmente conici e simili ad altrettanti
calici di fiori che avessero l'epiderme viscoso;
non si può abbastanza ammirare la struttura or
ganica dell'interno di ogni ramoscello . Questo
gran Zoofito è, al dir del Sig. Ellis, un vero
polipario, ed una congerie di animali marini,
dei quali il fusto è il sostegno : le specie di se
-
Z O O 2o3
rhenze, che si crede di vedervi , sono altrettan
te uova ; ed i pretesi fiori sono i polipi mede
simi, ciascuno dei quali ha otto branche o brac
cia, guarnite da ambedue i lati di file di fibre
le quali sembra che facciano le funzioni di di
ta . La bocca, che è situata al centro delle brac-
cia, nel sito in cui queste si uniscono, ha due
labbra dritte e dentate. Il Sig. Ellis, nel far la
sezione di un'animale così straordinario e così
composto, ha scoperto una vessica la quale , ol
tre la proprietà comune con quella dei pesci che
nuotano , gli serve ancora come di canale per
condurre i materiali, che questi diversi corpi
radunano, e che sono ad essi necessari per la
difesa e per l'accrescimento del lungo fusto os
seo di essi. E' persuaso lo stesso Naturalista al
tro non essere il Lylium lapideum, che le spo- -
glie petrificate di questo animale : quanto al Si
gnor Mylius, èegli inclinatissimo a credere, che
questo nuovo corpo marino abbia qualche somi
glianza coi corpi di mare petrificati, che si chia
mano encrini, i quali hanno un fusto o una co
da articolata e che potrebbero chiamarsi Aste
rias Zoophytos composita. Vedete adesso l'articolo
TPalma Marina.
Il Sig. C. G. di R. ha osservato, in settembre
1781, uno Zoofito singolare del Mar Baltico,
ove se ne trovano in quantità grande. Questo
Zoofito è come un corpo rotondo , concavo,
che ha generalmente una circonferenza uguale al
la larghezza della palma della mano; è esso for
mato di una sostanza flessibile, molle, traspa
en
ha
264 Z O G)
rente, di un turchiniccio, simile a quello di
certe foglie di piante aquatiche, che ha nel cen
tro o nella concavità quattro piastre circolari,
che esibisce in qualche maniera nel complesso ;
l'apparenza di un tulipano e che metten sotto gli
occhj di tanto in tanto nell'acqua, un novimen
to peristaltico dalla superficie al fondo, e dal fon
do alla superficie ; la sostanza di esso è mucila
ginosa al tatto, estensibile come la resina elasti
ca : si distingue attraverso a questa sostanza una
quantità di filetti o raggi che divergono dal cen
tro alla circonferenza, estensibili e contrattivi :
due aperture bislunghe , situate al centro e l'una
accanto all' altra sembra che siano due bocche ,
o due succhiatoj, ma senza denti : i filetti o
raggi , mobili e vermicolari , sono come altret
tante piccole braacia finissime, gelatinosissime, e
che si suddividono all' infinito alle estremità . Si
direbbe di una stella medusa, ma di un genere
nuovo; l'inviluppo non n'è in alcuna maniera
membranoso ; ma semplicemente gelatinoso , So
spetta il nostro Osservatore che i raggi delle fi
brille siano vere trachèe , cioè polmoni .
Deve parimente annoverarsi tra i corpi Zoofiti
il preteso animale fiore, che si trova nell'isola
di S. Lucia, che alcuni dilettanti riguardano co
me una produzione vegetabile , ma che ha ca
ratteri particolari che lo approssimano alle so
stanze animali. Evvi in una caverna dell' isola di
S. Lucia, vicino al mare , un gran recipiente,
di dodici o quindici piedi di profondità, l'acqua
del quale è salsa; il fondo è composto di roc
che,
Z O O 205
-sammaìs=
che , dalle quali si sollevano in ogni tempo cer
te sostanze , che esibiscono alla prima occhiata
certi bei fiori rilucenti, simili appresso a poco
ai nostri ciperi scempi , ma di un colore mol
to più chiaro . Quando si vogliono cogliere que
ste specie di fiori, ed allorchè vi si accosta la
mano o qualunque altro strumento alla distanza
di due o tre piedi , si richiudono i fiori e si
affondano sotto l'acqua ; cessato questo moto, rie
scono fuori e si riaprono . Esaminando da vici
no questa sostanza , si trovano nel centro del
disco quattro filamenti bruni , simili alle gambe
del ragno, e che si muovono intorno intorno a
certe specie di petali di color di paglia o gial
lo chiaro, con un moto vivo e spontaneo : qne
ste gambe si uniscono come tenaglie per germir
la preda , e i petali si richiudono immediatamen
te per rinserrarla ed impedir che fugga . Sotto
queste apparenze di fiori vi è un fusto nero ,
grande come la coda di un corvo , e questo fu
sto sembra che sia il corpo dell' animale ; si so
spetta che viva dei frammenti dei piccoli insetti
che rigetta il mare in questa parte di acqua sal
sa, abitata dall'animale , e che il bel colore di
cui lo ha arricchito la Natura, gli sia stato da
to per attirarsi questi vermetti o insetti, i qua
li, come tutti gli animali acquatici, si dirigono
verso gli oggetti rilucenti. Non potrebbe, per
avventura questa produzione singolare essere una
specie di anemone di mare ? O , non potrebbe
darsi che vi fossero nel mare piante sensitive
dell' ordine delle attrappamosche , che
riIn
2c,6 Z O O
--
Inglesi chiamano tipitivvitch, o buram - cadal è
Vedete Anemone di mare e Attrappa mosche.
Il Sig.Abate Dicquemare ha osservato anch'es
so sulle spiagge dell' Havre, un'animal marino,
che sembra composto di petali, di un pistillo ri
gonfio in cima e alla base, sostenuto sul calice :
tra questa base del pistillo e i petali, vi sono
molti tubercoli di color giallastro, simili agli sta
mi, il calice è sostenuto da un peduncolo ogam
bo, che aveva il suo basamento sopra un' ostrica
vecchia , ed era impegnato in una falsa spugna
di color di polpa di popone. Il nostro Osserva
tore ha chiamato quest' animale il floriforme . I
pretesi petali, dic'egli, sonoventidue, ventiquat
tro o ventotto membri, rotondi, bianchi, semi
trasparenti, che possono muoversi per tutte le
direzioni : il pistillo altra cosa non è che un cir
condario di membra più piccole, mobiliper ogni
verso ed innestate sopra un corpo semitrasparen
te, suscettibile di contrazione e di dilatazione :
tutto il corpo dell'animale è bianco e semitraspa
rente ; tutte le parti di esso sono dotate di sen
sibilità, ed hanno moti spontanei di contrazione
e di dilatazione, che cangiano la forma totale di
esse, o quella di alcune soltanto. Il Sig. Dic
quamare ha veduto alcuni di questi animali affer
rar fortemente colle proprie membra corpi estra
nei, come gli afferrano gli animali di mare. Sup
pone egli che la vita attiva di un' individuo flo
riforme possa arrivare a sedici giorni , in capo
ai quali sembra che patisca , si distacca dal suo
peduncolo, cade in fondo all'acqua, ove perisce
e Sl
Z O O ze7
e si distrugge in tre o quattro giorni: tre gior
ni dopo si vede un'altro individuo in cima al
medesimo fusto ed alle estremità del medesimo
peduncolo. Qual'è il principio di questa succes
sione?
Il Sig. Cavaliere le Febvre Deshayes, ha fatto
inserire nel Giornale di Fisica e di Storia Natu
rale, novembre 1785, la descrizione di una spe
cie di anemone di mare a piume, o animale fiore,
il quale sembra che abbia molta analogia col flo
riforme del Sig. Abate Dicquemare. Il Sig. le
Febvre Deshayes ha osservato il suo animale fio
re sulle spiaggie dell'America, ed eccone la frase
latina, equivalente a una descrizione : Anemone
Maritima, plumigera , forma exteriori rosacea ,
brachis plumeis fori tubiciformi plane consimilis
discolor aut variegata, pedibus rupi adharens, etc.
-sive animal floriforme, Vi si contano trentasei
petali o braccia piumate .
Si trova ancora nella Storia Naturale della
Contea di Down in Irlanda , la descrizione di
unOZoofito
turchiniccio, rotondo e schiacciato,
largo sedici pollici, col ventre socchiuso, e che
lascia scorgere da questa apertura certe vessichet
te , simili in qualche sorte agli intestini di un ani-
male. Fu esposto in un luogo asciutto all'azio
ne del sole, ove parve che provasse una specie
di dissoluzione.
Dice Lemery, che gli antichi Botanici hanno
dato il nome di Zoofito a molte specie di pian
te, che hanno creduto partecipar dell'animale
ugualmente che della pianta, come le spugne e la
pen
2e8 Z O (O
Penna marina, perchè si muovono nelle acque
nelle quali nascono, come se fossero animali .
Questo autore finisce, dicendo che , quando si
esaminano in buona fisica e senza preoccupazio
ne le piante che sono chiamate Zoofiti , come
l'Agnus Scythicus, si riconosce che sono sempli
ci piante e che non hanno nulla di animale, e
che in questa maniera non vi dev' esserveroZoo
fito. Vedete Agnello Tartaro.
Quanto a noi costantemente crediamo all'esi
stenza degli Zoofiti, cioè di corpi organizzati ,
di un volume più o meno considerabile , che
partecipano del vegetabile unicamente per la con
figurazione esteriore; ma che sono costantemen
te animali per la maniera con cui si muovono,
rivivono e si riproducono. Infatti queste sorti
d'individui hanno i moti spontanei, che sono
propri agli animali, ed in particolare a quelli
di questa specie . Sentono quando vengono toc
cati, e danno prova della percezione che hanno :
cercano , per mezzo di certe parti del corpo,
il necessario alimento, lo afferrano, lo riten
gono e lo divorano . Tutto quello che si può
dire, e di questo siamo d'accordo anche noi,
si è che gli Zoofiti sono animali che, nè per la
forma , nè per l'organizzazione, rassomigliano
a quelli che ordinariamente vediamo : il mecca
nismo di essi è poco conosciuto, e quello che
se ne sa prova soltanto che è molto più sem
plice di quello degli altri animali . Hanno forme
stravaganti, e partecipano più di quelle delle
piante che di quelle degli animali; e verrebbe
qua
7 O O 2C9
quasi la tentazione di dire che sono creature con
cepite ed eseguite sopra un disegno diverso da
quello che la natura ha seguito per popolare il
globo che noi abitiamo ; che sono come gl'in
dizj e i saggi di un'altr'ordine e di un'aitra con
catenazione di enti . Queste specie di mollusche
altro non esibiscono che una congerie di sostanze
gelatinose, per lo più senz'alcuna parte solida,
corpi talvolta che hanno un'infinità di braccia o
di piedi che estendono o ritirano ad arbitrio, e
dei quali si servono per mutar sito e per affer
rar gli oggetti che si trovano a portata : taluni
hanno gli occhi , spesse volte grossissimi , tal
volta due denti che mal non somigliano al becco del
papagallo, situati nel centro di una mola visco
sa . Ecco le sole parti che danno agli Zoofiti
qualche somiglianza col rimanente degli animali .
Noi ripetiamo, che ciò non ostante tutte o la
maggior parte di queste mole stravaganti agli oc
chj nostri, si muovono, fuggono, evitano i pe-
ricoli, aspettano, inseguiscono ed attrappano la
preda, e danno tutti i contrassegni di sensibilità,
di bisogno , di desiderio , di godimento che si
osservano negli altri animali; e siccome ammet
tono o rifiutano, variano liberamente le manovre
secondo i casi, riparano le, perdite che fanno,
sentono dunque la propria esistenza e sentono che
esiste qualche cosa fuori di esse medesime . Gli
umori di esse , coloriti di porpora, di viola , di
verde , di turchino, ne vanno a gonfiare i vasi
in filetti dello stesso colore; e quando hanno le
braccia o , se si voglia, i piedi stesi, si crede
Bom.T.XXXIX. Oreb
2 I( Z O O
rebbe spesse volte di vedere un fiore schiuso ,
dipinto e variato dei più grati colori ; ma questa
forma , fallace sovente ed ingannatrice , spari
sce, e l'animale si richiude nel momento in cui
si tocca; spesse volte cagiona sulla mano indi
screta o imprudente che l'afferra, un bruciore,
l'impressione del quale si fa sentire per untem
po più o meno lungo .
Si trovano Zoofiti nel mare, ove si veggono
attraverso al cristallo di sue acque, nei luoghi
in cui sono trasparenti e quiete . Gli uni nuo
tano nella massa del fluido, gli altri strisciano
sulla rena o la melma, e il maggior numero ,
dice il Sig. Mauduyt, pende dagli scogli ai quali
è attaccato . Allora il fondo del mare e i fian
chi degli scogli compariscono coperti di fiori,
alcuni dei quali sono sbucciati, e gli altri anco
ra chiusi . -
Sono ben pochi gli Zoofiti , che si possano
far seccareper conservarli in questo stato: si pos
sono mantenere per qualche tempo in vasi pieni
di acqua di mare, nella quale si veggono sten
dersi , ripiegarsi , e godere dello spettacolo del
moto di essi, poi farli passare in qualche fluido
conservatore , nel quale sempre si richiudono
morendo, e perdono il lucido dei colori i quali
risiedendo negli umori di essi, spariscono a mi
sura che questi si vanno alterando. Forse ses'im
mergesse uno Zoofito ben'aperto in un liquore
attivissimo, come lo spirito di vino, vi perireb
be prima di potersi chiudere , e sarebbe cosa
più piacevole senza dubbio il conservarlo aper
tO
Z O O 2 I
to. Si possono ancora usare i mezzi indicati per
la conservazione di alcuni polipi , all'articolo
Corallina .
Gli Zoofiti, secondo Linneo, sono vere pian
te , che hanno un sistema nervoso e l'organo
del sentimento e del moto . Ma un'essere in tal
guisa conformato non è una pianta, e dev'esse
re annoverato tra gli animali, poichè ne ha tutte
le proprietà, la vita, il sentimento e il moto
spontaneo. Linneo colloca gli Zoofiti tra gli ani
mali e i vegetabili, in bivio animalium et vege
tabilium . Bisogna ciò non ostante, che egli ab
bia riconosciuto negli Zoofiti un maggior nume
ro, di relazioni con gli animali che colle piante,
poichè gli ha messi nel regno animale del suo
sistema della Natura . Finalmente, si vede da ciò
che abbiamo qui sopra esposto, che questi esseri
sono animali che non dimostrano alcun'anello,
alcun passaggio assoluto dal regno vegetabile al
regno animale.
-
Il Sig. Dottor Pallas ha pubblicato, nel 1766,
un'Opera latina, in ottavo sugli Zoofiti. Questo
dotto Autore ha fatto ricerche grandissime per
determinare e classificare gli esseri organizzati
dei quali si tratta. Dà egli a quasi tutti la de
nominazione di animal vegetante ; ed ecco il ri
sultato di sue osservazioni .
Gli Zoofiti o animali piante formano l'anello
di passaggio dai vegetabili agli animali. Riguar
da egli questa classe come l'unica provincia erma
frodita dell'Impero della Natura, e divide gli
Zoofiti in quindici generi principali; cioè:
O 2 I • N'Idra.
212 2 o o
1. L'Idra . Hydra, Fran Hydre. E' il polipo
di acqua dolce del Sig. di Réaumur, ed ilprotea
di alcuni Scrittori moderni ; e ne riporta quat
tro specre .
2 . L'Escara. Eschara, Fran. Escare . E' il flu
stra di Linneo; e ne descrive quindici specie ,
tra le quali si trovano la pietra di spugna delle
farmacopée , la falsa manichetta di Nettuno. Ge
neralmente l'Escara è un fusto sottile, foliaceo ,
quasi membranoso, composto di cellule tubula
te, sporgenti e disposte sopra più file , ed ogni
cellula contiene un polipo.
3 La Cellularia. Cellularia, Fran. Cellulaire .
E la corallina a cellule degli Autori. Ne rife
risce diciassette specie. E' ordinariamente un fu
sto ramoso, spesse volte articolato , composto
di cellule alterne o affastellate, e fissato alla base
per mezzo di tubetti; ogni celletta contiene un
polipo .
--
4. La Tubularia. Tubularia, Fran. Tubulaire,
E'la serie dei tubi a consistenza di corno . So
no flessibilì ed elastici . L'Autore fa menzione di
nove specie ,
5 . Il Polipo a braccia o in mazzetto. Brachio
nus, Fran. Polype d bras ou en bouquet. Ne ri
porta diciotto specie, che comprendono i vermi
che Linneo aveva chiamati vorticelli, a cagione
del vortice che eccitano nell' acqua. L'animale
descritto sotto il nome di rotifero, è di questo
genere Vedete anche l'articolo Polipo a braccia.
6. La Sertularia o Settularia. Sertularia aut
Sectularia, Fran. Sertulaire ou Sectulaire . E'una-- -
spe
o o 213
specie di corallina ramosa, tubulata, articolata 3
schiacciata , della consistenza del corno molle
Ne riferisce trentasette specie, come l' asperella
o còda cavallina marina , la cuscuta di mare, la
conca anatifera, la coda di volpe .
7. La Gorgone. Gorgonia, Fran. Gorgone. Con
tiene i ceratofiti o litofiti. ( La corteccia lamel
losa delle gorgoni è colorita 3 porosa o zigrina
ta . Boerhave l'ha chiamata tinanokeratophyte ) .
Gl'individui di questo genere hanno la tessitura
del corno , colla figura e flessibilità dei rami di
alberi. Questi corpi, propriamente parlando, al
tro non sono che lo scheletro dei polipi che gli
hanno abitati ed hanno ad essi dato la formia;
sono finalmente Zoofiti o piante animali per ecs
cellenza; tali sono il ventaglio di mare, Antipa
thes fiabellum, Pallas, il falso antipate, chiamato
impropriamente corallo nero, e una quantità di
altri. L'Autore ne riferisce trentuna specie.
8. L'Antipate : Antipathes, Fran. Antipaté
Produzione poliparia con fusto semplice o ramo
so, di natura cornea, semitrasparente, e la cor
teccia del quale non è in alcuna maniera calca
re , ma piuttosto gelatinosa . Sé ne contano die
ci specie, e queste specie si accostano molto al
le gorgoni . . .
9 . L' Iside; Isis. Nome che Liuneo ha dato
al genere dei coralli. Vi è il corallo rosso, i
bianco ( se ne trova di color violaceo e di
color giallo ), e il corallo articolato o rosso o
bianco. L'autore rifesisce quattro sole specie
d'isidi. Questi fusti ramosi, continui o composti
O 3 di
214Z O Ci
-
di articolazioni calcari, sono coperti all'esterno
di un' invoglio friabile, seminato di cellule, cia
scuna delle quali contiene un polipo.
1o. La Millepora, Millepora. E' dura, calca
re, sinuosa o ramosa; è di una sostanza conti
nua e adorna nella superficie di piccolissimi po
ri, clie sono numerosi , cilindrici e stellati, coa
me nella madrepora . Se ne contano diciotto
specie; tali sono la frondipora, la
nichetta di TNettuno , la coralloide violacca delle
Filippine, il corno di daino, etc.
1 i . La Madrepora, Madrepora . Questi poli
parj sono sempre ramiosi o cellulari, duri e cal
cari. L'autore ne riferisce 35 specie ; tali sono
il fungo di mare , il beretto di Nettuno, il cer
vello di Nettuno, l'amaranto di mare, il garofa
no di mare, il gran poro o acroporo, il corallo
bianco delle officine, la gran madrepora stellata,
l'astroite, l'abrotanoide, etc.
2. La Tubipora, Tubipora. E'composta di can
nelli o tubi solidi, paralleli , perpendicolari, di
stintamente separati gli uni dagli altri, e con
giunti insieme ciò non ostante da tramezzi tra
sversali , ogni tubo è composto di articolazioni
e terminato in cima da un rivolto schiacciato e
radiato ; tal'è la canna d'organo .
13 . L'alcione, Alcyonium. Gli Alcioni han
no un'invoglio cartilaginoso e tutta la sostanza
molle, in cui si osservano molti pori stellati;
tal'è l'Alcione arborescente di Norvegia, la ma
mo di mare o di ladro ; il pomo o borsa di ma
re, l'uva di mare, il polmone di mare, la té
thye,
Zo o -
215
thye, il vespajo marino, &c. Le specie di que
sto genere sono dodici.
14. La Pennatula, Pennatula. E' composta di
un fusto coriaceo o carnoso, ordinariamente li
bero o non fissato , nudo alla base , corrugato
o alato e dentato verso la cima : il giro supe
riore delle alette è guarnito di polipi ed evvi
nell'interno una specie di osso ; tali sono lo Zeo
fito del mare di Groenlandia, la penna marina,
la freccia marina , &c., e questo genere com
prende undici specie .-
15 . La Spugna, Spongia . E' il lavoro e il ni
do di certi vermi . La superficie di questa pro
duzione, fibrosa, flessibile, porosissima, sempli
ce, tubulosa o ramificata , è coperta di una vi
scosità sensibile e seminata di aperture che as
sorbiscono l'acqua; l'autore ne riferisce ventotto
specie -
Così il Sig. Pallas stabilisce quindici generi di
Zoofiti , i quali generi comprendono duecento
cinquanta specie .
Aggiunge alla serie degli Zoofiti e ne forma
un'appendice , tre generi dubbi , Genera ambi
gua . Il primo comprende sette specie di tenia;
il secondo, la famiglia dei volvoci, dei quali ri
ferisce due specie. Questo secondo genere, il
volvoce, è stato scoperto dai Signori Baker e
Roesel, ed è un animalculo di una struttura uni
forme, che sembra un globetto senza organizza
zione ; e si muove ciò non ostante e va avanti
come gli piace nelle acque dolci che ne sono
'abitazione . Nuota ravvolgendosi sul proprio asO
Se
2 16 Z O ()
maa
se per passar da un luogo all'altro, e riceve ff
nome da questa maniera di muoversi . Se ne
trovano nell'acqua corrotta dei letamaj; (si vuo
le che se ne trovino anche neil'infusione del se
me di canapa ed in quella della tremella ) . So
no dapprincipio piccolissimi; ingrossano in segui
to a segno di esser distinti colla nuda vista: so
no di un color verde giallastro e di una sostan
za membranosa e trasparente. Il volvoce, esami
nato col microscopio , comparisce composto di
una congerie di granelletti o uova, come l'idra
e proteo. Dicono altri, che il mezzo della so
stanza membranosa racchiude molti globi più pic
eoli , nei quali sono incassati altri globi , che si
edistaccano successivamente dai gobetti genitori -
Pretende il Sig. Pallas che le molecule organiche,
che si trovano nel seme degli animali grandi, sta
no enti animati, appartenenti a questo genere
d'individui. ( Noi sappiamo che la legge la qua
le stabilisce la necessità del concorso dei due ses
si, è ben lontana dall'esser generale ; che la na
tura vi ha fatto eccezioni numerose , che nella
classe degli insetti, in quella dei vermi ed in
euella dei conchigli vi sono molti generi, ogn'
individuo dei quali riproduce il suo simile senza
il concorso di un' individuo maschio ; che sem
bra che aecada lo stesso in quasi tutte le specie
di animalculi microscopici, che in molti di que
sti la cosa è certa; e che sono state vedute e ri
vedute la terza, la quarta e fino la quinta gene
razione, rinchiuse nei volvoci grandi. Vedete ades
so, all'articolo Corgoglione, la generazione di que-
- Stl
Z O O 217
sti animali). Il terzo genere comprende le coral
tine le quali Imperati ha disegnate sotto il titolo
di nodularie; e le quali, secondo il nostro Auto
re, appartengono al regno vegetabile ; come il
fuco, la penna di pavone, l'androsace e la coral
lina articolata delle officine; ( noi poniamo quest'
altima tra i poliparj. Vediete Corallina) . Questo
genere contien tredici specie .
Diciamo adesso, col Signor Bruguiere, che i
Vermi-zoofiti, creduti una volta vegetabili , ri
guardati in progresso come anelli di connessione
tra il regno animale e il vegetabile, ed ugual
mente mal conosciuti sotto questo punto di vi
sta, sono proprj a tutti i climi, ma molto più
abbondanti sotto i mari dell'Equatore che sotto
le acque agghiacciate dei Poli : influiscono essi
più potentemente che altrove sul cangiamento
delle coste , se vi ostruiscono l'ingresso di una
rada, coll' erigere una diga impenetrabile ai va
scelli; per altra parte questi vermi, segnatamen
te quelli di trasudazione pietrosa , giungono a
chiudere un porto, ed esercitano così le funzio
ni alle quali sembra che siano stati destinati ,
quelle cioè di produr la terra calcare, o di unir
ne insieme le molecule disperse. Vedete agli ar
ticoli Pietra calcare , Corallo , Coralline, Fossili,
i monumenti che fanno fede dell' esistenza di
queste sorte di vermi , e che provano, da una
parte la continuità dei lavori, che han fatto dai
primi tempi del mondo, e dall'altra il punto di
vista sotto il quale questi animali sono intima
mente legati all' organizzazione fisica del nostro
glo
18 Z O O
globo. Finalmente i vermi dei quali trattiamo
sono stati osservati con quella curiosità che pos
sono ispirare unicamente gl'interessi più grandi;
e tai ricerche hanno fatto conoscere ehe le fa
coltà dell'animalità sono diverse nei vermi-Zoo
fiti, &c., e forse più estese che nei quadrupedi;
e finalmente che lo spazio che occupano nella
Natura è immenso e di gran lunga superiore a
quello che occupano tutti gli altri animali presi
ZOOFITOLITI, zoophytolithi. Nome che si
dà ai fossili o alle petrificazioni degli Zoofiti ar
borescenti : tali sono le stelle di mare di rag
gi intieri, o della specie che si chiama capellu
ta, delle quali spesse volte si trovano le sole
vertebre. Vi sono gli stelliti, le asterie, gli en
trochi stellati, gli encriniti, i trochiti o trochi,
gli entrochi radiati, le vertebre del giglio lapi
deo o di pietra, &c. Vedete queste parole .
ZOOGLIFITI. Nome dato a certe pietre figu
rate che rappresentano impronte di animali .
ZOOLITI. Lat. Zoolithae. Si dà questo nome
ad alcuni parti dure di animali divenuti fossili ,
e conservate in diversi stati . Questi fossili o pe
trificazioni sono rarissime in alcuni paesi, ed ab
bondanti in altri. Alcuni confondono malamente
gli Zooliti colle ooliti; Vedete quest' ultima pa
rola, e gli articoli Petrificazione e Fossili . L'avo
rio fossile e le turchesi sono specie di Zooliti .
Si veggono in uno dei Gabinetti di curiosità a
Chantilly, tre pezzi di corna di cervo petrifica
ti, e due grossissimi pezzi di difese ossee o zan-
) e
Z O R 219
he di elefante , ed una costa di balena . Lin
neo parla di un cervo petrificato trovato a Gi
nevra; ma quante altre petrificazioni non vi so
no, e che sono altrettanti monumenti della ca
tastrofe del globo terrestre ?
ZOOLOGIA, Lat. Zoologia. Cosi si chiama la
scienza che tratta di tuttigli animali della Natura,
e questa scienza si divide in altrettante parti sepa
rate, quante sono le classi degli animali; cioè :
l'Antropologia o la Storia dell'Uomo; la Tetra
podologia , o la Storia dei Quadrupedi: si chia
ma l'ornitologia, quella degli Uccelli; Anfibiolo
gìa, quella degli Anfibj; Ittiologia, quella dei
Pesci . Entomologia, quella degl'Insetti. Zoofito
logìa , quella degli Zoofiti; Gammarologia, quel
la dei Crostacei; Conchiliologìa, quella delle Con
chiglie : Elmento logìa quella dei Vermi.
ZOOMORFITI. Questa parola serve per dise
gnare certe pietre, che hanno qualche somiglian
za con alcuni animali noti. Si dà il nome di Fi
tomorfiti alle arborizzazioni . Vedete l' articolo
Dendriti. Alcuni Naturalisti moderni, riguardano
i Litofiti, come animali Fitomorfi .
ZOOTIPOLITI , Lat. zootypolithi. Si dà que
sto nome alle pietre che portano l'impronta di
qualche animale o di alcune di sue parti. Vede
te Impronte.
ZOPISSE, nome che si dà al catrame secc
che si distacca dalle navi al ritorno da un lun
go viaggio. Vedete Catrame all'articolo Pino.
ZORILLO. Nome dato a un'animale del Pe
rù, che forma la quarta e la più piccola specie
delle moffette. Vedete questa parola.
28 U C
ZORINO Vedete Liana rossa .
ZOUCET oZOUCHET. Vedete Colinho di fiume;
ZUCCA. Lat. Cucurbita . Fran. Courge. Nome
di un genere di piante della famiglia delle Cucur
bitacee, così chiamate dal nome latino Cucurbita
Questo genere di piante ha molte relazioni cói ce
triuoli; ma n'è distinto pei semi che hanno un'
orlo particolare e rimarchevolissimo : comprende
erbe striscianti, munite di urili, a foglie alterne ;
i fiori sono monoici , cioè tutti di un sesso so
lo ; ma i maschj e le femmine si trovano uniti
sul medesimo individuo ; questi fiori hanno la
corolla monopetala, campanulati, col lembo di
viso in cinque incisioni ascellari; el'orlo del ca
lice è terminato da cinque denti in lesina . I
frutti sono grossi pomi polputi, sugosi, divisi
interiormente in tre o cinque celle, da tramez
zi molli e membranosi, e queste celle conten
gono semi numerosi, schiacciati, bislunghi, &c.
La maggior parte delle piante di questo gene
re, serve di alimento ed ad altri usi ; e tra di
esse si trovano le più grosse della famiglia del
le cucurbitacee e quelle che hanno i frutti più
grossi che siano a nostra notizia . Sono inoltre
interessantissime pel numero prodigioso di razze
e di varietà che vi si osservano e per le diffe
renze grandi che si incontrano tra alcune .
Tutte le specie di Zucche che esamineremo
nel progresso di quest'articolo, sono riguarda
te, al dir dei Signori De la Marck e Duches
ne, come annue, ma nei climi caldissimi, d'on
de sono originarie, debbono esser annue persi
sfega
-
2 U c 22
stenti, perchè i rami che strisciano per terra,
vi prendono radice per una gran parte dei nodi
che hanno, e ne ripullulano incessantemente al
tre nuove, bene spesso anche dopo l'intiera ma
tarità dei frutti ; il the non accade alle specie
puramente annue . Tutte le parti della pianta so
no piene di pelli permanenti, trattone il frutto
solo dal quale cadono quando comincia a ingros
sare e ne lasciano la buccia intieramente liscia.
Le Zucche si distinguono in quattro specie prin
cipali, e che esibiscono la Zucca dai fiori bian
chi te zucche larghe semplicemente dette , le
zucche grosse, i Poponi , le zucche nostrali, le
zucche indiane o di Virginia, le Zucche a berlin
gozzo, a pasticcino o a corona, i carciofi di Ge
rusalemme, le false coloquintide, il cocomero, o
sia pasteca, o anguria.-
1 . La Zucca dai fiori bianchi, cucurbita leu
santha, Duches. Cucurbita ( lagenaria) foliis sub
angulatis, tomentosis, basi subtus biglandulosis,
pomis lignosis, Linn. Fran. la courge a fleurs
blanches ou la calebasse. Ha le foglie quasi ro
tonde, di un verde pallido, molli, lanuginose,
leggermente appiccicaticcie e odorose, ed ha in
sotto due ghiandette coniche, vicino all'inserzio
ne del peziolo. Il fiore è bianco, molto strombato ed
a ruota, il seme è sottile , ma la pelle
grossa, e il cercine del giro dà a questi semi
una figura quadrata. La polpa del frutto è spu
gnosa, bianchissima; la pelle, dapprincipio di un
verde pallido, diviene di un giallo sporco nella
maturità . I furti variano molto quanto alla fi-
gu
222Z U C
gura e quanto alla grossezza ; ciò non ostante
queste varietà possono ridursi a tre razze prin
cipali; cioè:
a, La zucca dei pellegrini o la zucca da be
re , cucurbita lagenaria , Tourn, 1o7; & fiore
albo , folio molli , Bauh. Pin. 313 , Fran. la
cougourde ou la gourde des Pelerins, ou la Cour
ge-Bouteille. Queste denominazioni indicano la
figura del frutto. La parte della coda ( del pe
duncolo ) si trova diminuita, non in forma di
era, ma in forma di collo allungato o di col
o di bottiglia. Altre volte questa parte vicina
alla coda si gonfia , imitando più in piccolo la
figura del ventre, dal quale non rimane separa
ta, se non che per un semplice stringimento
Vi sono alcuni di questi frutti macchiati di un
color più cupo , cucurbita lagenaria variegata,
Tourn . La Zucca dei pellegrini è la razza che
ha i frutti meno grossi.
b. La Zucca larga semplicemente detta, Cucur
bita latior, Dod. Pempt. 669; Cucurbita major
sessilis, fiore albo . Bauh Pin. 312, Fran. la
Gourde simplement dite. E' la Zucca da pescare,
d'invoglio duro e di grossi frutti rigonfi . E'
quella di cui si servono i nuotatori principianti,
per sostenersi più facilmente alla superficie dell'
acqua, attaccandosi alle ascelle uno di questi frut
ti secchi e vuoti, ed in conseguenza pieni d'aria.
Questa Zucca , chiamata in Francese calebasse,
ha fatto passare nell' isole francesi di America il
nome di calebassier. Vedete Zucca arborea o al
bero cucurbitifero, il qual nome è stato dato all'
Z U C23
albero che porta i eeuis , e la polpa dei quali
serve per fare il siroppo di calebasse . Questa
Zucca medesima è quella che, per la sua forma e
per la sua grossezza, ha fatto dare alla parte in
feriore dei lambicchi il nome di cucurbita. , Le
foglie ne sono leggermcnte dentate, come nella
razza seguente .-
c . La Zucca lunga o a tromba , Cucurbita lon
gior , Dod. Pempt ; Cucurbita Americana teres &
cubitalis, Tourn. Fran. la Courge longue, ou la
Courge-Trompette. La lunghezza grande dei frutti
in questa razza, dipende in gran parte dalla si
tuazione in cui si trovano . Posati in terra, si
curvano spesse volte in forma di falce o di luna
falcata, o anche si enfiano alle due estremità in
forma di pestello ; e se ne trovano parimente di
più e meno grosse ; le più grosse hanno la buc
cia più tenera e la polpa un poco più carnosa;
si mangiano in America e nella parte meridiona
le dell' Europa, anche fino a Lione, ove si chia
mano tromba e Zurca a tromba . Bisogna coglier
le come i cetriuoli , molto prima della maturità,
quando sono giunte alla metà della grossezza o
ai tre quarti al più . Le Zucche a tromba di frut
to lungo e stretto, che si trovano in Africa, e
sono state trasportate in America, hanno la buc
cia più dura ; e quando sono secche, i Negri le
vuotano, e ne fanno una specie d'istromento di
musica , da cui traggono il suono percuotendone
l'apertura colla palma della mano , come sopra
un bussolotto da giuocare ai dadi .
“ Sembra che gli antichi abbiano avuto cognizio
224 Z U C
ne di queste razze di Zucche ; e sembra ugual
mente che i Viaggiatori ne abbiano trovate nell'
America Meridionale, siccome in Amboina, ed in
altre contrade delle Grandi Indie, e che da que
sto tempo se ne sia moltiplicato il numero del
le razze .
E' noto che , quando ne sono ben secchi i
frutti, hanno la corteccia dura e come lignea ;
ed allora si vuotano e se ne fanno ( particolar
mente coi frutti dclla Zucca dei pellegrini) fia
schi o bottiglie e diversi altri comodi utensili
dei quali si servono i viaggiatori e la povera
gente - -
a . La zucca grossa o di frutti grossi , Cucur
hita maxima, Duch. . Melopepo fructu maximo al
ho, Tourn. 1o6; Cucurbita aspera folio non fisso ,
fructu maximo albo sessili, Giav. Bauh.2 ,p. 221;
Pepo compressus major, Bauh. Pin. 311 ; Cucur
bita pepo, Linn., Fran. Le potiron. Questa specie
di Lucca differisce dai poponi propriamente det
ti, pei fiori più strombati nel fondo del calice e
che hanno un lembo rivoltato in una maniera ri
marchevole; ne differisce per le foglie cordifor
mi, quasi orizontali, più grandi, di peli meno
rigidi, e la sostanza delle quali è più molle; il
frutto generalmente è più grosso e più costante
nella forma sferica, compressa, di coste regola
ri, ed a solchi considerabili alla testa e alla co
da , sphaera polis compressis, meridianis sulcatis,
Sauvag. : la polpa èpiù consistente, ma si scioglie,
in bocca ciò non ostante, ed è piena di sugo; la
buccia è fina, come nella maggiorparte delle Zuc
che
Z U C 225
aaaaaaa
che a berlingozzo a pasticino o a corona . Ben
chè esistano molte varietà nella specie delle Zuc
che di frutto grosso , niuna, secondo il Signor
Duch., partecipa della natura delle Zucche no
strali, colle quali sono state spesse volte coltiva
te e frammischiate .
Le Zucche grosse esibiscono tre varietà , cioè:
a . La Zucca grossa gialla comune, Fran. le po
tiron jaune commun . Questa tinta di giallo è
sempre rossigna , per quanto sia pallida, e se
ne trovano ancora alcune che sono quasi di co
ler di bronzo . Vi si osserva per lo più una li
sta biancastra, nel fondo. del solco, tra le coste;
questo sito è il più liscio ; ed il rimanente della
pelle, soggetto a certi piccoli screpoli e cicatri
ci bigiccie, è talvolta, come ricamato ad imita
zion del popone. La Zucca grossa gialla è la
più voluminosa , ma anche la più vuota; se ne
trovano ciò non ostante bene spesso del peso di
trenta o quaranta libbre (di Francia ); e talvol
ta di cinquanta o sessanta. Il colore della polpa
è di un bel giallo; che quanto è più vivo, tan
to più la Zucca è saporita . Non se ne mangia
la polpa cruda , perchè è nauseante ed insipida ,
ma se ne fa uso nelle minestre, e se ne fanno
conserve. La decozione di questa polpa passa per
rinfrescativa; la sostanza e, per buona negli ar
dori di viscere e nelle costipazioni che dipen
dono da questa causa . Rilassa le prime vie, e
passa ben presto per secesso .
b. La Zucca grossa verde maggiore. Questo
verde è sempre bigiccio e talvolta si accosta al
B0m.TXXXJX. P CG)
226 2 U C
color d'ardesia. E' soggetta alle liste bianche,
come la Zucca grossa gialla; anche la polpa va
ria di colore, vedendosene alcune , il giallo del
le quali si accosta al rosso d'arancio . General
mente le Zucche grosse verdi, un poco meno vo
luminose, si conservano perpiù lungo tempo, e
passano per le migliori
c . La Zucca grossa verde minore. E' una sotto
varietà, chevien distinta e ricercata, perchè ilfrut
to di essa, molto compresso, più pieno, e meno
abbondante di acqua, si conserva molte settimane
di più e buono a mangiarsi fino al fine di
marzo. Tutte le Zucche grosse hanno i fiori gialli ,
3 . La Zucca di lembo dritto o il Popone , Cu
curbita ppo, Duch., Fran. la Courge a limbe droit
ou le pepon . I poponi hanno come le Zucche
grosse, il fiore giallo ; ma nel popone , il fon
do della corolla è ristretto quasi in imbuto e il
lembo non è mai rivoltato. In ambedue le spe
cie, i semi,sono elittici, non tronchi, nè in
cavati/ in cina, e biancastri o di un color più
pallido della polpa che li contiene. Le due raz
ze principali che comprende la specie del popo
ne, sono la Zucca popona, e la zucca polimorfa,
a La Zucca popona, Cucurbita pepo moschata,
an Cucurbita major rotunda , flore luteo , folia
apero ( dulciter ) ? Bauh. Pin. 312 . Il sopran
nome di zucca Popona che le danno i Creoli nel
le Antille Francesi, e quello di Zucca moscata,
che l'è stato dato in Italia e in Provenza, ove
questo popone si coltiva, indica abbastanza il
conto che ne fanno questi popoli. Nelle provin
cie Francesi fredde, le Zucche popone non ven
/
/
z U C 227
e---
gono bene senza l'aiuto delle stufe, e richicdo
no altrettanta diligenza quanto i cocomeri . La
Zucca popona è una razza ambigua di sua natu
ra; si accosta ai poponi per la forma dei semi,
per l'aspetto e il colore della corolla, per la di
sposizione dei rami e per la figura angolosa del
le foglie , mentre la mollezza di queste foglie
medesime , la peluria gentile e fitta, la pallidez
za dei fiori esteriormente, lo stringimento nel
fondo del calice , l'allungamento delle punte ver
di esteriori del calice , e il sapore moscato del
la polpa del frutto, le danno molta analogia col
la specie delle Zucche dai fiori bianchi. Questa
polpa è parimente più secca di quella delle Zuc
che Indiane ed ha le fibre più fine ; ma è nel
tempo stesso più consistente di quella delle Zuc
che lunghe o a tronba , e partecipa in questo
di quella delle Zucche a berlingozzo. Del rima
nente si osserva nella razza della Zucca popo
na, un numero assai grande di varietà o relati
vamente alla forma del frutto, schiacciato , sferi
co, ovale , cilindrico, a clava, apestello, più o
meno grosso e a coste più o meno espresse, o
relativamente al colore, di un verde più o me
no cupo, fuori e dentro, dal giallo di zolfo più
pallido, fino al rosso d'arancio.
b . La zucca popoma polimorfa, Cucurbita pepo
polymorpha Duch. , Fran. le Pepon polymorphe. Il
carattere di quest'altra razza principale, che com
prende le Zucche comuni, le Zucche indiane, le
Zucche a berlingozzo, e le false coloquintide, sem.
bra che sia l'incostanza medesima, e deve pa-
P 2per
a 28 Z U C
rer difficile a descriversi, quando si concepisce la
mutabilità di sua figura in quasi tutte le parti -
La grandezza dei fiori, la forma di essi regolar
mente conica, la direzione obliqua o quasi retta
e non mai orizontale di sue foglie, il colorbru
no, l'asprezza che risulta da una parte della so
stanza di esse , fragile e secca per se stessa ,
mentre le coste e le grosse fibre ne sono estre
mamente aquee, e dall'altra, dalla forma dei pe
li rigidi alla base, e tumefatti, che vi si trovano
seminati , questo , dicono i Signori Duchesne e
de la Marck, è tutto ciò che si può osservar di
comune tra le piante che quì si raccolgono sot
to il nome di Zucca popona polimorfa.
Sembra necessario , prima di determinar le
razze, di dar qui luogo ad alcune osservazioni,
le quali, senza esser generali, sono almeno cos
muni a molte . 1 . I frutti, il color verde dei
quali è il più nero, sono quelli che maturando
si , acquistano la tinta di giallo più carica, se
gnatamente dalla parte del sole, perchè risulta
dalla privazione della luce di quest'astro, che la
parte inferiore del frutto che posa in terra, im
bianchisce . 2 . Quando i frutti sono variamente
listati, ciò accade sempre nel mezzo o ai tre
quarti del giro di essi, ove la buccia è meno
grossa , e più vicina alla coda che alla testa;
ed essendo la zona verde della testa più grande
e più rigonfia di quella della coda, è parimente
quella alla quale corrispondono i tramezzi del
frutto che contengono i semi . 3 . Quando ifrut
ti, non sono listati, le zone verdi della testa e
del
7 t) -
229
della coda esibiscono certe punte principali dell'
una relativamente all' altra, come per avvicinar
si; ed essendo il numero di queste punte in cor
rispondenza coll'interno del frutto , indica il nu
mero dei tramezzi c delle celle, che è ordina
riamente dalle tre alle cinque ; si crede di avere
osservato che le altre piccole punte che si veg
gono su i frutti grossi, siano meno espresse, ed
in corrispondenza colla struttura interna del fio
re e dei sostegni di esso. 4. Ciò che abbiam
detto adesso relativamcnte alle fascie o punte
principali, e che sono ordinariamente staccate dal
chiaro o dal bruno, talvolta dal bianco di latte,
sul rimanente del frutto , ha luogo per quella
specie di moschini che ne sono semplicemente i
frammenti ; questi moschini sono più o meno
grandi, più o meno collegati, e più o meno nu
merosi sul fritto ; assai quadrangolari e non mai
rotondi, cd anche meno stellati, come sono i mo
schini di diversi cocomeri. 5 . Le impressioni
o alterazioni di colore, che non dipendono dal
sole, ma dal passaggio dei vasi alimentari , for
mano le liste o fascie colorite e i moschini so
prammentovati; il passaggio di questi medesimi
vasi, più o meno libero, e sotto la buccia del
frutto giovane, vi cagiona talvolta una disugua
glianza di accrescimento ; e il frutto , nel ma
turarsi, perde la forma rotonda, per divenire o
semplicemente costato, come nelle Zucchie india
ne, o cornuto come nelle Zucche. aberlingozzo.
Un' altro stato di alterazione è ciò che si chia
ma le verruche, e che sembrerebbe meglio dise
P 3gna
23oZU C
gnato col nome di bernoccoli, perchè non sono
escrescenze puramente esteriori, ma tumefazioni
vuote del guscio, che formano interiormente al
trettante cavità corrispondenti , benchè più pic
cole in proporzione , attesochè il guscio è ivi di
una grossezza maggiore . Questi bernoccoli sono
di due sorti ; ora larghi al piede e poco elevati ,
ora più alti e strozzati al piede ; prendono essi
la forma di tumori; talvolta questi tumori sono
aggruppati gli uni sugli altri: è da presumersi
che una tal difformità è un vero stato di malat
tia, poichè i frutti nei quali arriva a quest'ecces
so, non hanno alcun buon serme ma unicamente
alcuni imperfetti rudimenti . Certe Zucche popo
ne si trovano semplicemente ondate ; e sono
quelle che hanno il guscio meno duro , e ciò
non ostante la polpa aquea, perchè nelle Zucche
a berlingozzo o a pasticcino, che hanno la pol
pa asciutta e consistente , la buccia è finissima,
e nel tempo stesso liscissima . Finalmente alcune
Zucche popone sono , direm cosi , ricamate co
me il popone, e questo ricamo granoso di un
bigio rossigno , non passa più oltre della buccia ,
e si vede soltanto sopra certe parti che esibisco
no nel tempo stesso alcuni screpoli, più o me
no profondi . Passiamo adesso alla descrizione
delle razze secondarie delle Zucche popone po
limorfe .
Le false coloquintide, che i Francesi chiamano
coloquinelles, fausses oranges, ou orangines, Cu
curbita polymorpha colocyntha, Duch.; Pepo ro
tundus auranti forma , Bauh. Pin. 311. ; Pepo
fra
-
2 lj 6 23 i
fractu minimo spherico, Tourn. 1 o5., Fran. les
fausses coloquintes. Questa pianta è fecondissima;
il frutto è della grossezza di un gross'arancio ,
regolarissimamente a tre celle, ed abbonda di
semi assai grossi ; la polpa è giallastra e fibrosa
questo frutto è un poco amaro , si secca facila
mente ed acquista allora un'odore un poco mu
schiato, formando la pelle di esso un guscio asa
sai solido , di un verde nero quando è fresco ;
e nella maturità, di un giallo di arancio vivissi
mo. Ve ne sono alcuni che variano per la gros
sezza , che sono di color pallido, e che
ta rimangono verdi quasi tutto l'inverno. Fi
nalmente, ve ne sono altri a guscio listato, e
questi sono varietà che risultano dal miscuglio
lle razze,
La zucca a peretta, che i Francesi chiamano
ancora false pere o coloquintide lattee , cucurbita
polymorpha pyridaris, Duch. ; colocynthis pyri
formis, seu amarus, Bauh Pin. 313, Tourn.
1 o8; Cucurbita ovifera , Linn.Mant. 126, Fran,
la cougourdette ; ha il frutto più piccolo di quel
lo delle false coloquintide ; ha la forma d'uovo,
o di pera ; il guscio grosso e solido ; la pelle di
un verde bruno, segnata di liste e di moschini
di un bianco di latte la polpa fresca dapprinci
pio ed in seguito fibrosa e friabile.
La Zucca a cedrato, Cucurbita verrucosa . C.
Bauh., Lin. Melopepo verrucosus, Tourn. Fran.
la barbarine ou barbaresque. Generalmente il frut
to delle Zucche a cedrato è più grosso di quello,
della Zucca a peretta; la corteccia ugualmente p4
du
232 Z U C
dura , ma ordinariamente bernoccoluta o verru
cosa, gialla o variamentè listata, e talvolta se
gnata di liste verdi. Ve ne sono di orbiculari,
di sferico ovali e di allungate a cetriuolo-
Le Zucche indiane e di Virginia e le Zucche
nostrali, Cucurbita polymorpha oblonga, pepo Vir
ginianus: pepo oblongus, Bauh.. Pin. 311 , Tourn
105 ; pepo major oblongus, Dod. Pempt. 665 ;
cucurbita folis asperis, sive zuccha, flore luteo,
Giov. Bauh. 2, 2 18; Cucurbita pepo, Linn. pe
po vulgaris, Macoks Virginiani, Ray Hist. 639
e 641. Fran. Les giraumons & les citrouilles. Le
Zucche Indiane e le Zucche nostrali possono es
ser riguardate, al dir dei Signori Duchesne e
de la Marck, cpme semplici razze di una mede
sima specie colle più piccole tra le Zucche po
pone polimorfe delle quali abbiamo più sopra
parlato . Vogliono essi che la sproporzione di
volume che si trova tra questi frutti , non sia
n ostacolo alla loro asserzione, tanto più che
si trovano alcuni di questi frutti di razza mista,
segnatamente nelle Zucche a cedrato, che fanno
anello e rendono il passaggio insensibile.
Le Zucche indiane si possono distinguere dalle
nostrali, per una polpa ordinariamente più pal
lida , e sempre più fina ; sembra ugualmente che
abbiano in generale le foglie più profondamente
frastagliate di quelle delle Zucche comuni, che
sono per lo più semplicemente angolose ; ma
queste leggiere differenze sono per altra parte
meno sensibili di quelle della forma e del colo
re del frutto. -
Si
Z U C 233
aaaaaaaa
Si distingue la Zucca comune verde , di pelle
tenera, lucidissima, di polpa coloritissima , tal
volta variata di giallo. La Zucca bigia, di un
verde pallido , di una forma ovale, un poco a
pera. La Zucca bianca, scolorita, e nel tempo
stesso così molle, che il proprio peso le fa per
der la forma naturale, che è ugualmente a pera -
la Zucca gialla, ugualmeote ritondata ai due ca
pi, e la più comune a Parigi, prima che la Zue
ca grossa (potiron ) l'avesse fatta abbandonare,
cucurbita pepo, oblongus, vulgaris; le Zucche fi
nora riferite sono le comuni o volgari.
Tra le Zucche Indiane e di Virginia ( girata
mens ), si distinguono quelle che sono verdi ,
bernoccolute, di enorme grossezza ed eguali ai
due capi , come le Zucche comuni . La Zucca
indiana nera , fina dalla parte della coda , di
pelle liscissima , e di polpa consistente ; pro
duce essa talvolta alcune varietà ; le une di un
verde pallido, le altre a liste , altre totalmente
gialle ed uguali ai due capi; vi è un'altra varie
tà perfettamente nera , e che va assottigliandosi
solamenté verso la testa , ed un' altra finalmente
screziata di giallo verso la parte della coda. La
Zucca indiana rotonda, di un verde nero, gros
sa talvolta come la Zucca di frutti grossi, segna
ta talvolta di liste e di moschini pallidi. Si so
no vedute alcune di queste Zucche che richiama
vano l'attenzione per l'estensione prodigiosa che
aveva preso quella parte che si chiama occhio, e
nella quale si trovava il sito degli stimmi del
fiore, disegnato in una maniera straordinarissima --
-
Le
34 , z ti c
Le fecondazioniintersecate ossia triste, hanno
renduto la razza delle Zucche indiane, origina
riamente domestica ed invariabile, non meno ina
costante di qualunque altra ... La grossezza e la
forma della varietà della Zucca indiana rotonda,
fanno presumere che sia la prima per la quale
sia stato usato il nome francese giraumon (gira
monte), che significa propriamente un monte che
gira . Le Zucche indiane o a liste , chiamate da
ungo tempo cetriuoli di Malta o di Barbaria, e
da alcuni , Zucche Irrochesi ; questi frutti sono
variatissimi, scherzano tutti nella forma e nel co
lore come i precedenti, e si riducono alla mie
desima natura di essi ; ve ne ha parimente che
sono traversati da un numero assai grande di
screpoli per tutte le direzioni o da moschini fi
inissimi ; alcuni hanno bernoccoli enormi, e le li
ste non hanno tutte i medesimi gradi di colore .
Le Zucche indiane bianche , cioè di un giallo
pallido, chiamate da alcuni cetriuoli d'inverno ,
possono esser riguardate come le più degénera
te delle precedenti ; e sono in fatti comunemen
te le più piccole . Finalmente, la Zucca indiana
verde , tenera, a liste e a moschini, o carichi,
o pallidi, forma un'ultima varietà poco costan
te , ma che interessa l'attenzione, attesochè que
sto colore indica ordinariamente quelle, la pol
pa delle quali è più delicata a mangiarsi.
Le zucche a berlingozzo ossia a pasticcino o a
corona, chiamate ancora dai Francesi berretto di
Elettore, berretto da Prete , corona Imperiale ,
carciofo di Gerusalemme o di Spagna,
A
Z U C 235
d'Astracan, melopepo clypeiformis Bauh. Pin. 312 ;
Tourn. 1o6; Cucurbita melopepo , Lin. Fran. les
pastissons. La razza di queste Zucche esibisce pian
te difformi e come rachitiche ; lo stato di con
trazione da cui sono affette, si manifesta ini
tutte le parti di esse ; e questa malattia eredi
taria si perpetua da molti secoli più o meno
costantemente, ma si riproduce sempre pel pia
cere che si ha di ripiantare i semi dei frutti che
sono più regolarmente deformati. Questi frutti
hanno generalmente la pelle fina come le false
coloquintide , ma ordinariamente più nolle ; la
polpa più consistente e molto asciutta , per lo
che si conservano lunghissirno tempo , benchè
perdano facilissimamente la coda o gambo. Quan
to alla forma, se ne trovano alcuni rotondi, pi
riformi o turbinati; ma più spesso ancora nelle
razze domestiche, come se fossero stretti dalle
fibre nervose del calice , la polpa si gonfia e
sfugge negli intervalli, formando ora dieci coste
in tutta la lunghezza e solamente più elevate
verso il mezzo, ora prominenze dirette verso la
testa o verso la coda, la quale circondano in co
rona. Altre volte ancora il frutto si trova stroz
zato pel mezzo, e rigonfio immediatamente in un
cappelletto largo , come nel fungo che non sia
ancora dilatato , o anche finalmente, è intiera
mente appianato a modo di scudo, e talvolta più
o meno regolarmente increspato . Le celle della
polpa sono in questi frutti spesse volte in nume
ro di quattro o di cinque . Una parte dei semi
è gobba, e tutti sono cortissimi, e quasi di for
338 z tj C
“maesa
ma rotonda, secondo la proporzione che si osa
serva in generale nelle Zucche popone, i frutti
più lunghi delle quali hanno parimente i semi
più lunghi. Quanto al nome di pastisson (Zucca
a pasticcino) che si usa in Provenza, dev'essere
stato dato a questi frutti , per rapporto alla for
ma che hanno simile a quella di diverse specie
di pasticci . Fin dal principio della vegetazione ,
i rami della pianta, più consistenti, per la vici
nanza considerabile dei nodi , invece di strisciar
mollemente, si gettano dall'uno e dall'altro lato,
alcuni anche verticalmente e non calano final
mente in terra , se non che strascinati dal peso
dei frutti; i peduncoli dei fiori maschj sono lun
ghissimi, non meno che le code delle foglie che
sono talvolta attortigliate o undulate ; la forma
totale della foglia è allungatissima; ne sono poco
sensibili gli angoli ; e gli urili non hanno al
cun'uso.
Riguardo alle varietà o razze subalterne delle
Zucche a pasticcino, se , alle differenze nella for
ma esteriore del frutto, si aggiunga la presenza
o l'assenza delle liste e dei moschini , facilmente
si comprende che ne deve divenire assai conside
rabile il numero. Si possono consultare, a que
sto proposito, nel Gabinetto delle stampe, i di
segni del Sig. Duchesne e la spiegazione ragio
nata ch'egli vi ha aggiunta. Il Sig. de la Marck
fa menzione delle Zucche a pasticcino cedrato ;
questa razza mista esibisce frutti mediocri , allun
gati in forma di bottiglia , con protuberanze e
una pelle gialla dura, e n'è buona a mangiarsi
la
Z U C 237
-
la polpa. La Zucca a pasticcino cheimita laZuc
ca indiana o di Virginia, nota avarj dilettanti
sotto i nomi impropri di cetriolo di quaresima,
di zucca grossa di Spagna, e megliodisegnata col
nome curioso che le danno i Francesi di Pe”
toise ( sette a tesa ), che oltre la suafecondi
tà , richiama ancora "a vegetazione ristretta »
analoga a, quella delle Zucche a pasticcino . In
questa specie mista, irami sono talvolta così
strettamente ammucchiati, che formano unfolto
cespuglio, ed i frutti informi che sononel cene
tro legano tardissimo ; raccorciati ebernoccoluti,
stentano molto a maturare, e restano verdiIn
altri individui, i frutti dimediocre grossezza
hanno una pelle lucida e pallida, appena segna
di liste; ma nello stato di vigore » leZucche a
pasticcino, simili a quelle d'Indiasono allungate
in forma di clava, assai grosse»talvolta con al
cuni grossi bernoccoli, e dipintedi belle liste e
di moschini di color verde vivo sopra ifondo
di giallo di paglia un poco verdastro 3 el'aspet
to fresco di questo esteriore spicca ancoradi più
per la bianehezza della polpa,quando si taglia il
frutto. Questa polpa è finissima, si conservafi
no alla primavera, ed è piùdelicata a mangiarsi
di qualunque Zucca indiana -
4. Il cocomero o Pasteca o Anguria o ****
dalle foglie laciniate. Cucurbita anguria»Duch. 3
Cucurbita citrullus, Linn. ; Anguriacitrullus di
cta, Bauh. Pin. 32. Tourno6; citrullus fo
lio colocynthidis secto, semine nigro. Giov Bauli
2. p. 235 ; Anguria Indica , Rumph. Amb- 3C i
“238 Z UI C
r
Citrullus officinarum, Lob, Ic. 64o ; Jacé seu an
guria, Pis. Bras. 263, Franc. la Pasteque ou le
Melon d'eau, Courge a feuilles laciniées . Si vede
in Giov. Bauino, che il nome patheca, batheca,
albutheca, di Avicenna, viene da batice, che è il
nome indiano. Non si deve confondere questa
pianta colla Zucca nostrale, che è unaZucca po
pona, come abbiamo veduto qui sopra. Il coco
nero ha le foglie profondamente incise , consi
stenti, fragili, e la direzione di esse è moltopiù
verticale che nelle Zuccbe popone . Il fiore ha
la corolla meno strombata di quella delle Zucche
di fiori bianchi o da nuotare, menogrande, me
no campanulata , più profondamente incisa che
nelle Zucche popone, ed è inoltre di un giallo
meno carico. Il frutto è molto costantemente or
biculare, ha la pelle fina, liscia e moschinata di
macchie stellate, con liste pallide ; i seni , assai
rigonfi e con orlo rivoltato piccolissimo , sono
rossi o neri; la polpa sempre coloritissima , di
un giallo di zafferano o di cedrato, e così inten
sa nella maggior parte dei cocomeri, che si pos
sono succhiare e vuotare come una noce di coc
co per una apertura fatta alla pelle.
Sembra che i Provenzali ristringano il nome
di cocomero o pasteca alle razze, il frutto delle
quali si scioglie menoin bocca, e che si usa so
lamente in confezione col vino dolce , cotto a
modo di mosto , come si fanno le pere in Bor
gogna. Se ne coltivano in Santogna, che si man
giano fritti; e vi si chiamano improprissimamen
te col nome di concombre ( cetriuolo ) .
ClC
z U C 239N
che più si sciolgono in bocca sono chiamati co
comeri; e maturano gli uni e gli altri assai ma
le intorno a Parigi, anche nelle rimesse .
Sembra dal nome brasiliano , Jacé, attribuito da
Marcgrave al cocomero, che questa razza fosse
coltivata al Brasile; ma osserva il Sig. Duchesne
che i Portoghesi lo hanno forse portato in que
sta contrada del mondo. In fatti Prospero Alpi
no ne aveva veduti in Egitto di grossezza tale,
che un frutto solo faceva il carico di un uomo,
e tre o quattro, quello di un cammello. Parkin
son ancora riferisce e forse senza fondamento ,
una pasteca di America, di polpa consistente, etc.
Ray ne cita una specie, sull'autorità di Cisalpi
no, di polpa lignea e così consistente , che il
frutto balzava come un pallone , piuttosto che
spezzarsi . Sembra che l' Italia sia la patria dei
Cocomeri, ove comunemente crescono , hanno
la polpa rossa, sono di uno squisitissimo sapo
re, e dove crescono ad una prodigiosa grossez
za, specialmente nel territorio di Pistoja in To
SCd il2 e
Zucca della Guiana e del Brasile. Vedete Ca
lalou .
Zucca Arborea, o Albero Cucurbitifero , Cre
scentia, Lin. , Fran. Calehassier. Nome diun ge
nere di pianta di fiori monopetali , della divisio
ne delle personate , al dir del Cavalier de la
Marck, e che comprende alberi di America, le
foglie dei quali sono semplici, alterne o a maz
zetti ; i fiori irregolari di queste piante , produ
cono frutti carnosi, di corteccia dura, e che per-
la
24oZ U C
la grossezza e per la forma, si accostano alle
Zucche nostrali da nuotare .
Zucca Arborea difoglie lunghe , Cucurbitifera ar
bor Americana, Sloan, ; Cujete, Plum. e Marcg.
Fran. Le Calebassierà feuilles longues. E'un albero
interessantissimo pel vantaggio del suo frutto nei
paesi in cui cresce. Si trova alle Antille, alla
Nuova spagna, nella Guiana, ed anche a S. Do
mingo, nei monti e nelle pianure. Quest'albero
è della grandezza del nostro melo . Ha il tron
co tortuoso, non meno che i rami, che pren
dono, per la maggior parte, una situazione ori
zontale; la corteccia è bigiccia e corrugata; il
legno, bianco e più coriaceo che duro ; i rami
sono guarniti ad ogni nodo di nove o dieci fo
glie, in fascetti, lanceolate , ristrette insensibil
mente verso la base ; terminate da una lunga pun
ta, quasi sessili, intiere, liscie, verdi, ed un po
co rilucenti . Hanno dai cinque ai sette pollici di
lunghezza, ed un pollice e mezzo nella massima
larghezza . I fiori nascono non solo sopra tutti
i rami, ma anche intorno al tronco dell'albero ;
sono monopetali, anomali, solitari, fatti a cam
pana, frastagliati nel giro in molte parti, bian
castri, di un' odore ingrato, sostenuti da un ca
lice separato in due segmenti verdastri, bislun
ghi, incavati in cucchiaio ; sorge il pistillo dal
fondo del calice , circondato di quattro stami, le
antere dei quali sono forti ed arcuate ; a quei fio
ri che divengono fertili, succedono frutti più o
menogrossi, secondo gl'individui, dalla grossez
za di un'uovo fino a quella di una Zucca , ora
bislunghi, ora sferici, senza punta o capezzolo
Z U C
alla cima . La corteccia è verde , liscia, dura »
coriacea, quasi lignea; e contiene una carne pol
posa, floscia, bianca , piena di sugo , di un sa
pore acidetto e di un' odor vinoso , e che rac
chiude molti semi brunicci , schiacciati e fatti a
cuore. Si conosce che i frutti sono maturi, quan
do il gambo, per cui sono attaccati all'albero, si
avvizzisce e diventa nero ; ed allora si può co
gliere . Vi sno alcuni abitanti che variano la fr
ma di questi frutti; perchè, quando sono maturi
per metà, gli stringono fortemente con uno spa
go, secondo la figura che vogliono ad essi dare -
Questo frutto è chiamato da Lemery Zucca di
Guinèa o d'Africa, perchè quest'albero, che vi
è stato portato dall'America, è coltivato anche
in Africa. In Guinèa il frutto si chiama Macha
mona ; nella Nuova Spagna, cohyne d Cujete, o
Hyguero, e couis nelle Colonie Francesi .
Si scavano o, per meglio dire, sivuotano que
ste Zucche, versandovi dentro acqua bollente per
farne macerare ed ammollir la polpa, onde facil
mente distaccarla ; e se ne fanno allora fiaschi o
bottiglie eccellenti ; vi si mettono anche dentro
talvolta le pietruzze coll'acqua per meglio ripu
lirle . Si pretende che mettendo queste Zucche
intiere in forno o sotto la cenere infuocata, se
ne può ugualmente liquefar la polpa per farla
uscire. Dice Lemery che i Cannibali ne fanna
piccoli vasi, dei quali si servono particolarmen
te per un mistero che riguarda la loro Divinità;
le vuotano essi e le riempiono di mais e d'altre
semenze o di pietruzze, e le adornano di fuori
Bom.TXXXIX.Q di
242 2 U e
-aaaaaa
di molte specie di piume, poi forandole in fon
do , vi mettono dentro un bastoncello, che con
ficcano in terra. Questi popoli hanno il costume
di conservare con molto rispetto tre o quattro
di tali Zucche , così accomodate in ciascuna di
loro capanne, le chiamano maraka e tamaraka,
e credono, quando maneggiano questo frutto e lo
sentono far qualche rumore, a cagione dei semi
e delle pietruzze che vi sono dentro, di parlar
eol loro Toupan, cioè, col loro Dio, e di aver
da lui certe risposte. Sono mantenuti in questa
superstizione dal loro Paigi o Indovini, i quali
fanno loro credere che col fumo di tabacco e
certi incantesimi e borbottar di parole, danno
una virtù divina al loro tamaraka.
G' Indiani lisciano la superficie esteriore di
questi frutti vuoti e seccati, e gli smaltano va
gamente col rucù, l' indaco ed altri bei colori,
stemperati nella gomma d'acajù. I loro disegni
alla selvaggia sono assai giusti, per gente che non
fa uso di riga nè di compasso; e si veggono tal
volta nei gabinetti dei curiosi alcuni di questi la
vori . Si fanno colla corteccia degli stessi frutti
diversi utensili domestici, segnatamente piatti,
e servono a tutti gli usi, purchè non si mettano al
fuoco. La Zucca arborea somministra la maggior
parte dei piccoli mobili di casa dei Caribi, dei
Negri delle Colonie e degli stranieri che vanno
alle isole. Questi utensili, secchie, vasi, fiaschi,
piatti, bicchieri, cucchiai, &c., sono chiamati
ccuis dai Negri . Il goligo o coyemboue, così van
taggioso agli stessi Negri ed ai Selvaggi per
le
ij ( 243
dere e conservar con pulizia il loro mangiare ,
altro non è che una di queste Zucche vuote,
che ha un'apertura da potervi passar la mano ;
si chiude esattamente l' apertura con un pezza
della Zucca stessa , fatto a cupoletta
Gli abitanti dei luoghi nei quali crescono que
sti frutti, ne riguardano la polpa come una pa
nacèa per un gran numero d' infermità e di ac
cidenti: l'usano contro l'idropisia, la diarrea,
nelle cascate, contusioni, colpi di sole, dolori
di testa ed anche per guarir le scottature, e ne
ritraggono un liquore simile alla nostra limona
ta. Vi è presentemente il costume di far bollir
questa polpà, di passarne la decozione per pan
no lino, di mescolarla in seguito con zucchero,
e di formarne un siroppo risolvente, del quale
si fa un'uso grande nelle isole per far uscire il
sangue coagulato : questo siroppo diviene attual
mente comune in Francia , è se ne fa uso pel
petto, sotto il nome di siroppo di calebasse. Gli
uccelli del paese, che hanno il becco forte e ro
busto, bucano questi frutti per mangiarne la pol
pa di cui sono ghiottissimi: questa stessa polpa,
seccata è, al dir di Lemery, di un sapor grato
come quello del marzapane -
Miller ci dice che è stata coltivata per curiosi
tà e con buona riuscita in Europa, questa Zucca
Americana in una stufa di calortemperato. Que.
sto albero esige un terreno leggiero ed inaffia
menti frequenti; e si moltiplica per rimessiticci e
per semi freschi
Il P. Plumier distingue cinque specie di zucO 2
che
244Z t C
che arborescenti. Nella prima , le foglie sono
bislunghe e strette; i frutti grossi ed ovali, e
questa è la specie quì sopra descritta. Nella se
conda, le foglie sono larghe , i frutti molli,
cujete latifolia, fructu putamine fragili. Nella
terza , l'albero è piccolo e produce frutti duri .
Nella quarta, le foglie sono strette, ifrutti pic
coli e sferici. Dice il Sig. de la Prefontaine che,
nella Guiana, i rami dei più grossi alberi di Zuc
che si estendono dai tre ai quattro piedi di di
stanza da terra, e producono i frutti più volu
minosi ; e che la Zucca arborea più alta non
passa i sedici piedi . Quest'ultima è chiamata
matallou dai Caribi uomini e dalle donne, buira
o haya : tiboucoulou è la Zucca arborea più pic
eola : mouloutoucou dai Caribi, commori dalle Ca
ribe : la Zucca lunga, aperta pel mezzo , che
serve di vaso da tenere il vino, è chiamata ton
ton dagli uomini , e chueyù dalle donne Cari
be : la Zucca mediocre , piena di pietruzze, che
serve loro di strumento, di violino o di tambu
rino, malagalì dagli uomini, chichira dalle don
ne . La Zucca fatta a pistola, camacoulou . Ri
guardo alla Zucca con fiori di gelsomino, e che
cresce nell' isole di Bahama, sembra che appar
tenga a un'altra specie di pianta .
-
Si chiama in America Zucca d'erba oZucca stri
sciante, la nostra Zucca larga da nuotare, che è
stata colà trasportata. Benchè la corteccia della Zuc
ca strisciante sia più grossa di quella della Zucca
arborea , è contuttociò meno a proposito per
contener liquori, perchè questo guscio che è me
lQ)
-
z. Uf C 245
no duro, fa loro contrarre un cattivo sapore ,
Vedete l'articolo Zucca . Riguardo alla Zucca ar
borea del Senegal , Vedete Baobab, all'articolo
Pan di Srimmia.
zucca Selvatica. E' la brionia o vitalba. Vede
te questo articolo.
ZUCCHERINO o MANGIA ZUCCHERO .
Lat. Certhia saccharivora . Nome dato a un pic
colissimo uccello che si trova a S. Domingo, al
la Giammaica , alla Guiana, alla Martinicca, a
Bahama, e solamente nelle contrade del Nuove»
Continente, ove si coltiva la canna da zucchero:
questo uccello è del genere del rampichino, e
se ne distinguono due specie, che probabilmente
sono semplici razze, o anche varietà, che diffe
riscono per le dimensioni più o meno grandi, e
pei colori più o meno cupi : generalmente, la
piuma superiore è di un bruno che tira o al nero,
o al bigio cenerino ; l'inferiore e il groppone
sono di un giallo più o meno carico , l'orlo
delle ali è gial'o; le penne di esse e quelle del
la coda sono bruniccie , orlate di bigio ceneri
no: quest'ultima tinta è quella della gola ; vi è
un tratto biancastro sopra ambedue gli occhj ;
il becco è nero; i piedi sono di un bigio tur
chiniccio : sono grossi appresso a poco come il
nostro rampichino. Questi uccelli prendono il
nome dall'abito che hanno di arrampicarsi su per
Ie canne dello zucchero , di ficcare il becco ne
gli screpoli del fusto e di succhiare il sugo zuc
cherino che contiene: ciò non ostante, siccome,
ai dire del Sig. Mauduyt, la lingua degli Zucche
--- --- ------------
IlIll
46 7 y “----
rini non è atta a succhiare come quella dei co
librì e degli uccelli nosche, e non è una tromi
ba, come in questi, forse gli Zuccherini d'altro
non si alimentano che d' insetti attirati dallo
spandimento del liquore delle canne da zucche
ro , e che così si trovano su queste canne .
ZUCCHERO. Vedete l'articolo Canna da Zucche
ro. Abbiamo parlato dello Zucchero d'acero, in
seguito all'articolo Acero ; dello Zucchero di
bambù, alla parola Legno di bambù; e dello Zuc
chero di betulla alla parola Betulla, &c. GliAn
tichi hanno fatto ancora menzione di altre sorti
di Zucchero naturale, cioè del tabaxir, che è il
Saccar-mambì delle Indie, o lo Zucchero della
canna arborescente, più nota sotto il nome di
bambù; lo Zucchero alhusar e alhasser, che è la
manna dell'Apocino . Vedete queste parole .
Zucchero di Monte . Vedete Balsamo del porco
e Gomart.
ZUIMPEZEE. Vedete champanzèe.
ZURNABA o ZURNAPA o GIRNAFFA . E'
la giraffa. Vedete all'articolo Cammellopardo .
ZWITER. Nome dato a una miniera di sta
gno, in piccoli grani, in una ganga poco co
stante ; è essa talvolta di marna bianca a Eyben
stock , e talvolta di quarzo misto di mica a
Ehrenfriedersdorff. Vedete l'articolo Stagno .
ZYGENA, Lat. zygcna. Vedete Martello.
ZYZEL, Vedete zizel.
FINE DEL ToMo TRIGESIMoNoNo.