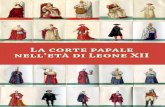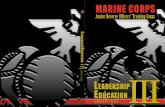Con Tod A. Marder, La Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona : iconologia e costruzione
Transcript of Con Tod A. Marder, La Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona : iconologia e costruzione
progettuale D’Amelio - mArDer 2011, nonché il recente volume di Frank Fehrenbach (1998, 2008) e i sempre utili testi di Cesare D’Onofrio (1957, 1965, 1985), solo per citare alcuni.
LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA : ICONOLOGIA E COSTRUZIONE
MARIA GRAZIA D’AMELIO E TOD ALLAN MARDER
A tre anni dal giubileo del 1650, Francesco Borromini (1599-1667) è incaricato di ricalibrare i condotti dell’acqua in Campo Marzio per alimen-tare una nuova monumentale fontana da costruire in piazza Navona1.
1 Vedi il chirografo datato 11 febbraio 1645, Archivio Stato Roma (da ora ASR), Camerale I, Chirografi 1645-1655, vol. 163, p. 168 e la Pianta della zona di Campo Marzio, servita al Borromini per progettare il tracciato della conduttura dell’Acqua Vergine a Piazza Navona, Biblioteca Apostolica Vaticana (da ora BAV), Vat. lat. 11257, f. 149.
Il termine post quem del progetto della fontana è deducibile dall’annotazione « Il Papa fu a S. Sebastiano per vedere nella Naumachia di Claudio, dove sta rovinando per terra un obelisco grandissimo per farlo risarcire et erigerlo in mezzo a piazza Navona imitando in ciò li vestigi di Sisto V », 27 aprile 1647, D. van Ameyden, Diario III, c. 32, in D’onofrio 1957 (ed. 1985), p. 412, n. 24.
Per la fontana sarebbe stato indetto un consulto di architetti, al quale avrebbe partecipato anche Alessandro Algardi, cfr. D’onofrio 1957 (ed. 1985), p. 406.
Per un incompleto ragguaglio bibliografico sulla fontana dei Fiumi cfr. frAschetti 1900, p. 179-195 ; BrAuer - WittkoWer 1931, I, p. 47-50 ; WittkoWer 1955 (trad. it. 1981), p. 175-176 ; D’onofrio 1957 (ed. 1985), p. 288-301 ; D’onofrio 1965 (ed. 1992), p. 288-322 ; fAgiolo - fAgiolo Dell’Arco 1967 ; huse 1970 ; PreimesBerger 1974 ; rivosecchi 1982 ; mArDer 1998, p. 94-100 ; ciPriAni 1999 ; roWlAnD 2001 (2002), p. 153-181 ; Petrucci 2004 ; fAgiolo 2006 ; fAncelli 2006 ; fehrenBAch 2008, p. 15-196 ; currAn et al. 2009, currAn et al, 2009, p. 161-168.
Il volume La Fontana dei Fiumi in Piazza Navona. Gli interventi conservativi sull’obelisco Pamphilj. Il piano di manutenzione, a cura di Annamaria Pandolfi (Roma 2012) è interessante per la documentazione del cantiere di restauro aperto nel 2010 e concluso nel 2011 ; tuttavia i risultati della ricerca storica compendiati nel detto volume non sono stati confrontati con i contributi sulla tecnica dell’innalzamento degli obelischi spezzati e sull’organizzazione della fabbrica secentesca dell’obelisco di piazza Navona D’Amelio 1999 e D’Amelio 2006a e quella sulla ricostruzione della vicenda
Fig. 1 – F. Borromini, Progetto per fontana dei Quattro Fiumi, 1647 ca., BAV, Vat. Lat. 11258, f. 200r.
394 LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA : ICONOLOGIA E COSTRUZIONE
Quella per piazza Navona è una commissione papale di grande prestigio che aveva significato per Borromini (sul posto occupato nei lavori di palazzo Pamphili dal 1646) il riscatto da una lunga e sofferta marginalità professionale4. Eppure, il 12 giugno 1651, giorno dell’inaugurazione della fontana dei Quattro Fiumi, è Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) a ricevere onore e gloria per l’opera che corona anche le ambizioni degli altri due protagonisti dell’impresa, il pontefice Innocenzo X (Giovan Battista Pamphili, 1644-55) e il gesuita
4 « Innocenzo X diede la fontana di mezzo al Cav. Borromini, quale condusse l’acqua e scoprì il pensiero di condurvi la Guglia », vedi il manoscritto di Fioravante Martinelli pubblicato in D’onofrio 1969, p. 282. Per palazzo Pamphili vedi in particolare leone 2008.
Borromini elabora anche il progetto per la fontana, immaginando un ampio bacino circolare (13.40 m di diametro), dominato da un obelisco, quello di Domiziano (81-96 d.C.), allora ancora spez-zato e giacente a terra nel circo di Massenzio fuori porta San Sebastiano2 ; un precedente compositivo che vedeva l’abbinamento fontana+obelisco era la proposta ineseguita di Carlo Maderno (1556-1629) per il monolite di piazza San Pietro (traslato nel 1586) che, in quella soluzione, sarebbe stato circon-dato al piede da una vasca mistilinea3 (fig. 1).
2 iversen 1968, I, p. 84-86 ; PreimesBerger 1974, p. 102, 114, 134-137 ; rivosecchi 1982, p. 119-138 ; vitAle 1988, p. 27-20 ; fAgiolo Dell’Arco 1997, p. 153-154 ; fehrenBAch 1998 ; mArDer 2000.
3 Vedi il progetto per piazza San Pietro, Firenze, Uffizi A 263.
Fig. 2 – Obelisco Panfilio eretto dalla Santità di Nostro Signore Innocentio X in piazza Navona sopra la nobilissima et maravigliosa fontana inventione et opera del Cavalier Gio : Lorenzo Bernini scoperta li 12 giugno 1651,
Giovan Battista de Rossi, Roma, 1651.
395MARIA GRAZIA D’AMELIO E TOD ALLAN MARDER
prevalente rispetto a tutti gli altri elementi, obelisco compreso8 ? Forse in questa chiave deve essere letta la testimonianza di Domenico Bernini che racconta come, molti anni dopo, suo padre « passando una volta per piazza Navona, ei dispettosamente chiudesse le bandinelle della carrozza per non rimirare la Fonte e dicesse, Oh quanto mi vergogno di aver operato così male », non nel senso di aver creato un’opera poco o troppo scenografica, ma piuttosto nell’avere vergognosamente cospirato per sottrarre l’incarico a Borromini9.
Inoltre, Bernini può avere sfruttato le compe-tenze di Kircher per arrivare a un’espressione formale più potentemente rappresentativa dell’al-lora dominus urbi et orbi papa Innocenzo X ? Insomma : Bernini può avere utilizzato un idioma con papa Pamphili più persuasivo, quello del linguaggio scultoreo, un terreno sul quale Borromini non poteva nè competere nè tantomeno vincere ?
Tentando un approfondimento sull’icono-logia della fontana dei Fiumi appare evidente che il codice comunicativo è, in effetti, molto più complesso di quanto si creda e che, se agli occhi di un romano del Seicento esso era più comprensibile (a tal punto da essere illustrato in componimenti poetici e descrizioni editi nell’anno dell’inaugu-razione), per noi è ancora un rebus da decifrare completamente10.
Solo per fare un esempio, è di difficile deco-dificazione la preferenza delle personificazioni del Danubio e del Rio della Plata (esplorato nel 1516) per « incarnare » l’Europa e le Americhe al posto, rispettivamente, dei più scontati e preve-dibili Tevere (la cui storia per Roma è nel mito) e Mississipi (il « padre delle acque » per i nativi americani) ; tranne ipotizzare un’inequivocabile scelta politica, mirata a focalizzare l’attenzione su due precise aree dell’universo cristiano, la prima cuore dell’ortodossia protestante e oggetto di minaccia del comun nemico turco e la seconda appena conquistata al cattolicesimo grazie alla vincente strategia missionaria delle « riduzioni gesuitiche », vale a dire i territori evangelizzati dai padri riformati del SS. Nome di Gesù (e questo può essere stato suggerito da Kircher).
8 ASM, Cancelleria Ducale, s.d, in frAschetti 1900, p. 18, nota 2.
9 Bernini 1713, p. 86-87.10 Cfr. Nuova descrittione 1651 ; BernAl Di gioyA 1651 ;
Descrittione dell’obelisco o guglia di Navona 1651 ; vignoli 1651 ; luAlDi 1651 (in huse 1970).
Athanasius Kircher (1602-80). Infatti, con la fontana, papa Pamphili aveva creato un manifesto tridimensionale con cui rivendicare per Santa Romana Chiesa la sovranità sul mondo ; Kircher aveva condensato in un’opera di architettura gli studi di una vita ; Bernini aveva rilanciato la sua carriera, dopo i clamorosi fallimenti dei campanili di San Pietro e della cappella dei Re Magi5. Per Borromini, invece, la vicenda dette inizio a una spirale negativa proprio nei rapporti con quei committenti (Innocenzo X, ma anche con il tesoriere papale Virgilio Spada) che con più entusiasmo lo avevano sostenenuto6 (fig. 2).
Su questo rovescio della storia, la letteratura è stranamente discordante e ancora oggi non sono state chiarite le circostanze che hanno determi-nato il passaggio della commissione da Borromini a Bernini. Forse, per meglio comprendere i fatti, è più vantaggioso leggere, in filigrana, alcuni indizi e chiedersi se, per sottrarre a Borromini un incarico così importante, Bernini abbia scientemente escogitato uno stratagemma molto più perva-sivo, rispetto ai banali episodi annotati in una lettera dell’agente estense Francesco Mantovani e nelle biografie di Filippo Baldinucci (1624-97)
e di Domenico Bernini (1657-1723)7. E cioè gli episodi della donazione a Olimpia Maidalchini di un prezioso modello in argento della fontana o della benevola malleveria di Nicolò Ludovisi (rispettivamente la cognata e il nipote acquisito di Innocenzo X) che avrebbero convinto papa Pamphili ad affidare il progetto a Bernini.
Bernini può avere organizzato una « trappola » professionale « in maniera ch’il Borromino è caduto per cedergli il luogo », confezionando disegni e modelli per esaltare l’opulenta opera di scultura che egli aveva ideato come componente compositiva
5 mArDer 1998, p. 63-66, 72-80 ; mcPhee 2002. Anche se la reputazione di Bernini era stata intaccata dagli insuccessi dei campanili di San Pietro e della cappella dei Re Magi, egli manteneva il ruolo di architetto capo della Fabbrica di San Pietro e proprio in quegli anni era occupato a ridisegnare la navata della basilica Vaticana in vista del giubileo del 1650.
6 mArDer 2000.7 Archivio di Stato di Modena (da ora ASM), Cancelleria
Ducale, s.d, in frAschetti 1900, p. 18, nota 2. La versione accreditata dai due biografi di Bernini, Baldinucci (BAlDinucci 1847, vol. V, p. 616-617) e di Domenico Bernini (Bernini 1713, p. 86-87), vuole che sia stato il nipote acquisito del papa, il principe Nicola Ludovisi a spingere Bernini a elaborare un progetto per la fontana di piazza Navona, il cui modello, portato a palazzo Pamphili, venne mostrato a Innocenzo X, cfr. D’Amelio-mArDer 2011.
396 LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA : ICONOLOGIA E COSTRUZIONE
La fontana dei Fiumi, come detto, è metafora in pietra del dominio della Chiesa di Roma sui quattro continenti ed evoca anche il dominio di Innocenzo X sul mondo, essendo la colomba con il ramoscello d’olivo – al contempo – sia simbolo dello Spirito Santo sia emblema della famiglia Pamphili. La fontana è, dunque, l’immagine costruita ad hoc per la propaganda cattolica che viene divulgata mediante un florilegio di incisioni per opporsi, anche figurativamente, alle tendenze della legislazione religiosa europea (già affiorate nel XVI secolo e sancite nella pace di Vestfalia, 1648) orientate verso il riconoscimento della libertà di culto per tutte le confessioni11.
Immagine della fontana dei Fiumi intenzio-nalmente densa di significati fattuali e allego-rici, nella quale è difficile distinguere l’apporto di Innocenzo X, di Kircher, di Borromini prima e Bernini poi. Tuttavia sembrerebbe evidente il contributo determinante dell’enciclopedico Kircher ; lo si comprende appieno sfogliando i due tomi del suo Mundus Subterraneus (1664-1665, i cui contenuti furono anticipati – nei decenni precedenti la pubblicazione – da Kircher in nume-rose conferenze al Collegio Romano) nel quale egli compendia le sue osservazioni sulla struttura primordiale della terra, maximo Dei opificio per usare le sue parole12. Egli descrive la litosfera che inviluppa un nucleo perforato da canali comuni-canti, percorsi incessantemente da magma e da acque, così come avviene nel corpo umano ossi-genato dall’apparato circolatorio ; l’immagine della crosta terrestre così illustrata è trascritta fedelmente nello scoglio di base della fontana dei Fiumi, un masso roccioso attraversato da cavità, bagnate dalle acque, che isolano i quattro appoggi affioranti dalla vasca (fig. 3, 4a, 4b).
Su di essa si addensano flora e fauna dei quattro continenti ; si tratta di una autentica « raccolta » di animali reali e fantastici, di piante domestiche ed esotiche, quasi un gabinetto scientifico delle curiosità, un wunderkammer a cielo aperto ; anche questa idea potrebbe essere ascritta a Kircher che, nel suo Mundus Subterraneus, descrive la sua
11 Cassiano dal Pozzo addirittura sostiene che « è effettivamente la più nobile e straordinaria fontana, che fin’hora sia stata vista in Italia », cfr. lumBroso 1876, p. 194. Fabio Chigi (il futuro Alessandro VII) nel 1951 chiede da Aquisgrana di avere una stampa della fontana dei Fiumi, BAV, Codice Chigi, A III 55, c. 810v.
12 kircher 1665 (per l’obelisco di piazza Navona, libro VIII, capo II, vol. II, p. 101 e libro XI, capo III, vol. II, p. 333).
Fig. 4a-4b – D.M.T. Abbate, Rilievo della Fontana dei Quattro Fiumi, piante, in M. Fagiolo e P. Portoghesi (a cura di), Roma Barocca : Bernini, Borromini, Pietro da Cortona,
Milano, 2006, p. 210 e 213.
Fig. 3 – A. Kircher, Mundus subterraneus : in XII libros, II ed., apud Jonnem Janssonium à Waesberge&Filios,
Amsterdam, 1678, vol. 1, p. 221.
397MARIA GRAZIA D’AMELIO E TOD ALLAN MARDER
anche supporre il disinteresse di Kircher nel divul-gare i misteri dell’universo che, scrive, è e deve restare « legato con nodi segreti »16.
Dunque l’Obeliscus Pamphilius non è l’icono-logia della fontana dei Fiumi. Tuttavia, per Bernini la cooperazione con Kircher deve essere stata la mossa vincente : perchè non fondere una moltitu-dine di figure animali, di alberi, di piante e fiori, di personificazioni fluviali (Nilo, Danubio, Rio della Plata, Gange) propria dell’ordine terrestre con l’uni-verso divino reso tangibile dall’obelisco ? (fig. 5).
Flora e fauna che, osservando i modelli di progetto della fontana, colonizza sempre più diffusamente lo scoglio, la cui dimensione lievita progressivamente avvicinandosi alla soluzione finale17 ; questo è evidente nel primo modello
16 Non è un caso che, nel frontespizio del volume Obeliscus Pamphilianus, tra i personaggi ritratti è anche Harpocrates che porta il dito sulle labbra per significare : « se capisci, mantieni il tuo silenzio ».
17 Il dimensionamento della scogliera è correlata a una correzione della struttura in itinere ritenuta forse troppo ardita staticamente nelle prime soluzioni.
ossessione maniacale nel rintracciare nelle faglie e nei rilievi, nei solchi e nelle gibbosità della crosta terrestre figure geometriche, lettere degli alfabeti greco e latino, ma soprattutto nell’individuare sagome antropomorfe, zoomorfe e fitomorfe, nonchè simboli arcani rivelatori della presenza divina nel creato13.
Certamente, i suoi tentativi di penetrare, fin dagli anni ’30 del Seicento, i misteri dei gerogli-fici gli valsero il coinvolgimento nel progetto della fontana dei Fiumi. In parole sue : « Sua Santità ha sentito dire che sono abile nel decifrare gerogli-fici, e così mi ha fatto chiamare in questo modo : Padre, abbiamo deciso di erigere un obelisco di immense proporzioni. Sarà compito suo stabilire il significato delle iscrizioni su di esso. Poiché lei è stato dotato di un tale talento, vorremmo che si dedicasse completamente a questo compito, facendo tutto il possibile perché coloro che rimarranno colpiti dalla mole di questo grande obelisco possano giungere, attraverso i suoi sforzi, a comprendere i significati segreti delle sue iscri-zioni »14. Un anno prima dell’inaugurazione, nel 1650, Kircher si affretta a pubblicare il volume Obeliscus Pamphilius il cui testo, però, non illustra il linguaggio figurato della fontana dei Fiumi15. Per esempio : Kircher ricorda, nel suo personalissimo bestiario, il leone e il cavallo (entrambi presenti nella fontana dei Fiumi) come animali sacri per gli egizi « per una certa loro analogia e similitu-dine alle qualità divine » ma, nella narrazione, menziona anche altri animali che non fanno parte della composizione di Bernini. E ancora : Kircher sostiene che l’obelisco con il suo benben apicale – la materializzazione di un raggio di sole nella mitologia del clero eliopolitano – trasmette la luce divina ai quattro continenti e ai « quattro fiumi del paradiso », che ovviamente non sono il Nilo, il Danubio, il Gange e il Rio della Plata.
Queste discrasie tra testo letterario e opera costruita, forse, si possono giustificare con un mancato aggiornamento del testo dell’Obeliscus Pamphilius per la pubblicazione oppure si può
13 kircher 1665, libro VIII, capo IX, vol. II, p. 35-36, 39. Vedi anche rossi 1979, p. 26.
14 mArDer 2000.15 Il primo capitolo dell’Obeliscus Pamphilianus (kircher
1650) ricostruisce – con errori – la storia dell’obelisco e i tre capitoli successivi trattano le ricadute della cultura egizia sulle civiltà greca, romana e ebraica. Nel quinto capitolo, la traduzione dei geroglifici dell’obelisco di Domiziano è completamente sbagliata, cfr. grenier 1987.
Fig. 5 – G.L. Bernini, Studio per la fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona, Paris, Louvre, Département des
Arts Graphiques, inv. 9587.
398 LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA : ICONOLOGIA E COSTRUZIONE
Fiumi è uno degli attributi delle Americhe – era descritto già pochi anni dopo l’esplorazione delle Indie Occidentali nei trattati zoologici ; peraltro, esso era un pezzo pregevole della collezione del museo (allestito nel 1651) di Kircher, tanto da essere collocato in un posto di grande visibilità – sospeso alla volta – nella prima sala che certa-mente Bernini deve avere studiato (fig. 6a, 6b)19.
Il disegno (BAV, Vat. lat. 11258, f. 199r) – attri-buito a Francesco Righi – è nodale per una rifles-sione a carattere compositivo sulla fontana dei Fiumi20 ; in questo disegno, peraltro commentato sommariamente nel recente e corposo studio di Frank Fehrenbach sul monumento, il progetto di Bernini è commisurato con i quattro obelischi delle piazze di San Pietro, di San Giovanni in Laterano, del Popolo, di Santa Maria Maggiore e
19 De sePi 1678, p. 55. Kircher descrive l’armadillo nell’Arca Noe in tres libros digesta (kircher 1675, p. 69).
20 connors 1980, p. 216, 247-249 ; mArDer 2000.
(quello ligneo policromo della collezione eredi Bernini) nel quale è rarefatta l’inclusione vegetale e i soli animali presenti sono il leone, il cavallo, l’armadillo con « l’armatura di piastre ossee embri-cate che proteggono le spalle, le cinture dorsali, le quattro dita artigliate nell’arto anteriore, e la fila di piccoli denti, tutti uguali che armano la rima buccale »18. Quest’ultimo – che nella fontana dei
L’elenco dei modelli della fontana è in D’onofrio 1957 (ed. 1985), p. 418-420. Per i modelli della fontana cfr. sestieri 1970 ; forti 1970 ; ZAmBoni 1971 ; Bernini a Palazzo Borromeo 2009 ; roDrígueZ 2003. Oltre questi modelli è anche quello inviato nel 1668 alla corte francese (era consuetudine spedire nelle corti europee incisioni o souvenir delle imprese artistiche pontificie), visto da Lorenzo Malagotti (1637-1712) nel prezioso gabinetto delle filigrane di Versailles e così descritto : « su diversi sgabelloni, varie figure d’argento, e in specie i quattro fiumi di piazza Navona che al Bernino non dovette dispiacer punto il trovarvi », cfr. mAgAlotti 1991, p. 98-102.
18 Nel modello Eredi Bernini l’attributo dell’Africa è la sfinge, cfr. Bernini a Palazzo Borromeo 2009. Vedi anche cAPAnnA 2001 ; cAstelli gAttinArA 2001, p. 196.
Fig. 6a-6b – Modello della Fontana dei Quattro Fiumi, viste generali e particolare, 1648 ca., Roma, collezione privata, fotografie ARTE FOTOGRAFICA, Roma, in Bernini a Palazzo Borromeo, a cura di A. Zanardi Landi, per l’Ambasciata d’Italia
presso la Santa Sede, Torino, 2009.
399MARIA GRAZIA D’AMELIO E TOD ALLAN MARDER
– snodo tra differenti direzioni ed elementi di relazione tra edifici in primo piano e fondali delle piazze romane – la composizione architettonica prevedeva le poche varianti sui modani dei piedi-stalli, sottomessa com’era all’incombente reperto archeologico.
Diversamente, il progetto di Bernini non è impostato sulla consueta partizione degli obeli-schi sistini (piedistallo-base-stele), per intenderci, come nella precedente e opaca idea che Borromini aveva formulato proprio per la Fontana dei Fiumi (BAV, Vat. Lat. 11258, f. 200r). Bernini opera una scelta differente, obbligata dalla modesta altezza dell’obelisco di Domiziano, « che haveva necessità di un piede stalle sublime se doveva comparire perchè di sua natura è curta et picciola, in modo che senza aiuto havrebbe fatto poco rumore in una piazza (Navona) tanto ampla et Magnifica »25.
25 Cfr. la descrizione di Francesco Mantovani, ASM, Cancelleria Ducale, s.d., in frAschetti 1900, p. 18, nota 2. Vedi anche la descrizione conservata nell’Archivio Spada : « e se bene (l’obelisco) non è uguale in grandezza alle famose guglie di San Giovanni in Laterano, e di San Pietro, nondimeno essendo alta palmi 64 1/2 (in realtà è alta 16.53
– osservando l’elaborato con attenzione – con la proposta che Borromini aveva predisposto per lo stesso tema (fig. 7)21.
In effetti, la fontana dei Fiumi compare nell’e-lenco delle « opere di architettura e miste » di Bernini, stilato da Baldinucci, insieme ad altri 45 interventi che vanno dalla scala minuta dell’arredo (per esempio, l’altare nella cappella Rospigliosi nella chiesa del SS. Nome di Gesù) alla dimen-sione urbana, come il ridisegno di piazza San Pietro22. Per « miste », Filippo Baldinucci intende quei lavori in cui Bernini si misura con generi arti-stici diversi, amalgamandoli in una straordinaria unità creativa teorizzata con l’efficace definizione del « bel composto », coniata appunto dallo stesso Baldinucci23.
Tuttavia, una tale classificazione per la fontana dei Fiumi è forse ancora troppo limitativa, poiché l’opera è l’esito della progettualità di un architetto allora « moderno » che affronta il tema del riuso di un manufatto antico – l’obelisco di Domiziano – con un approccio decisamente anticonvenzionale, rendendolo strumentale alla propria creazione artistica.
Nel reimpiego dell’obelisco Bernini è spregiu-dicato, specie se si confronta il suo operato con quello di Domenico Fontana (1543-1607), il quale, sei decenni prima, aveva traslato il monolite di San Pietro e rimontato gli obelischi di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore, di piazza del Popolo, trasformandoli in gigantesche aste porta-croce, tutte caratterizzate dalla mancata propor-zionalità tra piedistallo e stele24. Per questi ultimi
21 fehrenBAch 2008, p. 15-196 ; D’Amelio-mArDer 2011.22 Il regesto delle opere compilato da Baldinucci è diviso
in quattro gruppi (Ritratti con busto, Statue di marmo, Statue di metallo, Opere di architettura e miste), cfr. BAlDinucci 1682, p. 105-107.
23 « E’ concetto molto universale, ch’egli sia stato il primo, che abbia tentato di unire l’architettura colla scultura e pittura in tal modo, che di tutto si facesse un bel composto ; il che fece egli con togliere alcune uniformità odiose di attitudini, rompendole talora senza violare le buone regole, ma senza obbligarsi a regola », BAlDinucci 1682, p. 131. Sul « bel composto » tra i molti titoli, lAvin 1980 ; montAnAri 2005.
24 mArino - lAnconelli 1987, p. 52-53. L’altezza dei piedistalli varia dai 7.14 m. dell’obelisco di Santa Maria Maggiore la cui stele è alta 14.73 m. agli 8.26 m. di quello del Flaminio con 23.91 m. di stele, agli 8.50 m. circa dei piedistalli degli obelischi Vaticano e Lateranense con le guglie rispettivamente di 25.36 e di 32.40 m. ; infine, ai 7.60 m. del piedistallo del Sallustiano sul quale è issata una stele di 13.90 m.
Fig. 7 – F. Righi (attribuito), La fontana dei Quattro Fiumi tra gli obelischi di Roma Moderna, 1651. Biblioteca Apostolica
Vaticana, Vat. Lat. 11258, f. 199r.
400 LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA : ICONOLOGIA E COSTRUZIONE
plastica capace di polarizzare l’attenzione dell’os-servatore, anche in misura maggiore rispetto all’o-belisco. In effetti, la virtuosistica opera di intaglio nel vivo del travertino dona alle inerti rocce fremiti di vita con peonie, fichi d’india, le spire di un rettile o con le fronde squassate dal vento della palma che smarginano i taglienti profili dei solchi tetto-
nici della pietra. Le ardite operazioni di intaglio sono difficilmente comprensibili se non « da chi l’ha viste operare in atto pratico », ma intuibili se si riflette al suo costo, pari a ben 1/3 dell’importo totale dei lavori di circa 30.000 scudi30 (fig. 8).
30 Nel conto dello scalpellino (Prezzo e stima di tutti li lavori di scoltura, e d’intaglio che si sono fatti in trevertino ne l’opera della fonte di Navona, Biblioteca Corsiniana (da ora BC), Roma, Codice Corsiniano 167, c. 102-104, pubblicato in D’onofrio 1957 (ed. 1985), p. 539-540 emerge la difficoltà di realizzare gli elementi zoomorfi e fitomorfi in altorilievo e a tutto tondo, « staccati » dal blocco lapideo come il « serpente di lunghezza palmi 20 in circa quale formando molti giri
L’importanza di questa asserzione è facilmente intuibile dal già citato disegno di Francesco Righi (BAV, Vat. lat. 11258, f. 199r) : la colomba bronzea apicale nel progetto di Borromini è posta a circa 28 metri mentre nella proposta di Bernini essa presidia l’obelisco a 32 metri rispetto alla quota della piazza.
In effetti, nella combinazione obelisco-fon-tana Bernini supera i modelli cinquecenteschi progettando la base dell’obelisco con le forme di una scogliera che, compositivamente, ha un ruolo paritetico o addirittura predominante rispetto alla stele sovrastante26. Anche perchè dai primi progetti della fontana (per esempio, quello fissato nel già ricordato modello degli eredi Bernini) all’e-secuzione, l’aumento dimensionale della scogliera risponde a precise esigenze strutturali, già note a Bernini per averle affrontate nel Baldacchino di San Pietro, il cui primo schema – un telaio colle-gato con un doppio arco incrociato e dominato dal gigantesco Cristo Reggistendardo bronzeo – non era stato realizzato per problemi statici27.
La scogliera affiora da una vasca ovale, il cui diametro maggiore (circa 20 metri) è disposto sull’asse longitudinale di piazza Navona in modo da apparire, allo sguardo di un osservatore posto lungo tale direzione, perfettamente circolare28. Non è un caso che nel potente inganno percettivo cade anche Paul Letarouilly che, negli Edifices de Rome Moderne (Paris 1849) delinea la pianta della vasca, appunto, perfettamente circolare29.
L’enorme scogliera – che materializza l’im-magine combinata del cattolicesimo e della gens Pamphilja trionfante sui quattro continenti allora conosciuti – è caratterizzata da un’aggettivazione
m, ndr) e grosso nella parte inferiore 6 1/2 e nella superiore palmi 4 essendo maggiore in altezza di quello di Santa Maria Maggiore dovendo servire per ornamento, e termine di una fontana, fu giudicata tanto meno disdicevole il servirsene », ASR, Archivio Spada, vol. 235, c. 495-501.
26 Come detto, dall’ideazione all’esecuzione, la composizione perde lo sviluppo verticale impresso da Bernini nei primi schizzi della fontana per un progressivo riproporzionamento della scogliera, visibile anche nel modello quale sontuoso regalo cortigiano conservato nel Patrimonio National de Madrid.
27 Per i problemi statici del Baldacchino di San Pietro, cfr. D’Amelio 2009.
28 16.50 metri è il diametro minore della vasca, cfr. Di gADDo 1964, p. 168-171 ; fAncelli 2006, p. 208-213 ; Filippo Baldinucci (1682, p. 32) fornisce per primo i dati dimensionali della vasca.
29 letArouilly 1849-1866, vol. 4, pl. 274.
Fig. 8 – Obelisco Panfilio eretto dalla Santità di N.S. Innocentio X in piazza Navona sopra la nobilissima et
meravigliosa fontana inventione et opera del Cavalier Gio : Lorenzo Bernino, scoperta li 12 giugno 1651 parte orientale,
Giacomo de Rossi, Roma alla Pace.
401MARIA GRAZIA D’AMELIO E TOD ALLAN MARDER
gine perennemente mutevole, nei colori come nei suoni. Per inciso, sull’impianto idraulico della fontana, ideato da Luigi Bernini (1612-81) fratello di Gian Lorenzo, vero esperto sulla « speculazione delle forze e misure dell’acque rinchiuse », non è stato ancora condotto uno studio sistematico32.
La genesi progettuale della scogliera è compen-diata nei disegni conservati nel Museum der Bildenden Künste, Lipsia33. In 18 rapidi schizzi, Bernini traccia contemporaneamente la forma e la costruzione dello scoglio articolato in quattro protrusioni come fosse un cavalletto a quattro gambe che si incurva formando un antro, una grotta che riunisce emblematicamente le forme naturali e quelle architettoniche (fig. 9).
A questo stadio dispone per file le rocce squa-drate, lasciando il vuoto al centro ed affida neces-sariamente alla sola massa del basamento la stabi-lità del manufatto adottando apparentemente il principio strutturale trilitico, nei quattro piedritti
32 Bernini 1713, p. 153-154.33 courtWright 1981, p. 108-119.
Inoltre nella composizione architettonica della fontana entrano prepotenti e scenografici getti, zampilli e cascate d’acqua che, sgorgando da fistole con ugelli a tubo e a stramazzo, da feritoie a lama e da bocche a cono, agitano perennemente le acque di quell’oceano immaginario costretto in una piccola vasca31. Le acque che sgorgano come da sorgenti sotterranee tra le rocce come descritto nell’Hydrophylacia nel Mondus Subterraneus di Kircher e il loro baluginare sono per Bernini un elemento fondante del progetto poiché, velando le asperità della scogliera e « sommuovendo » la massa rocciosa, offrono allo spettatore un’imma-
viene ad essere la maggior parte spiccato » oppure « un cavallo spiccato quasi al tutto rilievo con fatica estrema, e particolarmente è considerabile la fattura della groppa, e gambe dietro per esser tanto nel masso, che con gran difficoltà si poteva lavorare, se non con ferri lunghissimi » ; per il cantiere della fontana D’Amelio 1999. Una copia dei conti della fabbrica di piazza Navona è in ASR, Camerali I, Fabbriche B 1150 allegato B e un brogliaccio e altre copie sono segnalate in D’Amelio 1999.
31 fontAnA 1696 ; vAlADier 1828, I, tav. LXIII.
Fig. 9 – G. L. Bernini, Studio per la fontana dei Quattro Fiumi, 1648, ca., Lipsia, Museum der Bildenden Künste, inv. 7907r.
402 LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA : ICONOLOGIA E COSTRUZIONE
zione è testimoniata da Domenico Bernini : « tutte le congiunzioni de’ pezzi dello scoglio essendo tagliate a coda di Rondine, restano in tal modo in se medesime incassate, che l’una all’altra fa tena-cissima legatura, e tutte le legature concertano mirabilmente per tenere insieme il Tutto »37.
mutila da heimBürger rAvAlli 1977, p. 252.37 Bernini 1713, p. 90. Tuttavia durante il restauro
del 2007, dall’analisi della scogliera effettuata da Peter Rockwell, esperto della lavorazione della pietra e scultore egli stesso, ha rivelato che solo in un punto – sotto al colosso del Rio della Plata – per placcare la superficie dell’ugello da cui fuoriesce l’acqua è un incastro a coda di rondine ; invece i grandi blocchi di quella parte della scogliera risultano staffati poi accordati, in fase di finitura, con una vernice color del travertino. Le analisi della superficie dello scoglio e dei suoi intagli vegetali e animali, una volta per tutte, smentiscono l’ipotesi avanzata per primo da Rudolph Wittkower, forse a seguito dell’osservazione di uno dei modello (quello eredi Bernini), che esso fosse stato dipinto. Dall’analisi del manufatto finora eseguita c’è la conferma che in taluni punti della fontana, nella criniera del leone, nella barba del Rio della Plata e in uno dei due scudi araldici, sono tracce di lavorazione di mano del Bernini che utilizza in modo non convenzionale e estremamente libero sia il trapano che la gradina per dare dalle superfici un forte effetto chiaroscurale. Ringraziamo l’architetto Annamaria Pandolfi dell’Istituto Centrale del Restauro, la quale ci ha permesso di visitare il cantiere di restauro della fontana dei Fiumi ; un debito di gratitudine va a Peter Rockwell per le preziose indicazioni sulle tecniche costruttive impiegate nella fontana dei Fiumi.
collegati in sommità da blocchi posti in orizzon-tale a formare una possente architrave, alla quale è demandato il compito di sostenere il carico dell’o-belisco e trasmetterlo ai sostegni34. Nella soluzione definitiva, tuttavia, la conformazione centinata delle quattro fenditure che perforano la scogliera e la configurazione dei sostegni, scolpiti quali speroni rocciosi, evidenziano un comportamento statico della scogliera assimilabile a quello di un sistema archivoltato (anche se per costruzione si tratta di pseudovolta essendo i conci di pietra tiburtina disposti con un’apparecchiatura a giaci-tura orizzontale) (fig. 10)35.
Peraltro, la disposizione dei blocchi secondo la giacitura orizzontale segnata nei disegni di Lipsia è eseguita con una laboriosa concatenazione di blocchi tagliati a coda di rondine (simile all’innesto che si realizza nei mobili antichi, per intenderci), collegamento che realizza un incastro perfetto tale da eliminare lo scorrimento reciproco dei pezzi (bloccati anche mediante i tradizionali perni e spranghe impiombati)36. Questa acrobatica lavora-
34 Una stratificazione mantenuta in fase esecutiva. Oltre che dall’osservazione diretta della fontana, vedi la disposizione dei blocchi nel rilievo di ABBAte 2006, p. 213.
35 Siamo grati a Fabrizio De Cesaris (Facoltà di Architettura, Università Roma La Sapienza) per le preziose indicazioni sul comportamento statico della fontana dei Fiumi.
36 ASM, Archivio Spada, vol. 235, c. 495-501, pubblicata
Fig. 10 – D.M.T. Abbate, Rilievo della Fontana dei Quattro Fiumi, prospetti, in M. Fagiolo e P. Portoghesi (a cura di), Roma Barocca : Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, Milano, 2006, p. 211.
403MARIA GRAZIA D’AMELIO E TOD ALLAN MARDER
L’organizzazione del cantiere della fontana è il connubio tra il cantiere edilizio tradizionale, quello straordinario per l’innalzamento di un obelisco, il laboratorio dello scalpellino e lo studio dello scultore. Un raro e prezioso documento sui preliminari dei lavori, « Memorie di tutto quello che sarebbe espediente di fare per la resolutione della fabbrica (di Navona ndr) », redatto con tutta probabilità dal soprastante della Fabbrica di San Pietro l’architetto Pietro Paolo Drei (?-1656) rivela gli aspetti da pianificare per aprire il cantiere nella Roma della metà del Seicento42. Il testo, articolato in 11 punti, verte sull’organizzazione dei lavori di scultura e sugli approvvigionamenti dei materiali da costruzione resi complicati dal gran numero di opere in costruzione per il giubileo del 1650.
Infatti, proseguendo la tradizione medievale delle « logge » per gli scalpellini, nel documento si prevede l’allestimento di una tettoia per la lavora-zione dei pezzi lapidei a piè d’opera, accorgimento che permette un notevole risparmio economico evitando i due distinti trasporti dei blocchi, il primo da Tivoli alle botteghe degli scalpellini concentrate a Santa Marta dietro San Pietro e, a lavorazione conclusa, da San Pietro a piazza Navona ; inoltre consente di limitare gli inevitabili danni legati alla movimentazione delle pietre già lavorate e assi-cura il controllo costante e minuzioso dell’opera, specie per la realizzazione dello scoglio, dove solo un lavoro di squadra ben diretto poteva garantire un risultato concertato.
Nel documento sono elencate altre iniziative da intraprendere per velocizzare gli approvvigionamenti : una di queste è la stipula di accordi con i fornitori dei travertini per l’esclusiva dei pezzi già scelti e segnati nelle cave di Tivoli e le modalità del loro trasporto via Tevere con sbarco al porto di Ripa Grande (sulla riva destra del Tevere), per la mancanza di un comodo attraversamento sull’altra sponda, dopo il crollo del ponte Santa Maria (ponte Rotto) avvenuto nel 1592. Per la pozzolana l’estensore del programma
42 L’esegesi del documento è in D’Amelio 1999, p. 93-105. L’idea che sia sopraggiunto un possibile cambio del materiale da costruzione per la scogliera – secondo un’ipotesi avanzata da Wittkower e ripresa recentemente da alcuni studiosi – sulla base dell’osservazione del modello conservato dagli eredi di Bernini non trova alcun riscontro nei documenti della fabbrica. Drei è soprastante della Fabbrica di San Pietro, architetto e collaboratore di Bernini, cfr. mcPhee 2008, p. 353-373.
Come detto, il disegno di Lipsia è una tavola sinottica in cui Bernini simula il processo costrut-tivo che dall’ordine geometrico di blocchi regolari giustapposti e giocati su accurati allargamenti, restringimenti e scarti improvvisi della base, al termine della fase progettuale, approda a un caos naturalistico accuratamente calibrato, quello che Francesco Milizia (1725-98) definisce di « naturale rozzezza combinata a una certa polizia cittadi-nesca »38.
L’obelisco si pone « in falso » per usare il termine del tempo, avendo sotto di sè uno spes-sore di roccia esiguo, « bastar appena potrebbe a sostener un modesto peso, non che una Macchina così grande »39. Per alimentare questa suggestione, Bernini ripartisce il peso dell’obelisco sui quattro speroni dello scoglio, infrangendo, con lo svuo-tamento della roccia, proprio in corrispondenza della maggiore sollecitazione, il precetto statico che nessun carico deve avere sotto di sé il « vacuo perchè essendo intervacuo non è solido ne dura-bile »40. Inoltre, il rigore costruttivo, dissimulato da un trattamento superficiale naturalistico dello scoglio ha improvvisamente uno iato nei profondi tagli inclinati, scolpiti a imitazione delle faglie della crosta terrestre in procinto di slittare. Un artificio che introduce uno stupefacente principio decostruttivo, accrescendo l’idea di un equilibrio incerto e precario, proprio nella parte dello scoglio sulla quale grava l’obelisco.
Insomma un’inedita composizione (audace se si pensa alle conoscenze secentesche della mecca-nica pratica) che, alla base, lascia ampie fenditure – i due tenebrosi anfratti presidiati dal leone e dal cavallo – per traguardare i fondali opposti della piazza. Agli occhi dei contemporanei l’immagine della fontana è tanto stupefacente da alimen-tare continui allarmi sulla stabilità dell’obelisco ; Domenico Bernini racconta con vividezza l’epi-sodio seguito a un violento nubifragio che aveva visto l’irriverente Bernini deridere la folla accorsa per assistere alla rovina dell’obelisco facendolo legare con quattro « deboli spaghi là dove la Guglia posa sul Piedistallo (...) con altrettanti chiodi assi-curati alle quattro vicine Case, e ciò fatto rasse-renossi nel volto, e come se riuscita gli fosse una qualche grand’impresa, tutto allegro partissi »41.
38 miliZiA 1785 (IV ed.), 2, p. 175.39 Bernini 1713, p. 90.40 Ivi.41 Bernini 1713, p. 92-93.
404 LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA : ICONOLOGIA E COSTRUZIONE
I documenti amministrativi rivelano che anche per il cantiere della fontana dei Fiumi, viene messo in atto il dispositivo del prestito/vendita dei mate-riali nonchè della fornitura di manodopera con la Fabbrica di San Pietro43. Lo prova non solo l’ine-dito motu proprio di Innocenzo X Pamphili che impone alla Fabbrica di San Pietro di mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie, ma anche la presenza, nell’inventario (1650) sempre nei magazzini di San Pietro, di una fune lunga tra i 50 e i 60 palmi (un « capezzone novo » di oltre 100 metri), appositamente filata per il sollevamento dell’obelisco pamfiliano e – a fine lavori – venduta alla Congregazione della Fabbrica di San Pietro44.
L’obelisco pseudo-egizio (in realtà inciso da geroglifici sotto il principato di Domiziano) è di granito rosso ed è alto 16.53 metri45. Peraltro esso era già stato accuratamente misurato e idealmente ricomposto nei disegni cinquecen-teschi di Giuliano da Sangallo (1443 ?-1516) e di Baldassarre Peruzzi (1481-1536) e ricordato nell’A-nonymus Magliabecchianus, da Poggio Bracciolini e da Herwarth von Hohenburg46.
43 La lettura dei documenti contabili del cantiere fornisce prova di questi scambi : la stessa somma (circa 276 scudi) compare sia nel computo della spesa « per lavori di scalpello nei travertini che si fanno nella fabbrica di San Pietro », che nelle entrate come denari « avuti dalla Reverenda Fabbrica per resto, e saldo, di conti passati tra la detta e l’opera della guglia ». In realtà, la somma è il costo di lavorazioni ordinarie eseguite nelle officine di San Pietro nonché del nolo di alcuni strumenti, a cui viene detratto il valore dei materiali di risulta del cantiere di Navona che, a fine lavoro, vengono acquistati proprio dalla Congregazione della Fabbrica Vaticana, cfr. D’Amelio 2002 ; D’Amelio 2006a.
44 Le macchine impiegate nel cantiere di Navona per le operazioni elementari di trasporto e innalzamento dei materiali sono argani, burbere e capre oltre a funi. Mancano nei conti, i pagamenti (molto onerosi in relazione al costo globale dell’opera) per l’acquisto degli strumenti atti al sollevamento come traglie, girelle, polee, o per il collegamento dei pezzi di legno come chiavarde (asta di ferro con una testa da una parte e un foro dall’altra per l’alloggio della zeppa), cinti di ferro e staffe (elementi conformati in modo da tenere uniti i pezzi di legno che compongono le antenne e i puntelli dell’impalcatura), polee (carrucole con girella) ; tali attrezzature sono fornite dai magazzini della Fabbrica di San Pietro come espressamente determinato in un chirografo di Innocenzo X del 10 febbraio 1651, ASR, Camerale I, Chirografi 1645-1655 (vedi appendice documentaria).
45 L’obelisco che in origine celebrava le gesta di Domiziano è, dapprima, collocato nel Campo Iseo ; nel 309, esso viene trasportato nel circo di Massenzio, fuori porta Capena lungo la via Appia Antica.
46 D’onofrio 1957 (ed. 1985), p. 288-301.
prevede di concedere facoltà a cavare nel luogo più vicino a piazza Navona, mentre per il reperimento delle tevolozze (mattoni di spolio dei monumenti antichi) egli ipotizza l’emissione di un editto che fissi il prezzo da corrispondere a « chi ne porterà » al cantiere. Per l’acquisto dei mattoni egli sottolinea la necessità di stipulare patti con più fornaciari per averne a sufficienza per tutta la durata della costruzione. Oltre alla fornitura diretta da parte di due mercanti, per la calce egli prevede di realizzare una calcara all’interno dell’area di sedime del cantiere, utilizzando per la scaglia i residui della lavorazione dei travertini e i travertini di spoglio e per la cottura delle pietre 6.000 fascine di quercia giovane, la « cerqua pedagnola », provenienti dalle tenute boschive della Camera Apostolica.
L’ultima annotazione del documento è : « haven-dosi da fare detta opera, sarà necessario avere gran quantità di piane, travicelli per fare li ponti, de quali legnami non ce ne sono ». Infatti, gran parte del legname necessario per l’opera provvisionale necessaria per innalzare l’obelisco sarà noleggiato, pagando con una somma maggiorata, il deperi-mento di parte dei legnami conseguente all’uso.
Fig. 11 – F. Borromini, Progetto di restauro dell’obelisco di Domiziano, 1647 ca., BAV, Vat. Lat. 11258, f. 198.
405MARIA GRAZIA D’AMELIO E TOD ALLAN MARDER
damente lungo la consolare Appia, ma con grosse difficoltà lungo le anguste strade del centro urbano.
In realtà a piazza Navona vengono portati anche i due blocchi del piedistallo originale e il pyramidion. Quest’ultimo, fortemente danneg-giato, è sostituito da una nuova cuspide incisa con gli stessi geroglifici dell’originale49. Insomma, un restauro rivelatore del grado di libertà degli operatori secenteschi, talvolta chiamati a impor-tanti reintegri, come quelli praticati nella statuaria antica con i disinvolti montaggi di busti femminili su gambe maschili virili o su volti di vecchi canuti.
Nel 1649, sulla scogliera ancora rustica – forse priva delle fenditure come sembrerebbe dai disegni di Nicodemus Tessin di Stoccolma (Nationalmuseum HCC2253v) e di Copenhagen (Record Office D2984) – è montata la struttura provvisionale (il castello) per l’innalzamento dell’o-belisco (fig. 12, 13)50.
49 Il pyramidion ora è al Museo Gregoriano Egizio in Vaticano, cfr. leosPo 2001, p. 131-132.
50 Il disegno di Stoccolma (sul cui recto è l’armatura della cupola di San Pietro) è la riproduzione del castello per l’innalzamento dell’obelisco della Fontana dei Fiumi è di Nicodemus Tessin il Giovane (1654-1728) durante uno dei suoi soggiorni romani, cfr. olin - henriksson (a cura di) 2004, p. 160. Il disegno conservato a Copenhagen, Record Office D2984 che rappresenta la stessa impalcatura è stato attribuito erroneamente da Erik Iversen a Francesco Borromini (1599-1667) ; in realtà anch’esso è riconducibile a Tessin, vista la calligrafia e la coincidenza che sul recto del foglio è raffigurata – come nel foglio di Stoccolma – l’armatura della cupola di S. Pietro, cfr. iversen 1987.
Il 9 luglio del 1648, i tre frammenti più piccoli (pesanti dalle 6 alle 8 tonnellate), – i tre sommi-tali contraddistinti con i numeri 1, 2, 3 nel disegno di Borromini (BAV, Vat. Lat. 11258, f. 198) – sono trasportati dal circo di Massenzio a piazza Navona, ciascuno con un carro trainato da quattro paia di bufale47 (fig. 11).
I due tronchi piramidali più grandi (lunghi rispettivamente 5.80 metri e 3 metri, del peso di 30 e di 11 tonnellate), sono adagiati su una slitta lignea (nizza) che scorre su elementi lignei (parati) dalle estremità ricurve, preventivamente insapo-nati per agevolare lo scivolamento ; nizza che veniva trascinata « per terra a poco a poco con gli argani, et con ordegni et grossi canaponi a forza di quattro cavalli »48. Il trasporto dura circa due mesi, rapi-
47 Conto della spesa dell’opera della Guglia in Piazza Navona fatta erigere dalla Santa memoria di N. Signore Innocenzo Decimo non compresavi però la spesa delli condotti dell’acqua, Roma, BC, Codice Corsiniano 167, c. 20.
48 gigli 1994, 2, p. 763.
Fig. 13 – N. Tessin il Giovane, Il Castello della Guglia in piazza Navona con la sua misura, 1675, Copenhagen,
Record Office, D2984.
Fig. 12 – N. Tessin il Giovane, Il Castello della Guglia in piazza Navona con la sua misura, 1675, Stoccolma,
Nationalmuseum, HCC2253v.
406 LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA : ICONOLOGIA E COSTRUZIONE
In estrema sintesi, l’impalcatura per rimontare l’obelisco di San Giovanni in Laterano era composta da due file di quattro pilastri (le antenne), realiz-zati, data la notevole altezza (di circa 36 metri) con più travi di legno, collegate con legature di corde e con cinti metallici (chiavarde e staffe)52 (fig. 14).
Come nella struttura provvisionale dell’obelisco Vaticano, le antenne erano stabilizzate, oltre che da controventature (saettoni, croci e traverse), da quattro puntelli posti ad altezze diverse e ortogonali al letto del castello ; le antenne collocate alle estre-mità delle due file avevano oltre alla puntellatura ordinaria, un secondo ordine di puntelli disposto secondo la direzione di trascinamento dell’obelisco.
Trasversalmente, sulla sommità del castello, erano disposte quattro travi doppie (incavallature) per sostenere l’imbragatura degli strumenti di sollevamento (taglie).
Queste ultime, composte da carrucole (girelle), erano collegate mediante funi alle pulegge (polee) fissate alla base del castello e infine ad argani mano-vrati da uomini e da cavalli, guidati nei loro movi-menti da ordini impartiti direttamente dall’archi-tetto secondo un rigoroso protocollo. Otto grosse funi (ventole) tese tra la testa delle antenne e altret-tanti elementi lignei (passoni o omini morti) infissi nel terreno avevano il compito di stabilizzare il castello (fig. 15).
52 Le antenne erano solidamente piantate a terra, in otto scavi a sezione quadrata predisposti durante la costruzione delle fondazioni del piedistallo.
L’impalcatura è progettata in relazione alla quota di imposta del piedistallo, posta a circa 7 metri sopra al piano vasca e di quella dell’obelisco a 12 metri.
Osservando la struttura dell’impalcatura per l’innalzamento dell’obelisco, l’immediato rimando è alla tecnologia ideata da Domenico Fontana e fissata nel suo volume Della Trasportazione dell’O-belisco Vaticano (Roma 1590) e rifluita nella prassi della movimentazione dei blocchi lapidei di grande dimensione. In particolare è istruttiva, per la strut-tura dell’impalcatura lignea e per i principi mecca-nici applicati, la lettura dei capitoli relativi al rimon-taggio degli obelischi di San Giovanni in Laterano
(il più alto di Roma), di Santa Maria Maggiore e di piazza del Popolo in quanto essi, come quello montato a piazza Navona, erano stati rinvenuti abbattuti e spezzati in più parti51. Questa precisa-zione è essenziale, poiché a differenza del mono-lite di piazza San Pietro, rimasto in piedi dietro la Basilica e poi traslato per intero, l’innalzamento di un obeliscus fractus avviene per sollevamento, per sovrapposizione e per giustapposizione succes-siva dei frammenti che, nel caso dell’obelisco di Innocenzo X, sono cinque a cui si deve aggiungere il pyramidion e la colomba bronzea alta 1.60 metri.
Tessin, grazie alla malleveria di Cristina di Svezia, frequenta lo studio di Bernini intorno agli anni 1675-78, dove probabilmente ha copiato il disegno dell’impalcatura.
51 fontAnA 1590, p. 70-77. Per la tecnica per il montaggio degli obelischi spezzati cfr. D’Amelio 1998 e 2006b.
Fig. 14 – G. Guerra - N. Bonifacio, L’innalzamento dell’obelisco di piazza San Pietro a Roma a opera di Domenico Fontana, 1586.
407MARIA GRAZIA D’AMELIO E TOD ALLAN MARDER
pesa 326 tonnellate53. Applicando lo stesso calcolo, il frammento più grande dell’obelisco di piazza Navona è alto metri 5.80 e pesa 30 tonnellate, vale a dire undici volte meno rispetto all’obelisco di San Pietro54. Si può ipotizzare, e i conti della fabbrica ne forniscono un indizio, con il pagamento della fattura di solo quattro funi per stabilizzare l’im-palcatura, che il numero delle antenne del castello della fontana dei Fiumi fossero solo due. L’ipotesi è confermata dai due disegni dell’impalcatura (Stoccolma e Copenaghen) e dalla descrizione
53 L’obelisco di San Pietro è alto 113 palmi (circa 25 metri) con un il peso complessivo stimato da Fontana pari a circa 964.000 libbre (pari a 326 tonnellate).
54 Il frammento più grande dell’obelisco di Domiziano come detto 26 palmi (5.80 metri) con un peso di circa 84.000 libbre (meno di 30 tonnellate).
Per l’innalzamento dell’obelisco di San Pietro il piedistallo era stato interrato sino alla faccia supe-riore sotto un piano inclinato artificiale – la piazza pensile, opportunamente consolidata e armata con sbadacchi e puntelli – sul quale era stato trascinato l’obelisco disteso per essere poi issato al centro del castello. Non è provato che per l’innalzamento dell’obelisco della fontana dei Fiumi, la scogliera fosse stata ricoperta da una rampa di terra o da uno scivolo di legno per facilitare il trascinamento dei frammenti alla quota del piedistallo, per essere poi sollevati (fig. 16).
A piazza Navona, il castello aveva dimen-sioni ridotte rispetto all’impalcatura allestita da Domenico Fontana per l’obelisco di San Pietro, del quale conosciamo nel dettaglio le misure. La conferma indiretta è nel confronto dei blocchi da sollevare : l’obelisco Vaticano è alto 25 metri e
Fig. 15 – D. Fontana, Il castello per l’innalzamento dell’obelisco Vaticano, 1586, in Templum Vaticanum et ipsius origo, ed. Carolo Fontana. ([Sculpt :] Alex Speculus), Ex.
Typ. Jo. Francisci Buagni, Roma, 1694, p. 155.
Fig. 16 – D. Fontana, Il modo tenuto per l’innalzamento dell’obelisco Vaticano, 1586, in Della Trasportazione dell’Obelisco Vaticano et delle fabriche di Nostro Signore
Papa Sisto V, D. Basa, Roma, 1590, tav. 32.
408 LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA : ICONOLOGIA E COSTRUZIONE
volumetria tronco-piramidale. Infatti, se per un fusto monolitico l’innalzamento sul piedistallo avviene al centro geometrico del castello, sollevato quando esso si trova in parte sotto l’incavallatura del castello, per montare un obelisco ridotto in frammenti è necessario che la struttura provvisio-nale sia eccentrica rispetto alla base dell’obelisco stesso, in modo da lasciare dietro lo spazio neces-sario per trascinare sotto il castello i frammenti e per sollevarli fino a un’altezza di poco maggiore rispetto alla quota di giustapposizione, senza avere l’ingombro dei pezzi già posizionati (fig. 17).
Una volta ultimata questa fase, il frammento veniva momentaneamente sospeso su due travi (da qui la maggiore altezza del castello), poste di traverso rispetto al castello, al fine di agevolare l’operazione di scollegamento degli strumenti e delle funi impiegate per il sollevamento. Il fram-mento era, poi, traslato orizzontalmente fino al piombo del frammento inferiore e su uno dei suoi lati veniva montata una taglia collegata a un argano, capace di gestire lo spostamento in questo caso micrometrico ed eliminare, dunque, il peri-colo di movimenti troppo rapidi e incontrollabili.
Il frammento era anche legato con una fune che passava sotto il suo piede e sopra la faccia superiore. La fune, però, non rimaneva sulle super-fici superiore e inferiore come accade, per esem-plificare, nella legatura di un pacco, ma trovava posto in appositi incassi (le casse) scavati a croce nel vivo della pietra stessa. Le funi così alloggiate e legate, dopo la sovrapposizione del frammento su un pezzo già posizionato, non ingombrando le superfici dei pezzi in contatto, dopo averle sciolte potevano essere sfilate con facilità.
Questo espediente studiato per ottenere un sollevamento più sicuro creava, al contempo, l’al-loggio di tasselli, in questo caso dei prismi lapidei, necessari per ristabilire la coesione tra i frammenti dell’obelisco.
Anche se nella descrizione di Virgilio Spada, con enfasi, si parla « di nuova maniera » per riunire i pezzi dell’obelisco di piazza Navona, in realtà, la tecnologia impiegata è quella già descritta da Domenico Fontana nella sua Trasportazione. Si tratta della cosiddetta tassellatura, realizzata con l’inzeppatura di pezzi di granito (ripieni maschi) tra due frammenti dalle superfici di contatto preventi-vamente scavate ; i tasselli, conformati in modo da colmare gli incassi a croce venivano resi solidali con il granito dell’obelisco mediante una colatura di piombo fuso. Questo permetteva di ricostituire la stele « di modo che chi con argani la volesse
dell’operazione di Virgilio Spada che esalta l’ar-ditezza dell’operazione : « Si come per alzarla (Bernini ndr) inventò modo assai facile perchè dove altri hanno per alzare simili pesi e machine fatto castelli con otto, e più colonne di travi, che chiamano candele, ni meno di quattro, egli s’av-venturò a non porsi più che due, ben conoscendo tal numero bastare, e quando fu il tempo d’alzarla e chi la curiosità di chi credeva altrimenti, invitava tutti ad andarvi, principiando l’alzarvi alcun hori avanti il giorno, all’alba fu veduta finita l’opera, e la guglia finalmente riposta al suo luogo, con meraviglia di tutti e confusione di chi pronosticava disordini »55.
In ogni caso per montare i sei pezzi dell’obe-lisco di piazza Navona, la struttura provvisionale doveva essere, in proporzione, più lunga e più alta rispetto a una impalcatura allestita per l’innalza-mento di un obelisco con le stesse dimensioni, rimasto monolitico. Queste specifiche tecniche trovano riscontro nel volume di Domenico Fontana che, dopo la traslazione dell’obelisco monolitico di piazza San Pietro, per ricomporre i cippi grani-tici di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di piazza del Popolo, deve necessaria-mente modificare la procedura sperimentata con successo in Vaticano56. Quella per gli obelischi spezzati è una tecnologia meno impegnativa per i minori pesi da movimentare, ma che pone grosse difficoltà per ricostituire, in opera, la loro nitida
55 ASR, Archivio Spada, vol. 235, c. 495-501.56 mercAti 1589 (ed. 1981), p. 313-328.
Fig. 17 – Piante delle strutture provvisionali per gli innalzamenti degli obelischi Vaticano (a sinistra) e di San Giovanni in
Laterano, ricostruzione grafica di M.G. D’Amelio.
409MARIA GRAZIA D’AMELIO E TOD ALLAN MARDER
mente mimetizzati tra i geroglifici che glorificano Domiziano, fraintesi clamorosamente dall’egitto-logo Atanasius Kircher come un inno alla dea Iside58.
Studi recenti hanno dimostrato che la struttura dell’incarico era stata ideata per essere assegnata a Borromini, erede della dinastia Fontana-Maderno, e che, solo più tardi, era stata conferita al suo rivale Bernini. Lo testimonia l’attendibile Fioravante Martinelli che, nel suo manoscritto emendato
58 iversen 1968, I, p. 76-92 e fig. 39.
alzare, col legarla solo nella cima, la sosterrebbe tutta insieme »57 (fig. 18, 18a, 18b, 18c).
La tecnica ideata da Fontana per recuperare l’assetto monolitico dei pezzi dell’obelisco di San Giovanni in Laterano, ha trovato applicazione anche in quello di piazza Navona ed è chiaramente visibile nella zona tra il piedistallo e la base dell’obelisco, mentre nelle giunture dei quattro pezzi superiori, i segni dei tasselli (essi stessi incisi) sono magistral-
57 ASR, Archivio Spada, vol. 235, c. 495-501.
Fig. 18-18a-18b-18c – G.L. Bernini, La fontana dei Quattro Fiumi, particolari, fotografie di T. A. Marder.
410 LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA : ICONOLOGIA E COSTRUZIONE
APPENDICE DOCUMENTARIA
Motu Proprio di Innocenzo X per la costruzione della fontana dei Fiumi, ASR, Camerale I, Chirografi 1645-1655, 10 febbraio 1651.
Mons. Giacomo Franzone Chierico della nostra Camera Apostolica, Avendo noi altre volte ordinato a Monsignor Luca Torregiani Arcivescovo di Ravenna Chierico della medesima Camera Apostolica che gli facesse levare la guglia del Cerchio di Caracalla dove ella stava et quella condotta in Piazza Navona facesse restau-rare et erigere in detta Piazza per ornamento della nuova fontana principiata nella medesima Piazza per fare in essa la mostra di quella portione dell’acqua vergine che noi habbiamo ivi fatta condurre come più ampia-mente si contiene nel Chirografo da noi segnato sotto il di dieci luglio 1648 del seguente tenore Monsignor Luca Torregiani Arcivescovo di Ravenna Chierico della nostra Camera Apostolica Havendosi fatto condurre in Piazza Navona certa portione dell’acqua Vergine, et volendo che per la mostra d’essa si facci una fontana con orna-mento di statue et per più terminarla fra l’altre cose vi si conduca et erga la Guglia che sta nel Cerchio di Caracalla labbiamo resoluto di commettere à voi l’esecutione di questa nostra volontà onde di Nostro motu proprio certa scientia e pienezza della nostra assoluta potestà con la presente vi deputiamo sopra la cura et effettuatione di quest’opera e vi ordiniamo che quanto prima facerete levare dal detto Cerchio la detta Guglia, e quella condurre dove giudicarete espediente e la facciate restaurare in ogni parte che giudicarete necessario e poi la facerete erigere in detta piazza et ornarla ad uso di fontana per fare in essa la mostra di detta acqua conforme il disegno fatto d’ordine nostro dal Cavalier Gio Lorenzo Bernini Architetto, et per fare la spesa di detta opera vi conce-diamo ampia facoltà et autorità et anco vi ordiniamo che oltre alli scudi cinquemila che habbiamo ordinato à Monsignore Tesoriere nostro Generale che faccia notare dal Depositario Generale di detta Nostra Camera in conto à parte à vostra disposizione et ogni altra somma che ci paresse farvi pagare per spenderli in servitio di detta opera imponiate una tassa proportionata secondo e nel modo et forma et con dispositione che vi habbiamo ordi-nato di già stabilita nella Congregazione delli Maestri di Strada ascendenti in tutto fino alla somma di scudi moneta 25 sopra tutti li Palazzi Case e Botteghe di Roma e quelle facciate riscuotere per mezzo delli Offitiali ò Ministri che deputarete dalli Padroni di detti Palazzi, Case, o Botteghe tanto secolari come ecclesiastici et che fossero Conventi Monasterij Ospedali Seminarij Collegij, Congregationi et delle 12 composte con detta Camera et altri luoghi Pij et anco Cardinali di Santa Chiesa, Chierici di detta Camera, et Camerlenghi, et altri qualsivoglia privilegiati et con titolo oneroso et ancorche ricercassero speciale espressione quali tutte non eccettuando alcuno vogliamo, che siano tutti tenuti à contribuire à detta tassa e tutto quello che si riscuoterà di detta tassa faccia depositare appresso detta Depositeria di detta Camera in detto conto apparte à vostra dispositione per spenderli
peraltro da Francesco Borromini, sostiene che : « Innocenzo X diede la Fontana di Mezzo al Cav. Borromino, quale condusse l’acqua e scoprì il pensiero di condurvi la Guglia »59.
Come già ricordato, il fatto è confermato dal già citato Francesco Mantovani che, nella sua missiva indirizzata alla corte di Modena, aveva riferito che Bernini aveva preso il controllo della commissione « in maniera che il Borromino è caduto per cedergli il luogo »60. Tuttavia, sulla fontana dei Fiumi, Borromini può vantare importanti crediti : da una parte egli condusse con due canali di un palmo l’uno l’acqua Vergine al centro di piazza Navona e dall’altra « scoprì il pensiero di condurvi la guglia », vale a dire ebbe l’idea di riutilizzare un manufatto antico (vedi l’anastilosi nel disegno di Borromini, BAV, Vat. Lat. 11258, f. 198), carico di memoria che rimanda alla grandezza dell’antica Roma e che rievoca i faraoni, personaggi destinati all’immortalità e investiti di potere sacro e assoluto come gli imperatori prima e i pontefici della Chiesa di Roma poi61.
Inoltre Borromini aveva disegnato un « piedi-stallo à guscio nel quale fossero scalpellati quattro historie di basso rilievo, e con quattro fiumi più celebri del mondo, e con ornamenti al P. Vergilio Spada, qual poi fu data al Cav. Bernino ad istanza della Signora Donna Olimpia Pamfilia »62. Dunque, nel progetto di Francesco Borromini, pure lontano dai vertici architettonici della sua produzione, erano già presenti – in forma larvale – tutti quegli ingredienti (l’obelisco, la colomba apicale, le figura-zioni dei quattro fiumi rappresentativi del mondo), successivamente congegnati in un linguaggio magniloquente, scenografico e grandioso da Gian Lorenzo Bernini.
Maria Grazia D’Amelio
Università degli Studidi Roma Tor Vergata,
Dipartimento Ingegneria dell’Impresa
Tod Allan mArDer
Rutgers School of Arts and Sciences (SAS), Department of Art History
59 Il manoscritto di Fioravante Martinelli, Roma ornata dall’architettura, pittura e scoltura, ca 1660, in D’onofrio 1969, p. 282.
60 ASM, Cancelleria Ducale, s.d., in frAschetti 1900, p. 18, nota 2.
61 Borromini arriva, però, dopo Sisto V Peretti che aveva intenzione di innalzare ben due obelischi a piazza Navona come è detto in un Avviso di Roma del 25 marzo 1586, cfr. DonAti 1942, p. 39, n. 11.
62 D’onofrio 1969, p. 282.
411MARIA GRAZIA D’AMELIO E TOD ALLAN MARDER
strissimo Cardinale Pamphilio da detto Monsignore Torregiani e da esso Cardinale, di nostro ordine fatti porre in faccia vostra et à vostra dispositione nel Banco del nostro Depositario Generale come ogni altra somma di denari che ci paresse di farvi pagare voi possiate spenderli per servitio di detta opera approvando noi d’adesso tutti li mandati et ordini che di essi darete e tutte le spese che per conto di detta opera farete come il tutto fatto et operato di nostro particolare ordine e mandato datovi à bocca.
Volendo anco e decretando che la presente vaglia con la semplice nostra sottoscrittione senz’esser ammessa e registrata in detta Nostra Camera e suoi libri non ostante le Costitutioni di Pio 4° nostro predecessore de registrandis e qualsivoglia altre Costitutioni et ordini Apostoliche inc.o e di qualsivoglia altro nostro Predecessore leggi, statuti riforme, et di Roma Privilegij usi, stili consuetudini e tutto quello che nel Chirografo habbiamo voluto che non ostassero, e tutte altre cose che facessero in contrario, quali tutte e singole havendo il lor tenore qui per sufficien-temente espresse per questa volta solamente et a quest’ef-fetto espressamente deroghiamo. Dati nel nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavallo li X febraro 1651.
Innocentius Papa X.
ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE
ABBAte 2006 = D. M. T. Abbate, La vasca ovata della Fontana dei Fiumi : geometria in movimento, in M. Fagiolo, P. Portoghesi (a cura di), Roma Barocca : Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, Milano, 2006, p. 213.
BAlDinucci 1847 = F. Baldinucci, Notizie dei professori del disegno, Firenze, 1847, 5 voll.
BAlDinucci 1682 = F. Baldinucci, Vita del cavaliere Gio. Lorenzo Bernino : scultore architetto e pittore, Firenze, 1682.
BernAl Di gioyA 1651 = A. Bernal di Gioya, Copiosissimo discorso della fontana, e guglia eretta in Piazza Navona, per ordine della Santità di Nostro Signore Innocentio X dal Signor Cavalier Bernini : con una abondante dichiaratione delli quattro fiumi, Roma, 1651.
Bernini 1713 = D. Bernini, Vita del Cavaliere Gio. Lorenzo Bernino, Roma, 1713.
Bernini a Palazzo Borromeo 2009 = A. Zanardi Landi (a cura di), Bernini a Palazzo Borromeo, Torino, 2009.
BrAuer - WittkoWer 1931 = H. Brauer, R. Wittkower, Die Zeichnungen des Gianlorenzo Bernini, Berlin, 1931, 2 voll.
cAPAnnA 2001 = E. Capanna, Zoologia kircheriana, in E. Lo Sardo (a cura di), Athanasius Kircher S.J. Il museo del mondo, Roma, 2001, p. 167-177.
cAstelli gAttinArA 2001 = F. Castelli Gattinara, Roma : l’armadillo di Kircher per la Fontana dei Fiumi, in Il giornale dell’arte, 19, 2001, p. 24.
ciPriAni 1999 = A. Cipriani, Gian Lorenzo Bernini. La Fontana dei Fiumi, in M. G. Bernardini, M. Fagiolo
per servitio di detta opera che vi serviate delli Architetti Capimastri Operarij, Ministri et Offitiali che giudicarete esser necessarij e deputiate quelli che vi parerà esser necessari con l’assegnamento delle mercedi salarij e provisioni convenienti à vostro arbitrio che possiate fare tutti quelli partiti, che più vi paressero tanto sopra la provisone di pietre, legnami, et altre materie che biso-gneranno per detta opera quanto sopra maestrie e tutte l’altre cose necessarie con li patti, e Capitoli che vi pare-ranno e di stipulare qualsivoglia. Instrumento con obli-gare per l’osservanza d’esso la nostra Camera nella sua più ampla forma. Che possiate far pigliare pietre, travi, legnami, et tutte l’altre materie necessarie a detta opera dove si trovaranno con far pagare alli Padroni (?) il giusto prezzo à vostro arbitrio. Che non solo possiate sforzare Maestri, Artisti, Lavoranti, et homini, Cavalli, Carrette, Bestie, et tutti quelli che faranno bisogno a servire à detta opera, ma anco valersi à pigliare dalla Basilica di S. Pietro tutti li stigli che saranno necessarij cioè traglie, Police, Argani ferramenti, legnami grossi, Canapi et Capezzoni et qualsivoglia altra cosa che bisogna, ancorche non sia espressa con pagare alla fabrica di detta Basilica tutto quello che si consumarà per detto servitio ordinando à chi spetta di detta Basilica e fabrica che a egli acconimodamo che delli suddetti denari facciate pagare con li semplici ordini e mandati li prezzi, noliti salari, mercedi provisioni e tutto quello che alla permuta si doverà pagare a chi si doveranno per causa di detta opera a nostro arbitrio, e facciate ogni e qualunque altra cosa etiam qui non espresse e che necessariamente si dovesse esprimere per il total adempimento di detta opera fusse in qualsivoglia modo e maniera necessaria dandovi (...) ciò ogni e qualunque facoltà approvando. Noi d’adesso per allora tutto quello che da noi sarà stato fatto et operato come il tutto fatto et operato di nostro particolare ordine, e mandato datovi à bocca. Volendo e denotando che la presente vaglia con la nostra semplice sottoscritione senz’esser ammessa ne registrata in detta nostra Camera e sui libri nonostante la Costitutione di Pio 4° nostro Predecessore de registrandie tutte e qual-sivoglia altre costituitioni et ordini Apostoliche, Leggi, Statuti, reforme etiam di Roma Privilegij, usi, soliti consuetudini, e tutte e singole altre cose, che facessero in contrario, alle quali tutte e singole havendo il lor tenore qui per espresso a sufficienza per questa volta solamente et à quest’effetto espressamente deroghiamo.
Dati nel nostro Palazzo Apostolico di Monte Cavalllo li 10 luglio 1648 et essendo dopo l’erettione di detta Guglia e principiato la detta fontana partito di Monsignor Torregiano per la residenza della sua Chiesa abbiamo determinato acciorchè detta opera si conduca à perfet-tione e si termini quanto prima d’appoggiarli alla persona vostra. Onde di nostro motu proprio certa scientia e pienezza della nostra assoluta potestà con la presente vi deputiamo in luogo di detto Monsignore Torregiani con tutte e singole facoltà autorità et privilegij che labbiamo concessi al detto Monsignore Torregiani nel soprascritto Chirografo surrogandovi in ciò in suo luogo. Vogliamo inoltre che li scudi duemila girati in faccia dell’Illu-
412 LA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA : ICONOLOGIA E COSTRUZIONE
D’Amelio - mArDer 2011 = M. G. D’Amelio, T. A. Marder, Art and Science in Baroque Rome : Innocent X, Gianlorenzo Bernini, Athanasius Kircher, and the Four Rivers Fountain, in S. Leone (a cura di), The Pamphilj and the Arts : Patronage and Consumption in Baroque Rome, Chestnut Hill-Chicago, 2011, p. 23-36.
DonAti 1942 = U. Donati, Artisti ticinesi a Roma, Bellinzona, 1942.
D’onofrio 1957 = C. D’Onofrio, Le Fontane di Roma, Roma, 1957 (ed. Roma, 1985).
D’onofrio, 1965 = C. D’Onofrio, Gli obelischi di Roma, storia e urbanistica di una città dall’età antica al XX secolo, Roma, 1965 (ed. Roma, 1992).
D’onofrio 1969 = C. D’Onofrio, Roma nel Seicento, Firenze, 1969.
Di gADDo 1964 = B. Di Gaddo, Le fontane di Roma, Rilievi, Genova, 1964, p. 168-171
fAgiolo Dell’Arco 1997 = M. Fagiolo dell’Arco, La festa barocca, Roma, 1997.
fAgiolo 2006 = M. Fagiolo, Piazza Navona e la Fontana dei Fiumi, in M. Fagiolo, P. Portoghesi (a cura di), Roma Barocca : Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, Milano, 2006, p. 200-207.
fAgiolo - fAgiolo Dell’Arco 1967 = M. Fagiolo, M. Fagiolo dell’Arco, Bernini : una introduzione al gran teatro del barocco, Roma, 1967.
fAncelli 2006 = P. Fancelli, Il rilevamento della Fontana dei Fiumi, in M. Fagiolo, P. Portoghesi (a cura di), Roma Barocca : Bernini, Borromini, Pietro da Cortona, Milano, 2006, p. 208-213.
fehrenBAch 1998 = F. Fehrenbach, Discordia concors. Gianlorenzo Berninis Fontana dei Quattro Fiumi (1648-51) als päpstliches Friedensmonument, in H. Duchhardt (a cura di), in Historische Zeitschrift, Beiheft XXVI (Der Westfälische Friede), Monaco, 1998, p. 715-740
fehrenBAch 2008 = F. Fehrenbach, Compendia Mundi : Gianlorenzo Berninis Fontana dei Quattro Fiumi (1648-51) und Nicola Salvis Fontana di Trevi (1732-62), Monaco, 2008.
fontAnA 1590 = D. Fontana, Della Trasportazione dell’Obe-lisco Vaticano, Roma, 1590.
fontAnA 1696 = C. Fontana, Utilissimo trattato dell’acque correnti : nel quale si notificano le misure, ed espe-rienze di esse, Roma, 1696.
forti 1970 = A. Forti, La Fontana dei Quattro Fiumi nel modello originale, in L’Urbe XXXIII, 1, 1970, p. 21-23.
frAschetti 1900 = S. Fraschetti, Il Bernini. La sua vita, la sua opera, il suo tempo, Milano, 1900.
gigli 1994 = G. Gigli, Diario di Roma (1608-1670), ed. M. Barberito, Roma, 1994, 2 voll.
grenier 1987 = J.-C. Grenier, Les inscriptions hiéroglyphiq-ues de l’obélisque Pamphili. Un témoignage méconnue sur l’avénement de Domitien, in Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité, 99, 2, 1987, p. 937-961.
mArino - lAconelli 1987 = A. Marino, A.Laconelli, I Libri dei conti di Domenico Fontana, in E. Guidoni (a cura di), Storia della Città, L’Urbanistica nell’età di Sisto V, 40, 1987, p. 52-53.
dell’Arco (a cura di), Gian Lorenzo Bernini. Regista del Barocco, Milano, 1999, p. 375-381.
connors 1980 = J. Connors, Borromini and the Roman Oratory : Style and Society, Cambridge, Mass., 1980.
courtright 1981 = N. Courtright, Four Rivers Fountain, in I. Lavin, P. Gordon, L. Klinger, S. Ostrow, S. Cather, N. Courtright, I. Dreyer (a cura di), Drawings by Gianlorenzo Bernini from the Museum der Bildenden Künste Leipzig, German Democratic Republic, Princeton N. J., 1981.
currAn et al. 2009 = B. A. Curran, A. Grafton, P. O. Long, B. Weiss, Obelisk. A History, Cambridge Mass., 2009.
Descrittione dell’obelisco o guglia di Navona 1651 = Descrittione dell’obelisco o guglia di Navona fatta ereggere dalla SS. di N.S. Innocentio X al Sig. Cavalier Bernino : con la dichiaratione copiosa dell’origine di questa guglia ; con un lamento ridicolo, che fanno quelli, che si sono partiti da d. piazza, Roma, 1651.
De sePi 1678 = G. De Sepi, Romani Collegii Societatis Jesu Musaeum celeberrimum, Cujus magnum Antiquariae rei, statuarum imaginum, picturarumque partem Ex Legato Alphonsi Domini, S. P. Q. R. A. Secretis, muni-fica Liberalitate relictum. Etc etc. ... exponit Georgius de Sepibus Valesius, Authoris in Machinis concin-nandis executor, Amsterdam, 1678.
D’Amelio 1999 = M. G. D’Amelio, Organizzazione e macchine del cantiere barocco a Roma : la Fontana dei Fiumi a Piazza Navona (e della cappella Paolina a Santa Maggiore di N. Marconi), in Annali del Barocco in Sicilia, 6, 1999, p. 93-105.
D’Amelio 2002 = M. G. D’Amelio, Il ruolo della Reverenda Fabbrica di San Pietro nei cantieri romani.(sec. XVI-XVIII), in R. Bösel, H. Fillitz (a cura di), Römische Historische Mitteilungen des Historischen Instituts beim Österreichischen kulturforum in rom, Vienna, 2002, p. 393-424.
D’Amelio 2006a = M. G. D’Amelio, Building materials, tools and machinery belonging to the Reverenda Fabbrica di San Pietro, used for building Romae from the late 16th to the late 19th century, in H. Schlimme (a cura di), Practice and Science in Early Modern Italian Building. Towards an Epistemic History of Architecture, Milano, 2006, p. 125-136.
D’Amelio 2006a = M. G. D’Amelio, The Tecnology for the Raising of the Broken Obelisks : the Cases of the San Giovanni in Laterano Obelisk (Roma 1587) and the Axum Stelae (Tigray 2006), in P.B. Lourenço, P. Roca, C. Modena, S. Agrawal (a cura di), Proceedings of the 5th International Conference, Structural Analisys Historical Constructions. Possibilities of Numerical and Experimental Techniques, New Delhi 6-8 november 2006, New Delhi, 2006, p. 277-284.
D’Amelio 2009 = M. G. D’Amelio, Construir una « quimera » : el ensamblaje y el acabado superficial de el Baldacchino de Gian Lorenzo Bernini en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, in S. Huerta, R. Marin, R. Soler, A. Zaragoza (a cura di), Proceedings VI Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Valencia, 2009, 1, p. 375-384.
413MARIA GRAZIA D’AMELIO E TOD ALLAN MARDER
mcPhee 2008 = S. McPhee, The long arm of the Fabbrica, in G. Satzinger, S. Schütze (a cura di), Sankt Peter in Rom 1506-2006, beiträge der internationalen Tagung vom 22 - 25 Februar 2006 in Bonn, Monaco, 2008, p. 353-373.
mercAti 1589 = M. Mercati, Gli obelischi di Roma, Roma, 1589, ed. cons. a cura di G. Cantelli, Bologna, 1981, p. 313-328.
miliZiA 1785 (IV ed.) = F. Milizia, Memorie degli architetti antichi e moderni, Bassano, IV ed. 1785, 2 voll.
montAnAri 2005 = T. Montanari, Il bel composto : nota filologica su un nodo della storiografia berniniana, in Studi secenteschi, 46, 2005, p. 195-210.
olin - henriksson (a cura di) 2004 = M. Olin, L. Henriks-son (a cura di), Nicodemus Tessin the Younger, Sour-ces Works Collections, Architectural Drawings, Eccle-siastical and Garden Architecture, Stoccolma, 2004.
Nuova descrittione 1651 = Nuova descrittione della famosa maraviglia della guglia, e fontana di Navona : con le dichiarationi copiose, & esplicationi di tutte le cose, che in essa si contengono, e l’origine, e conto di tutte le guglie di Roma per sino ad hoggi ; con una canzona curiosa di chi si lamenta, per essere sfrattati via di piazza gli artisti ; la risposta inclusivi à i sudetti, Roma, 1651.
Petrucci 2004 = F. Petrucci, Bernini pubblico e Bernini privato : la Fontana dei Fiumi e il tema cristologico, in F. Checa Cremades (a cura di), Velázquez, Bernini, Luca Giordano : le corti del Barocco, Milano, 2004, p. 67-83.
PreimesBerger 1974 = R. Preimesberger, Obeliscus Pam-philius : Beiträge zu Vorgeschichte und Ikonographie des Vierströmebrunnens auf Piazza Navona, in Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3.F.25, 1974, p. 77-162.
rivosecchi 1982 = V. Rivosecchi, Esotismo in Roma barocca : studi sul Padre Kircher, Roma, 1982.
roDrígueZ 2003 = D. Rodríguez, Sobre el modelo de bronce de la Fontana dei Quattro Fiumi de Gian Lorenzo Bernini conservada en el Palacio Real de Madrid, in Reales sitios, 40.2003,155, 2003, p. 26-41.
rossi 1979 = P. Rossi, I segni del tempo : storia della terra e storia delle nazioni da Hooke a Vico, Milano, 1979.
roWlAnD 2001 (2002) = I. D. Rowland, The united sense of the universe : Athanasius Kircher in Piazza Navona, in Memoirs of the American Academy in Rome, 46, 2001 (2002), p. 153-181.
sestieri 1970 = E. Sestieri, La Fontana dei Quattro Fiumi e il suo bozzetto, Roma, 1970.
vAlADier 1828 = G. Valadier, L’architettura pratica, Roma, 1828, 5 voll..
vignoli 1651 = M. P. Vignoli, L’obelisco di Piazza Navona, Roma, 1651.
vitAle 1988 = M. Vitale, Il Seicento di Kircher : i geroglifici della fantasia, in Art et dossier, XXIV, 1988.
WittkoWer 1955 = R. Wittkower, Gian Lorenzo Bernini : the sculptor of the Roman baroque, Londra, 1955 (trad. it. Milano, 1981).
ZAmBoni 1971 = S. Zamboni, Gian Lorenzo Bernini : un modello per la Fontana dei Quattro Fiumi ritrovato, in Rapporto sull’attività di tutela, conservazione e restauro, Bologna, 1971, p. 31-43.
heimBürger rAvAlli 1977 = M. Heimbürger Ravalli, Architettura, scultura e arti minori nel barocco italiano : ricerche nell’Archivio Spada, Firenze, 1977.
huse 1970 = N. Huse, La Fontaine des Fleuves du Bernin, in Revue de l’art, 7, 1970, p. 6-17.
kircher 1650 = Athanasii Kircheri e Soc. Iesv Obeliscvs Pamphilivs, hoc est, Interpretatio noua & hucusque intentata obelisci hieroglyphici quem non ita pridem ex veteri hippodromo Antonini Caracallae Cæsaris, in agonale forum transtulit, integritati restituit, & in Urbis æternae ornamentum erexit Innocentivs X Pont. Max. In quo post varia Ægyptiacæ, Chaldaicæ, Hebraicæ, Græcanicæ antiquitatis, doctrinæque qua sacræ, qua profanæ monumenta, veterum tandem theologia, hieroglyphicis inuoluta symbolis, detecta e tenebris in lucem, Roma, 1650.
kircher 1665 = A. Kircher, Mundus subterraneus in XII libros digestus, Amsterdam, 1665.
kircher 1675 = A. Kircher, Arca Noe in tres libros digesta, Amsterdam, 1675.
iversen 1968 = E. Iversen, Obelisks in exile, The obelisks of Rome, Copenhagen, 1968, 2 voll.
iversen 1987 = E. Iversen, An unknown Borromini design for the raising of the obelisk in the piazza Navona, in Analecta Romans Instituti Danici, XVI, 1987, p. 128-135.
lAvin 1980 = I. Lavin, Bernini and the unity of the visual arts, New York, 1980.
leone 2008 = S. Leone, The Palazzo Pamphilj in Piazza Navona : Constructing Identity in Early Modern Rome, Londra, 2008.
leosPo 2001 = E. Leospo, Frammenti dell’Obelisco di Piazza Navona, in E. Lo Sardo (a cura di), Athanasius Kircher S.J. Il museo del mondo, Roma, 2001, p. 131-132.
letArouilly 1849-1866 = P. M. Letarouilly, Édifices de Rome moderne ou Recueil des palais, maisons, églises, couvents et autres monuments publics et particuliers les plus remarquables de la Ville de Rome, Liegi, 1849-1866, 6 voll.
luAlDi 1651 = M. Lualdi, Descrittione della fontana Pamphilia, dove fu già il cerchio Agonale, Roma, 1651.
lumBroso 1876 = G. Lumbroso, Notizie sulla vita di Cassiano Dal Pozzo, protettore delle belle arti, fautore della scienza dell’antichità nel secolo decimosettimo : con alcuni suoi ricordi e una centuria di lettere, in Miscellanea di storia italiana, XV, Torino, 1875.
mAgAlotti 1991 = L. Magalotti, Diario di Francia dell’anno 1668, ed. M. L. Doglio, Palermo, 1991, p 98-102.
mArDer 1998 = T. A. Marder, Gian Lorenzo Bernini, Milano, 1998.
mArDer 2000 = T. A. Marder, Borromini e Bernini a piazza Navona, in C.L. Frommel, E. Sladek (a cura di), Francesco Borromini, atti del convegno internazionale Roma 13-15 gennaio 2000, Milano, 2000, p. 140-145.
mcPhee 2002 = S. McPhee, Bernini and the bell towers : architecture and politics at the Vatican, New Haven, 2002.