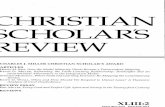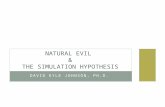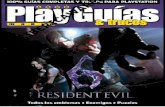Christian Faith & the problem of Evil
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Christian Faith & the problem of Evil
[in Rassegna di teologia 43 (2002) 75-98]
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
C. Lorenzo Rossetti
“Non c’è un punto del messaggio cristiano che non sia, per un certo aspetto, una risposta al problema del male” (CCC 309).
Non si può non considerare l’assillo e lo scandalo di fronte all’enigma del male, tanto fisico (dolore, catastrofi naturali…) quanto morale (peccato, odio, crudeltà…) come un segno peculiare di autentica umanità1. Si sa che la Moder-nità ha espresso con veemenza la presa di coscienza del Male nella sua radicali-tà e “assurdità”2. Senza pretendere svolgere qui un trattato “de malo”, vogliamo solo evidenziare, quasi illustrando la frase del Catechismo citata in esergo, quanto la Fede della Chiesa nel suo insieme (kat’holon) aiuti l’intelligenza a confrontarsi con questo mistero. Da tale soccorso la prassi si trova ovviamente rinforzata per poter concretamente fronteggiare con Dio il dramma del male. Dapprima ricorderemo sinteticamente gli esiti delle principali risposte non cri-stiane all’enigma del male (1); indicheremo poi il contenuto ex parte quaestio-nis de malo del Credo ecclesiale nei suoi aspetti teo-logici e protologici (2) e
1 Per un primo orientamento nella sconfinata bibliografia sul tema, rimandiamo soprattutto a P. RICOEUR, “Il male”, in Enciclopedia delle religioni, dir. M. ELIADE, Milano, 1997, 417-427. Segnaliamo i volumi collettivi “Liberaci dal male”, in Parola Spirito e Vita 19 (1989); Domande a Giobbe. Intervista sul problema del male, ed. M. CIAMPA, Roma, 1989; Mysterium iniquitatis. Il problema del male, ed. G.L. BRENA, Roma 2000; Padre nostro liberaci dal male, ed. D. PIAZZA, Cinisello Balsamo 2000 (in particolare il contributo di M. Farrugia, pp. 249-290). Rimandiamo anche a A. POMA, Avranno fine le parole vane?, Cini-sello Balsamo, 1998; G. DE SIMONE, “In lotta con il drago. Dio, la libertà, il male”, in Ras-segna di Teologia 41 (2000) 81-86; H. HARING, Il male nel mondo. Potenza o impotenza di Dio?, Brescia 2001. 2 Basti pensare al grido di Dostoievski o di Camus di fronte alla sofferenza degli innocenti. Vedi rispettivamente P. EVDOKIMOV, Dostoievski e il problema del male, Roma 1995 e P. MICCOLI, Il problema del male in Albert Camus, Alba 1971.
75
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
cristologici e pneumatologici (3); nella conclusione, segnaleremo quanto i dati della fede cattolica consentano la sussunzione degli elementi di verità rinvenuti nelle altre religioni o filosofie (4).
1. Principali atteggiamenti non cristiani di fronte al problema del male Se il problema del male non è illuminato dalla fede nel “Dio e Padre di Ge-sù Cristo”, le più notevoli risposte all’enigma del male si potrebbero sintetizza-re –semplificando, ma senza eccessivi semplicismi– sotto queste quattro cate-gorie, di per sé incompatibili fra loro: la rassegnazione religiosa; la denuncia dualistica; la ribellione ateistica e l’integrazione intellettualistica3. Spieghiamo-le brevemente individuandone le conseguenze pratiche. 1.1. Il Monismo e la sottomissione religiosa È probabilmente fra le più antiche e degne risposte umane al problema del male. La si trova in varie grandi religioni, specie nel Giudaismo e nell’Islam4. Un’acuta percezione del monismo creazionale pone l’unico Dio come causa prima ed insindacabile di ogni cosa. Il credente dovrà assumere la propria re-sponsabilità e libertà tendendo in definitiva a radicalizzare il sentimento del Timor di Dio. In fondo, chi siamo noi per giudicare il Creatore? Se da Dio ac-cettiamo il bene perché non accettare il male? L’uomo, scopertosi un “vermi-ciattolo” nell’universo, si riterrà chiamato ad arginare il male con la propria fe-deltà alla Legge divina (Thorah/Shari’a/Dharma) e potrà solo ammutolire alla domanda dell’Onnipotente: “Dov’eri tu quando Io ponevo le fondamenta della terra?” (Gb 38,4). La conseguenza pratica di questo atteggiamento è la velata tristezza della rassegnazione (se non addirittura del fatalismo) lenita forse dalla fede nella provvidenza e dalla speranza nella retribuzione futura o ultraterrena. 1.2. Il dualismo e il male “irriducibile”
3 Della sterminata bibliografia circa il problema del male nelle religioni e nelle filosofie ri-cordiamo soltanto tre opere collettive: Il bene e il male nelle religioni, Fossano, 1970; La ragione e il male, ed. G. FERRETTI, Genova 1988; Del bene e del male. Tradizioni religiose a confronto, ed. M. RAVERI, Venezia 1997. 4 Cfr. p.e. P. SACCHI, “Il problema del male nell’ebraismo precristiano”, in Del bene e del male. Op. cit. 117-124 e G. VERCELLIN, “Il Grande Satana. L’Islam di fronte al problema del male”, ibid. 183-196.
C. Lorenzo Rossetti 76
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
Diversamente dal monismo teistico, la risposta dualistica costata nel mondo la presenza simultanea e quasi equivalente del bene e del male. Questa duplice esperienza costringe a porre al fianco del Divino –proprio per giustificarne la bontà– un altro principio ontologico e cosmogonico. È questa la risposta di non poche religioni primitive, dello zoroastrismo, della gnosi, del manicheismo5. Si rifiuta qui la visione unitaria di un mondo sostanzialmente buono, prodotto dal-le mani di un Dio unico e santo. Il male non è tanto un peccato, una colpa, quanto una macchia naturale, insita nella costituzione di alcuni esseri. Gli esiti pratici del dualismo sono noti: il tendenziale disprezzo per la materia e per la realtà visibile, la divisione del mondo in due categorie: i buoni e i cattivi, gli spirituali e i materiali ecc. Sul piano della vita concreta non si tratterà tanto di combattere il male quanto piuttosto di evitarlo, nel ripiego quasi narcisistico sulla comunità di coloro che sanno, che sono puri. 1.3. La ribellione ateistica e il male “inaccettabile” È la risposta tipica dell’uomo moderno; la soluzione di buona parte dell’esistenzialismo francese di Sartre e di Camus6. Se Dio esistesse sarebbe l’ultimo responsabile di tutta la massa di male inaccettabile presente nel mon-do. Un tale Dio privo di bontà non può esistere. Si riscontra facilmente questo atteggiamento in persone sensibili ed emozionali. La conseguenza pratica di questo visione del mondo è paradossalmente un’“inflazione” del male. Tutto diviene “passione inutile”. Si finisce per male-dire tutta la realtà. Mancando qualsivoglia vera possibilità di riscatto, tutto è dolore, assurdo, nauseante. L’autenticità, l’impegno rivoluzionario (come l’ascesi verso il Nirvana) sono i diversi volti di altrettanti tentativi di sfuggire ad un mondo ostile. La felicità personale, ineludibilmente agognata, è una tanto necessaria quanto assurda im-maginazione (Sisifo felice!). 1.4. Le costruzioni teoriche e il male “integrato” È questa la risposta meno comune, l’appannaggio di una élite di pensatori credenti o atei. Non ci si pone il problema da un punto di vista morale o emoti-vo. Per non lasciare al male l’ultima parola, lo si accetta come dato di fatto, fa-cendogli perdere la sua singolarità e tragicità Il male è così addomesticato, me-tabolizzato; esso fa parte del mondo e come tale va com-preso. Potremmo citare 5 Cfr. G. GNOLI, “Zoroastro e mani”, ibid. 125-136. 6 Si pensi soltanto alla Nausée e a L’homme révolté. Ci sembra che –nel suo asserto fonda-mentale– tale ribellione al mondo come dominio del dolore sia anche quella del Buddhismo più originario.
C. Lorenzo Rossetti 77
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
qui la teodicea razionalistica di Leibniz per cui, in fin dei conti, “tutto è bene nel migliore dei mondi possibili”7; l’idealismo hegeliano che vede nel male quella componente estetica necessaria alla bellezza del tutto; il positivismo scientistico per cui il male è un positum della natura delle cose; l’a-moralismo di Nietzsche che intende superare sia il male che il bene nell’affermazione gioiosa che “dice Sì”… L’esito effettivo di tali diversissime prospettive sarà quello di relativizzare radicalmente il male concreto e di smorzare lo sforzo pratico per ridurlo e combatterlo. Non abbiamo richiamato questi dati soltanto perché si conosce una realtà comparandola ad altre, ma anche perché siamo convinti che le risposte non cri-stiane veicolino, insieme ad assunti lacunosi e irrecepibili, degli elementi validi e preziosi che trovano spazio nella Fede cristiana attestandone la plenitudo veri-tatis. La rivelazione della paternità divina (con il corollario protologico della permissione del male) e del mistero pasquale (con il corollario escatologico del-la redenzione) consente di illuminare dall’Alto l’enigma del male, la cui condi-zione di possibilità ultima risiede nella libertà e gratuità dell’amore paterno e filiale di e in Dio (2.1). Da parte sua, la creazione come tale comporta la neces-sità del male fisico, come privatio boni (2.2). Ma il discorso della fede, rispet-toso della tragicità del male morale, deve prolungarsi ricorrendo ad una demo-nologia (2.3) e ad una lettura trinitaria del peccato originale (2.4). Questi ele-menti costituiscono il prologo alla definitiva risposta cristiana al male che av-viene nel Mistero Pasquale. Mistero ab aeterno presente nel cuore amante del Padre (3).
2. Elementi teo-logici e protologici 2.1. “In unum Deum, Patrem omnipotentem”: Il “drammatico” amore del Padre
e la libertà del Figlio 2.1.1. La compassione e la pazienza del Padre
Non si può non rispondere alla questione posta dall’enigma del male senza
indicare ciò che la rivelazione biblica –culminante in Cristo– rende manifesto come il mistero della Sofferenza di Dio8. Già l’AT e il Giudaismo hanno per- 7 Circa l’indole solo apparentemente cristiana della teodicea leibniziana rispetto a questo argomento, vedi G. COTTIER, “Le mal”, in Nova et Vetera, 72 (1997) 5-13. 8 Questo delicato tema è stato opportunamente riscoperto dalla teologia del XX secolo. Ri-cordiamo solo i nomi degli ortodossi Bulgakov e Florenskij, dei riformati Barth e Mol-tmann, dei cattolici Balthasar, Durrwell e Galot. In prospettiva ebraica: Rosenzweig, He-
C. Lorenzo Rossetti 78
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
cepito chiaramente che il Dio vivente non può essere a-patico, privo di senti-menti e di passione. Certo egli è l’immutabile, “Io sono lo stesso e non cam-bio”, dice Yhwh, Colui che è, ma la sua immutabilità o, meglio, invariabilità, non è altro che il segno dell’eternità e della fedeltà dell’Amore. La Bibbia ci porta a rifiutare tanto l’umanizzazione di Dio quanto la sua anestetizzazione9. Dio ha un pathos divino. “La natura del pathos divino è un mistero per l’uomo. Ciò che Isaia (55,8s) disse riguardo ai pensieri di Dio può essere allo stesso modo applicato al suo pathos: Infatti, il mio pathos non è il vostro pathos, né le vostre vie sono le mie vie, dice il Signore. Infatti, come i cieli sono superiori alla terra, così le mie vie sono superiori alle vostre vie, e il mio pathos al vo-stro”10. Il dato tradizionale della Impassibilità-Immutabilità divina (a-patheia) asserito tanto dalla Metafisica11, quanto dalla Scrittura12 deve quindi essere associato con un altro dato attestato con forza dalla Rivelazione giudeocristiana: il perso-nale coinvolgimento del Signore nella storia umana13 e quindi anche la sua “sofferenza”. In Dio (“coincidentia oppositorum”) A-patheia e Sym-patheia non si escludono. Dio trascende il nostro intendimento. L’assoluta Paternità di Dio comprende in se stessa un’auto-rinuncia fondata nell’Amore di auto-donazione. Dio Padre da sempre e nella sua naturale, suprema ed assoluta liber-tà “rinuncia” per così dire alla sua solitudine per generare in sé il Figlio eterno. Alcuni tra i migliori teologi del nostro secolo, quali Bulgakov e Balthasar, non esitano a parlare di una “kenosi” di amore nella vita intra-trinitaria stessa. Sem-bra che si trovi qui la chiave dell’ineffabile Mistero di Dio, nel contempo Stes-so e Nuovo, Immutabile e Pieno di Compassione. In Lui, la più remota Tra-scendenza si confà alla più umile Immanenza: “Così dice Yhwh: “Il cielo è il mio trono, la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi potreste costruire? In quale luogo potrei fissare la dimora? Tutte queste cose ha fatto la mia mano ed esse sono mie, oracolo di Yhwh. Su chi volgerò lo sguardo? Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi teme la mia parola”” (Is 66,1-2). Divinum est in minimo contineri.
schel, Wiesel. In senso più tradizionale vedi T. WEINANDY, Does God suffer, Edinburgh 2000. 9 A. HESCHEL, Il Messaggio dei profeti, Roma 1981, 76. 10 Ibid. 77. 11 Cfr. ARISTOTELE, Metafisica, XI. 12 P.e. Mal 3,6: “Io sono Yhwh, non cambio”; Gc 1,17: in Dio, Padre delle luci “non c’è va-riazione, né ombra di cambiamento (tropês aposkìasma)”. Un bel testo della tradizione in proposito si trova in CIRILLO DI GERUSALEMME, Catechesi, IV,4-5. 13 Cfr. Es 3; Mi 6,1-8, Mt 27,46, Rm 8,32.
C. Lorenzo Rossetti 79
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
Se nel suo mistero più profondo Dio non fosse Amore e Padre non si potrebbe-ro comprendere questi prodigiosi avvistamenti vetero-testamentari che una bel-lissima invocazione cristiana compendia così: “O Dio che manifesti la tua on-nipotenza soprattutto nella grazia del perdono”14. Così come Dio è padre in un modo unico e divino, così –e per i cristiani, proprio per questo stesso motivo– egli è capace di pathos in un modo unico e supremo. Si conosce la prudenza della Chiesa antica al riguardo15. Da una parte essa doveva premunirsi dall’eresia patripassiana che confondeva le persone del Padre e del Figlio e pre-tendeva che sulla Croce la persona stessa del Padre avesse subito la passione. Da un’altra parte l’influenza della filosofia ellenistica, con la sua esaltazione della trascendenza divina, indusse i primi autori ecclesiastici ad enfatizzare l’immutabilità e l’impassibilità di Dio. Inutile dire quanto la teologia contempo-ranea, non più minacciata dal modalismo, né dipendente da una particolare cor-rente filosofica abbia felicemente riscoperto questa verità rivelata: Dio soffre in un modo divino, Dio non è indifferente al dolore umano, egli com-patisce, egli lotta con e per l’uomo. Era quanto già Origene aveva intuito in un testo divenu-to giustamente celebre:
Farò un esempio tratto dalla nostra vita, poi se lo Spirito santo me lo con-cederà, passerò a parlare di Gesù Cristo e di Dio Padre. Quando mi rivol-go a uno e lo supplico in mio favore, che abbia compassione di me, se è privo di pietà non lo tocca nessuna delle parole che gli dico; se invece è di animo sensibile e non ha alcuna durezza di cuore, mi presta ascolto, prova compassione per me e dispiega dinanzi alle mie preghiere un’interiore tenerezza. Riguardo al Salvatore, fai conto che accada la stessa cosa. Egli è disceso sulla terra mosso a pietà del genere umano, ha sofferto i nostri dolori ancor prima di patire la croce e degnarsi assumere la nostra carne; se egli non avesse patito, non sarebbe venuto a trovarsi nella condizione della nostra vita di uomini. Prima ha patito (primum passus est), poi è disceso e si è mostrato. Qual è questa passione che ha sofferto per noi? È la passione dell’amore (caritatis est passio). Persino il Padre, il Dio dell’universo, “pietoso e clemente” e di gran benignità, non soffre anche lui in certo qual modo? Non sai che quando governa le cose umane, condivide le sofferenze degli uomini? Infatti, “il Signore ha sop-portato i tuoi costumi, come un uomo sopporta quelli di suo figlio” (cfr. Dt 1,31). Quindi Dio prende i nostri costumi, come il Figlio di Dio porta le nostre sofferenze. Nemmeno il Padre è impassibile (ipse Pater non est impassibilis). Se lo preghiamo, prova pietà e misericordia, soffre di amo-
14 Messale romano, Preghiera eucaristica della riconciliazione, cfr. Mt 5,45. 15 Vedi su questo A. FRONHOFEN, Apatheia tou Theou, Frankfurt am M., 1987.
C. Lorenzo Rossetti 80
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
re e s’immedesima nei sentimenti che non potrebbe avere data la gran-dezza della sua natura, e per causa nostra sopporta i dolori degli uomini16.
2.1.2. Il Padre del Figlio libero Prolunghiamo questa riflessione rifacendoci alla parabola del Padre miseri-
cordioso. L’assoluta Paternità amante di Dio è la condizione di possibilità del male come rifiuto dell’amore. Dio è tanto Padre che permette alle sue creature di rifiutarlo. Di fronte all’arrogante ed insultante sfida rivolta dal figlio ribelle (“dammi la parte di sostanza [ousias] che mi spetta!”), il vangelo lascia perce-pire il drammatico e umilissimo silenzio del Padre (cfr. Lc 15,12). Il male e il peccato sono permessi da Dio solo in quanto potranno essere superati da un Amore e un Perdono più grandi. Essi sono segni della Gratuità dell’Amore di Dio (Lc 6,35) e, una volta sconfitti dall’amore del Padre, diverranno l’incentivo per la creatura –che fa esperienza concreta della sua indegnità– ad amare ancora di più Dio (Lc 7,37-50). “Experimento discens unde liberatus est, semper gra-tus existat Domino17”. La paternità divina è la chiave che permette di accettare e affrontare l’enigma del male. Confessare l’origine di tutto il creato nell’onnipotenza paterna di Dio addita anche una forma di “kenosi”, un abbassamento, un gesto di umiltà e di silenzio da parte del Creatore: “sì, in un certo senso lo si può dire: di fronte alla libertà umana Dio ha voluto rendersi “impotente”18”. Dio Padre, per amore,
16 ORIGENE, Omelie su Ezechiele, 6,6. Nel magistero recente, è GIOVANNI PAOLO II ad aver riportato l’attenzione sul “dolore del Padre”: “questo imperscrutabile e indicibile “dolore” di padre genererà soprattutto la mirabile economia dell’amore redentivo in Gesù Cristo, af-finché, per mezzo del mistero della pietà, nella storia dell’uomo, l’amore possa rivelarsi più forte del peccato. Perché prevalga il “dono”!” (Dominum et vivificantem, 39,2). 17 IRENEO, Adversus Haereses, III, 20, 2. 18 GIOVANNI PAOLO II, Varcare la soglia della speranza, Milano 1994, 73. Si ricorderà in proposito la nota dottrina ebraica –espressa in particolare da Isacco Luria († 1572)– dello Zimzum: la contrazione divina che dà luogo all’essere del mondo (cfr. p.e. G. SCHOLEM, Le grandi correnti della mistica ebraica, Genova 1986, 270-274). S. BULGAKOV ha stupenda-mente espresso il dato teologico dell’umiltà del Padre: “Dio trattiene la sua onnipotenza, rispettando le vie del mondo nella sua libertà (...). Dio è Spirito e fonte d’ispirazione. La vela del mondo è estranea allo spirito e all’ispirazione, s’impantana a servire la carne, stri-scia nella bassezza della sensualità e del torpore spirituale, si esalta in un ateismo demente e in un delirio sacrilego, maledice quanto è santo o gli resta indifferente. E il cielo tace. Tale è la kenosis dell’amore del Padre (...) il sacrificio della pazienza: sopportare l’essere del mondo decaduto in presenza di colui che è la verità, il giudice, l’onnipotente, Iddio” (Il Pa-raclito, Bologna 1987, 629-631).
C. Lorenzo Rossetti 81
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
vuole di fronte a sé un mondo autonomo e degli spiriti liberi19. In questa sua decisione creatrice è inclusa la possibilità della ri-conoscenza e del rifiuto. Il gesto creatore in quanto gesto paterno non si im-pone, ma si pro-pone come dono di amore e di vita in vista di un possibile ritorno glorificante della creatura filiale alla Fonte divina. Creato in Filio, il mondo –riassunto nell’uomo– è chiamato a riflettere la libera gratitudine del Figlio-Sapienza, eterno Sì e Amen del Padre e al Padre20. Abbiamo detto “libera gratitudine” del Figlio. Pensiamo infatti che la condizione ultima di possibilità del male come rifiuto del Padre stia proprio nella libertà del Figlio eterno. Libertà come estremo segno dell’identità personale del Logos. “Nessuno prende la mia vita ma la do da me stesso (ap’emautou)” dice Cristo (Gv 10,18). Il Canone Romano ha aggiunto alle parole della consacrazione: “egli offrendosi liberamente alla sua passione”. Ora, questa libertà filiale di obbedienza, di adesione alla volontà paterna non esprime forse l’ineffabile libertà del Figlio eterno nel suo donarsi al Padre? Se è vero che egli, umanamente, si è offerto sulla croce con uno “Spirito eterno” (Eb 9,14), e se questa offerta è stata libera, possiamo legittimamente pensare che, in divinis, vi sia una imprepensabile libertà di amore del tutto prima, analogatum princeps di ogni altra riconoscenza, gratitudine e obbedienza. Inoltre questa li-bertà, proprio in quanto tale, si avvera come l’estrema condizione di possibilità, in creaturis, del suo contrario: il rifiuto e la mis-conoscenza. Il Figlio ama il Padre con amore totale, perché è Padre, nella totale gratuità ed anche –perché il Padre così vuole essere amato– nella vera libertà. Ogni creatura, costituita in Cristo, trova la sua verità nell’amare il Padre come Cristo lo ama, per se stesso e liberamente. 2.1.3. La Provvidenza del Padre
In Dio, il Potere si manifesta quindi nella Misericordia: “Tutto il mondo da-
vanti a te, come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina ca-duta sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto tu puoi, non guardi ai peccati degli uomini, in vista del pentimento (eis metánoian). Poiché tu ami tut-te le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato; se avessi odiato qual-cosa, non l’avresti neppure creata. Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non vuoi? O conservarsi se tu non l’avessi chiamata all’esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte sono tue, Signore, amante della vita” (Sap 11,22-26). 19 Forse nessuno meglio di Ch. PEGUY ne Le Mystère des saints innocents ha espresso ques-to dato: “être aimé librement./ Rien ne pèse ce poids, rien ne pèse ce prix” (cfr. Oeuvres poétiques complètes, Paris 1975, 716). Filosoficamente cfr. N. BERDJAEV, Il senso della creazione. Saggio per una giustificazione dell’uomo, Milano 1994, 410. 20 Cfr. 2Cor 1,20, Ap 3,14.
C. Lorenzo Rossetti 82
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
La risposta classica della teologia cristiana al problema del male è quella ripor-tata dal Catechismo della Chiesa cattolica: Dio permette il male perché è capace di trarne un Bene maggiore. “Gli angeli e gli uomini, creature intelligenti e libe-re, devono camminare verso il loro destino ultimo per una libera scelta e un amore di preferenza. Essi possono, quindi, deviare. In realtà, hanno peccato. E’ così che nel mondo è entrato il male morale, incommensurabilmente più grave del male fisico. Dio non è in alcun modo, né direttamente né indirettamente, la causa del male morale. Però, rispettando la libertà della sua creatura, lo permet-te e, misteriosamente, sa trarne il bene: Infatti “Dio onnipotente [...], essendo supremamente buono, non permetterebbe mai che un qualsiasi male esistesse nelle sue opere, se non fosse sufficientemente potente e buono da trarre dal male stesso il bene”21”. Dio ha creato un mondo in cui il male esiste; egli ha persino accettato di per-mettere l’esistenza di un male radicale (demoniaco). E questo perché “ne valeva la pena”22. Giovanni Damasceno ricordava che Dio è più forte della cattiva vo-lontà umana: “Se il fatto che Dio sapeva che l’uomo sarebbe diventato malva-gio avesse impedito a Dio di suscitare all’esistenza gli esseri che nella sua bon-tà voleva creare, questo avrebbe significato che il male era più forte della bontà di Dio”23. 2.2. “Factorem caeli e terrae”: contingenza e drammaticità del male 2.2.1. L’inevitabile possibilità del male… Un dato tradizionale della filosofia e della teologia è che il male esiste e non potrebbe non esistere. “Il male esiste in vista della perfezione dell’universo” diceva san Tommaso24. Pretendere un mondo in cui non esiste-rebbe il male significa esigere la “quadratura del cerchio”25. In quanto realtà finita, quindi limitata e imperfetta, il mondo creato non può non comportare la “privatio boni”, l’assenza di bene, che è la classica definizione del male. Questa visione delle cose è estremamente salutare e positiva. Essa infrange il dilemma-pregiudizio filosofico epicureo per cui in fondo Dio vorrebbe ma non può evita-re il male (e quindi non è veramente Onnipotente) oppure potrebbe ma non vuo-
21 CCC 311; la citazione è di AGOSTINO, Enchiridion, 11,3. A questo corrisponde la tesi classica sostenuta anche da Ch. JOURNET, Le Mal, Paris 1961. 22 Cfr. A. TORRES QUEIRUGA, Credo in Dio Padre, Casale Monferrato 1994, 142ss. 23 De fide orthodoxa, IV,21. Citato anche da E. BIANCHI, Adamo, op. cit. 183. 24 “Malum invenitur in rebus propter perfectionem universi, quae requirit ut sint quaedam quae a bonitate deficere possint, sicut et corruptibilia” (cfr. Summa Theologiae, I, 48, 2). 25 Cfr. A. TORRES QUEIRUGA, Credo in Dio Padre, op. cit. cap. IV, specie pp.133-136.
C. Lorenzo Rossetti 83
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
le evitare il male (e quindi non è veramente Buono). Affermare che Dio in real-tà non può (non per im-potenza sua, ma per la natura stessa delle cose) creare un mondo perfetto aiuta non poco a situare il problema del male nella giusta ot-tica. 2.2.2. … e tuttavia lo scandalo V’è però un rischio in questo approccio. Presentare il male come un neces-sità metafisica tradisce per certi aspetti il mistero del male nella sua indeducibi-lità e contingenza quale ci è proposto dai capitoli 2 e 3 della Genesi26. In questo senso bisogna conciliare necessità ontologica dell’imperfezione fisica, come segno della finitezza e limitatezza del mondo creato e la contingenza del male morale, come segno della realizzazione di una possibilità insita nell’esercizio, o meglio nell’abuso e “misuso”, della libertà. Si deve dire che in verità il male risulta veramente tale solo se pensato congiuntamente al Dio buono. Si capisce così un’espressione alquanto ardita di san Tommaso: “se il male esiste, esiste Dio”27. Il mondo in cui viviamo è sufficientemente bello ed enorme per suscita-re in noi la riconoscenza e il ringraziamento nel santo timore del Creatore; ma esso è altresì sufficientemente “rovinato” per attestarsi anche come luogo di peccato e di “esilio” additando il vero destino dell’umanità nel Mondo nuovo (cfr. 2Pt 3,13). Il male fisico può essere infatti legittimamente considerato (oltre che come intrinseca imperfezione della finitezza) anche come riflesso cosmico del peccato e indice prezioso della non definitività di questo eone. Nel linguag-gio della Genesi possiamo dire che la terra attuale è nel contempo benedetta e maledetta da Dio28. 2.3. “Et invisibilium…”. L’imprescindibile demonologia È stato affermato che a proposito del male, “parlare del demonio non risolve nulla, o forse appiattisce la difficoltà. Se non si vuole cadere nel dualismo…si deve spiegare perché Dio ha permesso che questi agisse, perché il
26 Cfr. al riguardo L. PAREYSON, Ontologia della libertà. Il male e la sofferenza, Torino 1995, 228; A. LÉONARD, Le ragioni del credere, Milano 1994; A. GESCHÉ, Il male, Milano 1996, 110ss: “parlando del male in termini di contingenza, il giudeo-cristianesimo ha defi-nitivamente escluso il male dalla natura delle cose per farne una realtà di cultura e dunque di libertà e di dominio” (113). 27 “Si malum est, Deus est” (Summa contra Gentiles, III,71). Ci pare che le forti riflessioni di Ph. NÉMO vadano in questa stessa direzione (cfr. Job et l’excès du mal, Paris 1978). L’“eccesso” del male rimanda alla trascendenza salvifica di Dio (231-232). 28 Cfr. Gen 1,22.28; 3,16-17; Rm 8,20-21.
C. Lorenzo Rossetti 84
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
Signore del mondo abbia lasciato libero il grande assassino. Questo se non ci si chiede prima come è diventato cattivo il demonio, senza un demonio che lo avesse fatto cattivo”29. Nondimeno, non sfugge a nessun teologo cattolico che affrontare il problema del male senza ricorrere anche ad una demonologia sarebbe come voler imparare una lingua con un vocabolario monco. Dopo anni di timoroso silenzio si sta avvertendo l’esigenza di riaprire il discorso su questo delicato punto nodale della dottrina cristiana30. Dai pochi dati de Traditione Fidei che possediamo sul demonio, dobbiamo ritenere che egli fosse il primo degli angeli, spirito intelligente e libero, quindi creato originariamente “prope Deum”, potremmo aggiungere “prope Filium”. Luci-fero: il portatore di luce, colui che più delle altre creature sapeva liberamente e gratuitamente lodare il Padre ad immagine del Figlio. Questa sua prossimità al Figlio consente di capire il suo duplice peccato: la superbia e l’invidia. Corruptio optimi pessima. Dobbiamo pensare che con un atto di libertà immensamente superiore alla nostra, colui che più somigliava al Logos, amando e lodando il Padre in una dipendenza tutta filiale, si sia allontanato totalmente dal suo stato, rifiutando radicalmente la paternità divina. Il paterno disegno divino dell’incarnazione del Figlio (che avrebbe sollevato la creatura umile e fangosa ad una dignità superiore a quella angelica) fu occasione dell’invidia e della caduta dell’angelo. Il peccato di Satana consiste nel rigetto della filialità e nella pretesa all’an-archia31. Questo è l’archetipo del peccato originale. Il portatore di luce, di lode libera e gratuita, si è trasformato nel Principe delle tenebre, colui che porta nel mondo l’inconcepibile odium Dei e la gratuità nel male: la crudeltà. Questa, pressoché sconosciuta nel regno animale, entra nel mondo umano come stigmate del male morale per opera del padre della menzogna, l’anti-Dio, l’anti-
29 TORRES QUEIRUGA, Credo in Dio Padre, op. cit. 130. 30 I riti catecumenali e battesimali della Chiesa (cioè l’abc della fede cattolica) sono prati-camente incomprensibili a prescindere dall’esplicita credenza nell’esistenza del demonio. Vedi le chiarissime affermazioni del CCC nn. 391-395. Cfr. S. BULGAKOV, La sposa dell’Agnello, Bologna 1991, 222-241; A. GESCHÉ, Il male, op. cit. 73-76; C. BALDUCCI, Il diavolo, Milano 1994; R. LAVATORI, Satana, un caso serio. Studio di demonologia cristia-na, Roma 1996; B. FORTE, “Cristo, il vincitore di Satana”, in Asprenas 46 (2000) 483-498. 31 San Tommaso, erede di Agostino, diceva che il diavolo aspirando al possesso della beati-tudine finale in virtù della sua propria natura (per virtutem suae naturae) e non in grazia di qualcuno di superiore (et non ex gratia alicuius superioris), il ché è prerogativa di Dio, de-siderò una qualità di Dio (De malo, 16, 3). Si potrebbe forse precisare ciò che Tommaso chiama il proprium Deo, come proprium Patri. Il peccato demoniaco è un attentato alla pa-ternità divina, il contrario stesso della filialità dell’Unigenito. Per Maritain il diavolo “ha voluto godere, a modo suo, di quel privilegio divino che è la sovrana autarkeia” (cfr. CH. JOURNET,– J. MARITAIN, – PHILIPPE DE LA TRINITE, Le Péché de l’Ange, Paris 1961, 80-81, n.5). BULGAKOV parla di “auto-teismo” (op. cit. 228)
C. Lorenzo Rossetti 85
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
Figlio, lo pseudo-Padre, il diavolo. La presenza del male radicale, del demoniaco è l’unica valida risposta al “perché?” umano di fronte al male totalmente irrazionale e ingiustificato. In questo senso, il XX secolo, con il suo funesto corteo di stragi e genocidi impone una riflessione sul demoniaco. Se, dopo la Shoah, la teologia contemporanea cedesse alla tentazione di tacere sul diavolo, essa insulterebbe la verità e la giustizia di Dio ed anche l’uomo sarebbe vittima di questo silenzio, giacché solo affermando l’esistenza di Satana si può continuare a sperare nell’umanità32. Non ci si può più accontentare della consueta risposta: il male esiste perché il mondo è “finito” quindi imperfetto in se stesso. Il male non è soltanto assenza di bene, esso può assumere –e di fatto ha tragicamente assunto– il volto maleficamente attivo della crudeltà e del sadismo. Noi diciamo che l’esistenza del demonio come pseudo-Padre e anti-Figlio, ossia come principio di gratuità nel male, è l’unico dato che permetta di rendere conto intellettualmente di questo tipo di male. La dottrina cattolica dell’eternità dell’inferno come sorte finale del demonio è anche l’unica valida risposta all’esigenza di giustizia che dal fondo del dolore umano grida a Dio33. 2.4. Il peccato originale come “An-Archia” e rifiuto della Filialità34
Sono ben note le distinzioni teologiche tra peccato originale originante (la col-pa personale e “corporativa”35 di Adamo) e peccato originale originato (la con-seguenza del primo e la presenza del peccato in noi) e tra l’Immagine (Eikôn) e la Somiglianza (Homoiôsis)36 nella costituzione umana. Il Peccato ha ridotto la natura umana, l’ha indebolita e ferita, ma non l’ha distrutta; esso ha deturpato l’immagine sì da allontanarla della somiglianza al suo prototipo, Cristo; ma non l’ha eliminata. La dignità umana è preservata nel libero arbitrio: la volontà co-me facoltà di tendere al bene (liberum arbitrium) che sussiste anche dopo il
32 GESCHÉ va in questo senso, Il male, op. cit. 74. Si sa che è grande la tentazione in chi non ammette l’esistenza del demonio di demonizzare l’uomo stesso. 33 Non si tratta di giustizia vendicativa, ma di dare il giusto peso alla tragicità dal male. Su questo tema ci permettiamo rimandare al nostro “Speranza universale e possibilità dell’inferno. Per una teologia ortodossa dell’apocatastasi”, in Lateranum 55 (1999) 131-137. 34 Riprendiamo qui quanto esposto in ““Perché diano gloria al Padre vostro celeste”. Pater-nità divina e missione della Chiesa”, in Lateranum 66 (2000) 242-245. 35 Si intende che in Adamo, come in Cristo nuovo Adamo, è incluso tutto il corpo dell’umanità. Cfr. su questo L.F. LADARIA, Antropologia teologica, Madrid-Roma, 1983. 36 Cfr. ORIGENE, Peri Archon, III,6,1.
C. Lorenzo Rossetti 86
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
peccato, sebbene esso sia “attenuatum et inclinatum”37; così come permane la vocazione alla figliolanza divina. Una riflessione speculativa sul peccato originale nella nostra prospettiva ci in-duce a definirlo come rifiuto della Paternità di Dio. Esso è positivo in Adamo, come superba ed esplicita Decisione di rompere la relazione di filialità verso Dio. Esso è negativo in noi, cioè come Dimenticanza o Ignoranza del Padre38. Possiamo proporre questa definizione del peccato originale originato: l’Ignoranza esistenziale della paternità di Dio, che provoca l’auto-fondazione ego-centrica della vita e quindi la mortale incoercibilità della concupiscenza. L’Ego è creato ad immagine dell’ineffabile personalità divina del Figlio che conosce se stesso come il “Tu” amato del Padre. L’Io dell’eterno Figlio è to-talmente centrato nel Padre (Gv 1,18); è un Abisso infinito che si scopre sempre colmato dalla ricchezza infinita del Padre, che lo costituisce come un Io distinto da sé, chiamandolo “Tu”. Tu es Filius meus. La pienezza della personalità, del-la vita, consiste nel lasciarsi amare, nel ricevere la vita, nel sentirsi chiamato e costituito interlocutore filiale del Padre. L’“Ego” umano è chiamato a realizzar-si come “Tu” del Padre, in Gesù; come “Tu” desiderato e amato dal Padre; ri-cettacolo della sua Pienezza. Haec vita in Filio eius est. Il peccato originale è rifiuto di questa realizzazione filiale nell’Altro, nel Padre. Inevitabile conse-guenza di tale rifiuto è l’ansiosa ricerca di auto-realizzazione in se stesso, e nel mondo categoriale. Questa rimarrà sempre pura illusione, perché l’essere uma-no –in quanto “ens finitum capax infiniti”– non può trovare se stesso che al di là di se stesso. Il mancato auto-trascendimento filiale in Dio e fraterno nel prossi-mo significa condanna all’Alienazione e all’Idolatria sotto il dominio della concupiscenza (cfr. Ger 2,27; Rm 7,14-25). Il peccato originale è un attentato all’An-archia divina. I cristiani possono e devono interpretare anche trinitaria-mente il racconto di Gen 3. Il testo parla bene di due alberi: quello della Vita e quello della Conoscenza del bene e del male. Ma è anche vero che vi è tra i due una quasi identificazione. Già alcune tradizioni ebraiche ravvisavano in questi
37 Cfr. Concilio di Trento DS 1521, 1525, 1555. La trasmissione del peccato originale av-viene con la generazione e per propagazione (seguendo Agostino, DS 1512-1513); si rifiuta quindi il pelagianesimo con la dottrina della trasmissione per imitazione. 38 Suggestivo il pensiero di CLEMENTE ALESSANDRINO (cfr. Protrepticus XI, 111,1-3) che vede nel peccato originale la disobbedienza al Padre (parakoê Patros) da parte dell’uomo, figlio-bambino-servo di Dio (pais). Il peccato originale originato è “il No esistenziale” det-to a Dio o contro Dio dalla trascendenza personale”. Un “no” detto all’assoluta auto-donazione/ auto-comunicazione di Dio e della sua vita divina (cioè sua santità). In noi, il peccato originale è una condizione di Mancanza, di Assenza (cfr. K. RAHNER, Corso fon-damentale sulla fede. Introduzione al concetto di cristianesimo, Cinisello Balsamo 1990, 154).
C. Lorenzo Rossetti 87
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
due alberi il simbolo delle prerogative divine39. Vediamo nella distinzione-identità dei due alberi due possibilità di relazione tra l’uomo e Dio fondate su due nozioni trinitarie. L’albero della Vita, cui potevano40 mangiare l’uomo e la donna, rappresenta per noi la figliolanza. L’uomo è creato nella filialità per la figliolanza. Questa piena relazione –che troverà in Gesù il suo perfetto compi-mento– non è preclusa all’uomo. La tradizione cristiana vedrà infatti nella Cro-ce di Cristo-Figlio questo albero reso accessibile all’umanità. L’albero della conoscenza del bene e del male rappresenta invece la nozione di An-Archia, di imprincipialità, di primità assoluta propria di Dio Padre. Il grande comanda-mento di Gen 2,7, più ancora che una “prova”41, è, come ogni comando divino una Parola di amore, di verità e di vita. Esso equivale a questo: “tutto è tuo, tut-to ti è donato, tutto quanto possiedi ti è stato regalato. Godi di tutto, riconosci la tua dignità di beneficiario divino, di creatura filiale e privilegiata. Accetta la tua creaturalità e diventa figlio. Una cosa sola ti chiedo: non dimenticare che la tua verità è la filialità, la figliolanza. Non pretendere essere tu il Padre. Questo è menzogna, è falsità e schiavitù: è morte. Non attentare a ciò che è unicamente la mia prerogativa: essere senza padre, senza origine, senza principio. Se tu ri-fiutassi o dimenticassi che la Vita è in Me e che ne puoi godere veramente solo se rimani in Me, ti priveresti della vita: tu moriresti”. L’An-Archia –come inse-gnavano i padri greci– si addice soltanto a Dio Padre. Neppure il Figlio eterno è an-archico. Anzi, egli è eternamente colui che è nel seno del Padre, nel Princi-pio. Nel suo caso si potrebbe forse parlare di “En-Archia42”. Verità e vita dell’uomo è il permanere nel Padre, ricevere da Lui la vita. Peccato invece è an-archia, pretesa di autonomia, di aut-archia. Qui appare la tragicità del peccato.
39 Vedi C. GIRAUDO, Eucaristia per la Chiesa, Roma-Brescia, 1989 41ss. “L’Albero della Vita designa Dio in quanto origine fontale del soffio di vita e perciò stesso il solo immorta-le; l’altro, L’Albero della scienza del bene e del male, ancora designa Dio come il solo cui compete disporre, regolare, normare la vita che da lui procede, e ciò in forza di quella asso-luta conoscenza esperienziale che egli ha delle creature” (p. 41). Sulla Tradizione giudaica di questa interpretazione vedi p.42, n.17. 40 In questo ci scostiamo da GIRAUDO, Eucaristia, op.cit. 41, n.14. 41 Tradizionalmente il Comandamento di non mangiare dell’albero della conoscenza è con-siderato Prova di Obbedienza (cfr. AGOSTINO, Enarrationes in Psalmos, II, 70,7). Il tema è ripreso anche in CCC 396, in cui però la prospettiva è più positiva: “l’uomo non può vivere questa amicizia [con Dio] che come libera sottomissione”; l’Albero proibito “evoca simbo-licamente il limite invalicabile che l’uomo in quanto creatura, deve liberamente riconosce-re e con fiducia rispettare”. Si deve però anche ricordare che Gen 2,7 “non è un ordine, ma l’avvertimento di un destino” (P. EVDOKIMOV, La novità dello Spirito, Milano 1997, 27). 42 Secondo un’intuizione della teologia alessandrina, cfr. ATANASIO, Contra Arianos, IV,1; CIRILLO, In Ioannem, 1,1.
C. Lorenzo Rossetti 88
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
Esso non è primariamente un male morale, è un “errore ontologico43”, un man-care il bersaglio (in greco hamartia). La nudità che l’uomo scopre dopo il pec-cato, la sua morte, non è altro che l’essere entrato nella menzogna, l’essersi sra-dicato dalla Fonte vera della vita. Divenuto an-archico, l’uomo non ha altra Ar-chê che se stesso, non ha altre risorse di vita che la sua piccola e fragile vita creaturale. Da qui nasce una interna dicotomia: il desiderio di amare e il non poter amare, mirabilmente descritto da san Paolo in Rm 7. Distaccatosi dalla Fonte della Vita, l’uomo non ha la vita in se stesso; desideroso di amare, cioè di dare la vita, egli non lo può fare perché nessuno può dare ciò che non ha. L’uomo rimane profondamente filiale; l’immagine divina è sempre iscritta nel suo cuore, l’immagine del Figlio, dell’Amato che può amare. Ma questa imma-gine è deturpata, egli ha per così dire una “filialità orfana”. Se Adamo si è al-lontanato dalla Luce, i suoi figli nasceranno nelle tenebre44. Non avendo più conoscenza del Padre vero, bisognerà trovare altri padri (idoli), alla scuola del padre usurpatore, lo pseudo-padre (Gv 8,44). La storia della salvezza sarà tutta animata da un medesimo slancio di amore paterno da parte di Dio teso a scon-figgere il male e a recuperare la creatura per adottarla.
3. Elementi cristologici e pneumatologici Nell’evento Cristo, il male è svelato, combattuto e sconfitto: “La rivelazio-ne dell’amore divino in Cristo ha manifestato ad un tempo l’estensione del ma-le e la sovrabbondanza della grazia” (CCC 385).
Solo alla luce di Cristo e della sua vittoria sul male si può parlare in verità del male e solo alla sua luce lo si potrà affrontare per combatterlo veramente. Il male (l’anti-Dio, la menzogna, il peccato e la morte) trova la sua più radicale risposta, contestazione e sconfitta nel Mistero Pasquale di Gesù Cristo. Nella Morte e Risurrezione di Gesù di Nazaret appare l’abisso della paternità divina, il suo sacrificio di amore e la sua schiacciante vittoria sul male: “Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi (hyper hêmôn), chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato (parédôken) per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù, che è morto, anzi, che è risuscitato, sta alla destra di Dio e intercede per noi? Chi ci separerà dun-que dall’amore di Cristo? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori (hypernikômen) per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che
43 BULGAKOV usava già questa espressione (La sposa, op.cit. 239). 44 Vedi la bellissima pagina di san GREGORIO MAGNO, Dialogi, 4,1.
C. Lorenzo Rossetti 89
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore” (Rm 8,31-39). Riassumiamo una possibile “Cristodicea” con queste tesi che poi espliciteremo: 1. In Cristo e mediante lo Spirito, il male è svelato nella sua radicale e demo-
niaca profondità. 2. In Cristo, Dio “soffre” il male e compatisce ogni dolore umano. 3. In Cristo, il male è vinto con l’Amore che perdona ed espia il peccato. 4. In Cristo, disceso agli inferi, la salvezza è proposta a tutti i mortali. 5. In Cristo, l’umiliato risorto, la sofferenza è redenta, le opere di amore ripa-
gate e compiuta ogni giustizia. 6. Nello Spirito di Cristo il male è vinto mediante la possibilità di una vita
nuova nella speranza e nell’amore. Si ha così, insieme la più grande conso-lazione e il più grande sprone all’amore effettivo.
3.1. Denuncia
Cristo ha passato tutta la sua vita beneficando e risanando i sofferenti nel
corpo e nello spirito (cfr. At 10,38). Di fronte al dolore egli si pone come colui che lo vuole sollevare (cfr. Lc 4,1-4) e, come Giobbe, rifiuta di ascrivere il do-lore fisico ad una colpa personale, attribuendo invece come unico valore positi-vo alla sofferenza quello di sollecitare la conversione degli uomini (cfr. Lc 13,1-5) e la manifestazione delle opere di Dio (cfr. Gv 9,3). Ma Gesù non ha soltanto compatito e sollevato il dolore umano. Egli ha anche operato una Kri-sis/Martyria, un Giudizio di svelamento e di condanna del male e del peccato. Egli ne ha rilevato le più oscure e tenebrose origini. Tale missione profetica comporta l’odio e la persecuzione da parte di chi giace sotto il dominio del Principe di questo mondo (cfr. Gv 8,4; 1Gv 5,19). “Il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché di lui io attesto (martyrô) che le sue opere sono catti-ve” (Gv 7,7). “Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto in mezzo a loro opere che nessun altro mai ha fatto, non avrebbero alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre mio. Questo perché si a-dempisse la parola scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato senza ragione (dô-rean)” (Gv 15,23-25). La sorte toccata a Gesù Cristo sarà condivisa anche dai suoi discepoli una volta animati dallo Spirito di verità che convince il mondo quanto al peccato (cfr. Gv 16,8-11; 17,14)45. Essi sono chiamati a combattere il male prima di tutto denunciandolo profeticamente: “non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente (elénchete), 45 Un commento magisteriale a questo si trova in GIOVANNI PAOLO II, Dominum et vivifi-cantem, nn. 27-28.
C. Lorenzo Rossetti 90
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
poiché di quanto viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare. Tutte queste cose che vengono apertamente condannate (elenchómena) sono ri-velate dalla luce, perché tutto quello che si manifesta è luce” (Ef 5,11-13). La Chiesa diviene così coscienza critica del mondo e della società. In questo sta la sua missione martiriale e profetica46. 3.2. Compassione
Sulla croce di Gesù, Dio Padre rivela se stesso e il suo amore sconfinato per
gli uomini. Quello che Abramo non fu costretto a fare per significare il suo a-more per Dio, Lui lo ha fatto per noi, “rinunciando” a quello che aveva di più prezioso (cfr. Rm 8,32). Il Figlio nel suo annichilamento condivide ogni dereli-zione: “proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personal-mente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova” (Eb 2,18). “Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermi-tà, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato” (Eb 4,15). Si sa quanto Balthasar abbia insistito sull’amore divino che in Cristo vuole com-patire ogni dolore umano, fino a sprofondare nella solitudine più tetra (Mi-teinsamkeit–Co-solitudine)47. Gesù diventa, per amore ai peccatori, Peccato, Vittima per il Peccato, Maledizione per noi48. Nel grido straziante della Croce, preghiera del derelitto –pronunciata nella lingua materna, cioè sgorgata dal fondo del cuore (e non solo recitata come vogliono alcune esegesi)– Gesù vive il Salmo 2249. “Mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato?” (Mc 15,34). “Nessuno può essere abbandonato tanto dal Padre quanto lo può il Figlio, il quale soltanto conosce il Padre come egli è50”. Nel Figlio umiliato risplende il
46 GIOVANNI PAOLO II scrive che il martirio contribuisce a che “non si precipiti nella crisi più pericolosa che può affliggere l’uomo: la confusione del bene e del male, che rende im-possibile costruire e conservare l’ordine morale dei singoli e delle comunità…Dando piena testimonianza al bene, [i martiri] sono un vivente rimprovero a quanti trasgrediscono la legge (cfr. Sap 2,12) e fanno risuonare con permanente attualità le parole del profeta: “Guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l’amaro in dolce e il dolce in amaro” (Is 5,20)” (Veritatis splen-dor, 93,1). Cfr. S. PIÉ Y NINOT, “Martirio e vita cristiana. Prospettive teologiche attuali”, in Martirio e vita cristiana, ed. M. NARO, Caltanissetta-Roma 1997, 271-295. 47 Cfr. Teologia dei Tre giorni, Brescia 1997. 48 Cfr. 2Cor 5,21, Gal 3,13; Rm 8,3; 1Gv 2,2. 49 Cfr. C. LUBICH, Il grido, Roma 2000. 50 L’amore divino, in Cristo, vuole com-patire ogni dolore umano, fino a condividere la so-litudine più tetra (Miteinsamkeit/Co-solitudine; cfr. H.U. von BALTHASAR, Epilogo, Milano
C. Lorenzo Rossetti 91
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
cuore squarciato del Padre che dice Sì all’umanità, all’umanità peccatrice; la ama, la accetta, la perdona. Sulla Croce appare il volto radioso del Padre: l’onnipotenza che è compassione e misericordia. 3.3. Espiazione e trasfigurazione della Croce In Cristo, Dio e l’umanità vincono il male con l’Amore, perdonando ed e-spiando il peccato51. La Croce diviene il grande “convertitore”, ciò che tra-sforma il culmine dell’abominio e della maledizione (turpissima mors!), in sal-vezza e benedizione (crux gloriosa, spes unica!). Morendo per amore Cristo capovolge il significato della croce e sconvolge così il male, l’ingiustizia, la cattiveria, la crudeltà. Strumento di morte e motivo di bestemmia, la Croce di-viene luogo di amore e occasione di affidamento (cfr. Lc 23,46). Incitamento al rancore e alla vendetta, essa si trasforma in fonte di perdono e di misericordia (cfr. Lc 23,34). Segno supremo dell’Assenza del Dio benedetto, essa ne diviene il Trono regale. Il sesto giorno (lo stesso giorno in cui fu creato Adamo!) appa-re l’uomo nuovo52: Ecce Homo. Ecco il Figlio: Colui che rifiuta ogni tentazione di an-archia, ogni auto-fondazione della vita; Colui che rimane sempre nel Pa-dre, con il Padre, per il Padre; Colui che è mosso dallo Spirito eterno di amore, Spirito di verità e di dipendenza, Spirito di filiale obbedienza e fiducia, Spirito di responsabilità e di libertà. Ecco l’Albero della Vita. Ora lo Spirito può essere donato (cfr. Gv 7,39). Ora il peccato è smascherato e la verità proclamata. In Cristo morto per i peccatori si attua la grande ed unica Espiazione. Il male che causava la condanna e meritava il castigo di Dio (cfr. Is 53,7) è ora assorbito nell’atto di amore di obbedienza perfetta che lo consuma e annienta53. La tra-sfigurazione della Croce dischiude la possibilità alla redenzione dell’esperienza del dolore: “nella croce di Cristo non solo si è compiuta la redenzione mediante la sofferenza, ma anche la stessa sofferenza umana è stata redenta54”. “Cristo allo stesso tempo ha insegnato all’uomo a far del bene con la sofferenza e a far del bene a chi soffre. In questo duplice aspetto egli ha svelato fino in fondo il senso della sofferenza55”.
1995, 165). Su questo tema vedi anche le riflessioni di F.X. DURRWELL, Le Père. Dieu en son mystère, Paris 1988, 68ss e 161ss. 51 Per quanto segue rimane validissimo M. HENGEL, Crocifissione ed espiazione, Brescia 1988. 52 Come notato da sant’IRENEO, Adv. Haer. V, 23, 2. 53 Cfr. Rm 5,8; 1Pt 2,24-25; 1Gv 2,2. 54 GIOVANNI PAOLO II, Salvifici doloris, 19. 55 Ibid. 30.
C. Lorenzo Rossetti 92
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
3.4. Salvezza proposta a tutti Anche il “descensus ad inferos” ha una dimensione salvifica e di vittoria sul
male56. Al di là del suo linguaggio mitico, la nota pericope di 1Pt 3,18-19 evo-ca l’universalizzazione del valore liberatorio e pasquale della morte di Gesù. Si tratta di una applicazione/dilatazione del Vangelo ai morti: “Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito (pneúmati). E in spirito andò ad annunziare (ekêryxen) la salvezza anche agli spiriti che attende-vano in prigione”. La fede ecclesiale professa così la certezza che ogni essere umano che sperimenta la sorte comune, è proposta la partecipazione al “morire filiale” di Gesù. Come se il Cristo proclamasse che in Lui vi è la possibilità di trasfigurare quel momento ultimo che ha posto fine ad ogni vita. Il Vangelo ri-volto ai morti potrebbe enunciarsi così. “Io sono morto d’una morte filiale, d’una morte d’amore che è accolta dal Dio onnipotente. Unitevi, voi che siete morti, al mio morire che risorge!57”. In questo senso si può capire Gaudium et spes 22, per cui la possibilità di partecipare alla risurrezione di Gesù: “non vale solamente per i cristiani ma anche per tutti gli uomini di buona volontà, nel cui cuore lavora invisibilmente la grazia. Cristo, infatti, è morto per tutti e la voca-zione ultima dell’uomo è effettivamente una sola, quella divina, perciò dob-biamo ritenere che lo Spirito santo dia a tutti la possibilità di venire a contatto, nel modo che Dio conosce, col mistero pasquale”. 3.5. Risurrezione e Giustizia
La Risurrezione in quanto (ri)generazione è la proclamazione della verità
compiuta sulla Croce: “Questi era mio Figlio. Egli è la Verità. Non v’è altra ve-rità/eternità che questo amore di Figlio. Lui è la vita eterna. La vita eterna è in lui. Questo uomo è l’unica realtà degna del cielo. L’eternità appartiene agli uo-mini come lui, che possiedono il suo Spirito, che si lasciano guidare dallo Spiri-to di figliolanza”. Se la Passione di Cristo era assimilabile alle “doglie del par-
56 Su questo punto del Credo, cfr. G. ANCONA, Disceso agli inferi. Storia e interpretazione di un articolo di fede, Roma 1999. 57 Ci ispiriamo liberamente alle intuizioni di F.X. DURRWELL, Regards chrétiens sur l’au-delà, Paris 1994: La morte di Gesù è beata perché dà luogo alla generazione da parte del Padre (At 13,33). Cristo “espia” con la sua santità, con la sua compassione muore di “una morte infinita, nella quale tutti gli uomini potranno morire con lui” (55). La sua morte svela il senso della morte: essere generato, accolto dal Padre. Gesù diviene così mediatore di una morte filiale: “Gesù prendimi in te, nel tuo morire verso il Padre!” (57). Il con-morire è an-ticipato nel battesimo (Rm 6; 2Tm 2,11).
C. Lorenzo Rossetti 93
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
to”, la sua Resurrezione è il suo lasciarsi generare da Dio in gloria e potenza (cfr. Rm 1,4), cioè nello Spirito Santo, il suo essere portato (assumptus) nel se-no del Padre58. La Risurrezione è la redenzione operata in Gesù. In essa, l’amore crocefisso con il quale egli ha vinto la morte del peccato ottiene la di-chiarazione divina di verità e di eterna fecondità. E nel Cristo glorioso ogni sof-ferenza è racchiusa e redenta59. La Redenzione in Cristo come adozione filiale e liberazione dal male –già pre-figurata dall’Elezione filiale d’Israele liberato dalla Schiavitù (cfr. Es 4,22-23)– è il compimento della Creazione come prima “liberazione” dal Nulla (cfr. Rm 4,17), e definitiva esperienza di Adozione filiale come attiva accoglienza dell’incondizionato Amore del Padre. Credere nell’esaltazione a Kyrios dell’uomo dei dolori significa anche accogliere la sanzione data da Dio alla sof-ferenza innocente e amante. Nel Cristo glorioso ogni dolore umano troverà re-denzione e ogni azione d’amore sarà ripagata (cfr. Mt 25,32ss). Il Cristo escatologico sarà la Giustizia del Padre. In lui, Dio giudicherà in quan-to uomo: A lui è stato dato ogni giudizio perché è Figlio dell’uomo (cfr. Gv 5,27). Dio ha voluto che fosse l’uomo a giudicare l’uomo. Non è affatto bla-sfemo immaginare le perplessità dell’umanità confrontata al giudizio divino: “Chi sei tu per giudicare la nostra debolezza dall’alto della tua onnipotenza? Come potresti tu, l’Irraggiungibile, l’Impassibile giudicare e forse anche perdo-nare coloro che hanno provocato tante e così grandi sofferenze a noi, povere creature vulnerabili?”. Possiamo dire che il Padre, il Dio rivelato in Gesù, non ricusa di confrontarsi con questa umanissima obiezione. Anzi egli l’ha accetta-ta. Non sarà Lui a giudicare il genere umano; anche se ne avrebbe ovviamente il diritto. La giustizia divina si piega all’esigenza di giustizia iscritta nel cuore dell’uomo. Può perdonare veramente solo colui che ha subito il torto60. La mi-sericordia ha sempre la meglio nel giudizio. E anche Dio vuole avere la meglio. Per questo egli giudicherà nella sua umanità, ferita, oltraggiata e martoriata: in Gesù. Il Padre accetta di non giudicare dall’alto della sua autorità, ma concede al Figlio, in quanto uomo di giudicare dall’abisso della sua umiliazione. Se per-dono sarà dato, esso salirà dal fondo del dolore patito. Lui lo potrà dare perché è stato “uomo dei dolori che ben conosce il patire” (Is 53,3), in cui ogni vittima è compresa. Ogni dolore umano, lui lo ha sperimentato61.
58 Cfr. DURRWELL, Le Père, op. cit. 27-29: la Pasqua di Gesù (come risurrezione-generatrice) è manifestazione dell’amore paterno di Dio espresso in questo versetto del Salmo 2: “Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato” (At 13,33). 59 Ancora GIOVANNI PAOLO II, Dominum et vivificantem, 40,4. 60 Così anche E. BIANCHI, I paradossi della croce, Brescia 1999, 56. 61 GIOVANNI PAOLO II sostiene con arditezza che in Cristo umiliato e crocefisso “Dio…desidera per così dire, giustificarsi davanti alla storia dell’uomo” e la verità del suo
C. Lorenzo Rossetti 94
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
3.6. Vita nuova nello Spirito
3.6.1. Morte al peccato In Cristo e nello Spirito, il male è sconfitto nella possibilità concessa nella gra-zia di vincere il peccato e di affrontare l’esistenza con speranza e amore. La re-denzione operata da Cristo non solo rivela il perdono e l’amore di Dio per l’uomo, ma provoca anche, mediante l’opera dello Spirito, l’interiore rinnova-mento della persona. Si passa così dalla condanna del peccato (“non posse non peccare”, la schiavitù alla paura della morte e all’egoismo, cfr. Eb 2,15), alla libertà della vita nuova nella giustizia (“posse non peccare”, cfr. Rm 6,6-7)62. In termini paolini si tratta di “morire al peccato”; in termini giovannei, di “esse-re generati da Dio” così da “non peccare più” (1Gv 3,3-10). Nell’orizzonte di questa esistenza nuova, lo Spirito di fede infonde due atteggiamenti inseparabi-li: la Speranza e l’Amore. Questi sono la pratica conseguenza dalla coscienza che nel sofferente è presente Cristo, il Figlio di Dio, Dio stesso (cfr. Mt 25, 40). 3.6.2. Speranza escatologica: l’associazione dei sofferenti alla gloria del Cri-
sto La risposta cristiana al male offre nella rivelazione escatologica del Cristo giudice una stupefacente risposta. In ogni sofferente è presente Cristo. Essi so-no i suoi fratelli più piccoli, gli saranno associati nel Giudizio. Gli saranno uniti nella gloria così come gli furono vicino nella sofferenza. Questa è l’unica e più vera e profonda consolazione per ogni sofferenza innocente. Senza questa spe-ranza, radicata in Gesù risorto, che è “in agonia fino alla fine del mondo63”, la vita dopo la prima tortura della storia, dopo le prime lacrime versate da un bambino indifeso sarebbe un Assurdo, al quale bisognerebbe veramente rifiuta-re “il biglietto d’ingresso64”. Questo annuncio così chiaro nella rivelazione bi-blica, della potenza risanante e consolante di Dio (si pensi in particolare al terzo vangelo, ma anche all’Apocalisse65) deve essere proclamato, con buona pace della mentalità immanentista e materialistica. Esso è un elemento imprescindi-
essere Amore non è una “verità sospesa nel vuoto” (Varcare la soglia della speranza, op. cit. 68). 62 Le espressioni latine sono di AGOSTINO, De Civitate Dei 22,30,4. 63 B. PASCAL, Il mistero di Gesù, v.8, cfr. D. LEDUC-FAYETTE, Pascal et le mystère du mal, Paris 1996, pp. 261ss; 273ss. 64 F.N. DOSTOIEVSKI, I fratelli Karamazov, V, iv, Milano 1995, 315. 65 Cfr. Lc 6,20ss; 16,19-31; Ap 21,1ss.
C. Lorenzo Rossetti 95
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
bile della risposta cristiana al problema del male. Verrà infatti il giorno in cui Dio tergerà ogni lacrima e non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né af-fanno (cfr. Ap 21,4). Questa consolante realtà escatologica –anima della spe-ranza cristiana, anticipata nella vita nuova di fede e di amore, stimola la respon-sabilizzante missione66. Non si può infatti menzionare questo dato di consola-zione e di speranza senza ribadire simultaneamente e con altrettanto vigore l’ultimo e più concreto elemento della risposta cristiana all’enigma del male: la speranza teologale di partecipare alla risurrezione di Gesù permette di superare ogni tribolazione e sofferenza mondana (cfr. Rm 5,3-5; 8,18; Ap 21,4) ispirando nel pari tempo la più forte motivazione alla effettiva carità e solidarietà su que-sta terra.
3.6.3. Amore: Soccorrere il misero come dovere verso Dio Mt 25 non solo esprime la Giustizia e la Speranza, esso propone ugualmen-te l’elemento determinante della positiva lotta contro il male e il dolore67: l’Amore. Dal momento dell’incarnazione del Figlio, il Padre vede in ogni uo-mo, specie nel più umiliato, un’immagine vivente del suo Unigenito; pertanto, amare e soccorrere i bisognosi diventa un’esigenza dell’amore verso Dio. Non soccorrere uno di “questi piccoli” equivale a bestemmiare, ad apostatare, a non riconoscere il Figlio venuto nella carne. Equivale ad essere anti-Cristo (cfr. 2Gv 1,7). Cosicché la medesima risposta che riempiva di consolazione, impedisce di rimanere inattivi di fronte al dolore. Questo elemento della fede cristiana è il più grande sprone che ci sia per la solidarietà e la lotta, anche sociale, contro il male e l’ingiustizia. Gli esempi storici sono costanti ed innumerevoli: dai primi Mercedari che si vendevano come schiavi per riscattare i prigionieri a san Gio-vanni di Dio e Camillo de Lellis che trattavano i malati come loro signori, a Padre Pio e Madre Teresa di Calcutta che spesero la vita lottando quotidiana-mente contro il male in ogni sua forma. Essi sono le più limpide testimonianze della concreta forza operatrice che la risposta cattolica al male può immettere nella prassi.
66 Andrebbero qui richiamati i bei brani della Gaudium et spes in cui si ribadisce che l’attesa del Regno eterno lungi dal diminuire lo zelo per le faccende di questa terra lo rin-forza (cfr. GS 39,3; 43,1; 57,1). 67 Da più parti si è rilevato che di fronte all’enigma del male ancor più decisiva della teorica questione della sua origine è la proposta di efficaci atteggiamenti che lo possano combatte-re, cfr. p.e. P. RICOEUR, Il male, Brescia 1993, 48-50, V. POSSENTI, Dio e il male, Milano 1996, 57-61.
C. Lorenzo Rossetti 96
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
4. Ricapitolazione: la pienezza “catholica” delle Beatitudini Crediamo che dallo studio condotto possa affiorare oltre una teodicea e una cristodicea, una “ecclesiodicea”, ovvero una singolare manifestazione della “cattolicità” della Chiesa nel significato qualitativo di pienezza di verità e di dottrina68 e derivatamente la conferma della necessità della sua missione per il bene dell’umanità. Infatti, la risposta “cattolica”, cioè universale e piena, pro-posta dalla Chiesa all’enigma del male compendiata nelle Beatitudini (cfr. Mt 5,3-11) consente di trattenere in vitale e paradossale unità le particulae veri racchiuse nei vari tentativi umani e religiosi non cristiani menzionati all’inizio (cfr. 1), eludendo invece ciò che in essi è inaccettabile. Come i seguaci delle grandi religioni, anche il cristiano reagisce di fronte al male innanzi tutto con timor di Dio (cfr. 1.1; 2.2.1) e con umile pazienza (“bea-ti i miti”), ma senza la tristezza della rassegnazione; anzi con una “gioia indici-bile e gloriosa” fondata nella certa speranza della risurrezione (cfr. 3.5; 3.6.3). In modo analogo a talune esigenze avvertite dal pensiero dualista (cfr. 1.2; 2.3), il cristiano denuncia francamente e coraggiosamente l’esistenza e l’azione del demoniaco come male antagonista “irriducibile” (cfr. 3.1), ma senza inficiare la confessione nell’unicità di Dio quale Principio buono e Fine provvidente di o-gni cosa (cfr. 2.1.1-3) e con la certezza che il “nemico” è sin d’ora sconfitto e che alla fine sarà definitivamente “gettato fuori” dall’unico Signore della storia (cfr. 3.3; 3.6.2). Dell’uomo moderno, scandalizzato dal male giudicato inaccettabile (cfr. 1.3), il cristiano condivide la giusta indignazione (“beati gli afflitti”) di fronte alla tra-gicità di ogni singola sofferenza (cfr. 2.2.2), ma senza l’insana (e vana) rivolta atesitica; al contrario, vedendo il proprio Signore partecipe e presente in qualsi-voglia dolore, dovrà fare di tutto per alleviarlo con operosa carità (cfr. 3.1; 3.6.3). Anche il cristiano non può lasciare l’ultima parola al male (cfr. 1.4), perché confessa la vittoria finale del progetto divino (eudokia) già riportata in Cristo (cfr. 3.6.2); ma, sapendo che essa deve essere completata in se stesso e nella 68 Così come lo esprimeva CIRILLO DI GERUSALEMME: “La Chiesa è chiamata cattolica per-ché è sparsa attraverso il mondo, da un capo all’altro della terra, anche perché insegna uni-versalmente e completamente tutte le dottrine (dià tò didáskein katholikôs kaì aneleipôs hápanta) che l’uomo dovrebbe conoscere circa le realtà visibili e invisibili, celesti e terre-stri; ed anche perché sottomette alla vera adorazione tutta l’umanità, governanti e sudditi, dotti e ignoranti; inoltre perché cura e guarisce in modo universale (dià tò katholikôs iatre-úein mèn kaì therapeúein) ogni sorta di peccato commesso con l’anima o con il corpo, e possiede in se stessa ogni possibile virtù, tanto in opere, quanto in parole o in doni spirituali di ogni tipo” (Catecheses, XVIII, 23).
C. Lorenzo Rossetti 97
Il Credo della Chiesa e l’enigma del male
storia, egli non si permetterà mai di sdrammatizzare il male, né potrà abbassare la guardia (cfr. 2.1.3; 3.6.1). Sottomissione e responsabilità, fiducia e vigilanza, accettazione e indignazione, affidamento e combattività, timore e gioia, denuncia e perdono… sono altret-tante attitudini paradossalmente contrastanti ma naturalmente coesistenti nell’ethos della fede cattolica confrontata al male. Questo è possibile non per un’elaborazione intellettuale, ma sgorga dall’accoglienza dell’indeducibile rive-lazione della paternità amante del Dio Santo pienamente svelata nella Pasqua di Gesù (cfr. 2.1; 3.2-5). Uniti a Lui, nel suo Spirito, possiamo e quindi dobbiamo fattivamente lottare contro il male (“beati gli affamati di giustizia, i misericor-diosi, gli operatori di pace”), con salda fiducia nella grazia e nella provvidenza (“beati i poveri in spirito”). Conformati al Figlio mediante lo Spirito, fatti por-tatori di misericordia, di giustizia e di pace, alleati dell’unico Padre buono, lo preghiamo e con lui cooperiamo per la definitiva liberazione dal male. Dimora della pienezza dello Spirito Paraclito e custode di ogni grazia e di ogni mezzo di salvezza69, la comunità ecclesiale dispone del più vigoroso rimedio contro il male. La “Paráklêsis” (cfr. 2Cor 1,3): la consolazione-conforto-incoraggiamento che essa può offrire all’umanità per fronteggiare la drammati-ca questione del male è del tutto singolare e costituisce il soccorso più completo di cui gli uomini possano avvalersi su questa terra. Si tratta di una pienezza di grazia affidata dal Signore alla Chiesa, che ne segnala la “cattolicità” e la so-spinge alla missione, giacché non si può non comunicare un tesoro così prezio-so e benefico.
69 Cfr. IRENEO, Adv. Haer. III, 24: “ubi Ecclesia ibi et Spiritus Dei, ubi Spiritus Dei ibi Ec-clesia et omnis gratia”; cfr. anche Lumen gentium 8 e Unitatis redintegratio 3.
C. Lorenzo Rossetti 98