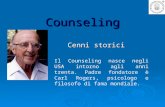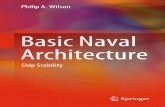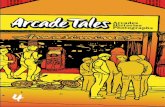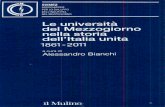BOLLES+WILSON: Tacuit et fecit. Il progetto realizzato come teoria/Tacuit et fecit. Built design as...
Transcript of BOLLES+WILSON: Tacuit et fecit. Il progetto realizzato come teoria/Tacuit et fecit. Built design as...
arianuova
Collana diretta daAntonio Carbone
TraduzioniAntonella Bergamin
StampaCentro Grafico Srl - Foggia
Prima Edizione giugno 2014
CopyrightCasa editrice LibriaMelfi (Italia)Tel/fax +39 (0)972 [email protected]
ISBN 978 88 6764 036 2
BOLLES+WILSONTACUIT ET FECIT
SOMMARIO
Tacuit et Fecit.Il progetto realizzato come teoria 7 Patrizio M. Martinelli
Tacuit et Fecit.Built design as theory 13Patrizio M. Martinelli
PROGETTI 19
Indice dei progetti | Index of projects 132
Note biografiche | Biographical notes 136
7
Tacuit et fecit. Il progetto realizzato come teoria Patrizio M. Martinelli
Quando mi trovo ad affrontare, come in questa particolare occasione, il per-corso architettonico e l’opera progettuale di Bolles+Wilson, mi torna sempre alla memoria quell’atteggiamento nei confronti dell’architettura per il quale il rapporto tra l’elaborazione di una teoria dell’architettura e il progetto può in qualche modo rivelarsi rovesciato, per cui l’ambito della speculazione teorica si mostra e si sostanzia con la ricerca progettuale, vero e proprio testo che dimostra gli esiti di un’idea e di un metodo.Analogamente, possiamo dire che, in parallelo con l’attività critico-teorica e a quella della divulgazione scientifica (molto più preminente nei primi anni della loro carriera, ma ancora recentemente svolta da Wilson nelle collabo-razioni soprattutto con la rivista “AA files” e con “El Croquis”), sia l’opera progettata e realizzata di Bolles+Wilson a costruire, in qualche modo, una teoria del progetto. Il fare, oltre e forse più che le parole: tacuit et fecit, come nella dedica che T.S. Eliot fa al padre in apertura del Bosco sacro1.Ogni incarico professionale diventa per i due architetti l’occasione per proget-tare una teoria attraverso il concreto e sapiente costruire, per affrontare il tema dell’incarico (dal piccolo oggetto di design al masterplan) come possibi-lità di una ricerca sui contenuti, basata quindi non tanto sull’astrazione di dottrine e dogmi, quanto sulla realtà della costruzione architettonica, parten-do dalle domande sul cosa? e sul come?, per giungere ad un’opera collettiva e civile che assommi in sé il bello e l’utile, che tenga assieme le polarità di arte
1 T.S. Eliot, Il bosco sacro. Saggi sulla poesia e la critica, Bompiani, Milano 2003.
8
e tecnica, architettura ed ingegneria, pensiero e prassi, in un reciproco e fecondo trasformarsi.Ma questo succede attraverso un metodo che affronta “caso per caso” (direbbe Ernesto Nathan Rogers) in maniera non dogmatica il tema d’archi-tettura: non c’è un archivio di soluzioni consolidate cui attingere, non ci sono soluzioni preconfezionate da adattare al contesto di riferimento, non c’è l’applicazione di un modello, l’utilizzo di un outil, come nemmeno la ci-tazione, né letterale e neppure trasfigurata. Tornano così alla mente le parole del sociologo francese Edgar Morin: “La teoria è aperta all’universo del quale rende conto: da esso estrae conferme e se sorgono dati che la contraddicono, procede a verifiche e revisioni (…). Una teoria che si chiude di fronte al reale si converte in dottrina. La dottrina è la teoria che afferma che la sua verità è definitivamente provata, e rifiuta tutte le smentite della realtà. La dottrina-cittadella blinda i suoi assiomi che si convertono così in dogmi”2.Questa non fissità della teoria (sia come pura speculazione, e in maggior grado quando verificata nel progetto), sempre pronta a mettersi in discussio-ne, mi ricorda anche l’immagine del meandro che Le Corbusier evoca per descrivere l’agire del pensiero e dell’opera dell’uomo: esso rappresenta l’idea che si muove, abbandonando il percorso lineare e razionale, e si confronta con ostacoli, variazioni, difficoltà, circostanze trovando “soluzioni apparente-mente miracolose che improvvisamente risolvono situazioni inestricabili”3. Ma sottintende anche la contrapposizione fra ragione ed emozione, fra azio-ne meditata ed istinto, fra esprit de géométrie ed esprit de finesse, categorie tutte della vita da una parte, ma fondanti il progetto dall’altra.In questo senso ogni progetto di Bolles+Wilson diventa esemplare e unico, espressione di una libertà e di una vivacità di soluzioni che esprimono l’essenza
2 E. Morin, Per uscire dal ventesimo secolo, Lubrina LEB, Bergamo 1989, p. 69.3 Le Corbusier, Precisazioni sullo stato attuale dell’architettura e dell’urbanistica, a cura di F. Ten tori, Laterza, Bari-Roma 1979, p. 15.
9
di una ricerca unitaria pur nelle sue sfaccettate realizzazioni, che si svincola dalle rigidezze di qualsiasi apparato teorico, dal riferimento formalista alla storia, dall’appartenenza a qualsivoglia filone o -ismo, ma recupera il momen-to gioioso e vitale della creazione architettonica, che proprio dalla necessità di costruire, con appropriatezza, il luogo di espressione dell’operare umano, intimo e privato, civile e pubblico, trova la sua ragione essenziale. Qui sta, a mio parere, la autentica e non algida razionalità (e torno a Morin) nella loro opera: “La vera razionalità, aperta per natura, dialoga con un reale che le resiste. Fa incessantemente la spola fra istanza logica e istanza empirica: è il frutto del dibattito argomentato delle idee, e non già la proprietà di un siste-ma di idee. Un razionalismo che ignora gli esseri, la soggettività, l’affettività, la vita, è irrazionale”4.Queste modalità di confronto con il progetto pongono, a mio parere, Bolles+Wilson su un piano molto diverso, quasi unico, rispetto alla scena ar-chitettonica internazionale e in particolare a quella nazionale tedesca. La cifra stilistica che li contraddistingue è esito certamente della loro formazione (en-trambi completano gli studi presso l’Architectural Association di Londra, col-laborando con Koolhaas e Zenghelis), della vicinanza non solo geografica di Münster, città del nord della Germania dove lo studio ha sede dai primi anni Novanta, con la cultura architettonica contemporanea olandese, e non da ultimo della stessa osmotica contaminazione culturale e caratteriale di Julia e Peter, in uno scambio dialettico (in cui talora le parti si invertono e si fondono) che confluisce nell’opera realizzata: la razionalità elegante e pragmatica, la competenza e il rigore tecnico/costruttivo, l’attenzione per l’appropriatezza e l’efficienza a tutti i livelli e le scale del progetto, tipica di Julia Bolles (docente e per alcuni anni dean della Münster School of Architecture, ateneo che proprio su queste tematiche ha costruito il proprio carattere d’eccellenza in ambito europeo); la meditata creatività, l’immaginazione che diventa (pre)visione
4 E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milano 2011, p. 22.
10
progettuale attraverso lo schizzo, l’attenzione sapiente del costruttore per gli aspetti compositivi, spaziali e materici di Peter Wilson.Ma pur nella diversità degli esiti progettuali, la “firma” dello studio di Münster è riconoscibile sempre, testimoniata in ogni fase del progetto, dal primo dise-gno ideativo fino alla sua realizzazione.Come ben documenta la raccolta di progetti presente in questo libro, le scale del progetto e i temi che lo studio di Bolles+Wilson affronta sono i più vari, dalla residenza unifamiliare e collettiva, alla torre, all’edificio pubblico, fino a veri e propri interventi alla scala del masterplan (fra i più recenti, in corso di realizzazione proprio in Italia, l’intervento per Monteluce a Perugia). Ma tutti hanno a che fare con la “casa”: la casa dell’uomo, il luogo del lavoro (“uffi-cio” è Bürohaus, in tedesco), l’aula dell’istituzione, la biblioteca, il teatro, la piazza (come “stanza urbana”) sono tutte declinazioni del domestico, come lo stesso Wilson afferma, in un pensiero mediato dalla lettura della Poetica dello spazio di Bachelard, per il quale “la casa è il contenitore e catalizzatore della memoria, della poetica. Egli procede per accumulazione: una molteplici-tà di strati, memorie private e collettive, soffitte stracolme, cantine fradice”5. Di qui l’interno, come generatore dello spazio: la pianta (generatrice, ci inse-gna Le Corbusier), non solo come astratto tracciato fondativo dell’architettu-ra, ma come primo gesto nella costruzione di luoghi scolpiti in sequenze spaziali studiate in ogni aspetto (materiale, textures, colore, dettaglio…), in composizioni stratigrafiche a definire una “interiorità quasi loosiana e una parallela esplorazione verticale dello spazio fisico e psicologico-emotivo”6, recintata da margini che diventano facciate esterne (i prospetti) ed interne (nel lavoro in sezione) in cui predomina il pieno murario, piuttosto che il vuoto trasparente del cristallo, in cui le visuali verso l’esterno, fondamentali,
5 P. Wilson, “Sometimes Bachelard”, in Poetics in Architecture, numero monografico di “Architectural Design”, vol. LXXII, n. 2, 2002, pp. 15-18 (traduzione italiana “Talvolta Bachelard”, in A.Germano (a cura di), Bolles+Wilson. Opere e progetti, Electa, Milano 2004, p. 305).6 Ibidem.
11
non sono totalizzanti come i diaframmi vitrei consentono, ma selezionate con accuratezza in punti di vista privilegiati, e con un controllo preciso della luce, verso la qualità del vivere, il piacere dell’abitare. E questo piacere di fare architettura per il piacere di vivere l’architettura e la città lo riconosciamo sempre, nell’opera di Bolles+Wilson, attraverso il valore rappresentativo del disegno, a partire dal momento ideativo. In tutte le fasi che vanno dai piccoli schizzi acquerellati, quasi sempre pre-visioni prospettiche dei progetti, con grande attenzione per gli interni o per le “scenografie urbane” che l’intervento dell’architetto anticipa col disegno, fino agli elaborati tecnici in cui alla fredda restituzione grafica del disegno automatico si sovrappone l’intervento materico, cromatico, quasi pittorico della mano dell’uomo, riconosciamo il piacere quasi sensuale dell’architetto che disegna, che pone su carta il pensiero per fissare l’idea, verificarla e, alla fine del percorso, comunicarla. Di tali percorsi e narrazioni grafiche, in questo volume troviamo una versione anche inedita, rispetto allo stile che li contrad-distingue, fortemente dominato dalla carica coloristica che spesso riconoscia-mo nella stessa opera costruita: nelle pagine a seguire il disegno al tratto in bianco e nero e l’assenza del colore non fanno che confermare la forza dei loro progetti, esaltandone la forte carica compositiva, la precisione rigorosa ma mai rigida della geometria e la generosa eleganza delle soluzioni.Questo trasmette l’opera di Bolles+Wilson, anche attraverso le architetture qui raccolte, a noi tutti ma anche e soprattutto alle giovani generazioni che si stanno formando (come è noto, oltre che architetti della pratica operativa, Julia Bolles e Peter Wilson sono legati alla scuola, all’insegnamento): che il progetto va affrontato liberi da condizionamenti, dottrine e dogmi, partendo dal tema, dal luogo, dal dato materiale e spaziale alla scala (domestica) dell’uomo, per arrivare ad una architettura corretta, precisa, sapiente attra-verso il piacere del progetto, per il piacere di abitare la casa, la città, il mondo.
13
Tacuit et fecit. Built design as theory Patrizio M. Martinelli
Whenever I am asked, like in this particular occasion, to write about Bolles+Wilson’s architectural trajectory and design work, I tend to think about a way of practicing architecture that somehow turns the relationship between the development of architectural theory and design on its head and uses design research to reveal and substantiate theoretical speculation, like an actual text that demonstrates the results of an idea and a method.This certainly applies to the way Bolles+Wilson’s design theory has somehow emerged from their designs and built works even more than from their critical-theoretical and journalistic activity (much more relevant at the beginning of their career and recently still practiced by Wilson who writes for “AA Files” and “El Croquis”). Their production seems to count even more than their words: Tacuit et fecit [literally, “He has been silent and he has performed”], to quote the Latin phrase T.S. Eliot used as a dedication to his father in The Sacred Wood1.Every professional commission is an opportunity for the two architects to design a theory through a solid and skilful art of building, to approach its program (from the small design object to the master plan) as a chance to research its contents, based on the reality of architectural construction rather than on the abstraction of doctrines and dogmas, and on questions like what? and how?, to produce a collective and civil work that combines both beautiful and useful elements, art and technique, architecture and engineering, thought and practice, in a mutual and fruitful transformation.
1 T.S. Eliot, Il bosco sacro. Saggi sulla poesia e la critica, Bompiani, Milan 2003.
14
But no archive of established solutions to be used as reference, no ready-made solutions to be adapted to specific contexts, no models or tools, not even literal or transfigured quotations support this method that undogmatically approaches architecture on a “case by case basis” (to quote Ernesto Nathan Rogers’ words).As the French sociologist Edgar Morin has insightfully explained: “Theory is open to the universe it describes: it derives validation from it and whenever it receives contradictory information, it reviews and cross-checks its findings (...). When a theory shuts itself out from reality, it becomes a doctrine. A doctrine is a theory for which its own truth is proved once and for all, and refuses any confutation coming from reality. The axioms of this fortified doctrine are irrefutable and therefore become dogmas”2.The flexibility of a theory (both as pure speculation and even more when confirmed by design) that is always ready to question itself also reminds me of the image of the meander evoked by Le Corbusier to describe how the mind works and deals with problems: it represents the idea that moves away from linear and rational development to confront obstacles, variations, difficulties, circumstances, to find “apparently miraculous solutions that suddenly resolve apparently inextricable situations”3. But it also underlies the conflict between reason and feeling, meditated action and instinct, esprit de géométrie and esprit de finesse, as concepts that are both totally part of life and the foundations of design.In this sense, all of Bolles+Wilson’s designs are exemplary and unique, and as such express free and dynamic solutions that reflect the essence of a research that is both coherent and capable of diversified solutions. Unconstrained by theoretical structures, a formalist fealty to history, or an allegiance to any genre or -ism whatsoever, such research rediscovers the joyful and vital
2 E. Morin, Per uscire dal ventesimo secolo, Lubrina LEB, Bergamo 1989, p. 69.3 Le Corbusier, Precisazioni sullo stato attuale dell’architettura e dell’urbanistica, F. Tentori (ed.), Laterza, Bari-Rome 1979, p. 15.
15
impulse of architectural creation as mainly founded on the pure urge to create an appropriate place for human life, for its intimate and private, or civil and public expressions. I will turn once more to Edgar Morin to define the true and all but cold rationality of their work: “True rationality is by nature open and engaged in dialogue with the real, which resists it. It constantly goes back and forth between the logical instance and the empirical instance; it is the fruit of debate of ideas, and not the property of a system of ideas. Rationalism that ignores subjectivity, affectivity, life, and beings, is irrational”4.I think Bolles+Wilson’s approach to design puts them in a rather special, almost unique place in the context of the international and even more of the German architectural scene. What makes them different in terms of style is certainly the result of their training (both completed their studies at London’s Architectural Association, and worked with Koolhaas and Zenghelis), of the not merely geographical proximity of Münster, the city in northern Germany where they established their practice in the early Nineties, to the Dutch contemporary architectural culture, and, last but not least, of their cultural and personal closeness, and their way of dialectically trading roles when they shape their designs – Julia Bolles with her elegant and pragmatic rationality, her technical/constructional skill and stringency, her focus on adequacy and efficiency through every level and scale of design (precisely the qualities that have made the Münster School of Architecture, where Julia has taught and served as dean for a few years, a school of European standing); and Peter Wilson with his meditated creativity and imagination that comes through as design vision and pre-view in his sketches, and his skilful approach to compositional, spatial and textural aspects.Yet, in spite of the diversity of their designs, the “signature” of the Münster-based practice is always recognizable in every phase of design, since the very first concept sketch through the completed work.
4 E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, Milan 2011, p. 22.
16
As the selection of designs in this book clearly shows, Bolles+Wilson tackle extremely diverse scales of design and programs, from one-family and collective housing to towers, public buildings, and master plans (including, most recently, the Monteluce master plan now under construction in Perugia, Italy). What all these works have in common is the concept of “house”: whether they are actual houses or workplaces (the German word for “office” is Bürohaus), institutional headquarters, libraries, theatres, squares (as “urban rooms”), they are all declinations of the domestic space, as Wilson himself says, in his meditation about the Poetics of Space by Gaston Bachelard who describes the house as “the container and the catalyst of memory, of poetics. He proceeds by accumulation: a multiplicity of layers, individual and collective memories, crammed garrets, sodden cellars”5. This is the source of the interior as generator of space, and of the plan (itself a generator of space as defined by Le Corbusier) as the first step in the construction of places rather than an abstract foundational trace. Such places become spatial sequences that, studied in every aspect (of material, texture, color, detail, ...) in layered compositions, define an “almost Loosian inwardness and a parallel vertical exploration of physical and psychological-emotional space”6, framed by images that become façades and interior elevations (in section) where solid walls prevail over the transparent void of crystal, and the fundamental views to the outside are not as open as the glass diaphragms would allow but carefully restricted to privileged points of view, with a precise control of light aimed at providing a comfortable space, and the pleasure of living.The pleasure Bolles+Wilson take in creating architecture for the pleasure of living architecture and the city is always recognizable in their work and made apparent by the representative value of design, starting with the concept phase.
5 P. Wilson, “Sometimes Bachelard”, in Poetics in Architecture, “Architectural Design”, monographic issue, vol. LXXII, n. 2, 2002, pp. 15-18 (Italian translation “Talvolta Bachelard”, in A. Germano (ed.), Bolles+Wilson. Opere e progetti, Electa, Milan 2004, p. 305).6 Ibidem.
17
In every step, from the small watercolor sketches, very often perspective pre-views with carefully detailed interiors or “urban scenes”, all the way through the graphically cold CAD shop drawings enlivened by a textured, colored, almost painterly touch, we recognize the almost sensual pleasure these architects take in drawing, and in projecting their thought on paper to crystallize, review and finally communicate it. This book also shines a new light on their developments and graphical narrations, known for the powerful coloristic charge that is their signature style, often recognizable in the same design’s built version. The absence of color and the black and white line drawings in the following pages only confirm the power of their designs, and highlight their robust compositional charge, their precise but never rigid geometry and their generously elegant solutions.What this selection of Bolles+Wilson’s works conveys to us all but especially to the younger generations, the architects of the future (Julia Bolles and Peter Wilson’s commitment to teaching alongside their professional practice is well known), is that design should be unburdened by constraints, doctrines or dogmas. It should be only guided by program, place, material and space at the (domestic) scale of man to achieve a correct, precise, articulate architecture and, through the pleasure of design, the pleasure of living the house, the city, the world.