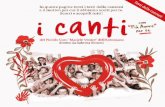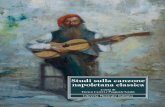Donatello’s Bust of Youth and the Ficino Canon of Proportions
Bernardo Tasso, Ficino, l'Evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla "Canzone all’Anima"...
Transcript of Bernardo Tasso, Ficino, l'Evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla "Canzone all’Anima"...
BERNARDO TASSO, FICINO, L’EVANGELISMO.RIFLESSIONI E MATERIALI
ATTORNO ALLA CANZONE ALL’ANIMA (1535-1560)
GIOVANNI FERRONI
1. La questione delle idee religiose di Bernardo Tasso e i documenti riguar-danti i suoi rapporti con l’evangelismo italiano sono stati ripresi da una serie diarticoli recenti1 che hanno riletto con maggiore attenzione alcune testimonian-ze, per lo più note ma poco o male utilizzate, relative alle opinioni del poeta erisalenti al periodo fra gli anni Trenta e gli anni Sessanta del Cinquecento.
Tali contributi affermando in maniera più o meno sicura l’influenza de-gli ambienti del rinnovamento religioso o, più specificamente, del circolo val-desiano di Napoli2 sul Tasso e rompendo quindi con la tradizione critica pre-cedente che aveva difeso l’ortodossia cattolica del poeta3, faticano però a dareprecisamente conto della sua posizione in quel lasso di tempo: questo nontanto a motivo della sua sfuggente personalità o di un suo ipotetico nicode-mismo4, ma soprattutto a causa della natura dei documenti disponibili, delmodo con cui essi sono stati selezionati e, non ultimo, della tesi alla cui di-mostrazione essi sono stati resi funzionali.
Il dossier è composto, stando ai lavori citati, da materiale scarso e diso-mogeneo: i pochissimi pezzi dell’epistolario in cui la fede del Tasso è chiama-ta direttamente o indirettamente in causa5, qualche verbale d’interrogatorio6e qualche lettera o scritto occasionale di altro autore7. Il tracciato biografico-spirituale del Tasso ne risulta così illuminato in modo discontinuo e più de-bolmente là dove sarebbe forse più necessario far luce, ovvero fra la secondametà degli anni Trenta e gli anni Quaranta, quando il diffondersi in Italia diidee riformate raggiunge il culmine.
253
L’insieme delle testimonianze interne ed esterne allo scrittoio tassiano ri-sulterebbe perciò del tutto insufficiente a precisare i termini della questionese non gli fosse affiancata la lunga lista delle personalità a vario titolo ascrivi-bili all’area della riforma religiosa frequentate dal Tasso lungo quasi tutto ilcorso della sua vita8. Sono appunto tali relazioni che sospingono il poeta nellargo campo dell’evangelismo costituendo la prova principale delle sue incli-nazioni eterodosse. Poiché tuttavia la sua posizione appare di così difficile let-tura, l’ampia ma generica apertura di credito verso il contesto nel quale eglivisse – ancor oggi tutt’altro che precisamente ricostruito9 – rischia di distor-cere anziché facilitare l’interpretazione dei documenti riferibili a Bernardo, dicondurre a un’indagine indiziaria e a conclusioni schematiche che si lascianosfuggire l’oggetto dell’indagine anziché stringere la presa.
Paradossalmente inoltre, è stata operata un’ulteriore riduzione delle fontidisponibili mettendo spesso ai margini del discorso sia il complesso dell’ope-ra e della riflessione letterarie del Tasso sia, più particolarmente, i suoi testipoetici d’argomento penitenziale o dedicati a figure eminenti dell’evangeli-smo. Dissipando o ignorando gran parte del potere significante e del reale va-lore testimoniale di un testo poetico, salmi, odi e sonetti, più spesso citati checommentati o discussi10, sono stati talora inseriti in modo inerte all’internodi ragionamenti più ampi e viziati, in parte, da un’impostazione deduttivapoco adatta al caso in questione.
Se infatti l’ottica da assumere non è quella dell’inquisitore, ma quella dichi cerca di comprendere un passato distante, il punto, nell’esame di testiepistolari e poetici, non è quello di imporre loro un’etichetta, di esprimerecioè un giudizio definitivo sull’ortodossia o l’eterodossia del Tasso fra gli anniTrenta e gli anni Sessanta, ma di descriverli, mettendo in risalto la posizionedi Bernardo per come essa emerge dai suoi scritti, dei quali si dovranno rile-vare tutte le ambiguità senza risolverle ma dando loro piena dignità, renden-do esplicito ciò di cui esse sono testimonianza. In altri termini, la domandainiziale che ci si dovrebbe porre – soprattutto quando ci si accosti a persona-lità la cui competenza e consapevolezza teologico-dogmatiche non è dettoche fossero pienamente sviluppate – non è tanto se il Tasso fosse in odore d’e-resia e, se sì, di qual specie ma, con minor ambizione, quale pietà i suoi testirivelino, se vada incontro a mutamenti e quali essi siano.
Ora, la cosiddetta Canzone all’anima11 permette di fissare un buon puntod’inizio per riconsiderare alcuni aspetti del problema: la sua lunga vicenda re-
Giovanni Ferroni
254
dazionale ed editoriale, che si cercherà di ricostruire, i punti di contatto conaltri testi tassiani e il sostrato filosofico che essi presuppongono, la sua singo-larità nel panorama della lirica coeva assieme a una certa consonanza con leistanze dell’evangelismo, ne fanno un testo stimolante per cogliere non sol-tanto la cristallizzazione formale di un determinato contenuto ma anche, nel-la diacronia, gli aggiustamenti semantici cui quel contenuto andò incontro,la dinamica impressa dalla storia a quella forma. Sulla base di questa lirica sipotrà quindi tornare a riflettere sul Tasso e, per suo tramite, implicitamente,sulla modalità della risposta da parte della élite letteraria della Penisola aldiffondersi di nuove interpretazioni circa i fondamenti della fede e il rappor-to fra Dio e il credente.
2. Innanzi tutto, alcuni dati essenziali: la canzone fu edita per la primavolta nel Libro terzo degli Amori di Bernardo Tasso (A3)12, stampato a Venezia,sotto la diretta supervisione dell’autore, da Bernardino Stagnino entro il 28luglio 153713. Il Tasso inserirà la lirica in chiusura della prima delle tre sezio-ni che compongono A314 facendone quindi
il momento culminante delle rime di pentimento e dell’intera parabola degli Amori. Inessa il poeta bergamasco si rivolge, sotto la guida di un’ispirazione celeste, alla sua ani-ma per richiamarla a seguire i sentieri della redenzione e ad abbandonare definitiva-mente le pulsioni passionali15.
Per completare l’argomento e una sommaria descrizione del testo, è inol-tre necessario dire subito che, per rendere più allettante l’invito alla conver-sione, il poeta inserisce nella parte iniziale un discorso di Dio alla sua «sposa»(v. 27), nella seconda si distende in una descrizione della vita beata nel cielo eche, nella conclusione, invita di nuovo l’anima alla penitenza.
Benché si sappia pochissimo sulle vicende redazionali dei primi due libridegli Amori (A1 e A2), per quanto riguarda A3 «soccorre […] la sopravviven-za di un importante manoscritto autografo16, contenente una prima versionedella raccolta, in buona parte divergente dalla stampa per lezioni, ordina-mento e presenza dei testi (sottoposti inoltre a qualche correzione e a fre-quenti indicazioni di spostamento)»17. Poiché «l’esemplazione del codice è daascrivere al 1536 ca.»18 e poiché la nostra canzone vi compare alle cc. 12v-17vanche la sua trascrizione dovrebbe risalire a quella data. Ancora precedentedovrebbe essere la sua stesura: un indizio in questo senso viene proprio dalla
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
255
Giovanni Ferroni
256
sua collocazione nella zona iniziale di P il cui «ordinamento originario […]potrebbe rispecchiare in buona parte l’effettivo ordine cronologico di compo-sizione dei testi, man mano trascritti e quindi sottoposti a riordinamento unavolta raggiunto un numero consistente»19. Si potrebbe concludere che Ber-nardo scrisse la canzone fra il 1534 – essa segue nella successione originaria diP i sonetti scritti per l’elezione di papa Paolo III (13 ottobre) – e il 1536 an-no, come detto, della probabile costituzione del codice.
Questa ricostruzione è precisata dall’inequivocabile testimonianza dellalettera scritta il 22 aprile 1535 da Carlo Gualteruzzi a Cosimo Gheri. In queigiorni, il Tasso,
già havea tratto fuori una sua lunga canzone fatta questi dì santi, la quale esso chiamaPenitentia. Ma venute le rime del Bembo tanto si volgemmo ad esse, et io prima che al-trove a ritrovar me stesso, perciò che la lettera di Vostra Signoria me n’havea invaghito,anchora che io non la credessi in tutto così da prima. Sopra la qual cosa il Tasso preliba-to disse molte parole et spesso adimandava delle maggiori sciocchezze del mondo, di-cendo piaccia questa parola, et piacevi quest’altra, et usareste voi questo modo di parla-re et usareste quest’altro. Alla fine io non potei soffrir di più, ma gli risposi: A me piac-ciono tutte le cose del Bembo et tante le userei quando sapessi, et mi venisse bene difarlo, et non mi dimandate più questa parte, perciò che io sono per voler più tosto errarseco che andar drittamente con altri. Quivi esso si tacque dopo haver detto alcune paro-le che non meritano un frullo20.
Stando alle parole di Gualteruzzi, Bernardo compose l’intera, “lunga”canzone – tredici stanze e congedo –, forse nella stessa Roma in cui si trovavaancora in aprile, durante la settima santa del 1535 – fra il 21 e il 28 marzo,circa cioè un mese prima la lettera al Gheri –; si può osservare, in aggiunta,che il titolo attribuito dal Tasso al suo nuovo parto poetico, «Penitentia», lorenderebbe invero più consono al periodo quaresimale, riportandoci alloraun poco indietro ma non oltre, ovviamente, la solennità delle ceneri festeg-giata quell’anno il 10 febbraio.
La genesi del testo smentisce il valore conclusivo assegnatogli in A3 doveimprimerà al canzoniere «il sigillo petrarchista della canzone religiosa di penti-mento»21 e verrà a trovarsi in una zona cronologicamente prossima alla data distampa, comprendente cioè «in prevalenza testi d’occasione che paiono presu-mere la rifrequentazione dell’ambiente veneziano e padovano nel 1537»22.Inoltre, sia l’ordine della trascrizione in P, in cui 31 e 39 sono consecutive, siaquello, nuovo, creato da Bernardo con una fitta serie di postille (P1), mostrano
come il testo avesse in origine tutt’altro ruolo23. «Posizione di stacco», è statodetto24, fra la sezione di testi dedicati a Giulia Gonzaga (31-38) e quella checomprende i sonetti per Paolo III (40-42) e Vittoria Colonna (43)25: in effettise il testo si apre a una dimensione di rinnovamento spirituale e religiosoespressa anche nei sonetti 40-43, i versi «perché questo ingegno […] Ha rivol-to a cercar cose terrene | Intento a laudar bellezza humana, | Che dal vero ti to-glie et allontana» (vv. 59, 63-65) sembrano riferirsi proprio all’ampia serie inlode della Gonzaga.
Assieme a questo dato deve però essere rilevata anche la fitta rete di ri-mandi intertestuali che legano 39 alle due serie vicine e garantiscono la con-tinuità e complessiva compattezza della sequenza. Esamino di seguito soltan-to pochi esempi.
Il primo componimento per Giulia Gonzaga (31) è anch’esso una canzo-ne, condivide con 39 lo schema metrico petrarchesco26 ed è il prototipo, poiripreso in altri testi, della lode per la nobildonna. In particolare, è il dettatodella quarta stanza di 31 che più si avvicina alla canzone 39, poiché il Tasso,elogiando la bellezza spirituale di Giulia e dovendone celebrare l’inalterabi-lità, lo fa marcando l’antitesi fra le condizioni della vita terrena e quelle dellavita spirituale. Se l’«occhio terreno […] scorge un’aer sol vago et sereno, |Che si turba hor da sera, hor da mattino» (31, 53, 56-57), quello «De l’intel-letto» (v. 55) contempla invece l’immodificabile bellezza interiore (vv. 59-65)caratterizzata ricorrendo alla medesima soluzione retorica delle stanze sesta,settima e ottava di 39 (vd. soprattutto i vv. 69-71, 88-98) che descrivonol’imperturbabile stato goduto dall’anima nel «celeste regno» (v. 55).
Conformemente a questi versi in cui la distinzione fra cielo e terra è ri-dotta all’opposizione perenne/mutevole, il Tasso ribadisce più avanti, nellaconclusione di 43, la concezione secondo la quale chi, in questa vita, già par-tecipa delle realtà oltremondane gode di un punto di vista privilegiato e pro-minente rispetto alla variabilità delle cose sottoposte a corruzione: «O perfet-to piacere, o vera vita; | Scorger l’error del Sole, et de la Luna, | Et star sovra lestelle et gli elementi» (vv. 12-14). In modo simile rispetto a quanto fatto in39, sarà ancora il luogo eternamente ameno che potrà raffigurare, nel primosonetto per Paolo III, la rinnovata tranquillità del gregge dei cristiani affidatia un buon pastore simile al primo (40, 1-4, 9-11). Le eccezionali virtù dellaGonzaga, innate, sono poi descritte sotto la metafora floreale – «Di celestiamaranti et di viole | Ornando vostra altera alma beltate» (38, 3-4) – che tor-
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
257
nerà in 39 prima fra gli allettamenti proposti all’anima da Dio (vv. 43-45),quindi nella caratterizzazione di Dio stesso (vv. 101-104) la cui rappresenta-zione è qui contaminata da quella di un più classico Zeus o di un Apollo (co-me, senza più, in 38, 10). I versi appena citati di 39 contengono inoltre unriferimento a Dio come creatore o regolatore dell’universo che appare untratto piuttosto tipico dell’immagine tassiana del divino se si guarda ad altripassi quali «Il fattor de le cose altere e rade» (31, 44; ugualmente in 36, 2), «ilgran Motor superno» (32, 5), «[…] lui, che rende bianchi et freddi i verni |Verde et temprata la stagion novella» (35, 2-3) o «mastro de le cose belle»(37, 3).
Tornando poi alla canzone 31, dev’essere infine segnalata anche l’allocu-zione con cui la «cieca gente et stolta» (v. 66) è chiamata a contemplare e se-guire l’esempio di Giulia, la «pura et candida angeletta» (v. 71): l’appello di-retto al lettore, soprattutto nella sesta e nella settima stanza, conferisce allavoce del poeta un tono predicatorio – non nuovo per la verità negli Amori –27che, ancora una volta, trova riscontro nel ripetuto appello all’«anima trista»posto inizialmente in bocca al Padre (39, 15) e poi ribadito nella secondaparte (vv. 53 e 118).
3. I contatti fra i tre gruppi di testi e la canzone 39 mostrano in modosufficientemente chiaro sia la compattezza di questa zona di P1 sia che per ilTasso, alla metà degli anni Trenta, dal punto di vista dello stile e dei mezzi re-torici, non vi erano ragioni per separare i testi di lode – pubblica, come l’ele-zione d’un Papa, o privata, come per una nobildonna – da quelli d’ispirazio-ne religiosa. Ciò significa che Bernardo non si era posto il problema dellapoesia spirituale come genere lirico e della sua specificità stilistico-espressiva,una questione che, come vedremo, non è circoscrivibile a un ambito esclusi-vamente letterario.
È intanto opportuno soffermarsi sulla serie 31-38, sul sonetto 43 e su al-tri testi a questi legati e presenti, oltre che in P, in A2 e in A3: si otterrà cosìun’immagine più precisa del contesto in cui la nostra canzone è calata, dellastoria poetica che la precede e dell’intrecciarsi, anche nei componimenti en-comiastici, di maniere e linee di pensiero differenti e, a dispetto delle inten-zioni del Tasso, non sempre facilmente conciliabili se osservate da un puntodi vista diverso da quello dei suoi riferimenti filosofici e della sua concezionedi poesia.
Giovanni Ferroni
258
La canzone 31 propone, come detto, quasi per intero la serie di topoi adi-biti alle lodi per la Gonzaga: l’eccezionale congiunzione di bellezza interioreed esteriore che in lei si verifica e di cui il poeta canta l’origine divina indica,a chiunque la conosca, la via della virtù e dell’eternità poiché nel suo cammi-no di gloria essa è scala per la conoscenza di Dio. Il Tasso ricorre con ognievidenza ai luoghi più comuni del platonismo poetico cinquecentesco, luo-ghi da lui già percorsi almeno nei testi per la Gonzaga raccolti in A2 (55-57 e79-80). Tuttavia in P, anche a causa del più frequente riferirsi a Dio, divienepiù forte la tensione insita nel nucleo concettuale – la preminenza dell’animasul corpo – messo in versi nella canzone 31 e nei testi successivi. La ‘scissione’fra le due bellezze della Gonzaga fa sì che i sonetti che seguono 31 abbianoper tema principale ora l’una ora l’altra. Così da una parte il sonetto 32 ponel’accento sull’irripetibile e divina bellezza fisica, con l’augurio che mai sfiori-sca e proclamando «beato chi per essa piange et sospira» (v. 14)28, il 34 diceGiulia più bella della greca Elena e della stessa Venere e il 37 più d’ogni altradonna; dall’altra il sonetto 35 riconferma la lode della «pura angeletta» (v. 1)che reca grazie celesti agli uomini, che ne «volge l’alme a la beata vita» in 36,4 e per la quale, al suo nascere, «Arse d’amor ogni creata cosa» 38, 11.
Fra i testi del Tasso per la Gonzaga – i primi dei quali si trovano già inA1 –, meriterebbe un ampio discorso a parte Se di penne giamai candide etbelle, il poemetto di settantaquattro ottave già presente in P (cc. 47r-68v) eposto in conclusione di A3: esso infatti dialoga a distanza ma intensamentecon tutta la sequenza 31-38, riprendendone e arricchendone i motivi, ora va-riati, ora ripetuti con maggiore chiarezza. Della canzone 31, e in particolaredelle stanze terza-quinta, il Tasso riprende la struttura filosofico-narrativa – apartire dalla fine dell’originaria perfezione del mondo, si narra la creazionedell’anima e del corpo di Giulia, la sua discesa in terra e gli effetti che vi pro-duce – e, portando alle estreme conseguenze i principi là espressi, conduce lalode della Gonzaga fino a farne quasi il mezzo di redenzione del genere uma-no. Si vedano su questo punto, che è il fondamento di tutto l’apparato enco-miastico messo in scena dal Tasso, almeno le ottave XIV-XVI (cc. 50r-v)29:
Vedendo il saggio Padre di NaturaAl cui imperio soggiace ogni elemento,Che rende l’aria hor nubilosa hor pura,Et corregge col cenno il mare e ’l vento,Che l’opra, ch’egli havea con tanta cura
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
259
Fatta di ricco et nobile ornamento,Era un mar di dolor largo et profondo,Lo prese alta pietà del cieco mondo.Et la cagione di cotanto errore
Scernendo col saver, che tutto vedeConobbe che ’l difetto era, ch’amoreHaveva a sdegno ogni terrena sedePoi che quell’aurea età lieta, et miglioreMosse per indi departirsi il piede,Et che si stava de la madre in gremboChiuso di gioie in un eterno nembo.Onde per ritornar vago et beato
Com’era ne prim’anni il basso regnoPensò mandar in quest’humano statoDi sua vera beltate il più bel pegno,De la cui gran vaghezza inamoratoIl mondo havesse ogn’altra cosa a sdegnoEt dietro l’orme sue pregiate et santeVolgesse verso il cielo ambe le piante.
Senza esagerare la portata di questi versi, dev’essere sottolineato comenella curiosa e cortigiana versione dell’economia della salvezza che esprimo-no, Dio, per rinnovare il mondo, restaurarne l’aurea innocenza e ricondurlo,per amore, a sé, invii non Cristo – cui non si fa mai riferimento –, ma Giulia.Che la figura di costei usurpi anche tratti propri di quella messianica sembrarivelarsi anche in elementi meno appariscenti quale, ad esempio, la ripresalessicale dal momento culminante dell’episodio del battesimo di Gesù secon-do la narrazione dei sinottici (Mc 1, 11; Mt 3, 17; Lc 3, 21): la perfezioneideale con cui Dio aveva plasmato il corpo di Giulia sarebbe stata inarrivabileper qualsiasi artista, giacché Egli «Compiacque in questa sola al suo desio»(XIX, 5; c. 51v)30.
Più avanti nel congedarsi dal suo Creatore e dalla corte celeste, Giuliaviene baciata sulla bocca da Dio stesso che, così facendo, le infonde lo straor-dinario ardore di carità che, una volta sulla terra, le darà modo di operare iprodigi narrati dal poeta e di rivolare senza ostacoli al cielo da cui era venu-ta31. Di nuovo, vale la pena osservare che si tratta di una rappresentazione de-cisamente insolita nella tradizione poetica petrarchesca e per la quale invecesi trova ampio riscontro, a partire dall’attacco del Cantico dei Cantici, nellaletteratura religiosa in cui il bacio spesso rappresenta il culmine di un percor-
Giovanni Ferroni
260
so ascensionale, suggella il compiersi dell’amore ed è simbolo delle nozze spi-rituali, del vincolo di perfetta carità con cui l’anima è unita a Dio32.
L’esempio appena esaminato è forse solo un caso isolato nel corpus liricotassiano degli anni Trenta, ma è comunque sufficiente ad aprire la questione,piuttosto inesplorata, della presenza di riferimenti alla Scrittura e alla tradi-zione cristiana, patristica e medievale, nei versi di Bernardo33. Il tema nonpuò essere qui affrontato se non di sbieco sia per la vastità dell’indagine ne-cessaria, sia perché ciò che più mi sembra interessante osservare in questi testiè la commistione fra l’immaginario e i codici espressivi della letteratura reli-giosa con una predominante matrice concettuale e ideologica che non è cri-stiana, ma platonica.
Il dato, certo non innovativo per la cultura e la lirica cinquecentesche34 edi per sé abbastanza evidente alla lettura dei versi tassiani anche a chi abbiapoca pratica con la filosofia rinascimentale, trova una conferma significativaproprio fra le carte di P che raccolgono anche uno zibaldone di appunti, no-te, excerpta e sententiae di enorme interesse per chi voglia entrare nel labora-torio e, soprattutto, nella forma mentis tassiani. Fra le altre cose, vi è conser-vato un ampio frammento delle note di lettura del Commentarium in Convi-vium Platonis o De Amore di Ficino35: si tratta d’un privato strumento di la-voro in cui Bernardo, velocemente, trascrive, compendia o adatta le porzionidi testo che gli interessano36.
Gli appunti sono quasi certamente posteriori ai versi per la Gonzaga enon sappiamo in quale occasione e per qual fine il Tasso leggesse o tornasse aleggere il Commentarium, ma, a giudicare dai suoi versi fra il ’31 e il ’37, ilcontenuto filosofico dell’opera doveva comunque essergli già noto, almenonelle sue linee generali e, se non dalla fonte originale almeno tramite qualchemediazione – a cominciare dagli Asolani. Questi excerpta, raccolti da un testoessenziale per comprendere la lettera e lo spirito di tanta lirica cinquecente-sca, permettono di accompagnare per un buon tratto il procedere e le pausedella lettura di Bernardo, di cogliere il suo interesse per alcuni nuclei tematicie di illuminarne, a ritroso, la scrittura poetica. Converrà perciò fare un suntoparziale ma ragionato di ciò che egli ritenne importante annotare.
Al centro sta la pulchritudo, il «Dei radius» (9), lo «splendor diuinae bo-nitatis» (6) e «splendor diuini uultus» (38) che scintilla e traluce in tutto ciòche esiste, dalle intelligenze angeliche fino alla bellezza terrena delle anime edei corpi: nelle prime lo si ama ardentemente come «stabilem […] decorem»
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
261
(3), i secondi invece essendo «animarum mentiumque umbrae et uestigia»(7) e rappresentando solo un’«ombratilem et fluxa imaginem pulchritudinis»(2) e devono essere oggetto di una più distaccata dilezione. Duplici le Veneriquindi, come duplici sono anche gli amori, l’uno e l’altro «honestus atqueprobandus sed si quis generationis auidior contemplationem deserat aut ge-nerationem praeter modum cum foeminis […] prosequatur aut formam cor-poris pulchritudini animi praeferat his utique dignitate amoris abutitur»(27). Tuttavia, poiché la conoscenza umana inizia dai sensi, è dalle miglioriqualità dei corpi che ci formiamo un giudizio su quelle divine, è a partire daciò che percepiamo, in particolare con la vista e l’udito, che possiamo metter-ci in traccia della bellezza interiore, la bonitas. Essa sfugge ai sensi ma si mo-stra all’esterno grazie a un «decorem quendam […] honestissimum» (34), aun «bonitatis florem […] quasi esca quadam latens interius bonitas allicit in-tuentes» (35). Da queste bellezze, interiori ed esteriori, nasce il «bonus amor»(5) cioè il «desiderium pulchri» (26) e prende inizio il necessario moto circo-lare di ritorno verso l’origine prima di quella bellezza. Si tratta comunque diun percorso non semplice poiché il lume della ragione naturale è «in corporisbarathrum ceu letheum flumen imersus, suiquemet ad tempus oblitus sensi-bus et libidine quasi satellitibus et tiranno raptatur» (31), tuttavia la certezzadel moto è garantita non soltanto da una definizione d’Amore, «Amor circu-lus est bonus a bono in bonum perpetuo reuolutus» (10), ma anche dallaconfortante assicurazione che «quisquis decorem in […] mente, anima, Na-tura et corpore contemplatur amatque Dei fulgorem in his, perque fulgoremhuiusmodi Deum ipsum intuetur et amat» (17). La ragione, se liberata dagliostacoli, potrà quindi risalire la serie delle cause fino ad intuire che «Architec-tum ingentis huius machine aliquem esse» (31) – Dio, la Bonitas «per quemcuncta sunt bona» (8) – e desidererà vederlo e possederlo, essere cioè beata,infatti «Beatus est cui nihil deest» (33). È allora lo stesso sforzo della risalitache stimola il lume naturale «ad diuinam lucem recuperandam» (31), a sfor-zarsi di «accendere rursus in animo» (31) quel lume soprannaturale che la vi-ta nella materia porta a trascurare e dimenticare: è solo grazie a questo che èpossibile vedere Dio.
Da uno sguardo sintetico sugli appunti di Bernardo emerge quindi l’in-teresse costante per la bellezza e la sua definizione, per la piena comprensionedel dinamismo che genera e del ruolo che essa ha nel ricondurre chi la perce-pisce al Dio che ne è fonte; ciò implica d’altra parte anche un’attenzione par-
Giovanni Ferroni
262
ticolare per la giustificazione dell’amore rivolto verso le creature e per il chia-rimento dei limiti entro i quali lo si deve praticare. Emblematiche a questoproposito sono le note 2-4 e soprattutto la quarta che esplicita una conse-guenza piuttosto ovvia delle due precedenti ma che Bernardo riporta ugual-mente sulla carta di P quasi a voler rimarcare il contributo della bellezza deicorpi a una compiuta e stupefacente καλοκαγαθία (19) che è il segno più lim-pido della perfezione divina ed è quindi un richiamo fortissimo alla conver-sione platonica, all’ascesi purificatrice e al ritorno verso la dimenticata patriaceleste.
All’interno dello schema riassuntivo che si è tratto dagli excerpta ficinianidel Tasso rientrano agevolmente sia le ottave del poemetto per Giulia Gonza-ga sia la canzone 31 della quale anzi le note 2-4, appena citate, rappresentanoil fondamento concettuale. Accertato che gli appunti di Bernardo sono latraccia più esplicita del carattere platonico di molti dei suoi versi, i rinvii in-crociati, dalla poesia alla filosofia d’amore e viceversa, potrebbero natural-mente moltiplicarsi. Ciò che più conta è però che il ricorso al pensiero di Fi-cino non è per il Tasso un panneggio nobilitante e che le sue note, pur orien-tate talora da un interesse e da un gusto spiccatamente letterari – di qui, adesempio, la cura nel rilevare la presenza di comparationes –, rappresentanouna selezione di ‘cose’, di significativi concetti filosofici suscettibili di esserepoi tradotti in poesia, in ritmo e immagini. Il platonismo non è insomma perBernardo un elemento episodico della sua vita intellettuale, una suppellettiledel pensiero e della poesia ma, al contrario, la sua struttura fondante, una ve-rità razionale in cui confidare e sulla quale costruire la rappresentazione dellapropria persona di amante e poeta fin dagli esordi del 153137, ciò che proba-bilmente determina la struttura complessiva degli Amori38 e che, infine, con-diziona l’idea di Dio, della beatitudine dell’anima e della salvezza tanto nelpoemetto encomiastico per la Gonzaga quanto in un testo penitenziale comela canzone 39.
Tornerò più avanti su questa interferenza di codice espressivo all’internodi differenti tipologie testuali, ma è intanto necessario sottolineare che il pati-nato spiritualismo platonico dei versi del Tasso non cela affatto la loro mon-danità cortigiana, ne è, anzi, parte integrante. Si tratta, di nuovo, di un datopiuttosto ovvio, che però conviene rendere esplicito: esso permette infatti diapprezzare meglio sia tutta la distanza fra la condizione d’un’esistenza brillan-te e mondana presupposta dai testi tassiani e il percorso di perfezione spiri-
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
263
tuale additato da Valdés nell’Alfabeto cristiano, sia la diversità fra i testi dedi-cati alla Gonzaga, tutti incentrati, al fondo, sulla lode di una bella donna39 equelli dedicati alla Colonna, elogiata certo per l’avvenenza ma celebrata es-senzialmente come poetessa, con riferimento ancora alle sue rime amorose, ocome innamorata di Dio.
Il sonetto dedicato in P alla marchesa di Pescara, il 43, ha difatti un te-nore diverso, più severo: la donna non è cantata per la sua bellezza, ma l’in-tento encomiastico si risolve tutto in una rappresentazione della vita intera-mente contemplativa e perciò perfettamente felice di Vittoria. Non mancanoneppure qui elementi platonici, ma, dovendo narrare e descrivere le incon-suete operazioni d’un intelletto che si è ormai liberato dell’involucro corpo-reo e può ricongiungersi al proprio principio, il Tasso ricorre a zone un po’meno frequentate e trite di quella filosofia d’amore40. Il sonetto, pur isolatoin P come poi in A3, ha però legami strettissimi con l’ampia serie di testi de-dicati alla Colonna in A2, al punto da proseguire la traccia narrativa che neregolava la successione41.
Il sonetto 43 è, a tutti gli effetti, una variazione sul tema proposto dall’ul-timo di quella serie (A2, 63) poiché vi si raffigura nuovamente la Colonnache, raccolta in orazione mentale e staccatasi dal «mondo tempestoso et rio»(v. 2), si unisce alle intelligenze angeliche nella visione infinitamente gioiosa diDio, il «sommo bene» (63, 8), il punto in cui «si finisce ogni desio» (43, 6).Evidente poi la ripresa fra i due testi di alcuni motivi fondamentali, come larepulsa verso il mondo e i suoi inganni, l’esaltazione della «vera […] vita» (63,12 e 43, 12), accompagnata da alcune significative coincidenze formali – l’i-dentità della rima A di 63 e B di 43 con recupero dei rimanti desio : natio :Dio, l’identica struttura sintattica della seconda terzina – che contribuiscono astringere il rapporto fra i testi. Il sonetto 43 si ricollega quindi a 63 tornando arappresentare la Colonna nel punto culminante della sua contemplazione inpuro spirito (63, 9-11), tornando a fissare il punto d’arrivo del percorso de-scritto in A2.
Là infatti il Tasso aveva raccontato di una poetessa che, raggiunti i verticidell’arte poetica e guadagnatasi con la gloria l’eternità, aveva poi improvvisa-mente deciso di abbandonare le rime per convertirsi alla contemplazione diDio, ignorando le rimostranze d’Apollo, delle Muse e dei contemporanei.Punto di svolta, anche se in parte preannunciato dai sonetti 59 e 60, è il dit-tico formato dal sonetto 61 e dalla canzone 62. Se nel sonetto (vv. 1-8) Ber-
Giovanni Ferroni
264
nardo sembra accettare l’irrevocabilità della scelta di Vittoria, l’ampia canzo-ne, costruita su un impianto narrativo esattamente come la 31 per GiuliaGonzaga, ripercorre tutta la recente vicenda intellettuale e spirituale dellaColonna, una vicenda che Bernardo, da poeta, propone, almeno in parte, co-me esemplare.
Il testo, in virtù delle sue implicazioni metapoetiche e della perspicuitàdel messaggio, è particolarmente significativo al punto che andrebbe rilettointegralmente e commentato verso a verso. Mi limito invece a ripercorrerloin modo sommario e ad approfondirne alcuni passaggi.
Presentata nella prima stanza – con evidente ripresa di Lucrezio, De re-rum natura, II, 1-1342 – come colei che, avendo trovato «di salute il vero por-to» (v. 3), può, con il distacco e la letizia del saggio, osservare «l’onde sì peri-gliose e ’l camin torto» dei miseri che cercano d’approdare «al desiato lido» (v.9), Vittoria è lodata, nella seconda, come la restauratrice della gloria di Romamentre nella terza, in cui inizia la parte più narrativa, viene descritta la suaanima scendere sulla terra «per tor gli animi nostri alle terrene | Voglie» (vv.37-38). Il racconto prosegue nella quarta stanza nella quale la donna scegliedi dare «di se stessa a la ragione il freno» (v. 42) e di salire il «poggio […] de laVirtute» (v. 52); qui, «Guidata da Virtù, ne’ larghi prati | De la Filosofia no-bile e degna, | Ch’a la vita immortal salir n’ensegna, | […] Cerca le parti ripo-ste e nascose, | Per trovar i principi delle cose» (vv. 60-65). Non paga, Vittoriaprocede oltre e «Appesa di Platone al caro lembo | Cercò di poesia le scoleelette» (vv. 70-71); divenuta però «Exempio d’eloquenza e d’onor vero» (v.76), rifiuta ora di «Cingersi di trionfante lauro | Drizzando il cor a più graditaspeme» (vv. 86-87). Il momento cruciale della conversione dalla poesia allafede è poi commentato e giustificato dal Tasso nell’ampio monologo interioreattribuito alla Colonna (vv. 87-103).
Nella costruzione argomentativa tassiana, finalizzata all’encomio, i pas-saggi da un grado all’altro sono presentati in modo tale da evidenziare i distin-ti momenti del percorso ma anche da dissimulare le contraddizioni che vi sigenerano. In realtà infatti il soliloquio di Vittoria, tutto giocato sull’opposizio-ne fra effimero ed eterno – esattamente come nella Canzone all’anima –, mettein discussione la positività di tutto il cammino fatto fin lì: abbandonare «tuttoquel che qui fa l’uom beato» (v. 89), la riprovazione dei «piaceri […] di duolferma radice» (vv. 95-96), la consapevolezza di essere immersa nel transeunte,nel non-essere – «quest’è imagin di vita, e solo un’ombra | Di ben» (vv. 99-
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
265
100) –, e che «la vera vita […] è in cielo» (v. 102), implica che la virtù, la filo-sofia e la poesia, che erano state esercitate con onore e che promettevano di al-lontanare da «gioie fallaci e […] diletti» (v. 47), d’insegnare a raggiungere «lavita immortal» e di rompere «a la Morte, al tempo i privilegi» (v. 78), siano,nei fatti, fallaci, sono solo le lusinghe di «un vano errore», cosicché il sertod’alloro con cui trionfano i poeti sarà sostituito da una corona «di stelle» (v.120). Soltanto nella fronte della settima stanza, ove si palesa il rifiuto dellapoesia – «Et or che dato v’han l’alto governo | Le Muse […] del suo famoso esacro monte, | Come di poco onor schiva e nemica, | Par che sì picciol donprendiate a scherno» (vv. 79-83) –, Bernardo sembra prendere le distanze, nonsenza amara ironia, dalla scelta della Colonna che, evidentemente, lo chiamain causa come poeta. In gioco ci sono la gloria poetica, l’eternità ch’essa puòdare e il modo per ottenerla, questioni che attraversano da cima a fondo lacanzone 62, tutti e tre gli Amori e che, nello specifico, il Tasso aveva affrontatoin termini quanto mai espliciti nella lettera con cui dedicava proprio alla mar-chesa di Pescara le Egloghe et elegie che costituiscono l’ultima sezione di A243.Nell’epistola – in cui non v’è traccia della conversione della dedicataria ma sidice anzi che ha superato «Safo e tutte l’altre nelle bone lettere più famose» –Bernardo ribadisce che, anch’egli, come coloro «che di più alto e nobile intel-letto sono, […] questa immortalità di procacciarsi s’affatica; acciò che se Mor-te […] a questo lume ne toglie, il nome almeno nelle memorie delle genti siresti vivo»44. È difficile, mi sembra, non rilevare come i mezzi e i fini ideali delclassicismo cinquecentesco siano concorrenziali e contrastanti con quelli dellaspiritualità, piuttosto ascetica, della Colonna per come viene descritta in A2 ecome, poi, si sarebbe a tutti gli effetti espressa nei versi e nelle prose degli anniimmediatamente successivi45.
Il Tasso tuttavia, come nei sonetti che precedono e che seguono la canzo-ne, cerca di ricomporre i punti di vista divergenti, facendo oggetto dell’elogiola nuova vita divina di Vittoria, predicendole sicura fama terrena («Chiara vi-vrete in bocca de le genti | Già nel tempio d’onor fatta immortale» vv. 132-133) e proponendola come modello per se stesso e per gli «Spiriti gentili» (v.138). Ad essi infatti si rivolge, nella conclusione (vv. 137-143), con una pare-nesi che è contraria ed uguale a quelle della canzone 31, alla «cieca gente etstolta», e della canzone 39, all’«anima trista».
L’unità di prospettive diverse ha tuttavia il prezzo dell’alterazione, sensi-bile e sottilmente mistificatoria, dei propositi della Marchesa: nella conclu-
Giovanni Ferroni
266
sione dell’undicesima e ultima stanza46 Bernardo reinterpreta infatti la vio-lenta separazione di Vittoria dal mondo come un sottrarsi «a le mondanenoie» (v. 141), come un distacco che sarebbe il frutto del desiderio di pace etranquillità. Con ciò egli traduce nei termini di una sorta di otium contem-plativo molto prossimo a quello laico delle lettere, quel che nei versi e nei te-sti precedenti era apparso invece, più radicalmente, come una scelta contrap-posta a quell’ideale e dettata soltanto dall’approdo a un’austera vita devotaraggiunta nel corso di un costante e progressivo mutamento e superamentod’interessi e gradi spirituali.
C’è da credere quindi che la sequenza testuale di A2-A3 fornisca unarappresentazione piuttosto tendenziosa della Colonna e dica molto di più delTasso e del filtro letterario e culturale che gli consentiva d’interpretare e ren-dere poetabile la realtà di quanto non dica della realtà stessa. Da ciò deriva,ovviamente, l’utilità dei testi qui rapidamente esaminati perché, sebbene nonsiano definibili come ‘spirituali’, essi offrono, non meno della Canzone all’a-nima, un’occasione notevole per osservare i tratti caratteristici dell’attitudinetassiana verso il divino e della sua concezione di pietà e devozione intorno al-la metà degli anni Trenta.
Si dovrà poi osservare, a margine del discorso sul Tasso, che la straordina-ria compattezza della serie lirica per la Colonna, l’insistenza e la precisione concui egli ne descrive il percorso interiore, il contrasto garbato ma su questionidi fondo cui dà voce e la consuetudine che all’inizio del terzo decennio del se-colo egli ebbe con la piccola ma vivace corte ischitana47, rendono difficile im-maginare che la genesi di questi testi non si radicasse in occasioni e fatti reali.Ci si potrebbe anzi chiedere se un omaggio di tale, inconsueta, ampiezza qualè quello di A2 non sia anche il frutto d’un’indiretta volontà di autopromozio-ne della stessa Colonna connessa al mecenatismo esercitato nei confronti delTasso48. Stupisce comunque che delle liriche tassiane sia stato tenuto così pococonto nella ricostruzione della storia poetica della Colonna49 e della sua svoltaspirituale – uno snodo biograficamente e culturalmente delicato su cui sappia-mo in realtà piuttosto poco50 –, soprattutto nell’ottica della costruzione delproprio personaggio prima ch’esso diventasse di pubblico dominio grazie an-che alla stampa parmense del 153851. La testimonianza di Bernardo, ante1534 per A2 e databile al 1535 circa per P, è invece fra le primissime di tipopoetico che, dall’interno della cerchia, relativamente ristretta, d’intellettualicon cui la marchesa era in contatto, ne attestino la conversione e, soprattutto,
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
267
che ne esplicitino gli effetti in ambito letterario. Come si è visto, il Tasso offrela rappresentazione di una fase di impasse, di una sospensione della scrittura acausa della scoperta del rapporto col divino come dimensione totalizzante del-l’esistenza. Se ebbe effettivamente luogo, si trattò di una fase non lunga poichéla raccolta lirica testimoniata dal ms. Vaticano Chigi L IV 79, datata all’otto-bre del 1536, conserva già alcuni sonetti spirituali52; tuttavia, identificandouna linea di confine fra un ‘prima’ e un ‘poi’, i testi di A2 e A3 contribuisconoa tratteggiare uno sfondo, non inverosimile nei suoi tratti essenziali, per lacomparsa, altrimenti del tutto improvvisa, della nota lettera del 12 luglio1536 con la quale Gualteruzzi comunicava al Gheri che la marchesa aveva «ri-volto il suo stile a Dio» e a Dio soltanto53.
4. La stesura, fra il febbraio e il marzo 1535, della canzone Penitentia sicolloca quindi all’interno di un sistema poetico-culturale ben strutturato edefinito rispetto al quale presenta forti elementi di continuità, in parte giàesaminati, assieme ad alcuni, notevoli, tratti di discontinuità. La canzone èinfatti un testo singolare tanto per la forma quanto per il contenuto, un testoa basso tasso di ‘petrarchismo’, anche a dispetto, come si vedrà, della colloca-zione in A3.
Si tratta, innanzi tutto, di un esempio di canzone «a sviluppo drammati-co-dialogico»54, di per sé non particolarmente raro ma realizzato qui in ma-niera tale da essere «difficilmente inquadrabile in modo univoco sia nelle ca-tegorie cinquecentesche che in quelle valide per […] Petrarca»55. Nello speci-fico, la canzone, rispetto alla tradizione in cui s’inserisce,
ibrida diverse soluzioni: vi è la presenza dell’ipostasi dell’io (l’anima) che permette alpoeta di parlare a se stesso in un dialogo distanziato, ma ciò che complica il quadro èche al cospetto di questo destinatario silenzioso (l’anima) vi sono in realtà due interlo-cutori (il poeta e il Signore) che pronunciano battute. E tuttavia […] gli attori non so-no contendenti in un dibattito […] ma […] cooperano allo stesso fine persuasivo neiconfronti del destinatario […]. Infine, manca la cornice di contestualizzazione dellascena che, così, finisce per svolgersi in presa diretta davanti agli occhi del lettore […].L’io lirico non patisce di diventare personaggio di un racconto da lui stesso rievocato erimane il centro catalizzatore di un discorso che si fa tutto al presente56.
Tali particolarità si spiegano abbastanza bene non appena si ponga men-te al retroterra filosofico che si è cercato di delineare nelle pagine precendenti
Giovanni Ferroni
268
e alla concezione del divino e alla modalità di autopresentazione dell’io liricoche ne dipendono. Da un lato si può infatti osservare che la scissione dell’ionel ruolo, contemporaneo, di destinatario e di attore in alleanza con Dio,corrisponde piuttosto bene alla distinzione dell’anima platonica in un princi-pio razionale, reso ottuso dal contatto col mondo sensibile57, e in uno divi-no58 che, risvegliato dall’ispirazione celeste, il «grido alto et canoro» dell’inci-pit, condivide, ovviamente, il punto di vista di Dio.
Quanto poi all’assenza di «cornice di contestualizzazione» – tralasciandoil fatto che la ricollocazione del testo nella sua originaria temperie quaresima-le gliene fornirebbe una – mi pare che rientri nella palese ricerca di evidentiada parte Tasso al fine di rendere immediata l’identificazione del lettore conl’anima chiamata al pentimento: il testo infatti, soprattutto nella versione del1535, prima cioè che fosse impiegato per concludere la vicenda dell’io poeti-co degli Amori, proprio per le peculiarità enunciative sopra elencate, estende-va a chiunque il suo appello.
In certo senso, la canzone funziona quindi come un’omelia che, pronun-ciata in un’occasione specifica, è rivolta tanto a ogni singolo fedele, adem-piendo quindi a un ruolo di catechesi individuale, quanto all’intero corpodell’assemblea di cui contribuisce a costruire l’unità. Con ciò mi sembra op-portuno ribadire il carattere eminentemente oratorio di questa lirica, un ca-rattere che si manifesta anche in precisi e ricorrenti tratti stilistici sui qualinon mi soffermo – principalmente l’uso dell’anafora ma anche il continuo ri-volgersi al ‘tu’ del destinatario59 – e per il quale varrà la pena richiamare, inparallelo, la canzone dedicata a Clemente VII (A2, 76) anch’essa costruita se-condo il modo drammatico-dialogico. Qui è l’Italia che per due stanze (se-conda e terza) prende la parola in un’appassionata esortazione al papa affin-ché cessino le guerre nella Penisola60. La vicinanza fra i due componimenti siapprezza non soltanto, in modo puntuale, per la maniera assai simile con laquale si realizza il passaggio da una voce all’altra61, ma soprattutto per il pi-glio patetico e declamatorio con cui parlano i due personaggi chiamati arafforzare il punto di vista dell’io lirico e che è il segno distintivo dell’identicafunzione che svolgono.
Sotto l’aspetto della pura tecnica retorica infatti, proprio come quelle diA2, 76 anche le tre stanze di 39 (dalla seconda alla quarta compresa) in cuiDio si rivolge direttamente all’anima, sono una digressione finalizzata a per-suadere il destinatario non tanto con un’argomentazione quanto piuttosto at-
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
269
traverso il coinvolgimento emotivo; a differenza però di quanto accade nellacanzone al papa, nella Penitentia, poiché il mezzo di questa mozione dell’af-fetto, è il piacere che ci si attende dall’amore di Dio e per Dio, dalla beatitu-dine promessa qui sulla terra62 e poi in paradiso, la parola poetica movendonon può che farsi anche dilettosa. Il diletto poi, nella concezione poetico-sti-listica che dal 1529 circa il Tasso era andato sviluppando a partire dal model-lo della contemporanea poesia latina, soprattutto da quella di MarcantonioFlaminio63, non può che essere realizzato tramite una suavitas di stile che fini-sce per coincidere con una dizione e un immaginario ‘all’antica’ e col corredod’un’ornamentazione mitologica. Da quest’ultima, per quanto impiegatasempre per figurare l’opposto delle realtà celesti64, dipende poi, in definitiva,anche la descrizione idillico-pastorale del paradiso che occupa ben quattrostanze (dalla sesta alla nona) e che rincara la dose di delicatezze poetiche – mad’origine prettamente biblica: la ripresa dal Cantico dei Cantici è al limite del-la traduzione letterale65 –, profuse nelle stanze del monologo di Dio. La de-scrizione del regno celeste è certamente memore della sesta lirica dell’Arcadiasannazariana, Alma beata e bella – in particolare delle prime due stanze66 –,ma, per l’ampiezza, per il ricorso a una lussuosa imagérie classicheggiante, ri-sulta in definitiva del tutto inedita.
La maniera ‘floreale’ del Tasso, non è però del tutto gratuita, finalizzatacioè alla pura e semplice produzione di un piacere poetico; al contrario, comeessa racchiude per il lettore un ammaestramento morale o spirituale, direttoo indiretto, riveste un contenuto concettuale che, con grande probabilità, èd’origine filosofica. Se, ad esempio, le «rose» e i «gigli» dei vv. 72 e 74 sarannoda leggere come semplici metafore della carità e della purezza che regnanonell’«imperio eterno» (v. 68), per spiegare invece il significato dei vv. 44-45,come pure dei vv. 114-117, credo si possano richiamare i due passi del Deamore, trascritti da Bernardo in P, in cui il rapporto fra pulchritudo e bonitas èillustrato proprio con l’esempio del seme e del fiore67. Stante inoltre la conce-zione di Dio quale bonitas68, lo stesso passo ficiniano contribuisce forse anchea dare materia per la rappresentazione del volto di Dio (vv. 102-104), un pas-saggio per il quale dev’essere tuttavia richiamato anche il capitolo quarto del-la quinta oratio – anch’esso schedato da Tasso in P –69. Quest’ultimo poi, inunione ovviamente alla Genesi, rappresenta a sua volta anche il presuppostodei vv. 34-3570. La descrizione infine della vita beata degli angeli e delle ani-me, nella nona stanza (vv. 105-113), potrebbe invece risentire del capitolo se-
Giovanni Ferroni
270
sto della quarta oratio, significativamente intitolato «Amor animas reducit incoelum, beatitudinis distribuit gradus, gaudium largitur aeternum», nel qua-le viene illustrata la perfezione del piacere che risulta dalla visione di Dio71.Se l’interpretazione proposta coglie nel segno anche questi passi e l’immaginedel divino che trasmettono, non meno dei testi per la Gonzaga o la Colonna,troverebbero il loro fondamento nell’elaborazione ficiniana, ripresa e fattapropria dal Tasso.
Se tale ipotesi fosse ulteriormente confermata da ricerche più approfon-dite di quelle possibili in questa sede, si tratterebbe di un dato significativogiacché le parti ‘dilettose’ della canzone, così a lungo protratte (sette stanze sudieci), hanno, per la loro singolarità e il loro sperimentalismo, un peso note-vole nella connotazione del testo. Su di esse, evidentemente, il Tasso puntavamolto per conquistarsi l’attenzione e il plauso degli intendenti di poesia fral’inverno e la primavera del 1535, a sei mesi circa dalla stampa di A2 (settem-bre 1534), una raccolta che per parte sua sarà senz’altro risultata innovativaper la straordinaria ricchezza e varietà metrica, stilistica e tematica dei testi ivicontenuti e per il livello qualitativo che era stato raggiunto. Con la Penitentiail Tasso intendeva probabilmente trasferire i frutti di quell’esperienza, checomprendeva le odi, le ecloghe, le elegie ma anche altre due canzoni piutto-sto ‘sperimentali’ come la 32 e la 90, nel territorio della lirica penitenziale chepareva a tutti gli effetti repugnare alla «prelibata» maniera tassiana. Si trattavadi un’operazione piuttosto ardita, non soltanto perché a quella data non era-no davvero molti gli autori che avessero scritto – e poco dopo pubblicato –un testo d’ispirazione religiosa così ampio e, soprattutto, così originale, maanche perché quel testo poteva essere soggetto a censure di vario genere.
Il moto di stizza con cui Gualteruzzi aveva posto fine alle petulanti solle-citazioni di Bernardo nel suo eccepire rispetto all’uso linguistico e stilistico diBembo mette in evidenza sia la distanza fra le rime del grande maestro vene-ziano e la ricerca formale del Tasso, ottimamente esemplificata dalla canzoneappena «tratta fuori», sia l’accoglienza, forse non fredda ma neppure trionfa-le, che un bembiano ortodosso, e anche più, quale Gualteruzzi poteva riser-vare alle innovazioni del bergamasco. D’altra parte la Penitentia, con la suacommistione di classicismo e cristianesimo, sarà forse andata incontro anchea riserve d’ordine morale se già il sonetto a Priapo, pubblicato nella prima enella seconda edizione di A1 (1531 e 1534), era stato tacciato d’oscenità neldialogo introduttivo del Petrarca spirituale72.
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
271
Le critiche d’un Malipiero, indirizzate però all’esercizio profano della poe-sia tout court, si collocavano certo a tutt’altro piano della gerarchia letteraria ri-spetto a quello frequentato da un Gualteruzzi e dal Tasso, ma sono non di me-no rappresentative dell’insofferenza di certi ambienti religiosi, tanto più rigo-rosi quanto meno inclini ad apprezzare o giustificare le pose paganeggiantidella letteratura contemporanea, un’insofferenza della quale si dovrà teneredebito conto anche in ambito evangelico. Qualche scrupolo, in tal senso, do-vette averlo anche lo stesso Bernardo se, nel passaggio da P ad A3, la perifrasiche concludeva la descrizione di Dio celebrandone l’opera creatrice (39, 103-104) veniva corretta eliminando la commistione con le favole pagane.
Le peculiarità stilistiche della Canzone all’anima divengono ancor piùevidenti confrontiamo quel testo con i sonetti spirituali della Colonna con-servati nel ms. chigiano, i più antichi a noi noti. I testi della marchesa, purevidenziando notevoli punti di contatto con la lirica di Bernardo73, seguonofin da subito tutt’altra strada: confermando un’impostazione bembiana, lin-guaggio e simbologia della sua nuova maniera promanano dall’interno delsuo petrarchismo, piegato adesso a esprimere un contenuto nuovo che divie-ne l’unico oggetto della poesia e l’elemento identificante d’un genere autono-mo74.
Tale enucleazione del tema religioso, il suo adattamento alle contempo-ranee esigenze di riforma spirituale, le ricadute letterarie che tutto ciò com-porta, sono fatti di cui la poetessa appare già pienamente consapevole nel so-netto 104 del chigiano75. La gestione qui un po’ faticosa del lungo periodoche occupa metà della fronte e tutta la sirma del sonetto, non oscura il valoredi un testo che coglie l’occasione della lode dei «santi» (v. 3: da intendersi ve-rosimilmente, come gli evangelisti) per proporre un’esplicita riflessione sulsenso dello scrivere versi e del nuovo percorso poetico intrapreso. Le dichiara-zioni di modestia stilistica (vv. 7, 14) assurgono anzi a cifra caratterizzanted’un’intera stagione lirica: esse infatti non rispondono a ragioni di natura so-ciale76, ma piuttosto a quelle del genere letterario che la Colonna sta definen-do. L’affermazione, davvero precoce ma che sarà poi ribadita in altri e più ce-lebri sonetti (p. es. S1, 1; S1, 4; S1, 137; S1, 179), di una poesia il cui pro-grammatico «carattere inculto […] nasce dal distacco tra l’autrice e la suaopera»77 cui non è affidata alcuna ambizione formale e quindi alcuna aspira-zione di gloria né per sé né per altri, trova qui una formulazione tanto chiaraquanto suggestiva. Come illustra l’immagine della «perla candida» legata in
Giovanni Ferroni
272
oro, all’«arte» è contrapposto il «vero» (v. 4) con la sua esigenza di semplicità,di nudità, secondo il percorso di un’ascesi, anche letteraria, che respinge ogni«vaghezza» (v. 10) e che ristringe l’io, con le sue ambizioni mondane e i suoiartifici, nel minore spazio possibile. Con ciò la nuova poesia ha già definito,in teoria e prassi, il suo stile, volutamente umile e disadorno, e la sua finalità,dare testimonianza a un «vero» senza intessergli attorno altri fregi, senza frap-porsi all’espandersi della «sua più chiara luce» (v. 11). Le «simplici parole» (v.3), l’orientamento anti-intellettualistico che presuppongono, sono quindi ilcorrispettivo dell’iniziale spiritualità della Colonna – prossima a quella deiprimi cappuccini nella cui radicale austerità vedeva rinascere l’originario spi-rito francescano78 – ma, più in generale, sono lo stigma della poesia che siorigina dalle ‘conversioni’ evangeliche, indipendentemente, direi, dalla tintapiù o meno eterodossa che le può distinguere.79
5. Quanto detto fin qui dovrebbe aver messo in luce la centralità dellaquestione delle scelte formali del Tasso, escludendo altresì l’ipotesi che lascrittura di una canzone penitenziale in uno stile che rompeva con il modellopetrarchesco-bembiano della poesia di pentimento fosse, per il Tasso, un’ope-razione da condursi ‘a freddo’ come un puro esercizio di laboratorio lettera-rio. Come detto, la maniera fiorita del poeta bergamasco era indirizzata sì agenerare un diletto ma, a sua volta, esprimeva un contenuto preciso. Anch’es-so, si deve aggiungere, era tutt’altro che consueto nella tradizione lirica, trat-tandosi dell’invito al pentimento non solo per mezzo di una meditazione sul-la corruttela generata dal peccato e quindi sul timore della pena ma dellaprofferta dei piaceri eterni che l’anima godrà in paradiso e, in parte, già sullaterra se vorrà volgersi all’amore divino abbandonando i piaceri terreni. Nes-suna minaccia di castigo quindi, o quasi, ma un invito all’amore: è su questopunto, mi sembra, che si schiude la porta dell’evangelismo e si apre la que-stione del rapporto che con esso ebbe il Tasso.
L’argomentazione infatti che accentua la dimensione individuale e affet-tiva del rapporto con Dio era quella più propria di quanti, fra il terzo e ilquarto decennio del secolo, insistevano su una religiosità interiore, implicita-mente o esplicitamente affrancata dalla pratica delle buone opere, intese co-me mezzo di soddisfazione dei peccati commessi e quindi di salvezza. È que-sta «la via dell’amore», contigua alla «teologia del cielo aperto»80 ed estrema-mente sospetta in quegli anni, potendo presupporre i principi della giustifica-
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
273
zione sola fide, cioè che la «fede nella salvezza è la salvezza»81, della pace dellacoscienza derivante dalla consapevolezza di essere già stati salvati dalla infini-ta misericordia di Dio che, per gratuito amore, ha soddisfatto, nel sacrificiodi Cristo, ogni peccato e ha salvato gratuitamente, l’uomo aprendo una vialarga per il paradiso.
La potenziale eterodossia occultata nel tema della canzone tassiana si tra-duce in atto ed emerge in tutta la sua nettezza se si usa, come esempio a con-trasto, un breve frammento di Flaminio che, nel 1542, per lettera, consigliavaa Carlo Gualteruzzi l’Imitazione di Cristo come testo edificante. Al consigliorichiestogli, l’allievo di Valdés aggiungeva soltanto la seguente precisazione:
[…] una cosa desidero in detto libro, cioè che non appruovo la via del timore, dellaquale egli spesso si serve, ma basta esserne avvertito. Non già ch’io biasimi ogni sorte ditimore, ma biasimo il timor penale, il quale è segno o d’infedeltà o di fede debolissima;perché s’io credo da dovero che Christo habbia satifatto per tutti i miei peccati passati,presenti et futuri, non è possibile ch’io tema di esser condennato nel giudicio di Dio,massimamente s’io credo che la giustitia et la santità di Christo sia diventata mia per lafede, come debbo credere, se voglio essere vero christiano82.
Flaminio è, come spesso gli accade, chiarissimo, al limite del didascalico:solo la «via dell’amore» dev’essere praticata e predicata non quella «del timo-re» e il «vero cristiano», dubbioso su di sé ma certo della grazia divina, pro-porrà a se stesso e ai suoi fratelli in spirito la dolcezza salvifica dell’amore edella misericordia di Dio, non certo lo spauracchio della dannazione eterna.In quest’ottica bene aveva fatto il Tasso a far parlare Dio come si è detto e co-struire il suo testo attorno a una dilettosa descrizione del paradiso. Un passocome quello flaminiano è però tutt’altro che un trascurabile corollario in unaconversazione fra due amici su temi spirituali, poiché Flaminio, anche al di làdegli evidenti riecheggiamenti delle opere di Valdés83, motiva, come se nientefosse, la sua riserva sull’Imitazione di Cristo sulla base di una concezione so-stanzialmente imputativa della giustificazione: è erroneo, argomenta, temereil «giudicio di Dio» perché in quel giorno egli non guarderà i peccati com-messi dall’uomo, ma il mantello della giustizia di Cristo di cui l’anima, «perla fede», si sarà rivestita. Simul peccator et iustus, insomma, l’uomo si salva so-lo in ragione della sua fede in Cristo che, morendo e meritando per amore,ha «satisfatto» a ogni peccato e, facendosi carico di ogni colpa, ha reso inutilel’impossibile adempimento della legge, sanando la consapevolezza delle man-
Giovanni Ferroni
274
canze dovuve all’insufficienza umana e, quindi, annullando ogni timore delladannazione per mezzo della sua grazia. Né si può trascurare che nelle ultimerighe flaminiane risuona distintamente l’eco del fröhlich Wechsel che Lutero,sviluppando l’immagine del rapporto sponsale fra l’anima e Cristo, avevasuggestivamente proposto nel Von der Freiheit eines Christenmenschen84.
Più vicini alla canzone tassiana, nel tempo e nell’ispirazione, meno sco-pertamente eterodossi della lettera di Flaminio, sono alcuni passi tratti daidialoghi di Ochino, poi confluiti nei Dialogi sette pubblicati nel 1540 (Vene-zia, Zoppino). Il Dialogo del convertirsi presto è incentrato, come avverte il ti-tolo, sulla necessità di eliminare, senza remore o ulteriori indugi, ogni attac-camento al mondo per restituirsi a Dio. Del dialogo, i cui interlocutori sonoCristo e l’anima, riporto la battuta iniziale e quella conclusiva, entrambe affi-date al divino innamorato:
È possibile che tu sii tanto villana, ch’io figliuolo di Iddio, somma bellezza, ti chiamoogni giorno al paradiso e già tanto longo tempo, non per mio, ma per tuo bene, e tusorda, rustica et ingrata non rispondi? Se ben gentile e grata alle cose del mondo nonmanchi in far tutti gli debiti tuoi, e di me solo non ne fai conto alcuno? […]Vota adunque ben lo stomaco della tua conscienza, e poi verrai a me; fa, sii presta, nonaspettar d’haver la testa sotto la mannaia; lascia gli peccati, anzi ch’essi lasciano te. Quan-to più tardi, tanto più da me ti lontani e più difficile ti sarà tornar; crescono sempre glituoi habiti tristi; che stai adunque a far? Riguarda il mio amore e non voler che tante miefatiche siano state vane e che ’l mio sparso sangue sia senza frutto; habbi se non di te, dime compassione, sai ben che non sei più tua e che per te perdei la vita. Te aspetto con lebraccia in croce, te invito e chiamo al paradiso; pur che tu vegni a me in verità ogni cosati perdonarò, sarai la mia cordiale, diletta e cara sposa e sempre con me trionferai85.
Come si vede, la suasoria ochiniana ha un andamento circolare simile aquello della canzone tassiana: l’invito incessante «al paradiso», l’eccellenzadell’amante, l’attesa della «sposa», il colpevole tergiversare dell’amata che cer-ca di conciliare Dio e il mondo, l’appello alla penitenza, ne sono i motivi piùricorrenti ed offrono una versione della ‘via dell’amore’ davvero assonantecon il nucleo tematico della Penitentia di Bernardo. Persino i fugaci accennialla dannazione eterna presenti nella canzone (vv. 9 e 123), che non modifi-cano la sostanza del discorso e rappresentano non più d’uno scenario possibi-le valido solo come extrema ratio, trovano riscontro nel dialogo ochiniano cheli presenta con identica modalità86.
Alcuni dei temi presenti nel colloquio fra Cristo e l’anima, dato il loro
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
275
carattere propedeutico alla vita spirituale, si possono incontrare anche in altritesti ochiniani87; in particolare, erano già stati anticipati nel Dialogo in chemodo la persona debbia reggere bene se stessa, poi inserito come terzo nei Dialo-gi sette, la cui pubblicazione è congetturalmente datata al 153688 quindi an-cor più in prossimità della composizione della Canzone all’anima. Più ampiodell’altro, più complesso da un punto di vista strutturale e segnato da ambi-zioni culturali e letterarie molto maggiori, questo dialogo, che ha come inter-locutori principali un «Maestro» e un «Discepolo», verte sul problema del«saper ben vivere»89 e quindi sulla necessità per l’uomo d’individuare il pro-prio «ultimo fine»90, cioè Dio, e sul modo di raggiungerlo così da «havere ilparadiso nella presente vita»91. Il ragionamento del Maestro muove da unadescrizione figurata dell’anima umana rappresentata come «un regno, nelquale la regina è la volontà» che
perché per la sua libertà può fare quello che gli piace et perché è cieca, imperò che névede, né è atta a vedere, però Dio gli ha posto a canto un gran savio chiamato l’intellet-to, acciò che secondo il suo giudicio si habbi a governare, essendo però subdito ad essavolontà in considerare hor questo et hor quello, secondo che a lei piace92.
L’intelletto che, per parte sua, è «tutto immisto et spirituale», quindi im-mortale,
essendo per lume naturale illuminato, vede quello che bisogna per il buon governodell’anima et questo molte volte vede per lume acquisito, o per infuso et sopranaturaleilluminato; et voltandosi alla volontà le recita tutto quello che essa debbe operare, co-mandandole tutte quelle cose che sono necessarie per la salute sua. […] E se ella esse-quisce secondo che le ditta, la lauda, applaude et falle festa dicendo: «Oh quanto benfascesti a obedirmi»; ma se ella fa il contrario, la lacera, morde, mormora et reclama93.
La concezione dell’anima di Ochino, nei suoi elementi generali, è piutto-sto chiara: molto vicina a quella ficiniana94, prevede una conoscenza raziona-le «naturale» che dev’essere integrata, per individuare finalità generali e parti-colari, da un’illuminazione «sopranaturale»95. Soprattutto, per quanto qui ciriguarda, è però significativo che la volontà e l’intelletto acquisiscano il ruolodi vere e proprie personae loquentes e che fra le due si stabilisca un dialogo,sviluppato in effetti nella seconda parte dell’operetta in cui viene ripercorsoin cinquanta tappe, il sentiero che porta l’anima a vivere secondo il desiderio
Giovanni Ferroni
276
di Dio.Il testo è quindi volto a mostrare come la volontà possa innamorarsi del
proprio «ultimo fine»: nel quarto passaggio «l’intelletto […] va cercando inDio tutte quelle cose che possono movere la volontà a portarli amore», poi,nel quinto,
riferisce alla volontà e dice: «Io trovo che Dio è il nostro ultimo fine il quale è somma-mente buono, bello, dolce, soave, pio, clemente, giusto, veridico, onnipotente, savio;trovo che sempre ci ha amato, ama et amarà con sommo, infinito, eterno, continuo,gratuito, sincero e puro amore e che ha in sé ogni perfettione. Trovo che lui è il tuo veroet legitimo sposo, per tuo amore ha creato il mondo e tutto per te mandò il suo proprioFigliuolo, [il quale] per te patì trentatré anni e sparse il proprio sangue in su la croce;per te ha preparato il paradiso e ti aspetta in cielo96.
La risposta a quest’offerta d’amore, ciò su cui si gioca la salvezza dell’ani-ma, può procedere per varie vie, ma l’inchiesta dell’intelletto alla ricerca dei«migliori mezzi per poter salvarsi» approda alla conclusione che «la via de loamore di Dio è la più sicura, breve, netta, facile et honesta che tutte le al-tre»97. Poco avanti, avendo cercato «modi atti e vie, perché la volontà […]ascenda al sommo amore di Dio», l’intelletto afferma:
Io truovo in Dio somma bontà, infinita sapientia, incomprehensibile dolcezza, supera-bondante carità, immensa pietà, suprema clementia […]; io truovo che gli è quello ch’eltutto creò per tuo amore; egli ti diede l’esser tanto nobile e ti ha preservato infino adhora; egli per te si fece huomo, per te venne in terra […] et finalmente per tuo amorevolse essere preso, legato, flagellato et posto in croce. Hor vedi se doveresti amarlo98.
Sono queste, per lo più, le direttrici fondamentali lungo le quali si muo-ve anche l’argomentazione tassiana che apparirebbe allora intensamente per-meata dal messaggio evangelico e concorde nella proclamazione di tesi quali-ficanti come l’«immensa pietà» divina e la «via dell’amore» come accesso allavera pietà.
Mi sono però particolarmente trattenuto sui testi di Ochino – e ai pochipresi in esame si sarebbero potute aggiungere almeno le due serie di prediche,lucchesi e veneziane, stampate prima della fuga – perché si dovrà mettere inconto l’eventualità che, trovandosi forse a Roma durante la quaresima del1535, Bernardo abbia seguito, con la Colonna, il frequentatissimo ciclo diprediche tenute proprio da Ochino a S. Lorenzo in Damaso. Non è questo
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
277
un elemento decisivo ai fini dell’analisi e della comprensione del testo tassia-no, ma questa suggestiva eventualità – né si tratterebbe d’un caso isolato99 –consentirebbe di legarlo a un’occasione specifica di cui nulla ci è direttamentenoto ma della quale i più antichi dei Dialogi sette permettono di farsi un’idea.Oltre ai motivi che si sono visti, potrebbero allora essere fatti risalire all’in-flusso dei sermoni del senese anche il tono predicatorio e, più ancora, gli ele-menti di durezza ascetica della canzone – e si osservi che il «soave pentir»dell’edizioni a stampa e che tanto bene connota lo stile e il tono generale deltesto corregge il primitivo «amaro» (v. 132).
Nondimeno la religiosità della Penitentia non coincide affatto con quelladi Flaminio o con quella di Ochino. Un elemento mi pare rivelatore: a diffe-renza dell’uno, dell’altro o della stessa Colonna – si vedano ancora i sonettidel chigiano –, Bernardo, pur componendo un testo penitenziale e compo-nendolo durante la Quaresima, non fa mai riferimento alla passione di Cri-sto, la spiritualità che anima la canzone pare espungere dal proprio orizzontela croce e il suo dramma. Ciò si riverbera su tutto il testo: una volta esclusodella relazione con Cristo e sottratto ad ogni concreto riferimento alla storiadella salvezza dell’uomo e al prezzo pagato per essa, anche il Padre, nonostan-te le sue appassionate parole, sembra come privato del suo essere personale ediviene qualcosa di non molto diverso da un demiurgo, creatore e regolatoredell’universo, un principio ideale o astratto di cui, come l’Italia nella canzonea Clemente VII, poter fare prosopopea. Della canzone, che offre un’istanta-nea della pietà tassiana e delle sue forme letterarie fra il 1535 e il 1537, do-vrebbe allora essere sottolineata la connotazione intellettuale e quindi, dinuovo, l’influenza d’una religiosità erede di quella ficiniana che, come già neitesti di A2 per la Colonna, suggerisce gli ideali della purificazione come af-francamento dal peso del corpo e della beatitudine come deificatio hominis.
Se la predicazione ochiniana si riflettesse davvero nella Penitentia, colpi-rebbe non tanto la presenza di temi evangelici quanto la ricomposizione eriformulazione fattane da Bernardo sulla base della propria formazione cultu-rale, cosicché la sua prossimità, su certi temi, all’evangelismo si sarebbe verifi-cata proprio grazie al platonismo e non in contrapposizione ad esso come ri-fiuto d’una sapienza mondana. Se, in tal modo, si individuano elementi diconvergenza per evangelismo e platonismo100 e si mette un po’ più a fuoco laposizione del Tasso, si deve però allo stesso tempo constatare la sua mancataadesione al paradigma della ‘conversione evangelica’ come scelta radicale fra
Giovanni Ferroni
278
Cristo e il mondo, come cesura biografica e letteraria fra un ‘prima’ e un ‘do-po’, un paradigma ampiamente descritto da opere quali i Dialogi ochiniani ol’Alfabeto cristiano e a cui autorevolmente rimandano gli esempi, cui si è fattocenno, della Colonna e di Flaminio101. Ed è un fatto, elementare ma signifi-cativo per lo studio del suo rapporto con il movimento riformatore, che talecesura, nella vita e nell’opera di Bernardo, non si produsse mai.
6. Pur essendo latrice di un messaggio di rinnovamento e di purificazio-ne, a dispetto di alcune precise consonanze, l’assenza di una religiosità radica-ta nel sacrificio di Cristo impedisce di considerare la canzone tassiana un’e-spressione diretta delle istanze dell’evangelismo.
Se ne ha ulteriore conferma se si bada alla sua collocazione in A3: essachiude sì gli Amori e il racconto del costante oscillare fra ascensioni spiritualie ricadute sensuali, ma l’accostamento che nel 1537 si realizza con A3, 65 ri-sulta, dal punto di vista d’una spiritualità anti-intellettuale come quella del-l’evangelismo, davvero stridente. L’ideale che Bernardo vi celebra e che vederealizzarsi nelle vite di Andrea Corner e Trifon Gabriele è quello di un ozioelevato, di un’appartata e costante contemplazione laica, rivolta a osservazio-ni scientifiche e questioni letterarie: in ciò si compiono la virtù morale, la fe-licità dell’esistenza e la vera gloria che rende eterni.
Torna quindi a emergere un punto essenziale su cui gli esponenti filo-riformati dell’evangelismo e il Tasso non potevano concordare: il valore auto-nomo della ragione e dell’opera umane. Per i primi il tema di fondo è l’incol-mabile iato fra Dio e la corrotta natura dell’uomo, l’impossibilità per la ragio-ne di conoscere la verità e per la volontà di compiere atti pienamente morali,cosicché Dio è l’unica fonte di vera conoscenza e Cristo l’unico modello digiustizia e via di felicità; per Bernardo invece, anche dopo gli anni Trenta, laragione naturale, soprattutto in quanti ritiene capaci di superare gli impedi-menti frapposti dalla materia all’anima, sarà sempre in grado di indicare la viadel bene e la filosofia, a cominciare da quella dei prediletti auctores antichi, re-sta un imprescindibile punto di riferimento per il pensiero, per l’azione, per lascrittura. La possibilità d’una mediazione fra queste due posizioni, che si com-pie con esiti sempre diversi in Tasso e in altri102, non toglie che vi era, al fondo,una differenza fondamentale fra il non voler sapere altro che Gesù Cristo cro-cifisso e ritenere, con Ficino, che «philosophia et religio germanae sunt»103.
Il livello della mediazione fra il 1535 e il 1560, limite cronologico di
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
279
questa indagine, si sposta: alcune lettere di Bernardo, tante volte analizzate,evidenziano certo una più sensibile influenza di argomentazioni e motivievangelici nel pensiero di Bernardo ma non modificano i termini della que-stione. La lettera a Flaminio, dei primissimi anni Quaranta, ad esempio, dicealcune cose interessanti: che il Tasso aveva già avuto conversazioni spiritualicon il corrispondente, che ne giudicava del tutto ortodosse le posizioni e cheil tentativo d’iniziazione valdesiana, se c’era stato, aveva dato frutti ben scarsi,se Bernardo continuava a parlare della sua vita spirituale in termini rigorosa-mente e tecnicamente platonici, enfatizzando, all’opposto di quanto avevainsegnato lo spagnolo anche ai novizi, i propri sforzi di purificazione e mo-strando di non aver ben chiari gli immediati effetti della fede nel ‘beneficio diCristo’. Lo stesso si potrebbe dire delle lettere alla Colonna nella quarta dellequali sono almeno menzionati la passione e i suoi effetti salvifici benché l’i-dea di grazia che ne emerge, più prossima a quella di ‘grazia susseguente’, nonsia riconducibile a quella professata dalle guide spirituali della marchesa.
Non trovo cambiamenti sostanziali neppure nell’ultima evoluzione dellalirica tassiana. Nel 1560 Bernardo pubblica con il Quarto e il Quinto libro diRime anche di trenta «Ode sacre o Salmi che li vogliamo nominare»104 compo-ste «tra il febbraio e il giugno del 1557»105: è indiscutibile che molti passi diqueste preghiere poetiche presuppongano un approfondimento della fede insenso evangelico dipendenti, almeno in parte, da documentabili letture dellapiù matura lirica spirituale della Colonna e di Flaminio106. Tuttavia, la presen-za di notevoli elementi di continuità con la produzione precedente fanno re-stare la pietà espressa dai Salmi ben al di qua della spiritualità valdesiana oschiettamente evangelica che è stata loro attribuita ma con la quale non si ac-cordano sempre né lo stile – i riferimenti mitologici, pur occasionali e allegori-ci, a Tifeo, Sisifo, Nettuno ecc. appaiono ormai un po’ fuori luogo– né, so-prattutto, il contenuto. Bernardo vi si raffigura infatti ancora diviso fra senso eragione, «cure» o piaceri mondani e aspirazioni celesti, costantemente alla ri-cerca di una grazia che lo purifichi, lo renda giusto (XXIV, 45) e perciò lo salvidal male, costantemente timoroso delle tentazioni del diavolo e della danna-zione – «segno d’infedeltà o di fede debolissima» sentenziava Flaminio – pron-to a ricordare i propri sforzi (XVI, 41-45), sempre privo di quella pace dellacoscienza che Valdés diceva essere il segno distintivo degli eletti in quantofrutto immediato della certezza di essere già stati giustificati e salvati (XI, 31-35). In breve, se esaminati da un punto di vista più propriamente teologico
Giovanni Ferroni
280
sui temi cruciali della grazia, della salvezza sola fide e delle loro immediateconseguenze, anche i Salmi rivelano sia la distanza rispetto al nucleo centraledella fede di Valdés e Flaminio sia la prossimità con la Canzone all’anima ri-spetto alla quale si possono annotare la somiglianza nelle descrizioni del para-diso (IX, 36-49) o del volto divino (XVII, 36-40), nel valore assegnato allabellezza e dei piaceri celesti nell’invito alla conversione (XV, 21-40), nel ri-proporsi d’un immaginario platonico (XVII, 11-15).
È, infine, proprio la Canzone che conferma la mancanza di un reale pro-gresso in senso evangelico della spiritualità tassiana: riedita nel Quinto libro,dislocata fra l’ultimo salmo e i quattro sonetti conclusivi della sezione, pur es-sendo un testo ormai antico e risalente a una temperie storico-religiosa tuttadiversa, essa fu riproposta senza varianti sostanziali, segno evidente che nonera ritenuta bisognosa d’aggiornamento, che il suo impianto concettuale e lesue capacità espressive apparivano al Tasso ancora validi, ancora perfettamen-te corrispondenti alla sua religiosità e consonanti con le sue nuove odi sacre.Essa diviene allora il simbolo di una sostanziale continuità e di una, persinodolente, fedeltà a se stesso, alla propria formazione filosofica e letteraria, auna religiosità certo interiore e «tormentata»107 ma non riconducibile al radi-calismo valdesiano del quale Bernardo non poteva o non sapeva condividerel’essenziale né accettare le ricadute che, certamente, avrebbe avuto anche sullasua concezione dello stile, della poesia e della cultura.
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
281
1 Vd. A. Barbieri, Bernardo Tasso in odore d’e-resia, in «Studi Tassiani», XLVIII, 2000, pp.67-71; D. Fratani, Edizione e nicodemismo,in «Line@editoriale», II, 2010, pp. 56-81(consultato per via telematica all’indirizzohttp://e-revues.pum.univ-tlse2.fr/sdx2/li-neaeditoriale/article.xsp?numero=2&id_ar-ticle=article_004-237); A. Magalhães, Al-l’ombra dell’eresia: Bernardo Tasso e le donnedella Bibbia in Francia e in Italia, in Le donnedella Bibbia la Bibbia delle donne. Teatro, let-teratura e vita, Atti del XV Convegno Inter-nazionale di Studio, Verona, 16-17 ottobre2009, a cura di R. Gorris Camos, Fasano,Schena, 2012, pp. 159-218; F. Zuliani, An-notazioni per lo studio delle convinzioni reli-giose di Bernardo Tasso, in «Rivista di Studi eLetteratura Religiosa», XLIX, 1, 2013, pp.239-250; R. Morace, Bernardo Tasso e ilgruppo valdesiano. Per una lettura dei «Sal-mi», in Quaderno di Italianistica 2014, Pisa,ETS, 2014, pp. 57-90. Della stessa Moracevd. anche i contributi dedicati a temi e testiprossimi a quelli qui indagatati: Del «rinovel-lare» la lingua volgare: i «Salmi» di BernardoTasso, in I cantieri dell’italianistica. Ricerca,didattica e organizzazione agli inizi del XXIsecolo, Atti del XVII congresso dell’ADI, Ro-ma 18-21 settembre 2013, a cura di B.Alfonzetti, G. Baldassarri e F. Tomasi, Roma,Adi, 2014 (consultato in rete: http://www.italianisti.it/Atti-di-Congreso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=581 [da-ta consultazione: 31/10/2015]) e I Salmi traRiforma e Controriforma, in corso di stampain «Studi (e testi) italiani».
2 A. Barbieri, Bernardo Tasso in odore d’eresia,cit., pp. 70-71; D. Fratani, Edizione…, cit.;A. Magalhães, All’ombra dell’eresia…, cit.,pp. 160, 213; con migliore accuratezza edequilibrio F. Zuliani, Annotazioni…, cit., pp.242-243, 249-250 e R. Morace, BernardoTasso e il gruppo valdesiano…, cit., pp. 85-86.
3 F. Pintor, Delle liriche di Bernardo Tasso, in «An-nali della R. Scuola Normale Superiore di Pi-sa», Filosofia e Filologia, XIV, 1900, pp. 16-17.
4 Su cui invece insistono A. Magalhães, Al-l’ombra dell’eresia…, cit., pp. 160, 162 e R.
Morace, Bernardo Tasso e il gruppo valdesia-no…, cit., pp. 67-69.
5 Vd. le lettere del Tasso a Vittoria Colonna(V. Colonna, Carteggio, a cura di E. Ferraro eG. Müller, Torino, Loescher, 1889, pp. 317-321), a Marcantonio Flaminio, a BerardinoRota, alla moglie Porzia in B. Tasso, Lettere(rist. anastatica dell’ed. Giglio, 1559), premes-sa di G. Baldassarri, a cura di D. Rasi, vol. I,Bologna, Arnaldo Forni, 2002, pp. 242-244,352-359, 522. Sulla lettera a Flaminio vd.anche i giudizi di G. Cerboni Baiardi, La liri-ca di Bernardo Tasso, Urbino, Argalìa, 1966,pp. 98-101 e di chi scrive in Dulces lusus. Li-rica pastorale e libri di poesia nel Cinquecento,Alessandria, Dell’Orso, 2012, pp. 226-227.La lettere al Rota era comparsa già nell’anto-logia curata da Dionigi Atanagi, De le letteredi Tredici huomini illustri, Roma, Valerio eLuigi Dorico, 1554, c. 175v. Su questo dos-sier di lettere tassiane, oltre ai citati contributidi Magalhães, Zuliani e Morace, si attende ilcontributo di D. Fratani, Quelques lettres ‘spi-rituelles’. Bernardo Tasso, 1549, in Culture etReligion, CIRRI, Paris, Sorbonne nouvelle,annunciato in stampa in D. Fratani, Edizio-ne…, cit., nota 95.
6 Cfr. il costituto del 13 novembre 1566 diPiero Carnesecchi citato da A. Magalhães,All’ombra dell’eresia…, cit., p. 164 e nota 11e da R. Morace, Bernardo Tasso e il gruppovaldesiano…, cit., pp. 73-74.
7 In particolare la sezione che riguarda Tasso ela sua lettera al Rota in P.P. Vergerio, Giudi-cio sopra le lettere di tredeci huomini illustripublicate da M. Dionigi Atanagi & stampatein Venetia nell’anno 1554, s.l. [Tubinga],1555, c. B8r-v.
8 Vd. gli elenchi di A. Magalhães, All’ombradell’eresia…, cit., pp. 171-174, 181-182 e194, di F. Zuliani, Annotazioni…, cit., pp.237-240 e di R. Morace, Bernardo Tasso e ilgruppo valdesiano…, cit., pp. 58-60.
9 Per la biografia tassiana si deve ricorrere an-cora all’invecchiato E. Williamson, BernardoTasso, Roma, Edizioni di Storia e Letteratu-ra, 1951 (versione italiana a cura di D. Rota,Bergamo, Centro Studi Tassiani, 1993). Qual-
Giovanni Ferroni
282
che precisazione, soprattutto sul versante let-terario, è stata data da V. Martignone, TraFerrara e il Veneto: l’apprendistato poetico diBernardo Tasso, in «Schifanoia», 2005,28/29, pp. 303-313, ma si avverte la neces-sità di uno studio storico che, a partire dauna nuova ricerca documentaria, ripercorrala parabola biografica del Tasso e riesamini ilsuo ruolo nei vari contesti politico-culturaliin cui si trovò ad agire. Alcuni nuovi auto-grafi sono segnalati da G. Arbizzoni, Bernar-do Tasso, in M. Motolese, P. Procaccioli, E.Russo (a cura di), Autografi dei letterati ita-liani. Il Cinquecento, vol. II, Roma, Salerno,2013, pp. 345-358.
10 Fa eccezione R. Morace, Bernardo Tasso e ilgruppo valdesiano…, cit., pp. 76 ss.
11 La denominazione fu assegnata al testo dalRuscelli nell’ultima edizione delle liriche tas-siane pubblicata nel 1560.
12 Per le citazioni dagli Amori, ove non diversa-mente indicato, faccio riferimento a B. Tas-so, Rime, vol. I, testo e note a cura di D.Chiodo, Torino, RES, 1995.
13 Cfr. la lettera scritta in quella data da Ber-nardo a Giovan Giacomo Tasso pubblicatain B. Tasso, Otto lettere inedite, a cura di M.Platter Zappalà, in «Bergomum», XX, 1,1942, parte speciale, pp. 1 ss., lettera n. 1.
14 Sulla struttura degli Amori vd. G. Ferroni,Come leggere «I tre libri degli Amori» di Ber-nardo Tasso (1534-1537), in S. Albonico (acura di), Quaderno di Italianistica 2011, Pi-sa, ETS, 2011, pp. 71-116 (in particolare latavola di A3 alle pp. 109-110).
15 G. Guidolin, La canzone nel primo Cinque-cento. Metrica, sintassi e formule tematichenella rifondazione del modello petrarchesco,Lucca, Maria Pacini Fazzi, 2010, p. 297.
16 È il ms. 1399 della biblioteca Oliveriana diPesaro (P) nel quale A3 è esemplato, in unaforma precedente quella definitiva, alle cc.1r-94r. Il ms. è stato studiato e impiegato damolti studiosi del Tasso fra i quali vd. F. Pin-tor, Delle liriche di Bernardo Tasso, cit.; D.Tordi, Il codice autografo di rime e prose diBernardo Tasso, Firenze, Stabilimento graficoC. A. Materassi, 1902; R. Morace, L’auto-
grafo oliveriano dell’Amadigi ‘epico’ di Bernar-do Tasso, in «Nuova rivista di letteratura ita-liana», XI, 1-2, 2008, pp. 155-181; G. Ar-bizzoni, Bernardo Tasso, cit., p. 349.
17 V. Martignone, Per l’edizione critica del terzo li-bro degli Amori di Bernardo Tasso, in F. Gavaz-zeni (a cura di), Sul Tasso. Studi di filologia e let-teratura italiana offerti a Luigi Poma, Roma-Padova, Antenore, 2003, pp. 387-413: 388.
18 Ivi, p. 389.19 Ivi, pp. 390-391. P nasce però (cfr. Ivi, p.
389) come trascrizione in pulito di uno opiù antigrafi rispetto ai quali resta quindipossibile che la seriazione dei testi sia statamodificata e che perciò neppure l’ordina-mento di P rispecchi esattamente la succes-sione cronologica di composizione dei testi.
20 O. Moroni, Carlo Gualteruzzi (1500-1577) e isuoi corrispondenti, Città del Vaticano, Biblio-teca Apostolica Vaticana, 1984, pp. 64-65.
21 V. Martignone, Per l’edizione critica…, cit.,p. 392.
22 Ivi, p. 393.23 Per le corrispondenze fra P, P1 e A3 e le
convenzioni grafiche impiegate cfr. la Tavo-la. Per il testo delle liriche 31-43 vd. l’Ap-pendice 1.
24 V. Martignone, Per l’edizione critica…, cit.,p. 391.
25 Ibid. Non sono da assegnare alla Colonna 44e neppure 45, attribuito dalla didascaliadell’ultima edizione delle rime tassiane (Ve-nezia, Giolito de’ Ferrari, 1560) alla Marche-sa del Vasto, cioè Maria d’Aragona.
26 È lo stesso di RVF 129; 31 è però più brevedi 39 (otto stanze contro dieci). La testura èfra le preferite dal Tasso: cfr. G. Guidolin, Lacanzone…, cit., pp. 70-72, 76, 100-101.
27 Cfr. almeno A2, 27, 66 ss. e 107-111.28 Il verso riprende, quasi alla lettera, A2, 80,
14 e sarà ricalcato da A3, 67, XVI, 8.29 L’ottava XV manca in A3: è questa una delle
molte varianti del testo del poemetto tràditoda P.
30 Il verso è immutato in A3, 67, XIII, 5.31 «Basciolla in bocca e le mando nel core |
Eterno foco del suo santo amore» XXX, 7-8,c. 53v (A3, 67, XXXIII, 7-8).
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
283
32 Il riferimento è probabilmente inesatto, macfr., sul tema, il commento dedicato al primoversetto del Cantico dei Cantici, «Osculeturme osculo oris sui», sviluppato nei primi ottosermoni sul libro biblico in S. Bernardo diChiaravalle, Opera omnia. Tomus IV, in J.-P.Migne (a cura di), Patrologia latina, vol.CLXXXIII, Paris, 1862, 785-814. L’immagi-ne del bacio sulla bocca come simbolo del gra-do ultimo della via unitiva per giungere a Dioricorre anche in un’opera spirituale coeva allacanzone tassiana del frate cappuccino (dal1534), quindi confratello di Bernardino Ochi-no, G. Pili da Fano, Arte de la unione, Brescia,Damiano e Jacopo Filippo fratelli, 1536 (in se-guito più volte ristampata) che si può leggerein C. Cargnoni (a cura di), I frati cappuccini.Documenti e testimonianze del primo secolo, vol.III/1, Perugia, EFI, 1991, pp. 419 ss.
33 Qualche cenno solo in R. Morace, BernardoTasso e il gruppo valdesiano…, cit., pp. 65-66.
34 Fra i moltissimi esempi che si potrebbero ci-tare si ricordino almeno, per la vicinanzacronologica e d’ambito culturale, quello diGiovanni Guidiccioni studiato da A.A. Piat-ti, «Ché tempo è di ritrarsi al vero lume». Mo-ralità, spiritualità e pentimento nelle «Rimedi religione» di Giovanni Guidiccioni, inM.L. Doglio e C. Delcorno (a cura di), Ri-me sacre dal Petrarca al Tasso, Bologna, ilMulino, 2005, pp. 95-124, e quello di Vit-toria Colonna su cui vd. C. Ranieri, VittoriaColonna e la Riforma: alcune osservazioni cri-tiche, in «Studi latini e italiani», VI, 1992,pp. 87-96: 93.
35 Su quest’opera vd. almeno C. Vasoli, Il Deamore e l’itinerario della deificatio, in Id., Fi-losofia e religione nella cultura del Rinascimen-to, Napoli, Guida editori, 1988, pp. 75-117.
36 Per la trascrizione completa degli appuntitassiani e dei corrispondenti passi del Com-mentarium di Ficino vd. l’Appendice 2 cui,nelle citazioni, rinvia la numerazione fra pa-rentesi.
37 Nel sonetto, poi rifiutato, che apriva la pri-ma edizione di A1, Non la virtù de le sorelledive, si incontra un amante-poeta sottopostoin parte alla fenomenologia amorosa descrit-
ta negli excerpta 19-21, diviso fra la contem-plazione e la lode delle «bellezze» (v. 5) del-l’amata e il tormento causato dal «desio» (v.7) non ricambiato, dalla frustrazione del«puro affetto» (v. 10).
38 Su questo aspetto vd. i cenni in G. Ferroni,Come leggere…, cit., pp. 141-142.
39 Cfr. in questo senso, esplicitamente, la lette-ra di dedica alla Gonzaga della terza sezionedi A2.
40 L’interpretazione tassiana della contempla-zione delle realtà celesti tramite l’orazionementale si fonda sulla teoria platonica chegiustifica anche l’immortalità dell’anima – lapossibilità dell’anima di operare senza ilmezzo del corpo: per restare al Commenta-rium di Ficino, cfr. il seguente passo – nontrascritto da Tasso – del capitolo III dellaquarta oratio (in Omnia divini Platonis ope-ra…, cit., c. I6v): «homo solus est animus,corpus autem hominis opus et instrumen-tum. Eo maxime, quod animus operationemeius potissimam, intelligentiam scilicet, sineullo corporis instrumento exercet, cum resper illam incorporales intelligat per corpusuero sola corporalia cognoscantur».
41 Per una sommaria descrizione vd. G. Ferro-ni, Come leggere…, cit., pp. 126-127. Nontengo qui conto dei sonetti 64 e 65 che chiu-dono la serie di A2 variando la modalità d’e-logio: il primo lo ripropone in chiave pisca-toria, l’altro è indirizzato all’isola di Ischia.
42 La presenza del poema lucreziana nell’operapoetica di Tasso è un tema rilevante ma pocoindagato: cfr. V. Prosperi, L’uso di un’anticaimmagine nel dibattito teorico del secondoCinquecento: il caso di Bernardo Tasso, in«Schifanoia», 26/27, 2004, pp. 271-278;qualche ulteriore riflessione su Bernardo equalche altra ripresa lucreziana nei suoi versiin Ead., Di soavi licor gli orli del vaso. Fortunadi Lucrezio dall’Umanesimo alla Controrifor-ma, Torino, Nino Aragno, 2004, pp. 129-131, 208-210 e Ead. Per un bilancio dellafortuna di Lucrezio tra Umanesimo e Contro-riforma, in «Sandalion. Quaderni di culturaclassica, cristiana e medievale», XXXI, 2008,pp. 191-210: 201, 208-209.
Giovanni Ferroni
284
43 Su questa lettera di dedica, all’interno dellaproblematica ricostruzione della bibliotecadella Colonna, con un accenno anche ai rap-porti fra il Tasso e la marchesa di Pescara, vd.anche C. Ranieri, Vittoria Colonna: dediche,libri e manoscritti, in «Critica letteraria»,XIII, 2, 1985, pp. 249-270: 261-262.
44 B. Tasso, Rime, cit., p. 261.45 Si ricordino almeno i sonetti S1, 1 e 4, prin-
cipio e fine della raccolta della Colonna perMichelangelo su cui vd. C. Scarpati, Le rimespirituali di Vittoria Colonna nel codice Vati-cano donato a Michelangelo, in ID., Invenzio-ne e scrittura. Saggi di letteratura italiana,Milano, Vita e Pensiero, 2005, pp. 129-162:130-132 e i testi citati da V. Copello, «Conquel picciol mio sol, ch’ancor mi luce». Il pe-trarchismo spirituale di Vittoria Colonna, inM Danzi (a cura di), Quaderni Ginevrini d’I-talianistica. Lettura e edizione di testi italiani(secc. XIII-XX). Dieci progetti di dottorato diricerca all’Università di Ginevra, Lecce-Rova-ro, Pensa Multimedia, 2014, pp. 89-122:106-109.
46 Ma la stessa linea argomentativa si trova giàanticipata ai vv. 115-117.
47 Sul tema rinvio ai tradizionali studi biogra-fici di A. von Reumont, Vittoria Colonna.Leben, Dichten, Glauben im XVI. Jahrhun-dert, Freiburg im Breisgau, Herder’scheVerlagshandlung, 1881; A. Giordano, Ladimora di Vittoria Colonna a Napoli, Napo-li, Tipografia Melfi & Joele, 1906; S. The-rault, Un Cénacle humaniste de la Renaissan-ce autour de Vittoria Colonna châtelaine d’I-schia, Firenze-Paris, Sansoni Antiquariato-Librairie Marcel Didier, 1968. Vd. anche ilpiù recente M. Marrocco, Ischia e il suo ce-nacolo di primo Cinquecento: un rinnovatoParnaso per le muse meridionali, in I cantieridell’italianistica…, cit. (consultato in rete:http://www.italianisti.it/Atti-di-Congresso?pg=cms&ext=p&cms_codsec=14&cms_codcms=581 [data consultazione: 31/10/2015]).
48 La dedica delle Ecloghe et Elegie in A2 rientrasenz’altro in un rapporto di patronage chesembra confermato anche dalla lettera diBernardo alla marchesa (su cui cfr. S. The-
rault, Un Cénacle humaniste…, cit., p. 242)49 I testi tassiani erano già stati menzionati, ma
in modo scarsamente efficace da un punto divista critico, da A. von Reumont, VittoriaColonna…, cit., pp. 120-121 e da S. The-rault, Un Cénacle humaniste…, cit., pp. 234-243 (in particolare 241-242); la Therault de-scrive il passaggio dalla poesia amorosa aquella spirituale, sulla scorta di Wyss, alle pp.148-149 (ma vd. anche pp. 194-195).
50 Di difficile lettura, come si sa, sono in parti-colare i presupposti filosofico-teologici diquella svolta, ma le liriche tassiane, e in par-ticolare la canzone 62, con il loro espliciti ri-ferimenti platonici, potrebbero offrire unelemento di sostegno per la ricostruzione fat-tane da C. Ranieri, Vittoria Colonna e laRiforma…, cit., e poi in Ead., Premesse uma-nistiche alla religiosità di Vittoria Colonna, in«Rivista di storia e letteratura religiosa»,XXXII, 3, 1996, pp. 531-548 e ancora inEad., Imprestiti platonici nella formazione re-ligiosa di Vittoria Colonna, in Presenze etero-dosse nel viterbese tra Quattro e Cinquecento,Atti del convegno internazionale, Viterbo 2-3 dicembre 1996, a cura di V. De Caprio eC. Ranieri, Roma, Archivio Guido Izzi,2000, pp. 193-212.
51 Sulla precoce fama della Colonna come poe-tessa in materia di religione, antecedente, al-meno a Firenze, il suo involontario esordioeditoriale cfr. M. Plaisance, La diffusione aFirenze delle «Rime» di Vittoria Colonna, inId., L’Accademia e il suo principe. Cultura epolitica a Firenze al tempo di Cosimo I e diFrancesco de’ Medici, Manziana, Vecchiarelli,2004, pp. 281-289: 281-282 e, con più det-tagli, F. Pignatti, Le poesie e le prose spiritualidi Anton Francesco Grazzini, in «Italique»,XII, 2009, pp. 123-172: 127-130.
52 Per i testi vd. l’Appendice 3. Si osservi che il so-netto 114 (S1, 23), scritto in occasione delNatale, dovrà essere datato al dicembre 1535.
53 O. Moroni, Carlo Gualteruzzi…, cit., p. 65;la distinzione tematica non esclude punti dicontatto fra le due parti dell’opera della Co-lonna: vd. R. Russell, The Mind’s Porsuit ofthe Divine. A Survey of secular and religious
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
285
Themes in Vittoria Colonna’s Sonnets, in «Fo-rum Italicum», XXVI, 1, 1992, pp. 14-27.
54 Per la caratterizzazione di questa tipologianei Rerum vulgarium fragmenta e nei poeticinquecenteschi vd. G. Guidolin, La canzo-ne…, cit., pp. 289-291.
55 Ivi, p. 297.56 Ivi, p. 299.57 La ragione naturale è esplicitamente menzio-
nata ai vv. 59-61: «[…] questo ingegno |Ch’egli ti diede acciò scorgessi il bene | Et ve-desti il camin de la salute»; il suo fine cono-scitivo, presupposto del ben operare, è inve-ce definito ai vv. 13 e 64-65.
58 Per restare ai termini del ficiniano De Amoreletto dal Tasso cfr. Omnia divini Platonis ope-ra…, cit., cc. I6v-K1r: «Lumen igitur habet[anima] geminum: Naturale alterum, siueingenitum: Diuinum alterum et infusum:quibus una coniunctis ceu duabus alis persublimem peruolare ualeat regionem. Ac sidiuino illo semper uteretur, semper diuinishaereret: Terra rationalibus esset animalibusuacua. Caeterum diuina prouidentia decre-tum est ut anima suijpsius sit domina, pos-sitque tum utroque simul lumine uti, tumaltero.»
59 Tali indizi formali, facilmente riscontrabilinel testo, sono segnalati anche da G. Guido-lin, La canzone…, cit., p. 298. Si tratta, co-munque, di elementi piuttosto frequenti intesti poetici concepiti con un forte intentoparenetico: cfr. il caso cronologicamentelontano, ma da questo punto di vista nondissimile, esaminato da F. Ferretti, FuggendoSaturno. Note sulla canzone «Alma inferma edolente» di Torquato Tasso, in M.L. Doglio eC. Delcorno (a cura di), Rime sacre…, cit.,pp. 157-204 (in particolare le pp. 162-164).
60 Anche su questa canzone vd. G. Guidolin,La canzone…, cit., p. 292.
61 Cfr. A2, 76, 21-24: «Udite Italia, che col rot-to crine, | e ’n bruna gonna, in queste vociscioglie | La lingua, e mesta vi riprega e dice: |‘Deh volgi gli occhi a queste rotte spoglie…»e 39, 14-15: «Non odi che ’l Signor ti pregaet dice | ‘Bagnati anima trista al sacro fiu-me…».
62 Cfr. 39, 38-39: «Non attendendo che la car-ne moia | Riedi a cibarti de l’eterna gioia».
63 Su questi aspetti dell’opera tassiana e il con-testo teorico in cui si colloca vd. G. Ferroni,Dulces lusus. Lirica pastorale e libri di poesianel Cinquecento, Alessandria, Edizioni del-l’Orso, 2012.
64 Cfr. 39, 85-87, 95, 97-98 e 104.65 Il rimando esatto in G. Guidolin, La canzo-
ne…, cit., p. 298 nota 68.66 Traccia minima, ma rivelatrice, l’occorrenza
della rima spirti : mirti ai vv. 77-78 della can-zone di Tasso e ai vv. 8, 11 di quella sannaza-riana. Non è questo l’unico caso in cui si pa-lesa un contatto diretto di Bernardo con ilmaestro napoletano –cfr. almeno il sonetto21 e la canzone 22 in A1 (ed. 1531) con So-netti et canzoni, 75.
67 Cfr. Appendice 2, 33-35 (e Omnia divini Pla-tonis opera…, cit., cc. K1v-K2r). Al contrario,non mi pare che possano dipendere da questoo altri passi del Commentarium i vv. 79-81.
68 Cfr. Appendice 2, 6 e 8 (e Omnia divini Pla-tonis opera…, cit., cc. I2v-I3r).
69 Cfr. Appendice 2, 38-40 (e Omnia divini Pla-tonis opera…, cit., c. K3r: qui in particolare,della pulchritudo del qualità del volto divinoriflesso nelle creature, si citano gratia, can-dor, nitor).
70 Cfr. ibid.: «Divina potestas omnia superemi-nens statim a se natis angelis, atque animissuum illum radium, in quo foecunda uisinest omnium creandorum, tanquam filijsclementer infundit. Hic in eis utpote sibipropinquioribus totius mundi dipositio-nem, et ordinem multo pingit exactius,quam in mundi materia. […] Quoniam ue-ro parentis uultus gratus est filijs, necesse estanimis dei patris uultum esse gratissimum.»
71 Cfr. Ivi, c. K1v: «Hic [Amor] animos sua be-neficentia primum ad coelestem ducit men-sam, ambrosia et nectare abundantem: dein-de singulos singulis accomodat sedibus: po-stremo suauiter detinet in aeternum. Nullienim coelum repetunt, nisi qui coelorum re-gi placuerunt: placent illi, qui eum summo-pere diligunt. […] Discumbentium praete-rea ordo in mensa coelesti diuersos sequitur
Giovanni Ferroni
286
gradus amantium. Nam qui deum excellen-tius dilexerunt, dapibus excellentioribus ibiuescuntur. […] Toto autem deo fruunturomnes, quia totus in singulis est ideis. […]Ideo liuor, ut Plato inquit in Phaedro, abesta diuino choro. Cum enim omnium iucun-dissimum sit, re amata potiri: quilibet in eopotiundo quod amat contentus plenusqueuiuit. […] Fit etiam ut sine ulla satietate ani-mi ijsdem uescantur dapibus in aeternum.Ut enim oblectentur conuiuae, non epulaenon uina sufficiunt, nisi fames, sitisque aduescendum alliciant: ac tandiu oblectatioquandiu et auiditas permanet.»
72 Cfr. G. Forni, Vittoria Colonna, la Canzonealla Vergine e la poesia spirituale, in Id., Plu-ralità del petrarchismo, Lucca, Pacini Editore,2011, pp. 63-91: 66.
73 Cfr. la canzone tassiana con il sonetto 114,per lo stile, il 93 per il tema penitenziale, il58 per il tema dell’amore misericordioso diDio (testi in Appendice 3).
74 Sulle ragioni del riconoscimento di questo pri-mato vd. da ultimo V. Copello, «Con quel pic-ciol mio sol, ch’ancor mi luce»…, cit., pp. 92-93110, 113.
75 Vd. il testo in Appendice 3.76 Sulla necessità per una gentildonna di
ostentare modestia in relazione alla propriaattività letteraria vd. T. Crivelli, «Mentre alprincipio il fin non corrisponde». Note sulcanzoniere di Vittoria Colonna, in S. Calli-garo e A. Di Dio (a cura di), Marco Praloran1955-2011. Studi offerti dai colleghi delleuniversità svizzere, Pisa, Edizioni ETS,2013, pp. 117-136: 125-126: la Crivelli di-scute in queste pagine la mancanza di auto-rizzazione per le stampe delle rime colonne-si, ma credo che il suo discorso possa essereadattato anche ad alcune affermazioni dipoetica di Vittoria.
77 C. Scarpati, Le rime spirituali…, cit., p. 131,ma vd. anche p. 132 che conclude il com-mento a S1, 4.
78 Vd. C. Ranieri, «Si san Francesco fu eretico lisuoi imitatori son luterani». Vittoria Colonnae la riforma dei Cappuccini, in V. Criscuolo(a cura di), Ludovico da Fossombrone e l’ordi-
ne dei Cappuccini, Roma, Istituto Storico deiCappuccini, 1994, pp. 337-351.
79 Cfr. il caso di Flaminio e, in particolare, l’e-pistola di dedica dei M. Antonii Flaminii derebus divinis carmina ad Margaritam HenriciGallorum Regis sororem (Lutetiae, Ex officinaRob. Stephani, typographi Regij, M. D. L.,cc. a2r-v).
80 Vd. il fondamentale sesto capitolo di S. Sei-del Menchi, Erasmo in Italia 1520-1580, To-rino, Bollati Boringhieri, 1987, pp. 143-167(in particolare le pp. 143-148).
81 Ivi, p. 145.82 M. Flaminio, Lettere, a cura di A. Pastore, Ro-
ma, Edizioni dell’Ateneo & Bizzarri, 1978,pp. 121-122.
83 A puro titolo indicativo, cfr. per la letturadell’Imitatio Christi J. de Valdés, Alfabeto cri-stiano, a cura di M. Firpo, Torino, Einaudi,1994, p. 92; per il rifiuto del «timor penale»Ivi, pp. 42-43, 104-106 ma anche Id., Centoe dieci divine considerazioni, a cura di E. Cio-ne, Milano, Fratelli Bocca, XI, pp. 39-41; perl’opposizione veri/falsi cristiani in relazione algiudizio finale e alla vita cristiana Id., Loevangelio di S. Matteo, a cura di C. Ossola,Roma, Bulzoni, pp. 314-316, 469-474.
84 La dipendenza da Lutero, se non diretta,giungeva a Flaminio senz’altro mediatadall’opera di Valdés: su questo vd. C. Gilly,Juan de Valdés: Übersetzer und Bearbeiter vonLuthers Schriften in seinem Diálogo de Doctri-na, in «Archiv für Reformationsgeschichte»,LXXIV, 1983, pp. 257-305 e le osservazionidi A. Aubert, Valdesianesimo ed evangelismoitaliano: alcuni studi recenti, in «Rivista diStoria della Chiesa in Italia», XLI, 1987, pp.152-175 (soprattutto 152-162).
85 B. Ochino, I «Dialogi sette» e altri scritti deltempo della fuga, introduzione, edizione enote a cura di U. Rozzo, Torino, ClaudianaEditrice, pp. 91, 95-96; rimando all’intro-duzione di Rozzo per le note storiche e filo-logiche sui dialoghi ochiniani.
86 Ivi, p. 94: «però il savio dee securarsi e nondir sempre: ‘Ben farò’, senza incominciare;quasi tutti quei quai sono nell’inferno pensa-vano emendarsi et andolli fallito; però guar-
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
287
da che ’l simile a te non intravenga».87 Cfr. p. es. Ivi, pp. 53-54 (Dialogo del modo
dell’innamorarsi di Dio), pp. 62-64 (Dialogodel modo a diventar felice), pp. 100-101, 103(Dialogo del peregrinaggio per andar al para-diso).
88 Cfr. B. Nicolini, D’una sconosciuta edizionedi un dialogo dell’Ochino, in Id., Aspetti dellavita religiosa, politica e letteraria del Cinque-cento, Bologna, Tamari, 1963, pp. 26-33.Traggo però il testo da B. Ochino, I «Dialogisette»…, cit. poiché la copia vaticana segna-lata da Nicolini (Ferrajoli V 7622) è attual-mente esclusa dalla consultazione.
89 B. Ochino, I «Dialogi sette»…, cit., p. 67.90 Ivi, p. 70.91 Ivi, p. 80.92 Ivi, pp. 68-69.93 Ivi, p. 69.94 La vicinanza, soprattutto sulla questione del-
la volontà e su come viene trattata, sarà daascrivere anche al riferimento alla scolasticafrancescana (ma cfr. anche P.O. Kristeller, Ilpensiero filosofico…, cit., pp. 274-310).
95 Quanto al «lume acquisito», credo che Ochi-no si riferisca alla conoscenza ottenuta tra-mite l’apprendimento, proveniente cioè dal-lo studio della riflessione razionale degli altriuomini.
96 B. Ochino, I «Dialogi sette»…, cit., p. 71.97 Ivi, pp. 72-73.98 Ivi, p. 73.99 Cfr. il caso di Guidiccioni al quale le prediche
lucchesi di Ochino (aprile-maggio 1538)ispirarono il trittico formato dai sonetti 73-75 (G. Guidiccioni, Rime, ed. critica a curadi E. Torchio, Bologna, Commissione per itesti di lingua, 2006; sull’Ochino a Lucca vd.P. Mc Nair-J. Tedeschi, New light on Ochino,in «Bibliothèque d’Humanisme et Renais-sance», XXXV, 2, 1973, pp. 289-301). L’in-fluenza del cappuccino è manifesta nei vv.12-13 di 73 («Hor [l’alma] raccolta in sé stes-sa envia le scorte | Per passar salva») che di-
pendono infatti dai seguenti passi delle predi-che terza e quarta: «Tesauriza adunque tesoriin cielo, e a guisa de’ duchi, de’ signori e prin-cipi, manda i carriaggi avanti a te, e non li las-sare a dirieto che non ti gioveran[n]o poi nul-la […] E però manda, manda avanti le som-me e i carriaggi delle buone opere e non in-dugiare, imperoché così e con le predette cosepotrai acquistare la perfetta carità di Dio» (C.Cargnoni (a cura di), I frati cappuccini…,cit., pp. 2153, 2154); «Manda, manda,adonque i carriaggi avanti, muta la vita tua,spogliati dell’uomo vecchio, vestiti di CristoGiesù, scancella i tuoi peccati con le elemosi-ne, non aspettare, non confidare nelle pro-messe d’altri» (Ivi, p. 2163).
100 Vd. p. es. sulla necessità della ‘grazia’ pergiungere alla conoscenza diretta di Dio, P.O.Kristeller, Il pensiero filosofico…, cit., p. 262-263 e anche De Amore, IV, 5 (Omnia diviniPlatonis opera…, cit., c. K1r); sull’amore, enon la conoscenza, come via per tornare alcielo, Ivi, IV, 6, c. K1v.
101 Una schematica sintesi in G. Ferroni, A Fa-rewell to Arcadia: Marcantonio Flaminio fromPoetry to Faith, in E. Wåghäll Nivre (a curadi), Allusions and Reflections. Greek and Ro-man Mythology in Renaissance Europe, Cam-bridge, Cambridge Scholar Publishing, 2015,pp. 309-324.
102 La fede evangelica che gli è accreditata nonimpedisce a Varchi di coltivare l’amore pla-tonico: cfr. F. Pignatti, Le poesie e le prose…,cit., pp. 157-160.
103 P.O. Kristeller, Il pensiero filosofico…, cit., p.349.
104 B. Tasso, Rime, vol II, testo e note a cura diV. Martignone, Torino, RES, 1995, p. 187.
105 R. Morace, Del «rinovellare»…, cit. pp. 11-12.106 R. Morace, Bernardo Tasso e il gruppo valde-
siano…, cit., pp. 76 ss., 84. 84. Un diversalettura dei Salmi anche in Ead., Del «rinno-vellare»…, cit., pp. 11-12.
107 Ivi, p. 85.
Giovanni Ferroni
288
TAVOLA
La seguente tavola è costruita in parte sui dati forniti da V. Martignone, Per l’edizionecritica…, cit., pp. 396-398 ricontrollati su P. Qui e nel testo i numeri in grassetto sono sem-pre relativi a P1 quelli in corpo normale ad A3, i testi indicati con la sigla T e la cifra araba so-no quelli presenti in P, assenti in A3 e pubblicati per primo da D. Tordi, Il codice autografo dirime e prose…, cit., pp. 19-31 di cui si riprende la numerazione.
Nel testo degli incipit si distingue u da v, si normalizza l’uso delle maiuscole e si introdu-cono i diacritici.
P P1 Incipit A3 (1537)c. n° n° n°18r 17 1 Già quattro et dieci volte a i fiumi il freno 14v 8 2 Mentre del mio thesor guardato et caro 35r 9 3 Né per che fiumi tepidi et correnti 25v 10 4 Poi che col lume di benigna stella 519r 19 5 Mentre nel vago suo stelo materno a [T4]20r 21 6 I’ credeva di ghiaccio armato il core 420v 22 7 Quando tal hor con la memoria torno 619v 20 8 Con l’aurea treccia, ch’ondeggiando intorno 821r 23 9 Ecco che a l’aureo giogo un’altra volta a [T5]21v 24 10 Sacra ruina che ’l gran cerchio giri 923r 27 11 In ogni parte ovunque gli occhi giro 722v 26 12 Già di verde speranza si riveste 1233r 47 13 È ben ragion che ’l fortunato giorno 1122r 25 14 Di divino splendor cinto et adorno 1023v 28 15 Deh spargi co’ tuoi rai chiari et gelati 1324r 29 16 Allhor, che d’amaranti et di viole 1424v 30 17 Sovra un puro ruscel, che dolcemente 1525r 31 18 Già veggio mille augei bianchi et canori 1625v 32 19 Già ’l grido antico de l’altrui memorie, 1727v 36 20 Ben mi credea de la trilustre oscura 1828r 37 21 Ben fora tempo homai crudo et spietato 2128v 38 22 In queste rupi incolte in questi sassi 1929r 39 23 Perché con l’onde lor tranquille et chiare [>Se ben, famoso Po] 2029v 40 24 Se dopo la stagion bianca et gelata 2230r 41 25 Serchio gentil, che con le pure et chiare 33
289
43v 50 (25 bis) Hor che la nebbia si condensa et graue a [T9]30v 42 26 Quest’herbe questo fiume e questi fiori a [T6]31r 43 27 Candida luna che uagando intorno a [T7]31v 44 28 Ecco superbo et glorioso monte [>Ecco reale] 2332r 45 29 Se quel dolce pensier ch’ ad hora ad hora 2432v 46 30 Vago augellin che in questa parte e ’n quella a [T8]8r 15 31 Come potrò giamai solcar quest’onda 256r 11 32 Così di nostra etate il pigro verno 276v 12 33 Né per che mille lumi a paro a paro a [T2]1v 2 34 Ben dei piena di gioia et di stupore 2618v 18 35 Pura angeletta, de la luce bella, a [T3]26r 33 36 Donna real la cui beltà infinita 2826v 34 37 Se fra quante bellezze altere et rare 3027r 35 38 Mentre lassù fra l’anime beate 3112v 16 39 Odi dal cielo un grido alto et canoro 662v 4 40 Ben potrà di Iesù la greggia humile 363r 5 41 Versa con l’urna d’or Thebro dal fonte a [T1]4r 7 42 Poi che nochier dal sommo Padre eterno 372r 3 43 Hor vi si pò ben dir Donna beata 381r 1 44 Negro velo il bel crin sparso et negletto 393v 6 45 Fra ’l cerchio d’or di mille gemme adorno, 407r 13 46 D’angelica bellezza al suo fattore 417v 14 47 Ombre fresche, herbe verdi, acque lucenti 3438v 48 * Pastori, ecco l’Aurora 2940v 49 ** Crescete o vaghi fiori 3547r 51 Se di penne giamai candide et belle 6771r 52 Ben dovrebbe la fama ardente e viva 4671v 53 Ben può l’Adda turbata al re del mare a [T10]72r 54 S’unqua d’alto dolore invida morte a [T11]72v 55 Perch’al vostro valor sempre nemica 3279r 56 Chi con pronto veder d’occhio cervero a [T12]79v 57 Vorrei Donna gentil, che quel desio [>Temo, Donna gentil] 4786r 58 Lume eterno del Ciel sotto il cui regno a [T13]86v 59 Se mai sempre il tuo allhor caro et amato 4887r 60 Mentre rugiada dal gelato raggio 5187v 61 Se quella Donna dispietata et ria a [T14]88r 62 *** Aure liete et felici, a [T15]90v 63 **** Poi che di uaghi fiori 5293r 64 Benché sì ignudo et povero lasciato a [T16]93v 65 Perché nel Tauro cento volte et cento 5094r 66 Da qual splendor homai la luce havrete [>Da qual vago splendore] 49
Giovanni Ferroni
290
APPENDICE 1
Nota al testo
Si pubblicano, secondo l’ordinamento di P1, per il quale si rinvia alla Tavola, laCanzone all’anima e le sequenze testuali immediatamente precedenti e successive (31-38 e 40-43). Per la descrizione dei testimoni, la loro siglatura, la ricostruzione deiloro reciproci rapporti si rinvia invece a V. Martignone, Per l’edizione critica…, cit.,pp. 396-405. Non se ne accolgono invece i criteri di edizione (ivi, pp. 405-406), inragione della diversa prospettiva critica qui adottata che privilegia la prima redazionefissata dall’autore e non la sua ultima volontà: si dà quindi a testo la lezione finale diP privata degli errori. Il codice è trascritto in modo da conservare quanto più possibilela fisionomia dell’autografo che si presentava, in origine, come copia in pulito: si in-terviene quindi sul testo soltanto per distinguere u da v, quasi senza eccezione ridotteal grafema u nel manoscritto, e per introdurre segni diacritici, quasi sempre assenti.Il testo è corredato, ove necessario, da due fasce d’apparato critico: nella prima, ge-netica, si dà conto della trafila correttoria su P, nella seconda, evolutiva, si seguono,limitandosi alle sole varianti sostanziali, gli interventi successivi testimoniati dallestampe veneziane del 1537 (V3), del 1555 (V4) e del 1560 (V5) che, nella stragrandemaggioranza dei casi, sono concordi. In entrambe le fasce d’apparato la porzione ditesto coinvolta è seguita da parentesi quadra ma se la variante di lezione riguarda l’in-tero verso questo viene indicato solo con il numero corrispondente. Nella prima fasciad’apparato faccio ricorso ai seguenti ulteriori segni e abbreviazioni:
nel ms.: indica un errore meccanico corretto a testospsc: lezione sostitutiva inserita nell’interlinea superioresu: lezione sovrascritta una precedentevar. imm.: la variante che, nel verso, segue immediatamente la lezione precedente›xxx‹: lezione cassata
291
31
Come potrò giamai solcar quest’ondaDel mar de’ vostri honor Donna immortaleCon picciol barca del mio basso ingegno?Scorgami chiaro cielo aura seconda
5 Al porto non a me forse fatale,Ma ad altro spirto più sublime et degno;Né vi prendiate sdegnoDel mio soverchio ardir, tal, che per forzaVento importun del vostro duro orgoglio
10 La spinga in qualche scoglio:Alterna Apollo homai la poggia et l’orzaTu fatto fido Tiphi; et scorgi foraDi questo cupo mar l’ardita prora.Ma qual lucente tramontana et fida
15 M’insegnerà il camin se voi non sete,Col raggio de’ vostr’occhi ardente et chiaro;Voi dunque occhi sereni, in cui s’annidaDolcezza tal, che può far l’alme liete;Che può tornar soave ogn’altro amaro
20 Se da voi sol imparoA solcar l’onde de la gloria vostra,Non mi s’asconda il vago lume ardente,Ond’a l’oscura menteQualhor erra il camin chiaro si mostra;
25 Acciò nel cominciar non torni a rivaCon la barchetta di governo priva.Dico Donna real, che da che il sole
Veste col suo splendor di luce il mondo,Dal dì che cominciar le cose belle,
30 Non scese giù da le celesti scoleSpirito di virtute a voi segondoNon pur egual, in queste parti, o ’n quelle;Et fur tutte le stelleChe infondeno fra noi virtù et honore,
35 Per far bella di voi la nostra etateInsieme congiurateA darvi ogni divino alto splendore;
Giovanni Ferroni
292
Et vi mandar a provar caldo et geloPer far fede fra noi del ben de cielo.
40 Et perché alma sì pura et sì gentileHavesse albergo eguale a sua beltade,Che mostrasse di fuor l’alta vaghezza,Vi fece di sua mano a lui simileIl fattor de le cose altere e rade,
45 Et vinse di gran lunga ogni bellezzaTal, che quanto s’apprezzaHoggi fra noi di vago e d’honorato,A paro a voi, è come un’ombra al vero:Vostro solo è l’impero
50 Di tutto il bel di questo humano statoSì, che colei è bella a maraviglia,Che in qualche parte a voi pur s’assimiglia.Ma nulla è ciò, che quest’occhio terreno
A lato a quel che l’altro alto e diuino55 De l’intelletto in voi contempla et scerne;
Quel scorge un’aer sol vago et sereno,Che si turba hor da sera, hor da mattino;Et questo un sol de le bellezze interne,De le bellezze eterne,
60 I cui lucenti rai nebbia importuna,Né pioggia mai de la vecchiezza vela;Né morte asconde o cela,Non sottoposta a i casi di fortunaVera beltà, ch’ogn’hor cresce co gli anni,
65 Senza specchio operare et senza inganni.Volgete gli occhi o cieca gente et stolta
A l’interna beltà, che fece IddioQuanto più puote far vaga et perfetta;Ch’ogni virtù vedrete insieme accolta
70 Ch’ unqua dal petto del gran padre uscioIn questa pura et candida angeletta:Alma fra tante elettaA portar di lassù teco ogni bene,Sotto le vaghe tue purpuree piume,
75 Con cui va per costumeBellezza et castità, che rado aviene)
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
293
Congiunte con sì dolce compagnia,Che ciò che l’una vol l’altra desia.Qual pellegrino augello ardita vola
80 Senza contrasto di contrario ventoLa gloria tua a quell’eterna vita;Et presso al più bel ciel solinga et solaVolgesi in dietro a volo tardo et lento,Et l’alme nostre a tanto bene invita;
85 Indi lieta et romitaRinchiusa nel splendor del suo bel raggioCon la sua luce i nostri lumi abbaglia,Tal, che dove si sagliaComprender non si può, chi accorto et saggio
90 Non siegue l’orme di tua vera gloria,Ove vive di noi sempre memoria.Felice fiume a le cui rive nacque
Il fortunato parto, in cui disceseCosì raro miracol di natura,
95 Non sia chi turbi mai tue lucid’acque;Né nebbia adombre il tuo gentil paese;Anzi habbia l’aria ogn’ hor temprata et pura;Et lieta oltra misuraScherzi ogni Nimpha tua nel vago letto;
100 Oro l’arene sian, smeraldi l’herbe,Che fanno alte et superbeLe verde rive tue; piova dilettoSovra ’l tuo chiaro et honorato crineIn vece di rugiade mattutine.
105 Ne l’honorate piaggie,Che l’Ollio inonda col suo torto cornoNacque la maraviglia de la terra;Liri hor l’asconde et serraNel destro lido suo vago et adorno,
110 Et se ’n va più che ’l Thebro altero in vista,Che tal gratia fra noi raro s’acquista.
2. immortale] reale V3 V4 V5 3. picciol barca] barchetta V3 V4 V5 4. Scorgami chiarocielo] Sospingami favor d’aura V3 V4 V5 7. prendiate sdegno] prenda disdegno V3 V4 V5 9.Vento importun] Fiato importuno V3 V4 V5 vostro duro] vostr’empio V3 V4 V5 10. spinga]
Giovanni Ferroni
294
rompa V3 V4 V5 12. Tu fatto fido Tiphi;] Quasi saggio mio Tiphi,V3 V4 V5 13. cupo] largoV3 V4 V5 15. M’insegnerà] Mi mostrerà V3 V4 V5 16. ardente] amico V3 V4 V5 17. Voidunque occhi sereni,] Dunque de que’ begli occhi V3 V4 V5 20. voi sol] lor soli V3 V4 V523. Ond’a l’oscura] Onde a la cieca V3 V4 V5 26. Con la barchetta di] La naue mia del suoV3 V4 V5 27. real] immortal V3 V5 (inmortal V4) che il sole] quel giorno V3 V4 V5 28. Chel’huomo gli occhi in questa luce aperse, V3 V4 V5 29. E prima scorse il vaneggiar de l’hore;V3 V4 V5 30. Dal dì, che bianche, gialle, verdi, e perse V3 V4 V5 31. Vide le piaggie aprillieto et adorno; V3 V4 V5 32. E riconobbe il mondo il suo Fattore, V3 V4 V5 33. Non scesein terra fiore V3 V4 V5 34. Di virtute, e d’honor sì vago et bello: V3 V4 V5 35. Né con be-nigno mai favor del Cielo V3 V4 V5 36. A provar caldo e gelo V3 V4 V5 37. Venne da queldivino alto drapello V3 V4 V5 38. Spirito più di voi chiaro e felice V3 Spirto più di voi chiaroe più felice V4 V5 39. Per far lieta del mondo ogni pendice V3 V4 V5 43. fece di sua mano alui] fe’ con ogni studio a sé V3 V4 V5 47. Di vago, et di leggiadro hoggi fra noi V3 V4 V5 48.A paro] A lato V3 V4 V5 49. O nobil magistero V3 V4 V5 50. Di man propria di Dio, chevali et poi V3 V4 V5 51. Col lieto lume de le luci ardenti V3 V4 V5 52. Le tenebre tornarchiare e lucenti. V3 V4 V5 54. A lato] A paro V3 V4 V5 56. scorge un’aer] vede un aere V3V4 V5 57. Che conturbar si può sera e mattino V3 (mattina V4 matina V5), 59. De le] VereV3 V4 V5 60. lucenti] lucidi V3 V4 V5 64. Vera] Sola V3 V4 V5 65. operare et senza] adoprar,senz’altri V3 V4 V5 66. gli occhi o cieca gente et stolta] incaute genti alcuna volta V3 V4 V567. A l’interna] Gli occhi a quella V3 V4 V5 73. A] Per V3 V4 V5 74. vaghe] belle V3 V4 V576. castità,] honestà V3 V4 V5 82. ciel solinga] cielo altera V3 V4 V5 86. Chiusa nel lumedel suo ardente raggio V3 V4 V5 93. in cui] ove V3 V4 V5 99. tua nel vago letto] nel tuo her-boso letto V3 V4 V5 102. verde] fresche V3 V4 V5 103. Sovra ’l tuo chiaro et honorato] Dalciel sovra il tuo crespo humido V3 V4 V5 105. Ne le piaggie, che bagna V3 V4 V5 106. L’Olliodi chiaro e d’honorato grido V3 V4 V5 109. Nel suo più verde e dilettoso lido V3 V4 V5
32
Così di nostra etate il pigro vernoNon copra mai di ghiaccio o di pruineIl fior de gli anni nostri; et quelle brineDel viso habbian dal Cielo Aprile eterno;
5 Come fra quante il gran Motor supernoCreò bellezze altere et pellegrine;Fra quante ne verranno alte et divineVostro solo sarà ’l pregio in eterno;Ombra par di beltà qual più si tiene
10 Bella qua giù, s’al par di voi si miraEt perde il lume come fiamma al Sole:O bellezze fra noi perfette et sole
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
295
Fida scorta d’alzarsi al sommo bene,Beato chi per voi piange et sospira.
2. Giamai non vi ricopra il biondo crine V3 V4 V5 3. Di bianche nevi; et habbian lepruine, V3 V4 V5 4. Che sì vaga vi fanno il fresco eterno V3 V4 V5 6. Creò] Criò V3 V4 10.qua giù,] da noi, V3 V4 V5 12. fra noi] qua giù, V3 V4 V5 13. alzarsi] alzarci V3 V4 V5
33
Né per che mille lumi a paro a paroAlzino al Ciel le pure fiamme intorno,Allhor che ’l tauro il dì porta col cornoDi splendor coronato altero et raro,
5 Rendeno il Sol più rilucente et chiaroAnz’ei del proprio suo bel lume adornoRende hor men bello, et hor più vago il giornoCom’è di quello a noi largo od avaro:Né per che scrittor mille accorti et saggi
10 Cerchin più ardente far la gloria vostra,Crescon de la sua luce una favilla:Anz’ella co suoi vaghi aurati raggiAlluma il mondo oscuro, et l’età nostra,A grado sì perfetto il Ciel sortilla.
8. di] var. imm. di ›ai‹ biffato dopo un tentativo di correggere la a in d
34
Ben dei piena di gioia et di stuporeGaieta dir, che la greca famosaPer cui Troia dolente et angosciosaChiuse le luci in un eterno horrore
5 Cede a costei, che già dell’Ollio honoreIndi del Liri, hor nel tuo monte ascosaPiù d’altra donna altera et gloriosaPorta ne gli occhi et ne la fronte Amore,Se ti rimembra tale era, o men bella
10 La madre del Troian, di cui nutrice
Giovanni Ferroni
296
Serbi anchor grido sì pregiato et raro;O più d’ogn’altra età ricca et felice,A cui consente gratiosa stellaRimirar di beltà raggio sì chiaro.
2. Gaieta] Gaeta V4 V5 4. un eterno] sempiterno V3 V4 V5 5. già] pria V3 V4 V5
35
Pura angeletta de la luce bella,Che prendeste ne gli occhi chiari eterniDi lui, che rende bianchi et freddi i verni,Verde et temprata la stagion novella;
5 Che sotto i raggi di benigna stellaScendeste adorna de gli honor superniPer far a la bellezza oltraggi et scherniDi cui più qui si canta et si favellaAl vostro alto apparir santi costumi
10 Leggiadria nova, et gentilezza raraFer di mille virtuti il mondo adorno;Né cotante vaghezze adduce il giorno
Ne l’ampia fronte allhor che ’l ciel rischiara,Quante voi gratie ne’ celesti lumi
36
Donna real la cui beltà infinitaFormò di propria man l’alto fattorePerché accese del suo gentile ardoreVolgesse l’alme a la beata vita,
5 La cui gratia divina ogniuno invitaA l’opre degne di perpetuo honore;Ne’ cui lumi sereni honesto amorePer un raro miracolo s’addita:Virtù, senno, valore, et gentilezza
10 Vanno con voi, come col giorno il Sole,O sì come col Ciel le vaghe stelle:
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
297
L’andar celeste, il riso, et le paroleProprie di Dio, et l’altre cose belle,Fan poi perfetta in voi tanta bellezza.
4. Volgesse] Volgeste V3 V4 V5 12. vaghe stelle] stelle ardenti V3 V4 V5 13. Piene d’altiintelletti, e di dolcezza, V3 V4 V5 14. Son di vostra beltà ricchi ornamenti. V3 V4 V5
37
Se fra quante bellezze altere et rareNon pur pinse o scolpio Phidia od Apelle,Ma formò ’l mastro de le cose bellePer far arder d’amor la terra e ’l mare
5 Scelse le parti più pregiate et careNé si curò d’impoverir le stellePer far le vostre sol simili a quelleChe con la vista puon l’alme beare;Cedavi Iulia qual più in pregio sale,
10 Et mirandovi tutta al sol similePasca col contemplarvi ogni desioOver pianga d’invidia, et dica ah Dio
Perché si bella fai donna mortaleCh’a lato a lei ogni beltà sia vile
10. al sol] barrato con a spsc ma la correzione è incompleta
2. od] e V3 V4 V5 9. Qual fia Donna giamai mortal sì ardita, V3 V4 V5 10. Che pareggiil suo raggio al vostro sole V3 V4 V5 11. E non resti di luce e d’honor priva? V3 V4 V5 12.S’a le rose s’aguaglian le viole, V3 V4 V5 13. O ’l verde salce a la fiorita oliva, V3 V4 V5 14.Rimarrà lor beltà vinta e smarrita. V3 V4 V5
38
Mentre lassù fra l’anime beateVi vagheggiava ogn’hor la luna e ’l soleDi celesti amaranti et di violeOrnando vostra altera alma beltate
5 Vestite di color di puritate
Giovanni Ferroni
298
Spargevan per lodarvi alte paroleLe liete genti de l’eterne scoleDi sì pura angioletta inamorate:Ma poi scendeste in terra adorna et vaga
10 De la luce d’Apollo et de le stelleArse d’amor ogni creata cosaRendivi dunque honor qual più s’appaga
Di sua beltà che fra le donne belleSete fra fior come purpurea rosa
10. d’Apollo] di Phebo V3 V4 V5 12. dunque] adunque V3 V4 V5 14. Sete fra fiorcome] Sete, come tra i fior V3 (tra fior V4 V5)
39
Odi dal Cielo un grido alto et canoro,Ch’ a vera penitenza homai t’invitaAnima ne gli error chiusa et sepolta:Senti il gran Re di quel celeste choro,
5 Che ti richiama a la felice vitaEt tu pur tardi ne’ piaceri involta?Anima sorda ascolta,Vedi con quanto amor con quanta curaEi per te tema de l’eterno danno;
10 Et tu pur d’anno in annoTroppo più che non dei fatta securaDi colpa in colpa et d’uno in altro falloHai fatto contra il vero un duro callo.Non odi che ’l Signor ti prega et dice
15 Bagnati anima trista al sacro fiumeDi penitenza, e ’n quel ti lava et tergi;Indi purgata ben lieta et feliceTutta coperta di purpuree piumeIn grembo al tuo fattor t’inalza et ergi;
20 Et la nebbia dispergiCo’ raggi del dolor atroce et duroDe le tue colpe et de’ terreni inganni:Spiega i possenti vanni,
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
299
Amica mia, et a quest’aere oscuro25 A questa inferna et lagrimosa valle
Scorta da carità volgi le spalle.Deh vieni sposa mia, che già passato
È ’l freddo verno et le pruine, e ’l ghiaccio;Et depingono i fior la terra nostra:
30 Spiran le vigne il lor odore usato;Portano i fichi i verdi figli in braccioEt già la tortorella a noi si mostra:Questa terrena chiostraLascia colomba mia mostrami il volto
35 Ch’io feci a mia sembianza ardente et bello;Et con un ramuscelloDi verde palma novamente coltoNon attendendo che la carne moiaRiedi a cibarti de l’eterna gioia.
40 Vieni diletta mia, ch’io pur t’aspettoCon braccia aperte per pigliarti in gremboEt per porti nel trono alto et celeste;Et tutto pien d’un’amoroso affettoColt’ ho d’eterni fiori un pieno lembo
45 Per adornarti la candida veste:Esci da le tempesteDel mar irato del piacer mortaleEt vieni a tor di vita la corona,Che di mia man si dona
50 A chi lasciando il ben fallace et fraleA questo eterno et vero s’alza et volaEt de le voglie mie sol si consola.Et tu anima trista non intendi,
La voce del fattor che ti pur chiama55 Per darti parte de celeste regno?
Pigra perché non sorgi et non contendiAl vano senso, che tua morte brama?Perché del tuo fallir non prendi sdegno?Et perché questo ingegno
60 Ch’ egli ti diede acciò scorgessi il beneEt vedesti il camin de la saluteDato il tergo a virtute
Giovanni Ferroni
300
Hai rivolto a cercar cose terreneIntento a laudar bellezza humana,
65 Che dal vero ti toglie et allontana.De’ mondani pensier la nebbia, e ’l velo
Ch’ appanan gli occhi tuoi squarcia, et rimiraL’alta beltà di quell’imperio eterno:Ivi mai sempre sta sereno il Cielo
70 Vento di gratia dolcemente spiraNé mai senton que’ campi estate o vernoVaghe rose in eternoSpiegano al ciel bianco et vermiglio il crine;Et per le valli gli odorati gigli
75 I fior bianchi et vermigliCoperti di rugiade mattutineFanno corone a’ gloriosi spirtiPiù degne assai che di lauri o di mirti.Ivi le piante belle et verdeggianti
80 Carche di frutti inusitati et straniFan le selue lassù vaghe et frondoseFiumi di voluptà chiari et stagnantiBagniano i sempre verdi et larghi piani;Et per le piaggie apriche et dilettose
85 In vece di doglioseVoci di Progne, o de la sora ogn’horaS’ode armonia angelica et soave:Ivi forza non haveMorte, o colei, che tutto ’l mondo honora
90 Né la bianca vecchiezza in un momentoTorna le chiome di color d’argento.Ivi non scampan gli anni i mesi o l’hore
Scorte dal tempo fuggitivo et lieveNé cede unqua alla notte il chiaro giorno;
95 La vaga Cinthia non rinasce et moreNé fa di nubi il Ciel condenso et greve;Né col suo carro d’or si volge intornoPhebo: ad un modo adornoÈ sempre l’alto seggio con la luce
100 Onde piglia splendor la Luna, e ’l SoleSempre pien di viole
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
301
Le tempie, et cinto il crine il dì riluceNe gli occhi ardenti et ne la vaga fronteDi quel che fece il Padre di Phetonte.
105 Co gli angeli contente a paro a paroVanno cantando l’anime beateGodendo d’un piacer perfetto et veroSenza temenza che licore amaroTurbi giamai le lor dolcezze usate
110 Et con novo piacer rivolte al vero,Co gli occhi et col pensieroOgni loro desio menano a rivaAccese d’un amor dolce et gentile;Né mostra al vago aprile
115 Cotanti fior ben colta e molle rivaQuanta gioia produce et quanto giocoL’aventuroso et fortunato loco.Prendi il christallo homai anima trista
De la conscienza, e ’n quel ti tergi et specchia120 Onde il tuo primo amor t’ami et apregi
Non sopportar che la tua vaga vistaTurbi macchia di colpa nova o vecchiaPagar convienti a morte i privilegiEt co gli aurati fregi
125 Lasciar il corpo a la sua antica madrePerò fia meglio che purgata et bellaSì come vedovellaRitorni a riveder l’amato PadreE ’n mezzo de que’ santi angeli eletti
130 Viver a lato sempre a i più perfetti.Canzone ardente et calda
D’un amaro pentir del mio fallireAlzati a quel Signor che tutto vedeE di’, Pieno di fede
135 Acceso di devoto alto desireHumile chi mi feo pietà ti chereEt grida miserere miserere.
38. su rasura di precedente lezione non più leggibile 50. fallace] spsc a ›caduco‹ barrato 51.et vero] spsc a ›mio‹ barrato • alza] malza con m- cancellata 55. del] nel ms. de 60. diede] die con
Giovanni Ferroni
302
-de spsc • acciò] spsc a ›perche‹ barrato 62. Dato] spsc a ›Volto‹ barrato 63. Hai] nel ms. Ha 92.o] su et 93. fuggitivo] nel ms. fuggittivo 121. sopportar] nel ms. soportar 130. a i] nel ms. aii
6. tardi] stai V3 V4 V5 piaceri] piacer falsi V3 V4 V5 7. Anima] O cieca e V3 V4 V5 9.Ei per te tema de l’] Egli paventi del tuo V3 V4 V5 13. Hai fatto contra il vero] Fatt’ haicontra ’l ben proprio V3 V4 V5 17. purgata ben lieta et felice] come purgata peccatrice V3V4 V5 19. In grembo al tuo] Al tuo caro V3 V4 V5 24. quest’aere] quell’aere V3 V4 V5 25.questa] quella V3 V4 V5 28. ’l freddo] l’aspro V3 V4 V5 30. vigne] viti V3 V4 V5 31. fichi iverdi] fichi, verdi V4 V5 33. Questa] Quella V3 V4 42. Con la man di pietà leggera e prestaV3 V4 V5 43. pien d’un amoroso] acceso d’amoroso V3 V5 45. veste] vesta V3 V4 V5 46. letempeste] la tempesta V3 V4 V5 47. irato] profondo V3 V4 V5 54. ti] te V3 V4 V5 60. acciòscorgessi] onde scorgesti V3 V4 V5 64. a laudar] ad honorar V3 V4 V5 65. et] e t’ V3 V4 V566. pensier la nebbia e ’l velo] pensieri il fosco velo, V3 V4 V5 69. mai sempre sta sereno ilCielo] sempre è sereno, e lieto il cielo, V3 V4 V5 71. senton que’ campi estate] provan que’campi o state V3 V4 V5 72. Vaghe] Altre V3 V4 V5 73. ciel bianco e vermiglio il crine] sol illor purpureo crine V3 V4 V5 74. gli odorati gigli] altri odorati gigli V3 V4 V5 75 I fior bian-chi] Altri bianchi V3 V4 V5 76. Coperti] Fior, sparsi V3 V4 V5 77. Più vaghe fan, che dilauri, o di mirti V3 V4 V5 78. Ghirlande a i santi, e gloriosi spirti V3 V4 V5 81. lassù vagheet frondose] fiorite e dilettose V3 V4 V5 83. larghi] lieti V3 V4 V5 84. le piaggie apriche etdilettose] li colli, e per le piaggie ombrose V3 V4 V5 86. o] et V3 V4 V5 89. colei, che tutto’l mondo] Fortuna che i men degni V3 V4 V5 92. scampan] volan V3 V4 V5 96. fa di nubiil Ciel condenso] l’aere è d’atre nubi oscuro V3 V5 (V4 senza è) 97. Né col suo carro d’or sivolge] Col carro d’or non si rivolge V3 V4 V5 102. cinto il crine]’l biondo crine, V3 V4 V5103. vaga] chiara V3 V4 V5 104. quel che fece il Padre di Phetonte] lui, che fece il bel nostroOrizonte V3 V4 V5 108. temenza che licore] temer giamai, che nullo V3 V4 V5 109. Turbigiamai] Possa turbar V3 V4 V5 112. Accese d’un amor dolce e gentile V3 V4 V5 113. Ogn’altolor desio menano a riva V3 V4 V5 114. Ma qual fia che descriva V3 V4 V5 115. O chiuderpossa in carte humano stile V3 V4 V5 120. apregi] appregi V5 130. Viver a lato sempre] Aviver sempre a lato V3 V4 V5 131. ardente] dimessa V5 132. amaro] soave V3 V4 V5 134.di’, Pieno di fede] di’; con piena fede V3 V4 V5
40
Ben potrà di Iesù la greggia humileAndar secura per le piaggie ombrosePascendo l’herbe fresche et rugiadose,Con un’eterno et sempre verde Aprile;
5 Poi che le chiavi del suo caro ovile,Et l’honorata verga in man vi poseColui, che scorge tutte l’opre ascose,
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
303
Saggio pastor a quel primo simile:Homai non fia chi le fontane, o i fiumi
10 Le turbi, o vieti l’ombre, et state, et vernoLieta n’andrà sotto sì fida scorta:Volgete al Re del Ciel, volgete i lumi,
Mirate, com’ ei gode, et si confortaVedendo in vostra man l’alto governo.
12. Ciel, volgete i] cielo i santi V3 V4 V5
41
Versa con l’urna d’or Thebro dal fonteChiare et lucenti le tue turbid’onde,Et coronato di pregiata frondeFa’, che suoni di gioia intorno il monte
5 Le vaghe Nimphe l’honorata fronteCinte de’ lieti fior hor ne le spondeEt hor ne l’acque lucide et profondeDanzino in schiera leggiadrette et pronte;Poi che quei chiari dì tornano a dietro
10 Con lunghi passi, onde n’andasti alteroSovra quanti il gran mar n’accoglie in senoHomai ritorneran col corno pieno
Per honorarti Senna, Istro, et IberoPoi ch’un tuo figlio è successor di Pietro.
42
Poi che Nochier dal sommo Padre eternoEletto sete de la navicellaDi Pietro, che tant’anni in questa, e ’n quellaParte, ha sospinto tempestoso verno,
5 Veggiola già col vostro alto governoVinta ogni forza di maligna stella,Et di sì lunga uscita atra procellaHaver i venti irati et l’onde a scherno;
Giovanni Ferroni
304
Et coronata di novella fronde10 L’ardita prora, entrar nel fido porto
U’ non mai segno di tempesta appare;E i naviganti per le liete sponde
Stanchi dal lungo error gir a diporto,Date l’humide vesti al Dio del mare.
3. tant’] molt’ V3 V4 V5 e ’n quella] e quella V3 V4 V5 9. E con l’ardita prora coronataV3 V4 V5 10. Entrar nel fido et desiato porto; V3 V4 V5 12. E per le sponde la lieta brigataV3 V4 V5 13. Stanchi] Stanca V3 V4 V5
43
Hor vi si pò ben dir Donna beata,Che in questo mondo tempestoso et rio,Volta co gli occhi de la mente a DioVivete vita sì tranquilla et grata;
5 Et con le penne del pensiero alzataLà, dove si finisce ogni desio,Sì come nel terreno almo et natioFelice trappassate ogni giornata;Et l’angeliche squadre ad una ad una
10 Lieta mirando, et le beate gentiSentite a mezzo il cor gioia infinita;O perfetto piacere, o vera vita;
Scorger l’error del Sole, et de la LunaEt star sovra le stelle et gli elementi.
4. Lieta vita vivete et honorata; V3 V4 V5 7. nel] in un V3 V4 V5 10. Lieta mirando]Mirando allegra V3 V4 V5 beate] ben nate V3 V4 V5 13. l’error] gli error V3 V4 V5
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
305
APPENDICE 2
Nota al testo
Si trascrive il contenuto delle cc. 95r-96v di P che conservano il frammento de-gli excerpta dal De amore di Marsilio Ficino letto nell’in-quarto degli opera omnia diPlatone stampati a Basilea da Froben di cui si riportano, a fronte, i passi corrispon-denti. Il riferimento di Tasso al numero di pagina dell’antigrafo ne rende possibilel’identificazione. Lo stato frammentario degli excerpta è evidente a c. 96v in cui l’ul-timo appunto del Tasso resta incompleto; le successive cc. 97r-v sono bianche. Circala possibilità di datare gli appunti tassiani, si consideri che l’editio princeps, da cui sicita, è quella degli Omnia divini Platonis opera traslatione Marsili Ficini, emendationeet ad graecum codicem collatione Simonis Grynaei, Basileae in officina Frobeniana an-no MDXXXII; il volume sarà però ristampato, sempre da Froben, anche nel 1539 epoi altre volte nel corso del Cinquecento. Sebbene non si possa escludere l’uso dellaprinceps da parte di Bernardo, si dovrà però ricordare che numerose postille sue e delfiglio Torquato occupano i margini d’un esemplare della ristampa del 1539 [cfr. G.Arbizzoni, Bernardo Tasso, cit., p. 350 e M.T. Girardi, In margine a un postillato tas-siano dell’«Ars poetica» di Orazio, in E. Bellini, M.T. Girardi, U. Motta (a cura di),Studi di letteratura italiana in onore di Claudio Scarpati, Milano, Vita e Pensiero,2010, pp. 299-331: 301].
La numerazione progressiva della prima colonna di sinistra è assente in P ed èintrodotta per consentire un rinvio più semplice agli appunti tassiani. Nella trascri-zione di P si riproducono, senza correzioni o normalizzazioni, la grafia e la punteg-giatura ma si sciolgono tacitamente le numerosissime abbreviazioni – con la sola ec-cezione di quelle nei marginalia e di quelle con cui Tasso indica il rinvio al luogo deltesto e della frobeniana. Lo stesso criterio conservativo è stato adottato anche per latrascrizione del testo a stampa del De amore anch’esso riprodotto sciogliendo le ab-breviazioni presenti. Nella colonna a fianco dei passi trascritti si fornisce l’indicazio-ne topografica: per P si rinvia alla carta, per la stampa alla suddivisione interna del-l’opera ficiniana indicando in numeri romani l’oratio e con la cifra araba il capitolo.
306
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
307
PEx Conuiuio Diui Platonis collecta
in Phedri orationem
Omnia divini Platonis opera, Basilea, Froben, 1532
Commentarium Marsilii Ficini Florentini in Convivium Platonis de amore
1 95r Fruimur pulchritudine animi menteuisu et auditu non ceteris sensibus,igitur his tribus uenabimur pulchri-tudinem et per eam quae uocibu-sque corporibusque elucet tanquamper uestigia quaedam animi deco-rem inuestigabimus / paga 375.
I, 4 At nos ea parte fruimur, qua cogno-scimus, cognoscimus Mente, uisu-que et auditu. His itaque fruimur,caeteris sensibus non pulchritudine,quam desiderat amor, sed quouisalio potius quo corpus indiget, uti-mur. Igitur his tribus uenabimurpulchritudinem: et per eam quae inuocibus corporibusque elucet, tan-quam per uestigia quaedam animidecorem inuestigabimus.
2 Vbi corpus quidem pulchrum ani-mus minime tamquam ombratilemet fluxam imaginem pulchritudinisleuiter diligamus 375
Et ubi corpus quidem pulchrum,animus minime, tanquam umbrati-lem et fluxam imaginem pulchritu-dinis uix et leuiter diligamus.
3 Vbi solus animus pulcher stabilemhunc decorem animi ardenter ame-mus. 375
Vbi solus animus pulcher, stabilemhunc decorem animi ardenter ame-mus.
4 Nel margine: e c. iiij° 375Vbi uero vtraque pulchritudo con-currit vehementius admiremur
Vbi uero utraque pulchritudo con-currit, uehementius admiremur
5 Nel margine: e capit 2°/376Necessario enim est bonus amorcum a bono natus reuertitur in bo -num et totum illum caput secon-dum uide
II, 2 Amor circulus est bonus à bono inbonum perpetuo reouolutus. Neces-sario enim bonus est amor cum àbono natus Reuertatur in bonum.
6 Nel margine: Diffinit Pulchr.Pulchritudo est splendor diuinae bo-nitatis cap. 2° pag. 376
II, 3 PVLCHRITVDO EST SPLENDOR DIVI-NAE BONITATIS et Deus est centrumquattuor circulorum.
7 Corpora enim animarum mentium-que ombra et uestigia sunt eodemcapit.
Corpora enim, animarum mentium-que umbrae et uestigia sunt. Vmbrauero et uestigium figura eius, cuiusumbra est, et uestigium refert.
8 Bonitas si quidem rerum omniumunus ipse est Deus per quem cunctasunt bona eodem
Bonitas siquidem rerum omniumunus ipse est deus, per quem cunctasunt bona.
Giovanni Ferroni
308
9 Pulchritudo autem Dei radius est Pulchritudo autem dei radius
10 Amor in uoluptatem a pulchritu-dine desinit Amor circulus est bonusa bono in bonum perpetuo reuolu-tus cap 2° pag. 376
II, 2 Amor igitur in uoluptatem à pulchri-tudine desinit. Id sibi uoluit Hierotheiet Dionysij Areopagitae hymnus illepraeclarus: ubi sic hi theologi cecine-runt. Amor circulus est bonus à bonoin bonum perpetuo reuolutus.
11 Centrum unum omnium Deus estcirculi quattuor circa id assiduereuoluti Mens, anima, Natura, etMateria, eodem
II, 3 Centrum unum omnium Deus est.Circuli quatuor circa id assiduereuoluti, Mens, Anima, Natura, Ma-teria.
12 Theologi Bonitatem in centro, Pul-chritudinem in circulo posuerunt eocapit.
NEQVE ab re theologi ueteres, Boni-tatem in centro, pulchritudinem incirculo posuerunt. Bonitatem inqvamin centro uno; In circulis autem qua-tuor, Pulchritudinem.1
13 Quoniam humana Cognitio a sen-sibus oritur per ea quae in corpori-bus praestantiora videmus diuinaiudicare sepe numero consueuimuscapi. iiij pag. 378
II, 4 Quoniam humana cognitio à sensi-bus oritur: per ea quae in corporibuspraestantiora uidemus, diuina iudi-care saepenumero consueuimus
14 Vere namque res idee rationes, et se-mina sunt corporum uero formaeombrae rerum potius quam res esseuidentur eo. cap.
Verae nanque res, ideae, rationes, etsemina sunt: Corporum uero for-mae, umbrae rerum potius quamuerae res esse uidentur.
15 95v Pulchritudo est actus siue radiusinde idest a Deo per omnia pene-trans Primo in angelicam mentem,secundo in animam totius et reli-quos animos, Tertio in naturamQuarto in materiam CorporumMentem idearum ordine decorat,animam rerum serie complet, Natu-ram fulcit seminibus Materiam For-mis exornat cap. V° 378
II, 5 Pulchritudo actus quidam siue ra-dius inde per omnia penetrans:Primo in angelicam mentem: Se-cundo in animam totius et reliquosanimos: Tertio in naturam: Quartoin materima corporum. Mentemidearum ordine decorat: animam ra-tionum serie complet: naturam ful-cit seminibus: Materiam formisexornat.
1 Nel testo della stampa precede 11.
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
309
16 Nel margine: Comparatio. eo. cap.Quemadmodum solis radius unuscorpora quattuor ignem aerem ac-quam et terram illustrat sic unus Deiradius mentem, animam, naturam,materiamque illuminat
Quemadmodum uero solis radiusunus corpora quatuor, ignem, aerem,aquam, terramque illustrat: sic unusdei radius mentem, animam, natu-ram, materiamque illuminat.
17 Quicunque in quattuor elementisinspicit lumen solis ipsius aspicit ra-dium perque ipsum ad supernamsolis lucem intuendam conuertiturita quisquis decorem in quattuoristis mente, anima, Natura, et cor-pore contemplatur amatque Dei ful-gorem in his, perque fulgoremhuiusmodi Deum ipsum intuetur etamat eo. cap.
in his quatuor elementis quicunquelumen inspicit, solis ipsius aspicit ra-dium: perque ipsum ad supernamsolis lucem intuendam conuertitur.Ita quisquis decorem in quatuoristis, mente, anima, natura, corporecontemplatur, amatque, dei fulgo-rem in his, perque fulgorem huiu-smodi Deum ipsum intuetur etamat.
18 et totum caput sequentem pag. 378qui incipit Hinc efficitur ut corporisnullius aspectu uel tactu amatorisimpetus estinguitur non enim cor-pus hoc, aut aliud desiderat sed su-perni lumine splendorem percorpora refulgentem admiratur af-fectat et stupet. et cetera LEGE.
II, 6 HINC efficitur ut corporis nulliusaspectu uel tactu amatoris impetusextinguatur. Non enim corpus hocaut illud desiderat: sed superni lu-minis splendorem per corpora re-fulgentem admiratur, affectat, etstupet.
19 Sed diuinitatis fulgor ille in formosisemicans quasi Dei simulacrumamantes obstupescere contremiscereet venerari compellit c. vi pa. 378
Sed diuinitatis fulgor ille in formosisemicans quasi dei simulacrum aman-tes obstupescere, contremiscere, etuenerari compellit.
20 Gaudent simul et suspirant amantesSuspirant quod seipsos amittuntquod perdunt, quod perimunt,Gaudent quod in melius quiddamse transferunt eo. cap.
Fit etiam ut amore illaqueati uicissimsuspirent et gaudeant. Suspirantquod seipsos amittunt, quod per-dunt, quod perimunt. Gaudent quodin melius quiddam se transferunt.
21 Nel margine: ComparatioCalent vicissim et frigent instareorum quos tertiana febris inuaditMerito frigent quia calorem propriodeseruntur, nec non et calent cumsuperni radij fulgoribus accendantureo ca.
Calent quoque uicissim et frigent:instar eorum, quos tertiana febrisinuadit. Merito frigent: quia caloreproprio deseruntur: nec non et ca-lent, cum superni radij fulgoribusaccendantur.
Giovanni Ferroni
310
22 Frigiditatem timiditas, caliditatemaudatia sequitur ideo timidi et auda-ces apparent eo ca.
Frigiditatem timiditas: caliditatemaudacia sequitur. Ideo timidi quo-que uicissim et audaces apparent.
23 Hebetissimi praeterea quique acu-tiores amando redduntur Quis enimcelesti radio aspirantur non acutis-sime uideat. eo. cap.
Hebetissimi praeterea quique acu-tiores amando redduntur. Quisenim caelesti radio aspirante, nonacutissime uideat?
24 Duplex est Venus una in intelligentiailla quam in mente angelica posui-mus altera Venus uis generandi ani-mae mundi tributa: Vtraque suisimilem comitem habet amorem, illaenim amore ingenito ad intelligen-dam Dei pulchritudinem rapitur,haec item amore suo ad eandem pul-chritudinem in corporibus pro-creanda illa diuinitatis fulgorem in seprimum complectitur Deinde huc inVenerem secundam traducit, Haecfulgoris illius scintillas in materiammundi transfundit capi VIJ pa. 379
II, 7 Denique ut summatim dicam, du-plex est Venus. Vna sane est intelli-gentia illa quam in mente angelicaposuimus. Altera uis generandi ani-mae mundi tributa. Vtraque sui si-milem comitem habet amorem. Illaenim amore ingenito ad intelligen-dam dei pulchritudinem rapitur.Haec item amore suo ad eandempulchritudinem in corporibus pro-creandam. Illa diuinitatis fulgoremin se primum complectitur: deindehunc in Venerem secundam tradu-cit. Haec fulgoris illius scintillas inmateriam mundi transfundit.
25 96r Scintillarum huiusmodi singulamundi corpora, pro captu naturaespeciosa uidentur Horum speciemcorporum humanus animus peroculos percipit eo. cap
Scintillarum huiusmodi praesentiasingula mundi corpora, pro captunaturae, speciosa uidentur. Horumspeciem corporum humanus ani-mus, per oculos percipit.
26 Quomodo Amor seu desideriumpulchri oriuntur in nobis2
27 Cum primum humani corporis spe-cies oculis nostris offertur mens no-stra quae prima in nobis Venus esteam tanquam diuini decoris imagi-nem ueneratur et diligit perque hancad illum saepenumero incitatur Visautem generandi quam est secundaVenus formam generare huic simi-lem concupiscit vtrobique igitur
Cum primum humani corporis spe-cies oculis nostris offertur, mens no-stra quae prima in nobis Venus est,eam tanquam diuini decoris imagi-nem ueneratur et diligit: perquehanc ad illum saepenumero incita-tur. Vis autem generandi, secundaVenus, formam generare huic simi-lem concupiscit. Vtrobique igitur
2 La notazione di P non trova corrispondenza nel capitolo 7 della seconda oratio del De amore: sitratta di un titolo autonomamente premesso dal Tasso al passo 27.
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
311
amor est ibi contemplande hic gene-randae pulchritudinis desideriumAmor uterque honestus atque pro-bandus, Sed si quis generationis aui-dior contemplationem deserat autgenerationem praeter modum cumfoeminis uel contra naturae ordi-nem cum masculis prosequatur autformam corporis pulchritudinianimi praeferat his utique dignitateamoris abutitur / etc. usque in fineeo. ca.
amor est. Ibi contemplandae, hic ge-nerandae pulchritudinis desiderium.Amor uterque honestus atque pro-bandus. Vterque enim diuinamimaginem sequitur. Quid igitur inamore Pausanias improbat? Dicamequidem. Siquis generationis auidiorcontemplationem deserat, aut gene-rationem praeter modum cum foe-minis, uel contra naturae ordinemcum masculis prosequatur, aut for-mam corporis pulchritudini animipraeferat, is utique dignitate amorisabutitur. hunc amoris abusum uitu-perat Pausanias. Quo qui recte uti-tur, corporis quidem formamlaudat: sed per illam, excellentioremanimi mentisque et dei speciem co-gitat, eamque uehementius admira-tur, et amat. Generationis autem etcongressus officio eatenus utitur,quatenus naturalis ordo legesqueciuiles à prudentibus statutae prae-scribunt. De his diffusius Pausanias.
28 AMATORIS diffinitio secundum Pla-tonem in cap. viij pa. 379. qui inci-pit Vos autem amici hortor etc.
II, 8 VOS autem amici hortor et obsecro,ut amorem rem profecto diuinamtotis uiribus complectamini, nequeuos illud deterreat quod de amantequodam Platonem dixisse ferunt.Ille, inquit, amator animus est pro-prio in corpore mortuus: in alienocorpore uiuens.
29 Qui non amat amantem homicidiireus est habendus
Qui uero non amat amantem, ho-micidij reus est habendus.
30 O felicem vitam amatoris quamduae uitae sequuntur O mirumcommercium quo quis se ipsum tra-dit pro alio nec habet nec habere sedesinit etc. Eo. capite.
O felicem mortem quam duae vitaesequuntur. O mirum comercium:quo quis seipsum tradit pro alio, nechabet, nec habere se desinit.3
3 Nel testo della stampa precede 29.
Giovanni Ferroni
312
31 Superbiam Causam fuisse dicit [var.imm. di >vt ai< barrato] Aristophanesut animus qui natus est integer seca-retur id est ex geminis luminibus al-tero posthac vteretur alterum ueronegligeret: Hic in corporis barathrumceu letheum flumen imersus, suique-met ad tempus oblitus sensibus et li-bidine quasi satellitibus et Tirannoraptatur: Verum adulto corpore, pur-gatis sensuum instrumentis confe-rente doctrina paulum resipiscit ubinaturalis emicat fulgor naturaliumquererum ordinem indagat qua inuesti-gatione Architectum ingentis huiusmachine aliquem esse persentit eumet uidere cupit et possidere / Ille solodiuino splendore conspicitur ideomens propriae lucis indagine ad diui-nam lucem recuperandam vehemen-tissime instigatur / Instigatio ueroappetitioque huiusmodi uerus estamor quo duce dimidium hominis al-terum, alterum eiusdem concupiscit/ Quia naturale lumen quod animidimidium est lumen illud diuinumquod alterum eiusdem dimidium di-citur [var. imm. di >concupiscit< ed>est< barrati] olim neglectum accen-dere rursus in animo nititur ca. V. 385
IV, 5 HANC plane superbiam causamfuisse Aristophanes ait, ut animusqui natus est integer, secaretur, id estex geminis luminibus altero posthacuteretur, alterum uero negligeret.Hic in corporis barathrum ceuletheum flumen immersus, suique-met ad tempus oblitus, sensibus et li-bidine, quasi satellitibus et tyrannoraptatur. Verum adulto corpore, pur-gatis sensuum instrumentis confe-rente doctrina, paululum resipiscit:ubi naturalis emicat fulgor, natura-liumque rerum ordinem indagat:qua inuestigatione architectum in-gentis huius machinae aliquem essepersentit: eum et uidere cupit et pos-sidere: ille solo diuino splendoreconspicitur. Ideo mens propriae lucisindagine ad diuinam lucem recupe-randam uehementissime instigatur.Instigatio uero, appetitioque huiu-smodi uerus est amor: quo duce di-midium hominis alterum, alterumeiusdem dimidium concupiscit, quianaturale lumen, quod animi dimi-dium est, lumen illud diuinum quodalterum eiusdem dimidium diciturolim neglectum accendere rursus inanimo nititur
32 96v Liuor abest a diuino Choro Quumenim omnium iucundissimum sit reamata potiri, quilibet in eo potiundoquod amat contentus plenusqueuiuit et totum caput .vj. pagina 386.
IV, 6 Ideo liuor, ut Plato inquit in Phaedro,abest à diuino choro. Cum enim om-nium iucundissimum sit, re amatapotiri: quilibet in eo potiundo quodamat contentus plenusque uiuit.
33 BEATI DiffinitioBeatus est cui nihil deest et est abomni parte perfectus: Perfectioautem est duplex et exterior: Interio-rem bonitatem exteriorem pulchri-tudinem dicimus: cap. j° 386
V, 1 Beatum in Philebo Plato uult esse,cui nihil deest: idque esse illud quodsit ab omni parte perfectum. Estautem perfectio interior quaedam,est et exterior. Interiorem, bonita-tem: exteriorem, pulchritudinem di-cimus.
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
313
34 Virtus etiam animi decorem quen-dam prae se ferre uidetur in uerbis ge-stibus operibus honestissimum [honc- spc a >mode< barrato] eo. ca.
Virtus etiam animi decorem quen-dam prae se ferre uidetur in uerbis,gestibus, operibus, honestissimum.
35 Bonitatis florem esse pulchritudi-nem uolumus, cuius floris illecebrisquasi esca quadam latens interiusbonitas allicit intuentes. eo capite.
Quo circa bonitatis florem quendamesse pulchritudinem uolumus: cuiusfloris illecebris, quasi esca quadam,latens interius bonitas allicit intuen-tes.
36 Nel margine: ComparatioVt flores arborum seminibus orti se-mina ipsi quoque producunt, itaspeciem hanc bonitatis florem ut exbono pullulat
arbitror, tantum inter bonitatem etspecie, quantum inter semen et flo-sculum interesse: atque ut flores ar-borum seminibus orti semina ipsiquoque producunt: ita speciem hancbonitatis florem ut ex bono pullulat
37 Visus in sublimi parte corporis uelutignis in suprema mundi regione lo-catur et lumen natura sua percipitquod ignis est proprium ca. 2° 387
V, 2 Visus in sublimi parte corporis uelutignis in suprema mundi regione lo-catur, et lumen natura sua percipit,quod ignis est proprium.
38 Atque haec ipsa seu uirtutis seu fi-gurae, seu uocum gratia quae ani-mum per rationem uel uisum uelauditum ad se uocat et rapit pulch-ritudo rectissime dicitur eo. cap. 388
atque haec ipsa seu uirtutis, seu fi-gurae, siue uocum gratia quae ani-mum per rationem uel uisum uelauditum ad se uocat, et rapit, pulch-ritudo rectissime dicitur.
39 Pulchritudo est splendor diuini uul-tus ca. iiij° 389
V, 4 PVLCHRITVDO EST SPLENDOR DIVINIVVLTUS
40 Nel margine: bHinc efficitur ut diuini uultus illiuscandorem in se perpetuo Enitentemnon prius animaduertat quamadulto iam corpore et ratione exper-gefacta Dei uultum in dei machinarefulgentem et oculis manifestumcogitatione consideret Qua quidemcogitatione prouehitur ad eum quiintus emicat intuendum eo. ca.
Hinc efficitur ut diuini uultus illiuscandorem in se perpetuo enitentem,non prius animaduertat, quàmadulto iam corpore, et ratione exper-gefacta dei uultum in dei machinarefulgentem, et oculis manifestumcogitatione consideret. Qua quidemconsideratione prouehitur ad eum,qui intus emicat, intuendum.
41 Nel margine: aDivina potestas omnia superemi-nens statim a se natis angelis et ani-mis suum illum radium in quo
DIVINA potestas omnia superemi-nens statim à se natis angelis, atqueanimis suum illum radium, in quofoecunda uis inest omnium crean-
Giovanni Ferroni
314
4 Nel testo della stampa precede 40.
foecunda uis inest omnium crean-dorum tanquam filijs clementer in-fundit. eo. ca. in p°.
dorum, tanquam filijs clementer in-fundit.4
42 Amamus hominem cum in illo per-spicue diuini splendoris scintillamrefulget ca. V 390 [var imm. di >oca390< barrato]
V, 5 Vbi particularis amor ad particula-rem pulchritudinem nascitur. Sic etad hominem aliquem ordinis mun-dani membrum afficimur: praeser-tim cum in illo perspicue diuinidecoris scintilla refulget.
43 Affectus huiusmodi duabus ex causisnascitur tum quia paterni uultusnobis placet imago, tum etiam quiahominis apte compositi species et fi-gura cum ea humani generis rationequam animus noster ab omniumauctore suscipit et
Affectus huiusmodi duabus ex causisnascitur: tum quia paterni uultusnobis placet imago: tum etiam quiahominis apte compositi species, etfigura, cum ea humani generis ra-tione, quam animus noster ab om-nium autore suscipit, et retinet,aptissime congruit.
APPENDICE 3
Nota al testo
Si pubblica di seguito il testo dei sette sonetti spirituali conservati nel ms. ChigiL.IV.79 della Biblioteca Apostolica Vaticana; per la sua storia, la descrizione del te-stimone e la tavola delle liriche rinvio a F. Carboni, La prima raccolta lirica datata diVittoria Colonna, in «Aevum», LXXVI, 3, 2002, pp. 681-707. Come minima inte-grazione del contributo di Carboni, aggiungo che la filigrana presente in tutte le cc.del fascicolo recante le liriche della Colonna e ben visibile a cc. 337-338 raffigurauno “scudo metà capriolato a due pezze e metà vuoto posato sopra il dorso di un lu-po e posto entro un cerchio” (A. Zonghi, Le marche principali delle carte fabrianesidal 1293 al 1599, Fabriano, Tipografia Gentile, 1881, p. 106). Il tipo è quindi simi-le agli esempi proposti da Zonghi (cfr. ivi, tav. 125) e da D. Woodward (Catalogue ofWatermarks in Italian printed Maps ca. 1540-1600, Firenze, Leo S. Olschki, 1996,pp. 135-136, nn. 221-223), ma ne differisce per l’assenza di stella o corona che lìsormonta i cerchi e per la datazione che entrambi gli autori collocano agli anni ’60-’70 del Cinquecento.
Trascrivo il testo dal ms. sciogliendo tacitamente le abbreviazioni, riconducen-do all’uso moderno la suddivisione della parole, l’alternanza di u e v, di i e j, lemaiuscole, l’uso di h, dei diacritici e della punteggiatura. Fra parentesi uncinate in-dico le integrazioni.
Accanto all’indicazione della carta del chigiano indico la numerazione dell’ed.Bullock delle Rime della Colonna (Roma-Bari, Laterza, 1982) cui rimando ancheper le varianti successive e il complesso della tradizione manoscritta e a stampa.
315
(c. 325v = S1, 24)Sonetto 33 della Marchesa: del Venerdì Santo.
Gl’angioli eletti a quel ben infinitobraman oggi soffrir penosa morte,perché l’alta1 et luminosa corte,non sia più il servo che ’l signor gradito;piagne, la nostra matre, il gust’ arditoch’a figli soi del ciel chiuse le portee che le man piagate or fieno scorteper ridurce al cammin da lei smarrito;ascond’il sol la sua fulgente chioma,spezzans’i sassi vivi, aprons’i i monti,trema la terra ancor, turbans‹i› l’acque,piangeno i spirti2 a’ nostri danni prontidelle catene lor l’aggiunta soma,l’omo non piange et pur piangendo nacque.
(c. 333v-334r = S1, 99)2Sonetto 58
Le nostre colpe han mosso il tuo furoregiustamente, Signor, nei nostri danni,ma se l’offese avanzan li affannide assai la tua bontà vince ogni error‹e›.Chiede merciè ciascun, carco d’orrore,deposta la superbia di ricchi panni;non fe’ raggion il lungo volger d’anniquel ch‹e›’l divin iuditio in sì poch’ore:vede’l passato mal, piange el presente,del futur teme et più il supplicio eternoche tal vita tal premio al fine apporta.Scorga il bel raggio tuo la cieca gente,sent’il remedio del tuo amor superno,apri ormai di pietà l’immensa porta.
Giovanni Ferroni
316
1 Il ms. legge altra.2 Il sonetto è preceduto, sempre a c. 333v, dalla trascrizione di nove versi dello stesso testo poi
cancellata perché ai vv. 1-7 sono fatti seguire i vv. 11-12.3 Il ms. legge spiriti dando un verso ipermetro.
(c. 334v = S1, 88)Sonetto 60
Signor, ch’in quella inacessabil luce,quasi in alta caligine, t’ascondi,ma viva gratia et chiari rai diffondidal specchio eterno ov’ogni ben riluce,principia il tutto e al suo fin conduce4,un solo cenno tuo, qual mille mondipotria far e disfar, che nei profondiabissi in terra e in ciel sei vero duce:risguarda me, ti prego, in questo centroterrestre afflitta e, con l’ardor che suole,la tua bontad’al mio martir provegga.Pon l’alma ormai tant’al tuo regno dentro,ch’almen lontan la scaldi tuo gran solee da vicin quel picciol mio rivegga.
(c. 341r = S2, 25)Sonetto 85
Beata lei ch’eterno amor accese,ma con divino strale e celest’arco,con pura face, allor ch’al sacro varcol’indusse dal suo chiaro almo paese!Suave il laccio fu ch’i spirti preseper dargli libertà; felice incarcoche di peso mortal l’ha sì al cor scarco;piaghe ch’alla salute all’alma rese;lagrime che lavar l’animo insanodi venenosa scabia; ardor beatoche d’altro incendio poi la asicura.Distesa ai santi pie’, possente manola tirò in Cielo: oh vero amante gratoche no ’l5 merto di noi, m’al cor misura!
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
317
4 Emendo, sulla sorta di Rime 1538 (cfr. ed. Bullock, p. 258), il ms. che legge el suo fin o duce.5 Il ms. legge non l.
(c. 343r = S1, 86)Sonetto 93
Guarda l’alto principio onde deriva,anima, l’esser nostro e vedrai bene che quagiù ti mandò con quella spenedel cui gran frutto il proprio error ti6 priva.Sei presso ove si paga a l’altra rivadi eterna gloria o ver di eterne pene,come qui fuste o volta alle Syrenefalse del mondo o di lor canto schiva.Deh, fa che non ti7 volgan le secondeda la prima caggion, onde il disegnodivin s’offenda da mortai colori;non sottragge sua grand’ira né ascondela bella luce ad umil petto sdegnoQuanto emenda il pentir li nostri errori.
(c. 347v = S1, 139)Sonetto 104
Le tante opre divine, el gran imperoin terra e in ciel del nostro eterno sole,scrisser quei santi in simplici paroleper non giunger, con arte, forze al vero.Mossa da simil fede, e scrivo et speroche, se le lode vostre rare o solequal posso canto et com’ el ver lo vole,non sente sdegno el vostro animo altiero,ché, quasi perla candida ch’in orosottil s’appoggia sì ch’altra vaghezzanon pò impedir la sua più chiara luce,la vostra vera luce, in quell’altezzache merta così ricco e bel tesoro,dentro al mio basso stil sola reluce.
Giovanni Ferroni
318
6 Il ms. legge si.7 Il ms. legge si.
(cc. 350r-v = S1, 23)Sonetto 114
Apra il sen Giove e di sue gratie tantefaccia che ’l mondo in ogni parte abonde,sì che l’anime poi ricche e fecondesien tutte qui di virtù chiare et sante;soave primavera orni et ammantela terra et corran puro nettar l’ondee si vestan di gemme le lor spondee ogni scoglio sia vago diamante,per onorar il giorno aventuroso,il desiato, divin parto elettoche recc’ancor vera salute a noi.Ma a cantar come in veste human’ ascosoVenne l’immortal Dio, discenda poiDa le angeliche squadre il più perfetto.
Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla Canzone all’anima
319