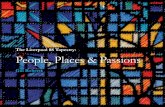Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa and the passions of Usury
Transcript of Basil of Caesarea, Gregory of Nyssa and the passions of Usury
MARCELLO LA MATINA
BASILIO DI CESAREA, GREGORIO DI NISSAE, LE PASSIONI DELL'USURA
Estratto daPAN - Sntdi dell'Istituto di Filologia Latina ,,G.
Monaco,,15-16
PALERMO 1998
MARCELLO LA MATINA
BASILIO DI CESAREA, GREGORIO DI NISSAE LE PASSIONI DELL'USUM
0. Considet azioni preliminari
0.1 Lo studio delle omelie tardoantiche rappresenta una formadi indagine testuale di notevole importanza. Esse infatti non solo ciforniscono preziose informazioni sulle modalità di diffusione de1 mes-saggio cristiano nell'ecumene, ma sovente ci offrono materia per delleriflessioni sugli sviluppi delle forme argomentative, anche in relazionea temi di interesse sociale. Inoltre, l'omelia è luogo d'incontro, e taloradi contrasto , fra valoi appartenenti a sistemi assiologici diversi. Owio,pertanto, che il suo studio resulti importante anche in vista di una mi-gliore conoscenza dei rud0q, ossia di tutte quelle affezioni che qualifi-cano o modificano il rapporto fiduciario tra Enunciante ed Enunciata-rio nonché il 'fare' dei vari attori rappresentati nel testo.
0.2 Le due omelie sull'usura scritte rispettivamente da Basilio diCesarea (Hornilia in partem Psalmi XIV et contra feneratores) e daGregorio di Nissa (Contra usurarios oratio) sono assai interessanti per lostudioso del testo antico (1). Infatti contengono informazioni su un fe-
(1) Per il testo dell'omelia di Basilio facciamo riferimento all'edizione dei Mi-gne (PG XXIX, 264C - 280C); Ieggiamo invece il testo deli'omelia di Gregorio di Nissanella moderna edizione curata da Ernst Gebhardt (Brill, Leiden 1967), contenuta ne1
IX vol. delle Opere di Gregorio di Nissa, pp. l%-207. Fra gli studi sulle nosre omeliesegnaliamo: S. Giet, «De saint Basile à saint Ambroise. La condamnation du prét à in-térét au IVe siècle», in Science Religieuse, )2 (1944), pp.95-128; M. Giacchero, «Aspettieconomici fra III e IV secolo. Prestito ad interesse e commercio nel pensiero dei Pa-dri», in Augustinianun,lT 0.977), pp.2547; R.F. Maloney, «The Teaching of theFathers on Usury. An Historical Study on the Developments of Christian Thinking»,rn Vigiliae Christianae , 27 0973), pp. 24t-265; F. Marconcini, «La illegittimità del pre-stito di moneta a interesse in due omelie del secolo IV», in AA.W., Raccolta di scrittiin memoria di G. Toniolo,Yita e Pensiero, Milano 1929, pp.287J25; O. Schilling,
t32 Marcello La Matina
nomeno sociale evidentemente pervasivo e preoccupante. Ma sonoimportanti soprattutto come fenomeni e prodotti della comunicazione.Le omelie in questione sono la trascrizione (probabilmente manipolata,ma ciò non ne riduce l'importanza) di atti comunicativi realmentecompiuti da un Enunciante socialmente qualificato - il presbitero -dinanzi ad un Enunciatario portatore di una istanza sociale generaliz -zata - l'insieme del pubblico degli uditori. In esse si parla di usura e simettono in scena delle passioni. Alcune fra queste sono connesse allacircolazione di beni economici (l'avadzia,la dissipazione, la bramosiadi ricchezze), altre riguardano la circolazione e la manipolazione di og-getti cognitivi (il vero sapere dell'Enunciante in merito all'usura e Iastrategia argomentativa per comunicare questo sapere all'Enunciata-rio; il contratto fiduciario fra Enunciante ed Enunciatario; infine lacredenza in merito ai <<veri valori>>, contrapposta a una credenza sui«falsi valori>>).
0.1 In questo articolo cercheremo di mettere in luce brevementealcuni caratteri della struttura testuale delle due orazioni. In pafii-colare, dal punto di vista che potremmo dire tematico, vorremmoanalizzarc i riferimenti alla prutic^ dell'usura; dal punto di vtsta ih-morfico (2), cioè della forma del contenuto, vorremmo evidenziarc lasequenza degli stati di cose attraverso i quali il tema. dell'usura vienepei così dire narrativizzato entro le diverse cornici discorsive. Infine,àal punto di vista patemico, vorremmo contribuire a mettere in luce lasceneggiatura dei vari stati d'animo che accompagnano il 'fare' degliattori Greditore/debitore) e dei comunicatori (oratore/pubblico). Dalmomento che la nostra analisi riguarda prevalentemente il piano de1
contenuto testuale, vorremmo servirci - sia pure con una certa li-bertà - di alcune categorie proprie dell'analisi semiotica greimasiana.
1. Il piano tematico el'organizzazione intertestuale
t.L Testi religiosi primari e secondari
Converrà iniziarc con una distinzione. Per quanto concerne i
Reichtum und Eigentum in der altkirchlicben Literatur. Ein Beitrag zur sozialen Frage,
Herder, Freiburg 1908; M. Forlin Patrucco, <<Aspetti di vita familiare nei IV secolonegli scritti dei Padri cappadoci>>, in R. Cantalamessa (a cura di), Etica sessuale e ma'
trimoniale nel cristianesimo delle origini, Vita e Pensiero, Milano 7976,pp. 158-179.(2)Per questo termine e, più avanti, per la terminologia relativa al riferimento
letterario (citazione occulta, menzione, riferimento specifico e generico, ecc.) siamo
debitori verso G. D'Ippolito, L'approccio intertestuale alla poesia. Sondaggi da Vetgilioe dalla poesia uistiana greca di Gregorio e di Sinesio,Ist. Filol. Greca, Palermo 1985, p'28; Id., «Basilio di Cesarea e la poesia greca», in AA.W., Basilio di Cesarea: la sua età
e il Basilianesimo in Sicilia. Atti Congr. Internaz. (Univ. Messina, Fac. Lett., )-6 XII1979), Messina 1983, pp. )09-)79, soprattutto J27 ss.
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
testi religiosi, occorre differenziare i testi primari dai testi secondari.Sono testi primari in una cultura i testi detti anche sacri o canonici;mentre una gran parte dei testi secondari <<non è che un commentariodei testi primari nei quali I'esplicazione o la vahfiazione si fondanoprincipalmente su informazioni tratte dall'insieme dei testi canoni-cil> (r). La definizione di queste due classi di testi presuppone :una fi-gura di autorità che si attribuisce un sapere circa la fiatura dei testi inquestione: dunque presuppone delle strategie interpretative accredi-tate in un dato momento della storia di questi testi. Di conseguenza,proprio perché è legata alla diacronia, la divisione iniziale fra testi pri-mari e secondari non va considerata un fatto statico bensì un eventodinamico, Un testo religioso può ad es. inizialmente far parte di unaraccolta di testi ritenuti canonici, senza essere esso stesso accettatocome canonico; può però divenirlo in un secondo tempo, È il caso dellaLettera agli Ebrei, enffata a far pafie assai presto della raccolta delleepistole paoline (il più antico testimone della raccolta paolina, il pne 6.12OO ca.,la contiene), ma accolta nel canone della Chiesa occidentalesolo nel IV secolo (a).
1.2 Le omelie corrue forme di "edizione"
Le omelie sono testi religiosi secondari e costituiscono nelf in-sieme una forma letteraria tipicamente cristiana (t). Un'omelia è ingenere un testo prevalentemente orale, performato da un parlanteabilitato (= un presbitero) dinanzi ad un uditorio, neIl'ambito di unainterazione rituale condivisa. In essa, tipicamente, un oratore(manifestato o meno attraverso specifiche marche dell'enunciazionee/o attraverso l'assunzione di un simulacro enunciativo) sviluppa unaatgomefltazione basata sulla lettura di altri testi. Alcuni di questi sonostati previamente resi noti (ne11'ambito della medesima circostanzaenunèiativa) all'uditorio mediante un tipo di lettura che è detto pro-clamazione; altri possono essere dall'oratore richiamati alla memoriadell'uditorio attraverso la prassi della citazione o dell'allusione. Pur es-
sendo legata essenzialmente al rito che le fa da cornice, l'omelia tardo-antica viene concepita anche come performance retorica, il cui testoviene quindi conservato e divulgato attraverso la scrittura. Un'esi-
(l)Per questa distinzione vedi J.S. Petòfi, Vers une tbéorie partielle du texte,Buske, Hambwg 1975, p. 121.
(4) K. Aland und B. Aland, Der Text des Neuen Testaments, Deutsche Bibelge-sellschaft, Stuttgart 1982; t. it. di S. Timpanaro, ll testo del Nuouo Testamento, M^-rietti, Genova 1987, p.55.
(5) Sul genere omiletico vedi M. Sachot, «Homilie>>, in Reallexikon fùr Antikeund Cbristentum: Sacltuòrterbucb zur Auseinandensetzung des Christentums mit derantiken Veh,Bd. XVI, Hiersemann, Stuttgart 1994, pp. 148-175.
t3)
134 Marcello La Matina
genza di letterarietà fa dunque Ia sua comparsa in questo tipo di prosareligiosa elevandola a genere letterario. In base alle nostre conoscenze,possiamo collocare la fioritura di un genere omiletico nell'età post-co-stantinana, quando l'omelia seppe mescolare la primitiva attitudineinterpretativo-esplicativa della Sacra Scrittura alle abilità argomenta-tive tipiche delle scuole ellenistiche di retorica (6).
Così concepita un'omelia è per noi anche un tipo di "edizione"di testi, nel senso specificato in un nostro lavoro recente (7). In quellibro si argomentava che tutta quanta la comunicazione può essereconsiderata pervasa da una certa "attitudine filologica", al punto che<<il ruolo di un parlante in una situazione comunicativa può essere as -
similato a quello del filologo che pubblica un testo>> (p. 128). Non sol-tanto nel padare o nello scrivere, ma anche nella lettura o nell'ascoltonoi siamo chiamati a compiere operazioni di rimpiazzamento, che ri-producono, riscrivono, condensano o espandono un qualche testo an-ieriore, udito/letto o semplicemente presente nella memoria. Sicché levarie fasi della produzione di un testo (in questo caso, secondario) pos-
sono essere accostate alle operuzioni editoriali del filologo. Si acquisi-sce il testo primaio (collatio),lo si compara col nostro idioletto(recensio),1o si giudica (iudicium), operando talvolta degli aggiustamenticompensativi ( e rn en datio ne s) .-
È ,rostta opinione che anche nella comunicazione religiosa si ri-trovi questa sorta di attitudine che Contini definì una volta «filologia.o-e éue.rto quotidiano» (s), L'omileta che cita o allude a un testo (aun frammento di testo) effettua infatti una sorta di impiazzamentodelle espressioni di quel testo - solitamente un testo religioso primario
- mediante l'uso di altre espressioni che in un caso servono a riportarepiù o meno letteralmente tale testo (= è questa la cosiddettatraduzione omofonica). In altri casi Ie espressioni timpiazzanti servi-ranno a parafrasare, tradurre, espandere o condensare il testo prima-rio (= tràduzione diafonica). In questo lavoro di timpiazzamento - e
perfino nella più letterale delle citazioni - non tutto rimane immutatoàal punto di vista del significato. Piccoli e grandi smottamenti delr.r.sà hurrrro luogo, che trasformano il testo riprodotto. Dal punto divista testologico,ìl fare dell'omileta può così essere equiparato a quellodi un editorè che 'pubblica' dei frammenti di testo: (a) in un modo perlui accurato (= testo omofonico) e/o (b) in modi che facciano emergerela distanza tra espressioni del testo da riprodurre / paruftasarc /commentare ed espressioni del testo effettivamente riprodotto; in que-
(6) Per quanto concerne gli aspetti pragmatici della oratoria religiosa dei nostriautorisivedaJ. Bernardi, La prédication des Pères Cappadociens. Le prédicateur et son
auditoire, Presses Universitaires de France, Paris 1968.(7) M. La Matina, Il testo antico. Per una semiotica come filologia integrata,
L'Epos, Palermo, 1994.(8) G. Contini, Breuiario di ecdotica, Einaudi, Torino L986, p. ).
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura 1.)5
sto secondo caso l'assenza di accutatezza può perciò essere voluta dal-l'editore, che otterrà un testo diafonico, ossia con delle differenze più omeno incisive rispetto al testo primario. Ya da sé che lo studio dei casidi diafonia è sovente la parte più interessante per iI testologo. Si pensi,p.€s., alla critica delle varianti, la quale può a buon diritto essere con-siderata una analisi del range di diafonia, cioè della differenzialità pre-sente in certi luoghi del testo; owero si pensi, per casi più eclatanti,allo studio delle traduzioni e di qualsiasi forma di riscrittura lettendadi un testo, ove ciò che viene portato in luce è proprio lo spazio, la di-stanza che separa il testo dalle sue vaianti diafoniche.
Normalmente, il modo di 'editare' accurato produce nel testosecondario citazioni di / allusioni a frammenti del testo primario; ilmodo non accurato, cioè diafonico, produce invece commentari del te-sto primario (espansioni, condensazioni, ecc.). Metodologicamente, quiconverrà partire da quelle espressioni del testo secondario che sianopiù vicine ad espressioni del testo primario. Muoveremo perciò daileiitazioni - esplicite od occulte -
per ricavare le unità di senso ele-mentari (= i cosiddetti 'semi'), che costituiscono la base per l'argomen-tazione dei due omileti. Si vedrà al contempo come questi semi sono
organizzati in un percorso sintattico orientato. In un secondo tempo si
vedrà come queste unità si dispongono linearmente in sequenze nar-rative, espandendosi e convertendosi in unità di senso più complesse,di cui si dirà più avanti.
1.3.11 regime intertestuale: citazioni e/o allusioni
In quanto testi religiosi secondari, le omelie mobilizzano la cono-scenza del Destinarte " del Destinatario, attivando un gioco di ri-mandi intertestuali particolarmente pervasivo. Naturalmente, occor-rerà distinguere i rifèrimenti pertinenti al tema globale del testo (che
saranno dàtti riferimenti isotopi, ossia costituenti un livello di senso
omogeneo) dai riferimenti non pertinenti (che saran detti allotopi). LadeciJone spetta all'analista e dipende dalla struttura globale che que-
sti avrà ricònosciuto nei testi in esame. Nel caso delle nostre due ome-lie, ritroviamo almeno le seguenti tre forme di intertestualità: riferi-menti alla Sacra Scrittura, a testi pagati, all'omelia di Basilio da partedi Gregorio.
1.1.1. Riferimenti a frammenti testuali della Sacra Scrittura, che
vengono attualizzati sia attraverso la citazione esplicita o, occulta, sia
,ttràu..ro procedure di espansione tematica (come vedremo sub 2,
analizzando l' organrzzazione narrativa). Concentriamoci sulle cita-zionilallusioni, clie costituiscono il testo primario da cui scaturisce l'o-melia in quanto testo secondario. Raggruppiamo i frammenti di testo
n6 Marcello La Matina
.secondario."portatori" di citazioni e/o allusioni al testo primario nellequattro unità tematiche seguenti:
(a) La pnma unità tematica che possiamo riconoscere nel testoprimario citato nguarda il /prestito usuraio/ e la sua condanna. Basilioha dedicato la sua omelia al Salmo X/V (poco prima letto nella liturgia),nel quale si presenra la figura del giuslo .he - si dice ul ". i -<<presta denaro senza fare usura>>. Il salmo viene citato da Basilio inL2651', con riferimento all'uomo dalla vita salda ('frq <iocrl.eritoo (rofrg):«'TrioypriQrov trD l"6yrp tov réi.erov o rlpoQritrlq, ròv tfrq riool"edtou (c,xlqèrcrprioeoOar pé)"),ovto, èv toìq ovòpcry«0ripaorv mrrlpi0pqoe to croydpr.ovcxòto6 è:rì t6rql pt òo0vor>> (cfr. Ps 14,5); e poi ribadito in 1.2658 (<<Tocxucò to0to ru«peil"r1Qev o tlpoQritrlg, Iéyrr». Tò dpyriprov crutot oòréòrrrrev ènì t6rql» cfr. Ps 14,5).Il credito fenerutizio,il tdxoq, f, se*piÈfortemente condannato in Israele come uno tra i peggiori mali; ondà ilriferimento al frammento di Ezechiele condensaio-in 1.2658: <<.,O teyùp 'Ie(ent1l" èv toìq Lreyi.otorE tdv rardv tiOetar tdrov l"«Beìv rsì nleo-vcropòv>>(e) (cfr. Ezechiel 22, 12). Altri tre frammenri, citati da Basilio,connettono il tema del /prestiro usuraio/ a quello dell'/inganno/:L.2658 «Kcrì rril.rv Qnoi' A6l,oq ènì ò6l.rp, rcrì t6roq ènì t6rq (cfr. Ger. 9,6). In 1..2658 «Our è§é).rrev èr t6v rc),crterdv oòrfrg t6rog rcrì ò6i.o?(cfr. Ps 54, 1,2),la menzione delle <<piazze>>, da cui il /presiito usuraiò/lo-n è allontanato, afiicola nello spazio l'assenza di un rapporto conl'altro, ridotto dall'usura a mero strumento di accumulazione. Nelterzo frammento va notata la condanna dell'ambiguità nei rapporti, il/far credere/ che manipola I'altro, riducendolo ancora una vòlta a fi-gura di <<strumento>> dei propri progetti, Questo è chiaramente dettoda Basilio nel co-testo seguente: 5,280A oroì oi l,éyovteq tò mrpòvyX,rrù, rcxì rò yl"urò nrrpòv (cfr.Is. 5,20), cui aggiunge ciò che segue:rcrì oi qy_ptoaryAp!ù4talv 0rl,uv0porniav xpooaToperjovteg.
Il testo proclamato prima dell'omelia di Gregorio era invecetratto dal libro di Ezechiele. Si tratta del brano in cui il profeta minac -
cia di distruggere la città di Gerusalemme che si è resà colpevole diiniquità e di aver dimenticato il Signore. Gregorio condensa il passo in195, 12 <<'Hrpoc6pe0« toO rupoQritou Qover5ovtog tù po10r1pà t6v òocver-opdtrov térvcr toò6 rdrouq» (cfr. Ezech. 22, l2).In un altro passaggioGregorio applica all'usura l'epiteto che Giovanni Battista adopeiàvaper i Farisei e i Sadducei, "razza di vipere". Rivolto all'usuraio, gli sug-gerisce: 1-96, 11 «Einè toiq noté oou Qrl"tritorg t6rorg tÌ1v 'Irociwou to6pontroroO Qovriv' fevvripoto èròvdv» (cfr. Matth. 3,7).Da notare ilQrfutritorq, che, figurativizzando un legame di affezione fra l'usuraio e il
(9) Quando i termini t6xoq e nl.eovoop6g sono impiegati insieme, il primo parerife_rirsi al prestito di danaro, mentre il secondo va risèrvato al prestito ài prod-ottide1la terra e di altri beni fungibili. Basilio usa J4 volte t6roq e solo I volte zr).eovcrop6q(cfr. S. Giet, art. cit., p. 102).
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
suo oggetto valore, lascia intravedere il tema dell'/avaùzial, passioneche implica accumulazione o ritenzione di beni. Questa prima unitàtematica lega perciò l'usura alla negazione del rapporto con l'altro, fa -cendo emergere il legame privilegiato che il Soggetto usuraio intrat-tiene con l'Oggetto valore. L'eliminazione di ogni forma di rapportointerpersonale a causa della attitudine avaru del fenerator è beÀ-mar-cata in questo passo del profeta Amos, dove il tema del /prestito usu-raiol viene figurativizzato col ricorso alf invettiva verso coloro che cal-pestano il povero e sterminano gli umili del paese: 202,8 «Oi« yo0v ò0eorcéoroq 'Apòq l,éyer' 'Arorio«te, oi èrtpiPovre€ eiq tò npolì névrlrcx roìrcxtu,òtvcroter5ovteq ntoxoùq ènì tt1q yfrq, oi l.éyovteq. n6te òrel.^erloetcn òpfv rcrì èpno)"(oopev;» (cfr. Amos 8,4-5).
(b) La seconda unità tematica è quella che chiameremo del/prestito non-usuraio/. Diversamente dal credito feneratizio, il sem-plice prestito era considerato in Israele una sorta di servizio da ren-dere gratuitamente al vicino (10). In questo secondo gruppo di fram-menti testuali vedremo perciò la negazione del /prestiro usuraio / e ilconseguente spostamento del tema dal rapporto Usuraio -+ Oggetto(dove l'altro come persona scompare) al rapporto fra il prestatore el'<<altro come prossimo>>.
Le figure della «fratellanza>> e della <<prossimità>> sono ben evi-denti nei riferimenti di Basilio, tanto in L.265B «Kcrì o v6poq òrcrpp(ò'qvcr:royoperier Oòr èrtoneìg rrD cròeIOQ oor rcoì tO nÀ.noiov oou>> (cfr.Deut.2),19) quanto in2.269A <<Auveroto0, Qnoi, roì IperoQerLetou «-rccrvtr'locivtrrrv cx)"l"riì,orq, èlnoronfiv alrOotépov nordtsr ò ftprog» (cfr.Prcv.29,13), dove compare - in un contesto forse ironico - il temaveterotestamentario della eguaglianza nella diversità dei ruoli. Evi-dente è pure,il tema del /prestito non-usuraio/ come servizio gratuito,enunciato in 1.265C «'O pèv o6v KrSprog èvopyCoq rjpiv òretd§oto, i.éyrr»'Kcì tòv Oé),ovts srò oo0 òcrvetooo0cn pt1 orootpaOfq», (cfr. Matth.5,42) e ripreso in 5.280C «Mrite o8v tòv Oéì"ovtcx Ecrveiocro0cn sno-otpcrQfrq» (cfr. Matth. 5,42).
Quest'ultimo versetto è riportato anche nel testo di Gregorio(196, 20 <<Kcrì tòv 0él"ovtcr òcrvetocroOcn pfi cxrootpoQfg» cfr. Matth.5,42), ove si fa riferimento al /prestito non-usuraio/ come a un gestoconforme al dettato divino: 206,17 <<"Efierro roì rò òcrvei(erv noporcrl"d(...), roreiv òè to0to pì petù t6ro» pr1òà nl,eovgopdv, dl"l"à r«0òg rjptvo Odog òietd(crto l"6yog» (cfr. Luca 6, )5). In più, però, i riferimentibiblici di Gregorio introducono un secondo elemento di carattere pas-sionale: la /paiienza/. È infatti facendo ricorso alla pcrrpoOopio che i'o -
ratore può dire: 201,4 «'Eav òcrveiolq «ipyr5prov tr! <iòe),Qri oou, oòr éon
t)l
2116 s.
(10) Cfr. A. Bernard, <<Usure>>, inDictionnaire de Théologie Catbolique, XV, col.
B8 Marcello La Matina
oòtòv rcrtemeiyrov>> (cfr. Exod. 22,24). Ma si veda anche il contesto se-guente, dove il tema delia porpoOrpi.cx conclude una successione di ci-tazioni:204, l0 «ut1eg vdpov npoQ(tog eocryyelrrù :ropoyyé),pcrtcx' rcivtrov(roreg opo6 Boolvt<r» prQ Srovf tfiv ayarrrlv, tfiv Qrl"crv0pronicrv rcrì t6vpèv Ley6vtcrlv' Orr èrtorrd.€ t«0 dòe1,06 oou (cfr. Deut. 2),20) , t6v òé'Tò crpyriprov oùr éErorev ènì t6rro (cfr. Ps. 14,5), ct),Lrr»' 'Eùv òuveiorlqtQ cròeÀgQ ooo, oùr éoT crùtòv roterueiyrov>> (cfr. Exod. 22,25). Vederel'altro come <<prossimo>> comporta una sorta di reciprocità (la OtL,*crv0p<onicr), quale quella evocata nel seguente riferimento al Pater No-ster 20), 13 «"AQeq flpiv tà òqerl.ripcxto npdv, òq rcrì riU"dg crQrixcrpev
toìq òQerÀetcnq rjpdv» (cfr. Matth. 6, 12) . (Citazione riproposta in 201,16Koì dQeg t'1piv tù oQer).ripoto rip6v, ra0òq rcrì rlpetg tiqrjrupev toiq ò-gerLetorg qp6v (cfr. Matth.6,72).
(c) La terua unità tematica è quella del /condono/, attivato dalriconoscimento della appartenenza dei due soggetti (creditore e debi-tore) ad un medesimo universo assiologico, Qui è presente non solo la«prossimità» (che è pur sempre una relazione orizzontale), ma anchela /comune iponimia/, ossia la subordinazione ad una figura di ipero-nimo comune (= ssrvi di uno stesso padrone, figli di uno stesso padre,discepoli di uno stesso maestro, eredi di uno stesso Regno, ecc.).
Basilio evoca chiaramente questa <<co-iponimia>> attraverso le fi-gure della <<pietil> e del <.prestare aDio>>:5.277C 'o yàp èi,e6v ntrolòvòcrvei(er @ed (cfr. Prov. 19,77). La stessa logica crematistica è trasfigu-rata dall' éXeog, e il prestito, privato della speranza di restituzione, di-viene un dono: 5.217C Aovei(ete ncrp' 6v oùr è}"rci(ete crno)'opdv (cfr.
Lleica 6,34-5). E ancora, con un più esplicito riferimento alla figura del/condono/: 2Ol, 8 Koì ei òovei(ete, nap' drv è)unile'ce crro),apeiv..' lscil.<<noiu rpiv lriprq;»l (cfr. L,tca6,35).
Sapere di essere co-iponimi di uno stesso Padre rende possibile1'abbandono dei legami terreni per diventare co-eredi della vitaeterna. Così il tema appare in Gregorio 1.99,15 «flétpoo yop èprot6vtoqruì À,éyovtoq' 'IEoò t'1pdq crqrirapev rc<ivto rcrì r'1rol,otOriocrpév oou ticipcr éotor t'1piìv; opilv l"éyco ùpriv, Qr1oi, n&q, 6onq crQfrrev oiric4 r'i &òel,-
Qoòq n dròetQùq ri ruotép« r'l pqtépcx fi pvo0rcr 11 térva ri oyporig, àra-tovtorl,cxoiovcx l,rivetm rcrì (oìv slowov rl,qpovop{oer» (cfr. Matth. 19,
27 -8). Sempre Gregorio contrappone come contraria alla Qtl,cxv0pr»nicrcristiana la Qr),opyupiapruticata dagli usurai: 198, 10 « IIpòq toùvocvtiovro0 dnootohro0 yprippotoq relprlpévov tr| Pirp, nolvru òròdvtcr toiqcrioiooorv oo òrò Or)"dv0pronov yvrrlptlv, cn 1"à òrà 0rldpYopov tp6rov»(cfr. Matth. 5, 42?).
(d) La quarta unità tematica è quella della mancanza di con-dono, del /non-condono/, che, negando la rclazione di co-iponimia, ri-porta l'altro ad una figura di <<estraneo>>. Questo tema è ben sviluppato
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
nelle citazioni scelte da Gregorio. Questi menziona per ben due volteLaparubola del servo spietato (Matth. 78,23-35). Le due menzioni evo-cano la figura di un servo che rifiuta di condonare un piccolo debitoad un suo co-iponimo, un or5vòor},oq appunto, dopo che il padrone dientrambi ha condonato proprio a lui una somma enorme. L'unità te-matica del /non-condono/ agisce perciò come negazione della yiprq etrasforma l'altro in un <<estraneo>>. Vedi 201, 9 «'Ev nopaBol,fr tòvor),r1pòv olrétr1v mrp6q roki(oooa, òq tQ òpoòori)"rrl npooruvo0vtr oòràrerl.rio0n oròb gOfrrev èrcrtòv òqv«pirov eòtel"bq Xpéoq crD(o6 tdv popi,rovts),civtrrlv ì"oBòv tfiv otyy6p'no1v>> (cfr. Matth. 18, 28-10). E, più ayanti,204,15 <<Mat0aìoq òè àv mcrpapol"crig éxp«(e l.eyrov òeonotrròv 1"6yov <i-rucryyé},ì,rr»' Ao07.e novqpé, n&ocrv m1v oQerl"fiv èreivlv riQ'arcri oor, èneìn«perril.eocig pe' oòx éòer rcrì oè è}.efrocrr tòv orivòorl,6v o'oo, òg raì èyr6
oe nÀ.érlocu raì òpyroOeìq ò rtptoq nopéò<rlrev crutòv toiq pcrocxvrotofig,
Éroq o6 crro6@ n&v tò oQerl.dpevov oòt6» (cfr. Matth. 18, 32-4). Anche inquesto caso un elemento passionale, relativo quindi all'essere, po-trebbe trovar posto fra due unità tematiche. E l'él.eog, che permette diindividuare nell'altro il soggetto di un fare reciprocabile: il condonarsia vicenda. Se non che, il servo spietato nega 1'éLeoq, e nega la co-ipo -
nimia del or5vòou),6q oor.l, riducendo l'altro ad un <<estraneo>>.
A questo punto, per ragioni di completezza, diamo in nota anchel'elenco dei riferimenti non pertinenti che abbiamo chiamato (d) rife -
rimenti allotopi (11).
1.1.2. Riferimenti a testi della cultura pagana, attualizzati permezzo di citazioni occulte o di riferimento generico. Già E. Fialon (12)
(11) (Basilio) - indovinello di Sansone:5.2SOB 'Anò èoOiovtog è€nl,ee 0p66tq, xcrì <irò iolopo0 è(fl1"0e ytr"txt (cfr. Iudic. 14,14).
(Gregorio) - /impossibilia r ealizzatr da Dio/ :
200,21 N0v pèv rel.eri<ov nétpo6 rqylv drnoppeìv (cfr. Exod. 17, 6).ZOO,Z4 t$eqòè ppé1rov è( oùpovo0 d.ptov <iouvri0rl roì lévov (cfr. Exod. 16, l5).200,25 Kcr\ rdl.tv lLurcrtvrov tfiv mrpùv Meppòv èroQfr (riì'ou (cfr. Exod. 15,22-25).200,25 Tig oteipcrg 'El.rodpet e{itoxov nor6v t{v ycrotépo (cfr. Luca 7, )6-7 e 1,, 5'25) .
200,26 Aròoòq tfr "Awq tòv xcrpoufiX (cfr. Regnor. I = Sam. 1,1-20).200,27 Tft Mopig tòv èv ropOevtq np<otdtorov (cfr. Luca l,)1-5 e2,7).
/aurarkeia/ (solo in Basilio):2.269A, IIìve ù6oto rinò o6v olyeiorv (cfr. Prov.5, 15).
2.2698 opécrp 1ùp rQ òvtt otevòv rò dì.l.6tptov (cfr. Prov. » ,27)./cattive conseguenze/ (solo in Basilio):
2.272A tlril,rv yùp ii(et oot 11 nevicr riorep dyuOòq òpopeòq (cfr. Prov. 24,)4).5.2SOB où oulÀélooorv rirò drov06v otoQul.àq, où6è drò tprB6l.r»v o0ro (cfr. Matth.7,
16)./riferimenti alla situazione comunicativa/ (solo in Gregorio):
l95,l5"Iva pfi t'1 rétpo èreivrl yev6pe0cr, èg'ilv rcrtsneoòv ò ondpoq (r1pòg roì dyovogépervev (cfr. Luca 8, 1l).
195,16 Mn& Àe10n rpòg np&g, ri note npòg tòv òuotiyoryov 'lopori),' 'Arofr ororioete roì oupr1 ouvfrte raì p}.Énovteq Bl.éyete roì où pù 1ònte (cfr. Is. 6,9).(12) E. Fialon, Étude historique et littéraire sur Saint Basile,Paris 1869. Più re-
r)9
t40 Marcello La Matina
nel 1869 aveva dimostrato una dipendenza della omelia di Basilio daltruttato De uitando aere alieno opera di Plutarco (1r). Un esame per-sonale della questione ci ha rivelato almeno quindici luoghi in cui Ba-silio cita occultamente Plutarco. Poiché i risultati della nostra ricercasaranno presto pubblicati (1a), ci limitiamo qui a fornire l'elenco deiluoghi:
(1) Bas. 269A < Plu. 827E; (2) Bas. 269A < Plu. 828A; (l) Bas.269A < Plu. 828A; (4) Bas. 2698 < Plu. 8288; (5) Bas. 269C-D < Plu.828E; (6) Bas. 272A < Plu. 829A; (7) Bas. 272C-273A < Plu. 829F; (8)
Bas.273A < Plu. 830A; (9) Bas. 2738 < Plu. 8298; (10) Bas. 2738-C <Plu.8298; (11) Bas.276B< Plu. B30B; (12) Bas. 276C < Plu. 827E-F(cfr. anche 8l0D); (13) Bas. 276C < Plu.830E; (14) Bas. 277A <Plu.831A; (15) Bas. 276r^ < Plu. 830A.
Gregorio è parco di riferimenti a testi pagani, forse perché il suotesto "dialoga" già abbastanza col testo basiliano. I1 primo riferimentospecifico alla letterat:ura pagana è ad Omero. Riferendosi alf inoperositàdell'usuraio, scrive (197, 15 Gebhardt): <<dozrupto cmt@ por5i'etm tàncxvtu roì avripotcr Qr5eo0ar>>, citando parzialmente Od. 9, 108-9, dove si
dice dei Ciclopi: <<otte Qorctooolv lepoìv Qttòv orit'crpdtoorv / o,7"1"ù. ray'croncrpru raì uvripotu xavra Qrlovtar>> 1t:). Vi è poi un riferimentogenerico a elementi contenutistici propri della mitologia greca: <<Kcrtù
pipqorv 'El,ì,tivtrlv, oì òcxipovdq flvcrq proov0pconouq rcrì Qovrio«q crvtì tfrqd[q0o0g rl"rioe<oq Eòpevi8aq npoooyoperiooot.>> (202, 14 ss. Gebhardt).Un secondo riferimento specifico, questa volta a De uitando aere alieno829D, è secondo noi abbastanza probabile; poiché Io anùizziamo nellacitata ricerca, esso non sarà qui discusso.
Sia Basilio sia Gregorio fanno cenno poi al tema della /fecondità/dell'oro o del danaro. Basilio collega al concetto di <<generazione>> la
centemente ha riproposto il tema G. Lozza, «Plutarco, S. Basilio e gli usurai>>, inK2INaNIA,4 (1980), pp. D9-160.
(11) Esaminando la questione della dipendenza di Basilio da Plutarco, G. Ma-renghi (Plutarco, No all'usura!,Introduzione, testo critico, ffaduzione e commento a
cura di G. Marenghi, D'Auria, Napoli 1996, p. 62) osserva che le concordanze non si
limitano alla impostazione. Oltre a trovarvi ricca materia per delle esemplificazioni,Basilio trae dal testo plutarcheo delle considelz;zioni sociali (sul lavoro e sul primatodeli'uomo nel mondo animale) e degli elementi di valutazione (sul ricorso al prestito,sulla necessaria misura nel desiderare, ecc).
(14) M. La Matina, «Plutarco negli autori cristiani greci>>, comunicazione letta e
discussa al VII Congresso di studi plutarchei (Milano - Gargnano, 28)0 maggio 1997),
in corso di pubblicazione negli Atti. Un confronto puntuale tra il testo basiliano e
quello plutarcheo si trova in M. Giacchero, <<L'influsso di Plutarco sulla condanna delprestito a interesse>>, in AA. YY., Tenaonyma, (= Pubblicazioni dell'Istituto di Fiiol.Class. e Mediev. dell'Univ. di Genova, n. 25), Genova 1966, pp. 157 -174.
(15) Il tema delf inoperosità è connesso alla figura dell'avaro accumulatore, ilgt),rip1upoq, anche nel periodo classico. Cfu. A. Cozzo, Le passioni econonnicbe nella Gre'cia antica, Sellerio, Palermo 1991, p. )0.
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
parola r6_roq-, <<usura», di cui scandaglia l'etimo in i.27iC <<per questaragione lscil. perché si moltiplica vertiginosamentel questa forma diavidità (tò eìòoq ro0to tfrq n)"eove§icrg) ha preso questa-denominazione.Infatti,l'usura vien detta tdroq, cioè "parto", per la grande capacità digenerare il male (òrù tùv ruoi,oyovisv toO rsròt). Dònde, altrimenti? Oforse l'usura è detta rdroq, "parto", a motivo dei dolori e delle soffe-renze (òrù tùq òòivog roì l,r5nog) che apporta negli animi dei mutua -
tarb>. In questo Basilio potrebbe alludere al pensiero di Aristotele chenel primo libro della Politica scrive: «ò òè t6rog oùtò rorcì n).Éov. 60evxcrì to{5vopcr to0t' e1},r1Qev' <ipotcr yòp tù trrtdpeva toìg yew6o-tv cnjtdèotrv, ò òè t6roq yivetar v6pro'pcr vopiopotoq» (1258 b) (16). Gregorio,per parte sua, mette in risalto la natura sterile del danaro in 2OO, 29:<<Tu, o usuraio, non cercare usure dal bronzo e dall'oro, che sono ma-terie sterilil> (»ò òè 1ol"ro0 roì 1puoo0, tdv <iydvrov ò1.6v, pr1 (ritertdrov). Ora, l'idea che il danaro,la moneta, fosse sterile eru allabasedella condanna del prestito a interesse da parte di Aristotele (ibidem):«Si ha perfettamente ragione di biasimare l'usura (q opotr"ootoor(), acausa del fatto che i guadagni sono tratti dalla moneta stessa (aro tòcin' suto0 toO vopiopcroq dìvcn t{v rtflorv) e non da ciò per cui Ia mo-neta è stata istituita. La moneta esiste in funzione dello scambio(petaBol,fg è1éveto lriprv), mentre l'usura moltiplica la monetastessa>> (17). Potrebbe pertanto anche in questo caso ipotizzarsi un ri-ferimento, in forma di allusione, ad Aristotele o, almeno, a qualcheforma vulgata del suo pensiero.
1.3.3. Riferimenti di Gregorio al testo di Basilio. Sono numerosie alcuni di essi verranno ffattati più avanti. Considerate le finalità delnostro scritto, è sufficiente indicare qui il principale, quello che se-gnala la dipendenza dell'omelia gregoriana dal testo di Basilio. Come ènoto, l'omelia di Gregorio è stata scritta dopo quella di Basilio(fors'anche dopo la morte di quest'ultimo, awenuta il 1" gennaio del379) probabilmente nel marzo dello stesso anno (1s). Nelle prime bat-tute del suo discorso (1.95,19 ss. Gebhardt) Gregorio menziona esplici-
(16) «L'usura, invece, moltiplica il danaro stesso. Da qui essa ha assunto ilnome di t6rog, poiché gli esseri genetati sono della stessa natura dei loro genitori, e l'u -
sura è danaro (figlio) di danaro>>.
1tl) La teoria di Aristotele sarà ancora alla base della riflessione sul prestitonell'ambito cattolico di età medievale. Si pensi, ad es., al celebre detto Nummus nonparit nummos od alla differenziazionefra res frugiferae eres fion frugiferae. Su questiaspetti cfr. M. Rossino, «Morale cattolica e usura>>, in A. Rossi (a cura di),usura. Eco-nomia Società e Istituzioni: una riflessione a più uoci, S.E.I., Torino 1997, pp. 144-I78.Ma vd. spec. la voce <<Usure>> nel Dictionnaire de théologie catholique, XV, cit., coll.2fi) e ss. Per la condanna dell'usura in età medievale, vedi J. Le Goff, Tempo dellacbiesa, tempo del mercante, Einaudi, Toino 1,977.
(18) Cfr. e.g. J. Daniélou, <<La chronologie des sermons de Grégoire de Nysse»,in Reuue de sciences religieuses,29 (1.955), pp. )46-372.
t4r
142 Marcello La Matina
tamente il testo di Basilio, confessando umilmente il proprio desideriodt aemulatio:
<<Iloputto0por Eb toò6 rirouoopÉvotq pri8opdq 0pooritqt6q pou ii ovotoqrcrtoyqQlocxo0cxr, et avòpòq l,oyd6oq ruì òvopuoto0 rcrtà Qrl'oooQiu,v, ncivtov òà
Àdyrrrv aorqOévtoq rcot8eicrv, ènì tflq ùro0Éoeroq toritrlq eùòorrprjouvtog raì rct -tcrl,rndvtoq tòv rotù torrotdv )"61ov rtflpa tri Fitp rdyò npòq tlv oÒt{vctprl,Iuv raOflrcr 6vov ti Bodv &ppcr npòq toùq oteQcrvitcrq inruooq (eu(dpevoq'»
[«Prego coloro che ascolteranno questo discorso di non condannarmi pelalteri§ia o dissennatezza se anch'io ho aggiogato il mio carro di asini o dibuoi per una stessa gara dt fronte ai cavalli coronati di un uomo scelto e
nominato per sapienza, addestrato in ogni genere di discorsi e apptezz_ato inquesto stesso argomento, il quale ha lasciato il suo discorso <<Contro gli usu-
rai>> come possesso per la vita.>>1
che si tratti di Basilio lo si capisce anche dalle ultime parole del-l'omelia, dove Gregorio ricorda: (207, 4 ss.) «ò Oeoruéotoq ruat{p rip6vBcroiÀeroq èv t@ iòi.rp oryyprippao ooQdg è(en6vr1oe ruX.eiovcr npòq toòq &-poril,o4 Eàvet(opévouq .ii toòq nlsoveror6q òcrvet(ovrcq 7ror11odpevoq 16-
YOV.>>
In sostanza, i riferimenti che giocano un ruolo centrale nelle due
omelie sono quelli al testo religioso primario, costituito dalla Bib-bia (le). Essi ii hanno permesso di rintracciare i semi fondamentalidelle omelie. Servendoci del quadrato semiotico (20), possiamo mo-
strafe l'organizzazione di questà 'semantica fondamentale' che costi-tuisce it liiello profondo della articolazione del senso. Ricordiamo che ilquadrato semiotico - detto anche modello costituzionale - è una
,ìrrttrm che permette di fappresentare visivamente l'articolazionedelle unità di sìgnificato costituenti una qualsiasi categoria semantica.
Esso è costituit;da quattfo elementi (s1, s2, non-sl e non-s2) e dalle
(19) può essere interessante differenziare le citazioni. Basilio cita 9 volte l'AnticoTestamento e 4 volte il Nuovo; Gregorio cita 6 volte l'Antico e 9 volte ii Nuovo
Testamento. Ne consegue che in Basilio dobbiamo aspettarci una attenzione maggio.re
ai temi (a) e (b), -"ri. nel testo di Gregorio un ruolo più rilevante sarà giocato dai
temi neotestamentari della fratellanza e della remissione (o non-remissione) dei debiti'(20) L,elaborazione del quadrato semioticb è dovuta al semiologo lituano Al-
girdas J. Greimas che così l'ha tiatteggiata in Du seas, Seuil, Paris 1970, p. 160: «Cette
Itrr,,.t,r.e élémentaire t...1 doit étre congue comme le developpement logique d'une ca-
tégorie sémique binaire du type blancvs noir, dont les termes sont, entte eux, dans une
rJation de àntrariété, chacun étant en mème temps susceptible de projeter un nou-
veau terme qui serait son contradictoire, les termes contradictoires pouvant à leur tourcontracter une relation de présupposition à l'égard du terme contraire opposé». Per
una presentazione sistematica del quadrato, si veda AJ. Greimas et J. Courtés, Sémioti-que.-Dictionnaire raisonné de la tbeorie du langa-ge, Hachette, Paris 1,979.; tr. it' a cura
ài p. f'ubbri, Senniotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio, la casa Usher,
Firenze 1986, pp. 275-278.
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
rclazioni cui essi danno luogo. Fra questi, sl ed s2 sono detti contrari ecostituiscono l'asse della contrarietà. Parallelamente, non-s2 e non-s1costituisconol'asse dei subcontrad.La relazione fra s1 e non-sl è in-vece detta di contraddizione, come pure quella tra s2 e non-s2. Questedue relazioni sono chiamate schemi.Infine, non-s2 e s1 sono retti darapporto di implicazione, come pure non-s1 ed s2: a tali ultime rela-zioni si dà il nome di deissi.
Disponiamo ora nel quadrato le unità tematiche che abbiamorintracciato nei contesti di citazione. Ciò che otteniamo è, da unaparte, la articolazione di alcune relazioni stabili fra questi elementi. P.es., in sL sta il /prestito usuraio/, il tdrog, con la sua caratteristica distrumentalizzazione dell'altro. Il suo contrario, s2, presenta il/condono/, la yo.ptg,la remissione dei debiti. Sull'asse dei subcontrarivediamo opporsi il /non-condono/, che è implicato dall'usura, e il/prestito gratrtito/, che risulta conforme al /condono/ e aI conseguentericonoscimento della /co-iponimia/. Per ciò che concerne i dueschemi, "sl us non-l" contrappone due unità appartenenti ad unamedesima isotopia, che potremmo chiamare ECONOMICA, mentre 1o
schema "s2 us non-s2" articola due termini appartenenti ad unaisotopia che potremmo chiamare UMANITARIA. La giustezza di que.ste etichette non ha molta importanza. Usando parole grecheavremmo potuto definire il primo schema come isotopia del ronqf,rrdve il secondo come isotopia della QtLnv0pronicr. Ciò che importa notare è
che la negazione di un sema "economico" comporta la affermazione diun sema "umanitario" e viceversa. Per quanto invece concerne le duedeissi, è possibile contrapporre la prima, "sl e- non-s2", alla seconda,"s2 <- non-s1", sulla base di un investimento assiologico dovuto allaproiezione sul quadrato della categoria timica 'euforia' e.,s 'disforia'. Inta1 modo, diremo euforica la deissi /condono/-/prestito non-usuraio/,poiché resulta conforme al sistema assiologico accreditato presso i no-stri testi e disforica la deissi /prestito usuraio/-/non-condono/, inquanto presenta dei valori difformi, o antivalori.
«altro=strumento»
/prestito usuraio/«altro=co-iponimo,
/condoro/
sl, {# s2
t4)
r><t9 1--------------; ;i
/non<ondono/«altro=esttaneo»
/prestito non-usuraio /«altro=prossimo»
r44 Marcello La Matina
Ma c'è anche un altro modo in cui il quadrato può essere letto, ecioè come la rappresentazione dinamica del modo in cui il senso vieneprodotto. Se la lettura statica ci dice quali sono le relazioni fondamen-tali, la lettura dinamica prospetta nella vicenda della costruzione delsenso alcune possibili operazioni. Le relazioni costituiscono la morfolo-gia del quadrato, mentre le operazioni possibili sono la sua sintassi,beninteso, una sintassi logica di profondità. Per esempio, possiamoimmaginare che la contraddizione tra sL e non-sl sia leggibile dinami-camente come la negazione del primo termine el'affermazione del se-condo. E ancora possiamo immaginare che la implicazione fra non-sled s2 sia leggibile come l'affermazione del termine conforme s2. Leoperazioni effettuabili entro il quadrato sono orientate e perciò preve-dibili. P. es., da non-sl si può passare ad sl e viceversa, mentre non sipuò passare direttamente da s1 al suo contrario s2 (in termini di logicaòccor.e prima negare sl e poi affermare il contenuto contrario) (21).
Tuttavia, ciò che occorre mettere in luce è che attraverso la sin-tassi operazionale, il senso è messo in grado di creare le basi per l'arti-colazione di una sequenza naffatiya. Basterà convertire la sintassi Iogica in una sintassi attanziale. Il che significa convertire le operazioni a
òarattere logico del quadrato (affermazione, negazione etc.) in opera-zioni a caratìere antropomorfo che rinviano al <<fare>> di qualcuno che
agisce e che comunica (22). P. es., nel nostro caso, si può convertirel'operazione di <<affermare s1>> nel (quasi) enunciato narrativo <<un
Soggetto pratica l'usura>j. L'operazione di <<negare s1>> potrebbe alloracoirispo.ràere al fatto che <<un Antisoggetto condanna l'usura>> e
quella di «affermare non-sl>> al fatto che «tale Antisoggetto sostiene ilprestito gratuito>>. A questo punto, seguendo le rego-le della sintassi,l'operaziòne successiva di «affermafe s2>>, cioè la affetmazione teticadiin valore contrario ad s1, può essere convertita nel fare di un Sog-getto - a questo livello aficora indefinito - che pratica la remissionedei debiti. La sequenza può ancora continuare se riscriviamo l'opera -
zione che nega s2 e afferma non-s2 come il fare di qualcuno che rifiutidi praticare la remissione dei debiti e metta in opera un comporta-
-.ito che contraddice ad essa - come awiene nella parabola delservo spietato citata da Gregorio. In questo modo sul quadrato ab-biamo iovrascritto una sequenza narcativa. Non abbiamo ancora unastoria, ma una rappresentazione antropomorfa che semplicemente pre-
(21) Cfr. Greimas, Du sens, cit. p. 165: <<L'opération de conradiction qui, en
niant par exemple, le terme sl, pose en méme temps le terme non-sl, doit ètre suivied'une nouvelle opération de présupposition faisant surgir et conjoignant au tefme non-
sl, le nouveau terme s2rr.(22) Scrive sempre Greimas, ibidem, p. 168. <<Le faire est donc une opération
doublement anthropomorphe: en tant qu'activité, elle présuppose un suiet; en tant que
message, elle est objectivée et implique 1'axe de transmission entre destinateur et desti-
nataire>>.
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'asura
figura ia storia con i suoi attori,la sua afticolazione spaziale e tempo-rale: in una sola espressione, con la sua messa in discorso.
A conclusione, abbiamo rinvenuto nei contesti di citazione leprincipali unità tematiche (/prestito usuraio/; /prestito gratuito/;/condono/; /non-condono/) e abbiamo visto come esse siano logica-mente articolate. Vedremo adesso come esse, convertite nel modeiloattanziale, diano forma alla organizzazione narcativa delle nostre dueomelie.
2. fl, piano ilomorfico e l'organizzazione nanativa
2.1. U na microscen eggiatura
Basilio (1..2658) così caratterizzal'rsura: <<T(l 6vcr yàp cxncrvOpro-
rioq r5neppol,rlv é1a tòv prèv cdv cxvcryrutov èvòedq é1ovto (r1tdv òrlvet-opcr eiq map«pr0iuv to0 piot, tòv òè pfi <iprdo0cn t@ reQal,ofrp, oì,1,' è-nrvodv èr t6v oupQop6v toO ruévqtoq rpoodòooq èouQ rcrì eozopicrqowdyetv.>> Con queste parole egli colloca il prestito usuraio, cincrvOpr*-,aaq òneppol"fiv, nella deissi disforica del quadrato. Inoltre ce ne dà inqualche modo una piccola sceneggiatura. L'usun è la storia di dueSoggetti e di un Oggetto valore scambiato fta di essi. I primi attanti adentrare in gioco sono perciò Soggetto e Oggetto, Essi esistono sintatti -
camente solo in virtù della relazione che li lega. Entrambi sono figuredel desiderio, di colui che desidera e di ciò che è oggetto di questo de-siderio 1zr). il primo soggetto, diciamo il mutuatario, si trova disgiuntodall'oggetto valore (= il danaro necessario a vivere), mentre il secondosoggetto, il mutuante, è congiunto con questo valore.
In termini narratologici, la storia comincia con la situazione dimanque del mutuatario (<<tòv pèv t6v crvcryrcrtrov èvòedq é1ovto>) e conla successiva quéte dei mezzi per alleviare il bisogno («(1teìv òcivetopcr
eiq napapu0icrv toò piou»). E subito dopo si trasforma nella storia del-f ingordigia del mutuante che non si accontenta di ricevere quanto hadato in prestito («tòv òà pfl dpreioOcxr t@ reQol,otrp»), ma che col suocomportamento riduce I'altro a strumento del suo desiderio di posse-dere l'oggetto valore, studiando anzi di accrescere questo valore(«èrnvoeiv èr tdv oopQop6v toO névqtog npoodEouq èoot@ rcxì eònopicxq
orvciyerv>>).Il primo livello di lettura di questa microstoria è quello del 'fare'
dei soggetti coinvolti. I1 Soggetto disgiunto attiva un Programma nar-rativo di acquisizione dell'oggetto valore, mentre il Soggetto già con-giunto, rcùizzato (= il ricco), attiva un Programma narrativo di accu-mulazione. Tuttavia, i due programmi - si capisce subito - non ver-
145
(2') Cfr. AJ. Greimas, Sérnantique structarale, Larousse, Paris 1966, pp. 176-7.
146 Marcello La Matina
tono su un identico valore: il ricco mutuante non si contenta del capi -
tale, vuole di più. Ed è qui che entra in gioco il secondo livello di let-tura. Già Soggetto congiunto, il ricco è anche un Soggetto appassio-nato: un avaro o un Qti"ripytpoq. Sicché, quello che dovrebbe essereuno scambio di oggetti in virtù di un conmatto diventa un atto disfruttamento dell'altro. In più - come l'espressione «èrctvodv (...)
npoo6òorq ècrut@ rcxì eùnopicrq ou.ciyerv>> lascia immaginare - I'Oggettovalore prestato non è che in apparcnza un Adiuvante del Soggetto de-privato. Gravato di fatto dall'usura, il òcrvetopo si,configura come unuero e proprio Opponente del soggetto mutuatario, impedendogli larcalizzazione del programma narrativo di ncrpopu0io toO piou per ilquale aveva chiesto il prestito. Ma c'è anche un terzo livello, quello delgìudizio di valore espresso dall'Enunciante. Basilio scrive che il rap-porto fra usuraio e debitore <<tQ òvtt (...) crruvOpr»uo4 ùteppol"r1v é14».Ìr, qr.tto modo egli si attribuisce un sapere sull'/essere/ (tQ 6vct) deivalori ed effettua- una sanzione negativa nei confronti della perfor-
nxance dell'usuraio. Questo terzo livello - che coinvolge il piano dellaenunciazione - mette in gioco le passioni dell'oratore (anche la difesa
della verità può assumere connotati patemici) e disegna ii piano dellaveridizione (r.). il piano dell'enunciato, quello dove sono descritti gli«stati di cose>> che iostituiscon o la nanazione, si mescola così al pianodell'enunciazione, dove viene stipulato il contratto fiduciario fua
Enunciante ed Enunciatario. Anz| vedremo dai passi riportati che
molto spesso una sequenza nanativa (p.es., il 'fare' dell'usuraio) non è
descrivitile co-e puio /farc/ di un soggetto, ma viene sovrastata dalgiudizio morale dell'Enunciante.
2.2. Sintassi del Prestito
Sia l'omelia di Basilio sia quella di Gregorio mettono in scena ilrapporto fra il mutuante usuraio e il suo mutuatario, fra il ricco avato e
il àèbitore. Diverso è però il punto di vista scelto dall'omileta. Se infattiBasilio indirizza di pìeferenza la sua omelia a «quelli che chiedonoprestiti con leggerezrar, (npò; òè toòq rpoleipo4 òuvet(opevoug),|'omelia.ài Gregorio é-irru... rivolia proprio contro coloro che prestano ad
usura. "Il
motivo di questa scèlta, spiegato da Gregorio nelle paroleconclusive dell'omelia, è il desiderio di non voler toccare un tema che
(24) r.L^ caregoria deila veridizione è costituita lscil. nel quadrato semioticol (.'.)
dalla messa in reiazione di due schemi: lo schema apparire/non-apparire è chiamatomanifestazione, quello di essere/non-essere tmmanenza. È fra queste due dimensionidell'esistenza che-si gioca il "gioco della verità": inferire, a partire dalla manifestazione,l'esistenza dell'immanenza, è deliberare sull'essere dell'essere>> (Greimas et Courtés, op.
cit.,p. )79). Come si vedrà, è nel gioco della veridizione che si esercita, a vantaggio del-I'Enunciatario, il fare persuasivo dell'omiieta.
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
egli giudica lrattato così sapientemente dal divino Basilio nel suoscritto (npòq òà toòq rupo1eipo4 Ecrver(opévoug (...) oòòévcr rorr(oopcxr ),6yovripxdv cròcoig rptvcrq tùv oupPoul,{v, tv ò 0eonéotog notfip t'1p6v Bcx-oiì.erog èv tQ iòirp orvTprippcrtt ooQ6q è(er6vr1oe). Eptrambi i raccontisono tuttavia spesso sovrapponibili e costituiscono una espansionenarcativa delle unità tematiche (/prestito usuraio/, /prestito gratuito/ecc.) riscontrate nei frammenti di testo primario citati. In relazione poialla dialettica tra testo religioso primario e testo religioso secondario,va detto che siamo in presenza di un modo di "edizione" che, dopoaver citato il testo primario, ne fornisce una versione espansa attra-verso la procedura che abbiamo chiamato traduzione diafonica.
Un altra caratteristica, che accomuna i due racconti - o, meglio,le due sceneggiature - è la particolarità semantica di non vertere sudegli individui determinati, ma su individui astratti, ridotti a tipisemantici. In termini logici diremmo che la parcla toroyl'riQog, con cuia volte viene designato I'usuraio, e la patola 1pecùotqg, con cui si desi -
gna il debitore, non si riferiscono in Basilio e Gregorio a nessun indivi-duo particolare. Al contrario, esse denotano l'intera classe degli indi-viduf che sono <<usurai>> e «debitori». La differenza è in sostanza trariferimento individuale -
qui assente (25) - e riferimento collettivo o
denotazione - qui presente. Questa semplice scelta logica della deno-tazione è dunquè la spiegazione di quel procedimento che in retoricaviene chiamato etopea, a cui i nostri autori attingono a piene mani perla carutteizzazione del prestito.
Servendoci ora dèl modello attanziale, vediamo di portare allaIuce la comune struttura soggiacente ai due (quasi) racconti. A questoIivello di articolazione del senso, la struttura del prestito può essere
descritta come una successione di stati di congiunzione e disgiunzionedei due Soggetti rispetto al valore investito nel danaro. Proiettando sul
quadrato là categoiia della giunzione (26) si può dare conto dello svi-
luppo sintagmatico del racconto.
147
(25)Fa eccezione Greg. 205,1-26, che racconta la vicenda di un avaro usuraiopresentandola come un fatto realmente accaduto e anzi ben presente alla memoria de-
gli uditori.- eq «Si chiama gianzione la relazione che unisce il soggetto all'oggetto, (...). La
posizione dell'oggetto di valore sul percorso sintattico permette di distinguere ad
èsempio fra disgiunzione (l'oggetto che non è mai stato posseduto) e non-congiunzione(che presuppone, sintagmaticamente, che I'oggetto sia stato posseduto). Greimas et
Courtés, Serniotìca , oP. cit. , p. 16) .
t48
Icongitlnzione]
/possesso/
[non-disgirmzione]
/non-mancanza/
Marcello La Matina
52
Idisgiunzione]/mNrcanza/
sL
S1
32
[non-congiunzione]
/non-possesso/
2.2.1. La quéte del mutuatario
_ I1 Soggetto mutuatario si rrova inizialmente disgiunto dall'oggettodi valore, in condizione di /man canza/ . Vi sono almeno due mòai diinterpretare sui nostri testi Ia situazione di rnanque. Gregorio fa dfeti-mento a soggetti che sono in condizione di effettiva necessità: biso-gnosi, appunto, se non poveri affatto (196,20 òrù neviav oe iretetier ruìtaiq 0ripcnq Tpool(de'qrm, onopdv rotaQeriyer npòq tòv oòv nì,o0rov, ivcryévr1 cròtQ tflg Ipeicrq ètrtroupog). Basilio, invece, parla talvolta di per-sone <<strette da necessità» (1.265C [ò òè QrX<ipTupoq] òpdv uno ttg cr-v<l"yrnq dvòpa rcrrcrrcrpnr6pevov npò tdrv yovcttov ireteriovto) . Tuttaiain un punto fa esplicito riferimento a persone non proprio indigenti,ma desiderose di un prestito per attuare un loro programma di/magnificenza/.4.276C Ksitor opdpev oòIì roòE tdv rivcryrsirrlv èvòedgèpIopévorq fuì tò ò<iverov (ouòà yùp é1ooor toòq nrote6ovroq), cr),},ò òa-vei(ovtcn civ0pcoruor, òondv«r6 uvetpevmq rcrì rol"otel.eior.q ardpnorg èar-roòq èmòt8dvteg, ol yuvmreicnq r\òoru0eicng Eoul"eriovteq. Sarebbero cioèdei dissoluti, cultori dell'apparenza e del lusso, facili vittime dei desi-deri eccessivi delle loro mogli (27).
Ad ogni modo, dotato di un /voler essere congiunto/, questosoggetto sospende la /mancanza/ mediante la stipula di un contratto diprestito (198, L7 i èv tQ Xriptn ypcxO(, rl òpol"oyio toO otevoÉÉvtog.òc6oo petà tfrg èpy«oiog). Sul quadrato, l'operazione è la negazione dis2. In questa fase di [non-disgiunzione] egli diviene un soggerro poten-zializzato, cioè in attesa di rcalizzare il suo programma narrativo volto a/colmarc la mancanzal. Questa posizione intermedia fua la prepara-zione e la rcalizzazione va forse considerata <<come una porta aperta, inseno al percorso naffativo, sull'immaginario e sull'universo passiona-
(27) Su questi aspetti vedi G.Lozza, art. cit., pp. 140 e 158-9 e S. Giet, art. cit.,pp.97-8.
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
Ie» (zs;. Essa si presta dunque al fantasticare del soggetto in attesadella congiunzione con l'oggetto valore. Così il mutuatario descritto daBasilio guarda ai ricchi immaginando di essere come lorc (4.277A tòòè toùq pèv nl,ootrioovrcx,q B}"fuerg). Ciò che caratteizza quesro stadiodel soggetto è la fuga dal presente e il rifugio in un castello di fragilisperanze: atteggiamento che l'Enunciante sanziona negativamenteO.272C Nrlri«q gpevòg trrrt èr t6v ncrpdvro» èooròv rueproté]"]"erv, u]"]"'cròt'tl,org èì"niorv èmtpé\rovt« Qavep&g FIciFlq rcrì crvavnppricoo rcrtstol.-p0v).
I1 passaggio a sl può essere interpretato come l'acquisizione del-I'oggetto. Questa fase è evidentemente connotata come euforica. Il<<mutamento nel tenore di vita>>, la <<mensa fornita>, gli «abiti di va-lore>>, i <<servi meglio vestitil>, infine la <<compagnia di adulatori e pa-rassiti>>, sono tutte figure evocate da Basilio per evidenziarc Ia diatesieuforica della condizione di /possesso/. (2.268C A«Fòv òè tà XpriLrgccr,tflv pèv rupotlv l,«prpdq èott rcrì neptyaprlq, d),l,orptrp civ0er yeyavolpévog,ènrorlpaivr,w tf petopo),fr toO Biou' rpo,nelo yùp ùvetpévr1, èoOfig rcol,r-teÀeotépcr, oirét«r rpòg tò Qaròp6tepov è(ql,l"oypevot t@ opipofl, 16-l.cxreq, olpndt«r' rrlQfrveg oir<ov popior), Due notazioni oscurano il felicequadretto. Anzitutto, il fatto che si tratti di danaro altrui (ci,l"otpirpcivOer yeyuvropévoq) introduce il tema della restituzione, della éroo'rq.Poi, l'aspetto verbale puntuale di l"op<ov, in contrasto con quelTo dura-tiuo degli altri verbi espressi (èoti, èrroqpoivrov)- e delle frasi nomi-nali, interpretabili come aspettualmente duratiue - fa intravedere laprecarietà di questa soddisfazione. Mentre il soggetto è persuaso delladuratività dell'esperienza, l'Enunciante aspettualizza qtest^ condi-zione come puntuale/incoatiua (tìv pàv npoltqv).
L'introduzione del tema del tempo segnala che il percorso narra-tivo del mutuatario non è concluso. Il danaro non è un oggetto consu-mabile, ma è soggetto ad essere speso («tò pèv lpripotcr ùzroÈpei»). Sic-ché, dopo il processo di /acquisizione/ ha luogo un processo di/dissipazione/, che si caruttedzza come disforico. Sia Basilio sia Gre-gorio insistono su questa contrapposizione figurativa fra <<tempo inco-ativo>> (euforico) e <<tempo durativo>> (disforico):
(Basilio)
2.269C Mrrpòv èyrcrl,l,rornodpevoq roiq cxl,l,otpiorq, iiotepov rsì tòvnatprpolv èxorrioq.
4.277 A urrpòv Ipdvov roiq «il"l,otpiorg èvopprvdpevor, ùotepov raìrò oixeto òòr5puvto.
(28) A. ;. Greimas et J. Fontanille, Sérniotiqae des passions, Seuil, Paris 1991,; tr.it. a cura di F. Marsciani e I. Pezzini, Semiotica delle passioni. Dagli stati di cose aglistati d'animo, Bompiani, Milano 1996, p. 727 . Ma sull'introduzione di questa caregoriadella «potenzializzazione>> vd. ie pp. 45 e s.
t49
150 Marcello La Matina
(Gregorio)
196,14 répne'ce rpòq oliTov, cn"l,ò Ip6vor6 totepov ò aQ' updv iòqntrpòv yivetan òrll"qtriprov tfr VuXf
196,17 prrpòv tépyuvteq t{v 6pv rcxì tlv &rofiv :reptqpioavteqsiolviou i"dnrlq yiveo0e rp6(evor.
202,20 rupòq,ò),i.yov tépnouocr àv dplotq raì rcrrpòv tòv eiq{iotepov0iov ropooreoci(orocx.
202,26 oi tò évtoru r6v òcxveropcitolv l,cxpprivovteq òl"iTov et-nopt'1o«vteg Ipdvov {lotepov crùt,4q tfq ruatprrflq èotioq èrnintouorv.
Tutto accade come se la /congiunzione/ con l'oggetto valore sitrasformasse da euforica in disforica. Già alle prime scadenze il mu-tuatario scoprirà il potere delle usure; e allora non riposerà la notte négodrà del giorno o del sole, ma avrà, in uggia la vita, odierà i giorni chegli recano le scadenze di pagamento. In sogno vedrà l'usuraio incom-bergli, un incubol, e da sveglio l'usura sarà per lui preoccupazione co-stante. (Basilio 2.268C-D òq òè tà pèv lprip«tu ònoppei, o òè lpdvoqrpolòv toòq t6rouq èuut@ oupnporiyet, où v{xteg èreivrp &vrizraoorv gé-porolv, oÒ1t'1pépo Qcnòpa, ou1fil,rog tepnvdq, dl,),cr òoolepaiver tòv piov,prod tùq tpépoq rpòg tfiv npoOeopi.crv èretyopévcxg, Qopeitcn toòq pfrv«gòq tdrrov nu'cépac,. Kocv rcrOetòq, èvrircvtov Bl,enet tòv òuverotilv, rcxròvtivcrp, tf reQcrl,fr neprot<ipevov' r&v Tp1yopn, éwoto crùt@ rcrì Qpovtìq ot6roq èoti).
Vincolato però dal contratto, egli deve in qualche modo resti-tuire. Nelle nostre oruzioni, il lpec6otqq viene descritto come impossibi-litatoa farlo, stretto tra il /dover farc/ e il /non-poter {arc/. Divenutosoggetto viftualizzato, il mutuatario è costretto a dllazionare la restitu-zione (non-sl) poiché è tornato alla situazione iniziale di mancanza(s2). Il soggetto può trovarsi allora dominato dal mutuante: la<<schiavitù per propria scelta> (1.2681''o yùp t6rorq àcxutòv òne60uvovrotcxot{oug, 6v tfiv értrorv où1 ùQiotcrtcn, òopLeicrv cxùOcripetov Kcrte-òé§ato òrù pior) o il <<male che cura un altro malo> (2.2698 Et pèv o$vé1erq 60ev amoòQq, ti or:1ì tlv ncrpo0oov évòercrv èr toritrov t6v crQopp6vòrcxtrr5erq; ei òè crcopeig Trpoq tÌ1v értrorv, rcrròv rorri Oeognerietq), di cuiparla Basilio, figurativizzano proprio questa condizione di /dominanza/di un soggetto sull'altro. A volte le conseguenze sono funeste: la finedell'illusione e del sogno (4.2774 "Ct r6oorq d«oLeoe tù o),l,6tpro ti-ya0d! 116oor" òvcrp nl,outriouvteq òrceponril,suoocv tfq (qpioq!), addirit-turala fine della vita per mano propria(20),14 ò n6oor òtò t6rov cry-
Idvnq f{yavto xcrì perSpoor notopdv àoutoòq è(éòcoxcrv rcrì rooQdtepovérprvcrv ro0 òsveroto0 tòv Oriv«tov, crqfrr«v òè ncriò«q òpQcrvoùq rar{vpq tporùv'éyov'cuc, tfi v mvicrv ).
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
2.2.2. Il'fare' del soggetto mutuante
Il soggetto mutuante si trova inizialmente congiunto con l'og-getto di valore, in condizione di /possesso/. E dunque un soggetto rea-lizzato. Quale può allora essere il suo programma narrativo? e cosa lomuove ad agire? La risposta può essere fornita da tre punti di vistadifferenti. Dal punto di vista del soggetto mutuante stesso, si tratta diun programma narrativo di /accumulazione/. Come osserva Basilio(1,2688) «oò èvòeioq roì ozropirxg uv0pc6nov èm(qtdg, ivu oot èvepyù tcr
Xp{pgts yévntcn». E Ia causa è una passione, la Qt},opyupia. ChiosaGregorio (198,1): l'usuraio appassionato «rsO' ripépcrv dptOpd tò répòoqrcri tfq èrcrOrpioq [ourì èpdp:rl,cxt«r>> 1zs). E questa «èrct0upia» che 1o
spinge ad intraprendere una sua quéte, per trovare il soggetto adatto a
"subire" il prestito feneratizio. Così in Gregorio:
<<Bazzica vicino ai ffibunali alla ricerca di uno che sia messo allesrette dagli esattori; segue i curatori fallimentari come gli avvoltoi tengondieto agli eserciti e alle guerre. Porta in giro la borsa col danaro e fa ve-dere ai vessati l'esca della caccia, così che, spalancando la bocca dinanzi aldanaro, per necessità, 1o ingoino insieme all'amo dell'usura>>. (197, 2) [poo-eòpeiiet toìg òrrcxotqpiotq, iva etipq tòv otevoripevov toìq rinoltqtniq, rctì toìqnp<irtoporv <iroÀouOeì òq taìq nopatri(eot rctì toìq ruol'Éporq oi 10neq. rceptQÉper tòBaldvttov rccrì òeirvuot toìq nvtyopévotq tflq, 0ripcrq Eé).eop, iv' èreivrp 6tà tflvlpeiov neprlrivcwteq ouyrotordoot tdv tdrov tò ciyrrotpov. )
Il programma usuraio viene però camuffato e il mutuante si pre-senta al mutuatario sotto le mentite spoglie di un Qr),civ0prrmoq, con unprogramma di /dono/. Solo dal punto di vista dell'Enunciante - comevedremo - il camuffamento è scoperto. Il mutuante è apparente-mente un donatore, ma in realtà un falso donatore e il suo fare appa -
rentemente filantropico è in realtà retto da una logica di arricchi-mento.
Uno statuto speciale ha l'oggetto di valore, talvolta figurativizzatodalla borsa col danaro (tò 9cr)"rivaov), talaltra dall'oro. Dal punto di vi-sta del mutuatario
^pparc come un Adiuvante concesso dal soggetto
/donatore/; invece, dal punto di vista del mutuante - che viene sma-scherato dall'Enunciante - l'oggetto valore è al tempo stesso figura diun Opponente del mutuatario e di un Adiuvante del mutuante. E lo«schiavo laborioso>> - descritto da Gregorio (198, 14) - che "lavora"per conto dell'usuraio allo scopo di tornare con degli utili: «ivo ògòo0},oq ènip"oI0o€ ò lpooòg èpyaoripevoq petà t6v pto06v èncrvé1"0r1». Edè 1a <<caparra di povertà>> che il mutuatario si mette in casa nel mo-mento in cui accetta il prestito. Anche questa figura è di Gregorio(196,28): «ò yàp évtorov lptoiov ònoòe16pevoq oppcrFdvcr neviuq trcrp-
151
(29) Gebhardt (ediz. cit.,pp.T-4) espunge oùx, seguendo Langerbeck.
t52 Marcello La Matina
priver èv EpooIripotr euepyeoiag 6Le0pov ènerociytov rf oi ri g».Questo soggetto mutuante, dicevamo, va a caccia della sua vit-
tima. .Con la stip,ula del contratto di prestito, egli diviene un soggetrovirtuarizzats (= [non-congiunzione]). La fase successiva, quella della/mancanza/ corrisponde alla erogazione effettiva del danàro che dàinizio a un processo di /rinuncia / . Tuttavia, per effetto del contrattoscritto, il mutuante, è solo apparentemente privo del suo danaro,mentre in realtà egli è nella situazione di [non-disgiunzione]. L'usuraio<<non ha un soldo in casa>>, ma possiede danaro virtualmente, <<èv yo:p-roftq>>, nell'obbligazione fhmatagli dal mutuatario. Sempre Gregòrioaflnota (198, 7): «Blenerq yoOv tòv nl,oriorov rcrì noì,r51puoov ro},1<irrqpr1òè èv vdptopo é^1ovra ènì tr1q oirioq, dl"l,'èv I«iptcxrq tùq è}"ri8sq, àv ò-pol"oyiorq tfiv ùlrdotcrorv, prl6èv éIovta roì ncinrtcx ra,téXovru,».
In attesa del rimborso, il mutuante è ora un soggetto potenzializ-zato. Condizione questa che - come già osservammo a proposito delmutuatario - consente al soggetto di costruire dei simulacri (euforicio disforici) e di scivolare nel passionale. Il mutuante potenzializzato at-tiva un immaginario pienamente disforico. Una volta avvenuta Ia/rinuncia/,l'oggetto di valore acquista per il nostro usuraio un'esi-stenza solo virtuale. Esiste, come diremmo oggi, solo sulla cafia. Maquesto modo di esistenza diviene per il soggetto potenzializzato im-prowisamente precario. Egli ha paura di perdere l'oggetto del suo de-siderio. Allora piange sul contratto, irrora di lacrime quel rotolo che fuuna volta irrorato dal péIov della scrittura mentre 1o esibisce come sifarebbe coi panni di un figlioletto morto. La descrizione caricaturaleche ne fa Gregorio è quella di un lutto. Vale la pena riportarla per in-tero:
(200,1) <<[L'usuraio] siede, le mani giunte, geme continuamente e
versa molte lacrime; dispiega il rotolo del contratto, compiange l'oro nellepieghe della scrittura, esibendo l'obbligazione scritta come fosse il vestitinodi un figlio morto. Se poi il prestito è un prestito marittimo, se ne sta sedutosulla spiaggia, affannandosi per le correnti dei venti e interrogando senzasosta quelli che approdano, casomai abbiano sentito di un naufragio o ab-biano essi stessi corso qualche pericolo durante \a navigazione. Si irrigidi-sce nell'animo quando vede il mate agitarsi, sogna, fantastica nell'a-nimo...>>1. («rciOqta,r tò ldpe ouvòriocrq, otÉver oove16q, òroòorpuet noì"l,ci, ri-vel"ittet tò lerpdypoQov, Opr1vd èv toiq ypcippoor tòv lpuoòv nporopi(rov tòoupBdlorov òq ipcittov uioO tel.eutrfoovrog' crn' èreivou 0epp6tepov èyeiper tòndOoq. &,v òè roì vcruttròv r] tò òdvetopcr, toìq cxipol,oìq rcpoorciOqtar, tù6rrvr(oetg peprpvQ t6v «ivÉprov, ouvel6g ErcpoxQ toùg rataipovtoq, pri nou vcrud-pov t'1rodoOr1, prj nou rMovteg èrtvòdveroav' nalvo0tar t{v ryul(v, 6tcrv «i-yprcxivouocxv iò',1 trlv Ociì"aooav, òveipora p)éney Qavtcroro0tcn tr\v yullv ...»).
Nelle nostre omelie il percorso del mutuante viene opportuna -
mente fermato in questa condizione di [non-disgiunzioneJ. Né Basilio
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
né Gregorio parlano esplicitamente di un successo dell'usuraio nellariscossione del credito. Troppo facile intuire l'opportunità retorica epedagogica di questa reticeiza, volta a scoraggiare i troppi che prati-cavano il mestiere di usuraio in un mondo dove la Wirtschaftsetbik eramateria dagli ambigui contorni. Per la stessa ragione, il percorso delmutuatario viene descritto dai due Enuncianti fino alla /mancanza/definitiva - ossia fino al ritorno alla condizione di povertà iniziale, conl'aggravante, però, delf interesse da restituire.
Come si vede nella figura presentata qui sotto, i percorsi dei duesoggetti sono - con questa particolarità del finale "zoppo" - assolu-tamente speculari:
dissipazione
s1->J ->s2
153
acoulslzlone
Mutuatario= s2 -> J-> s1
Mutuante= sL -> J-> s2
\---------.v+ \---------1-
rinuncia acquisizione
3. II piano passionale
).1. il modello dell'auarizia.
Finora abbiamo prevalentemente guardato al 'fare' dei nostrisoggetti, mostrandoli nella successione di congiunzioni e disgiunzionicon il loro oggetto valore. Abbiamo caratterizzato questo fare come unprocesso di scambio (travestito però da qualcos'altro), in virtù delquale il mutuante rinuncia temporaneamente ad un bene per darlo almutuatario in cambio della promessa scritta di una restituzione con gliinteressi. Secondo la sintassi attanziale, entrambi i soggetti si prepa-runo al fare, acquisendo una competenza ('0) che li abiliti a realizzare i'loro programma narrativo.
I1 mutuatario, s'è visto, deve rcalizzate un programma di/scioglimento della mancanza/ ed è competente secondo il /volerc/:
1lo) La semiotica greimasiana prescrive che l'esecuzione di una masformazioneoarcativa sia preceduta dall'acquisizione della competenza necessaria, appunto, a
compiere quella trasformazione da parte del soggetto operatore. La competenza puòessere perciò un saper-fare, un voler-fare, un poter-fare o un dover-fare. Ciascuno diquesti verbi che precedono il fare esprime una modalità. P. es. in «I1 povero vuole ar-ricchire», il volere (<<I1 povero vuole») modalizza il fare («II povero arricchisce»). Cfr.Greimas et Courtés, op. cit., s.u. <<Competenza>> e s.u. «Modalitò>.
s2-> s2 [-> s1]
154 Marcello La Matina
egli ua a cercdre il mutuante spinto dall'indigenza, che funziona cosìcome Destinante del suo fare. E forse competente secondo il /doverc/:Basilio accennava (4.276C) aI fatto che non chi manca del necessariochiede il prestito, ma chi vuole continuare a vivere nel lusso. Se le cosestessero così, in qualche caso bisognerebbe dire che il soggetto mutua-tario agisce spinto da una sorta di Destinante sociale, che viene figu-ratiizzato dal douer mantenere un elevato tenore di vita sociale. Com-petente non è, però, secondo il /potere/, mancando dell'Adiuvanteche potrebbe permettergli di operare la trasformazione: il danaro conil quale por termine alla condizione di bisogno (o col quale mantenerela propria "visibilità" sociale), Del ruolo ambiguo che il danaro svolgenello scambio feneratizio s'è detto prima. Aggiungeremo adesso che,dal punto di vista attanzrale, il danaro ha uno statuto doppio. Da unaparte, e per alcuni soggetti, è quello che in semiotica si dice un oggettodescrittiuo, al pa-'i di altri beni che vengono desiderati per se stessi.Dall'altra, però, dal momento che è capace di conferire e/o accrescereil potere, è rn oggetto modale. Esso rende competente il soggetto se-
condo il potere.Venendo ora al mutuante, abbiamo detto che il suo programma
narrativo è quello della /accumulazione/: un'accumulazione giudicatasmisurata, pèrché fuori dell'ordine naturale del desiderio. Come diceBasilio (2.269C), <<i cani, ricevuto che hanno, si placano; l'usuraio, al
contrario, quando incassa, si eccita di più. E non smette di latrare, ma
chiede sempre di più» («oi rrlveq l,opptivovteg rlpepoOvtcn' o òè òcrver-
otlq l,crppdvov Trpooep€0i(etcxr. Ou yùp rcsrietcn ùl,cxrtdv, crLl,ù to nl,éov
èm(qtd».) (r1).Sembra pertanto che, in quanto soggetto, il suo fare sia
modalizzato da qualcoia di più che un semplice volere. C'è una so gliache egli oltrepaJsa, divenendo così oggetto di una sanzione socialenegatùa che lò bolla come «Qrl"apyopo?. Un individuo così potrebbediÀi avaro, ma anche avido. Quel che pare cratterizzare tanto labramosia delle ricchezze quanto la smania di conservarle ha a che farecon la duratiuità della giunzione e sembra così appartenere al pianodella aspettualità. La cosiddetta <<semiotica delle passioni>> (r2) ha co-struito un modello, che potrà aiutarci a mettere ordine nell'universopassionale dell'usuraio. Di questo modello illusreremo solo gli aspetti
1lt) Nel fare questa notazione Basilio potrebbe avere in mente un giudizioexempli gratia come quello di Solone: <<fl)'odtou ò'orlòèv réppcr re$uopévov «ivopdor
reitoi» (fig. 1,71G.-P.;. M, pott"bbe aver voluto far riferimento al passo delDe cupid.
diu. (4.5248-F), dove Plurarco definisce la bramosia delle ricchezze come una forma didesiderio che confligge con il proprio soddisfacimento: «'AÀ.À.ù xcrì toOto tfrg Qt)'apyt -piogiòtov'èrtOupioytipéott polopévr1 rpòq tlv crutflg rl"riproorv»' Ad ogni modo, il mo-
tivo dell'insaziabilitir era troppo diffuso presso gli soittori dell'antichità perché si
possa patlare di allusione da parte di Basilio.(r2) In quel che segue faremo riferimento al volume di Greimas et Fontanille,
Sémiotique des passìons, cit., specialmente ai capitolo 2, che ha per titolo, nella tr' it. da
cui citiamo: «A proposito deil'avarizia», pp.94-1,65.
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
che sono maggiormente iegati al tenore del presente scritto.In termini dizionat'rali,l'ava1rzia è definibile come una forma di
attaccamento al danaro secondo forme e modi che la morale correntegiudica eccessivi. Se, come abbiamo visto, il rapporto con Ia icchezzasi traduce nei termini sintattici della giunzione di un Soggetto con unOggetto, la passione sembra introdurre in questo rapporto la que-stione dell'intensità e il riferimento ad un sistema di valori assuntocome metro per valutare le varie forme di giunzione. Per Greimas eFontanille l'avaizia ha due forme. La prima è dinarnica e consiste nellacongiunzione. La seconda è una forma statica e consiste nella non-dis-giunzione (la ritenzione). Inoltre la prima consiste nell'accumulare,mentre la seconda si esplica nel trattenere le ricchezze. Così avremmodue modi di essere avaroi c'è un avaro Qtl,tipyùpo€, che vuole semprepiù di quanto abbia; e c'è un avaro Qstòro)"6g, che mira alla conserva -
zione di quanto possiede. Talvolta questi due modi possono coesisterenello stesso individuo. Plutarco, ad es., scriveva che i qtl"dpTopor(cioègli avari cumulativi) accumulano come i prodighi, mentre spendonocome gli avati (scil. come gli avari ritensivi) (:r;. Vediamo nel solitoquadrato questi modi di essere, ottenuti proiettando la categoria dellagiunzione:
avarizia 1
CONGIUNZIONE DISGruNZIONE
AVARIZIA
NON-DISG.avarizia2
NON.CONG.
1tt) De cupid. diu. (5.5258) «oi òè qtkipyupot rtdvtot pèv ò6 nol,rtel,eig lpdvtor ò'
ògdvel.erioepot». Sottolinea Capriglione (Plutarco, La brarnosia di riccbezza. Introdu-zione, testo critico, ffaduzione e commento a cura di J. C. Capriglione e L. Toraca, [=Corpus Plutarchi Moralium, n.l, D'Auria, Napoli, 1996) che la terminologia è la stessaimpiegata da Aristotele, <d'avaro è aneleutheror tanto nel senso che non ha alcunaforma di generosità verso gli altri, quanto nel senso che si fa schiavo (...) di se stesso edella propria mania>> (p. L75).
t55
t56 Marcello La Matina
Quali sono i ftatti, per così dire, distintivi di questa passione?Vediamolo dal punto di vista del soggetto appassionato. Anzitutto,come si rilevava due paragrafi avanti, c'è la sua aspettualizzazione. Arendere riconoscibile la passione dell'avaro è il carattere iterativo dellacongiunzione e il carattere continuativo della non-disgiunzione. Vale a
dire che l'avaro cumulativo deve acquisire sempre nuova ricchezza,mentre l'avato ritensivo non deve mai perdere, nemmeno per unistante, quella che già possiede. In secondo luogo, è possibile che lacompetenza passionale funzioni come un simulacro del soggetto ap-passionato. Questo vuol dire che, da un lato, <<anche se prova unasoddisfazione nell'accumulare ùcchezze, I'avato non per questosmette di accumularne>> (p. 99).8, dall'altro, che «ciò cui mira l'avaronon sono tanto le dcchezze che accumula» quanto I'immagine-scopodi se medesimo circondato dalle icchezze. E un vedersi, o piuttosto un"sembrare" dell'/essere/ del soggetto. Questa immagine-scopo - ac-cessibile solo al soggetto - raffigura iI punto terminale di un pro-gtamma narrativo di accumulazione/conservazione che attende di es-sere compiuto. L'avaro si serve di questa rappresentazione mentaleper generare a posteriori la sua motivazione e la sua competenza.
C'è però anche un punto di vista sociale da prendere in conside-razione. Infatti, possiamo immaginare l' avaizia solamente sullo sfondodi una compagine sociale entro la quale le dcchezze siano consideratecome beni circolanti. Pertanto, l'accumulazione e la conservazione didcchezza resultano atteggiamenti eccessivi, cioè in definitiva, passioni,solo in quanto creano un ostacolo a questa «disposizione generale allaridistribuzione>> (p, i01). Si può allora rivedere la definizione comunedell'availzia'. <<L'avarizia non è dunque la passione di colui che pos-siede o che cerca di possedere, ma la passione di colui che è di ostacoloalla circolazione e alla ridistribuzione dei beni in una cornunità data>> (p.
10L; corsivo degli autori) ('a). Pertanto, è solo indirettamente chepossiamo definire I'avaizia facendo ricorso alla giunzione. Di fatto, ilcatattere essenziale di questa passione - come si vedrà bene nel pa -
rugrafo successivo - è quello di produrre delle alterazioni (giudicateindesiderabili dal punto di vista dell'osservatore sociale) nel processoregolare della circolazione dei valori in una società.
1la) Un concetto affine - quello della rtforq, che ostacola la pflotg
- si rimovaanche nell'antichità. Si veda e.g. il seguente passo in De cupid. diu. diPhtarco (6.525F-
526A): «Ordunque, come proviamo fastidio e disgusto per le vipere, le cantaridi e letarantole, più che per gli orsi ed i leoni, dal momento che quelle uccidono senzaricavare alcunché da quanti muoiono a causa loro (6tt xteiver roì on6l),oorv crvOpotooqpr1òèvprripevotoigdrol,l,upevorq òr'oùtdv), così bisogna provar disgusto, più che per idissipatori, per i perversi per micragnosità e gli avari, dal momento che questisottraggono ad altri cose di cui essi, per natura, non possono e non vogliono far uso(dQcnpo0vtor yòp rIl,l,ov, otg outoì pfroOor p{ òr5vovtor pr1òè negtruorv)>> [tr. it. diJo-landa C. CapriglioneJ.
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
3.2. La storia di un usuraio auaro
Gli indizi della passione fin qui individuati trovano esemplifica-zione in un passo dell'omelia di Gregorio (205, l-26). Si tratta di unsegmento narrativo, intercalato alla argomentazione, mediante de-brayage_enunciativo ed entbrayage enunciazionale (rr). In questo seg-mento l'Enunciante racconta la vicenda, che ritiene paradigmatica, diun locale usuraio («'Avr(p ctg frv ènì tfoòe tnq 7r61"€ogn), prEsentanàoiacome vera. I1 fatto che gli indici personali dell'attore (nome, casaro,ecc.) vengano espunti («orir àpd òè ro{lvopcr rolprpòd.v òvopcroo tòvte).euoiocrvtcr Qol,ott6p"evo9>) può essere ffattato come un segnale direalismo ()6). Anzi, proprio questa reticenza si presume inneschi nel-l'Enunciatario (= i fedeli presenti) un programma di agnizione:<<ascoltate il discorso e forse la più parte di voi scoprirà che la storia ènota>> (204,29: droriocte toO 1"6yoo, roì rdla oi roi,l,oì tfiv ùzr60eorv @q
Tvroprpov èmTvooeo0e).Dunque, viveva in città un uomo di mestiere usuraio (tépqv
é1rr» tù òcxveiopoto), vittima della passione dell'avarizia (r,Cp nri0er òàouveldpevoq tfq Qrl,crpyupiaq). Qui Gregorio congiunge in uno stessopersonaggio i due aspetti della accumulazione (<<traeva guadagno dalleabominevoli usure>>, tfiv èr tdv prcrp6v rdrov bcrxopniov) e della ri-tenzione [«era tirchio anche nello spender per sé - ché tali appuntosono gli avàri>>, Qeròrol,oq r]v rccrì nepì tfiv iòicrv òcrnrivqv (toro0tot yùp oiQrl,apyupor)].Il lessema «Qeròro[69> viene poi espanso attraverso per -
corsi figurativi che diremmo topici: sicché, Gregorio aggiunge che ilnostfo avaro <<non imbandiva mai una tavola con cibi a sufficienza>>,<<non mutava frequentemente d'abito>> <<né offriva ai suoi figli il neces-sario per vivere>> (rz), Questo, a livello figurativo.
A livello attanziale, il soggetto è contraddistinto da due pro-grammi narrativi. Da un lato, un programma di accumulazione: tro-vare in ogni modo nuove entrate (rudvrcr òb tpdnov ènrvo6v, 60ev cÌv èrì
(r') Con l'espressione 'débrayage enunciativo' intendiamo riferirci all'opera-zione che, muovendo dal soggetto dell'enunciazione, proietta e installa nel discorso de-gli attanti dell'enunciato; al conrario, l'espressione 'erzbruyage enunciazionale' fa rife-rimento al movimento di ritorno al piano dell'enunciazione. Esse sono usate in questocontesto per designare nel primo caso lo spostamento dell'asse narrativo verso leforme dell'enunciato enunciato (= l'istallazione del racconto coi suoi attori, ecc.), e nelsecondo caso per segnalare come l'enunciante ritorni su alcuni elementi del piano del-I'enunciazione (= il programma di agnizione suggerito all'enunciatario, la cancella-zione de-gli indici referenzialiper ottenere pedocutivamentevn e/fet de réel).
('6) Srrl rapporto tra "indici t.rtrìli" e realismo n^.rrii.,o si veda il nosro«Realismo e indicalità nei testi narrativi>> in Versus. Quademi di studi semiotici, 42(1985), pp.75-84.
(,7) Qui Gregorio porebbe aver attinto ancora una volta a Plutarco. Si veda Decupid diu.,4.524F: <<ro,itor n<ig oo povrxòv où6'oixtpòv rò nrieoq, ei a6 ipotirp pù xpitor6rò tò iryotv pq6'dptql òrà tò nervflv pnòà rÀ.orjtrp òtò tò grÀorl.outeiv».
t57
158 Marcello La Matina
tò rl,éov tòv opr0pòv TrposTdyol tdv lprlpdto:v); qui risalta il carattereiterativo della congiunzione, tipica dell'avaro cumulativo. Dall'altrolato, un programma di occultamento delie icchezze, che porta il sog-getto avaro a non fidarsi di nessuno (otte pÌ1v cr§r6rctor6v ovcr Q{}"«r«toO po}"«vtiou àv6pr(ev). Così scopriamo un altro tratto del soggettoappassionato: egli non può avere adiuvanti, né umani (ot térvov, oòòo0),ov, oÒ tpcme(itnv), né cosali (oò rl.dv, ou oQpcryìòcr). Il programmadi occultamento fa anche emergere l'aspetto sociale della passione:l'avaro sottrae il danaro alla circolazione e alla redistribuzione sociale.Semmai, la chcolazione è possibile entro un luogo segreto: <<riponevainvece l'oro nei penetrali dei muri e, cospargendo d'olio la materiafangosa dell'esterno, custodiva a tutti sconosciuto il tesoro (ciTvr»otov
ndorv dilev tòv 0qoaup6v), per di più spostandolo di luogo in luogo, e dimuro in muro, e badando sapientemente acché nessuno se ne avve-desse (rcrì tò ì,crw0«ivav ncivtcrg ooQt(6pevoq eupql<lvcog)».
Se non che, improwisamente, l'avaro muore e il suo danaro ri-mane per sempre nascosto a tutti. sottratto alla lpfrorgdalla passioneper la rctfrorg, l'oggetto di valore è ora per sempre negato alla redistri -
buzione. E qui Gregorio scherza sul doppio occultamento, del Soggettoe dell'Oggetto, espresso figurativamente dalla «sepoltur»> di entrambi:<<Improwisamente lasciò questa vita (o0p6ov crrfr)"Oe to0 Fiou) senza
aver rivelato ad alcuno di quei di casa doue l'oro fosse sepolto (ouòevì
t6v oireiov è(cryoperiocxq, évOo ò pmòq rst,roprriptrto). Fu sepobo pertanto anch'egli, guadagnandoci l'occultamento (rotoprix0rl pèv o8vrcxrdvoq tò rprirycn repòcivcrg)>>. Ne faranno le spese i figli, che avevanosperato di ricavare dalla morte del padre una certa agiatezza e che si
uèdorro invece costretti a raccogliere una eredità di stenti, maledicen-do ogni dì la stoltezza del padre (òtdyotor òà tòv Biov ciotrov «ivéooor,névqteq, èncxpr6pevor mo)")"ò raO'èrdotlv tfr toO notpòq potat6tqtr).
Due osservazioni a conclusione di questa parte. Abbiamo vistoprima come Greimas e Fontanille definissero I'avaizia un ostacolo allaiedistribuzione delle icchezze in una società; soprattutto un ostacoloalla circolazione sincronica àelle ricchezze. Ora questo apologo ci mo-stra come I'avadzia possa essere uri ostacolo per la circolazione anchediacronica delle ricchezze. E questo pare fosse vero perfino nel caso incui i figli venivano regolarmente designati eredi delle sostanze paterne.Su questa forma di avadzia diacronica scriveva e.g. Plutarco, De cupid.
diu.,7 .526/'-8:
<<"Per Zeus!' potrebbe dire qualcuno "ma costoro lscil. gli avai)conservano e tesaùrizzano per i figli e gli eredi". E come? A questi, infatti,quando sono ancora in vita, non danno alcunché (.,,) E perché vogliono la-sciare ai figli ed agli eredi molte ricchezze e un gran parimonio? Ma è
chiaro: perché anche questi li conservino per almi e questi ultimi per i figli,come i condotti di terracotta che nulla conservano per sé, ma ciascuno fadefluire verso un altro quanto riceve>> (tr. it. J. Capriglione).
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura t59
Inoltre, sempre Greimas e Fontanille padavano dell'avadziacome di :una alteruzione giudicata indesiderabile dal punto di vista diun osservatore sociale, in senso cioè orizzontale. Oru, anche nel nostroapologo l'oratore si comporta come un osseryatore sociale, ma pro-spetta all'avaro una doppia sanzione negativa: <<sterile affaista che haconcluso la sua vita così come I'aveva vissut»> (205,28i ri§ioX ro0 tp6-,roD Kcr,xc,ocpéycxq tòv pi.ov aveprofrog lprlpotrotr{q), questi lascerà ineredità ai figli la povertà e a se stesso la pena eterna. Si vede bene chela sanzione viene emessa con riferimento ad una norma e ad un At -
tante di rango superiore. V'è dunque nel richiamo a Dio e alla sualegge un tratto di uerticalità, che si aggiunge allo statuto dell'osserva-tore sociale modificandolo in senso sincretistico. Così, l'Enunciante,incaricato di parlare nel nome di Dio, è al tempo stesso attante valuta-tore ed anche soggetto-destinatario di un fare cognitivo che può esserericondotto all'iniziativa di Dio stesso. Questo vuol dire che l'istanza dimoruIizzazione è in questo caso sì delegata ad un osservatore sociale,ma che quest'ultimo non agisce per delega della comunità. L'omileta èun "editor" della Parola di Dio.
).3. Il soggetto dell'enunciazione
Nel descrivere il contenuto delle due omelie, di Basilio e di Gre-gorio, ci siamo essenzialmente collocati al livello dell'enunciato (r8). Daquesto punto di vista, un enunciato, sia pure sintagmaticamente estesoquanto i nostri testi, è - lo abbiamo visto - il luogo nel quale il sensosi articola secondo modalità che spetta ad una teoria mettere in luce. Equel che appunto abbiamo cercato di fare è stato costruire unpercorso che da certe unità tematiche minimali ci portasse a certe al -
tre unità narrative (gli attanti) considerate nel loro 'fare' e nel loro'essere'. È emersa cÀì la struttura narrativa del prestito usuraio e lastruttura passionale di almeno uno degli attanti coinvolti in essa, l'a-varo mutuante. E emersa, in sostanza, la struttura semantica dell'e-nunciato-testo.
Ma un enunciato non è soltanto il luogo in cui si iscrivono leforme del senso. Non è soltanto una struttura formale. Esso è ancheun prodotto, la cui esistenza presuppone un atto di enunciazione. L'e-nunciato-testo è così un oggetto scambiato fta gli attanti della comuni-cazione:l'enunciante, che gioca il ruolo del Destinatore (implicito) el'enunciatario, che gioca il ruolo del Destinatario (implicito) della co-municazion e (32).
118) Uso il termine 'enunciato' solo in quanto si contrappone al termine'enunciazione' nel metalinguaggio in uso.
1:r) Da ciò non segue che l'enunciatario abbia per Greimas un compito solo
160 Marcello La Matina
Le nostre omelie sono state anzitutto pronunciate in un contestoliturgico alla presenza di un Enunciatario - come abbiamo detto -portatore di una istanza sociale generulizzata. Collocandoci al livellodella enunciazione, vediamo di ricostruire il fare (e un po' anche l'es-sere) degli attanti della comunicazione. L'omileta agisce in un contestorituale. La sua performance va quindi letta come l'esecuzione di unprogramma di cui egli è soggetto-destinatario e di cui Dio (= la sua pa-rola canonica) è il destinatore implicito. La performance consiste nelmettere in atto un fare persuasivo mirante a far accogliere dall'Enun-ciatario il contratto fiduciario sul quale si basa la riuscita della comu-nicazione. Alla base del fare persuasivo dell'Enunciante c'è dunqueun /volere/ che l'Enunciataio modifichi le proprie credenze nel sensoprospettato dall'Enunciante.
Ma il fare dell'omileta può avere - e spesso ricerca di avere -degli effetti perlocutivi (+oi. Si tratta non solo di insegnare o persua-dere, di far sapere o far credere, ma si tratta di creare anche degli ef-fetti passionali, come la gioia,la pietà, ovvero l'indignazione, f ira e
perfino la collera. Notano opportunamente Greimas e Courtés {op. cit.,p, 251.): <<per noi, la nozione di perlocuzione dipende così in parte da
una semiotica cognitiva e da una semiotica delle passionb>. Attraversoil meccanismo della perlocuzione, il dire fa irrompere nel contesto co -
municativo il corpo dei partecipanti, modificandone la disposizione'C'è allora un piano passionale dell'oratore e dell'ascoltatore, certa-mente legato alla circolazione e alla manipolazione di oggetti cognitivi,ma che trascende il piano cognitivo. Contentiamoci di cogliere gliaspetti più rilevanti di questo complesso ingranaggio comunicativo,partendo ancora una volta dai testi.
3.3.1. La "passione" ueridittiua
I1 primo compito che l'oratore assume è quello di demistificareuna serié di camuffàmenti operati dell'usuraio, facendo emergere agli
passivo. Egli scrive infatti [con Courtés] che <d'enunciatario nòn è solamente il destina-
iario della comunicazione, ma anche il soggetto produttore del discorso, poiché la"lemura" è un atto di linguaggio (un atto di significazione) allo stesso titolo della pro-duzione dei discorso propriamente detto» (Greimas et Courtés, op. cit.,p.ID)'
1+o) La perlocuzione è così definita dal filosofo J. L. Austin: <<Il dire qualcosaprodurrà sovente, o addirittura di norma, determinati effetti conseguenti sui senti-menti, sui pensieri, sulle azioni di un uditorio, o di colui che parla o di alri individui; è
anche possibile dire qualcosa col preciso scopo, con l'intenzione o il proposito di pro-dure tali effetti. [...] Chiameremo l'esecuzione di un simile atto esecuzione di un attoperlocutorio o perlocuzione >> (maduco Austin, How to Do Things uith Vords, The\X/illiam James Lectures at Harward University, 1955, a cura di J. O. Urmson, OxfordUniv. Press, London 1962, p. l0l)
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura 16l
occhi dell'Enunciatario la verità dell'essere. Questa operazione dismascheramento è un tratto che accomuna Ia performance oratoria diBasilio a quella di Gregorio. Entrambi sanzionano negativamente ilcomportamento dell'usuraio, in apparenza amichevole, ma nei fattiostile. Possiamo confrontare i punti di vista. Così Basilio, descrivendo ilfare del mutuatario t.268A: «'Enì ouppuxiav èl,0rov lscil. 61pec6otqqJ,rcolÉprov e$pev. 'Ale6r0rippcrru nepr(r1tdlv, ònl.ntnpiotq èvétu1o>. E cosìGregorio (196,23), rivolto invece al mutuante, destinatario internodella sua omelia: «où òb toòvclvtiov noreìq' ò or5ppcrxqE ÉvtJ nol"eproq' oùyùp crutQ lscil. {p xper,roql oupnpcittetq. òrurog crv r«ì tfrq ovdyrrlq è-l"erOepro0etrl tfr q èmrerpévqq».
L'oratore denuncia e smaschera anche il camuffamento dell'og-getto di valore, presentato dagli usurai come un Adiuvante - dunquecome un oggetto amichevole. E amichevole vuol dire: «oggetto la cuicongiunzione è desiderabile», II gioco mistificatorio consiste appuntonel far apparire come desiderabile per il mutuatario Ia congiunzionecon la rièéhezza data in prestito. C'è anzitutto un camuffamento del/fare usuraio/ che potremmo definire linguistico-attributivo; nelle pa-role di Gregorio: (202,14 Kcrl"o0or òè trlv crpapticrv oepvoiq ovdpuor 0r-).crvOprorov tò ),i1ppcx npoooyperlovt€g). E c'è un camuffamento che di-remmo modale. Lo mette a nudo Basilio (1.268A-8), svelando che sottoil pretesto di un altruistico /dover-farc/ (léovnapcrpuOeìoOcn to0 ovòpòq
r1v ntoleicrv) l'usuraio nasconde il /voler-essere/ caratteristico dellasua passione (où òà noltnl,cxorcr(erq t{v évòercxv, èrrcxpno0o0cn (qt6vt{v épqpov). Il parallelismo sintattico rivela in molti punti delle oruzionila contrapposizione semantica tra una categoria dell'apparire e unacategoria dell'essere.- Un altro tipo di camuffamento - questa volta non attribuibile al
mutuante, -u ad una sorta di miopia del mutuatario - è quello già
trattato sub2.2.L a proposito della scansione temporale del prestito. Itesti grosso modo dièevano <<Non appena avuti i soldi, il mutuatario è
felice, ma poi piomba in una continua infelicità». Anche in questo caso
Basilio e Gregorio smascherano il camuffamento del tempo di con -giunzione, considerato dal mutuatario come tempo di arricchimento,ir..rt." di fatto è un tempo di impoverimento progressivo. C'è alloraun tempo dell'illusione (euforico) e un tempo della realtà (disforico). Ilpovero mutuatario, come puntualizzaBaslio (1.268B-C), non ha scelta.Il srro comportamento è determinato da una competenza modale che èstretta fra
il /non poter fare/:
<<Colui che cerca il prestito è preso in mezzo dall'impotenza. Da un latoguarda alla povertà e dispera di poter saldare il debito» (rcri ò pbv (nt6v tò8dveropcr, péoog ripqXoviuq uner)'qppévoq, òtcrv pàv rpòq tflv rcevicrv aniòr1,
onoytvororer tìv értrotv )
162 Marcello La Matina
ed il /dover fare/:
<<dall'altro, guarda alla presente necessità, e decide di rischiare il prestito».(6tsv òè npòq tr\v ncxpo0ocrv civriyrqv, rcrtutol"pQ toO òcrvei.opa,toq).
Pertanto, sia il mutuante sia il mutuatario sono, per ragioni di-verse ma legate al loro ruolo attafiziale, dei soggetti in gioco fra rcaltà e
illusione. Sicché tutti gli interventi sanzionatori degli oratori sono voltia mostrare il contrasto tra un ualore illusorio manifestato (= la filantro-pia del mutuante, Ia icchezza prestata, il benessere conseguente alprestito) e rn ualore reale non-manifestato (= la misantropia del mu -tuante, il danaro gravato dai tassi d'interesse, la povertà conseguenteallo sperperamento del capitale ricevuto). Riassumendo, abbiamo leseguenti contrapposizioni:
SOGGETTOMUTUANTE
OGGE,TTO
SOGGETTOMUTUATARIO
Donatore apparente'Ercì ouppalicrv è1.0òv
Danaro come Adiuvante'Al,e(rQ<ipporo
Congiunzione euforica
répne'ce rpòq ò)"t1ov
vs
vs Congiunzionedisforicavs {iotepovòr1}"qtriptov
Donatore ostile
nol.Éptov e6pev
Danaro come Opponenteòr1Àqtqpforq
VS
VS
Il fare persuasivo del soggetto dell'enunciaziote è volto a delibe-rare sull'esseie dei valori in gioco. Lo smascheramento dell'apparenzafallace costituisce una parte del gioco veridittivo. L'altra consiste nelmostrare la verità dell'essere che non si manifesta, ma rimane segreto.Prendiamo, ad es., dei frammenti dal testo di Basilio' Egli si rivolge almutuatario - cui è indirizzata la sua omelia - e dice che il prestitonon libera dal bisogno:
«Sopportiamo oggi Ie difficoltà che scaturiscono dalla povertà e nondifferiamole a domani. Se non prendi il danaro sarai povero sia oggi sia
domani; se, invece, 1o prendi sarai più penosamente logorato, poi che l'u-sura accresce la povertà>> (2.212A-B xripepov rri0ropev tà èr tflq èvòeic4, òu o-lepf , raì gj oruot0rrlpeOcx eiq tùv s{iprov. Mfl Eoverocxpevog pèv opoiroq éor1 révr1g
ruì o{pepov rcrì rpòq tò èQeEIìg' Eoverodpevoq òÈ 1oÀercotepovèrtpulroOrion, toO
tdrou tqv nevicrv npooentteivovtoq. )
Poi argomenta (2.269C) che chi è povero è ancora libero (névqg
d v0v, «1"1"' èi"er50epoq): se invece prende il prestito non arricchirà e, perdi più, diventerà schiavo del mutuante: uno schiavo mercenario co-sretto ad una inesorabile schiavitù (Acrvetoripevoq òè ouòb nÀotroioag,
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
rcrì t{v èX,eu0epicrv crQcnpe0rioq. Ao0},oq to6 òeòaverrdtoq ò òover<rd,pevoq,roì òo0l"og pro0oQ6poq crncxpcritqtov Qéprov tlv ).ettotpyicv). Infine, as-serisce che chi prende prestiti si priva della tranquillità, l'unica cosa ingrado di differenziare il povero dai ricchi: (3.273A'Evì tor5trp òroQép«*-pev t6v nX,outorivtrov oL névqteg, tfr upepruvfg. Kcrì rcrt«yel,6pev orit6vaypuruvotvtrov, cròtoì ro0eri6ovteq' roì tdv otveotritcov ueì xaì Qpovc-(6v tr»v, oòtoì <iQpovtoto0vteq rcrì uvetÉvot ).
E possibile mostrare il lavoro veridittivo operato da Basilio, rap-presentandolo nel quadrato seguente. Ricordiamo che - come s'èdetto alla nota 24 - il quadrato della veridizione mette in relazionedue schemi: quello della manifestazione (apparire/non-apparire) e
quello dell'immanenza (essere/non-essere). Il "gioco" della veridizionecomporta perciò che il soggetto incaricato di esercitare l'attività veri-dittoria (= l'oratore come osservatore sociale e come attante valuta-tore) muova da ciò che /appare/ sull'asse della manifestazione per di-svelare ciò che /non-appare/ e deliberare su /ciò che è/ (= 5r1'utt.dell'imman enza).
VERITA
161
manqueI
<<ora»
NECESSITA«dooo,
BENESSERE
non-essere
prestito
SE
GRETO
ILLUSIONE
essere
non-aPParlre
NON-BENESSERE NON-NECESSITA«non-dopo, «non-ora»
rldebito sneranza
FALSITA
Quello che il povero vede è che <<ora>> c'è una situazione diNECESSITA che scàturisce da una manque. Egli spera pertanto cheattraverso il prestito la necessità sarà negata (= NON-NECESSITA) enon sarà più presente (= <<non-ora). Pertanto egli considera lI prestitoche ricevèrà come :una gffanzia del BENESSERE futuro (= «dopo»).Fin qui i valori in campo per il povero mutuatario. A lui Basilio diceche là NECESSITA è reale (= corrisponde all' /essere/) e che la t'-c-
chezza prestata corrisponde a un BENESSERE apparente (= si trova
t64 Marcello La Matina
sull'asse della manifestazione). Inolre gli dice che sia la speranza dt al-lontanare la necessità, sia l'agiatezza conseguente al prestito (= NON-NECESSITA + BENESSERE) sono valori illusori (si trovano entrambisulla deissi dell'tttustONE). Ne consegue che ogni tentativo di sot-trarsi alla povertà mediante prestito a usura conduce ad una condi-zione di debito, cioè a un NON-BENESSERE, che è uguale a quello pre-sente - se non peggiore -, D2 che non è visibile (= si trova difattisulla deissi del SEGRETO), (Allo stesso modo potremmo mostrare, con-trapponendoli sullo schema apparire/non-apparire, gli altri terminiomologabili: «libertà» as <<non-libertà>> e «dpeprpvicr>> zs <<Qpovtig>, checompaiono nei due aitri frammenti citati sopra,)
3.3.2. Valori e antiualori
Anche Gregorio lavora a scardinare, attraverso il gioco veridit -
tivo, gli endoxa del suo destinatario, che è l'usuraio. Questi è convintoche il suo fare sia apportatore di guadagni? Ebbene, Gregorio gli pro -
pone di dbaltare le sue credenze. Si veda il passo seguente (206,16):
<<Ma io per prima cosa annunzio e proclamo il donare. Poi racco-mando anche il conceder prestiti. Infatti il prestito è una forma di dono.Raccomando però che ciò sia fatto senza usure né interessi, ma come la Pa-
rola di Dio ha disposto per noi. Allo stesso modo infatti è meritevole di pu-nizione sia chi non concede il prestito sia chi 1o concede ad usura. Poichédel primo viene condannato l'atteggiamento disumano, e del secondo l'atti-tudine mercantile>>. (èyò òà rp6tov pèv tò Eropeìo0crt 8rorqpriooro rcrì rcxpuy-yé}.),ro: érema rcxì tò òo,vei(erv rcx,paral,6 (òeritepov yàp eìòoq òoryedq ò<iveropc),rowìv Eb toOto pfi petù t6rr»v pqòà nleovaopdv, «il,),ù ro0òg nprv o Oeìoq, òte-ru\arc À61o9' òpoirog 1àp évo1og upropig ruì o pi1 òròoùg òdveropo rcrì ò petàtdrrov Eròodg, èreròt1 to0 pèv tò ptod,v0pronov toO òb tò rarcrlltròv rutorérpt-trxr.).
che presenta coincidenze con le seguenti aff.ermazioni di Basilio. Laprima (5.277D-280A) sul prestito gratuito:
<<Da' il danaro che giace senza scopo, senz^ gravarlo di interessi>>.(aòq tò eirfl reipevov opyriprov, ui Fgpdvrov oòtò taìq, rpoo0'rircng).
e l'altra (5.277.C) sulla congruità, fra prestito gratuito e dono, appafte-nenti al medesimo ordine di valori (si dirà dopo, alla medesima deissi):
<<Quando ti accingi a d,arc al povero per il Signore, il prestito è lastessa cosa che il dono; è dono perché non c'è speranza di restituzione, edè prestito, a causa della munificenza del Signore che ti compenserà in vece
di quello: Egli, per quel poco che ha ricevuto attaverso il povero, molto tirestituirà al posto loro>> ('otov nxorx| ncrpÉ26etv pél,l,ng òrò tòv Krlprov, tò oòtò
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
rsì ò6p6v èotr rcrì Edvetolro' ò6pov pàv Erù dlv &vel.ntodcw tflq, «inolriryerog,
òdveropo òè òrù tflv peyol,o8opeòv toO Aeorcdtou toO dno trwr5vtoq ùrcbp auto0,òq, prrpù l"opòv 6tù tot révr1toq, peyriX.o ùràp cròt6v «inoErooer).
Qui il discorso viene riportato sui comportamenti del mutuante.Gregorio pone su un piano due soggetti avad (<<chi non concede il pre-stito>> e <<chi concede il prestito ad usura>) e su un altro due compor-tamenti generosi («il donare>> e <<i1 prestare senza interessi>>). Basilioconferma il fatto che <<donare>> e <<prestare seflza interessi>> sono at-teggiamenti conformi in una assiologia euforica. Inoltre, con l'accennoallafigura del <<danaro che giace senza scopo>>, cioè inutilizzato, lasciaintravèdere il tema della /ritenzione/, tipica dell'avaro. E assai faciledisporre questi termini sul quadrato semiotico. In questo caso i valoriin gioco sono le possibilità fra cui può scegliere l'usuraio avaro.
tò rcrrur1ì,rrdv generosità 1
ò petcr t6rov òtòor5q òropeioOot
/donare//prestare ausuraf
ltx(J)xo)
fiorpeNelv
165
_l
sL
s2
/ritenere/o pl òtòoùq òcivetopcr
tò eirfr reipevovdpyriprov
tò ptociv0pCITrov
/prestare gratis/
òovei(erv...pì pecò t6rrrrv
òòq ... pn pcrprivorv
cnitò rpoo0r(rmg
generosità 2 -
Solo qualche commento. I quattro comportamenti presenti nelquadrato rappresentano <<quattro attitudini fondamentali dell'uomo difionte agli oggetti di valore» 1tr). La deissi di sinistra (tò r«tr'1ltr6v/ùproavOpòrov) mostra come il comportamento dell'avaro ritensivo (« ò
pr'1 òròoùg ò<lvetopa») sia presupposto da quello dell'avaro cumulativo(«o petà tdrov òtòor56»). Inutile dire che questa deissi è disforica e i
(aI) Greimas et Fontanille, op. cit.,p. lL5.
166 Marcello La Matina
comportamenti sono sanzionati negativamente dall'attante valutatore.La deissi di desma (ntroXr0 napéye:) mostra il rapporto di implicazionelogica esistente tral'attività, del donare e quella del prestare gratis («tòcxòtò rcrì ò6pdv èott rcrì òavetopc»> dice Basilio; <<òer5tepov yòp eìòoqòrrlpedq òrivetopo> gli fa eco Gregorio). Entrambe sono collocate nelladeissi euforica e fatte oggetto di una sanzione positiva da parte dell'at-tante valutatore. Così come si è fatto a proposito dell'avarizia, pos-siamo - seguendo Greimas et Fontanille - individuare nel ò<opdo0ore nel òcrvei(etv gratuito due forme distinte di generosità.
4. Rilievi conclusivi
Nel corso di questa analisi abbiamo rivolto la nostra attenziofie a
tre aspetti concernenti il contenuto delle omelie di Basilio e Gregoriosull'usura. Anzitutto, abbiamo cercato di stabilire de1le isotopie (a2),
ossia dei percorsi di senso che permettessero una lettura omogeneadei testi in questione, Nel far questo avevamo presenti due requisiti:(1) che le isotopie prescelte fossero leggibili in entrambi i testi, in mododa poter osservare comparativamente il senso testuale; (2) che il mododi reperire le suddette isotopie potesse avere un valore metodologico.Pensiamo di aver soddisfatto entrambi i requisiti. In particolare, il se -
condo ci ha portato a scegliere come punto dipartenza dell'analisi illi-vello intertestuale - contrariamente a quanto accade di solito. Ave-vamo così una base per mettere in relazione il testo religioso primariocon le nostre due omelie, che del primo costituiscono una sorta dicommento o espansione tematica.
I1 secondo obiettivo era di ricostruire, anche un po' con finalitàmetodologiche, la tessitura semantica di due testi che, già alla primalettura, ci erano parsi singolarmente ricchi e attraenti. A questo puntosi poneva il problema del metodo con cui fare ciò. Infatti la nostra«teiria dell'Editor» - di cui pure abbiamo usato qui qualche concetto
- non dispone aficota di categorie teoriche tali da consentire un ap-proccio comparativo dettagliato. Abbiamo perciò deciso di servirciàella semiotica greimasiana, soprattutto in ragione della sua finezzaeuristica e della sua compattezza terminologica -
qua e là ammorbi-dita per non affaticare troppo il lettore. Nessuna sorpresa, dunque,per questa analisi "à la Greimas", condotta da un analista così poco
(42) Sr1 concetto di 'isotopia' si veda A. J. Greimas et J. Courtés,\Sémiotique.Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, Tome 2, Hachette, Paris 1986, s.a.
<<Isotopie>>, pp. 127 s. Cfr. pure M. La Matina, «Isotopia e pragmatica del testo fua AJGreimas ed Ù. Ecor, inL.Melazzo and M. Herzfeld (eds),Semiotic Tbeory and Prac-
tice, Proceedings of tbe IIIrd Congress of tbe International Association for Semiotic Stu-
dies,Morfion-de Gruyter, Berlin and New York, vol. II, pp. 139'746.
Basilio di Cesarea, Gregorio di Nissa e le passioni dell'usura
"greimasiano". Del resto, siamo persuasi che la scelta di un metododebba obbedire solo alle necessità del1a ricerca.
Ad orientarci verso Greimas c'era poi il tema delle passioni, chevedevamo far da contrappunto a quello dell'usura. E come parlarcdell'usuraio senza patlare dell'avai,zia, della avidità? La semioticadelle passioni ci è stata utile in questo lavoro, sebbene iI nostro scavonel passionale non sia andato al di là della costruzione di qualche mo -
dello, al fine di far affiorate i legami talvolta invisibili che collegano unostato d'animo all'altro. L'indagine sulla sensibilizzazione e sulla mora-lizzazione sarà per un'altra volta.
Un altro aspetto di cui ci siamo occupati è quello della enuncia-zione. Si trattava di mettere in luce il lavoro compiuto dai nostri omiletiper assicurarsi un "contratto fiduciario" con i ioro rispettivi uditori.L'omelia tardoantica è un genere affascinante, che sa awincere per laestrema articolazione tematica e per la evidente uis oratoria. Dettoquesto, non giudicavamo opportuna una analisi di tipo tradizionale,fondata sul reperimento di qualche figura retorica e sulla ricostruzionedella <<struttura dell'argomentazione>>, Le nostre omelie avevano benaltro da darci che non la materia per qualche sterile tassonomia ditropi. C'era la materia viva e bruciante dell'usura: un tema che ancoroggi non manca di emergere dalle pagine della cronaca. E c'era lagrande energia costruttiva dispiegata dai nostri oratori per scardinareil sistema di credenze dei loro destinatari: in un caso (Basilio) possibilidebitori, nell'altro (Gregorio) possibili usurai.
Ora, l'aspetto che più ci ha colpiti è la presenza di moduli narra-tivi usati come strumenti di persuasione e di dissuasione. Gli omiletiraccontano in sostanza delle storie. C'è la storia del povero che va a
farsi un prestito e finisce male; e c'è la storia dell'avaro che va a pre-stare il suo danaro e finisce anch'egli male. Ma c'è poi la storia dellasalvezza, di un Dio che si offre come partner per l'usuraio e comemallevadore per il povero mutuatario. Ci pareva pertanto che questeomelie andassero lette soprattutto come macchine fabulatorie di untipo particolare. Apparecchi diegetici costruiti soprattutto per im-pressionare, nella penombra inquieta di una chiesa, un pubblico diascoltatori emotivamente disponibili. Ecco come il fare dei personaggirappresentati si piega alle esigenze perlocutive del narratore. Ecco lepassioni dell'oratore muovere le passioni dell'uditorio, assecondarle ostravolgerle, Per queste ragioni abbiamo dato spazio alle strategie at-tanziali e ai percorsi patemici. Purtroppo, non abbiamo potuto darealtrettanto spazio alle strutture discorsive, ai problemi della discorsi-vizzazione.
Un'ultima notazione. Abbiamo scritto anche per affrontare l'a-spetto veramente cruciale dell'enunciazione, ossia della comunicazionereligiosa. Qui, però, il modello predisposto da Greimas ci è parso pocoappropriato. Per questo abbiamo preferito il modello chiamato del-
167
168 Marcello La Matina
l'Editor (a,), che assimila, come abbiamo detto sub 1.2., il processo dellacomunicazione (della enunciazione) a quelio dell'editing di un filologo.Abbiamo visto infatti che l'Enunciante, per produrre il "suo" testo,non parte dal nulla, ma opera su un testo illimitato anteriore. L'e-nunciante non può allora essere assunto sic et sirnpliciter come la<<sorgente del messaggio». Quello che - per restare al caso presente
- un omileta fa è di editare, anche piuttosto creativamente, una partedi questo testo illimitato anteriore che abbiamo chiamato testo religiosoprimario. E nell'editare egli attiva - consapevolmente o inconsape-volmente - delle procedure di omologazione e/o di distanziamento ri-spetto al testo anteriore.
D'altra parte, neppure l'Enunciatario può essere consideratocome mero ricevente o <<punto terminale>> del processo comunicativo.Leggendo o ascoltando un testo, questi deve pian piano costruire iI te-sto sulla base di un semplice stimolo visivo o uditivo. Anch'egli pro-duce il "suo" testo operando su un testo anteriore, salvo che in questocaso il testo è costituito da un lato dagli stimoli (= il veicolo testuale, vi-sivo o uditivo) e dall'altro dal testo illimitato anteriore (che egli può re-attivarc in memoria e) che deciderà di impiegare per dare un sensoagli stimoli, visivi o uditivi, Pertanto, quello che un lettore o un ascolta-tore fa è di editare, talvolta creativamente, questo testo illimitato ante-riore. E questa sua edizione può essere mentale (senza, cioè, produ-zione di stimoli), ma anche parlata, scritta, ecc.
Il vantaggio di trattarc così la comunicazione risiede soprattuttonella possibilità di spiegare teoreticamente tutti i casi in cui un testoprodotto si differenzia dal testo anteriore. Compresi i casi di incom-prensione (misunderstanding), i lapsus linguae, gli scambi di parole(malapropisrns) assai comuni sia nella comunicazione ordinaria sia, p.es., nella trasmissione testuale manoscritta. In sostanza, 1o studio del-l'editing, essenzialmente comparativo, si prefigge di evidenziare e
spiegare la differenzialità osservabile in almeno due testi (o in un testocon varianti, riscritture, ecc.) nella persuasione che sia il fare compa-rativo la condizione preliminare per una interpretazione.
1+t) Cfu. M. La Matina , Il testo antico, cit., pp. 117 -129.