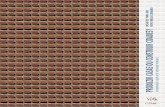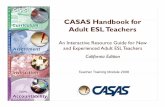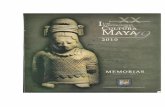Chalcatzingo, Morelos, Durante el Formativo: Una “Sociedad de Casas"
Bartolomé de las Casas, avvocato dell'umanità
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Bartolomé de las Casas, avvocato dell'umanità
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, AVVOCATO DELL’UMANITÀ...........1La questione dell’affidabilità delle fonti..........7
IL CONTESTO STORICO..................................9Ci possono essere degli esseri umani che non discendono da Adamo?...............................10Uomini a metà......................................16La metafisica del sangue e della razza.............26Il Requerimiento...................................31
TUTTO CIÒ CHE ASCENDE, CONVERGE.....................33Come si diventa Las Casas?.........................35Ingerenze umanitarie...............................43La Disputa.........................................57La dignità umana...................................68La libertà.........................................75Un’antropologia della speranza.....................83I diritti umani....................................89Il torturatore, o l’addomesticamento dell’uomo - parte prima........................................90Il mago, o l’addomesticamento dell’uomo - parte seconda............................................97Il Cristo razzista................................105Un dio implacabile................................110La fine dei tempi.................................115Il Dominio - l’America, Sepúlveda e l’Armageddon..117Utopia e sgomento nel Giardino dell’Eden..........123Las Casas, Erasmo e Origene.......................127
IL PARADISO RICONQUISTATO..........................133BIBLIOGRAFIA.......................................137LESSICO............................................140
BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, AVVOCATO DELL’UMANITÀ
Per voi è meglio se io me ne vado. Perchè se non me ne vado non verrà da voiil Paracleto [lo Spirito che vi difende, il Consolatore]. Maquando me ne sarò andato, ve lo manderò.
1
Giovanni 16:7
Giovanni definisce così lo Spirito Santo, dicendolo paracleto, che significaappunto avvocato; e ugualmente dice di Cristo nella sua lettera che egli èavvocato presso il Padre per i nostri peccati.Origene, “Commento al Cantico dei Cantici”
La scoperta dell’America coincise con la scoperta diun Mondo Nuovo e di un’Umanità Nuova, diversa,sconcertante. Francisco Lòpez de Gòmara (1511-1566),ecclesiastico e storico spagnolo, riconobbe nellascoperta dell’America il più grande evento della storiadopo la venuta del Cristo. Per l’umanità del Nuovo Mondofu quasi certamente il più grande evento in sensoassoluto. Gli indigeni presero coscienza del nuovo ordinequando ormai il loro servaggio si era trasformato in unacondizione irreversibile. Alcuni credettero che i nuoviarrivati fossero dèi o semidèi, altri, pur essendosi resiconto di avere a che fare con degli esseri umaniprovenienti da terre molto distanti, rimasero prigionieridel preconcetto che ogni civiltà sufficientementeavanzata da attraversare un oceano doveva per forzaessere benevola. La maggior parte degli indigeni cessò divivere troppo in fretta per potersi fare un’idea chiaradi ciò che stava accadendo. Fortunatamente, tra gliEuropei, ci furono anche persone di buona volontà elucida coscienza, come Bartolomé de Las Casas, cheusarono il Nuovo Mondo come uno specchio che poneva inevidenza il putridume e le brutture della civiltà delVecchio Mondo e si cimentarono nell’impresa di porvirimedio.
Le opinioni sono ancora divise sulla figura diBartolomé de Las Casas. “Nonostante la mole di documentie di studi che attestano il contrario, rimangono ancorapregiudizi e riserve verso un semplice clerigo che nonaveva mai fatto studi regolari e forse nemmeno raggiuntola licencia (laurea) in teologia, la cui opera non risponde
2
ai canoni accademici ed è totalmente finalizzata alla suaattività pratica, quindi facilmente tacciabile diparzialità, di apologetismo e propagandismo o nel,migliore dei casi, di umanitarismo e messianismoevangelico privo di mediazioni culturali. Noncontribuisce certo a far apprezzare l’opera delProcuratore degli indios il suo stile complicato,farraginoso, prolisso, discontinuo, poco elegante,lontano dalla chiarezza e dalla sistematicità degliscolastici come De Soto e De Vitoria, come puredall’eleganza della retorica di un Sepúlveda” (Tosi,2009).
Chi è dunque Bartolomé de Las Casas e perché qualcunodovrebbe essere interessato a leggere una sua biografia?A mio giudizio è una figura a dir poco straordinaria e,come tante personalità eccezionali, dei tratticaratteriali spigolosi hanno nuociuto alla sua immaginema hanno anche permesso ai suoi biografi di poterlavorare su materiale intrinsecamente stimolante. IlNostro non amava i compromessi, se questi comportavano unmaggior carico di sofferenza per i suoi protetti, gliindigeni americani. Non accettava di fare passi indietroquando era convinto di essere nel giusto, ossia quasisempre. Molti lo consideravano spocchioso ed arrogante, eforse lo era, specialmente quando riteneva che i suoiavversari fossero pavidi, o ignoranti, o in cattiva fedee dunque complici di un genocidio. Difficile non dargliragione: chi si mostra timido di fronte al male non èmeno colpevole di chi lo commette. Numerosi furono ipolitici, amministratori, imprenditori, esploratori,militari di professione e rappresentanti del clero che,per così dire, se la legarono al dito. Nel 1543 uninviperito cabildo (consiglio coloniale cittadino) diSantiago del Guatemala scrisse al sovrano che “in realtàsiamo allibiti di come la vostra Casa, fondata dai vostriavi cattolici…venga improvvisamente sovvertita da unmonaco illetterato e privo di senso religioso, invidioso,
3
vanitoso, passionale, agitato e non privo di cupidigia,colpevole per di più di suscitare scandalo! Tutto ciò atal punto che dovunque abbia abitato in queste Indie egliha dovuto essere espulso, non lo possono soffrire innessun monastero, non accetta di obbedire a nessuno e nondimora mai a lungo nello stesso luogo” (Mahn-Lot, 1985,p. 144). Come Gesù il Cristo, Las Casas, di estrazionenon agiata e per di più autodidatta, scandalizza i suoicontemporanei con gli insegnamenti, le azioni, le presedi posizione, la prodigiosa vitalità ed energia,l’asprezza delle sue polemiche, il rifiuto delpatriottismo e dell’ortodossia quando mascheranol’ingiustizia. Come Gesù, è invidiato, temuto,disprezzato, braccato, è pietra di scandalo. Un giornoesclama: “Signore, tu vedi che cosa cerco in tutto ciò eche non ci guadagno che fame, stanchezza, sete e odio daparte di tutti. Se sbaglio, è per il tuo Vangelo,illuminami affinché io non sia più per il mondo unoscandalo”. Drammatizza. Non è profeta in patria, ma laCorona lo sostiene, perché lui, scaltramente, intuisce dipotersi rendere utile alla corte di Spagna nel suotentativo di imbrigliare i Conquistadores che, troppolontani dalla madrepatria, la fanno da padroni nel NuovoMondo. Anche una parte importante del mondo accademico -fortunatamente, almeno in quella fase, egemone – loappoggia, perché i suoi nemici sono anche i loro nemici.
Quasi ogni sua iniziativa è però destinata alfallimento. Las Casas è un perdente della storia, ma unvincente della memoria e della coscienza umana, che lohanno premiato. Troppo in anticipo sui tempi, le sue ideerisultano francamente donchisciottesche nel lorocontesto, sebbene all’osservatore odierno possanoapparire come eminentemente ragionevoli e sensate. Con ilsuo zelo pesta troppi piedi. Commenta il vescovo delGuatemala Francisco de Marroquín: “Da quando padreBartolomé ha ricevuto la mitra ha dato libero sfogo allasua vanità; quando si dà prova di zelo, occorre unirvi
4
l’umiltà”. Las Casas non è umile, non ha né il tempo néla disposizione ad esserlo. Deve salvare quante più vitesia possibile, deve proteggere le culture e le comunitàlocali, “non perché io [sia] un cristiano migliore deglialtri, ma per la compassione che [provo] istintivamentenel vedere questa gente subire simili ingiustizie”. Ilsuddetto vescovo riconosce che “è molto dolce e sempretale resterà, ma…ha cominciato a recalcitrare”. MarianneMahn-Lot osserva molto giustamente che “gli spagnoli diCiudad Real erano credenti a modo loro, ma non potevanosopportare il fatto che il vescovo esigesse da loro unatrasformazione tanto repentina e radicale del propriostile di vita”. È intransigente, è moralizzatore, èschietto, è audace. “Questo parlare è duro: chi lo puòascoltare? Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i Suoidiscepoli mormoravano di ciò, disse loro: Questo viscandalizza?” (Gv. 6, 60-61). Il “Difensore degliIndiani”, storico, antropologo, politologo, filosofomorale, teologo autodidatta, consacrò la sua vita alladifesa dei deboli, degli oppressi e dell’umanità ingenerale, al di là di interessi e vicissitudini storiche.Fu un moderno Sisifo, lottò per anni, in ogni suo scrittoed in ogni sua orazione, contro un cinico realismo cheaveva già dichiarata persa la battaglia degli Indios, chenon ci credeva più e anzi, vedeva in una strutturaorganizzativa neofeudale l’unica alternativaall’estinzione degli autoctoni. Molti tra i suoiavversari, in fondo, disprezzavano quell’umanitàinferiore. Las Casas fu un novello Sisifo perchè ilmacigno che faceva rotolare (lo skandalon) era enorme eponderoso, la salita era aspra e gli sforzi sembravanofutili in una società che accumulava detriti sulla cimaper allontanare la meta e che irrideva chi spingeva laroccia della dignità e dei diritti umani, tacciandolo distolto idealismo o di labilità mentale. Il missionariofrancescano Toribio de Benavente, detto Motolinía,scriveva all’imperatore: “Non so come Sua Maestà abbia
5
potuto soportare un uomo così pesante, irrequieto,importuno, turbolento, litigioso, agitato, maleducato,offensivo, senza pace”. Era in corso un contrasto tradomenicani e francescani sulla maniera di evangelizzaregli autoctoni e Motolinía, che pure aveva a cuore lesorti dei medesimi, accusava Las Casas di eccessivoidealismo, di causare turbative del Nuovo Ordine, diessere un anti-colonialista. “Se hanno perseguitato Me,perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la Miaparola, osserveranno anche la vostra.” (Gv. 15, 20).Eppure, ogni giorno, quest’apostolo della libertà e dellagiustizia – e non è facile retorica, come avrò modo didimostrare – si risvegliava e riprendeva a sospingere,perché la sua vita non avrebbe avuto senso altrimenti.Come il Sisifo di Albert Camus, la sua azione fu unarivolta contro l’assurdo della Conquista, contro ladisumana insensatezza di una realtà senza Cristo, difronte alla quale non si poteva non levare la voce inprotesta, se si intendeva rimanere umani e cristiani.
La protesta di Las Casas fu ampia, intensa elungimirante, abbracciando diversi campi del sapere e nonmancò di influenzare Voltaire ed altri intellettualiilluministi. Questo pensatore-militante, a tratticontradditorio, a tratti proiettato in una dimensioneirrealistica, si rifà agli autori canonici ed alle SacreScritture, ma supera i primi per passione, impegno civileed umanità ed emula Gesù il Cristo nel suo caratteresovversivo, universalista e messianico. Dialoga conprofitto con la punta di diamante della teoria giuridicaeuropea, gli esponenti della Scuola di SalamancaFrancisco de Vitoria, Domingo de Soto e Melchor Cano, mase ne discosta per il maggior ruolo che affida almagistero della Chiesa e per l’opposizione alle ingerenzeumanitarie armate ed alla dottrina dei “doveri naturali”degli Indios verso gli Spagnoli. Semmai, per Las Casas,erano gli Spagnoli ad aver contratto doveri ben precisiverso gli autoctoni al momento della scoperta. Crede
6
energicamente nell’unità della specie umana e nei suoiattributi intrinsici di dignità, uguaglianza,socievolezza, razionalità e libertà, che permettono aciascun essere umano di godere di diritti inviolabili edinalienabili. Crede che ogni società ed ogni uomo possanorealizzare il loro potenziale attraverso l’educazione edil pieno godimento della loro libertà. Per lui ilperfezionamento, fine ultimo dell’umano, si ottienetramite la luce dell’intelletto che, anche autonomamente,può condurre alla conoscenza naturale di Dio; un eventospontaneo, visto che , ne è convinto, non esistono esseriumani che non tendano al divino, in modi e forme diversee proprie. È un paladino del rispetto delle usanze,credenze, leggi e costumi degli altri popoli, anticipandodi quattro secoli il relativismo epistemologico dellaprofessione antropologica. Non ritiene che la barbarie –che pure considera tale – di certe pratiche possadiventare un pretesto per imbarcarsi in crociate diimperialismo civilizzatore. A più riprese sottolinea comel’arretratezza di una cultura o civiltà in certi suoiaspetti – giudicata in base ai summenzionati principi-cardine della natura umana – si sormonta persuadendo lepersone con ragioni solide, facendo appelloall’intelletto, al buon senso, alla volontà, senzal’impiego di imposizioni e violenza. Solo così la specieumana può maturare in armonia con la sua natura. La viadella pace, della concordia e del rispetto è quellaindicata dal Cristo ed è l’unica da seguire. Il sistemadi sfruttamento ed asservimento neofeudale delleencomiendas (servizi di corvé coloniali imposti agliindigeni) è in diretta contraddizione con l’essenza dellanatura umana, è un peccato contro l’anima e contro Dioche dilapida la stessa vita umana. Ancora una volta conimpressionante lungimiranza. Las Casas insiste che ilpotere di sovranità risiede nella gente, nel popolo, nonnella sommità della piramide sociale. Senza la base nonesiste alcuna società e da essa procedono il diritto ed i
7
diritti. Nessuno può governare una nazione senza ilconsenso dei governati. L’autorità si deve costituire conlibere elezioni che includano l’intera cittadinanza,uomini e donne: il principio del suffragio universaledemocratico, teorizzato a metà del Cinquecento! Il fineultimo dei governanti dev’essere quello di garantire ilbene comune, inteso come giustizia, libertà, prosperità econcordia. Il limite dell’azione di governo è stabilitodai diritti dei cittadini e dalla legge. Più sorprendenteancora è la richiesta che ogni autorità legittimarecepisca la volontà popolare tramite un vero e proprioreferendum, quando le circostanze sono drammatiche e ledecisioni comportano conseguenze importanti per l’interacomunità. In pratica, nella visione lascasiana, unsovrano – o per meglio dire un presidente, o un supremodelegato – non può dichiarare guerra a nessun altranazione o intraprendere una politica coloniale senza ilconsenso dei sudditi/cittadini. Il grado di perfezione diuna comunità si misura in funzione della libertà di cuigodono i suoi cittadini. Questo è un criterio prettamenteliberale, concepito circa duecento anni prima che illiberalismo prendesse piede in Europa, e con buona pacedi chi, con una lettura altamente selettiva delle sueopere, focalizzata sulla prima metà della sua attivitàpubblicistica, lo ha accusato di essersi prestatounicamente a servire il ruolo di agente attivo epartecipe dell’imperialismo ecclesiastico e colonialeeuropeo (Capdevila, 1998; Castro, 2007).
L’originalità e forza anticipatrice di Las Casas nonsi fermava qui. Il carattere innovativo delle sueproposte e raccomandazioni non va ricercato nellepremesse – già ben delineate da diversi teorici umanistispagnoli, italiani e fiamminghi – ma nella radicalitàdelle sue conclusioni, frutto di una creativitàspeculativa alimentata dall’amarezza e disgusto per unpresente inumano e dal sogno di un mondo realmentemigliore e non confezionato ad uso e consumo dei
8
soverchiatori e prevaricatori. Così, ad esempio, ilvescovo del Chiapas teorizzava che il sovrano nondeteneva beni di proprietà per diritto di nascita, masolo in relazione alla volontà popolare; questi benipotevano anche essere alienati in caso di malgoverno. Diconseguenza le encomiendas perpetue erano illegittime, iservi indoamericani dovevano essere emancipati e lericchezze redistribuite, in quanto sottratteillegalmente. I popoli trattati ingiustamente etirannicamente avevano il diritto di ribellarsi ed anchedi usare la forza Allo stesso tempo, però, certi vizi inseno ad una comunità dovevano essere tollerati se iltentativo di risolverli rischiava di provocareconseguenze maggiormente dannose rispetto alla lorosussistenza.
Non ci fu nessun Las Casas a proteggere i nativinordamericani e gli schiavi neri di quelli chediventeranno gli Stati Uniti. I più celebrievangelizzatori puritani non ritennero mai che questiesseri umani avessero la medesima dignità dei coloni e lividero come un intralcio al Destino Manifesto della lorociviltà. L’espressione del Potere, in Nordamerica, nontrovò seri antagonisti in grado di contenerlo eframmentarlo e il risultato fu lo sterminio degliautoctoni. Quel che rimase fu un assordante silenzio difronte al male che, come si è detto, equivale acomplicità.
Quanto alla disputa teologico-antropologica diValladolid tra Las Casas e la sua nemesi, il filosofo diCordoba Juan Ginés de Sepúlveda, prima ancora di essereuna controversia sui diritti dell’uomo, essa concerne lanatura umana, tocca una pluralità di discipline e rivelai machiavellissimi che rischiano di oscurare la veritàdietro una cortina di fumo fatta di ragionamenti capziosie circolari, manipolazioni semantiche e simboliche edappello alla massimizzazione dell’utile. Essa ha comunquegettato le fondamenta per la teoria dei diritti umani e
9
legittimato i fini del movimento indigenista.Personalmente ritengo che sia uno dei più importantidibattiti della storia della teologia, del diritto edell'antropologia politica e che abbia anticipato disecoli le attuali polemiche sulla bioetica e sulglobalismo. Da una parte c'è il campione del naturalismoneo-paganeggiante (e, paradossalmente, di un’ortodossiainflessibile), dello sciovinismo militarista-imperialista, del feticismo della diversità (che diventafine a se stessa e gerarchizzata). Dall’altra unammiratore di Erasmo da Rotterdam, un paladino deidiritti umani universali, di una globalizzazione equa,egalitaria, giusta, rispettosa, pacifica, dell'idea cheogni essere umano dev'essere messo nelle condizioni dideterminare il proprio destino e non va trattato come uninfante o uno “schiavo di natura”.
Di conseguenza questo è anche un saggio sul contattotra una civiltà tecnologicamente avanzata, rapace emoralmente degradata (l’Impero spagnolo) ed una civiltàdecadente e violenta, isolata, devastata dalle pandemie,sadomasochisticamente prigioniera di attese apocalittiche(l’Impero azteco). Ci fu chi, tra gli emissari dellaprima, difese nobilmente la dignità della seconda difronte agli invasori, riscattando almeno in parte lenefandezze della propria. Tra questi, il più illustre fuBartolomé de las Casas, una figura purtroppo nonsufficientemente nota, nonostante un’esistenzaabbondantemente vissuta e che ha lasciato un segno nellastoria – oltre cinquant’anni di luci della ribalta traVecchio e Nuovo Mondo ed una decisiva influenza su benquattro tra re ed imperatori dell’epoca d’oro spagnola.
L’originalità di questa biografia risiede nellaprospettiva, che non è esclusivamente storica ma anchesocio-antropologica, filosofica, giuridica e politologicae rimarca l’attualità del pensiero di una persona“aiutata” da imprevedibili esperienze di vita atrasformare certi suoi difetti caratteriali in virtù e a
10
dare il meglio di sé, ad essere all’altezza della sfidadecisiva, a servire da modello anche a distanza disecoli.
Dopo una prima sezione dedicata ad una disamina delcontesto storico ed una seconda che esplora la vita diLas Casas, mi soffermo sul tema dell’appropriazione delCristo. Entrambe le parti – avversari e difesori degliindigeni – se ne appropriarono, ma solo i primi nesovvertirono il messaggio. Lo scenario prospettato daicritici di Las Casas è quello di una crociata di FratelliMaggiori, giunti nel Nuovo Mondo per decisione del BuonPastore, il Salvatore che avrebbe condotto il greggeall’ovile. La visione dello stesso Las Casas e degliindigenisti non era troppo dissimile, se non in un puntocruciale, che sta alla base della civiltà contemporanea:il libero arbitrio unito al rispetto della dignità umanaed al consenso informato, quest’ultimo intesonell’accezione più ampia di una relazione in cuicompletezza, trasparenza ed onestà permettono allepersone di essere pienamente consapevoli di quali sianole ramificazioni del loro beneplacito. Per gli avversaridei lascasiani, non di ovile si trattava, ma di unacatena di montaggio. Lo slogan ufficiale era quellodell’avvento della civiltà dell’amore, della pace e delbenessere, dopo il terrore azteco, ma la realtà era bendiversa. I nuovi signori soffrivano di un’illimitatabramosia di beni materiali e manodopera gratuita. Leinvocazioni ad amarsi ed a vivere in pace con iconquistadores seguendo l’esempio di Gesù erano dunqueingannevoli, perché miravano ad imporre una certa visionedel mondo, inducendo un’auto-lesionistica mansuetudineirriflessiva nei sudditi. Esisteva un’enorme discrepanzatra le parole ed i fatti. La predicazione dell’amore edella pace si accompagnava a misure di radicaleintolleranza verso i non-allineati, verso una societàdefinita senza Dio e irrimediabilmente corrotta, cherichiedeva un vasto sacrificio collettivo per essere
11
rifondata sulla base dei dieci comandamenti, il piùimportante dei quali è l’assoluta e completa obbedienza esottomissione al vero Dio. Contro tutto questo si scagliòLas Casas, contro la marcia ipocrisia di quelli il cuiunico Dio era – ma quanti di loro l’avevano davverocapito? – l’universo materiale, ma si proclamavanorazzialmente e spiritualmente superiori, appellandosialle parole di Gesù e dei Maestri della Chiesa. Controchi non sapeva cosa farsene dell’Amore e formava castedominanti che esigevano venerazione, onore, lealtà,sottomissione, conversione al loro culto e timorataidolatria, non amore. Las Casas obiettò all’ingiunzionedi adorare ed onorare la presunta volontà di Dio e dirispettare le sue leggi, se ciò comportava l’annullamentodi ogni libera volontà ed istanza critica. Obiettò allasegregazione degli indigeni nelle encomiendas erepartimientos – “un governo di tirannia molto più ingiustodi quello al quale furono soggetti gli Ebrei dal faraoneegiziano” –, alla ritualizzazione della fede e dellaquotidianità, perché questa ottundeva le menti efacilitava il compito di quelli che chiamava “tiranni”,scatenando la furia di Cortés e Pizarro. In questo nuovoordine instaurato dai conquistadores, chi disobbediva erapunito nei modi più atroci perché il perdono e latolleranza erano merce rara. L’idea di peccato mortaleacquistava un significato letterale in un clima culturaleda età del bronzo. I nuovi fedeli erano infantilizzati esi affermava che Dio – per mano e per bocca dei suoiinviati – si era assunto l’incarico di sistemare le cose,perché i nativi avevano dimostrato in modo definitivo laloro inettitudine, abiezione e pericolosità per se stessicontinuando a farsi la guerra e a sacrificare iprigionieri. Las Casas capì che molti colonialisti ecortigiani non vedevano nella predicazione un veicolo diilluminazione spirituale ma un pretesto per mantenerel’oscurantismo e l’ignoranza ed il dominio sulla mente,il corpo e lo spirito dei sottoposti. In un paradosso
12
orwelliano, ogni opposizione indigena a questo stato dicose era bollata come ispirata da Satana,dall’Anticristo. Solo la voce autorevole dei missionariindigenisti e dei teologi umanisti rivelava che il re eranudo, cioè che la fede dei coloni era segnata daun’interpretazione monolitica, unilaterale e perversa –ma molto conveniente – della tradizioneveterotestamentaria, fatta di violenza, risentimento,soprusi, tirannia, rancore e sanguinarietà.
Anche qui, la centralità della celebre disputa diValladolid è sancita dall’evidenza del fatto che nessuno,né prima né dopo, si era mai trovato a discettare dinatura umana e destino della sua civiltà in seguito allascoperta di un Nuovo Mondo e di traiettorie “evolutive”separate. L’unicità dell’evento e delle sue implicazioniè fuor di dubbio: una situazione analoga si realizzerebbesolo se fosse possibile retrocedere nel tempo fino almomento dell’incontro tra l’uomo anatomicamente moderno eil neandertal o se una civiltà extraterrestre prendessecontatto con la nostra. Prospettive che sono per ilmomento alquanto remote.
La questione dell’affidabilità delle fonti
Può essere rimasto uno spazio di saggezza in questa terra di avidità?Francisco Cervantes de Salazar, discorso del 25 gennaio1553
Uno studio comparativo di realtà molto diverse devepartire dal “principio di umanità”, che presuppone unoschema di relazioni tra credenze, desideri e mondo chesia il più simile possibile a quello che usiamoquotidianamente. Ma quanto possiamo fidarci delleinformazioni raccolte da cronisti e missionari europei?E, soprattutto, non rischiamo di incappare in grossolanifraintendimenti, applicando schemi d’analisicontemporanei a delle realtà del tutto estranee ad essi?
13
Luciano Gallino è dell’avviso che “l’obiezione talvoltamossa ai lavori di storiografia dei sociologi è diforzare in uno schema categoriale derivato in prevalenzadall’analisi delle società contemporanee, gli eventi disocietà del passato. Obiezioni simili tradiscono laricaduta in uno storicismo di pretto stampo diltheyano,per il quale soltanto le categorie dei soggetti deglieventi studiati sono valide per comprendere il passato.Di fatto, gran parte della storiografia e dellasociologia post-storicistiche hanno da tempo minato allabase l’ipotesi che coloro che partecipavano agli eventisi trovino in condizioni di privilegio per spiegare o percomprendere o interpretare gli eventi stessi, elaborandouna serie di concetti strutturali la cui funzionepreminente è di porre il contemporaneo in condizione dispiegare eventi del passato assai meglio di quanto nonabbiano potuto fare coloro che parteciparono ad essi”(Gallino, 1993: 664). Allo stesso modo, l’antropologiamoderna ha da tempo posto in rilievo come la definizioneche la fonte dà della sua realtà socio-culturale ègeneralmente inficiata da un processo cognitivo di auto-rappresentazione ideale. Che fare allora? Ho cercato diillustrare quale fosse la definizione lascasiana diverità e di realtà ed i limiti della sua percezionesoggettiva.
Bartolomé de las Casas non imparò mai le lingueindigene e non raccolse materiale etnografico, perché nonidolatrava le culture, ma amava le persone in carne edossa e, per aiutarle, si spostò incessantemente. Poichéviveva in una società in cui il valore di una persona eracommisurato alle sue realizzazioni culturali, si trovò adover magnificare le virtù civili ed intellettuali degliindo-americani. Per contrastare le descrizionigrottescamente menzognere degli indigeni da parte dicronisti visceralmente razzisti ed in combutta con icoloni e gli schiavisti, Las Casas si sentì obbligato ad
14
invertirle di segno e finì per idealizzare ed esagerare imeriti dei nativi, omettendo gli aspetti più sgradevolidella loro civiltà; li trasformò nella pietra di paragonedella perfezione, in “nobili selvaggi” di fineintelletto, vasta spiritualità, robusta costituzione evalore guerriero. Giunse perfino ad indicare i sacrificiumani di massa come indice di vitale religiosità nativa.In questo modo traslò i soggetti della sua analisi versoun piano di irrealtà che rischiava di mortificarecomunque la loro umanità e quotidianità e di cancellarecon un tratto di penna la disumanità precedente allaConquista. Francesco Surdich, docente di Storia delleesplorazioni e scoperte geografiche a Genova, èdell’opinione che Las Casas abbia idealizzatostrumentalmente il mondo indigeno, rendendolo di piùardua decodificazione, perché più interessato adifenderli che a farli conoscere (Surdich, 2002). Questotipo di discorso, ispirato da una sensibilitàpostmodernista, a mio avviso lascia però il tempo chetrova. Bisogna tenere a mente le circostanze storiche incui si trovò ad operare, ossia un’epoca in cui nonesisteva un’opinione pubblica attenta e i pregiudizietnocentrici erano percepiti come dogmi. I suoiantagonisti nel Nuovo Mondo erano spesso persone discarsa cultura e di vasta ambizione e cupidigia, quellinel Vecchio Mondo erano eruditi privi di una conoscenzadiretta della realtà coloniale. Nel frattempo i nativimorivano letteralmente come mosche, senza che lui potessein alcun modo arrestare quest’apocalisse, se nonperorando la causa indigena alla corte di Spagna conpassione ed eloquio, ma anche con astuzia, destrezza ediplomazia. Non si accontentò mai di confutare le tesidegli avversari, ma fece attivismo politico, cercando diinfluenzare il processo legislativo, di far approvarepiani per l’istituzione di comuni utopiche per i nativiconvertiti, per fermare le guerre, “giuste” o “ingiuste”che fossero, per abolire la schiavitù e screditare e
15
condannare quegli sfruttatori rapaci che erano gliencomenderos.
Se Las Casas peccò di etnocentrismo e benevolopaternalismo nelle sue azioni e prese di posizione, lo sipuò giudicare con una certa magnanimità e clemenza.Possiamo certamente preferirlo a chi, come Bernardino deSahagun e José de de Acosta, consigliava vivamente diapprendere le culture indigene, le superstizioni e glierrori per poterli curare, come si era fatto con i paganigreci e romani.
IL CONTESTO STORICO
Il prete [Las Casas], irato, va contro di loro riprendendoli aspramente perostacolarli, ed essi, che lo rispettavano un poco, cessarono quello chestavano per fare, e corì restarono vivi quaranta indios, ed i cinque se neandarono ad ucciderne dove gli altri uccidevano. E poiché il prete rimasefermo nell’ostacolare la morte dei quaranta, che erano giunti lì comeportatori, quando andò avanti, trovò una catasta di morti, che avevano fattocon i corpi, che era una cosa certamente da far spavento. Quando lo videNarváez, il capitano, gli disse: “Cosa sembra a Sua Signoria di questi nostrispagnoli? Che hanno fatto?”. Gli rispose il prete, vedendo davanti a sé tantifatti a pezzi, molto turbato dall’avvenimento così crudele: “Vi mando, sia Leisia loro, al diavolo”Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias
Las Casas fu, come tutti, un uomo del suo tempo, cioèlegato al suo ambiente culturale, sociale e politico.Bisogna dunque tenerne conto per poter valutare la suafigura, senza per questo cedere alla tentazione diattribuire alla sua vita ed al suo insegnamento quegliattributi di unicità, incomparabilità ed incomunicabilitàche impedirebbero allo studioso ed ai suoi lettori ditrarne delle lezioni utili per la loro esistenza, inun’epoca per molti versi differente ma per altriinquietantemente simile. Infatti è mia opinione che le
16
guerre sante, il fanatismo religioso, il Gott mit uns hannouna radice comune nell’iniquità della Conquista e nellapretesa mai sopita di accelerare con ogni mezzol’unificazione del mondo nell’unico ovile e sotto l’unicopastore profetizzato nella Bibbia – unum ovile et unus pastor–, l’obiettivo dell’omologazione culturale finale ad ununico modello superiore e prevalente.
Al tempo di Las Casas, ipocritamente, non si usòspesso il termine “schiavitù”, perché la giurisprudenzaspagnola la contemplava solo per i prigionieri di guerra.Esso fu presto sostituito dall’istituto dell’encomienda,una schiavitù di fatto, mascherata da contratti diderivazione medievale. Affermare che si era peccatoriperché si sfruttavano gli Indiani era tanto sconcertantequanto affermare che lo si era perché si sfruttavano glianimali da soma. In quell’epoca sfruttare gli indios edessere cristiano e prete non era considerata unacontraddizione in termini. Ce lo racconta Las Casas nellasua Historia: “Rimasero tutti meravigliati e anchespaventati da ciò che egli disse loro, e alcuni compuntie altri come se lo sognassero, ascoltando cose tantonuove come il dire che non potevano avere gli indios alloro servizio senza peccato; e non ci credevano, come sedicessero che non si potevano servire delle bestie delcampo”. Lo stesso presidente del Consiglio delle Indie –istituzione alla quale Las Casas rivolse diversi appelli–, Juan Rodrìguez de Fonseca, che era vescovo a Burgos,si vantava di possedere molti schiavi indios. Per questoil vescovo del Chiapas fu costretto ad assaltare letrincee ideologiche dei suoi oppositori partendo dalbasso. I pregiudizi erano saldissimi e robusti e leorecchie spesso tappate dalle esigenze erariali e da piùprosaiche mazzette dei coloni, che volevano garantirsilauti profitti, e delle multinazionali del tempo, come lacorporazione bancario-assicurativa della famiglia Welser,che si era impadronita di una fetta del Venezuela con isuoi mercenari, guidati dal conquistador tedesco Nikolaus
17
Federmann. Quella delle infamie perpetrate dalcapitalismo colonialista fu un’altra delle questioni dicui Las Casas si occupò in prima persona, scrivendo unalettera di denuncia al Consiglio delle Indie: “E come nonvedevano le Vostre Signorie lo sfruttamento cui itedeschi avrebbero sottoposto quella terra e i suoiabitanti nel tempo che gliela aveste concessa? Non siadopereranno a sfruttarla e a distruggerla per ricavareciò che hanno prestato ed è costato loro? Poiché affermoche, nei quattro anni in cui dicono debba durare loro (laconcessione), potranno rubare tanto per comprare tutta laGermania. Perché, signori, concedete così generosamenteciò che non conoscete, né sapete ciò che offrite, né ciòche potete dare, con sì grande danno di Dio e delprossimo?”.
Questa è invece una felice sintesi del muro di gommacontro cui si trovò a cozzare: “Tutti costoro, o alcunidi loro, furono i primi…che a corte infamarono gliindios, dicendo che non sapevano governarsi o che avevanobisogno di tutori; e questa cattiveria crebbe sempre,tanto che li umiliarono fino a dire che erano incapaci difede – che non è una piccola eresia – e a renderli ugualialle bestie, come se in tante migliaia di anni dacchéqueste terre sono popolate, piene di popoli e genti, coni loro re e signori, vivendo in tutta pace etranquillità, in tutta abbondanza e prosperità – quellache la Natura richiede affinché gli uomini vivano e simoltiplichino in inmenso – avessero avuto bisogno dellanostra protezione. […]. E così iniziarono per tuttoquesto orbe a infamare e dire quanti mali si potevanocredere negli indios e, principalmente, che erano bestie,fannulloni e che amavano l’ozio e che non si sapevanogovernare, per fingere necessità che sembrasse opportunopossederli e servirsi di loro in quell’infernaleschiavitù in cui li misero, dicendo di civilizzarli e perfarli lavorare” (Historia de las Indias). Così le richieste delNostro furono spesso respinte, sebbene il suo eroismo ed
18
il suo spirito indomito non mancassero di portare dallasua parte diverse figure di non poco prestigio e diinfluenzare alcune decisioni sovrane sulla politicacoloniale spagnola.
Ci possono essere degli esseri umani che non discendonoda Adamo?
Adolph Bandelier, un insigne archeologo svizzero cheesplorò l’America centrale e meridionale a cavallo tra ildiciannovesimo ed il ventesimo secolo, riassunse, in uninteressantissimo ed esaustivo articolo apparso nel 1905,le diverse tradizioni peruviane che menzionavano unaqualche sorta di leggendario sbarco di stranieri sullecoste sudamericane. Egli segnalava che l’origine dellegenti che avevano popolato il Nuovo Mondo era stato forseil primo dei problemi che si erano trovati ad affrontaregli Europei in seguito alla scoperte delle Americhe. Comevedremo, in genere la posizione prevalente fu quellamonogenetista, che tendeva a prediligere un’interpretazioneelastica delle Bibbia. I nativi sarebbero stati idiscendenti dei popoli protagonisti delle migrazioniconseguenti al crollo della Torre di Babele o, piùraramente, delle tribù d’Israele scomparse in seguitoalla deportazione in terra di Babilonia in un periodosuccessivo. Bandelier fece notare che per gli Spagnolidel tempo della Conquista fu molto facile interpretare leleggende locali come prove storiche a sostegno di questoassunto. Egli stesso mette in guardia chi intendaimpegnarsi nella disamina delle suddette leggende: “ciòche desidero si tenga nella massima considerazione è ilpericolo che le tradizioni orali indiane siano state“arricchite” da chi le ha raccolte, in modo da forniresostegno ad una particolare teoria” (Bandelier, 1905, p.251).
Il clima culturale e dottrinario del periodoinfluenzò dunque pesantemente i cronisti della prima fase
19
dell’”ispanizzazione” della futura America Latina. Questocapitolo esamina alcune delle teorie più in vogasull’origine delle popolazioni americane, elementi di unfurioso dibattito che si era scatenato in Europaall’indomani della scoperta del Nuovo Mondo edell’umanità che lo popolava. Da dove provenivano questegenti? Erano figli del demonio o avevano ricevuto in unaqualche misura il messaggio evangelico da ipoteticipredicatori giunti in America prima di Colombo? Potevanoessere considerati di pari dignità rispetto aiconquistatori europei oppure schiavi di natura? Bandelierraggruppò in tre grandi categorie le molteplicitradizioni riguardanti l’arrivo di “predicatoricaucasoidi” nel Sudamerica in un’epoca precedente allosbarco degli Spagnoli. La prima comprende quellenarrazioni che accennano alla comparsa di esseri umani difisionomia diversa da quella indigena. La secondaannovera quelle che fanno menzione di antichiinsediamenti americani costituiti da genti provenienti daregioni oltreoceano. Infine nella terza troviamo leleggende che narrano di sbarchi avvenuti sulla costanord-occidentale dell’America meridionale.
Dalla Corónica moralizada del Orden de San Agustin en el Peru dipadre Antonio de la Calancha veniamo a sapere che uominibianchi e barbuti, dopo essere sbarcati sulle costebrasiliane ed aver attraversato l’Amazzonia, erano giuntisul Titicaca predicando alla maniera di missionari. Làuno di loro era stato ucciso, mentre l’altro avevaproseguito il suo cammino fino ad arrivare sulle costedel Pacifico, dove era scomparso. In Colombia, presso iMuisca ed i Chibcha, incontriamo Bochica, predicatoredalla lunga barba, scalzo e vestito con una specie ditunica. Questa categoria di leggende in genere fariferimento alla figura di Wiracocha, una specie disemidio predicatore, che fu presto adottato come provadecisiva dai promotori della tesi secondo cui il NuovoMondo era già stato visitato dagli apostoli di Cristo,
20
come ad esempio San Tommaso, o da anonimi discepoli in unperiodo posteriore. Pr la seconda categoria ci sonopervenute le relazioni dei frati agostiniani sullaregione di Huamachuco, elaborate tra il 1552 ed il 1561,che hanno trascritto la credenza locale nell’esistenza inun remoto passato di insediamenti di stranieri che sisarebbero in parte estinti con il passare del tempo ed inparte sarebbero emigrati senza più fare ritorno. SecondoCieza de Leon (Cronica del Perú), un capo indigeno un giornosi diresse vero il Titicaca e trovò “sull’isola maggioredi quella palude delle genti di pelle bianca e barbutecon le quali si scontrò, sterminandoli”.
Nell’Historia del Perù y varones insignes en santidad, AnelloOliva, un gesuita italiano vissuto tra il XVI ed il XVIIsecolo, riferisce che un numero imprecisato di stranierisbarcarono lungo la costa del Venezuela, nei pressi diCaracas, per poi spingersi nell’interno, fino araggiungere Santa Elena nell’Ecuador e poi, per mezzo diuna lunga navigazione costiera, nel Perù meridionale edin Cile. Oliva sostiene che i dati in suo possessotestimoniano come questo popolo non fosse nativo delNuovo Mondo ma provenisse dalla Tartaria, la Cina diallora. Oliva fu il portavoce di un movimento gesuitaclandestino che cercava di tutelare la dignità dei nativiin qualunque modo possibile, anche avvalendosi ditradizioni arbitrariamente modificate. Tuttavia questecredenze esistevano anche nel nord del paese, piùprecisamente tra i Chimù, ed era diffusa una tradizioneincaica che collegava la genesi del mondo al cammino“demiurgico” di una specie di antenato totemico peruvianodivinizzato, tale Apu Kon Tikse Wiracocha (o KonirayaWiracocha), il quale, supremo artefice dell’universo, nonsi negò una lunga peregrinazione attraverso le terre dalui create, con la relativa assegnazione ad ogni popolodel suo proprio territorio di stanziamento e luogo diculto. Come segnala Mario Marchiori, “il fatto che inquesto mito si parli di luoghi che furono incorporati
21
nell’impero incaico relativamente tardi lascia supporreche questa versione sia il risultato dell’incorporazione,operata dagli Inca stessi per consolidare il loro impero,di miti originariamente locali” (Marchiori, 1999, 175).Nella cronaca di Oliva, basata sui racconti di Catari,uno degli ultimi sapienti inca (quipucamayoc), ritroviamoalcuni dei motivi presenti nelle fonti messicane:l’arrivo in America susseguente al Diluvio Universale(Pachakuti), la coesistenza di umani e giganti (alti tra i4 ed i 5 metri) che li tiranneggiavano, il pellegrinaggiodi predicatori di aspetto europeo, la stretta connessionetra potere imperiale e culto del sole.
Oliva fece parte di un ristretto e piuttostoriservato circolo di gesuiti dediti allo studio delleculture locali nell’intento di rendere loro giustizia.Carlos Galvez Peña, nella sua introduzione alla cronacadi Oliva, scrive che “alla base della sua opera si situala convinzione nella dignità umana degli indiani” checondivide con “un altro umanista del suo stesso ordine,padre José de Acosta”. Alcune dichiarazioni del gesuitaitaliano gli guadagnarono l’aperta ostilità di alcunipotenti gesuiti spagnoli, molto preoccupati a causa della“cattiva” influenza dei gesuiti italiani in Perù. SemprePeña osserva che nell’opera di Padre Vargas “Bibliotecaperuana”, si fa riferimento a un clima agitato e pernulla “fraterno”. È in particolar modo sul tema dellavalutazione della dignità umana degli indigeni americaniche si consuma la frattura fra i gesuiti italiani eumanisti (gesuiti e non) spagnoli. Nessuno stato osignoria italiana aveva il benché minimo interesse nelleAmeriche, a causa della posizione geografica decentratadella nostra penisola, che si trovava separatadall’Atlantico proprio da quelle potenze colonialiiberiche che si sarebbero divise la futura AmericaLatina. Il papato invece si trovava impegnatonell’organizzazione del programma di evangelizzazionedelle nuove terre. La creazione della Compagnia del Gesù
22
(1534) fu così approvata da papa Paolo III (1540) edincaricata di fare opera di proselitismo in EstremoOriente e nel Nuovo Mondo. All’inizio del XVII secolo siformarono due fazioni gesuite divise proprio dallaprovenienza dei propri simpatizzanti. Da una partetroviamo gesuiti italiani come Oliva e Giovanni AntonioCumis, o Matteo Ricci e Martino Martini in Cina, edall’altra soprattutto quelli spagnoli. In verità nonesistevano confini netti, ma solo dei poli di attrazionecontrapposti, che riproducevano nel contesto gesuita ildissidio tra latifondisti e missioni, specialmente inMessico, scaturito fin dall’inizio della colonizzazione acausa di una diversa visione della dignità ed umanitàdei vinti. Da una parte erano schierati i coloni, fautoridelle encomiendas, cioè di una forma di schiavitùlegittimata dalla necessità di condurre gli indigenisulla retta via. Già il 30 novembre del 1511 il frateAntonio de Montesinos si rivolgeva in una predica aicoloni, con queste parole: “Questi, non sono uomini? Nonhanno anime razionali? Non siete obbligati ad amarli comevoi stessi?”. Fu proprio questa predica a trafiggere lacoscienza di Las Casas, avviandolo alla sua vocazione: ladifesa dell’umanità e dignità degli oppressi.
La giustificazione di questo sistema di asservimentoera ricercata nella teoria politica di Aristotele, chegodeva di un vero e proprio rinascimento di interesse inquegli anni, e nel pensiero dell’Aquinate, che avevadistinto due tipi di dominio, uno “reale”, che consistevanel “governare uomini liberi e sudditi per il loro bene eutilità”, e l’altro “dispotico”, che “è come da signore aservo”. Il licenziato Gregorio applicò questo secondomodello agli indios, che ritiene giusto, dal momento che“si applica verso coloro che per natura sono servi ebarbari, quelli che mancano di giudizio e dicomprendonio, come sono questi indios, che secondol’opinione di tutti, sono come animali che parlano”(AA.VV., 1984, p. 95). L’encomienda divenne dunque un
23
“mezzo molto più conveniente [rispetto alla libertà] perricevere la fede e continuare a perseverare in essa”.L’aspetto più sgradevole di questa disputa fu che unsotterfugio per ottenere manodopera gratuita si trasformòin un pregiudizio duro a morire anche per gli stessiecclesiastici, molti dei quali conclusero che non valevala pena di sprecare delle energie per degli esseri chenon erano del tutto umani, quindi non adatti adaccogliere il messaggio e tantomeno i sacramenti. Così,mentre negli ambienti coloniali colti dilagavanoconcezioni poligeniste del popolamento del mondo, secondocui gli Indios non erano discendenti di Adamo, ma dialtro ceppo umano, e quindi non avevano la medesimadignità, oltre che le stesse potenzialità, degli Europei,dall’altra parte della barricata si sviluppava un accesodibattito monogenista. Questo cercava di dare unarisposta al quesito posto dall’esistenza di cultureevolute in zone così distanti dal mondo civile e che allostesso tempo progettava nuove forme di inculturazionedegli indigeni tramite le reducciones, soprattutto ad operadei missionari italiani che non erano invischiati negliinteressi economici dei coloni. Fu in questo stessoperiodo che si consumò anche una parziale frattura tragesuiti italiani ed umanisti italiani.
All’interno dell’ordine gesuita esistevano perciòdelle correnti di pensiero che si distaccavano, talora inmaniera drammatica, da quello che doveva esserel’indirizzo ufficiale, stabilito dalle alte gerarchiedell’ordine stesso. Alcuni gesuiti subirono la reazionedei loro superiori a causa di atteggiamenti non sempre“consoni” ai loro incarichi. Nel 1989, la scoperta in unacollezione privata di Napoli del cosiddetto “Manoscrittodi Napoli”, raccolta di scritti di alcuni gesuiti, tra iquali Oliva, Cumis e Pedro de Illanes, confermò comeall’interno dell’Ordine esistessero delle correnti dipensiero in contrasto con la politica filo-spagnola delPadre Generale Aquaviva e che furono costrette alla
24
clandestinità dal rigore di quest’ultimo. A Cumis fuimpedito il trasferimento in Cina, mentre ad Oliva non fuconcessa la pubblicazione della sua prima opera. Pedro deIllanes operò in un periodo posteriore, quando l’Ordinecominciava già a risentire delle pressioni politiche deiregni cristiani, sempre più insofferenti verso lecontinue intromissioni dei gesuiti nei loro affariinterni e i superiori avevano problemi ben più gravidella disciplina di missionari recalcitranti. EppureIllanes esprime opinioni del tutto affini a quelle deigesuiti che redassero il manoscritto e per molti versi inconsonanza con le più intime convinzioni di Las Casas. Inun passo del sopracitato documento, in cui Illaness’interroga sull’identità degli autori del manoscrittosulle origini degli Inca e del loro sistema di scrittura,leggiamo: “Chiunque egli sia, ha scritto una pagina distoria veramente drammatica: è poco, senza dubbio, ciòche resta dell’antica Gerusalemme sulla quale passarono,violenti e devastatori, i Conquistadores. Dio ne abbiamisericordia…”. Dunque per Illanes, che scriveva nel1737, era ancora del tutto naturale l’ereticaassociazione tra il l’Impero Inca (Tawantisuyu) e la“Città di Dio” agostiniana. Rimane da citare ilmisterioso Blas Valera, del quale Giovanni Antonio Cumisdice che “per l’intero popolo dei Piruani, essendo eglimeticcio, fu non solo guida spirituale, ma soprattuttoloro difensore…il quale ebbe molti fastidi dai suoistessi confratelli, per il fatto che s’era schieratocontro le torture della queshua che gli Spagnolipraticavano per estorcere l’oro…non voleva che alcuni diessi (i sacerdoti cristiani), falsamente col nome di GesùCristo sulla bocca, accusassero di idolatria il popolo…inquanto la religione da esso professata era molto simile aquella Cattolica”. Lo stesso Oliva dichiara che “tutte lereligioni hanno fondamenta comuni”. In un importantebrano, dedicato alla figura di Huayna Capac, undicesimoInca, Oliva esprime la sua convinzione che il vangelo sia
25
stato in qualche modo percepito dagli indigeni ancheprima dell’arrivo dei missionari. È il fol.74v., dalquale apprendiamo che l’Inca si era permesso di nonpiegare la testa di fronte al padre Inti, il Sole,motivando questa sua condotta sacrilega con unragionamento tanto arguto che era stato in grado diconvincere il Gran Sacerdote. Nessun suddito potevacostringere l’imperatore a fare alcunché. Stando così lecose solo un essere più potente poteva obbligare il Solea seguire costantemente la traiettoria celeste ad essoassegnata; di qui l’inutilità di mostrare devozione versoun servo. Oliva commenta questa argomentazione dell’Incaaffermando che, se i missionari fossero giunti a queltempo, sarebbero certamente riusciti a convertirlo allavera fede, dato che il seme era stato già gettato dalladivina provvidenza. Il miraggio di una comunità umanaunita da una stessa credenza pervadeva questiconfratelli, al punto da far loro intravedere lapossibilità che le sue fondamenta fossero già state inqualche modo gettate prima dell’arrivo deiConquistadores. Questo per merito delle riflessioni dialcuni individui particolarmente ispirati, o per unapredicazione diretta da parte di cristiani spintisi finlaggiù secoli addietro.
Ma torniamo alla domanda centrale che ci si pose almomento del Contatto, che è poi quella formulata daAgostino: ci possono essere degli esseri umani che nondiscendono da Adamo? Secondo Giuliano Gliozzil’appartenenza degli Americani al genere umano non fu maiseriamente messa in discussione nella Spagna del primoCinquecento, ligia alle consegne papali (Gliozzi, 1977).Per il gesuita José de Acosta, autore della Historia natural ymoral de las Indias era irrilevante il modo in cui Dio avevapopolato il Nuovo Mondo; ciò che contava era lafondamentale unità dell’umanità.
26
Tommaso Campanella, sebbene monogenista in accordocon le Sacre Scritture, era fautore della tesi dellaprogressiva corruzione della stirpe noachica approdata inAmerica e quindi della giustezza della punizione degliIndios da parte degli Spagnoli che, umiliandoli,divenivano strumenti della volontà provvidenziale.Campanella sosteneva che le Sacre Scritture menzionavanoil Nuovo Mondo: Mosé, a suo parere, aveva tramandato chei figli di Javan avevano raggiunto le isole; Gesù, semprea suo parere, affermava di voler raccogliere con sé anche“le altre pecore, che non sono di quest’ovile”. InfineEsdra che, ispirato dall’Altissimo, parlava dello strettoche si deve oltrepassare per regnare sopra il vasto mare(Gliozzi, 1977). Nella prospettiva monogenetista, chedominava gli ambienti ecclesiatici del tempo,intensamente impegnati a replicare alle teoriepoligenetiste “libertine”, era naturale che le Americhenon potessero essere intese come un mondo assolutamenteestraneo a quello biblico-cristiano. Ciò avrebbesignificato abdicare dalla missione suprema del suocompleto inglobamento realizzato con l’evangelizzazione econ la costituzione di una monarchia universalecattolica. Di conseguenza per Campanella l’unica famigliaumana, che ha come capostipite Adamo, fu distrutta da Diocon il diluvio universale che separò, come testimoniaPlatone, il Vecchio dal Nuovo Mondo. Questo fu ripopolatoda Noè, che provvide a mandarvi “colonie […] per la Chinaed il Giappone, ed empì di abitatori tutto il paese sin aBaccalaos e tutto il Perù” (Ghiozzi, op. cit.). Questidiscendenti non ebbero la possibilità di ricevere laparola di Cristo, e per questo continuarono a peccare.
Antonio de la Calancha (1584-1684), monacoagostiniano e antropologo ante litteram, sosteneval’ipotesi tartara perché anche lui non era rimasto immunealla “fascinazione” europea verso l’estremo Oriente. Unodei primo estensori delle cronistorie indigene, il padregesuita Miguel Cabello de Valboa, malagueño di nascita e
27
giunto in America a partire dal 1556, era noto per laprecisione delle sue ricerche, redatte dopo averminuziosamente esplorato gli altipiani e la forestavergine dell’Ecuador e del Perù settentrionale, ma ancheper essersi formato una pervicace convinzione riguardoall’origine dei nativi. Von Hagen (Von Hagen 1987, p.117) annota che “frate Juan de Orozcomán, un eruditofrancescano che in molti suoi scritti aveva già avanzatoipotesi sulle “origini”, così rispose a Cabello, avido disapere: gli indiani erano Ebrei; essi discendevano “daNoè attraverso Sem ed attraverso Ofir pronipote di Noè”.Padre Cabello adottò questa tesi. Mentre era a Quito,aveva persino eseguito una mappa, ora perduta, perrappresentare queste migrazioni; egli si lanciò adimostrare per mezzo dell’indagine che quegli indianidiscendenti da Ofir avevano raggiunto il Sudamericapassando per le isole sparpagliate nel Pacifico, tral’India e le due Americhe.
Per concludere, la testimonianza di FrancescoGuicciardini, che così commentava la scoperta del NuovoMondo nel capitolo nono del libro sesto della “Storiad’Italia”: “Né solo ha questa navigazione confuso moltecose affermate dagli scrittori delle cose terrene, madato, oltre a ciò, qualche ansietà agl’interpreti dellaScrittura sacra, soliti ad interpretare che quelversicolo del salmo, che contiene che in tutta la terrauscì il suono loro, e nei confini del mondo le paroleloro, significasse che la fede di Cristo fosse per labocca degli Apostoli penetrata per tutto il mondo:interpretazione aliena dalla verità, perché, nonapparendo notizia alcuna di queste terre, né trovandosisegno o reliquia alcuna della nostra fede, è indegno diessere creduto, o che la fede di Cristo vi sia statainnanzi a questi tempi, o che questa parte sì vasta delmondo sia mai più stata scoperta, o trovata da uomini delnostro emisferio” (Guicciardini, 1963). Molte idee etutte poco chiare.
28
Per completare la descrizione del clima ideologiconel quale si svilupparono le teorie sul popolamento delNuovo Mondo, sarà ora necessario concentrarsi sullanozione di razza come stava prendendo forma all’epocadella Riconquista, ossia della cacciata dei Mori dalsuolo iberico, avvenuta nel 1492, poco prima dellascoperta dell’America, quasi che l’impulsoespansionistico della corona di Castiglia non potessearrestarsi sulle coste del Mediterraneo.
Uomini a metà
Il sott’uomo, questa creatura, con le sue mani, i suoi piedi, quel suo tipo dicervello, con i suoi occhi e la sua bocca, una creatura che sembraappartenere alla stessa specie di quella umana. Tuttavia se ne discostacompletamente: una creatura orribile, una parvenza di uomo, con tratti similia quelli dell’uomo, ma situata, in virtù del suo spirito, della sua anima, al disotto dell’animale. All’interno di questa creatura vi è un caos di passioniselvagge, senza freni: un’indicibile volontà di distruzione, messa in atto dagliappetiti più primitivi, un’infamia senza pudore.Ufficio centrale delle SS per la razza e lacolonizzazione, testo di propaganda contro gli Ebrei(1942)
Nel secolo presente i neri sono creduti di razza e di origine totalmente diversida’ bianchi, e nondimeno totalmente uguali a questi in quanto è a dirittiumani. Nel secolo decimosesto i neri, creduti avere una radice coi bianchi, edessere una stessa famiglia, fu sostenuto, massimamente da’ teologispagnuoli, che in quanto a diritti, fossero per natura, e per volontà divina, digran lunga inferiori a noi. E nell’uno e nell’altro secolo i neri furono e sonovenduti e comperati, e fatti lavorare in catene sotto la sferza. Tale è l’etica; etanto le credenze in materia di morale hanno a che fare colle azioniGiacomo Leopardi, Pensieri LXVI
Atrocità, genocidi e schiavitù sono inevitabili? Nonper Las Casas, che si sforzava di trovare un modo per
29
prevenire la prepotenza dei forti sui deboli,raccogliendo tutte le ragioni che potessero sostenere lasua campagna umanitaria. Non si opponeva all’idea chealcuni popoli fossero effettivamente barbari ma facevarilevare come “queste genti delle Indie, come noi lestimavamo barbare, così anch’esse, non comprendendoci,ci consideravano tali” (Apologética Historia II, 435). Ribadivainoltre che tutti gli esseri umani sono stati creati adimmagine e somiglianza di Dio e quindi vanno consideratifratelli, redenti dal sacrificio del Cristo. Senza questacredenza nella creazione autoriflessa la servitù naturalesarebbe stata più facilmente difendibile. Bisogna peròpure ammettere che l’assunto cristiano da essa derivatodell’identico valore di tutte le anime umane potrà ancheaver influenzato positivamente il pensiero giuridicoeuropeo, ma non ha impedito che la schiavitù nei paesicattolici sia rimasta in vigore per quasi 1900 anni (Cubaabolì la schiavitù nel 1880 ed il Brasile nel 1888),ossia per circa il 95 per cento della storia dellaCristianità stessa.
Gregorio XVI, nella bolla In Supremo (1839), denunciavaquesta nefandezza in termini inequivocabili: “Ma poi, elo diciamo con immenso dolore, sono sorti, nello stessoambiente dei fedeli cristiani, alcuni che, accecati dallabramosia di uno sporco guadagno, in lontane einaccessibili regioni ridussero in schiavitù Indiani,Negri e altre miserabili creature, oppure, con un sempremaggiore e organizzato commercio, non esitarono adalimentare 1’indegna compravendita di coloro che eranostati catturati da altri”. Nonostante ciò, il suosuccessore, Pio IX, nelle sue istruzioni del 20 giugno1866 - pochi mesi dopo l’entrata in vigore deltredicesimo emendamento, abolizionista, dellaCostituzione degli Stati Uniti d’America, il 6 dicembre1865 - dichiarava che: “La servitù in quanto tale,considerata nella sua natura fondamentale, non è deltutto contraria alla legge naturale e divina; possono
30
esserci molti giusti diritti alla servitù e sia i teologiche i commentatori dei canoni sacri vi hanno fattoriferimento. Non è contrario alla legge naturale e divinache un servo possa essere venduto, acquistato, scambiatoo regalato” (cf. Martina, 1985).
Per l’intero corso della storia umana, l’istintodella prevaricazione e l’ideologia dell’oppressione hannocontinuato a dividere l’umanità in due categorie: laspecie degli uomini autentici e la specie dei semiumani,sottoumani o primati superiori, passibili diassoggettamento. Fortunatamente il filosofo britannicoJohn Locke (1632 –1704), paladino della proprietàprivata, fu l’ultimo dei grandi pensatori europei aprodurre argomentazioni in favore della schiavitùperpetua. Possiamo dunque sperare che eventuali futureinversioni di rotta, come durante il nazismo, siano soloepisodiche.
Mentre nel Nord Europa si dibatteva sulla possibilitàche diversi ceppi della specie umana si fosserosviluppati in diversi punti del globo, la disfidadialettica tra Las Casas e i suoi avversari orbitòpiuttosto intorno al tema della pari dignità incontrapposizione alla condizione di servitù naturale. Inun certo senso gli schiavisti ispanici utilizzavano leargomentazioni del pensiero razziale e solo in rari casimanifestavano pubblicamente il riduzionismo teriomorfodel nazismo, che combatteva Ebrei e Rom come specie anti-ariane e perciò sub-umane ed anti-umane. Non eraammessibile farlo, specialmente dopo la bolla Sublimis Deidel 1537, in cui Paolo III affermava che i nativiamericani erano esseri umani come tutti gli altri eperciò perfettamente idonei all’ammissione alla comunitàdei fedeli. Non solo, il pontefice sferrava un attaccodevastante alle opinioni di tutti coloro che giudicavanosemi-umani o sotto-umani gli indiani, associandoli aSatana: “Il nemico del genere umano, che sempre si oppone
31
alle opere buone affinché gli uomini periscano, inventòun mezzo fino ad oggi inaudito per impedire che la Paroladi Dio fosse predicata alle genti per la loro salvezza eispirò alcuni dei suoi sottoposti che, desiderandocompiacerlo, non hanno esitato ad affermare che gliIndiani occidentali e meridionali e le altre genti di cuiin questi tempi abbiamo avuto conoscenza, devono, con ilpretesto che ignorano la fede cattolica, essere condottialla nostra obbedienza come se fossero animali e liriducono in schiavitù, affliggendoli con quelle violenzeche si usano con le bestie. Noi quindi che, benchéindegnamente, facciamo in terra le veci di Nostro Signoree che con ogni sforzo cerchiamo di condurre al suo ovilele pecore del suo gregge che ci sono state affidate e chestanno fuori del suo recinto, considerando gli stessiindiani come i veri uomini che sono, che non solo sonocapaci di ricevere la fede cristiana, ma che, secondo lenostre informazioni, accorrono prontamente ad essa, edesiderando intervenire con rimedi opportuni, facendo usodell’Autorità apostolica determiniamo e dichiariamoattraverso le presenti lettere che detti Indiani, e tuttele genti di cui in futuro i cristiani verranno aconoscenza, benché vivano fuori della fede cristiana,possono usare, possedere e godere liberamente elecitamente della loro libertà e del dominio delle loroproprietà; che non devono essere ridotti in schiavitù eche quanto sia fatto contro di ciò è nullo e senzavalore; che detti Indiani e le altre genti devono essereinvitati ad abbracciare la fede di Cristo attraverso lapredicazione della Parola di Dio e con l’esempio di unasanta vita, non essendovi nulla in contrario”. Pensieriespliciti e categorici, ma purtroppo pronunciati in unsistema mondiale non regolato dal diritto internazionalee dai mezzi per farlo rispettare. La quasi totaleindifferenza dei partecipanti al Concilio di Trento neiconfronti della questione dell’evangelizzazione degliIndios e il fatto che entro la metà del sedicesimo secolo
32
il governo spagnolo aveva già nominato autonomamenteventidue vescovi ed arcivescovi sul suolo americano,dimostrano lo scarso ascendente papale in questefaccende.
Le cronache, le relazioni e le corrispondenzemostrano che molti Spagnoli non ebbero alcuno scrupolo ecredevano sinceramente che la falcidie degli indioscausata dalle epidemie fosse una punizione divina equindi la prova che Dio stava dalla loro parte. Si stimache, nel 1496, l’isola di Hispaniola (gli attuali statidi Santo Domingo ed Haiti) avesse una popolazione dioltre 3 milioni e mezzo di abitanti. Dopo soli 22 anni ilnumero di indigeni era calato fino a 16.000, dopo 44 annine erano rimasti 250. Secondo una stima complessiva, almomento del contatto, la popolazione messicana era dicirca 25 milioni. Dopo un secolo era scesa ad un milione.In Perù si passò da oltre 30 milioni a 5 milioni diindios in 28 anni di occupazione. La causa del collassodemografico non va ricercata solo nelle epidemie emigrazioni. Il calo continuò anche quando la situazionesi era ormai stabilizzata. Quel che avvenne fu che ilcrollo delle strutture socio-culturali indigene avevaucciso la speranza in un futuro migliore e non sifacevano più bambini, ci si suicidava, ci si lasciavamorire di inedia, o si moriva per esaurimento fisico dasfruttamento eccessivo (Traboulay, 1994).
Sia padre José de Acosta, peraltro un uomogeneralmente tollerante e comprensivo, sia Bernal Díazdel Castillo, esploratore, conquistador e cronista,stabilivano un parallelo tra Tenochtitlan e Gerusalemme etra gli Indios e gli Ebrei condannati dal Dio cristiano.Gregorio García, nell’Origen del los Indios del nuevo mundo,legittimava la guerra santa facendo riferimento allepiaghe bibliche che avevano imperversato nel Nuovo Mondoper punire gli indigeni. Il missionario francescanoToribio de Benavente, detto Motolinía, che pure in
33
diverse occasioni fustigava la violenza e l’arroganza deiconquistatori, era dello stesso avviso e cominciò la suaHistoria elencando le dieci piaghe inviate da Dio a punireil Nuovo Mondo. La guerra era un castigo, la servitùun’espiazione, la distruzione di culture, simboli e stilidi vita era ipocritamente elevata a principio di libertàtrascendente e redenzione. Un sinistro e terribileesempio di nichilismo teologico-morale: bisognavadisprezzare la vita terrena per potersi guadagnare quellaultraterrena. Convinti del fatto che Dio fosse dalla loroparte, gli Spagnoli trasformarono il Messico in un vero eproprio lager, dove gli indigeni morivano come mosche,dovendo persino pagare di tasca proprio per il materialeda costruzione che erano costretti ad usare per costruirela città dei nuovi signori, mentre i loro campi nonvenivano coltivati, condannandoli a morire di fame. Glischiavi che lavoravano nelle miniere recavano sul volto isegni dei vari padroni che li avevano posseduti. Allafine alcuni visi divenivano irriconoscibili. I neonativenivano fatti divorare dai cani per “diletto” o persfamarli. I trasferimenti uccidevano una gran parte diquesti schiavi. Innumerevoli testimoni assistettero astupri di massa, pire di prigionieri ancora vivi emassacri completamente gratuiti, con terribiliamputazioni e torture, per il puro piacere di farlo,perché era possibile farlo senza incorrere in alcunapunizione, come in Bosnia, come in Ruanda, come aNanchino, come nell’Europa nazista. C’era chi si sentivaimmune da ogni potere esterno, perché nessuno lo avrebbeincriminato per le sue azioni. Troppi esseri umanitrovano gratificante violare le norme morali piùbasilari. I conquistatori più crudeli non si comportaronoa quel modo solo perché erano avidi e volevano diventarericchi nel più breve tempo possibile, giacché l’oroconquista titoli, onorificenze, prestigio, status, ecc.Lo fecero anche perché si divertivano a farlo, altrimentinon avrebbe avuto senso distruggere la forza lavoro che
34
permetteva loro di arricchirsi. Si esaltarono nel loroistinto di morte, nel Bemächtigungsbetrieb, l’istinto didominio, di sopraffazione. Una società di maschiguerrieri, arrivisti, ingordi, brutali, stolti, pavidi,rinnegatori di se stessi, parvenu, leccapiedi privi dicoscienza e di scrupoli, sadici che godevano neltorturare e massacrare gli avversari domati. Ma anche diamministratori coloniali modello, che portavano a termineil proprio compito senza esaminare il suo contenuto,senza interrogarsi sulla sua eticità, che amavano unlavoro ben fatto in quanto tale. Tutto questo condusse adun’anestetizzazione della sensibilità. Né Cortés néPizarro, né molti altri sterminatori si sentirono maiveramente responsabili di nulla, anche se avevano fattoqualcosa di così enorme che non potevano nonriconoscerlo. La guerra di sterminio spagnola sovvertìl’ordine sociale locale e pervertì quello dellamadrepatria ma il tutto avvenne in una parentesitemporale, in un Nuovo Ordine di un Nuovo Mondo dove leregole del vecchio non valevano più, o moltolimitatamente. Un intervallo di tempo sospeso, al difuori della storia, non una cesura – anche se per gliindigeni fu la più devastante delle cesure. Unaliberazione dalle costrizioni della vita quotidiana in unsistema chiuso, una scatola nera ermeticamente sigillatarispetto all’esterno, dove l’anormalità diventava lanorma, le convenzioni non valevano più e mancava unareale presa di coscienza di quel che si stava facendo. Unsenso di finalità, di irreversibilità, di apatia edintorpidimento morale conquistò tanti conquistatori, chenon riuscivano a provare alcuna compassione se non per sestessi ed i compagni d’arme. Vivevano alla grande, eranodiventati ricchi, andavano a letto con la pancia piena,senza preoccupazioni per il futuro. Ognuno aveva ricavatoun profitto e si era lasciato alle spalle gliinconvenienti della miseria, le norme sociali dellamadrepatria e i principi fondanti della religione. In
35
molti casi è assai probabile che non percepissero diavere una vera e propria esistenza individuale e non lariconoscessero alle vittime, esattamente come questeultime – gli Aztechi ed i loro alleati – non l’avevanoriconosciuta ai popoli sottomessi. Qualcuno dovevarecitare la parte della vittima e qualcun altro quelladel persecutore trionfante.
Poi c’era il riduzionismo zoologico. In ognigenocidio si animalizzano le vittime. Più remoto edalieno il nemico, più calamitoso il massacro: conl’espandersi degli orizzonti, l’esotismo degli incontri,l’indebolirsi delle leggi e l’allontanarsi delle forzedell’ordine, tutto è permesso. Ci si convince che Dio nonha nulla a che vedere con le vittime, anzi, è favorevolealla loro distruzione. Senza questi elementi di certezzamorale, distanza psicologica e fatalismo biologistico eteologico, senza il carattere assoluto di questoprogetto, è difficile immaginare che la Conquista sisarebbe realizzata così brutalmente. Esaminiamo meglioquesto aspetto teriomorfizzante. Nel 1556 il cronistaGonzalo Fernández de Oviedo diede alle stampe la Historiageneral y natural de las Indias, che descriveva con abbondanza diparticolari le usanze indie, a volte in modo abbastanzaobiettivo, e talora persino con paragoni piuttostofavorevoli rispetto a Greci e Romani. Tuttavia, pur nonriducendo gli indiani al rango di cavalli o asini, licollocava da qualche parte tra i materiali da costruzionee gli altri oggetti inanimati. “Dio provvederà presto adistruggerli tutti”, tuonava, sicuro che “l’influenza diSatana scomparirà quando la maggior parte degli indianisarà morta…chi può negare che l’uso della polvere dasparo contro i pagani equivale alla combustionedell’incenso in onore di Nostro Signore?”. Concludeva poiche gli Indiani sono “codardi sozzi e mentitori che sisuicidano per noia, solo per danneggiare gli Spagnoli conla loro morte; non hanno alcun desiderio o capacità dilavorare” e l’idea di farne dei Cristiani equivaleva a
36
“martellare il ferro quando è freddo” perché le loroteste erano così dure che quando combattevano contro diloro gli Spagnoli dovevano stare attenti a non colpirliin testa con le spade, per non spezzarle. I sovraniindiani, continuava lo storico e naturalista spagnolo,non avevano alcuna pietà e governavano con l’intento diincutere il terrore, non facendosi amare. Adoravano ildiavolo, ma non per sincero amore, ma perché lo temevano.Essi spiegavano ai cronisti che se non lo avessero fattolui avrebbe inviato la grandine a distruggere i lororaccolti. Oviedo assicurava che gli uomini erano pigri,mandavano le donne e i bambini a lavorare mentre lorobattevano la fiacca e passavano le giornate adubriacarsi. Vivevano in povertà per l’eccessivatassazione dei sovrani aztechi e se non riuscivano apagare le tasse erano venduti come schiavi. Fu l’unicocronista ad essere citato da Sepúlveda nella Disputa diValladolid a supporto della tesi dell’intrinsecadepravazione ed inferiorità degli Indiani. Las Casasribattè che il cronista di corte aveva questa pessimaopinione degli indios perché lui stesso aveva preso partealla Conquista: il suo giudizio era distorto dallenefandezze che aveva a sua volta commesso o autorizzato.Accanto a queste asserzioni se ne possono enumerare altreche presentavano gli indiani come esseri semi-umani.Invero, la maggior parte dei commentatori europeiaccettava l’idea che i nativi fossero umani, ma eraindecisa sul loro grado di umanità. Altri non riuscivanoa trattenere il loro disprezzo per gli autoctoni; gliIndios erano una via di mezzo tra le scimmie e gliuomini, creati da Dio per servire l’uomo o comunque comeostacoli da sormontare nell’avanzata lungo la scala naturae,al fine di forgiare lo spirito e l’intelletto. L’umanistaaronese Pietro Martire d’Anghiera ed il filosofo politicoGiovanni Botero si trovavano d’accordo nello sminuirnel’umanità per la presunta assenza di leggi e di una verae propria classe dirigente. Il viceré Francisco de
37
Toledo, ottimo amministratore delle risorse minerarie delPerù quanto fu un pessimo gestore di quelle umane,asseriva che “prima di divenire cristiani, gli indiosdevono diventare uomini”. Il giurista Diego deCovarrubias, in seguito un abolizionista, li definiva“stolidi, dementes, obtusi, hebeti” e “di ingegnoanimale”. Persino l’educatore francescano fiammingoPieter van der Moere (Pedro de Gante), che si consideravaun padre per i suoi discenti, scrisse a Filippo II, nel1585, che erano “animali senza ragione, indomabili, chenon possiamo portare in seno alla Chiesa”, salvo poi dareun importante contributo allo sradicamento delletradizioni locali. “I nativi di questa terra sono…adattia ricevere la nostra santa fede. Ma hanno lo svantaggiodi essere di condizione servile, perché non fanno nullase non li si costringe…non hanno appreso a fare nulla peramore di virtù, ma solo per timore e paura. Tutti i lorosacrifici, cioè uccidere i propri figli o mutilarli, lofacevano per la paura, non per amore degli dèi” (cf.Thomas 1994, p. 463)
José de Acosta, antropologo ante litteram enaturalista gesuita, nell’Historia natural y moral de las Indiasaveva denunciato il pregiudizio di chi credeva che gliindiani fossero dei bruti, notando come, al contrario,chi li aveva studiati ed aveva appreso la loro storia erarimasto assolutamente “stupito di come ci siano staticosì tanto ordine e raziocinio tra loro”. Ciò nonostanteebbe a dire degli indigeni non associati in formestatuali che “a tutti costoro, che a malapena sonouomini, o sono uomini a metà, è opportuno insegnare aessere uomini e istruirli come bambini. E se attraendolicon carezze si lasceranno istruire, tanto meglio; ma seresistono, non per questo bisogna abbandonarli. […] Mabisogna costringerli con la forza ed il potere opportuni,ed obbligarli ad abbandonare la selva ed a riunirsi invillaggi e, anche in certo modo contro la loro volontà,far loro forza perché entrino nel regno dei cieli”. Il
38
domenicano Domingo de Betanzos li chiamava “bestias”. Nel1528 disse che la loro barbarie condannava i NativiAmericani ad una rapida e certamente meritata estinzione,salvo poi, nel 1549, sul letto di morte, sconfessaretutto quello che aveva detto sugli Indiani, dichiarandolofrutto di un equivoco dovuto alla scarsa conoscenza dellalingua autoctona ed alla sua ignoranza in generale. Ilgiurista spagnolo Juan de Matienzo li considerava “piùschiavi dei miei negri”. Il dominicano Tomás Ortizscriveva al Consiglio delle Indie che gli autoctoni eranocannibali, sodomiti, non conoscevano la giustizia,giravano nudi, non rispettavano l’amore, la virginità ela verità, salvo quando andava a loro vantaggio. Eranoanche scimuniti, instabili, imprevidenti, ingrati evolubili, brutali, si dilettavano nell’esagerare i propridifetti, erano disubbidienti, insubordinati edirrispettosi. Si rifiutavano o erano incapaci diapprendere il giusto modo di vivere. Le punizioni nonservivano da deterrente con loro. Mangiavano insetti evermi, osavano affermare che il messaggio cristiano eraadatto agli Spagnoli, ma non necessariamente a loro; nonvolevano cambiare le loro usanze. Più vecchi diventavano,peggio si comportavano: da ragazzini sembravano avere unaparvenza di civiltà, da vecchi diventavano delle bestie.“Devo dunque affermare che Dio non ha mai creato unarazza tanto radicata in vizi e bestialità, senza alcunapresenza di bontà e civiltà”. Il francescano Bernardinode Sahagún va apprezzato non solo per aver studiatorispettosamente la lingua franca del Messico centrale, ilnahuatl e la cultura Nahua dei Mexica, ma anche per lalodevole iniziativa di aver preservato i Colloquios y doctrinachristiana, i sermoni dettati dai primi francescani giuntiin Messico agli ultimi filosofi nahua. Da questiapprendiamo però che la visione comune era che l’indio,in quanto omuncolo, poteva essere ucciso o asservito, manon solo, era necessario che accettasse questa sua
39
condizione attraverso lo strumento di persuasione delterrore.
Quando l’umanità indigena non fu più messa indiscussione e la tesi della loro schiavitù naturale furespinta, si escogitò l’inghippo della servitùpaternalistica (schiavitù legale), cioè della presa inconsegna di terre, risorse e popolazione in forza delprincipio della res nullius (area legittimamenteappropriabile in quanto libera da vincoli proprietari),dello ius belli (il diritto di guerra) in una “guerralegittima” (bellum iustum), dello ius predae (diritto albottino) e dell’imperativo della buona amministrazione dipopoli immaturi (incapacità giuridica). Vale la pena disegnalare che questi stessi criteri di liceità furonoquelli che consentirono agli statunitensi di impadronirsidelle terre indiane e di segregare i nativi americaninelle riserve. Anche in quel caso una delle ragioniaddotte fu l’incapacità razziale di assolvere la missionemorale di mettere a frutto le risorse naturali. Ancoranel 1945 il giudice della Corte Suprema Robert H.Jackson, che fu anche il procuratore capo americano alprocesso di Norimberga, commentava come segue la sentenzadi “Northwestern Bands of Shoshone Indians v. UnitedStates” 324 U.S. 335 (1945): “Il senso del possesso, chesta alla base del diritto reale fondamentale [diproprietà], è una conquista esclusiva dei popoli civili”.In pratica, gli Europei avevano scoperto la terra, anchese questa era abitata da tempi ancestrali, e quindi se lapotevano tenere (con acclusa l’umanità ivi dimorante),perché erano signori e padroni di natura, in quantodotati di quelle facoltà intellettive e di quellasaggezza che mancavano agli altri popoli.
Nel 1524 Cortés in persona si rivolgeva al sovranoper difendere lo status quo: “Conviene che Vostra Maestàordini che gli Indiani di queste parti si affidino agliSpagnoli perpetuamente perché in questo mondo si avràcura di ognuno come di una cosa propria, un’eredità che
40
dovrà succedere ai discendenti”. Nel 1595, il gesuitaLuis de Molina (1535-1600) pubblicò il primo volume di DeIustitia et Iure, affrontando il problema posto dalla trattadegli schiavi per la sensibilità e coscienza cristiana.Rigettava l’argomento della schiavitù naturale masosteneva che, almeno provvisoriamente, si dovesseroagevolare “gli schiavisti pii”, quelli cioè disposti adonare agli schiavi la fede cristiana, strappandoli cosìad una vita barbara ed empia, “sebbene tutto ciò siaccompagni alla miseria della schiavitù perpetua”. Èforse una delle prime formulazioni dell’ideologia delfardello dell’uomo bianco, costretto dalla suacompassionevole coscienza a prendere sotto tutela l’umanoinferiore. Argomentazioni analoghe sarebbero poi stateavanzate dai gesuiti Alonso de Sandoval e Diego deAvendaño, qualche decennio dopo Molina. In Noticias históricasde la Nueva España (1589), Juan Suárez de Peralta, figlio diun encomendero e lontano parente di Cortés, scriveva chegli indiani se la passavano molto meglio rispetto a primadella conquista. Si domandava argutamente anche come mainessun attivista umanitario si fosse speso per la difesadei diritti dei neri come lo avevano fatto per gliindios. Ogni argomento usato per gli uni dovevanecessariamente valere anche per gli altri. Infatti,fatta eccezione per la pelle più scura, nient’altro lidistingueva: erano cannibali, praticavano la schiavitù,l’idolatria ed i sacrifici umani e non avevano attaccatoper primi gli Spagnoli, ma erano stati invasi. Eppure gliSpagnoli di ogni ordine e grado, inclusi vescovi, preti epersino frati, possedevano schiavi neri. Perché i duepesi e due misure?
Fino al diciottesimo secolo, non ci fu mai un seriodibattito sulla condizione degli Africani e sulla lorouguale umanità. Per lungo tempo Las Casas fu uno deipochi a pentirsi non solo dell’omissione della denunciama della perorazione dello schiavismo (André-Vincent,1980). Infatti nel 1516 e 1518 aveva suggerito
41
l’importazione di schiavi africani, fisicamente piùresistenti ed immuni alle malattie europee, e nel 1544aveva ottenuto una licenza per la loro importazione.Questa presa di posizione, che sconvolge la sensibilitàdei lettori contemporanei, veniva incontro all’esigenzamanifestata dai coloni di impedire che l’emancipazionedegli indigeni bloccasse lo sviluppo delle colonie. Inpratica, si rendevano necessarie delle concessioni, incambio di una contropartita: la liberazione dal giogo deinativi americani. Di qui la richiesta dei fratimissionari di passare all’importazione di schiaviguineani, o bozales. Nel 1518 il sovrano concede lalicenza di trasporto di quattromila schiavi africaninelle Americhe. Las Casas non fu direttamente coinvoltoin questa decisione ma non la avversò, anche perché fratePedro de Córdoba, in una missiva, lo esortava a dare perpersa la popolazione caraibica, ormai virtualmenteestinta, concentrandosi invece su quella del continente.Il comportamento lascasiano va dunque valutato alla lucedi un frangente davvero catastrofico, in cui un processodi colonizzazione ed evangelizzazione giudicatorealisticamente irreversibile è causa di un tracollodemografico inaccettabile sia in termini pratici, sia intermini cristiani.
Nel luglio del 1519 Las Casas redige un progetto cheprevede che ciascun colono disponga di sette schiavi eschiave per poter operare in modo tale da mantenersi edarricchire le casse reali. Las Casas, moltorealisticamente, non perde mai di vista la necessità diperorare ogni sua causa giustificandola con l’interessedel monarca ad espandere le sue disponibilitàfinanziarie. Questo suo progetto non comportava lacattura di persone libere, ma il trasferimento dallaSpagna alle Americhe di prigionieri di guerra, bianchi oneri. Il suo errore più grave fu quello di non essersiinterrogato sulla reale origine di quegli schiavi e sullalegittimità stessa della schiavitù di guerra.
42
Nonostante le sue raccomandazioni, la quota dischiavi importati, che non doveva eccedere lequattromila persone, fu superata molto presto. Solo nel1544, e specialmente a partire dal 1547, dopo la suaordinazione a vescovo, Las Casas modificò in manierasensibile la sua posizione sulla schiavitù africana,tanto che il rivoluzionario francese Danton, rivolgendosialla Convenzione nazionale, che avrebbe approvatol’abolizione della schiavitù il 4 febbraio del 1794, loindicava come un precursore dell’abolizionismo ed unmodello da prendere ad esempio (Beuchot, 1994).
Sostando a Lisbona prima di tornare nelle Americhe,apprese dai domenicani locali la realtà della trattanegriera e scoprì che altri uomini di chiesa portoghesiavevano raccolto le sue invettive contro il servaggioindio per applicarle agli Africani. Fu probabilmenteallora che gli si aprirono gli occhi e vide che glischiavi non erano prigionieri di guerre “giuste” mavittime di rapimenti e deportazioni. La sua prima severacritica del traffico di schiavi portoghese e la nettasconfessione dei suoi precedenti convincimenti arrivarononel capitolo 129 del terzo volume della Storia delle Indie,che però fu pubblicata integralmente solo tra il 1875 edil 1876. Questa porzione della Historia de las Indias fucompletata tra il 1555 ed il 1556. Si tratta dei capitoliche vanno dal 17 al 27, quelli di cui Pérez Fernándezcurerà un’edizione separata sotto il titolo di Brevísimarelación de la destrucción de África. In essi il domenicanoillustra e denuncia la conquista portoghese delleCanarie, delle Azzorre e della costa occidentale africanae spiega che nei primi anni del suo apostolato diversicoloni si rivolsero a lui per ottenere la licenza disfruttamento di schiavi neri (algunos negros esclavos)promettendo che in cambio avrebbero liberato gliindigeni, ormai consunti. Nella sua petizione al re LasCasas non distingueva tra schiavi neri e bianchi especificava una provenienza spagnola, non africana
43
(esclavos negros y blancos de Castilla). Era convinto che glischiavi fossero pirati turchi e saraceni catturati nelcorso delle scorrerie o delle rappresaglie, dunquepersone che dovevano sapere a che pena rischiavano diandare incontro. Nel testo chiamò “tratta infernale edesecrabile” la schiavitù dei neri, ammettendo di aver“visto e compreso che ridurre in schiavitù i neri eratanto ingiusto quanto nel caso degli indios…e non èchiaro se l’ignoranza nella quale [lui] versava in questamateria e se la sua buona fede gli potranno servire comescusa dinnanzi al giudizio di Dio”. La suaidentificazione della causa india con quella deglischiavi africani, per quanto relativamente tardiva, gli ècomunque valsa il titolo di “primo difensore dei neri”,da parte di Ángel Losada (1970).
A mio avviso è perciò corretto concludere che laleggenda di un Las Casas peroratore dell’istituzioneschiavista fu dovuta alla lentezza con la quale siprovvide a pubblicare la Historia de las Indias, che contenevala suddetta nettissima e meditata presa di distanza dallesue posizioni iniziali e la piena, convinta adesione alleposizioni abolizioniste.
*****Le radici di queste controversie vanno ricercate agli
albori della ricerca etnografica. Quando missionari edesploratori cominciarono a spingersi verso i quattroangoli del globo incontrando popolazioni esotiche e“primitive”, scoprirono che in molte lingue il vocabolousato per indicare gli esseri umani era anche il nomedella tribù dell’interlocutore. In altre parole, i membridella tribù erano etnocentricamente esseri umani, glialtri no. Una forma primigenia di razzismo. Inantropologia si definisce razza un gruppo di popolazioniappartenenti alla stessa specie che differisce in almenoalcune caratteristiche fisiche da un altro gruppo di
44
popolazioni della medesima specie. Il razzismo è invecel’atteggiamento di chi giudica e tratta le persone infunzione della loro razza perché ritiene che un sostratobiologico determini la natura delle differenze culturalitra gruppi umani. Oggi la categoria razza non pare averepiù alcuna utilità scientifica. Da tempo gli antropologinon compiono studi razziali ed anche i genetisti hannomarginalizzato questa tematica così scottante, questoperché non esistono studi empirici che siano riusciti atracciare una linea netta e definita tra gruppi dipopolazioni. Infatti certi tratti somatici o genetici piùdiffusi all’interno di un dato gruppo umano si possonoincontrare in un altro gruppo che risiede in uncontinente diverso. Come sottolinea Luca Cavalli-Sforza(Cavalli-Sforza, 1996), quando si divide una lineacontinua lo si fa solo in modo arbitrario, e questo èprecisamente ciò che avviene quando si separa la specieumana in razze.
Il concetto moderno, cioè a dire “biologico”, dirazza apparve a partire dal quindicesimo secolo dellanostra era nella penisola iberica (Sweet 1997). Inprecedenza musulmani e cristiani avevano ridotto inschiavitù le popolazioni sub-sahariane senza porsi troppoil problema di una giustificazione scientifica delle loroazioni. Ma la necessità di separare i marrani spagnoli(ebrei convertiti) dai “veri cattolici” per poi cacciarlirese indispensabile l’adozione di criteri biologici.Successivamente, con l’ascesa del metodo scientifico, neldiciottesimo secolo, rinomati naturalisti come Linneo,Buffon e Blumenbach cominciarono a raggruppare assieme lepopolazioni umane in funzione della loro posizionegeografica. Ma si era ancora distanti dalla maniagerarchizzatrice del secolo successivo, quello che videil trionfo del positivismo. Quando le ambizioniespansionistiche dei governi e della classe mercantileprevalsero la scienza non trovò mai particolarmente arduoconfermare i sospetti del pubblico europeo, e cioè che se
45
altre civiltà erano arretrate ciò dipendevadall’inferiorità biologica dei suoi membri. Questa derivacognitiva e ideologica della scienza antropologica emedica impose una concezione gerarchica delledifferenziazioni razziali basata su premesse“naturalistiche”. La scala naturae, che nel linguaggioteologico rappresentava la catena che univa gli esseriviventi più semplici su su fino agli esseri umani, agliangeli per arrivare infine a Dio, fu rivista in modo taleda poter essere impiegata per rappresentare i rapportigerarchici che intercorrevano tra le razze e le civiltàumane. Questa grande catena dei viventi formava una scalasulla quale si posizionavano gruppi e specie a secondadel loro livello qualitativo, in basso gli inferiori edin alto quelli di elevato valore intrinseco. La suaorigine storica può essere fatta risalire allespeculazioni dei filosofi politici della Grecia classicache s’interrogavano sulla miglior conformazione possibiledella polis. La città ideale, come sostenevano fra glialtri Platone ed Aristotele, avrebbe dovuto strutturarsiin modo tale che gli schiavi, che erano inferiori dinatura, occupassero per sempre i gradini più in basso.Quando questa visione dell’umanità si fuse con unalettura finalistica dell’evoluzione, quella secondo cuile razze bianche erano destinate fin dal principio adominare il mondo, nulla poté ostacolare le campagneimperialistiche delle grandi potenze europee in Asia eAfrica e degli Stati Uniti nella loro espansione versol’Oceano Pacifico. La distinzione tra classificazionetassonomica e giudizio di valore rimase estremamenteconfusa, mentre la variabilità culturale fuprogressivamente ridotta ad una questione di diversitàbiologica, dunque inalterabile. L’anatomista scozzeseRobert Knox, nel 1850, dichiarò che “la razza o ladiscendenza ereditaria sono tutto, esse marchiano l’uomo”(Hudson 1996, p. 248). In questo modo si radicava anchein Europa una dottrina, l’ereditarismo, per molti versi
46
affine a quella karmica. Infatti, a differenza di quantogeneralmente si crede, il karma non è esclusivamenteinteso come un qualcosa di astratto ed impalpabile, comeil peccato originale, ma anche come una sostanza che puòessere trasmessa attraverso i fluidi corporei, allastregua di un virus. Nell’originale sistema karmico ogniindividuo è punito non solo per i propri peccati emanchevolezze, ma anche per quelli degli antenati eparenti (Keyes e Daniel, 1983). Le prime avvisaglie diereditarismo risalgono al concetto medievale di noblesse derace (e del seme), ovverosia quella commistione dibiologismo e moralismo, razzismo e fissazione per ilignaggi che permeava l’ideologia endogamicadell’aristocrazia feudale europea e che potremmo anchechiamare genealogismo. Spiega Giuliano Gliozzi che “acavallo tra la biologia e la morale, il concetto dipurezza del sangue apparteneva… all’ideologia nobiliare:la pratica endogamica della nobiltà spagnola e tedesca sigiustificava implicitamente o esplicitamente conl’assunto che le virtù nobiliari si ereditassero colsangue” (Gliozzi 1993: p. 246). Fondato sul principio chesolo i nobili natali, e perciò la purezza del lignaggio,potevano assicurare la nobiltà dello spirito edell’intelletto, esso influenzò pesantemente laformazione del sistema castale latino-americano impostodai Conquistadores (Gliozzi, 1986).
Non intendo insinuare che il principale avversario diLas Casas, Juan Gines de Sepúlveda, avesse aderitoentusiasticamente a questo tipo di sviluppi teorici e, diconseguenza, ai relativi corollari politici. Non èpossibile dimostrarlo, perché Sepúlveda non avrebbe maiosato esprimersi pubblicamente in questi termini ma, comemostrerò, certe affermazioni contenute nelle sue opere enella corrispondenza privata sembrano in effetti alluderead un orizzonte mentale e morale non sufficientementedistante da questi orientamenti e in contrasto con la suaformazione umanista. Altri cronisti della Conquista
47
furono certamente molto più espliciti di lui, perché nontemevano l’autorità papale e confidavano nel fatto che laCorona spagnola avrebbe chiuso entrambi gli occhi, pur dievitare “complicazioni” nella sua politica coloniale. Losterminio degli indigeni fu reso possibiledall’accettazione di premesse che andarono ben oltre ilrazzismo più sfacciato, arrivando in certi casi asfiorare i dogmi dell’arianesimo nazista, un casoesemplare di materialismo deterministico radicalizzato.Abbiamo visto e vedremo che vi fu non solo il rifiuto diintendere gli individui quali soggetti autonomi edindipendenti, che hanno valore per quel che fanno e peril fatto di essere membri della stessa specie. Ful’appartenenza alla medesima specie ad essere messa indubbio. Molti commentatori dell’epoca della Conquistamanifestavano una certa resistenza a considerare i nativicome esseri interamente umani.
Ciò che avvenne nel nazismo ed in una porzionetutt’altro che insignificante dell’ideologia dellaConquista fu un cortocircuito logico, un annebbiamentodelle facoltà cognitive che impedì di vedere nell’Altroun proprio simile. Come per i nazisti gli Ebrei erano unaminaccia per l’intero ordine che intendevano erigere,così per certi Spagnoli gli indigeni che si rifiutavanodi convertirsi o fingevano di farlo per poi continuare apregare i propri dèi costituivano un’offesa alla Verità,alla Giustizia, alla Provvidenza divina. Uno dei tantimeriti di Las Casas fu quello di porsi come ostacolo difronte a questa deriva, minando alle fondamental’archetipo dell’uomo precivile ed infantile, in unperenne stato di minorità, dunque bisognoso di riceveretutela e sacrificabile, se riottoso. Lo fece con periziaed avvedutezza. Questo è un esempio di una sua denuncia,esplicita ed inoppugnabile: “Hanno trovato il modo dinascondere la loro tirannia ed ingiustizie e pergiustificare le proprie azioni ai loro occhi. Ecco comehanno fatto: hanno affermato falsamente che gli Indiani
48
erano così privi della ragione comune a tutti gli uominiche non erano in grado di governare se stessi e perciòabbisognavano di tutori. E l’insolenza e follia di questiuomini è diventata così grande che non hanno esistato adinsinuare che gli Indiani erano bestie o quasi comebestie, diffamandoli pubblicamente. Poi hanno sostenutoche era giusto sottometterli alla nostra autorità con laguerra, e cacciarli come prede e ridurli in schiavitù.Così potevano fare uso degli indiani a loro piacimento”(De unico vocationis modo omnium infidelium ad veram religionem,1530).
Si tratta ora di capire la natura delle affinità trail fanatismo di certi conquistadores e una metafisica delsangue e della razza che ha attraversato i secoli fino araggiungere la “dignità” di dottrina di stato sotto ilNazismo. I nazisti credevano in una mistica dellabiologia, l’ideologia neo-pagana della metagenetica,l’idea che l’eredità/lascito biologico e spirituale diuna persona o di un popolo fossero ontologicamenteidentici e trascendessero lo spazio e il tempo. Ladisuguaglianza tra razze era di ordine biologico espirituale. Per questo, secondo Hitler, l’Ebreo eraalieno all’ordine naturale. Si può ipotezzare che, per lestesse ragioni, secondo Juan Gines de Sepúlveda, lanemesi di Las Casas, gli Spagnoli avevano non solo ildiritto ma il dovere di sottomettere con la forza inativi americani al fine di riallinearli spiritualmente,moralmente e culturalmente alle sacre leggi di natura.
La metafisica del sangue e della razza
C'è soltanto una nobiltà di nascita, una nobiltà del sangue. […]. Là dove siparla di "aristocrazia dello spirito", di solito non mancano motivi per celarequalcosa: come è noto, questa è una locuzione comune fra gli ebreiambiziosi. Lo spirito da solo, infatti, non nobilita; ci vuole piuttosto, prima,qualcosa che nobiliti lo spirito. Di che cosa c'è bisogno a tale scopo? Delsangue
49
Friedrich W. Nietzsche, La volontà di potenza
Il concetto di razza proviene dall’idea di unamacchia incancellabile (macula) che si trova nellatradizione biblica dell’impurità e nell’ideologiaaristocratica del lignaggio, che impone misure diprotezione e perpetuazione del sangue nobile, il “sanguebuono”, attraverso la pratica dell’endogamia e l’accuratacompilazione di tavole genealogiche. Nel corso del tempoquesto criterio è stato esteso ai popoli e razze.
La forza misteriosa e incomprensibile del genos e delsangue sedusse anche Friedrich Schlegel: “In una veranazione, ossia una comunità che assomiglia ad unafamiglia molto unita, i cittadini dovrebbero esseretenuti uniti dal sangue”. L’antichità e la purezza dellacorrente di sangue che attraversa le generazionigarantisce la persistenza dei costumi tradizionali emilita contro le influenze esterne. Il sangue, comesimbolo di adesione eterna alle sorti della nazione,opera verticalmente (trascendendo le epoche eproiettandosi verso il futuro) ed orizzontalmente(trascendendo le vicende personali). “Solo il plasmagerminale, non l’anima, è immortale. L’uomo che muoresenza discendenza pone fine all’immortalità dei suoiantenati. Riesce ad uccidere i suoi morti”, affermal’antropologo francese Georges Vacher de Lapouge (Lesselections socials, 1896). Il lignaggio, non la vita sociale,determina il carattere: tutto si eredita, l’eredità ètutto. Nel nazismo si arriverà alla logica conclusione diquesto tipo di impostazione: il Volk è l’eterna catena disangue che unisce una generazione all’altra. L’individuoè una forma momentanea di una grande corrente ereditariache giunge dal passato e va nel futuro. Ciascuno è soloun anello nella catena della corrente del sangue deinostri avi, che giunge dall’eternità e deve andare versol’eternità. Compito di un popolo o di una razza è fare inmodo che questa corrente di sangue non si esaurisca. Per
50
Alfred Rosenberg sangue e carattere, razza e anima sonosoltanto differenti designazioni della stessa entità. Ildeterminismo del sangue non lascia spazio a conversionied assimilazioni. Esistono solo due leggi naturali:l’endogamia e la selezione. Il nazismo diventa allora unamissione cosmica, macro-storica, che ingloba l’originedelle civiltà, del pianeta. L’obiettivo è quello diritornare all’universo olistico e solipsistico dellatribù, con il suo esclusivismo e la sua morale brutale,ma questo all’interno di uno schemaapocalittico/millenaristico che coinvolge l’intero globo,l’intera specie umana. Il nazismo è stato sconfitto, manon molti anni fa il filosofo politico conservatorestatunitense Russell Kirk (1918-1994) credeva ancora inun grande ordine eterno dove il compito dell’uomo èquello di “venerare la misteriosa unione sociale deimorti, dei viventi e dei nascituri”.
L’inquisizione papale che precedette quella spagnolaaveva già disposto che gli eretici non incarcerati oeliminati indossassero delle croci gialle sui lorovestiti. Nella Spagna dell’Inquisizione fu richiesto aimedici di determinare il grado di purezza razziale diimputati sospettati di essere ebrei falsamenteconvertiti, come doveva poi avvenire nella Germanianazista, quando la figura del medico genetista (Erbarzt)fu investita del compito di stabilire la proporzione di“ebraicità” di certi cittadini tedeschi. Questaproblematica riguarda da vicino la vita e le scelte diLas Casas, che era nipote di ebrei convertiti, allostesso modo in cui un numero sproporzionato dei piùispirati paladini dei diritti dei nativi americani eradiscendente di ebrei convertiti. Tra questi, Francisco deVitoria e molti dei suoi colleghi alle università diValladolid e Salamanca. Evidentemente l’appartenenza adue mondi in conflitto influenzò drasticamente la visionedel mondo di questi umanisti.
51
La Spagna della Riconquista e dell’Inquisizione fuperciò un laboratorio sperimentale di omologazione esoggiogamento etnico alimentato dal fanatismo religioso edal realismo politico-giuridico. Come notava acutamenteCristoforo Colombo, la decisione di cacciare gli Ebreidalla Spagna fu presa lo stesso mese in cui si accolse lasua richiesta di partire alla ricerca di una rottaoccidentale per le Indie. In pratica nello stesso,fatidico anno, il 1492, si verificarono l’espulsione diEbrei e Mori, la conquista di Granada e la scopertadell’America. L’unità dei Cattolici doveva essererealizzata a qualunque costo e quindi serviva uno statoforte ed autoritario, una politica aggressiva ed unacampagna di disumanizzazione dei nemici. Successivamente,per imbrigliare quegli Ebrei che non erano fuggiti e sierano convertiti fittiziamente, furono emanati glistatuti di purezza del sangue, che impedivano agliinfedeli di intraprendere una carriera nel settorepubblico, nell’esercito e nel clero. In realtà già nel1348 le leggi “Las Siete Partidas” designavano gli Ebreiuna nazione straniera in Spagna. Furono seguite dapersecuzioni più o meno violente ed ufficiali. Nel 1449il Concilio di Toledo adottò il primo statuto, che fusubito rintuzzato da una bolla di Nicolò V che ribadivala forza redentrice del battesimo e proibiva didiscriminare i nuovi cristiani. Ciò non impedì che altristatuti fossero approvati in altre città, ma mai alivello nazionale. In Spagna i medici funsero daconsulenti per gli inquisitori impegnati ad epurare ifalsi convertiti, fornendo una legittimazione“scientifica” alle loro pratiche nella forma di treargomenti principali, che saranno poi talvoltariapplicati agli indigeni americani: (a) gli Ebrei sonointrinsecamente depravati ed inferiori; (b) la loroinferiorità e immoralità non risulta da fattori esternima dall’essere membri di una razza distinta; (c) non ci
52
può essere alcuna redenzione per loro, perché questecaratteristiche sono costituzionali ed ereditarie.
I nuovi cristiani, i marrani, i convertiti dalla fedeebraica, dovettero essere inseriti in una griglia diclassificazione del meticciato ordinata su venticategorie, mentre l’ortodossia della fede finì percoincidere con la purezza della genealogia, cioè delsangue (limpieza de sangre) (Dedieu 1992). La griglia furecuperata e re-impiegata nelle colonie americane perdistinguere le appartenenze castali in base ai gradi dimeticciamento. Questo processo di biologizzazione dellafede ebbe inizio nel quindicesimo secolo, quando ladiscriminazione sociale verso quelli che non eranooriginariamente cristiani si trasformò in discriminazionerazziale (Kamen 1997). Si sosteneva infatti che almomento del concepimento il feto avesse già acquisito itratti dei genitori e che l’odio giudeo verso i cristianiera un’infezione che sarebbe stata trasmessa di madre infiglio. A questo riguardo lo storico spagnolo Julio CaroBaroja (cf. Gracia Guillén 1984, p. 338) ha sottolineatocome la mentalità inquisitoriale era “così impregnata dibiologismo che si riteneva che il latte di una madreebrea giudaizzasse il figlio”. La valutazione dellapurezza di una persona si effettuava verificando ilproprio albero genealogico e le deposizioni sottogiuramento di parenti e testimoni. I convertiti, o nuovicristiani (“marrani” se precedentemente ebrei e“morischi” se precedentemente musulmani) non potevanoricoprire cariche pubbliche o emigrare nelle colonieamericane. Tuttavia molti aggirarono i divieti eriuscirono a rifarsi una vita nel Nuovo Mondo,costringendo l’Inquisizione ad estendere la sua longamanus anche oltreoceano, il 25 gennaio del 1569. Sebbenei nativi americani non rientrassero ufficialmente nellagiurisdizione dell’inquisizione coloniale, essi furonocomunque assimilati ai convertiti da un punto di vistagiuridico, perché anche a loro fu vietato di congiungersi
53
con gli spagnoli. Il risultato di questa patologia moralee culturale fu l’assurda proliferazione di portatori sanidi sangue impuro. Questi statuti crearono una casta diparia che infettava tutti quelli coi quali aveva degliintercorsi. Ma questa non era una casta riconoscibile dacaratteristiche esteriori e perciò nessuno potevaimmaginare che, entrando in una famiglia o accogliendoqualcuno nella sua famiglia, stava compromettendo persempre l’onorabilità del suo nome con una macchiaindelebile.
È tuttavia importante tenere a mente che il corpolegislativo nazionale spagnolo – come quello francese edegli stati italiani –, erede della giurisprudenza romanache separava rigidamente ius naturale e ius civile, rifiutòrecisamente di adottare parametri biologici per ladefinizione della persona giuridica. Gli statuti dilimpieza de sangre spagnoli furono avversati persino danumerosi inquisitori, che usavano la verifica del sanguesolo per corroborare altre prove. Di conseguenza essivennero raramente adottati, ed ancor più raramenteosservati, servendo soprattutto per risolvere le lotte dipotere tra famiglie altolocate e sopprimere ogni velleitàmeritocratica e di mobilità sociale.
Rimane il fatto che fu proprio questa fissazione peril sangue che rese accettabile la classificazione eseparazione degli esseri umani nelle colonie. Fu proprioquesto il paradigma contro cui Las Casas si battègagliardamente: l’immanentismo razzista che assegna aduna data comunità il compito di riprodurre continuamentela sua presunta essenza, perché essa è, di natura, unacomunità di essenza condivisa. Il razzismo dellaConquista fu, come tutte le sue manifestazioni, una formadi determinismo materialistico, il sintomo di un modo dipensare, piuttosto che la sua causa. Il sintomo dellavolontà di prevalere, di separare e gerarchizzare gliesseri umani dalla nascita. Come abbiamo visto il
54
nocciolo simbolico del razzismo spagnolo fu lo schemagenealogico, l’idea di filiazione che trasmette digenerazione in generazione una sostanza biologica espirituale, indice del possesso delle virtù necessarie alcomando ed alla supremazia. Le parole chiave sonol’immutabilità e l’inalterabilità. Questa ideologia eraall’origine della “banalità del male” della Conquista.Senza dubbio non tutti i coloni erano uniformementereazionari, bigotti, ignoranti, meschini, irrazionali,patologici. Nel Nuovo Mondo giunsero anche personeaperte, intelligenti e abbastanza beninformate. Ciònonostante, il linguaggio della purezza del sangue comeveicolo di fede autentica e nobili virtù dell’animo o, alcontrario, di vizi morali trasmessi di generazione ingenerazione, finì per condizionare la vita sociale dellecolonie americane iberiche fino al diciannovesimo secolo.Era un paradigma severo, categorico, anche spietato nellesue applicazioni più rigide. A livello teorico, nonavrebbe potuto ammettere gradazioni di purezza, ma giànel corso del diciassettesimo secolo ci si era resi contodel fatto incontrovertibile che gli statuti stavanomandavano in rovina l’impero, economicamente edemograficamente, e molti si opposero a questa praticadenunciando la sua inconciliabilità con il dirittocanonico e civile e con la tradizione neotestamentaria.Ma la discriminazione castale, sebbene abbandonata nellapratica, terminò ufficialmente solo nel 1773, mentrel’inquisizione sopravvisse fino all’inizio del secolosuccessivo. Nelle Americhe le cose furono più complicate,perché la realtà locale era estremamente eterogenea.Spagna e Portogallo vietarono l’immigrazione coloniale diEbrei, Mori, Gitani ed eretici, inclusi i loro figli, mala crisi demografica causata da epidemie ed oppressionecostrinse i sovrani a più miti consigli. La metafisicadel sangue fu presto estromessa dal discorso giuridico-legislativo e le unioni con gli indigeni non furonoproibite. Tuttavia, o forse proprio per questo, le
55
nozioni di razza ed etnicità continuarono a pervadere lesocietà locali. I meticci nascevano quasi sempre darelazioni extraconiugali o casuali – da cui il proverbiocolombiano “la palabra de mestizo se entiende deilegítimo” – ed erano estremamente malvisti, perché dinon facile classificazione e perché generalmente ritenutiinaffidabili, rimestatori delle gerarchie naturali. Inpratica la contrapposizione con un Altro più esoticoservì a ricompattare la società coloniale europea. Questoprocesso si intensificò con l’afflusso degli schiaviafricani, che subirono l’impatto più drammatico delmaterialismo biologico assurto a codice di organizzazionesocio-economica. Mentre dopo tre generazioni il sanguespagnolo cancellava la “macchia” del sangue indio, quellanera era indelebile. Quasi nessuno, oltre a Las Casas,obiettava all’idea della schiavitù dei neri. Diconseguenza la società spagnola, e specialmente quellaandalusa, rimase una società schiavista. Nel sedicesimosecolo, gli schiavi costituivano ben il quattordici percento degli abitanti di Granada. Siamo ben lontani dallepercentuali dell’Atene classica, ma non si può dire chel’umanesimo cristiano spagnolo abbia affrontato questoparadosso con il dovuto impegno ed una sufficientelucidità.
In America Latina la concentrazione di maschi europeiera tale che non si sarebbe potuta mantenere in vita unasocietà castale di tipo indiano, o una qualche forma diapartheid che anticipasse quello sudafricano. Adifferenza di quel che avveniva in Nord America – dove sitrasferivano intere famiglie nord-europee per sfuggirealle persecuzioni religiose –, le politiche colonialirelative alla purezza di sangue furono piuttostoelastiche, ma non lo furono le pratiche sociali, perchél’ideologia castale non tollera gradienti e sfumature trai tipi umani. I confini devono essere netti e devonocomportare significative variazioni di status. IConquistatori e le donne dell’aristocrazia indigena
56
potevano sposarsi, anzi, ciò poteva meglio garantire lastabilità del Nuovo Ordine, ma i meticci non formavanoun’unica categoria tassonomica. C’erano gli españoles, icreoli, i castizos, i mulatti, i morischi, gli albini, izambos e persino gli Inca. Oltre una dozzina dicategorie, ciascuna a sua volta suddivisa in parti, aseconda della percentuale di sangue “impuro” di unapersona. L’élite coloniale trattò diversamente i nuovimeticci rispetto ai discendenti di meticci che per alcunegenerazioni non si erano “contaminati”. Le persone la cuicondizione sociale, sangue e persino latte di balia“concordavano” potevano anche essere considerateinferiori, ma almeno erano pure. Anche i creoli, gliispanici nati nelle colonie americane e quindi per ciòstesso diversi da quelli nati e cresciuti nellamadrepatria, erano in qualche modo macchiati se eranostati allattati da balie indie o africane. Ai meticci erafatto divieto di intraprendere una carriera militare,accademica o ecclesiastica. In Perù non potevanoereditare encomiendas. Altrove il codice penale lidistingueva dai creoli, punendoli più severamente. Laloro capacità di fungere da ponte tra indigeni e colonili rendeva pericolosi per il Nuovo Ordine, potenzialmentesovversivi. Questa profezia si compì nel 1780, quando lavigorosa rivolta indigenista di Túpac Amaru II vide unmassiccio coinvolgimento di meticci ai quali non erastato permesso di integrarsi nella società coloniale. Conil passare del tempo e la complessificazione dei rapportisociali dovuta alla globalizzazione del colonialismo edei commerci internazionali, le genealogie di stampofeudale vennero abbandonate ed il colore della pelle e lafisionomia del volto (tratti somatici) divennero i nuoviparametri di classificazione. Non bastava dimostrare diessere “Spagnolo”, si doveva essere “bianco” (blanco) o“biondo” (rubio).
Possiamo dire che una delle grandi intuizioni di LasCasas fu quella di capire che per avere un impatto
57
prolungato, un’ideologia deve rispecchiare certi valori esimboli che esercitano una decisiva influenza in unasocietà. Dunque per abbattere il razzismo si dovevanocreare le premesse per una proficua convivenza tra igruppi etnici, ossia un’interdipendenza in grado diannullare la percezione di un divario radicale tra esseriumani. Las Casas comprese che il feticcio del sanguepoteva essere sconfitto solo con il meticciato ed ilfeticcio della civiltà superiore solo con la BuonaNovella di Gesù il Cristo. Già nel suo Memorial de losRimedios dell’aprile del 1516 aveva proposto che Spagnolied Indiani “si sarebbero dovuti mescolare dando in sposii figli degli uni alle figlie degli altri”. Servivaun’encomienda indivisa, un gemellaggio permanente, unagrande famiglia: “Gli uni sposeranno gli altri, e da lorosi formerà una sola repubblica, una delle migliori emagari persino la più cristiana e pacifica del mondo”.Sarebbe stato sufficiente per estirpare la logicacircolare di chi affermava che certi modi di fare econsiderare una cosa erano giusti perché naturali e seerano naturali allora dovevano essere veri e validi, cheè poi la tendenza a conficcare gli esseri umani incaselle, condannandoli a ripetere deterministicamente glistessi pensieri, gli stessi comportamenti, le stesseemozioni, in un eterno ritorno dell’identico a se stessoche congela ogni possibilità di mobilità sociale.
Il Requerimiento
La Corona spagnola cercò sempre un compromesso tra leesigenze di un umanitarismo compassionevole e quelle delrealismo più becero e letale, con risultati contradditorise non addirittura incomprensibili. Ad esempio nel 1512furono promulgate le Leggi di Burgos (Leyes de Burgos),concepite per regolamentare i rapporti tra conquistatorie conquistati e per definire lo status degli Indigeni.Essi erano considerati uomini liberi e tuttaviasottoposti alla sovranità spagnola, che aveva il compito
58
di evangelizzarli e consentiva il loro sfruttamento apatto che non fosse immoderato – uno spagnolo non potevadetenere più di 150 schiavi. Tra le varie disposizioni viera anche quella, molto lungimirante ed avvertita,secondo cui “nessuno poteva picchiare o frustare ochiamare cane un indio, o usare qualunque altro nome chenon fosse il suo”. È tuttavia facile notare che questeordinanze, nella loro applicazione, preservavanosostanzialmente lo status quo, perché erano soggette adintepretazioni del tutto soggettive. Per di più questeincludevano anche il ricorso alla forza in caso diresistenza all’evangelizzazione, che quindi comportavauna guerra giusta. Era una beffa per tutti queipredicatori e laici che avevano protestato pubblicamentecontro la tirannide che si stava instaurando nel NuovoMondo a pochi anni dalla sua “scoperta”. L’aspettotristemente ironico della faccenda era che si stabilivache una popolazione stava resistendo all’evangelizzazionein base alla sua reazione al cosiddetto Requerimiento,un’ingiunzione indirizzata agli indiani che era stataredatta nel 1514 da uno dei migliori giuristi spagnolidel tempo, Palacios Rubios, per venire incontroall’esigenza di regolare una conquista piuttosto caotica.Veniva letta agli indigeni in castigliano, il cheevidentemente ne impediva la comprensione. La sua utilitàera dunque quella di placare le poche coscienze noninvase dal cinismo e dalla cupidigia. Doveva essere lettoagli indigeni ma serviva in realtà a convincere gliEuropei che la Conquista era legittima. Las Casas sisarebbe poi scagliato contro quest’ingiunzione, spiegandoche affermazioni come: “Dio ha scelto San Pietro comeguida dell’umanità…affinché stabilisca la sua sede intutte le parti del mondo e governi su tutti i popoli,siano essi cristiani, mori, ebrei gentili o qualunquealtra setta” erano solo esempi di un’indecente egrossolana ipocrisia. Il Requerimiento non faceva altro checonfermare che le comunità native potevano autogovernarsi
59
ma che la loro autorità doveva comunque piegarsi alleesigenze dell’evangelizzazione e dello Stato. Mi siconsenta di citare ampi stralci di questo documento,perché questo stesso tipo di retorica fintamente benevolaè moneta di facile reperimento nella politicainternazionale di oggigiorno, sotto mentite spogliepseudo-umanitarie. “Da parte del re Don Ferdinando, e diDonna Giovanna, sua figlia, regina di Castiglia e Léon,di Aragona, delle Due Sicilie [...] dominatori dellenazioni barbare, noi loro servitori Vi notifichiamo erendiamo noto al meglio delle nostre possibilità, che…[…]…riconosciate la Chiesa come Governante e Superiore delmondo intero, e il sommo sacerdote chiamato Papa, e insuo nome il Re e la Regina Donna Giovanna nostri signori,in sua vece, come superiori e signori di queste isole edi questa Terra Ferma in virtù della detta donazione, eche consentiate e diate luogo che questi padri religiosidebbano dichiarare e predicare alla vostra volta lasopradetta parola. Se farete in questo modo, farete benee ciò che voi siete obbligati a fare nei confronto delleloro Altezze, e noi in loro nome vi riceveremo con tuttol’amore e la carità e vi lasceremo, con le vostri mogli efigli e terre, liberi, senza servitù, sì che voi possiatedisporre di essi e di voi stessi liberamente e nel modoche vi piaccia e riteniate meglio, ed essi non vicostringeranno a farvi Cristiani, a meno che voi stessi,una volta informati della verità, non vogliateconvertirvi alla nostra Santa Fede Cattolica, come quasitutti gli abitanti delle restanti isole hanno fatto. E,oltre a questo, le loro Altezze vi accordano moltiprivilegi ed esenzioni e vi conferiranno molti benefici.Ma, se voi non fate questo e con malizia frapponeteritardi, io vi dichiaro che, con l’aiuto di Dio, noifaremo ingresso con la forza nel vostro paese e vi faremoguerra in tutti i modi e maniere che potremo e viassoggetteremo al giogo e all’obbedienza della Chiesa edelle loro Altezze; vi prenderemo le vostre mogli e figli
60
e ne faremo degli schiavi e come tali li venderemo e nedisporremo come vogliano ordinare le loro Altezze, e viprenderemo i vostri beni e vi faremo tutto il male e idanni che possiamo, come a vassalli che non obbediscono erifiutano di riconoscere il loro Signore, e gli resistanoe lo contraddicano; e dichiariamo che le morti e leperdite che da questo deriveranno sono vostra colpa e nondelle loro Altezze o nostre, né dei cavalieri che vengonocon noi”. La premessa era che Gesù Cristo, signore dellignaggio umano e sovrano supremo con giurisdizionesull’intero universo, aveva trasmesso il suo potere aPietro e da questo esso era stato trasferito ai papi edai sovrani di Spagna e Portogallo. In questo modo sipotevano schiavizzare altri esseri umani nel nome di unareligione universalista ed egualitaria. La “scelta” degliautoctoni era quella tra diventare volontariamenteschiavi convertendosi, oppure diventarlo da superstiti.Com’è noto, il commento di Las Casas fu che “[non sapeva]se ridere o piangere dinanzi all’assurdità [di taleingiunzione]” e non poté fare a meno di domandarsi senella prospettiva indigena “tutto questo non dovevasembrare delirio o cose fuori di ragione e fuori strada,tutti vaneggiamenti e spropositi, soprattutto quandoveniva loro detto che erano obbligati ad assoggettarsialla Chiesa”.
Gustavo Gutiérrez ha opportunamente segnalato che“Cristo e la libertà umana sono i due grandi assentidalla teologia del Requerimiento: il primo non vienemenzionato e la seconda non è riconosciuta veramente agliindios. Si tratta di cattiva teologia, almeno quanto allaformulazione teorica, perché sul piano delle inevitabiliconseguenze pratiche è necessario piuttosto dire che vi èuna totale assenza di teologia, vale a dire diriflessione sulla fede in un Dio d’amore che sfocinell’amore per il prossimo” (Gutiérrez, 1995, p. 159).
61
TUTTO CIÒ CHE ASCENDE, CONVERGE
Uccidere un uomo non è difendere un’idea, è uccidere un uomoSébastien Castellion (1515-1563)
I Conquistadores non furono secondi a nessuno inquanto a doppiezza: con una mano propagavano i principidella loro santa fede, che invitava alla sobrietà, allamoderazione ed alla semplicità, mentre con l’altradepredavano i nuovi credenti coatti. La loro bramosia diricchezza si mascherava da pietà, la loro fanaticaambizione da devozione patriottica, la crudeltà adottatacome strumento di conversione e civilizzazione deipagani, l’asservimento come unica speranza di salvezza.“La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza èforza”, orwellianamente. Il totalitarismo azteco trovò lasua degna prosecuzione in quello spagnolo. “Guardatevidai falsi profeti i quali vengono verso di voi in vestida pecore, ma dentro son lupi rapaci. Li riconosceretedai loro frutti” (Matteo 7:15-16).
Las Casas era diverso perché non pensava che lapolitica e la predicazione avrebbero potuto trasformarela natura umana degli indigeni – non ce n’era bisogno –,ma piuttosto che sarebbero dovute servire a riscattarlidalla tirannide e dall’ignoranza. La sua intenzione eraquella di aiutare chi non era nella posizione di aiutarese stesso, di proteggere chi non aveva i mezzi per farlo,opponendosi alla religione della potenza ed alla teologiadel potere messe in campo dagli Spagnoli; promuovendocontemporaneamente l’esercizio della libertà consapevolee la presa di coscienza indigena della propria dignità,del proprio essere stati creati spiritualmente adimmagine e somiglianza di Dio, della verità che tutti gliesseri umani sono amati dal Creatore allo stesso modo enella stessa misura, anche quando sbagliano, ed infineliberandoli dell’errore di credere che il fine
62
dell’esistenza umana è l’obbedienza fine a se stessa o ilrisarcimento di un debito pregresso contratto con Dio.Las Casas era sicuro che l’umanità stesse ascendendo,stesse percorrendo un tragitto di perfezionamentospirituale e morale, stesse convergendo verso Dio,sebbene lungo strade diverse. L’importante era conoscerela parola del Cristo, che reindirizza gli sforzi dimiglioramento di ciascun individuo e popolo, senzainterferire con la loro volontà. La sua nemesi, JuanGinés de Sepúlveda, era più incline a credere chel’universo e la vita fossero brutali, spietati eviolenti, che la natura umana fose spregevole e corrotta(tranne quella dei “migliori”) e che non v’era rimedio,eccezion fatta per l’imposizione della volontàpacificatrice del più forte e illuminato dalla fede.Nella sua prospettiva la massa degli umani era priva divera grandezza, non era destinata alla gloria ma allasopravvivenza meccanica, seguita da un’anonimaestinzione. Era dunque nell’ordine delle cose considerarequasi tutte le persone come ingranaggi di un meccanismo –l’Impero Spagnolo – perfettamente oliato dalla teologiacristiana, come anelli di un’indistruttibile catena dellanecessità. Sepúlveda non si faceva scrupolo di appoggiarecon la sua eloquenza e la sua erudizione i progetti dichi utilizzava le cose dello spirito per fini egoistici ematerialistici, di chi si poneva al posto di Dio,giudicando sommersi e salvati.
Las Casas sapeva, per esperienza di vita, avendoavuto modo di incontrare un numero enorme di popoli epersone, dalle Fiandre fino al Perù e da Roma al Messicocentrale, che nessuno può prevedere con certezza che cosaè e che cosa è destinato a diventare qualcuno, nel bene enel male. Nessuno può realmente capire cosa passi per latesta di ciascun altro, come questi percepisca edinterpreti il mondo. A differenza di Sepúlveda, Las Casasera capace di e disponibile a fare ammenda, ammetteva diaver commesso errori e non cercava alibi. Il suo pregio
63
era quello di aver riconosciuto l’esistenza di un oceanointeriore di spiritualità e fede che si espandeva e sicontraeva a seconda della sollecitudine che riceveva.Cura che comportava il sottoporsi ad un costante esame dicoscienza, all’introspezione, all’esplorazione di séstessi e del mondo, per estendere i confini del propriosapere e quindi dell’autocoscienza, diventando sempre piùconsapevoli della vastità di quest’oceano e dell’amore diDio. Credo che da ciò dipendesse un suo atteggiamento chemolti critici hanno imputato ad arroganza e superbia.Nessuno di noi era presente e può parlare a ragion vedutama, a me pare che, tranne qualche rara eccezione, neisuoi scritti Las Casas non dia l’idea di essere borioso enon mostri di essere minimamente interessato alla fama,alla gloria, ai beni materiali. Quanto alle sue azioni,avendo la possibilità di diventare vescovo dellaprestigiosa e ricchissima diocesi di Cuzco, preferìquella semisconosciuta e problematica del Chiapas. Dopoil disastro del suo primo esperimento di convivenza traindigeni e spagnoli, non insistette e dedicò lunghi annialla ricerca delle cause del suo fallimento, che eracostato la vita a decine di nativi e ad alcuniconfratelli. Cercò di capire dove aveva sbagliatoleggendo i resoconti dei cronisti, scambiando opinionicon altri missionari, interrogando la sua coscienza insolitudine. La visione del mondo e la personalità diSepúlveda erano drammaticamente diverse. Le sueosservazioni denotavano una personalità egotista,un’irragionevole e smisurata attenzione verso se stessiche non era guidata e sostenuta dall’introspezioneautocritica e dall’empatia e quindi non poteva arrivare acomprendere che la logica che governa il creato e ciascunindividuo è la medesima, secondo la volontà di Dio. Nonera interessato a scoprire gli universi altrui, accecatocom’era dall’orgoglio, dalla vanità e dalla bramosia. Ilsuo era un atteggiamento aggressivo e predatorio neiconfronti del prossimo e del Nuovo Mondo.
64
Riconoscibilissimi, come vedremo in seguito, sono il suonarcisismo, il pessimismo antropologico, la megalomaniaed un’inestirpabile insoddisfazione di fondo, unitaall’invidia nei confronti dei successi altrui.Considerava l’ordine sociale esistente come uno specchiodei talenti innati dei singoli; di conseguenza gliinteressi ed i sentimenti altrui avevano meno valore deisuoi, emanazioni di un intelletto e di una personalitàsuperiori. Naturalmente questo è ciò che s’imponeva dicredere, con uno zelo pari solo alla ferocia con la qualelo tormentavano l’insicurezza ed il sospetto di nonessere speciale, sentimenti che lo spinsero a scrivere unpamphlet intitolato Propossiçiones Temerarias, Escandalosas yheréticas in cui accusava Las Casas di essere uno sfacciatomentitore ed un eretico per aver smascherato la suaipocrisia e per aver essenzialmente preannunciato leintuizioni fondamentali che stanno alla base dellaDichiarazione Universale dei Diritti Umani, la qualestabilisce che “tutti gli esseri umani nascono liberi edeguali in dignità e diritti” (art. 1), “senza distinzionealcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, dilingua, di religione, di opinione politica o di altrogenere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, dinascita o di altra condizione” (art. 2). Las Casas sisarebbe trovato in pieno accordo con questoriconoscimento della comune appartenenza alla specieumana, del valore e della dignità del singolo individuoin quanto tale e del diritto di ciascuno di essere messonelle condizioni di potersi sentire ed essere libero,materialmente, psicologicamente e spiritualmente.Enunciati irricevibili per Sepúlveda che rimaneva invecelegato alle tesi agostiniane e tommasiane dell’organicitàdel rapporto individuo-comunità, fondato sul presuppostodell’imperfezione della persona e perfezione dellacomunità, sulla dialettica dell’ordinare ed essereordinato e sul sacro dovere dell’obbedienza ad un ordinepiramidale e paternalista.
65
Come si diventa Las Casas?
Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera.Giovanni 15, 13
Bartolomé de Las Casas fu senza dubbio la figuracentrale di quel movimento che si attivò per tutelare inativi americani Indiani nel corso del sedicesimo secolo.A dire il vero, non è azzardato definirlo una delle piùstraordinarie figure della storia. Se gli eroi sono tuttequelle persone che, di fronte all’oppressione edall’ingiustizia si spendono personalmente, mettendo arepentaglio la propria incolumità, per porvi rimedio,fronteggiando forze soverchianti, allora Las Casas fu uneroe. Las Casas si trovò nel posto giusto al momentogiusto e seppe fare la scelta giusta, quella della veritàin luogo della menzogna, della giustizia in luogo delsopruso, del coraggio in luogo della pusillanimità, dellalibertà in luogo della tirannia.
Ebbe la fortuna di nascere in un periodo ed incircostanze tali che gli permisero di frequentare alcunetra le menti più rimarchevoli del suo tempo proprioquando un nuovo mondo e nuove civiltà furono scopertedagli Europei. Eloquente, devoto, caritatevole, tenace,vigoroso, inflessibile, fervente, a volte fin troppofervente, molto attento ai rapporti umani. Pio e saggio,disposto al sacrificio, ma anche impregnato di unafuriosa indignazione che non gli dava pace. Forse nonpotè mai essere diverso da quel che sentiva di doveressere. La sua non fu una vera scelta. Furono la suacoscienza e la sua indole a scegliere al posto suo.Disinteressato ai beni materiali ed al prestigio, rifiutòsempre donazioni personali e avanzamenti nella gerarchiadella Chiesa. Conobbe Ferdinando, Filippo il Bello, CarloV e Filippo II ed ogni volta, dopo aver assistitoall’ascesa e declino di notabili e signori, si trovò
66
costretto ad intraprendere nuovamente la stessa battagliaper convincere la nuova generazione di dirigenti edamministratori della giustezza della sua causa. A 82anni, poco prima di morire, ancora nel pieno possessodelle sue facoltà, si trovava al cospetto dei ministri diFilippo II per invocare la concessione ai Guatemaltechidi una corte di giustizia autonoma, come da promessa.
Per tutta la vita lottò per un unico obiettivo,quello del riconoscimento della dignità e del rispettodell’umanità e la difesa di popoli massacrati edumiliati, contro i capricci e le pretese di re, principi,schiavisti, coloni, generali, alti prelati, ed ingenerale contro una civiltà che si presumeva superiorementre spianava come uno schiacciasassi tutto ciò che lesi opponeva. Fu in grado di vedere le cose diversamentedalla norma contingente perché viveva diversamente.Risiedeva nel mondo in maniera attenta e consapevole e,così facendo, seppe superare le restrizioniepistemologiche che impediscono a chi fa parte di unacerta classe, gruppo o comunità umana di immedesimarsi inchi non ne fa parte.
Alcuni secoli più tardi, Dietrich Bonhoeffer avrebbeesortato le persone a contemplare i grandi eventi dellastoria dal basso, adottando la prospettiva di chi èmaltrattato, marginalizzato, svilito, sofferente. Ful’ottica di Las Casas, che comprese rapidamente che erail profitto ad aguzzare l’ingegno ed anestetizzare lacoscienza degli Spagnoli, non l’ignoranza.Indipendentemente da qualunque sforzo disensibilizzazione, gli encomenderos non erano disposti acambiare stile di vita e visione del mondo, convinti chein fondo la situazione avrebbe beneficiato gli uni e glialtri, nel lungo termine. Fu questa sua ottica piùorganica, più obiettiva che lo differenziò da chi sioccupò solo di rimediare alle sofferenze degli indigenisenza sviluppare una proposta di riforma che inibisse gliabusi, o da chi, oltreoceano, edificava meravigliose
67
strutture giuridiche e filosofiche in difesadell’umanità, senza preoccuparsi di renderle applicabilialle realtà specifiche. Las Casas non si fissò mai su unaparticolare teoria o pratica: si servì volentieri ditutto quel che poteva tornare utile agli indios (Ruston,2004).
Le sue denunce furono ammirate da chi guardava concompassione alla sorte degli indigeni, detestate daiConquistadores e dai nazionalisti spagnoli – specialmenteai tempi della dittatura franchista, ma ancora fino ainostri giorni – e manipolate dalle altre potenzecoloniali che le trasformarono nella “Leggenda Nera”anti-spagnola. Ad esempio, il futuro liberatoredell’Olanda dal giogo spagnolo, Guglielmo d’Orange,citava Las Casas per dimostrare la “naturalepredisposizione” degli Spagnoli alle crudeltà. Per laprima volta un impero doveva badare a come le iniziativedei propri coloniali si riflettevano sulla propriaimmagine internazionale. I fautori dei diritti umani loconsiderano generalmente un loro antesignano, altripongono in risalto le numerose contraddizioni del suopensiero e gli aspetti più oscuri della sua inizialevisione utopico-teocratica. Resta il fatto che, dal puntodi vista di popolazioni ormai sottomesse e martoriate, fuun dono del cielo.
Indubbiamente non fu l’unico a denunciare le atrocitàspagnole. L’esploratore e scrittore italiano GirolamoBenzoni descriveva analoghe vicende nella sua Storia delNuovo Mondo (1565) e in quegli stessi anni circolavanoaltre descrizioni dei massacri perpetrati dagli Spagnoliai danni dei calvinisti francesi in Florida, checorroboravano l’impressione che questi fossero i verinuovi barbari. Las Casas però non si limitò a denunciare,fece tutto quel che era umanamente possibile fare persistemare le cose e per prevenire future prevaricazioni.Per la prima volta, cercò di collocare al centro deldibattito politico-giuridico la nozione basilare di
68
dignità intesa come diritto di non essere umiliato, esolo in quanto tale fondamento di ogni altro dirittoinalienabile, non conferito da un sovrano ma patrimonionaturale dell’intera specie umana, indipendentementedall’aspetto, dalla cultura, dalle credenze e dallepratiche sociali. Il suo fallimento non è ragionesufficiente per continuare ad escluderlo dal pantheon delpensiero politico e giuridico mondiale.
Bartolomé nacque nel 1484 a Siviglia, una città strappataai Mori nel 1248, che svolse un ruolo fondamentale cometrait d’union tra le colonie americane ed i territorieuropei dell’impero spagnolo. Era figlio di conversos,ossia di Ebrei che avevano rinunziato alla propria fedepur di non essere costretti all’esilio, e questo quasicertamente influenzò il suo modo di porsi nei confrontidei popoli oppressi. Ancora ragazzino, era presente almomento del ritorno trionfale di Colombo dal Nuovo Mondoe rimase colpito dai sette Tainos che l’Ammiraglio delleIndie portava con sé. Nel 1493, suo padre, Pedro, assiemead alcuni dei suoi zii, s’imbarcò per il Nuovo Mondo conla seconda spedizione di Colombo. Pedro rientrò in patriasolo nel 1498 recando un regalo per suo figlio, ungiovane servo taino, di nome Juanico. Aveva fatto fortunae poté garantire al figlio un minimo di istruzione. Nel1498 accompagnò suo padre nel Nuovo Mondo assieme aColombo, ritornando a Cadice nel 1500. Nel 1502 viritornò per restarci, al seguito della spedizione diNicolás de Ovando, che doveva assumere il titolo digovernatore di Hispaniola. La sua partecipazione glivalse il conferimento del diritto di sfruttare un lottodi indigeni nella forma dell’encomienda. Nel 1507 fuordinato sacerdote a Roma. Una volta tornato nelleAmeriche, pur vestendo l’abito talare, acquistò terreni eschiavi e condusse una vita prospera ed apparentementeserena, senza nutrire particolari remore per il fatto cheil suo benessere derivava dallo sfruttamento di altri
69
esseri umani. Nella sua autobiografia ricordava quelgiorno ad Hispaniola (le odierne Haiti e Santo Domingo),quando un frate domenicano si rifiutò di confessarlo. Glichiese ragione del rifiuto e procedette poi a confutaregli argomenti del frate, fornendo contro-prove frivole econtenenti, a suo dire, solo una parvenza diragionevolezza e verità. Ad un certo punto il frate lointerruppe dicendo: “sono arrivato alla conclusione,padre, che la verità ebbe sempre molti nemici e lamenzogna molti aiuti”. Las Casas ricorda che “il chierico[Bartolomé] subito gli diede ragione, per la riverenza eossequio che gli si doveva, perché il religioso era unaveneranda persona e uomo molto dotto, più del prete; maper quanto riguarda liberare gli indios non si curò dellasua opinione” (Historia). Eppure, con il passare del tempola sua prospettiva comincò a cambiare, per viadell’accumularsi di esperienze che segnaronoprofondamente la sua coscienza, non ultima lapartecipazione come cappellano militare alla conquista diCuba, che si risolse in un bagno di sangue del tuttogratuito, visto che la maggior parte degli indigeni nonera intenzionata a ricorrere alla resistenza armata. LasCasas riferì poi di aver visto “crudeltà su una scala chenessun essere vivente aveva mai visto o si aspettava didover vedere”. Dopo aver assistito a questi insensatimassacri, si risvegliò in lui una sensibilità sopita. Fuun kairos, un intervallo di crisi e presa di coscienza,che l’avrebbe condotto ad una tappa radicalmente nuovadella sua esistenza. Ne nacque un sentimento di rigettonei confronti del sistema e di ciò che comportaval’accettarlo così com’era, passivamente. Si rese quindiconto che l’unica scelta moralmente decente era quelladella difesa degli indigeni contro i suoi compatrioti ecorreligionari. Così l’encomendero Las Casas si convertìnella nemesi degli encomenderos e la storia della suavita si confuse con quella della lotta perl’emancipazione degli indiani. In questo fu assistito dal
70
buon Pedro de la Renteria, un laico con l’animo di unmonaco: solitario, generoso e benevolo, contemplativo alpunto da essere quasi completamente indifferente allebrame del materialismo.
La svolta decisiva – non la conversione di unpeccatore, ma la rivelazione della sua vocazione diprofeta – giunse con la lettura di un passo del Libro delSiracide (34, 18-22) in preparazione del sermonepentecostale: “Sacrificare il frutto dell'ingiustizia èun’offerta da burla, i doni dei malvagi non sono graditia Dio. L’Altissimo non gradisce le offerte degli empi eper la moltitudine delle vittime non perdona i peccati.Sacrifica un figlio davanti al proprio padre chi offre unsacrificio con i beni dei poveri. Il pane dei bisognosi èla vita dei poveri, toglierlo a loro è commettere unassassinio. Uccide il prossimo chi gli toglie ilnutrimento. Versa sangue chi rifiuta il salarioall’operaio”. La crisi di coscienza che lo attanagliòtrovò poco dopo uno sbocco costruttivo grazie ad unpotente, vibrante ed indignato sermone di padre Antoniode Montesinos, che Las Casas ebbe l’opportunità diascoltare ad Hispaniola il 4 dicembre del 1511 e cheriporta nei suoi scritti. Montesinos esortava ariconoscere l’umanità dei nativi con queste parole:“Vivete nel peccato mortale per le atrocità che aveteimposto tirannicamente a questa gente innocente. Ditemi,che diritto avete di schiavizzarli? In base a cheautorità avete fatto loro la guerra quando vivevano inpace nei loro territori e li avete uccisi in modo che nonsi erano mai sentiti prima? Come potete opprimerli e noncurarvi di curarli e nutrirli, e farli lavorare fino allamorte per soddisfare la vostra avidità? E perché non vicurate della loro salute spirituale, affinché possonoarrivare a conoscere Dio, che siano battezzati e chepossano ascoltare la messa e santificare i giorni difesta? Non sono forse degli esseri umani? Non hanno forseun’anima razionale? Non siete forse obbligati ad amarli
71
come amate voi stessi? …Potete star sicuri che, in quantoa Salvezza, la vostra condizione non è migliore di quelladei Mori o dei Turchi che rifiutano la fede cristiana”(Iannarone, 1992, pp. 99-100). Prevedibilmente, queste parole, ed i sermoni successivi,che pure contribuirono alla promulgazione delle Leyes deBurgos a tutela degli indigeni, produssero non pocosconcerto ed irritazione alla corte di re Ferdinando, cheera di tutt’altra pasta rispetto alla moglie Isabella. Laregina, finché rimase in vita, insistette che gliindigeni fossero considerati e trattati come uominiliberi. Lui era un cinico realista, più interessatoall’oro che all’evangelizzazione, ed autorizzò ladeportazione di intere popolazioni per rinsanguare leregioni disabitate in seguito alle epidemie. Il sovranoconvocò Montesinos in Spagna per chiedere ragione dellasua condotta. Nel 1514 Las Casas aveva già deciso chetutto ciò che era stato commesso ai danni degli Indianiera “ingiusto e tirannico” e che la cosa migliore da faresarebbe stata muoversi come un pendolare tra Vecchio eNuovo Mondo prestando il proprio servizio come unavvocato dei diseredati. Così, nel 1515, Las Casas colsel’occasione e ripartì per la Spagna assieme a Montesinos,per parlare col re ed ottenere finanziamenti per ultimarela costruzione di un monastero domenicano. Ebbe così mododi prendere contatto per la prima volta con gli ambientidi corte che avrebbe frequentato assiduamente negli annia venire per perorare la causa dei nativi americani. Nelcorso di questo viaggio presentò il suo Memorial deremedios, in cui elencava venti ragioni per cui gliindiani non dovevano essere consegnati agli Spagnoli inencomienda, vassallaggio o risarcimento e poté incontrareil cardinale Francisco de Ximenes e Adriano di Utrecht,futuro papa Adriano VI e precettore di Carlo I (che saràintronato con il nome di Carlo V), il quale viveva ancoranelle Fiandre. Questi simpatizzavano per la sua causa efecero in modo che, nel 1516, ricevesse il titolo di
72
“Procurador o protector universal de todos los indios delas Indias”, conferitogli dal cardinal Cisneros assiemeal compito di tenere informata la corona riguardoall’implementazione delle disposizioni previste dalleleggi a tutela degli indios. Fu autorizzato a portare consé quegli uomini di chiesa che giudicava più idonei. Gli insegnamenti morali del Siracide e il sermone diMontesinos convinsero dunque Las Casas che bisognavapassare all’azione, affrancando i propri schiavi epredicando affinché gli altri coloni facessero lo stessoe rinunciassero all’encomienda. Ma questo non gli potevabastare. Aveva in mente qualcosa di molto piùrivoluzionario, la concretizzazione del sogno utopico diuna società ideale in cui la dignità umana fossesalvaguardata ed il messaggio di Cristo potesse essereinsegnato senza l’impiego di metodi di coercizione.Trascorse gli anni tra il 1516 ed il 1522 tentando intutti i modi di istituire una comunità cristianasperimentale a Cumanà, nel nord del Venezuela, dovecoloni spagnoli e indigeni avrebbero convissuto in pace econcordia, come fratelli spirituali di pari dignità.L’imperatore lo autorizzò a portare con sé dei colonispagnoli, che ribattezzò “I cavalieri dello speroned’oro”, per infondere un senso di romantico eroismo. LasCasas aveva persino disegnato un’uniforme per loro – unaveste bianca con una croce rossa sul petto – ma fu cosìonesto da ammettere in seguito che fu l’unico adindossarla. L’idea era quella di far vivere assiemeindigeni e spagnoli affinché i primi apprendessero laparola di Dio e le tecniche agricole per emulazione. Ilavoratori indigeni sarebbero stati salariati, avrebberoappreso nuove tecniche di coltivazione dai contadinispagnoli e avrebbero avuto accesso agli ospedali. Entroun anno, nel 1521, i nativi si erano già ribellati pervia delle scorrerie degli schiavisti che avevano rapito35 indiani dopo essere passati per la missione(rendendola complice agli occhi degli indigeni). Le
73
continue frizioni tra coloni in cerca di guadagni facilied indigeni tutt’altro che pacifici causarono l’uccisionedi due frati. La rappresaglia spagnola non si feceattendere: furono tutti schiavizzati. L’intera impresafallì miseramente, perché tra i desideri degli idealistie la realtà quotidiana si frappongono i vizi della naturaumana, che è come è e non come i riformatori vorrebberoche fosse nei loro progetti più radicali. I detrattori diLas Casas usarono subito questo fiasco per dimostrare chela conversione e pacificazione degli Indiani potevaessere ottenuta solo con la forza e la violenza.Tuttavia, come spesso avviene, non tutto il male vien pernuocere. Lo scacco costrinse il frate ad un profondoesame di coscienza e ad un attento riesame delle suestrategie. L’esperienza fu una salutare lezione di umiltàe concretezza che lo avviò su un percorso più produttivo,quello dell’accettazione dei difetti umani e del rifiutodell’hybris artificialistica, cioè a dire dell’idea chesia non solo possibile ma necessario fare tabula rasadell’esistente per ricrearlo minuziosamente dalle suefondamenta, facendo in modo che la variabile umana noninterferisca con i piani dell’utopista. Da quel momentoin poi Las Casas insisterà su motivi come l’adesionenaturale, lo slancio spontaneo e la libertà responsabiledi una scelta informata che erano agli antipodi rispettoai progetti di ingegneria sociale dei suoi avversari,intenti a costruire una società dominata dalla volontà erapacità del più forte in una cornice di astrazionidiscriminanti, rigide asimmetrie castali, uniformitàdispotiche, programmazioni mirate alla meccanizzazionedell’umanità indigena, in un’ipertrofia di ingordigia erazionalità inesorabile ed indifferente.
Las Casas reagì scomparendo dalla scena pubblica, inun monastero domenicano a Santo Domingo, nel 1523, nonprima però di aver affrontato dialetticamente, nel 1519,l’aristotelico Juan Quevedo, vescovo del Darien. ABarcellona, davanti al giovane imperatore Carlo V, Las
74
Casas liquidò Aristotele come “un gentile che bruciaall’inferno, la cui dottrina non va necessariamenteseguita a meno che non sia conforme alla veritàcristiana”. A Quevedo riservò un trattamento nondissimile: “E voi Signore, avete peccato mille e piùvolte perché non avete rischiato la vostra vita per levostre pecore, per sottrarle alle mani dei tiranni che lesterminano”. Quanto agli Indios, il domenicano dovetteammettere che il re aveva accettato, perchémalconsigliato, che esseri umani razionali fosserotrattati alla stregua di pezzi di legno da costruzione ocome greggi di pecore o come qualunque altro animale chepossa essere spostato indiscriminatamente, “e che seanche morissero per strada non sarebbe una gran perdita”.A Santo Domingo Las Casas potè continuare i suoi studiteologici, meditare sul da farsi e lavorare alla stesuradella Historia de las Indias, pubblicata nel 1561, e del primotrattato di missiologia della storia, il De unico vocationismodo omnium infidelium ad veram religionem (“Dell’unico modo diattrarre tutti i popoli alla vera Religione”), che videla luce tra il 1527 ed il 1530 (ma fu pubblicata inspagnolo solo nel 1942) e fu messo alla prova alcuni annipiù tardi a Tuzultlán, nel Guatemala. Tra il 1536 ed il1538 la sua opera di evangelizzazione pacifica nonrispose pienamente alle sue attese né in Nicaragua né inGuatemala ma, a parziale consolazione, il risultato nonfu neppure catastrofico come in Venezuela; tant’è che fupossibile ribattezzare “Verapaz” (Vera Pace) la regioneguatemalteca che inizialmente era stata chiamata “Tierrade Guerra” (Tuzultlán), per il carattere spartano dellasocietà indigena.
In seguito visitò il Perù e tornò in Europa, nel1539, per reclutare nuovi missionari ed incontrare ilsovrano. Durante la sua permanenza scrisse la celebreBrevísima Relación de la Destrucción de las Indias, che completò nel1552, ma che fu distribuita solo nel 1566, dopo la suamorte e tradotta in olandese nel 1578, in francese nel
75
1579, in inglese l’anno seguente, in latino nel 1598 edinfine in tedesco entro la fine del secolo. Presentòquest’opera, ancora abbozzata, al Concilio delle Indienel 1541, in vista della riforma legislativa del 1542.Era un trattato che intendeva fornire prove testimoniariee scioccanti di ciò che stava avvenendo nelle coloniespagnole americane. In questa relazione Las Casasaccusava i coloni spagnoli di sterminio sistematico estabiliva una peraltro forzata dicotomia tra cattivispagnoli ed indiani buoni, “pazienti, umili, pacifici”.Ne aveva comunque ben donde. Mentre nelle alte sfere sidiscettava di quieta diplomazia, gli Indios si stavanoestinguendo ed i Conquistadores badavano solo adaccumulare ricchezze. Nelle encomiendas i mariti eranoseparati dalle mogli e i genitori dai figli e mandati alavorare lontano dalle loro comunità. I coloni sicomportavano da nemici, non da insegnanti, e d’altraparte gli indiani non avevano bisogno di tutela, sapendogià cavarsela bene da soli nelle interazioni sociali.C’era solo bisogno di qualcuno che insegnasse loro ladottrina cristiana, nulla più di questo. Ed in pienalibertà, perché “la libertà è il più prezioso e piùelevato di tutti i beni di questo mondo”, andavaripetendo Las Casas, mentre nell’encomienda la condizionedegli indigeni era quella degli schiavi. I nativi eranoridotti a “pure bestie”, distrutti come “sale nell’acqua”in un mondo in cui il loro consenso e libero arbitrio noncontavano nulla. L’encomienda, continuava Las Casas, eraassolutamente illegale, perché non aveva ricevuto “ilconsenso di tutti quei popoli che non erano statichiamati, sentiti o difesi…come richiesto dalla leggenaturale, divina, canonica e imperiale”. Tra leaffermazioni che generarono più controversia ci fu quellasecondo cui “fin dall’inizio gli Spagnoli non si sonopresi la briga di predicare la fede cristiana a questegenti più che se si fosse trattato di cani ed altrianimali” e l’accusa che l’opera dei frati era ostruita
76
“perché si temeva che la diffusione del Vangelo sisarebbe interposta tra loro e l’oro e le ricchezze chebramavano”. Ammoniva le autorità: se le encomiendas nonfossero state abolite, il Nuovo Mondo sarebbe rimastospopolato. Se invece se gli indigeni fossero statitrattati come liberi vassalli sotto la direttagiurisdizione della corona le colonie avrebbero potutogarantire grande prosperità alla Spagna. Il domenicano,assennatamente, toccava il tasto dei benefici concretiche sarebbero derivati agli Spagnoli rimasti inmadrepatria a discapito degli emigrati, nonparticolarmente leali nei confronti della stessa.Altrimenti, concludeva minacciosamente, “Dio manderàorribili punizioni e forse distruggerà la Spagna”.
Nel 1542 apparvero le Veynte Razones (“Venti Ragioni”) indifesa delle libertà dei nativi, proprio in coincidenzacon l’emanazione delle Leyes Nuevas, da lui fortementevolute, che restringevano l’arbitrio degli encomenderos eribadivano certi diritti degli Indios. Queste Nuove Leggiseguivano in gran parte le sue indicazioni e prevedevanol’abolizione della schiavitù tranne che per gli schiaviacquistati legittimamente in precedenza, la liberazionedegli indigeni dalle encomiendas di proprietà privata ela soppressione di quelle illegittime, in vista dellagraduale eliminazione di questo istituto. “Disponiamo eordiniamo che d’ora in avanti nessun indiano sia fattoschiavo per alcun motivo, né di guerra, né di ribellioneo riscatto; ma siano trattati come quello che sono, cioèsudditi della Corona di Castiglia”. In un’altradisposizione leggiamo che: “Nessuno potrà servirsi degliindiani come persone al proprio servizio né in alcunaltro modo contro la loro volontà”. Non aveva peròefficacia retroattiva (de aquì en adelante). Si sancivaaltresì che gli esploratori avrebbero dovuto ottenere unalicenza e si dovevano fare accompagnare da ecclesiasticiche ne avrebbero mitigato gli eccessi. I nativi dovevanoinfine essere trattati con rispetto. Più chiaro di così.
77
Eppure, fatta la legge trovato l’inganno: il serviziopersonale obbligatorio fu sostituito da quellovolontario, che lo era solo formalmente. In teoria,dunque, le leggi abolivano interamente le encomiendas, mafurono aggirate in molti modi – tra i quali cospicuedonazioni al sovrano – e la schiavitù non fu di fattoabolita. Il primo vicerè del Perù, Blasco Nùñez de Vela,che cercò di rendere effettive le Nuove Leggi, provocòuna sommossa e finì decapitato, la sua testa attaccata aduna corda e trascinata in giro. Il 20 ottobre 1545 laforza di queste stesse leggi fu limitata drasticamentecon la revoca del capitolo XXX e solo nel 1562 Filippo IIdecise di non assegnare le encomiendas in perpetuità. Lasuccessiva legislazione non risolse nulla e servìsemplicemente ad esaltare il ruolo degli Spagnoli comepacificatori invece che conquistatori. L’istituzionedell’encomienda scomparve solo al principio deldiciottesimo secolo, con decreto abolitivo del 23novembre 1718. Queste leggi servirono comunque acomunicare ai coloni ispano-americani che i loro soprusinon avrebbero incontrato la compiacenza della monarchiaspagnola. Per il suo ruolo nella formulazione di questeleggi Las Casas fu minacciato di morte da chi avevainteresse a mantenere le cose come stavano. Nel 1543rifiutò di diventare vescovo di Cuzco, perché l’offertaserviva unicamente ad allontanarlo, ma nel 1544 accettòil seggio episcopale del Chiapas, dove si diresse assiemea 45 frati dominicani e 7 assistenti laici come guide edinterpreti. Nel frattempo le Nuove Leggi avevano causatoun inasprimento delle tensioni tra coloni e monarchia. InPerù era in corso una vera e propria insurrezione controla madrepatria, capitanata da Gonzalo Pizarro, uno deifratelli minori di Francisco Pizarro, il conquistatoredel Perù. Fu domata solo nel 1548, dopo che le NuoveLeggi furono parzialmente abrogate, proprio in quei puntipiù determinanti per la sorte degli indigeni e piùdevastanti per le rendite dei coloni. Ciò fece infuriare
78
Las Casas che, a Ciudad Real del Chiapas, aveva giàdovuto subire una continua serie di minacce e di piccolevendette da parte delle autorità spagnole, culminata inun complotto che doveva concludersi con il suoassassinio.
La sua prima mossa per evitare lo scacco fu quella direplicare con il suo Confessionario (Avisos y Reglas ParaConfesores). In esso ingiungeva ai predicatori dirifiutarsi di assolvere gli schiavisti e i venditorid’armi. L’assoluzione poteva seguire solo la restituzionedel maltolto e della libertà. In punto di morte i colonierano così costretti a firmare un atto con cuidistribuivano i loro beni agli indigeni sfruttati o ailoro discendenti, in cambio dell’assoluzione. Laresistenza e le proteste a queste “direttive” di LasCasas, che godeva del favore di moltissimievangelizzatori, furono violente. Gli encomenderos eranovenuti dalla Spagna con pochi soldi in tasca e tutto quelche avevano guadagnato lo dovevano alla manodoperagratuita degli indigeni. Per di più i loro eredi nonavrebbero ricevuto nulla. L’efficacia del Confessionarionon fu duratura e fu essenzialmente ristretta allaregione andina, ma servì quantomeno a moderare l’aviditàdei conquistatori. In esso si riaffermarono due principifondamentali: l’emancipazione degli indios e larestituzione del maltolto e compensazione delle vittime.Juan Ginés de Sepúlveda, la nemesi di Las Casas, definìquesto scritto “scandaloso e diabolico”. La Corona lointerpretò come un’implicita critica al suo operato echiese ragione di queste accuse, mentre diverse figuretramavano affinché fosse accusato di alto tradimento.Tornò in Spagna nel 1547, un anno dopo la morte diFrancisco de Vitoria, e fu immediatamente coinvolto intre dispute. La prima in difesa delle nuove leggi, sottoattacco da parte degli encomenderos e dei loro alleatinel clero. Poi si dovette difendere dalle accuserivoltegli dai medesimi per la sua proibizione di
79
assolverli prima che avessero risarcito gli Indios.Infine la celebre disfida di Valladolid, controSepúlveda.
Las Casas rimbeccò i suoi denigratori con i “TrentaProponimenti” in cui spiegava che la missione europea nelNuovo Mondo era quella di predicare il messaggio diCristo, non di perseguitare altri esseri umani. Las Casassosteneva che la bolla papale di donazione Inter Caetera (4maggio 1493) di Alessandro VI, quella che divideva ilmondo ad occidente delle Colonne d’Ercole tra Spagna ePortogallo, era stata concepita per sollecitare i sovraniiberici ad espandere e proteggere la fede e convertiregli infedeli. Dunque i fini materiali, pur importanti,non potevano avere la precedenza su quelli spirituali,per il buon nome stesso della Corona. Di conseguenza igovernanti indigeni non potevano essere privati dei lorotitoli di sovranità in accordo con la legge naturale e lalegge delle nazioni. Altrimenti si sarebbe data vialibera all’esproprio arbitrario e violento ed allatirannia. L’idolatria non era certo una ragionesufficiente per perpetrare il latrocinio ai danni di chise ne macchiava. Gli indigeni non avevano mai avutol’opportunità di ascoltare il vangelo e quindi nonavevano colpe. Gli unici che andavano puniti erano quelliche ostacolavano deliberatamente la predicazione. LasCasas avrebbe poi rivisto il suo giudizio anche su questopunto, sostenendo che persino in questo caso la violenzaera ingiustificata. Le premesse erano già chiare inquesto testo. Infatti il Nostro prevedeva che, una voltaconvertiti, i capi locali avrebbero riconosciuto lasovranità spagnola ma – e questo era un ragionamentoparticolarmente audace, per quei tempi – anche il rifiutodi convertirsi non era ragione sufficiente per punirli.Le conquiste armate non avevano perciò alcuna validitàgiuridica ed erano e rimanevano “ingiuste, inique etiranniche”. Per quel che riguardava il sistema di lavorocoatto, la sua opinione era che il diavolo in persona non
80
avrebbe potuto inventarsi un metodo più efficacedell’encomienda e del repartimiento per distruggere il mondodei nativi americani, perché questi costringevano gliIndiani a lavorare nelle miniere e come portatori sulunghissime distanze, dividendo le famiglie. Las Casasconcludeva rammentando al sovrano che questi aveva laresponsabilità di proteggere le leggi ed i costumi localiquando erano in armonia con le leggi e la moralitàspagnola, cambiando solo quelle che non lo erano edaiutando i nativi a rimediare ai difetti dei loro sistemidi governo.
In quegli anni Las Casas completò ben nove trattati,tra i quali la già citata Brevissima relazione della distruzionedelle Indie, che forse non era stata pensata per esserepubblicata ma solo per servire da canovaccio. Irritòmolte figure influenti. Nella sua Storia delle Indieridicolizzò Gonzalo Fernández de Oviedo definendolo “ilpeggiore nemico degli Indiani”, un uomo che cercava soloil suo profitto personale, e chiamò mentitore López deGómara. In cambio López de Gómara lo chiamò lunatico e,nella sua Historia General, si rifece all’autorità diSepúlveda per legittimare la conquista. Motolinía accusòa sua volta Las Casas di essere un falso profeta ed unipocrita che distruggeva la reputazione internazionaledella Spagna. Per Motolinía la conquista era un eventoprovvidenziale, divino e legato all’avvento delMillennio. Egli insinuò altresì che Las Casas era troppoimpegnato a rimestare nel torbido in Spagna per occuparsidel suo vescovato del Chiapas. Nel frattempo il consigliomunicipale di Città del Messico fece diverse donazioni aSepúlveda affinché continuasse la sua opera di difesadelle sue prerogative. Las Casas si mosse abilmenteperché ribadì l’innocenza della Corona e incolpò di tuttocoloni avidi e privi di coscienza. In questo modo offrìal re l’opportunità di rimettere in riga i suoi sudditiamericani che cercavano di ritagliarsi una sempremaggiore autonomia. La sua destrezza è ulteriormente
81
testimoniata dal fatto che fu in grado di creare attornoa sé una rete di simpatizzanti che esercitava unanotevole influenza a corte. Per fare un esempiodell’efficacia del suo attivismo e lobbismo basti pensareche Bernal Díaz, un encomendero favorevole ai massacripreventivi come monito per gli indigeni insubordinati obelligeranti, pur detestando Las Casas, cercò diservirsene, rivolgendosi a lui per farsi aiutare indiverse occasioni – ad esempio per consolidare la suaposizione professionale, ora che era “attempato e con unafamiglia numerosa”. Questo perché “so che dovunque Leiponga mano, ottiene dei risultati, che è proprio comedev’essere”. Las Casas ignorò le sue richieste. Persinoil vicerè della Nuova Spagna, Luis de Velasco, si rivolsea lui per ottenere un aumento di stipendio dal re.
Ingerenze umanitarie
L'idea di un uso della forza non più collegato alla pura e semplice potenzanazionale, ma messo al servizio del bene comune dei popoli, comporta moltirischi in termini di vite umane, ma è un classico esempio giusto diglobalizzazione dei diritti e dei valori assolutamente irrinunciabile, comerecita la Costituzione. Se la vita umana diviene l’obiettivo essenziale delleimprese militari, allora esse sono imprescindibili per la pace nel mondo. Sepoi ciascuna forza armata lega il proprio compito ad una missioneumanitaria che non appartiene più, di fatto, al solo interesse sovrano delloStato di cui è parte, allora abbiamo una funzione nazionale che si ampliafino a diventare un’istituzione etica globale.Joaquín Navarro-Valls, “Gli eserciti globali”, LaRepubblica, mercoledì 10 novembre 2010.
E se il giogo di Cristo è tanto soave ed il suo carico tanto leggero cheprendendolo sulle spalle, le anime trovano refrigerio e piacere, perchéconsentite si addossi loro un peso sì doloroso, insopportabile, un giogo cosìamaro e fonte di tanta disperazione?Las Casas, Lettera al Consiglio delle Indie
82
Las Casas condusse un’esistenza lunga ed attiva,morendo a 82 anni.
Juan Ginés de Sepúlveda non lo sconfisse nell’arenadella retorica, ma lo riuscì a superare in longevità.Nacque nel 1490 nei pressi di Cordoba, città dove morìnel 1573, a 83 anni, quasi fosse simbolicamente legato alsuo rivale. Studiò inizialmente ad Alcalà e Sigüenza, perpoi trasferirsi in Italia, paese che avrebbe amatoappassionatamente, grazie ad una borsa di studio per ilColegio de San Clemente a Bologna, dove affinò la suapreparazione sotto il famoso, sebbene teologicamentediscusso, filosofo Pietro Pomponazzi, grande amante dellafilosofia greca. L’altro suo patrono fu Alberto Pio,principe di Carpi, nipote di Pico della Mirandola efrequente visitatore del suddetto collegio. Questiapprezzò molto la statura intellettuale di Sepúlveda e lotenne a lungo con sé presso la corte di Carpi, tra il1522 ed il 1525. In Italia l’umanista spagnolo assistetteal Sacco di Roma del 1527 ed all’assedio di Napoli del1528. Per l’incoronazione ad imperatore di Carlo V,scrisse L’esortazione a Carlo V a muovere guerra ai Turchi (1529)contro la minaccia ottomana, “perché se non lo si arrestain tempo, gravi saranno il rischio ed il pericoloincombenti sulla nostra sicurezza e libertà”. Poi, inseguito al decesso del suo patrono papale, Clemente VII,seguì in Spagna l’imperatore, per diventare suo cronistae cappellano. Era stato lontano dalla Spagna per 20 anni.Traduttore dal greco al latino delle opere di Aristotele,era un grande ammiratore della Roma imperiale. Era inveceostile, come lo fu Alberto Pio, alle teorie di Erasmo daRotterdam e dei suoi estimatori, tra i quali proprio ilnostro Las Casas che, pur non essendo un erasmiano, avevaconferito evidenti accenti erasmiani alle sue opere,promuovendo un cattolicesimo non conformista, in un’epocain cui pure tirava una brutta aria per i difensorispagnoli di Erasmo.
83
Il teologo sivigliano si lasciò coinvolgere incontinue polemiche con gli erasmiani ma, nei loroconfronti, i suoi toni furono quasi sempre molto civili ecortesi. È degna di nota la sua contrarietà al pacifismoerasmiano che, osservava con una certa inquietudine,stava facendo proseliti anche a Bologna. Per Erasmol’imperialismo romano era un esempio perfetto deipericoli di un’illimitata autocrazia e per questa stessaragione era estremamente sospettoso nei confronti del suoerede, il Sacro Romano Impero, che tassava i suoicompatrioti olandesi con una forma di parassitismo cheappariva senza limiti, senza fine e senza ritegno. Erasmosoleva anche criticare severamente quegli educatori cheistillavano nei prìncipi il desiderio di emulare GiulioCesare, un leader a suo avviso tutt’altro che glorioso,ma anzi “pestifero”. Gli erasmiani esaltavano l’unità ela concordia della razza umana in sintonia conl’originale insegnamento di Gesù il Cristo e condannavanoi fattori di divisione e discordia, inclusa la de-umanizzazione dei nativi americani. In risposta a questiproclami pacifisti ed anti-romani, Sepúlveda scrisseGonsalus (1523), un’apologia della rincorsa della gloria,che secondo lui equivaleva alla ricerca del bene comune.In seguito scrisse altre tre opere in favore della giustaguerra. Quella del 1529, alla quale abbiamo giàaccennato, per controbattere alla posizione di Lutero chenegava il diritto dei Cristiani di fare guerra ai Turchi.Una nel 1533, il Democrates primus, o De conuenentia militarisdisciplinae cum christiana religione dialogus per riaffermare lacompatibilità tra la guerra e l’essere cristiani, inrisposta all’influenza di “quelli che si abbandonano aldesiderio di novità di fronte alle nuove idee”. Infine il“Trattato sulla giusta guerra nelle Indie” (Democratessegundo o de las justas causas de la guerra contra los indios) del 1544,riassunto poi nell’Apologia pro libro de iustis belli causis, cheapparirà il 1 maggio del 1550 e servirà per la Disputa diValladolid. Las Casas, molto tempestivamente, redigerà
84
immediatamente la sua replica, l’Apología contra los adversariosde los indios, che non fu mai diffusa.
Sepúlveda chiama a sostegno delle sue tesi sullaguerra giusta Sant’Agostino: “Cos’è che non ci sta benedella guerra? Che qualche volta muoiono quelli che devonomorire affinché quelli che devono vincere dominino inpace. Deplorare questo è da uomini timidi e pocoreligiosi”; San Gerolamo: “chi colpisce i mali in quelliche sono malvagi e possiede strumenti di morte peruccidere i peggiori, è ministro di Dio”; e infineSant’Ambrogio: “Quando per ingiunzione divina insorgono ipopoli per castigare i peccati, come fece il popoloebraico per occupare la terra promessa e distruggere legenti peccatrici, si può spargere il sangue dei peccatorisenza incorrere in alcuna colpa, e ciò che possiedonoingiustamente passerà debitamente sotto il controllo deibuoni”.
Alla fine del 1531 Sepúlveda scoprì suo malgrado cheil pacifismo umanista si era insinuato persino tra glistudenti spagnoli del suo collegio a Bologna, ora più chemai determinati a difendere la tesi secondo cui non sipuò essere allo stesso tempo un soldato ed un buoncristiano. Questo movimento di vera e propriacontestazione studentesca pacifista esercitò un’influenzapiuttosto estesa, geograficamente e temporalmente. Unesempio importante è quello di Alberico Gentili, umanistaitaliano emigrato in Inghilterra perché protestante, chepubblicò intorno al 1588 il De iure belli, una confutazionedell’esistenza delle guerre sante. Gentili eradell’opinione che la religione non potesse essere unmotivo sufficiente per dichiarare una guerra perché essariguarda il rapporto tra l’uomo e Dio e nessun uomo puòperciò lamentarsi con qualcun altro di essere statoinsultato per via di una divergenza nelle credenzereligiose. Un altro argomento sollevato era quellodell’inesistenza degli schiavi di natura, “perché, alcontrario, siamo tutti naturalmente fratelli…e non esiste
85
una ripugnanza naturale dell’uomo verso l’uomo…Se idesideri umani sono sconfinati e non c’è sufficientegloria e potere per soddisfarli, quella non è una leggedi natura, ma un difetto”. Tantomeno sussisteva ildiritto di far la guerra ad un popolo perché si rifiutavadi ascoltare il vangelo: “Anche se sta scritto “Andate intutto il mondo a predicare il vangelo ad ogni creatura”(Mc 16,15) non ne consegue che ogni creatura che sirifiuti di ascoltare debba essere costretta a farlo conla forza della guerra e delle armi. Queste sonoassurdità”.
Dal punto di vista delle élites tradizionali ladiffusione del pacifismo tra i giovani studenti avrebbepotuto creare una generazioni di “obiettori di coscienza”di fronte alla minaccia islamica. Sepúlveda sminuìl’importanza della considerazione che nel NuovoTestamento non si parlava di fare guerra, ribattendo che,se si voleve prendere Gesù a modello, visto che lui noncondannava l’adultera, allora si sarebbe dovuto farealtrettanto, ma non ci sognavamo di farlo. Mettere aconfronto l’adulterio e la guerra, in riferimento ad unarivelazione che era universalmente associata alla pace,alla concordia, alla fratellanza, alla carità edall’amore per il prossimo, era una scelta argomentativaquantomeno curiosa, ma Sepúlveda non se ne diede conto,la minaccia era troppo grave. Gli intellettuali pacifistiindebolivano il fronte comune contro il nemico: “Diconoche i cristiani dovrebbero vincerli non con la violenza,ma con la pazienza; voci queste che, come altre opinionieretiche, sono sicuro non procedono da errori dellamente, da depravazioni del pensiero o da ambizione, madal sacrilegio criminale ed insidioso di chi, corrottodai Turchi con doni e promesse, mette in grave pericolola libertà dei Cristiani”. È in questo contesto chenacque l’anti-erasmiano Democrates primus, pubblicato aRoma, che s’imperniava sulla celebrazione del codicecavalleresco: se gli altri non si sanno difendere, allora
86
meritavano di essere vinti e soggiogati. La sconfitta edil soggiogamento costituiranno la giusta punizione per iloro crimini collettivi contro la natura e per il lorofallimento nel creare una società civile. Questomanoscritto sarà seguito dal più famoso Democrates secundus(o Primus Alter), la cui stesura fu sollecitata da un membrodel Consiglio delle Indie per minare alla base i principiche informavano le Nuove Leggi del 1542 ed il rifiuto deimissionari di assolvere i coloni. Questo manoscrittoincorporava il dibattito sul Nuovo Mondo e sulle NuoveLeggi, ispirate agli scritti e discorsi di Las Casas emirate alla restrizione del potere dei nuovi signorilocali sugli indigeni. Il Democrates secundus ricapitolava itemi centrali del primo: le guerre giuste sonoautorizzate dalla legge di natura e ciò che è consentitodalla legge di natura è parimenti permesso dalla leggedivina. Un soldato non deve mai chiedersi se una guerrasia giusta o no, deve solo obbedire in buona fede,contando sul fatto che la responsabilità non ricadrà sudi lui. Una regola di vita che fu adottata da AdolfEichmann e dal giurista nazista Hans Frank, con le loropersonali formulazioni dell’imperativo kantiano:rispettivamente “agisci come se il principio delle tueazioni fosse quello stesso del legislatore o della leggedel tuo Paese” e “agisci in maniera tale che il Führer,se conoscesse le tue azioni, le approverebbe”.
Nel periodo intercorso tra la prima opera ed il suoseguito, Sepúlveda aveva aggiornato il suo pensiero.Aveva capito che gli Aztechi erano guerrieri, non“educande”, e che i Mexica erano convinti che Cortésfosse un emissario del dio Quetzalcoatl, identificato conil lontano sovrano spagnolo. Positivamente impressionatoda questa rivelazione nei suoi aneliti autoritari, –perché la personalità autoritaria onora sempre un nemicosconfitto ma valoroso, quando la sua resistenza ha messoin risalto il valore del vincitore – aveva ammorbidito itoni. Esaltava l’audacia della loro difesa finale e ne
87
minimizzava i vizi, arrivando ad attribuire ai Mexica unaconoscenza intuitiva dell’immortalità dell’anima el’aspirazione alla salvezza. Si registra una crescentemoderazione nei suoi giudizi, che continua con l’Apologiadel 1550, che descrive la società Mexica in terminirelativamente positivi, un giudizio però non esteso allealtre società indigene. Evidentemente l’amicizia conCortés – che, secondo lui, nel Nuovo Mondo aveva “agitoda apostolo” – e con diversi cronisti della Conquistaaveva mutato la sua opinione. In fondo, come recita ildetto, “molti nemici molto onore”. Non si poteva certosminuire l’impresa spagnola. Ma, ancora una volta, il suogiudizio sulla restante barbarie disorganizzata non sidiscostava molto dai giudizi precedenti. Così scrivevanel Democrates Alter: “Sono così ignavi e timidi che a malapena possono sopportare la presenza ostile dei nostri, espesso sono dispersi a migliaia e fuggono come donnette,sbaragliati da un numero così esiguo di spagnoli che nonarriva neppure al centinaio. [...] Così Cortés,all’inizio, per molti giorni tenne oppressa eterrorizzata, con l’aiuto di un piccolo numero dispagnoli e di pochi indigeni, una immensa moltitudine,che dava l’impressione di mancare non soltanto di abilitàe prudenza, ma anche di senso comune. Non sarebbe statopossibile esibire una prova più decisiva o convincenteper dimostrare che alcuni uomini sono superiori ad altriper ingegno, abilità, fortezza d’animo e virtù, e che isecondi sono servi per natura”.
Sepúlveda non cambiò mai idea sulla mancanza distrutture politiche atte all’autogoverno e rimaseconvinto di tre cose: (a) che tutte le azioni sono ilrisultato di una decisione divina o di una suaautorizzazione; (b) che ci sono certe azioni che sirealizzano miracolosamente per disegno divino; (c) che laProvvidenza illumina i leader prescelti rendendoli conscidi compiere una missione divina. L’orizzonte mentale cheaffiora dalla lettura dei suoi scritti e della sua
88
corrispondenza è, come detto, quello di una personalitàautoritaria: semplice, rigido, dualistico, chiaramentedelimitato. Noi, gli amici, e Loro, i nemici. Vi è unelevato grado di subordinazione alle autorità, diaggressività (anche solo verbale) nel nome delleautorità, e di convenzionalismo-conformismo: tutti devonoseguire le norme e pratiche stabilite dall’alto. Credevache, al fine di mantenere la pace, i sudditi dovesserotenersi anche i capi più incompetenti o moralmentedeprecabili, perché le leggi erano fatte per essereosservate, non per ribellarvisi. Tipicamente, Sepúlveda ègiustizialista verso i diversi e permissivo verso ipotenti e verso chi aggredisce qualcuno che è ilbersaglio delle autorità. La punizione divina o umana delcriminale lo fa sentire bene, lo fa sentire puro, perchéè intimamente persuaso che l’universo sia intrinsecamentegiusto e che le cose cattive succedono alle personecattive e che se ciò non avviene è per un qualcheimperscrutabile disegno divino che va accettato. Inpubblico si autocontrollava, appariva gentile, socievole,piacevole, amichevole – riaffermava l’assenza diavversione personale nei confronti di Las Casas, checonsiderava una persona iraconda e pericolosa, “diintenzioni migliori dei suoi giudizi”, verso il qualedichiarava però di non nutrire alcuna ostilità e dilimitarsi a “pregare che Dio gli concedesse una mente piùserena, affinché arrivasse a preferire le quieteriflessioni ai progetti turbolenti” (Epistola ad MelchioremCanum).
In privato era un vulcano che attende di eruttare intutta sicurezza e con l’approvazione del potere. Se sifosse trovato dall’altra parte, se cioè fosse nato aztecoo inca, è presumibile che si sarebbe comportato nellastessa maniera, con la stessa foga e zelo, anche se aruoli invertiti. Non si può ignorare la soddisfazione chetraspare quando l’autore distingue e discrimina, come seciò lo potesse far sentire più vivo. Come l’ideologo
89
reazionario statunitense del ventesimo secolo LeoStrauss, Sepúlveda era persuaso che le masseabbisognassero di comando e disciplina, non di governo(perché sono politicamente troppo incompetenti) edandassero frenate, represse, confinate (perché troppodissolute e volgari). Coltivava il mito dell’autoritàpolitica e di quelle strutture di potere in cui chicomanda gode di enorme discrezione e si autogratifica conabbondante liberalità, mentre chi è comandato è relegatoin rigidi binari morali. Ecco come poneva a confronto lacondizione degli autoctoni prima e dopo l’arrivo degliSpagnoli: “Prima della venuta dei cristiani avevano ilcarattere, i costumi, la religione e i nefandi sacrificiche abbiamo descritto; ora, dopo aver ricevuto col nostrodominio le nostre lettere, le nostre leggi e la nostramorale ed essersi impregnati della religione cristiana,coloro – e sono molti – che si sono mostrati docili aimaestri e ai sacerdoti che abbiamo loro procurato, sidiscostano tanto dalla loro prima condizione quanto icivilizzati dai barbari, i dotati di vista dai ciechi, imansueti dagli aggressivi, i pii dagli empi e, per dirlacon una sola espressione, quasi quanto gli uomini dallebestie” (Demócrates segundo).
Sepúlveda era profondamente colto e scrivevaelegantemente, ma i suoi ragionamenti non si dipanavanocon scorrevolezza. Forse perché, come insinuava lostudioso ellenista Juan Pérez de Castro, nei suoi scrittinon si riusciva a capire veramente cosa intendesse dire,perché non era un uomo di principio. In effetti iragionamenti degli autoritari tendono ad essere falsatida pregiudizi, salti logici, compartimentazione dellaconoscenza, omissioni, doppiopesismo, ipocrisia, mancanzadi autocritica, rimozioni, inferenze erronee,etnocentrismo e dogmatismo. La logica e l’evidenzaempirica non potevano cambiare le sue opinioni. Questo èprecisamente ciò che avvenne nello scambio di opinionicon Las Casas. L’esperienza in presa diretta del
90
domenicano non fu mai sufficiente a modificare il puntodi vista di Sepúlveda, prigioniero in una gabbia dierudizione che gli impediva di rendersi conto dellarealtà della sofferenza di milioni di esseri umani.Grande amante del pensiero aristotelico ed uno dei piùapprezzati traduttori e commentatori spagnoli diAristotele del sedicesimo secolo, Sepúlveda sottoscrivevai pareri espressi nei seguenti brani della Politica diAristotele: “Quale sia la natura dello schiavo e quali lesue capacità, è chiaro da queste considerazioni: unessere che per natura non appartiene a se stesso ma a unaltro, pur essendo uomo, questo è per natura schiavo: eappartiene a un altro chi, pur essendo uomo, è oggetto diproprietà: e oggetto di proprietà è uno strumentoordinato all’azione e separato”. E ancora: “Ora glistessi rapporti esistono tra gli uomini e gli altrianimali: gli animali domestici sono per natura miglioridei selvatici e a questi tutti è giovevole esseresoggetti all’uomo, perché in tal modo hanno la lorosicurezza. Cosí pure nelle relazioni del maschio verso lafemmina, l’uno è per natura superiore, l’altra inferiore,l’uno comanda, l’altra è comandata – ed è necessario chetra tutti gli uomini sia proprio in questo modo. Quindiquelli che differiscono tra loro quanto l’anima dal corpoo l’uomo dalla bestia (e si trovano in tale condizionecoloro la cui attività si riduce all’impiego delle forzefisiche ed è questo il meglio che se ne può trarre),costoro sono per natura schiavi, e il meglio per essi èstar soggetti a questa forma di autorità, proprio comenei casi citati”.
Fedeli a questo modello, gli Aristotelici difendevanouna nozione gerarchica del valore umano che vedeva allasommità della piramide i maschi adulti dotati diraziocinio, con in fondo le donne e i bambini dei popolopiù selvaggi. L’umanista spagnolo non citavaesplicitamente questi passi dello Stagirita, giàabbondantemente dibattuti, ma è evidente che il suo
91
argomento che il “più perfetto” è sempre superiore al“meno perfetto” derivava direttamente dalla Politica diAristotele. “Un singolo principio e dogma naturale: ilgoverno ed il dominio della perfezione sull’imperfezione,della forza sulla debolezza, della virtù sul vizio”,scriveva il pensatore cordobese: gli Indios eranodestinati a servire gli Spagnoli, “de ingenio más elegantes”.Nel Tratado sobre las justas causas de la guerra contra los Indios, chegenerò la controversia di Valladolid, citava esempibiblici di guerre giuste, condotte con obiettivi nobili esacrali e ribadiva che la legge di natura stabilisce unagerarchia tra signori perfetti e schiavi imperfetti(preludio a Nietzsche). Gli Spagnoli, nonostante il saccodi Roma, secondo lui esemplificavano la virtù e lagrazia. Il suo punto di vista è articolato in manierainequivocabile: “È per questo che le belve sono domate esono sottoposte all’autorità dell’uomo. Per questo motivol’uomo comanda alla donna, l’adulto al fanciullo, ilpadre al figlio: cioè, i più forti e i perfettiprevalgono sui più deboli e sugli imperfetti. Questastessa situazione si riscontra tra gli uomini; perché vene sono di quelli che sono per natura signori di altriche per natura sono servi. Quelli che superano gli altriper prudenza e per saggezza, anche se non prevalgono perla forza fisica, quelli sono, per la stessa natura, isignori; al contrario, i pigri, i tardi di mente, anchese hanno le forze fisiche per compiere tutti i lavorinecessari, sono per natura dei servi. Ed è giusto edutile che essi siano servi, e noi lo vediamo sanzionatodalla stessa legge divina, perché sta scritto nel librodei Proverbi: “Lo stolto servirà il saggio”. Tali sono lenazioni barbare e inumane, estranee alla vita civile e aicostumi tranquilli. E sarà sempre giusto e conforme aldiritto naturale che queste genti siano sottomesseall’autorità di principi e nazioni già colte ed umane, dimodo che, grazie alla virtù di quest’ultimi ed allaprudenza delle loro leggi, essi abbandonino la barbarie e
92
si conformino ad una vita più umana ed al culto dellevirtù. E se essi rifiutano questa autorità, si può loroimporla per mezzo delle armi e questa guerra sarà giustacome lo dimostra il diritto naturale. [...] Inconclusione: è giusto, normale e conforme alla leggenaturale che gli uomini probi, intelligenti, virtuosi edumani dominino tutti quelli che non hanno queste virtù”.
Altrettanto illuminante è questo suo rifarsidirettamente a quel passaggio della Bibbia – “Lo stoltoservirà il saggio” – che era stato citato favorevolmenteda Tommaso d’Aquino, ed all’esempio dei Romani, “il cuidominio sugli altri popoli era giusto e legittimo”.Sepúlveda menzionò anche il coraggio di Cortés nellaconquista del Messico come prova dell’innata superioritàdegli Spagnoli, in contrasto con la natura servile degliindigeni. Stiamo parlando di quello stesso Cortés che siera gloriato del fatto che nell’assedio di Tenochtitlanerano morti più Indiani che Ebrei nell’assedio diGerusalemme. Sepúlveda definiva gli indiani “homunculi”(sic!) immeritevoli di una qualche forma diautodeterminazione, ma al contrario tenuti a servire inuovi signori e padroni. Ignorava la distinzione trapagani, che non avevano mai potuto ascoltare la parola diCristo, ed infedeli come i Musulmani e gli Ebrei che, puravendo avuto accesso ad essa, la rifiutavano. Metteva aconfronto la “magnanimità, la temperanza, l’umanità e lareligione” degli Spagnoli “con quelle degli homunculi neiquali non rimane quasi alcuna vestigia di umanità”[“Compara ahora estas dotes de prudencia, ingenio,magnanimidad, templanza, humanidad y religión, con lasque tienen esos hombrecillos en los cuales apenasencontrarás vestigios de humanidad, que no sólo no poseenciencia alguna, sino que ni siquiera conocen las letrasni conservan ningún monumento de su historia sino ciertaoscura y vaga reminiscencia de algunas cosas consignadasen ciertas pinturas, y tampoco tienen leyes escritas,sino instituciones y costumbres bárbaras”. Demócrates
93
segundo, 309]. Concedeva che, “con il passare del tempo,quando saranno diventati più umani…” allora sarebbe statopossibile accordare loro maggiori libertà. Una voltacostretti ad abbandonare le loro pratiche innaturali, lapace e la giustizia sarebbero prevalse. Ma era difficileimmaginare che ciò sarebbe avvenuto in tempi ragionevoli.Infatti, sempre secondo il nostro, come tutti i barbari,gli Indios non conoscevano il senso della misura, sidavano agli eccessi, mentre “in medio stat virtus”. Questegenti, la cui religione era un’inversione della pietàcristiana, si comportavano davvero “come maiali con gliocchi sempre fissi sul terreno”. La pubblicazione diquest’opera fu inizialmente approvata dal consiglio diCastiglia, ma poi, tra il 1547 ed il 1548, il librodovette essere riesaminato da una commissione di teologialle università di Salamanca e Alcalà, che locondannarono. Sepúlveda imputò alle interferenze di LasCasas il mancato via libera e decise di inviare un suntodel testo alla corte papale, che lo approvò e lo fecepubblicare nella forma di un’Apologia. Tuttavia tutte lecopie che giunsero in Spagna furono bruciate per ordinedel sovrano. In realtà nessuno dei suoi scritti polemicifu mai pubblicato in Spagna mentre lui era in vita,inoltre le pressioni censorie di Salamanca ed Alcalá,oltre a quelle dell’Ordine dei Domenicani, furonosufficienti ad evitare che la sua opera arrivasse nelleAmeriche (se non clandestinamente) e rafforzasse lepretese dei coloni.
L’impressione generale era che Sepúlveda fosse benlontano dal corrispondere all’immagine dell’umanistailluminato tipica di una certa vulgata storiografica.Alcuni giudicavano certe sue asserzioni isteriche ocomunque irragionevoli. L’erudito ellenista Juan Páez deCastro, confessore di Filippo II, lo bollò come l’operadi un uomo “non sani capitis” (non sano di mente), forsesulla scorta di un scambio espitolare con l’autore, chesi era lamentato dell’imposizione dell’obbligo di
94
lanciare degli avvertimenti preventivi a degli idolatriquali erano gli indiani. Nei tempi biblici, osservavaSepúlveda, non c’erano stati avvertimenti ed inoltre erapiuttosto evidente che “nessun popolo abbandonerà mai lareligione dei suoi avi se non per la forza delle armi oper miracolo”. Altri recensori avevano trovato irritantelo stile letterario con cui aveva scritto il DemocratesAlter. Ma il suo intento era quello di farsi leggere da unvasto pubblico, non da un gruppo di specialisti. Questiteologi si atteggiavano a guardiani dello stile, ostili achi si permetteva di varcare le giurisdizionidisciplinari senza avere i titoli per farlo. Sepúlveda,come Erasmo, era visto come un impudente outsider. Vacomunque precisato che la visione del mondo di Sepúlvedanon era agli antipodi rispetto alla teologia“politicamente corretta”: cercava di non dare troppaenfasi alla sua fede nel determinismo biologico eribadiva che, alla lunga, gli indigeni potevano esserecivilizzati e che questo era l’obiettivo di Dio. Primaperò dovevano essere sottomessi. Secondo lui il passo delVangelo di Giovanni (10:16) in cui Gesù riferiva di avere“altre pecore, che non sono di questo ovile; anche quelledevo condurre, ed esse ascolteranno la mia voce, ediverranno un solo gregge, un solo pastore” potevaalludere ai nativi americani, anche se più probabilmentele pecore in questione erano un’allegoria dei popolilimitrofi non-Ebrei.
Sorprendentemente, in tutto questo i suoiragionamenti non si differenziavano poi molto da quellodi Francisco de Vitoria, “il pinnacolo del pensieroumanista spagnolo di quell’epoca”, celebrato ancora oggicome uno dei padri della dottrina dei diritti umani. Perfarsi un’idea della sua importanza, al momento della suamorte, nel 1546, quasi trenta dei suoi studenti erano giàdocenti universitari. Nelle sue lezioni universitarieVitoria aveva difeso i nativi americani, il loro dirittoalla proprietà privata e perfino quello a non farsi
95
convertire con la forza al cattolicesimo. Ma leggiamo ilpunto di vista di quest’ultimo sugli indiani: “Anche sequesti barbari non sono del tutto pazzi, non sono neppuretroppo lontani dall’esserlo…Non sono capaci, o non losono più, di governarsi da soli più di quanto losaprebbero fare dei folli o delle bestie ed animaliselvatici, visto e considerato che il loro cibo non è piùgradevole e per nulla migliore di quello degli animaliselvatici”. Inoltre la loro stupidità è “maggiore diquella dei bambini e pazzi in altri paesi”. Non che cifosse alcunché di inerentemente sbagliato in loro, è soloche erano stati sottoposti alle influenze sbagliate. Sepotevano sembrare insensati e stolti (insensati et hebetes)era per colpa della cattiva educazione. Confermeprovenivano dalle osservazioni del teologo Alonso de laVeracruz che viveva a Città del Messico e riferiva chegli indiani che risiedevano in città si comportavano inmodo perfettamente civile. Il francescano Juan de Silvaera dell’avviso che gli indiani dovevano essere educati acapire ciò che altri esseri umani potevano cogliereintuitivamente. Bisognava renderli consapevoli del fattoche erano davvero “uomini razionali con un’animasensibile, razionale ed immortale”. Analogamente, perVitoria, l’indio, come il povero villano europeo, eraforse un essere umano inferiore, ma rimaneva un “homosapiens”. Non schiavo naturale, ma infante naturale, unacreatura razionale in potenza, ma non in atto. Era perciòlecito intervenire per esercitare il diritto di tutela abeneficio degli indigeni e delle loro menti noninferiori, ma semplicemente immature, che dovevano essereplasmate e quindi richiedevano una costante tutela. Inquesto modo si anticipava l’argomento di Pufendorf che sequalcuno è capace di apprendere, ancheretrospettivamente, che qualcosa è nel suo interesse, sipuò dire che vi abbia acconsentito anche se è evidente atutti che non ha esercitato alcuna effettiva liberascelta. La legge naturale e Dio avevano così decretato:
96
il contratto sociale non poteva essere modificato, isudditi non avevano voce in capitolo su chi li comandava,ma si governava comunque con il loro consenso. Allostesso modo gli Indios dovevano accettare volontariamentela loro sottomissione, perché questa li avrebbeavvantaggiati. Finché gli Indios fossero rimasti nellacondizione infantile gli Spagnoli si sarebbero presi curadi loro (accipere curam illorum). Dunque Vitoria, un altroumanista che ragionava per sentito dire, dietro lamaschera del rispetto del diritto internazionale, offrivain pratica, più o meno consapevolmente, un perfettopretesto per una politica coloniale non troppo diversadall’odierna pax americana. Legato a doppio filo, comemolti altri colleghi, alle speculazioni aristoteliche,nel 1539 Vitoria lesse De Indis Relectio Posterior, sive de iure belli,uno dei testi seminali del diritto internazionale,all’università di Salamanca, ma commise un errore tantoingenuo quanto evidente nel reinterpretarearbitrariamente la posizione di Aristotele, invece dirifiutarla recisamente. Il risultato fu un trattato cherazionalizza l’impiego della guerra in determinatecircostanze e con cristiana moderazione, dopoun’elencazione delle fonti scritturali che invece lacondannano. Ora, poiché Vitoria era un intelletto digrandissimo spessore ed esperienza, è lecito sospettareche il suo obiettivo fosse quello di legittimarel’imperialismo spagnolo, cercando però nel contempo disalvare l’essenza del messaggio evangelico. Un’impresamoralmente discutibile e tecnicamente irrealizzabile, senon facendo uso di contorsioni logiche e riprovevoliomissioni.
Sia come sia, contro ogni evidenza testuale, Vitoriaaffermò di ritenere che Aristotele non credesse veramenteall’esistenza di una schiavitù di natura, ma fossepiuttosto orientato a giustificare la tutela degli uominisuperiori su quelli inferiori, fino a quando questiultimi non fossero maturati a sufficienza da potersi
97
emancipare. In fondo, come altri ebbero occasione disottolineare, lo stesso Agostino d’Ippona non era statocontrario alla schiavitù, perché questa offrival’opportunità di sviluppare le virtù dell’umiltà,perdono, modestia, obbedienza e pazienza, ossia parte delprogramma divino per la rigenerazione della razza umana.In questa maniera si salvava il costrutto teoricoaristotelico purgandolo di ogni implicazionebiodeterministica – “sei schiavo e la tua natura non puòessere modificata”.
Una posizione perlomeno stravagante, visto che se ilfilosofo greco avesse voluto indicare la reversibilità oalterabilità della condizione di schiavo non avrebbecerto insistito sul concetto di stato naturale. Ilrisultato di questa acrobazia concettuale fuun’imbarazzante giustificazione della tirannia cheavrebbe avuto un notevole successo nei secoli a venire.Per di più questa proveniva da un difensore dei dirittiumani ed era fondata su una revisione del pensiero dellostagirita che poteva essere confutata con una facilitàdisarmante, citando anche solo un paio di estratti dallaPolitica in cui il filosofo esplicitava il favore con cuivedeva l’idea di schiavitù naturale permanente. Vitoriacercò insomma di far passare Aristotele per un difensoredella dignità umana, andando anche oltre le “correzioni”di Tommaso d’Aquino, che pure procedevano in quellastessa direzione. L’Aquinate, infatti, si era almenoperitato di precisare che homo homini obbedire non tenetur, sedsolum Deo – gli uomini devono rispondere solo a Dio delleazioni che riguardano la loro sfera personale.
Questo punto di contatto tra i due intellettuali,Vitoria e Sepúlveda, non deve comunque oscurare i meritidella Relectio de Indis, che riconosceva comunque, tra lealtre cose, la dignità umana degli indios, il diritto diproprietà ed il diritto dei popoli di difendere lapropria sovranità (dominium). Questo in base allaseguente considerazione: (a) che non è vero che il
98
peccato impedisce di possedere delle terre in quantoquesto dominio è conferito per grazia divina e quindi ilpeccatore non la può ricevere. Per l’Aquinate gli esseriumani razionali esercitano il dominio e gli indios hannodimostrato con le loro realizzazioni che sono razionali.Sarebbero colpevoli di peccato mortale se rifiutassero laparola del Signore presentata da cristiani dalla condottamorale impeccabile e dagli argomenti dimostrabilmenteragionevoli. Ma purtroppo le cose non stavano ancoracosì; (b) che “una persona è padrona dei suoi atti quandopuò scegliere questo o quello”; (c) che gli indios “hannoa modo loro l’uso di ragione”, perché “è evidente cheseguono un certo ordine nelle loro cose: hanno cittàdebitamente governate, matrimoni ben definiti,magistrati, nobili, leggi, professori, industrie,commercio; tutto ciò richiede l’uso di ragione. Inoltrehanno anche una certa forma di religione e non sbaglianonemmeno nelle cose che sono evidenti ad altri, cosa che èun indizio dell’uso di ragione. Dio e la natura non liabbandonano in ciò che è indispensabile per la specie; lafacoltà principale nell’uomo è la ragione ed è inutile lapotenza che non si riduce in atto”. Infine Vitoriasottolineava che Gesù aveva affermato esplicitamente cheil suo regno non era di questo mondo, e di conseguenza lapretesa papale del dominus totius orbis era invalidata; alpontefice non spettava alcun potere temporale né perdiritto naturale, né per diritto umano e neppure perdiritto divino. Inoltre, “anche ammettendo che il SommoPontefice avesse questa potestà politica su tutto l’orbe,non potrebbe trasmetterla ai prìncipi secolari” e “anchese i barbari non volessero riconoscere nessun dominio delPapa, non si [potrebbe] per questo far loro guerra, néimpossessarsi dei loro beni e dei loro territori”.
Parole magnificamente rivoluzionarie, queste, cheperò si arrestarono ad un passo dal traguardo che saràvarcato solo da Las Casas: il rifiuto di considerarelegittima un’ingerenza umanitaria non richiesta dai suoi
99
presunti beneficiari. Come abbiamo visto, Vitoria eSepúlveda erano d’accordo nel ritenere che certi popolibarbari fossero a malapena in grado di autogovernarsi enecessitassero di assistenza, o per meglio dire di unatutela paternalistica che poteva anche comportare unaguerra giusta, nel caso in cui fossero state vittime ditirannia, idolatria e abusi: “Un altro titolo – spiegavaVitoria – può essere la tirannia degli stessi barbari ole leggi tiranniche a danno degli innocenti, come quelleche ordinano il sacrificio di uomini innocenti ol’uccisione di uomini senza colpa al fine di mangiarli”.In questi casi esisteva un obbligo morale di intervenire:“Ne è la prova il fatto che Dio abbia mandato ognuno aprendersi cura del suo prossimo e tutti questi sono ilnostro prossimo”. Vitoria demolisce le giustificazionicorrenti delle guerre condotte in America, ma ritienetuttavia che delle guerre giuste siano possibili, quandosia violato il “diritto naturale di socievolezza ecomunicazione”, oppure qualora l’intervento sia compiutoper proteggere degli innocenti contro la tirannia deicapi e delle leggi e pratiche indigene. Non vi è alcunanozione, neppure in fieri, di una vera eguaglianza fraspagnoli e indiani, come si evince dalla giustificazioneultima della guerra nelle Americhe: “Benché questibarbari non siano affatto pazzi, non sono tuttavialontani dalla follia […]; Non sono più capaci digovernarsi da sé di quanto lo siano i pazzi, gli animalie le bestie feroci, visto che il loro cibo non è piùgradevole ed è appena migliore di quello delle belve”.Era dunque lecito intervenire nel loro paese peresercitarvi un diritto di tutela, impeccabile base legaleper delle guerre imperialiste.
È importante ricordare che questo giudizio non eracondiviso dall’intero spettro dei giuristi spagnoli. Peresempio, se da un lato Juan de Solórzano y Pereyra sirifaceva allo ius ad subiciendum eos, il diritto asottomettere gli indigeni, assicurando che “non v’è
100
nazione così barbara, così stupida che, se educata eistruita correttamente, non si liberi dalla barbarie”,dall’altro Vasco de Quiroga, magistrato, membro dellaSeconda Audiencia che amministrò la giustizia in NuovaSpagna tra il 1531 ed il 1535 e primo vescovo diMichoacán, era recisamente contrario a progetti diaddestramento e rieducazione finalizzatiall’addomesticazione dell’indio. Egli denunciòripetutamente un sistema di potere che aveva bisogno dimantenere gli indiani in una condizione degradante perpotersene servire come “bestie prive di ragione”.Melchior Cano, che nel De dominio indiorum avevacategoricamente escluso la possibilità dell’esistenza diesseri umani servi di natura – “nullus homo est natura servus”–, aggiungeva che, se si interveniva in difesa diinnocenti, non si doveva andare oltre il necessario pergarantire la loro tutela. Certamente ciò non comportavaspoliazioni e tributi vessatori come risarcimento. GliSpagnoli erano andati in America “non come pellegrini, macome invasori, a meno che uno non voglia chiamare quellodi Alessandro un pellegrinaggio”. Diego de Covarrubias,discepolo di Vitoria e Cano, superò la posizione diVitoria, sostenendo che gli indiani avevano il diritto divietare il passaggio anche agli Spagnoli esclusivamenteinteressati al commercio perché, una volta entrati, laloro supremazia militare avrebbe causato la rovina degliindigeni. Il giurista Francisco Falcòn, “procuradorgeneral de los indios” e rappresentante dei cacicchiperuviani al secondo Concilio provinciale di Lima del1567 dichiarò, arditamente, in quell’occasione: “se SuaMaestà è sovrana delle terre del Regno di Castiglia, peraverle conquistate secondo giusta guerra, la stessa cosanon la si può dire per questi regni [le Nuove Indie],perché non li ha avuti con giusta guerra; […] sarebbe[piuttosto] da ritenersi tirannia”. Il giuristaprogressista Fernando Vázquez de Menchaca (1512-1569),che accompagnò Filippo II al Concilio di Trento, non fu
101
meno esplicito e denunciò la teoria della schiavitù diAristotele come un esempio di come le persone cerchino didissimulare le loro guerre dietro la maschera dellagiustizia e di “quel rilassamento dello spirito umano cheè quasi sempre causato dall’influenza e dall’opera diquelli che desiderano compiacere i principi illustri epotenti”; forse un velato riferimento a Sepúlveda.Proseguiva poi ancor più esplicitamente: “La dottrina diqueste autori è una tirannia bella e buona, introdotta inguisa di amicizia e saggi consigli, per il sicurosterminio della razza umana e dispotismo sui superstiti.Per poter praticare in tutta libertà questa tirannia,saccheggiando città e usando violenza, cercano digiustificarla con nomi fittizi, descrivendola come unadottrina vantaggiosa per chi subisce vessazioni, mentrein realtà non si è mai sentito o visto nulla di piùlontano dal vero e più meritevole di essere sbeffeggiatoe vilipeso”.
Nei primi anni del sedicesimo secolo gli erasmistispagnoli erano stati spinti in un angolo ed alcuniavevano optato per una virtuale clandestinità, mentre iguerrafondai dominavano il dibattito. Lo stesso Vitoriain una lettera al suo amico Frate Miguel de los Arcos silamentava del fatto che durante gli accesi dibattiti acorte si rischiava di essere giudicati sleali neiconfronti dell’imperatore. Ma, grazie anche a questefigure, gli anni a cavallo della metà del secoloservirono ad attenuare l’impatto della Conquista. Poi,purtroppo, il pendolo oscillò nella direzione opposta,perché il movimentismo teologico-giuridico progressistametteva in dubbio la liceità delle imprese coloniali, equesto fin dall’inizio. Leggiamo per esempio cosascriveva a questo proposito il teologo domenicano Domingode Soto, già nel 1535: “Abbiamo stabilito chel’imperatore in nessun modo detiene il dominiosull’intero mondo. Con quale diritto, dunque, possediamonoi l’impero oltremarino appena scoperto? Io davvero non
102
lo so”. Las Casas la pensava esattamente allo stesso modoe, in una lettera del 1549, raccomandavairrealisticamente a Soto di pretendere dal re unacondanna pubblica ed ufficiale della Conquista. Quellastessa lettera, però, ci istruisce su di un aspettocruciale dell’intera questione. Anche le personalità piùsensibili alla causa indigena erano disinformati o, inalternativa, usavano estrema cautela nel sollevare certequestioni con il sovrano. Infatti Soto, confessore diCarlo V, in una lettera precedente indirizzata a LasCasas aveva spiegato di non sentirsi abbastanza informatoper poter fornire una sua opinione di carattereteologico-politico, figuriamoci per protestare pressol’imperatore.
Bartolomé Carranza, che insegnava al collegio di SanGregorio a Valladolid, presenziò assieme all’imperatoreal concilio di Trento e si schierò dalla parte di LasCasas nella famosa Disputa di Valladolid, non fu cosìfortunato o forse si spinse troppo oltre nell’ammissionepubblica del suo erasmismo, senza poter godere di appoggisufficientemente influenti a corte. Nominato arcivescovodi Toledo nel 1558, un incarico estremamente prestigioso,l’anno successivo fu comunque incarceratodall’Inquisizione a Valladolid per il reato di eresia.Las Casas lo aiutò in ogni modo, testimoniando in suofavore e denunciando durante il processo il conflitto diinteressi dell’inquisitore, il quale temeva che se leopinioni di Carranza avessero trovato ascolto a corte isuoi affari (compravendita di latifondi) avrebbero subitoun duro colpo. La Spagna del tempo non poteva tollerarealcun tipo di religiosità interiorizzata e men che menomistica, come quella ammessa da Carranza. Nel 1576 fucondannato formalmente da papa Gregorio XIII e gli siordinò di abiurare sedici opinioni eretiche contenute nelsuo catechismo. Morì poco tempo dopo. A dispetto diqueste voci, tutt’altro che isolate, l’umanissimoufficiale coloniale Rodrigo de Albornoz dovette
103
commentare amaramente che sebbene ci fossero 400difensori degli Indiani per ogni indiano, la schiavitù edil commercio umano non furono mai aboliti. Eppure, “nonho trovato nella legge di Cristo che la libertàdell’anima debba essere pagata con la schiavitù delcorpo”.
Ricapitolando, a quell’epoca si era assistito ad unvasto recupero della sapienza aristotelica, che potevaperò anche essere adoperata – e fu proprio ciò cheavvenne – per puntellare un modello di società in cui unavasta massa di servi permetteva ad una minoranza disignori di indulgere in una vita edonistica, o nelmigliore dei casi contemplativa. Questi schiavi naturalinon potevano pensare da sé e provvedere per sé. Tuttavia,come gli animali addomesticati a contatto con i padroniaffinano le proprie capacità, così anche loro si potevanoriscattare, col passare del tempo. Vitoria aderivaall’idea di Tommaso d’Aquino che l’umanità costituisse uncorpo mistico spirituale e temporale e che il destino delmondo cristiano non poteva essere separato dal destinodell’umanità. Se una nazione non era capace diautogoverno doveva intervenire qualcuno dal di fuori,prendere in mano la situazione e rieducarla, facendolaragionare. Entrambe le prospettive legittimavano lapresenza spagnola nel Nuovo Mondo in quanto braccioterreno per la realizzazione del disegno provvidenzialedella conversione dell’umanità alla cristianità. Gliindigeni erano così immobilizzati in uno schema di storiaprovvidenziale a loro alieno ed in un sistema politico-amministrativo aristotelico-cristiano per lorodifficilmente intelligibile.
L’egemonia del diritto di origine romana nellagiurisprudenza iberica comportò il graduale superamentodella nozione di schiavitù naturale – ossial’intersecarsi della dottrina ciclica dell’eterno ricorso(gli esseri umani sono una mera espressione di lignaggi
104
ancestrali più o meno puri) e della concezioneteleologica naturale della storia (la biologia è undestino personale e collettivo). Ciò nonostante,all’estensione lineare delle leggi naturali nella sferasociale, si sostituì l’opposizione fondamentale(culturalista) tra il cristiano e il non cristiano comepretesto per costringere quest’ultimo a cambiare. Daschiavi naturali (permanenti) gli indigeni divenneroschiavi socio-culturali e provvidenziali, l’affrancamentodei quali era rinviato a data da destinarsi. Nel corsodella Disputa di Valladolid arrivò il benservito adAristotele da parte di Las Casas ed il rinsaldamento dellegame con il messaggio originario di Gesù Cristo:“Addio Aristotele! Il Cristo, che è verità eterna, ci halasciato questo comandamento: ‘Amerai il tuo prossimocome te stesso’. (…) Benché fosse un filosofo profondo,Aristotele non era degno di essere salvato e di giungerea Dio attraverso la conoscenza della vera fede” (Apología,3). Egli contrastò sempre l’idea che le forme culturalipotessero essere l’espressione di disposizioni innate, mala lucida forza e perspicacia della posizione di LasCasas risiedeva nella sua capacità di asserirevigorosamente e senza riserve ed esitazioni che un regalonon può essere un compito, un favore non può essere unincarico, la disponibilità non può essere una pretesa.L’umanismo “umanitario” della correctio fraterna di Sepúlvedaera quello che faceva dire a H.D. Thoreau: “Se sapessicon sicurezza che c’è un uomo che sta venendo a casa miacon il piano consapevole di farmi del bene, scapperei arotta di collo”. Las Casas, avendo vissuto di persona incircostanze che rivelavano la spudorata ipocrisia diquesta ideologia, aveva ben compreso che la regola aureanelle relazioni con il prossimo – “Fai agli altri quelloche vorresti fosse fatto a te” – andava completata, nelsenso dell’imperativo di trattare gli altri come loro, inprimo luogo, vorrebbero essere trattati; cioè ascoltareil loro punto di vista, le motivazioni più profonde,
105
capire le loro esigenze ed aspettative ed agire diconseguenza. Anche se questo poteva significare nonbattezzare nessuno che non avesse ben compreso cosasignificasse e che non avesse fornito il suo consensoinformato. Una logica diametricamente opposta a quella diquei francescani che si limitavano a battezzaremeccanicamente, come in una catena di montaggio, senzaverificare se i nuovi cristiani avevano realmente capitoa che cosa si stavano sottoponendo. Si compiacevano diaver battezzato la strabiliante cifra di quattro milionidi pagani in dodici anni di attività, con un picco di 15mila indiani in un sol giorno. Uno di loro, Juan de Tecto(Jan Dekkers), scrisse l’Apología del bautismo Administrado a losgentiles Mexicanos con solo el agua y la forma sacramental, in cuidifendeva il metodo del battesimo di massa argomentandoche la fine del mondo era prossima e, sostanzialmente,non bisognava guardare per il sottile. La conversionedegli indigeni avrebbe accelerato il compimento delleprofezie chiliastiche.
Ai nostri giorni l’arcivescovo emerito di Milano,Carlo Maria Martini, si muove sulla stessa lunghezzad’onda di Las Casas quando invita a seguire l’esortazionedi Gesù ad amare il nostro prossimo perché è come noi,ossia plurale, eterogeneo, fluido. Non si può enfatizzarea sufficienza la grandezza ed attualità dell’intuizionelascasiana, che ha una valenza universale. Questariecheggia nelle parole del filosofo inglese Peter G.Winch, quando afferma che “trattare una persona congiustizia vuol dire prendere seriamente la sua concezionedi sé stessa, i suoi attaccamenti e predilezioni, la suacomprensione della sua situazione e di che tipo dicomportamento le è richiesto in quelle circostanze” e inquelle del filosofo neo-confuciano Li Zhi, quando scriveche: “è da se stessi, non dagli altri, che bisognainnanzitutto esigere l’onestà, lo zelo e l’intrepidezza;queste virtù, quando le possediamo, cessano moltorapidamente di sembrare amabili se pretendiamo troppo
106
dagli altri”. Non basta donare tanto per donare, omettersi al servizio del prossimo in risposta ad uncomplesso di colpa esistenziale che ci attanaglia,facendoci pensare che dobbiamo qualcosa al prossimo ed alcosmo e prima li risarciamo meglio è. In quel caso è comeprendere. Purtroppo, a differenza di Las Casas e di nonmolti altri, diversi “indigenisti” aiutarono i nativi permotivi fondamentalmente egoistici, come ad esempio perrincuorarsi nella certezza di una ricompensa divina, oper ricevere segni tangibili di apprezzamento. Insomma lofecero per migliorare la propria immagine agli occhidegli altri, di se stessi e soprattutto di Dio. Nel farloviolarono sistematicamente il libero arbitrio degliautoctoni e quindi tradirono lo spirito del messaggio diGesù il Cristo. Il Las Casas delle sperimentazioni diingegneria sociale venezuelana rientrava in questacategoria di benefattori compulsivi. L’astuzia di molticonquistatori, imprenditori ed autorità coloniali fuquella di far leva su questo umanitarismo interessato perrealizzare i propri obiettivi, in ultimo distruggendo ilcorpo che li nutriva, come dei parassiti infinitamentevoraci, eternamente insoddisfatti, insaziabilmente acaccia di ricchezze materiali, risorse, potere, controllosul prossimo, incapaci di accettare limiti e diapprezzare il senso della misura. In questo senso ilmondo dei Conquistadores era un mondo di fantasie egrandiosi sogni di successo e ricompense, segnato da unforte desiderio di dominare o di essere dominati che nonpoteva non attirare Sepúlveda. Questi era un uomo che,stando al ritratto di Àngel Losada, che pure è un suoapologeta, fu “dominato dal desiderio di incrementare lesue proprietà” e trascorse la vita impegnato incompravendite di terreni ed immobili. “Non fece altronella sua vita che comprare, vendere, affittare edaccumulare rendite ecclesiastiche” ed ispezionare la suatenuta ed i suoi amati alveari, dall’osservazione deiquali, si può presumere, trasse spunto per le sue
107
teorizzazioni politologiche. Un uomo che, pur di vedersidar ragione, non esitava a millantare credito presso chinon gliene avrebbe dato, al punto che tre ecclesiasticiscrissero a Las Casas per lamentarsi del fatto cheSepúlveda avesse affermato pubblicamente e falsamente cheloro erano dalla sua parte. La stoccata del domenicanonon si fece attendere: “La smetta di nascondere i suoierrori dietro i nomi di così tanti uomini e cominci asostenere la causa di Cristo, come si conviene ad unostudioso”.
La Disputa
Nel 1550, l’anno in cui si svolse il confrontodialettico con Sepúlveda, Las Casas aveva 66 anni. Leopinioni erano divise e il re convocò alla corte diValladolid una giunta di teologi e giuristi per dirimerela questione se sia lecito fare la guerra a popoli le cui“colpe” risalgono a quando erano infedeli. Furonoconvocati i due rivali, in un confronto destinato atrascendere l’oggetto del contendere per cristallizzarenelle due trattazioni i due possibili approcci politicial problema dell’altro, del diverso: quello dellepiramidi oligarchiche e castali e quello democratico,universalista ed egalitario.
Las Casas aveva lasciato il Nuovo Mondo nel 1547 edera determinato a dedicare gli anni che gli rimanevano davivere all’attività di avvocato difensore dell’umanitàamericana. Sebbene per estrazione sociale fosse unpopolano, Las Casas era tutt’altro che un sempliciotto.Gli studi e la passione per l’apprendimento l’avevanoreso un erudito della letteratura teologica-scolastica edel diritto canonico (Parish, 1992). L’esperienza di vitae la pratica della dialettica avevano affinato la suaarte retorica. Fu moderno nel reperire nella matricedell’economia di profitto e rapina le radicidell’ideologia coloniale e nell’insistere che il
108
benessere materiale e la sopravvivenza degli indigenidovevano venire prima di ogni altra cosa, persino dellaconversione. Solo una conversione per amore era valida,mentre il comportamento tirannico e distruttivo degliSpagnoli era “uno scandalo agli occhi di Dio”.
Analizzò la civiltà azteca, quella degli sconfitti,nell’Apologética Historia, composta tra il 1527 ed il 1550,che però rimase inedita per oltre tre secoli. Questa verae propria ricerca etnografica si basava sulle sueesperienze personali, sulla sua estesa corrispondenza esu manoscritti altrui. Lo scopo era quello di dimostrareche gli indiani soddisfacevano tutti i requisitiaristotelici della buona vita. Erano semplicementerimasti isolati dal resto del mondo e non avevano potutofruire della circolazione della conoscenza e dellaverità. In breve avrebbero potuto recuperare il tempoperduto perché facevano parte di un’unica umanità, dotatadelle medesime facoltà. Questo, naturalmente, a patto chenella loro educazione si impiegasse il metodo giusto,fatto di “amore, gentilezza e premura”.
La disputa fu equilibrata. Sepúlveda eccelleva nellacultura classica e nel latino, Las Casas possedeva unafervida eloquenza - invidiabile e da molti invidiata - edun’esperienza sul campo estesissima, maggiore di chiunquealtro, cosa che fece pesare nel dibattito, quando adesempio insinuò che il suo rivale “aveva scritto il suolibretto velocemente e senza soppesare adeguatamente ilmateriale e le circostanze”. Nel corso della disputaSepúlveda si limitò sostanzialmente a riassumere i puntiprincipali della sua posizione “rigidamente ortodossa edaltamente sciovinista” (Pagden, 1989) che,comprensibilmente, non poteva essere elaborataulteriormente in un contesto come quello dellamadrepatria, che in generale non vedeva di buon occhioproclami biodeterministici (la natura come destino) cheponevano limiti alla Divina Provvidenza. Las Casas inveceapprofittò dell’occasione per illustrare la condizione
109
dei nativi e lesse estratti dalla sua apologia perdiversi giorni. Entrambi si autoproclamarono vincitori,ma la commissione non espresse alcun giudizio.
Al centro del conflitto tra i due “colossi” c’era ilprincipio di separazione contrapposto a quello di unità.Sepúlveda riusciva a vedere – o dava mostra di vedere –solo differenze, disparità, gerarchie, identificando inogni diversità la cifra dell’inferiorità ed una confermache gli Spagnoli avevano il diritto-dovere di imporre ilbene. “Sepúlveda crede che non l’eguaglianza, ma lagerarchia sia lo stato naturale della società umana”(Todorov, 1992). Las Casas enfatizzava le analogie, leaffinità e la condivisione paritaria, ossia quei principinutritivi che hanno alimentato la quercia dei diritticivili e dei diritti umani. Secondo Sepúlveda i nativiamerindiani potevano usufruire del diritto alla libertà,ma non nei medesimi termini degli Europei cristiani. Lalibertà dei primi era fortemente attenuata dalla loronatura specifica ed inferiore, ciò che lo induceva aritenere che non si sarebbe mai veramente raggiunta unacondizione di uguaglianza e che quindi la sovranitàspagnola non sarebbe mai stata seriamente messa indiscussione nei secoli a venire.
In pratica, la posizione dell’umanista di Cordoba èl’adattamento più estremo delle speculazioniaristoteliche sulla diversità umana che si potesseaccettare in un contesto giuridico e teologicogeneralmente ostile al concetto di inferiorità eschiavitù naturale, ma tollerante nei confrontidell’aggiogamento dei prigionieri di guerra a fini diconversione e civilizzazione. Un’impostazioneradicalmente anti-cristiana ed anti-umana agli occhi deldomenicano che, nella Brevissima relazione della distruzionedell’Africa, condannava queste pratiche senza mezzi termini:“Come se Dio fosse un violento ed iniquo tiranno egradisse e approvasse, per la parte che gliene offrono,le tirannie”.
110
Sepúlveda diede l’avvio alle sue argomentazioniusando come caso emblematico l’impero azteco, ritenuto laciviltà più sviluppata del Nuovo Mondo. Il comportamentodi Montezuma (Motekwmatzin, in lingua Nahuatl), cheavrebbe potuto schiacciare i pochi invasori ma si limitòa dissuaderli dall’avvicinarsi alla capitale, per poiaccoglierli senza offrire resistenza, è indicato comeprova della codardia, inanità, mancanza di spirito degliAztechi. Nessun aspetto della civiltà era davvero degnodi nota: commercio, edifici, vita sociale erano solonecessità naturali che sorgono automaticamente espontaneamente, senza merito alcuno da parte di chi ne fauso. La loro esistenza dimostrava solo che “non sono orsio scimmie e non sono completamente privi di ragione”.D’altra parte non avevano sapienza, né scrittura earchivi storici, ma solo immagini pittografiche. Nonavevano leggi scritte ma solo usanze e costumi barbari;soprattutto non conoscevano la proprietà privata. Cheavessero accettato questo stato di cose senza ribellarsiconfermava lo spirito meschino e servile di questibarbari che andavano sottomessi per il loro bene. Le loroterre sarebbe state meglio gestite da chi se ne intendevae non commetteva peccati così infamanti; il pontefice nonavrebbe avuto nulla da ridire.
Las Casas rispondeva che il papa non aveva unagiurisdizione punitiva universale e, se l’avesse avuta,questa si sarebbe dovuta estendere fino a includere lafornicazione, il furto e l’omicidio. Inoltre Israele nonsi era mai impadronito delle terre dei vicini perchéerano non credenti o idolatri o perché commettevanopeccati contro natura. Ciò detto, pur domandandosi conquale autorità questo papa assegnava terre che non gliappartenevano e mettendo in discussione la validitàgiuridica dell’espropriazione dei beni indigeni, nonnegava che le cose più imperfette dovessero cedere ilpasso a quelle più perfette quando le incontravano, “comela materia dinnanzi alla forma, il corpo dinnanzi
111
all’anima ed il sentimento dinnanzi alla ragione”, ma nonquando queste caratteristiche appartenevano a soggettidistinti. Perciò la gerarchizzazione nei rapporti tracoloni e soggetti era illegittima: “Nessun popolo liberopuò essere costretto a sottomettersi ad un popolo piùeducato, anche se questa sottomissione dovessedimostrarsi di grande vantaggio per il primo”. Qui LasCasas si rifaceva al principio cardine dello jus gentium,il consenso volontario dei soggetti. Anche lui avevastudiato il suo Aristotele, ma lo usava solo perconfermare le Scritture, non per reinterpretarne ilsenso. Dopo tutto, lo stesso Stagirita non aveva maiindicato chiaramente come distinguere uno schiavo da unuomo libero.
Tra i due esisteva un forte divario etico edesistenziale: uno metteva al centro l’uomo ed i deboli,l’altro il ceto e la nazione (i ricchi e i potenti).Sepúlveda cedeva alla passione per l’economia politica,al limite dell’eresia, con argomentazioni che mal siconciliavano con il diritto canonico e la teologia e checelavano un sostrato pagano e naturalista. Le sue tesierano in contrasto con la missione evangelizzatrice dellaConquista ma non con quella sfruttatrice deiConquistadores. Per questo non erano ben accolte a Corte,mentre erano molto ben viste in America. Per certi versiil pensiero di Sepúlveda fu l’espressione massima dellacoscienza sociale e politica dei conquistatori. Lo jusgentium, che regolava i rapporti tra i popoli, secondo luialtro non era che uno sviluppo del diritto di guerra.Poneva così la violenza e la sopraffazione all’originedel diritto, in diretto conflitto con il NuovoTestamento. Inoltre, insistendo sull’autonomia dellasfera sociale e politica da quella religiosa, sicollocava ad una distanza piuttosto ridotta da Lutero, alquale, oltre venticinque anni prima, aveva rivolto unasevera critica. Sepúlveda dichiarava che si era tenuti asottomettere con le armi, se non fosse stato possibile
112
farlo diversamente, quei popoli che per condizionenaturale dovevano obbedire ad altri e rifiutavano il lorofato. Ogni disuguaglianza era naturale e, in quantonaturale, era tale per decreto divino.
Questo assunto non era però ricevibile dai giuristispagnoli, che da tempo avevano accettato l’idea che lostato di diritto non avrebbe lasciato spazio a rapportidi sfruttamento servile, prediligendo la forma dicontratto sociale tra individui giuridicamente liberi.Per questa ragione il sistema di schiavitù di fatto cheesisteva nelle colonie americane non fu mai sancitogiuridicamente. Come al giorno d’oggi la tortura, illavoro nero e lo sfruttamento della prostituzione, purnon dovendo esistere, la schiavitù esisteva, e nessunopoteva farci nulla. Così si ideò l’istituzione neo-feudale dell’encomienda, fingendo ipocritamente che ciònon fosse in contrasto con lo spirito delle leggidell’impero.
Sepúlveda aveva un’idea ben definita del nuovo ordineche doveva essere costruito nelle Americhe: il dirittodoveva rispecchiare il sistema di potere e le strutturegerarchiche imposte dai vincitori. Il discrimine tracivile e barbaro era la proprietà privata, fino ad allorasconosciuta nel Nuovo Mondo. La Conquista era un’opera dicivilizzazione non tanto perché divulgava le parole diCristo, ma perché esportava il modello capitalista-mercantilista e pedagogico europeo. Un’anticipazionedella retorica del fardello dell’uomo bianco,ufficialmente tollerato in quanto atto caritatevole.
Un governo autonomo e rispettoso dei suoi cittadinispettava esclusivamente ai popoli avanzati, quelliinferiori – privi di sangue cristiano e dominati dallepassioni e dai vizi – necessitavano di governi autoritariche li avviassero su un cammino di rettitudine, anche seciò comportava il disprezzo dell’uomo per l’uomo. I nuovisignori avrebbero agito come strumenti di redenzione erigenerazione, vicari di Dio in terra.
113
Quattro furono le motivazioni addotte per dar contodi questa posizione: (a) la gravità dei delitti degliindiani, soprattutto la loro idolatria e i loro peccaticontro natura; (b) la grossolanità della lorointelligenza, che ne faceva una nazione servile, barbara,destinata ad essere sottomessa all’obbedienza da parte diuomini più avanzati, quali gli spagnoli; (c) le esigenzedella fede, poiché il loro assoggettamento avrebbe resopiù facile e rapida la predicazione; (d) il male che sifacevano tra loro, uccidendo degli uomini innocenti peroffrirli in sacrificio.
La prima giustificazione dell’asservimento degliIndios era formulata come segue: “Così il motivo perporre fine a questi atti criminali e mostruosi e perliberare gli innocenti dalle azioni ingiuriose commessecontro di loro, potrebbe già da solo concedervi ildiritto, peraltro già assegnatovi da Dio e dalla Natura,di sottomettere i barbari al vostro dominio…a ciò siaggiunga l’intento di garantire ai barbari molte coseutili e necessarie…una volta che questi beni siano statiofferti e che le mostruosità che spaventano per la loroempietà, siano state soppresse dallo sforzo, lavoro evalore della nostra gente, e che la religione cristiana ele sue ottime leggi sia stata introdotta, come potrebberoquesti popoli ripagarci di tanta abbondanza, varietà edimmortalità di doni?”.
In questa prospettiva la missione civilizzatricearrecava solo benefici ai colonizzati, che dovevanoessere eternamente grati ai loro nuovi signori.L’autorità di usare la forza traeva origine dallasuperiorità del sistema di valori e forma di governo deicolonizzatori. La civiltà non era il regalo della Spagnaal mondo ma di Dio all’umanità; la Spagna era solo unveicolo della volontà di Dio. Sepúlveda esprimeva concinica franchezza l’idea che l’inferiore è universalmenteresponsabile per la sua condizione. Gli indios obbedivanoall’arbitrio e non si curavano della loro libertà: “Tale
114
comportamento spontaneo e volontario, senza essereoppressi dalla forza delle armi, è un segno evidentedell’animo servile e vile di questi barbari […]. Talierano insomma l’indole e i costumi di questi omuncoli,tanto barbari, incolti e disumani, prima dell’arrivodegli Spagnoli”. Il dovere dei padroni-educatori non eraquello di coltivare la personalità dei singoli, comeunità indipendenti, ma di adattarli minuziosamente allaloro umile funzione di ingranaggi nella megamacchinadell’Impero, in nome di un fine più elevato, il BeneComune, l’Armonia Superiore, la realizzazione dellaVolontà di Dio in terra.
A dispetto delle giustificazioni addotte dai suoisostenitori, la visione sociale di Sepúlveda era inumanae cerebrale, ostile agli Indios nella loro realtàconcreta, perché si prefiggeva degli obiettiviirrealistici, rispetto ai quali non avrebbero mai potutoessere all’altezza. Si indicava la possibilità che lanatura umana indigena, seppur distinta da quella euro-cristiana, potesse essere modellata ed adattata alsistema grazie ad una corretta pedagogia, adun’organizzazione politico-sociale dirigista e a magliestrette e ad una pianificazione preveggente. Ladiffidenza totale nei confronti dell’Altro era alla basedi quest’apologia del Nuovo Ordine.
Leggere le tesi dei sostenitori della Conquistariporta alla mente il tema dell’”accusa del sangue”, cosìben delucidata da Furio Jesi. Gli Indios, come gli Ebrei,erano visti come “una popolazione che, pur mascherandosiipocritamente sotto parvenze di civiltà, era di fatto, eper sua incancellabile natura, diversa come i selvaggierano diversi dagli uomini civili. […]. Negli Ebrei,popolo “sacrificatore ed antropofago” si riconoscevadunque una singolare commistione di civiltà e di naturaselvaggia, di cultura e di impulsi cannibalici”.Ipocritamente ed esteriormente civilizzati, dall’animo“crudo, feroce e sanguinario”, non sono “selvaggi allo
115
stato puro, ma selvaggi mascherati, quelli che nonastuzia e ipocrisia sono riusciti a fingere di esserecivili” (Jesi, 2007).
La distopia del Nuovo Ordine Cristiano doveva essereprotetta dal peccato, dal sincretismo, dall’idolatriamascherata, persino dai più reconditi pensieri deisudditi, appannaggio del peccato, perché troppo iniqui,troppo fragili, troppo vulnerabili rispetto allepassioni. Mentre per Las Casas l’indio era un essereumano come lui, per Sepúlveda l’indio era una risorsa edun ostacolo in un ordine dove tutto doveva essere inperfetta sintonia con la volontà degli encomenderos.L’umanità era svalutata perché incompiuta ed imbarazzantee persino l’elemento spagnolo doveava guardarsi dallacontaminazione che sempre segue il contatto con l’impuro.Non era il cristiano che si macchiava delle più atrociscelleratezze con perfida innocenza, era l’autoctono chegli aveva forzato la mano, con la sua indocilità estoltezza. La coscienza di quest’ultimo andavacolonizzata come si fa con le aree geografiche,denaturata come da indicazioni del Grande Fratelloorwelliano: “Ti spremeremo fino a che tu non siacompletamente svuotato e quindi ti riempiremo di noistessi”.
L’indio doveva essere reso docile, duttile, dovevacapire che la volontà dei suoi signori-tutori eraespressione della forza della necessità,dell’indispensabilità, che si sbagliava se credeva diessere diretto surrettiziamente in una certa direzione:la sua era una scelta libera (sic!) che conseguiva allasua maturazione civile, alla sua debarbarizzazione.Sepúlveda si era costruito una stravagante concezionedell’autonomia e dell’emancipazione. Gli indigenisarebbero stati pronti all’autodeterminazione quandofossero stati in grado di agire nel senso voluto da chili aveva educati, dai suoi demiurghi-pedagoghi. Questosistema, in cui si era pienamente liberi se ci si
116
inchinava, se si dimostrava la propria innocenza, in cuii signori si riservavano il privilegio di far sentireliberi e uguali i servitori a loro piena discrezione, eraun simulacro di libertà, una burla estremamente dolorosaper chi se ne avvedeva.
È stupefacente osservare come le prescrizioni di“ingegneria comportamentale” di Sepúlveda coincidanotalora con quelle della pedagogia di Gor'kij – “Solonella sofferenza l’anima umana è bella” – e Makarenko –“La crudeltà è la più alta forma di umanesimo perchécostringe l’individuo a cambiare anche controvoglia”. Maè ancora più sorprendente constatare la somiglianza conil Grande Inquisitore sivigliano di Ivan Karamazov.Sepúlveda esortava gli Spagnoli a “sradicare le turpinefandezze e il grave crimine di divorare carne umana,crimini che offendono la natura, così come continuare arendere culto ai demoni piuttosto che a Dio […] e salvareda gravi ingiustizie molti innocenti che questi barbariimmolavano tutti gli anni”. Dio era con loro e nessunoavrebbe potuto arrestare la loro opera redentrice, poiché“per molte cose e molto gravi, questi barbari sonoobbligati a riconoscere il dominio degli spagnoli […] ese rifiutano il nostro dominio potrebbero essereobbligati con le armi ad accettarlo, e questa guerra, conl’autorità di grandi filosofi e teologi, sarà una guerragiusta per legge naturale”. L’uso della violenza e dellaguerra giusta era giustificato anche dalla parabolaevangelica (Lc 15,15-24) di quel signore che, dopo averinvitato molti a nozze, alla fine obbliga i poveri apartecipare al banchetto. L’umanista si richiamavaall’interpretazione di Sant’Agostino il quale,riferendosi ai primi, osservava che li si invita adentrare, mentre i poveri sono obbligati. “Questi,barbari, quindi, che violano la natura, sono blasfemi edidolatri, perciò sostengo che non solo li si puòinvitare, ma anche obbligare (compellere), costringereaffinché, ricevendo l’imposizione del potere dei
117
cristiani, ascoltino gli apostoli che annunciano loro ilVangelo”. Questo argomento conseguiva alla tesi centraledel Democrates Alter: si poteva ottenere più in un mese conuna conquista che in un secolo di predicazione. Nonservivano miracoli, perché i mezzi umani che godevano disanzione divina ottenevano gli stessi risultati. Laguerra era insomma necessaria e giusta e se si insegnavaai nativi senza terrorizzarli, questi sarebbero rimastitestardamente aggrappati alle loro tradizioni secolari.Nulla di strano che il domenicano Melchor Cano,subentrato a de Vitoria, trovasse in quest’opera passaggiche suonavano “offensivi per le orecchie pie”. Sepúlvedasembrava affascinato dai vincoli di servitù (vinculumserviendi) e dal patriarcalismo che compenetrano l’AnticoTestamento. Non amava la libertà e forse non la capiva.La nozione di giustizia parimenti gli sfuggiva.
Secondo Carlo Maria Martini “la giustizia èl’attributo fondamentale di Dio. Nel giudizio universaleGesù formula come criterio di distinzione tra il bene eil male la giustizia, l’impegno a favore dei piccoli,degli affamati, degli ignudi, dei carcerati, degliinfermi. Il giusto lotta contro le disuguaglianzesociali”. Se questo è vero, Dio non era con Sepúlvedaquando, rifacendosi alle ingiunzioni divine contenute nelDeuteronomio, affermava che la Spagna era autorizzata amuovere guerra a qualunque nazione di religione diversa.Non gli era accanto nemmeno quando, sempre nel DemocratesAlter, dichiarava che “il fatto che qualcuno di loro abbiaun’intelligenza per certe cose meccaniche non significache abbiano una maggiore saviezza, perché vediamo comecerti animali come le api e i ragni facciano cose chenessuna mente umana potrebbe ideare”. È cristiano ilmondo visto come un intero ordinato in cui l’ordine èstrettamente gerarchico e opera meccanicamente, in cui ilvalore della natura e dell’umanità inferiore corrispondeal suo valore d’uso, in cui l’obiettivo dei dominatori è
118
ottenere il libero consenso delle vittime al lorosupplizio, in modo da potersi scagionare preventivamente?
Per fortuna l’antagonista di Sepúlveda sapeva ilfatto suo. Nella sua difesa Las Casas si avvalse dellasua Apología e della Apologetica História Sumária, la sua operapiù antropologica, completata dopo il 1551. Intendevaguadagnarsi un pubblico più ampio, non solo gli espertidella commissione, e voleva altresì dimostrare al piùvasto numero di persone possibili che gli indiani eranomembri di pari dignità della comunità umana e che le lorosocietà erano sostanzialmente mature e civili, a dispettodella diversità di tradizioni e costumi. Volevacorroborare la tesi che “dietro le evidenti differenzeculturali tra i popoli umani esisteva un medesimosostrato di imperativi sociali e morali” (Pagden, 1989).Guardate alle cose che abbiamo in comune, non a quelloche ci divide! Ammirate le splendite città azteche einca! Nel confronto con Greci e Romani gli Aztechivincevano a livello tecnologico, architettonico,artigianale ed artistico; specialmente nell’usodecorativo delle piume, con le quali riuscivano acomporre ritratti e rappresentazioni che potevanocompetere con l’arte rinascimentale e per di piùcangiavano i colori a seconda della prospettivadell’osservatore. “Non abbiamo alcuna ragione dimeravigliarci dei difetti, delle usanze non civili esregolate che possiamo riscontrare presso le nazioniindiane, né abbiamo ragione di disprezzarle per questo.Infatti, tutte o la maggior parte delle nazioni del mondofurono molto più pervertite, irrazionali e depravate, efecero mostra di molto minor prudenza e sagacia nel loromodo di governarsi e di esercitare le virtù morali. Noistessi fummo molto peggiori al tempo dei nostri antenatie su tutta l’estensione del nostro territorio, sia perl’irrazionalità e la confusione dei costumi, sia per ivizi e le usanze bestiali” (Apologetica História). Per non
119
parlare della loro modestia e mitezza. Quanto alsacrificio umano, sicuramente i sacrifici indigenireclamavano meno vittime della Conquista: “Non è veroaffermare che nella Nuova Spagna si sacrificavano ognianno ventimila persone, né cento, né cinquanta, perché,se così fosse, non troveremmo tante infinite genti comene troviamo. Tale affermazione altro non è che la vocedei tiranni, per scusare e giustificare le loroarbitrarie violenze e per opprimere, depredare etiranneggiare gli indios... E questo pretendono coloroche dicono di essere dalla loro parte, come il dottore ei suoi seguaci…Il dottore ha contato malissimo, perchépossiamo con maggiore verità e meglio dire che gliSpagnoli hanno sacrificato alla loro dea amatissima eadorata, la cupidigia, ogni anno della loro permanenzanelle Indie una volta entrati in ogni provincia, piùanime di quante in cent’anni gli indios in tutte le Indiene avessero sacrificato ai loro dei”.
Inoltre gli indigeni non avevano avuto sentore dialcuna alternativa prima dell’arrivo degli Spagnoli:“Tanto coloro che volontariamente permettono di esseresacrificati, come i semplici uomini del popolo ingenerale, quanto i ministri che li sacrificano agli dèiper ordine dei principi e dei sacerdoti, agiscono sottogli effetti di una ignoranza invincibile, e il loroerrore dev’essere perdonato anche se arrivassimo asupporre l’esistenza di un giudice competente che possapunire tali peccati” (Apología). Non erano dunque incattiva fede e, finché i cristiani non fossero riusciti adimostrare coi fatti che la loro religione era ispiratada Dio, “essi sono senza dubbio tenuti a difendere ilculto dei loro dèi e la loro religione, e ad uscire conle loro forze armate contro chiunque cerchi di privarlidi tale culto o religione, o di recare loro offesa oimpedirne i sacrifici; contro di essi sono così tenuti alottare, a ucciderli, catturarli ed esercitare tutti queidiritti che sono corollario di una giusta guerra, in
120
accordo con il diritto delle genti” (ibid.). Mai si eraudita una tesi così ardita, che ritorce i principi dellascolastica contro chi li impiegava per giustificarel’imperialismo. Angél Losada, nell’introduzioneall’Apología, ha così riassunto l’innovativainterpretazione lascasiana del tomismo: “se i cristianifanno uso di mezzi violenti per imporre la loro volontàagli indios, è meglio che questi rimangano nella lororeligione tradizionale; anzi, in tal caso sono gli indiospagani a trovarsi sulla buona strada, e da loro devonoimparare i cristiani che si comportano così”.
Questo argomento si riaggancia alla strategia diconfrontare civiltà americane e civiltà classiche. Qualesocietà non ha praticato sacrifici nel suo passato? Nonfacevano sacrifici umani anche gli Spagnoli, i Greci e iRomani? In seguito però erano diventati popoli civili. Lostesso Abramo aveva offerto in sacrificio suo figlio aDio. Eppure non riteniamo questi popoli depravati madevoti, sebbene non ancora illuminati dalla Grazia. Untempo il sacrificio era importante per venerare Dio.Arrivavano persino a sacrificare se stessi per Dio: unadevozione più appassionata di questa non la si puòimmaginare! Las Casas, esibendo un’impressionante edanticipatrice capacità di distacco relativisticodall’oggetto della sua analisi comparativa, completava ilragionamento facendo rilevare che il sacrificio umano nonera in contrasto con la ragione naturale, era piuttostoun errore intrinseco della ragione naturale. Gliindoamericani non erano umani difettosi. Originariamente,a suo giudizio, erano monoteisti, come dimostrano i mitidel dio creatore e civilizzatore diffusi in tutte leAmeriche. Fu soltanto in seguito che l’isolamento liaveva esposti all’azione subdola e corruttrice deldemonio, spingendoli verso il politeismo. Ora li sidovevano aiutare a rinunciare ai sacrifici con la forzadelle argomentazioni e mostrando esempi di alternativemigliori, non con quella delle armi. “Se questi sacrifici
121
offendono Dio spetta a Dio punirli, non certo a noi”. Nonera stato forse San Paolo, nella Prima lettera aiCorinzi, a chiarire una volta per tutte questo punto?“Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sonoquelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori ligiudicherà Dio”. La Chiesa doveva forse oltraggiare Dioergendosi a giudice degli esseri umani quando lo stessoGesù il Cristo, stando a Luca (12, 13), aveva obiettato:“O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopradi voi?”. Infatti, sempre rifacendosi al NuovoTestamento, “Cristo non è venuto per giudicare il mondo,ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui” (Giovanni3, 17).
Gli Indios dovevano essere messi nelle condizioni diaccettare sinceramente e liberamente la cristianità, nonindotti a farlo slealmente o coercitivamente. Lapedagogia azteca insegnava ai figli ad essere ordinati,sensibili, prudenti e razionali: non certo il segno diuna società che non avrebbe saputo autogovernarsi.L’unico tratto barbaro era l’ignoranza delle Scritture,ma a questo si poteva presto porre rimedio. A questopunto la trattazione si fece allegorica. Le variemanifestazioni dell’umano che s’incontravano nel mondoerano eterogenee. Alcune assomigliavano a dei campi noncoltivati. E proprio come un campo abbandonato producevasolo spine e cardi ma, se coltivato, dava frutti, cosìogni essere umano, per quanto apparentemente barbaro eselvaggio, era dotato dell’uso della ragione e potevaapprendere e generare i frutti dell’eccellenza.
Al richiamo alle terribili punizioni divine descrittenel Vecchio Testamento, replicò che esse andavanocontemplate con meraviglia, non imitate. Quanto allarozzezza degli Indiani, egli poteva produrre innumerevoliprove a sostegno della tesi inversa. Alla questione dellamaggiore rapidità delle conversioni dopo una conquista,si poteva obiettare portando ad esempio l’opera deimissionari domenicani. La quarta tesi, quella del male
122
minore – una guerra causa meno morti dei sacrifici dimassa –, fu contrastata appellandosi al comandamento “nonuccidere”, più efficace dell’imperativo di “difendere gliinnocenti”, specialmente se ciò comportava una guerraindiscriminata che non poteva che far detestare la verafede agli indigeni. “Quando io parlo della forza dellearmi, parlo del peggiore di tutti i mali”.
Sui soldati della Conquista Las Casas erairremovibile: “Essendo stati educati all’insegnamento diCristo, non possono ignorare che non si deve arrecaredanno alle persone innocenti. Chi manca di questodiscernimento è reo di un gravissimo crimine verso Dio edè degno di una condanna eterna”. Las Casas accettava checi potessero essere danni collaterali a cose e persone,ma ribadiva che l’uso della forza non doveva avere unobiettivo preventivo ed offensivo. Neppure la liberazionedi innocenti poteva giustificare la messa a rischiodell’incolumità di un gran numero di altri innocenti. Perquesto precisava che, “sebbene sia vero che uccidere untiranno, che è una pestilenza per la repubblica, èun’azione buona e meritoria, lo stesso non si può direnel caso in cui il suo assassinio dia origine ad unaribellione o grave tumulto che raddoppi i mali dellasuddetta repubblica”. L’intero ragionamento di Sepúlvedaera contraddittorio e avrebbe arrecato infiniti dannialla causa dell’evangelizzazione: “Come potranno amarciqueste persone, e fare amicizia con noi (condizionenecessaria affinché possano ricevere la nostra fede) se ifigli si vedono orfani delle proprie madri, le mogliperdono i mariti, i padri perdono i loro figli ed amici;se vedono i loro cari feriti, tenuti prigionieri,spogliati delle loro proprietà e l’innumerevolemoltitudine di cui facevano parte ridotta ad uno sparutogruppo?”.
Nel Nuovo Testamento non si potevano trovare appigliche permettessero di sostenere una simile bestialità:“Citi dunque Sepúlveda un solo passaggio in cui il Cristo
123
o i Santi Padri ci abbiano insegnato che i pagani debbonoessere soggiogati mediante la guerra prima che gli sipredichi il vangelo!”. Non sarebbe stato possibile,infatti, “quando Cristo mandò i suoi discepoli apredicare, non li armò certo con spade e bombarde”. Se ilsacrificio era l’unico modo conosciuto dai nativi peronorare Dio, non si poteva impiegarlo come pretesto perassoggettarli. D’altronde anche i Romani li compivano, maquando fondarono l’impero non punirono i popoli dediti aisacrifici, si limitarono a proibirli per decreto.Volgendo poi l’attenzione a Luca 14,15, dove il compelleintrare, interpretato da Agostino come un’esortazione acostringere ad entrare nell’ovile della Chiesa, sembravaportare acqua al mulino di chi gradiva l’uso dellemaniere forti, Las Casas ribatteva che la costrizionedoveva essere di origine interiore, come confermatodall’analisi della medesima parabola effettuata daTommaso d’Aquino, che parlava di “efficace persuasione”.Imporre il vangelo con le armi era solo un pretesto perdepredare i nativi: “Che temano Dio, vendicatore dellamacchinazioni perverse, quelli che, con il pretesto dipropagare la fede, con la forza delle armi invadono leproprietà altrui, le saccheggiano e se ne appropriano”.Il processo di conversione poteva solo funzionare se sifosse usato Cristo ed il suo messaggio come modello.L’uso della violenza coattiva nel nome della veritàassoluta poteva solo smascherare la natura perversa dichi proclamava di rappresentarlo. Citava sant’Ambrogio:“Quando gli apostoli vollero chiedere il fuoco dal cielo,perché bruciasse i samaritani che non avevano volutoricevere Gesù nella loro città, egli, voltatosi, inveìdicendo loro: non conoscete lo spirito al qualeappartenete, il figlio dell’uomo non viene per mandare inrovina le anime, ma per salvarle”.
Inoltre, una volta che il vaso di Pandora dellaviolenza fosse stato scoperchiato, quest’ultima avrebbefinito per ritorcersi contro i suoi perpetratori, in
124
forza della giusta punizione divina. Ancora piùincisivamente, cercando la stoccata decisiva: “Il dottorefonda questi diritti [del re di Spagna sul Nuovo Mondo]sulla superiorità delle armi e sulla maggiore forzafisica. Questo serve solo a porre i nostri sovrani nellaposizione di tiranni. Il loro diritto si basasull’estensione del Verbo nel Nuovo Mondo e sulla lorobuona amministrazione delle Indie. Negare questa dottrinasignifica adulare ed ingannare i nostri monarchi emettere in pericolo la loro stessa salvezza. Il dottoreperverte il naturale ordine delle cose, trasformando imezzi in fini e ciò che è secondario in fondamentale. Èsecondario il vantaggio temporale, è fondamentale lapredicazione della vera fede. Chi ignora questo ha unaconoscenza ben limitata e chi lo nega non è più cristianodi Maometto”.
In verità, purtroppo, Las Casas era abbastanzaisolato in questa sua presa di posizione in Spagna. Lostesso Soto, che ricapitolava brillantemente leargomentazioni dei duellanti ebbe a dire: “sembra che ilsignor vescovo – se non mi sbaglio io – sia caduto in unerrore, perché una cosa è che li possiamo costringere alasciarci predicare, il che è opinione di molti dottori,altra cosa che li possiamo obbligare ad assistere allenostre prediche, il che non è altrettanto chiaro”. Inaltre parole la forza non poteva essere usata percostringere alla conversione ma era legittima se venivanoposti ostacoli all’evangelizzazione, in virtù dello jusdefendi nos, che ci riporta alla bizzarra nozione che gliSpagnoli, se in buona fede, erano automaticamente dallaparte giusta, di chi difendeva se stesso e il Cristodalle ingiurie e gli assalti dei non-credenti.
L’umanista di Cordoba vide che il domenicano si erascoperto ed assestò un fendente: “per l’opinione secondocui gli infedeli non possono essere giustamente forzatiad ascoltare la predicazione, si tratta di una dottrinanuova e falsa, e contraria a tutti coloro che nutrirono
125
una diversa opinione. Il Papa infatti ha il potere – anziil comando – di predicare egli stesso e per mezzo dialtri il Vangelo in tutto il mondo, e questo non si puòfare se i predicatori non vengono ascoltati; perciò egliha il potere, per mandato di Cristo, di costringere adascoltarli”. Gustavo Gutiérrez (Gutiérrez 1995) parlamolto a proposito di “teologia elaborata nellaprospettiva del potere”.
Las Casas era assolutamente persuaso che si dovessescongiurare il “pericolo del cancro velenoso” che ilcontraddittore voleva diffondere. “Che uomo di sanointelletto – si chiedeva, esagerando retoricamente levirtù dei suoi protetti – approverebbe una guerra controuomini che sono innocui, ignoranti, gentili, temperati,disarmati e privi di ogni difesa?”. Insisteva, poi,riportando il discorso nei binari del buon senso:“Sarebbe impossibile trovare nel mondo un’intera razza,nazione o regione che è così tonta, imbecille, scelleratao comunque priva in gran parte di un livello sufficientedi conoscenza e capacità naturale da non sapersigovernare autonomamente”.
Sepúlveda, lo abbiamo visto, non era dello stessoavviso: “In buon senso, talento, virtù ed umanità sonotanto inferiori agli Spagnoli quanto i bambini lo sononei confronti degli adulti…come le scimmie lo sono aconfronto degli uomini” [Bien puedes comprender ¡Oh Leopoldo! sees que conoces las costumbres y naturaleza de una y otra gente, que conperfecto derecho los españoles imperan sobre estos bárbaros del NuevoMundo e islas adyacentes, los cuales en prudencia, ingenio, virtud yhumanidad son tan inferiores a los españoles como los niños a los adultos ylas mujeres a los varones, habiendo entre ellos tanta diferencia como la queva de gentes fieras y crueles a gentes clementísimas, de los prodigiosamenteintemperantes a los continentes y templados, y estoy por decir que de monosa hombres, “Demócrates segundo”, 305].
Las Casas metteva in dubbio la competenza del rivale:“Non è andato a rileggersi le scritture con diligenza, osicuramente non ha compreso a sufficienza come applicarle
126
perché, in quest’epoca di grazia e carità, cerca diapplicare i rigidi precetti della Vecchia Legge che eranostati dati in circostanze speciali e quindi apre la portaa tiranni e saccheggiatori, a crudeli invasioni,oppressioni, violazioni e il crudo asservimento dinazioni inoffensive”. In pratica, non aveva senso credereche fosse giusto fare agli Indios quel che Dio avevacomandato agli Ebrei di fare agli egiziani e cananiti.
Sepúlveda era d’accordo sul fatto che la missioneprincipale era convertire gli indiani ma, in linea con lospirito del Requerimiento, ribadiva che la conquistamilitare avrebbe facilitato questo compito. Gli indianisi meritavano tutto quello che gli era franato addossoperché erano culturalmente e moralmente barbari, laciviltà europea era superiore e ad essa dovevanosottomettersi per il loro bene. Si rifaceva non solo allanozione aristotelica di schiavitù naturale ma anche alladefinizione agostiniana di schiavitù come punizione per ipropri peccati. L’idolatria, i sacrifici umani ed ilcannibalismo erano colpe evidenti e prove della giustezzadella sua posizione. Esisteva un diritto (legitimus titulus)di intervento bellico in difesa degli innocentes, cioèdelle vittime di sacrifici, antropofagia, tirannia deisovrani indigeni e delle loro leggi, aberranti normereligiose dei popoli indigeni, ecc. Le stesse ragioni chelegittimano le “guerre umanitarie” contemporanee.
Sepúlveda era schiettamente ma elegantementerazzista, ed in perfetta buona fede, poiché la sua menteera dogmatica, ideologica. La ricezione negativa dellasua opera in Spagna era in parte dovuta anche al fattoche aveva scelto la forma espositiva del dialogo, inluogo della trattazione classica. Il dialogo avevaenfatizzato le differenze tra conquistatori e indigenifino a renderle caricaturali, indebolendo così la cogenzadelle argomentazioni. Per lui i nativi sarebbero anchepotuti diventare amici dei nuovi dominatori, ma non primadi essere stati soggiogati. Mentre i loro talenti
127
avrebbero potuto gradualmente sorpassare quelli dellescimmie e degli orsi, i loro limiti mentali fisiologiciavrebbero impedito loro per lungo tempo di trascendere“le capacità delle api e dei ragni”. A suo avviso lamaggior parte degli indiani non era pienamente umana,mostrava solo una parvenza di umanità. Lo dimostrava ladiscrepanza tra il coraggio, la magnanimità e le virtùcivili degli Spagnoli e la natura selvaggia dei nativiamericani, che rifiutavano le norme e usanze della vitacivile. Si valutino i temperamenti dei rispettivi leader,esclamava ancora una volta: Hernan Cortés era nobile ecoraggioso, Montezuma era un codardo. Per questo gliSpagnoli erano moralmente e politicamente giustificatinelle loro pretese di dominio assoluto.
Vitoria aveva sostenuto che il livello di maturitàcivile e morale di alcune delle culture native era pari aquello dei contadini europei e che era la cultura cheaveva causato la divergenza nei percorsi di sviluppo, nonuna naturale condizione di schiavi. Sepúlvedasottoscriveva questa prospettiva, ma naturalizzava lacultura. Non poteva esserci un vero margine di sviluppoumano attraverso un processo civilizzatore che noncomportasse l’estirpamento delle culture locali. Chi nonvoleva capirlo si faceva partecipe di una farsa ipocrita.
Al che Las Casas non poteva esimersi dal chiedersiquando gli indigeni cristianizzati a milioni sarebberostati giudicati degni di vivere da uomini e donne libere?Non arrivò al punto di affermare che dovevano esserelasciati completamente in pace, perché era pur sempre unevangelizzatore, ma ribadì che la tolleranza era unaprecondizione della conversione, mentre per Sepúlveda lenecessità del realismo politico e della dottrinacristiana non lasciavano spazio alla tolleranza che, almassimo, poteva seguire la conversione completa. Purammettendo che c’erano state violenze ed atrocità, egliriteneva che il fine giustificasse i mezzi quando invece,come abbiamo visto, Las Casas ammoniva che tradurre i
128
mezzi in fini ed i fini in mezzi era una disastrosafallacia logica e morale.
La commissione che valutò la disputa, composta dagiuristi e studiosi della scuola di Salamanca e delConsiglio di Castiglia e delle Indie non possedeva alcunpotere formale o legale oltre quello di offrireconsulenza al monarca. I due non si incontrarono mainella stessa stanza. Questo consiglio non lasciò alcundocumento pubblico in cui fossero registrate le loropreferenze. Alcuni non erano stati convinti da Sepúlvedama nessuno si pronunciò a favore di Las Casas. In effettila giunta non si pronunciò a favore di nessuno dei duecontendenti, ma la monarchia decise che il trattato diSepúlveda De justis belli causis era troppo pericoloso e lobandì dal Nuovo Mondo.
L’autore, piccato, accusò il suo avversario dioscurare la verità e la giustizia con un’eloquenza, unacircospezione ed una perizia che “a confronto l’Ulisse diOmero era inerte e balbettante”. Gli addebitò laresponsabilità di aver provocato “un grande scandalo edinfamia contro i nostri sovrani”. Nella sua apologia LasCasas rispose che il suo rivale aveva “diffamato questipopoli di fronte al mondo intero”.
Il grande cardinale tedesco Josef Höffner,coltissimo, anti-nazista e “Giusto tra le Nazioni”, ungiorno scrisse che “tra gli Spagnoli, fu il nobile LasCasas che comprese più profondamente lo spirito delVangelo di Cristo”.
La dignità umana
Gli Indios sono nostri fratelli e il Cristo ha donato la sua vita per loro. Perchéli perseguitiamo con una crudeltà inumana, senza che ci abbiano fatto nullaper meritare un trattamento del genere?Bartolomé de Las Casas
129
È importante riconoscere che la prosecuzione della vita umana fisica non è diper sé il principio primo e assoluto. Sopra di esso sta quello della dignitàumana, dignità che nella visione cristiana e di molte religioni comporta unaapertura alla vita eterna che Dio promette all’uomo. Possiamo dire che staqui la definitiva dignità della persona… La vita fisica va dunque rispettata edifesa, ma non è il valore supremo e assoluto.Carlo Maria Martini
Nelle loro rispettive Relectiones, Vitoria e Sotosintetizzarono efficacemente quali erano gli interessi ele questioni al centro della Disputa, cioè cosa c’era inballo: “Con quale diritto gli indios sono statiassoggettati al dominio spagnolo”, “quale sia la potestàtemporale e civile dei reali di Spagna sugli indios” e“se sia giusto che un uomo possa essere signore di unaltro uomo”.
Sono vertenze che hanno accompagnato l’intera storiadella maturazione politica e civile dell’umanità.L’universalismo che sostiene la moderna teoria deidiritti umani risale all’ideale greco di paideia, a quellocosmopolita degli Stoici, all’umanitarismo “giudeo-cristiano”, all’antropocentrismo umanista delRinascimento ed alla nozione di individualità democraticache cominciò ad affermarsi con l’Illuminismo. Un camminoprogressivo che ha incontrato innumerevoli ostacoli.Sappiamo che i nazisti assegnavano valori diversi allepersone e sulla base di questo criterio arbitrario leamavano o odiavano, lavoravano per la loroschiavizzazione, eliminazione o integrazione nella razzaariana. Chi assegna un valore arbitrario alle personefinisce per amare solo quelli che fanno di tutto percompiacerlo e per detestare quelli che non la pensanocome lui. La ricetta perfetta per un disastro. QuegliIndios che resistevano furono macellati e torturati. Undestino inevitabile, questo, secondo Sepúlveda, che nelDemocrates Alter giustificava la guerra contro quelli “lacui condizione naturale richiede che debbano obbedire ad
130
altri, qualora rifiutino tale imperio e non rimanga altravia”. Di contro Las Casas contribuì a formare i rudimentidella teoria dei diritti umani universali, che traeorigine dalle nozioni di dignità metafisica dell’essereumano e di unitarietà della specie umana; questetrascendono criteri quantitativi, qualitativi e somatici,per riaffermare il valore incontestabile ed assolutodell’umano prototipico, ideale, che va al di là dellepreferenze soggettive.
La lungimiranza e genialità di Las Casas in questocampo è testimoniata dal cosiddetto Piano Las Casas-Cisneros, ideato nel 1516 per salvare le comunitàindigene caraibiche trasferendole dalle encomiendas avillaggi autonomi (corregimientos), ma mai portato acompimento per la morte del cardinal Francisco Jiménez deCisneros, che peraltro non godeva dei favori del nuovoimperatore, Carlo V, giunto in Spagna dalle Fiandre nel1517. Questo programma sanciva la validità di quasi tuttiquei principi che, dopo diversi secoli, sarebbero servitia tracciare le linee guida della dottrina dei dirittiumani: la razionalità degli Indoamericani; il dirittoalla vita ed all’integrità fisica; il diritto allasicurezza personale; il diritto alla dignità; il dirittoalla tutela della propria cultura; il diritto diassociazione ed il diritto di parola e di consultazionein faccende che rigurdano la propria condizionegiuridica. Principi che non necessitano di alcunadimostrazione, come sancito nella Dichiarazioned’Indipendenza Americana del 4 luglio del 1776: “Noiconsideriamo come autoevidenti queste verità, ossia chetutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sonostati dotati dal loro Creatore di sicuri dirittiinalienabili, e che tra questi sono la vita, la libertàed il perseguimento della felicità”. Con la stessaconvinzione, nell’Historia, Las Casas dichiarava: “Tutte lenazioni del mondo sono uomini, e di tutti gli uomini e diciascuno di essi una sola è la definizione, ed essa è che
131
sono razionali: tutti hanno comprensione e volontà e illoro libero arbitrio, essendo formati a immagine esomiglianza di Dio; tutti gli uomini hanno i loro cinquesensi esterni e i loro quattro interni, e ciascuno diessi si muove secondo il suo oggetto; tutti hanno iprincipî naturali o semi per intendere e per apprendere esapere le scienze e le cose che non sanno, e questo nonsoltanto in quelli di buona inclinazione, ma si trovanoanche in quelli che per costumi depravati sono malvagi,tutti si rallegrano del bene e sentono piacere di ciò cheè gustoso e allegro e tutti respingono e aborrono il malee si irritano dello sgradevole e di ciò che nuoce loro”.
Il merito di Las Casas e di altri teologi versatinella teoria politica e giuridica fu quello di capire chenon si poteva fondare un giudizio di valore su un valoreche non sia ultimo, non ulteriormente fondabile e quindioggettivo, pena la creazione di una concatenazioneinfinita, e che questo valore non poteva essereun’interpretazione arbitraria della volontà di Dio o diquella papale. Prima di tutto c’era l’umano, che siautofondava. Le dottrine totalitarie come quella deiConquistadores sono antiumanistiche perché, a differenzadella filosofia umanistica, considerano superabile lapersona umana. Al contrario, secondo Las Casas ed igiuristi di Salamanca, l’uomo non rientrava nellacategoria di ciò che è sottoponibile alla potestà ofacoltà di appropriazione per l’uso di qualcun altro.L’intuizione fondamentale e non razionalizzabile era chela persona non ha un valore in base a quello che ha o chefa, ma possiede una dignità assoluta ed è per questomeritevole del nostro assoluto rispetto. La vita umana èsacra perché ciascuno ha un valore pari alla somma ditutte le vite umane, passate, presenti e future. Questadignità non deriva esclusivamente da uno statusprivilegiato nell’universo. Sussisterebbe ugualmente inquanto la vita umana è una creazione di chi la vive.L’umanità adatta ciò che la circonda, non vice versa,
132
come è invece il caso degli altri animali. Per questo LasCasas, come altri grandi credenti della storia, assegnavaun’importanza monumentale alla libertà, inclusa lalibertà di culto. Egli aveva compreso che i due tipi didignità, quella fondata sull’universalmente comune (ladignità umana, quella dell’essere umano) e quella chenasce dall’universalmente differente (la dignità dellapersona), s’incontrano, si congiungono e si coniugano nellibero arbitrio.
In questo senso la teoria umanistica dei dirittipresuppone una dottrina della dignità umana, della suapreziosità e sacralità che non può essere facilmentedissociata dalla credenza in Dio o almeno da una visionedel mondo spirituale/religiosa in un senso profondamentemetafisico. Il diritto ha sempre ammesso che la personapossa non essere autonoma, ma ha riconosciuto capacitàgiuridica, cioè titolarità di diritti, ai minori ed aiminorati che pure hanno una ridotta capacità di agire. Ladignità rimane intatta, perché essere persona è qualcosadi più profondo e comprensivo dell’essere autonomi. Lalezione di Las Casas e dei Salmantini è che la condizionedell’umano non può essere ridotta o degradata a quelladegli animali irruenti, delle macchine, dellecose/strumenti o di bambini indocili o di malati croniciin costante bisogno di assistenza, come volevano farcredere Sepúlveda e quelli come lui. La nostra dignitàderiva in parte anche dalla nostra capacità di esserecreativi ed audaci nell’uso della nostra libertàd’azione, di pensiero e artistica, di essere responsabilidi noi stessi e di essere un proprio progetto e non unmanufatto o la creatura di qualcun altro. Questo, per LasCasas, era il dato di partenza e non ritenne mai didoversi sfiancare in un tentativo di difenderloanaliticamente. La sua esperienza personale era più chesufficiente. L’umanità è partecipe di una medesimacondizione e non esiste una migliore incarnazionedell’umano rispetto alle altre. Di qui la sua tolleranza
133
– se gli uomini sono essenzialmente uguali è possibileammettere che possano continuare ad esseresuperficialmente diversi – e di qui la sua perentoriadichiarazione in una lettera al principe Filippo, datata1544, che “Le leggi e le regole naturali e i dirittidegli uomini sono uguali in tutte le nazioni, cristiane egentili, qualunque sia la loro setta, legge, stato,colore e condizione, senza alcuna differenza”.
Quando gli esseri umani non sono oggetto di abusi edegrado hanno sempre dimostrato di meritarsi rispetto,comprensione e affetto. Nella sua Fondazione della metafisica deicostumi (1785), Immanuel Kant distinguerà tra esserirazionali e cose. Secondo Kant tutto ha un prezzo oppureuna dignità. Le cose hanno un prezzo, un valoreequivalente di qualche genere e possono essere scambiati.Gli esseri con dignità non hanno prezzo e non possonoessere scambiati. Per Kant l’uomo non può disporre di séstesso perché non può essere nello stesso tempo persona ecosa, proprietario e proprietà, perché questa sarebbeun’insanabile contraddizione; ne conseguirebbe la suamercificazione e la liceità giuridica della schiavitù. Diqui l’imperativo kantiano: “Agisci in modo da trattarel’umanità sia nella tua persona che nella persona di ognialtro sempre nello stesso tempo come un fine, e maisemplicemente come un mezzo”. Ebbene Las Casas, più didue secoli prima, aveva compreso questa verità, che èfrutto di un’intuizione morale che ha quasi certamentepercorso l’intera traiettoria esistenziale dell’HomoSapiens, non essendo una mera conseguenza logica di unfreddo calcolo razionale. Quando Las Casas affermava chela sua libertà è la medesima di quella degli indigeni,intendeva anche dire che se questi ultimi non sono esseriumani come lui, cioè se non sono persone di pari dignità,allora proprio non esistono delle persone e si devenegare l’idea di umanità. Anche i più deboli, malati,morenti, mentalmente carenti, ignoranti rimangono personeper la legge come per quel senso comune che ancora tanto
134
comune non era e tornerà a non esserlo nel tragicoventesimo secolo. Las Casas si rifiutava di descrivere ilvalore della vita umana come una convenzione legata aduna nozione soggettiva di legge naturale e di naturaumana, perciò inapplicabile nel caso degli indigeni che,non essendo pienamente umani, non erano “coperti” daessa. Questo tipo di logica era semplicemente contrarioalla sua e ad ogni esperienza umana di che cosa abbiavalore. Il valore della sua e dell’altrui vita eraintrinseco, senza altre qualifiche. Ciò che era dovuto alui per il semplice fatto di essere umano era dovutoanche agli Indios. La Sublimis Dei non lasciava dubbi inmateria quando enunciava: “Considerando gli stessiindiani come i veri uomini che sono”. In un certo senso,la religione cristiana di Las Casas era, come quelladelle origini, un’autentica religione dell’umanità, labase minima e non-negoziabile per costruire e farfunzionare una società in cui valga la pena di vivere.L’aspetto rivoluzionario, in tutto questo, è che Dio nongiocava un ruolo decisivo. Cristo era il suo referenteprincipale, il modello esemplare. L’antropologiafilosofica e politica di Las Casas accettava l’ipotesi diun Dio che, pur essendo onnipresente ed onnipotente,concedeva all’uomo la facoltà di seguire o non seguire ilmessaggio di suo figlio, di lavorare con Lui direttamentee deliberatamente, oppure indirettamente edinconsapevolmente, come fu per Adamo ed Eva. La suafilosofia morale, incentrata su un profondo rispettodella vita che superava le nozioni di razionalità e leggenaturale/divina, trovava il suo fondamento teorico nelconcetto di condivisione della vita, nel senso difratellanza, comunanza e compassione, nellaconsapevolezza della nostra mortalità, vulnerabilità efinitezza e nella convinzione che il principiofondamentale della moralità sarebbe dovuto essere quellosecondo cui ciascun individuo va capito attraversol’amore, secondo l’insegnamento di Gesù il Cristo. Dio
135
non era responsabile né del bene, né del male, era untestimone inattivo, ma partecipe, degli accadimenti. LasCasas scriveva non per esaltare Dio e la sua opera, maper rischiarare un mondo così impoverito di retroterrametafisico che i Conquistadores ed i coloni spagnoli,sebbene “cristianissimi”, di fatto si trovavano privi dialtra guida morale che non fosse la volontà di potenza,magari dissimulata dietro tradizioni e citazioniteologiche. Scriveva per ricordare ai suoi contemporaneile parole del Cristo, il suo esempio, la sua volontà dicapire la realtà dell’altro attraverso un’opera d’amore,di giustizia e di compassione, sentimenti che diventavanoforme di comprensione piuttosto che mere precondizioni opresupposti che facilitavano l’intendimento reciproco.Scriveva per esprimere il suo sdegno verso chi predicavabene e poi sguazzava nella realtà materiale che invece dasola non basta, verso chi si beava dei suoi castellispeculativi ed era incapace di raggiungere un’autentica,piena comprensione di quel che è fondamentale per la vitaumana, ciò che ci spinge ad attenerci ad una condottamorale, perché la cercava nella direzione sbagliata,nelle definizioni e nelle citazioni dotte. Molte diquelle definizioni, come il domenicano s’impegnò adimostrare nella Disputa ed in innumerevoli altriscritti, non sarebbero rimaste in piedi ad un’attentaanalisi. Quel che importava era il fatto, non la suadefinizione e ancor più pressanti erano la comprensione ela sensibilità, perché la percezione della vulnerabilitàe mortalità che ci accomuna, ci rende più inclini allatolleranza ed alla premura e sollecitudine verso ilnostro prossimo. Non a caso la “conversione” di Las Casasall’umanitarismo fu accelerata grandemente dallapartecipazione a spedizioni sanguinarie e dalla visionedell’abbrutimento di migliaia di esseri umani propriocome lui.
136
È assai probabile che la personalità di Sepúlvedafosse strutturalmente incapace di comprendere il sensopiù profondo degli argomenti del suo antagonista. In unalettera all’inquisitore Martín de Oliva, datata 1 ottobre1551, si lasciava andare ad una serie di recriminazioni:“Come si può vedere, le mie prove erano molto piùconvincenti delle sue, senza contare il fondamento dellamia argomentazione, senza dubbio più solida di quella deimiei avversari. Essi, è vero, maneggiavano la falsadialettica con un’abilità sorprendente: abituati comeerano alle polemiche scolastiche, fornivano le più straneed ingegnose interpretazioni delle Sacre Scritture edelle testimonianze dei Santi Padri, distorcendocompletamente il loro senso e offuscando la veritàpiuttosto che lasciarla risplendere” (cf. Di Liso, 2007,p. 152). Sospetto che quella di Sepúlveda fosse una formadi alienazione dal linguaggio dell’amore, dellatolleranza, della comprensione e del rispetto. Ai suoiocchi il Nuovo Mondo era e doveva essere ingiusto, comeil Vecchio, il cinismo era l’unico vero realismo ed unlinguaggio analitico-pragmatico era razionalmente piùattraente e plausibile. Per lui non esisteva una comuneumanità, non sussistevano legami invisibili di caratterenon utilitaristico che intessevano la trama sociale, quelmisterioso potere che abbiamo di influenzarci l’unl’altro in modi imprevedibili che incoraggial’interdipendenza, il mutuo supporto e la disponibilità apartecipare a progetti comuni. Per lui, presumibilmente,solo la razionalità e l’utile sociale erano di per sédegni di rispetto, mentre per Las Casas il linguaggiodell’utilità razionale era sempre parassitario rispetto aquello dell’amore e minava alle fondamenta la possibilitàdi riconoscere agli indigeni una dignità moraleindipendente dalla loro capacità di contribuire al benedell’Impero. Coerentemente, Las Casas ripudiava laschiavitù o la servitù estorta, perché scambiare un indioper denaro corrompeva il suo valore, che apparteneva ad
137
una sfera diversa, più alta, spirituale e divina, edassegnava un valore sproporzionato al denaro. Lasorprendente modernità di Las Casas, che non era unumanista di formazione, ma lo diventò col tempo, daautodidatta, fu la comprensione che la libertà sospingeogni forma di uguaglianze e l’uguaglianza promuove ognitipo di libertà. La libertà e l’uguaglianza comportano larivendicazione di un’umanità comune e la dignitàdell’individuo, che appartiene a se stesso e non adaltri, è architetto della sua vita e della sua anima, nondi quella altrui, è immaginifico e creativo e la suapelle non può essere indossata da altri. “Nell’arringafinale, il Vescovo del Chiapas elegge a criteriofondamentale di giustizia globale l’autonoma soggettivitàdelle popolazioni indigene e il común consenso de toda laRepública y de todos los particulares. È un pensiero davveroradicale che tende ad affermare, per un verso,l’uguaglianza naturale di tutti gli uomini e di tutti ipopoli e l’unità del genere umano e, per un altro verso,la libertà (civile, economica, culturale, religiosapolitica) e la piena sovranità delle comunidades e dei“regni” indigeni all’interno di un’organizzazionefederativa e sopranazionale. Nel quadro di una teocraziapontificia radicalmente svuotata di poteri temporali ericonvertita alle pure esigenze evangeliche, è garantitala libertà di coscienza, di religione e di culto degliindios, anche di fronte ai predicatori e alla Chiesaevangelizzatrice” (Di Liso 2007, p. 64).
Si potrebbe ipotizzare, e lo si è fatto, che l’unicomerito di Las Casas sia stato quello di aver applicato lepiù avanzate teorie giuridiche spagnole del tempo al casoindiano. Ma questa interpretazione ha il grave difetto diobliterare la causa prima della sua militanza in favoredei diritti umani e della dignità umana. Las Casas sicomportò a quel modo perché toccò con mano l’orrore di unmondo che non intendeva riconoscere questi principi, comei posteri avrebbero toccato con mano l’orrore del nazismo
138
e dei vari totalitarismi di destra e di sinistra.Esperienze che rammentano all’umanità come sarebbe ilmondo senza questi valori, il più nobile prodottodell’ingegno e della civiltà umana. Un mondo dove il mitofa apparire una contingenza disumana come eterna edinesorabile, dove un’immaginazione o curiosità perniciosavotata al male, alla viziosità ed all’impulso di morte è“maestra dell’errore”, un gelido mostro che genera unavirulenta e repellente tendenza a vivisezionare la realtàe, letteralmente, le persone. Si leggano, a questoproposito, le testimonianze di chi aveva visto iConquistadores, cristiani di nome ma non certo di fatto,eviscerare e mutilare donne e bambini indigeni. Questomentre un’immaginazione indolente diffonde lassitudinemorale, crudele indifferenza e disinteresse e cieca,conformistica obbedienza. Un universo parallelo in cui ildisprezzo irato verso il diverso, verso ciò che è “contronatura”, è corrivo con la logica del carnefice, dettatadall’odio organizzato e da ideali che, moralisticamenteed ipocritamente, si proclamano nobili, in piena adesioneai principi del bene, ma abbrutiscono chi li professa echi li subisce. Una dimensione dominata dall’esteticamanichea della dualità, che si abbatte feroce sulladignità ed alterità dei singoli, da un culto del sublime,delle linee nette e precise, i confini ben tracciati, icolori ordinatamente disposti sulla tavolozza, tipico dichi crede che la bellezza sia una, ordinata e prevedibilee non tollera ciò che gli appare come brutto, sformato,caotico, sciatto, scialbo, improvvisato, incoerente,fluido e mediocre. E anche dalla disciplinapaternalistica, tanto cara ai misantropi autoritari,quelli che vedono solo bruttezza e degradazione naturalenell’umano non addomesticato, non inquadrato in unacomposizione ben regolata e magari anche esteticamenteattraente, non pedina, preda, o bestia da soma.
La lettura delle cronache delle trucidazioni di massanella Nuova Spagna richiama alla mente la barbarie
139
nazista. Vorrei riportare un passo di Mario Spinella,tratto da “Memoria della Resistenza” (1995, p. 137),perché mi sembra emblematico della mentalità dellaConquista contro cui si batté Las Casas: “E mi domandavoper quale mostruosa logica i tedeschi credessero di dovercercare una giustificazione per trucidare i russi.Avrebbero potuto prenderli a caso, ma forse il solofingere che si trattava di ebrei, serviva loro dapretesto metafisico, li assolveva davanti al loroSignore”. R.D. Laing l’avrebbe chiamato un “sistema difantasia sociale”, ossia una visione della realtà in cuiun gruppo crede fermamente anche se non corrisponde allarealtà fattuale. Las Casas era esecrato dai colonialistiproprio perché le sue denunce producevano crepe in questosistema inerziale e le sue descrizioni degli orroricostringevano l’immaginazione di chi risiedeva inmadrepatria ad uscire dalla modalità selettivamenteinattiva in qui era stata confinata, sempre in nomedell’utile sociale e del bene dell’Impero. Una modalitàche, prima di Montesinos e Las Casas e pochi altri uominidi fede e di umanità, era riuscita a rendere assente ilpresente e presente l’assente, costruendo una realtàparallela su cui si potevano fare progetti come se questafosse l’unica autentica, come se la realtà tangibilefosse assente, o inesistente, o fosse un minuscolopezzetto della realtà che si voleva fosse vera, una suacaricatura. Come se gli indigeni fossero davvero numeri,unità, quantità, materiale da costruzione o di scarto,strumenti o impedimenti. Allora i Conquistadoreslottavano con tutte le proprie energie per barricarsi inqueste finzioni impedendo lo zampillamento di schizzi ogetti di realtà, compartimentando la propria esistenza.La verità era estirpata e sostituita con la credenza, conil costrutto mentale, il pregiudizio, la congettura, lafantasticheria, l’ubbia, il capriccio, il fantasma delreale. La destinazione finale era l’inimmaginato, che pergli Indios e gli Ebrei fu l’inimmaginabile, la tentata
140
pianificazione di un’estinzione. Non v’era spazio perl’immaginazione benigna, quella morale, che ci permettedi riconoscere nel prossimo un nostro fratello.
La crisi esistenziale e morale di Las Casas, invece,gli permise di neutralizzare quel meccanismo innatodell’umanità che impediva a troppi suoi compatrioti diassegnare agli altri un grado di realtà uguale alproprio. Come Eichmann, che non era privo di idee, ma eraposseduto da idee fisse perché il suo piccolo sé agognavasignificati, linearità, chiarezza, ordine, comandi,laboriosità, la sottomissione appassionata ad un’esteticadominante, intossicante e virulenta (come una conversionereligiosa) che depriva la persona della capacità di tenerconto delle considerazioni morali. I quotidiani dellaRepubblica Sociale Italiana annunciavano: “Non si puòvivere senza ideali, i nostri ideali sono i più alti”.Difficile distinguerli dai Conquistadores che, come loro,uccidevano perché sentivano di possedere un codice moraleintatto, perché erano sviati dalla volontà, anzi dallanecessità di credere, una rozza forma di autoinganno chedistrugge l’integrità delle persone, trasformandole invacui ed opachi strumenti di mendacità e di immoralità.Leggiamo direttamente da Las Casas, in Brevissima relazionedella distruzione delle Indie, l’impatto di queste fantasiesociali, o miopie selettive, sulla dignità umana:“Perniciosissima è sempre stata la cecità che hanno avutocoloro cui è affidato il governo delle Indie. [...]. Taleoffuscamento ha raggiunto il colmo quando sono stateescogitate, comandate e messe in pratica certeintimazioni da fare agli indiani, con le quali siingiunge loro di adottare la fede e di rendere obbedienzaai re di Castiglia, pena la guerra a fuoco e a sangue, lamorte e la schiavitù. Come se il figlio di Dio, che si èpur sacrificato anche per ognuno di loro, col dire, aproposito della sua legge, euntes docete omnes gentes, avesseordinato di fare tali ingiunzioni agli infedeli chevivono pacifici e tranquilli nelle loro terre; come se
141
avesse comandato che poi, senza predicazione alcuna nédottrina, se questi non si fossero piegati subito aosservarla e non si fossero dati corpo e anima allasignoria di un re mai visto né conosciuto, a un re daisudditi e dai messaggeri tanto crudeli, spietati eorribilmente tirannici [...] Dovessero per castigoperdere i beni e le terre, la libertà, le donne e i figliinsieme alle lor vite, tutti. E una cosa assurda, stolta,degna d’ogni ludibrio e vituperio: dell’inferno”.
Nella filosofia, come nella vita, tre sono ledistinzioni che contano: tra vero e falso, tra adeguatoed inadeguato e tra libero e servo. È su questa base checiascuno può giudicare se stesso ed è, immagino, questoil senso di un’importante riflessione di Las Casas, che asua volta si rifà a Seneca: “lo spirito umano vuoleessere persuaso e non costretto, in quanto ha in séqualche cosa di elevato e di sublime che non sopportacostrizioni ma si compiace di ciò che è rispettabile evirtuoso, perché lo ritiene in grado di confermare lapropria dignità”. Autenticità, verità, integrità edadeguatezza si realizzano solo attraverso il liberoarbitrio di una mente non offuscata. Recuperando unasapienza antica, Las Casas riaffermava il principio cheil fine dell’umano è essere libero, libero di essereonesto con se stesso e con gli altri, di pensare con lapropria testa senza doversi ogni volta chiedere cosa glialtri pensino, di vivere pienamente ed abbondantemente,cioè autenticamente.
La libertà
La prescrizione opera in favore della libertà e mai contro la libertà. La libertà,al contrario, non si può mai perdere per prescrizioneBartolomé de las Casas
142
Ulpiano aveva riassunto in poche formule gliimperativi etici universali che dovevano governare lequestioni umane: honeste vivere (vivere onestamente); alterumnon laedere (non danneggiare gli altri); suum cuique tribuere(dare a ciascuno il suo, ciò che si merita). Las Casasnon avrebbe avuto nulla da eccepire, ma non avrebbeneppure esitato a porre in cima a questa lista “esserelibero e non schiavo”. Las Casas ripeteva insistentementeche l’uomo è libero “di forma costitutiva” e che lalibertà religiosa è un corollario necessario delfondamentale valore antropologico della libertà e delladignità umana. In questa sua determinata adesione alprincipio della tolleranza si scorge la più altacomprensione della vicenda umana e del messaggioevangelico, diametralmente opposta alla sciaguratainterpretazione agostiniana del compelle eos intrare (Lc 14,23). Questo suo sconfinato attaccamento alla libertà loricavò probabilmente dal suo essere discendente diconversos: non si converte nessuno con la paura, perché lafede dev’essere autentica, altrimenti non ha alcunvalore. Il rifuto della fede non poteva in alcun modocomportare l’adozione di misure punitive. Coerentemente,Las Casas risolse diplomaticamente la questione dellarivolta (1519-1533) di Enriquillo, sovrano cristiano deiTaíno indigeni di Hispaniola, riconoscendo le ragioni diquesta insurrezione e proponendo soluzioni in grado diporre rimedio al malessere indigeno. Gli Spagnoli sidovevano limitare ad operare come “mediatori e coadiutoridi Gesù Cristo per la conversione di così numerosiinfedeli” (Historia de las Indias). Peraltro, “infedeli” è untermine che il domenicano usava sporadicamente esoprattutto a fini retorici. Per il resto la suapercezione degli Indios era certamente più simile aquella dei poveri del Vangelo, attraverso i quali Cristocomunica la Verità.
Quello della libertà come attributo essenzialedell’umano è un dato che noi moderni diamo per scontato,
143
ma non così gli antichi. L’insigne filologo tedesco BrunoSnell, ne La cultura greca e le origini del pensiero europeo (Snell,2002) ha rilevato che nell’Iliade non si trovanodecisioni personali. L’intervento degli dèi èdeterminante in ogni scelta e non c’è vera introspezione,consapevolezza della propria libertà, come non ci sonoscrupoli, rimorsi e ripensamenti. Tutto avviene perchécosì deve avvenire, al di là del bene e del male, delgiusto e dello sbagliato. Nelle saghe nordicheriscontriamo il medesimo motivo (Gurevich, 1995). Ildestino è installato nell’eroe come un software. L’eroerispetta i suoi dettami e produce le condizioni adattealla realizzazione delle profezie. Il suo fato, la suamisura di buona sorte e miserie è rivelato dal suoaspetto (in greco, kalokagathia: il bello e il buono,assumendo forma corporea, diventano veri) e dalle sueimprese o fallimenti. Le azioni dell’eroe sonomeccaniche, automatiche, inevitabili, perché decretatedall’ordine cosmico, che si riflette nell’ordine clanico,dove il personale ed il sovrapersonale sonoindistinguibili ed inseparabili. Non vi è coscienzapersonale, ma solo coscienza di gruppo. Non si può direche una cosa è sbagliata, ma solo: “la gente ritiene chequesta cosa sia sbagliata”. Non esistono parametri eticiuniversali ma solo costumanze claniche e copioni di ruolotramandati dalla notte dei tempi, cioè coordinate socio-culturali da interiorizzare. La mitologia greca offrenumerosi esempi di eroi che dichiarano di essere nati percompiere un destino preordinato e per difendere ilproprio nome, la propria reputazione. Nelle saghenordiche, come nelle epopee greche, è arduo incontrareeroi che disobbediscano al mandato divino o alle leggidella propria città per salvare una comunità (MacEwen,2006). L’eroe greco, quello germanico e quello giapponesenon possono fare a meno di misurare il proprio valore infunzione del soddisfacimento delle prerogative associateal proprio status e lignaggio, oltre che del
144
conseguimento della gloria personale. La civiltà aztecanon si discostava da questo modello iper-fatalistico. Apartire da Montezuma, che ammoniva: “Ed io vogliometterti in guardia; senza alcun dubbio, tutti saremomassacrati da questi dèi e il destino dei sopravvissutisarà di diventare schiavi e vassalli”. Gli Aztechiinsistevano ossessivamente sulla copertura di metallodegli Spagnoli, trattandoli come esseri sovrannaturali,“dèi-venuti-dal-cielo”. Le loro navi erano “opera, certo,più di dèi che di uomini”. Cortés era Quetzalcoatlredivivo, di cui si attendeva messianicamente il ritorno.Lui ne approfittò per sottometterli. “È la novità,l’insolito aspetto, la diversità che, insieme con lasuperiorità delle competenze tecnologiche, inducel’assunzione dei nuovi venuti al rango di dèi” (Todorov &Baudot, 1988, p. XXIV). Invece di contrastare la loroavanzata, li veneravano. Decimati dalle epidemie,interpretate come punizioni divine, tra gli indigeni lostupore lasciava il posto alla rassegnazione edall’accettazione: “Non ci è dato sottrarci ai decreti deldestino”, “ciò che è stato deciso, nessuno puòscongiurarlo”, “non si può sfuggire a ciò che deveaccadere”, “queste cose si compiranno. Nessuno potràimpedirle”, “chi non saprà comprendere, morrà; chicapirà, vivrà”. È ancora Todorov a commentare lucidamentel’accaduto: “Gli Indigeni non furono sconvolti dal timoredi perdere le loro terre, i loro regni o i loro averi, madalla certezza che il mondo ormai era giunto al suotermine, che tutte le generazioni dovevano, ormai,scomparire e perire, giacché gli dèi erano discesi dalcielo e ad altro non si poteva pensare che alla fine,alla rovina e alla distruzione di tutte le cose”. Lostesso fatalismo e determinismo avvinceva gli Spagnoli,che leggevano i segni e cercavano nelle Sacre Scrittureun annuncio profetico delle loro imprese. Las Casas nonne era immune, ma la straziante realtà della megamacchinamortifera e schiavista della Conquista lo scioccarono ad
145
un punto tale da non consentirgli più di restareindifferente e passivo. In lui teoria e pratica eranoindissolubilmente interconnessi. Da quel momento in poila difesa e caldeggiamento del libero arbitrio, larivendicazione di una sfera di libertà inviolabilenell’essere umano divennero la cifra delle sue parole edazioni.
È degno di nota il fatto che, forse intuitivamente oforse inconsciamente, Las Casas colse la perniciositàdella fusione di pessimismo, fanatismo e determinismobio-culturale (l’ordine esistente riflette innateproporzioni di talento ed intelligenza) e si fece unpunto d’onore e di principio di demolire ogni singolopilastro portante di quest’edificio anti-umano ed anti-cristiano, così idoneo a far emergere ed irrobustire lepeggiori pulsioni dell’animo umano. Egli ripudiava ildesiderio e l’illusione di appartenere ad un’éliteprivilegiata – una razza spirituale dominante –,l’imperativo di svuotarsi della propria coscienza,personalità e libero arbitrio, l’infantilismo impostoagli indigeni, le relazioni strenuamente gerarchizzate,la fobia del diverso, il prevalere dell’idea astrattasulla persona, dell’obbedire sul pensare, del serviresull’amare, del vegetare sul vivere, dell’umiliazionesull’umiltà, del conformismo spirituale sulla vitadell’anima, delle ripetizioni a pappagallo sullaconsapevolezza, del fine di plasmare il prossimo invecedi aiutarlo fiorire. Abbiamo detto che il suo credopolitico era incentrato sul principio di libertà. Per LasCasas Dio stesso è principio di libertà. In una letteraal principe Filippo, datata 20 aprile 1544, scrive:“Tutti gli indiani che vi si trovano devono essereconsiderati liberi: perché in verità lo sono, in baseallo stesso diritto per cui io stesso sono libero”. Unaconsiderazione profondamente in anticipo sui tempi. Pocomeno di 400 anni dopo, un grande avvocato statunitense,Clarence Darrow, era ancora costretto a spiegare alla
146
giuria ciò che avrebbe dovuto essere auto-evidente, ecioè che “potete proteggere le vostre libertà a questomondo solo se proteggete la libertà altrui. Potete essereliberi solo se io sono libero”.
Le ramificazioni di questo assunto a livello socio-politico avrebbero potuto essere dirompenti, se fosserostate recepite in Europa. Per Las Casas, la gente dovevapoter vivere in comunità politicamente organizzate,essendo soggetta al minimo controllo necessario a farlefunzionare. Non era lecito usare il pretesto dellariottosità per imporre regimi di dispotismo illuminato.La libertà dei singoli doveva essere l’obiettivo finale,perché senza la libertà la ragione, che fa propendere lepersone per una vita sociale pacifica ed armoniosa, nonavrebbe potuto ricercare il bene ed evitare il male senzaincontrare restrizioni. Ogni restrizione era un passoverso il male. Se il libero esercizio della ragionecostituiva un diritto umano fondamentale per gli Europei,lo stesso doveva valere per i nativi americani. Nemmenoil papa poteva revocare questo diritto, neppure abeneficio dell’evangelizzazione, perché il pontefice nonaveva alcuna autorità sui non-Cristiani e non potevaautorizzare la punizione dei loro peccati o ordinare larimozione dei loro capi. Ogni conversione doveva esserelibera e volontaria, nessun uso della forza poteva esserecondonato. “Gli Apostoli facevano appello alla solapersuasione. Gesù non li ha mai autorizzati a costringerecoloro che non volevano ascoltare o ad infastidirechicchessia. Dovevano invece armarsi di una grandepazienza, poiché le anime si conquistano soltanto con ladolcezza della voce, il volto umile e l’affabilità…Essidovevano testimoniare il loro disprezzo dei benitemporali, e la loro condotta doveva essere buona e icostumi irreprensibili…Gli Apostoli non furono mai vistipersegitare o uccidere un essere umano, nemmeno i loronemici”. La predicazione doveva dunque avvenire“quietamente, tranquillamente e dolcemente, utilizzando
147
un modo calmo e soave, rogativo ed attraente, ed inintervali di tempo successivi, affinché si possa prima ditutto pensare sulle affermazioni che vengono proposte edinferire se crederle e dare il consenso….In conclusione,è indipensabile disporre di tempo sufficiente perascoltare, pensare, discorrere e deliberare su ciò cheviene proposto così da conoscere se sono veritiere ofalse, se sono degne od indegne le cose alle qualiprestiamo il nostro assenso” (De unico vocationis modo omniuminfidelium ad veram religionem). Rifacendosi al pensiero diVitoria, Las Casas ribadiva che se una comunità indianasi rifiutava di ascoltare la parola del Signore o diosservare leggi diverse dalle sue non li si potevacostringere a farlo. Juan de la Peña, studente di Cano eCarranza e legatissimo a Las Casas, condivideval’opinione di questo suo amico fraterno: la fede è undono soprannaturale, nessuno può essere costretto ariceverlo, altrimenti è tirannia. Mentre secondoSepúlveda gli schiavi africani stavano meglio da schiaviche da uomini liberi in Africa, de la Peña replicava chesolo in una condizione di completo caos sociale eviolenza generalizzata si poteva dire una cosa del generee non era certo il caso né degli Africani né degliIndiani. Quanto alla distinzione tra superiori edinferiori, il giurista salmantino chiedeva retoricamentese il re di Spagna avrebbe avuto il diritto diintervenire in Francia se si fosse stabilito che gliSpagnoli erano superiori in intelligenza. Per entrambi,il vescovo del Chiapas ed il giurista, gli indios avevanoil diritto naturale di formare la società che preferivanoed in America non sarebbe stato illegale per deiCristiani essere soggetti, volontariamente, a non-Cristiani, visto che la sovranità indiana sulle proprieterre era legittima e l’intervento spagnolo era illegalequando comportava l’espropriazione di terre. Lasupremazia spagnola sarebbe stata autorizzata solo da unalibera scelta da parte di una maggioranza degli indigeni.
148
Nel preambolo alla sua opera più importante dal puntodi vista della teoria politica, il De regia potestate,pubblicato postumo a Francoforte nel 1571 e summa del suopensiero negli ultimi tre anni di vita, Las Casasdichiarava solennemente: “Dall’inizio del genere umanotutti gli uomini sono liberi per diritto naturale e peril diritto dei popoli. La libertà è uguale per tutti”.Quest’opera è, sostanzialmente, un trattato politicosulla libertà delle persone e dei popoli in un mondo incui il pontefice esercitava una potestà ecumenica maesclusivamente spirituale e il sovrano non aveva alcunpotere che non fosse stabilito sulla base del consensodei sudditi – nulla subiectio imposita fuit sine consensu populi. Ilpopolo, scriveva Las Casas, è la causa efficiente efinale di ogni autorità legittima e la legge ha lo scopodi fungere da garanzia della libertà dei cittadini control’arbitrio dei forti e prepotenti. Sulla stessa linea,alcuni secoli dopo, si muoverà il pensiero del religiosoe politico francese Jean-Baptiste Henri Lacordaire (1802– 1861), uno dei fondatori del cristianesimo moderno, cheparafrasando Rousseau, sentenziava: “Tra il debole e ilforte, tra il povero e il ricco, tra il servo e ilpadrone, è la libertà che opprime ed è la legge cheaffranca”. Per Las Casas la società ideale era quelladove i cittadini eleggevano i propri dirigenti – perliberam electionem – e, nel farlo, non perdevano la proprialibertà. Chi andava al potere non si doveva sentireautorizzato a costringere le persone ad agire adetrimento proprio o del bene comune al di fuori dellacornice legislativa e del diritto naturale. Questo era undiritto originario, universale e necessario,indivisibile, che accomunava tutti gli esseri umani nellastessa misura ed era imprescrivibile. Seguendo la lezionestoica, con riferimento esplicito a Cicerone, Las Casassosteneva che tutte le nazioni ed i popoli, per ilsemplice fatto di esistere, a prescindere dalle lorocredenze e costumanze, erano liberi e dovevano rimanere
149
tali. Non avrebbe avuto senso, e sarebbe stato contrarioal diritto naturale, credere che dopo la venuta di Cristoi non-credenti fossero stati privati dei loro diritti,trasferiti istantaneamente ai credenti, come se questifossero gli unici, veri uomini.
Furono numerosi i missionari che, pur denunciandol’infamia del sistema neofeudale e gerarchicodell’encomienda, conclusero che forse quello era un maleminore, l’unica maniera per porre rimedio al disastro,prima che acquistasse un carattere definitivo.Confidavano nel fatto che, con alcuni correttivi, nelNuovo Mondo la forza dei signori sarebbe stata temperatadai doveri verso i sottoposti e da una tutelapaternalistica illuminata. Las Casas non fu mai di questoavviso. Accusato di avere in mente una teocraziasacerdotalista anacronistica, in realtà il radicalismocristiano di Las Casas avrebbe demolito qualunquestruttura piramidale; seguendo l’esempio di Gesù ilCristo, appunto. Non avversava gli encomenderos mal’encomienda. Era pronto a redistribuire le ricchezzerestituite ai coloni ricchi anche ai coloni poveri, cheavrebbero comunque potuto continuare a ricevere una partedei profitti di un lavoro indiano libero da vincoli disfruttamento padronale, in un regime di equa spartizionedelle risorse. Non era un fanatico indigenista, ma unsincero cultore della giustizia e della libertà, libertàche non avrebbe avuto senso in una condizione di miseriae disperazione, dove non sarebbe possibile una genuinaadesione alla verità, un sincero atto di fede. D’altraparte per Las Casas un diverso grado di sviluppo civile ebenessere economico non minacciava l’unità fondamentaledel genere umano. Un’uguaglianza ontologica, radicatanella legge naturale e divina, fondava l’uguaglianzagiuridica degli uomini. La nozione di un diritto cheesisteva nella natura, poteva essere riconosciutodall’umanità e veniva prima delle leggi specifiche eraun’idea piuttosto diffusa nella cristianità e
150
nell’umanesimo del tempo. Las Casas però, come altri, siaugurava che il Nuovo Mondo diventasse il luogo deputatoad un esperimento nuovo: la possibilità di disfarsi dellafrenesia mercantile e di mettere il pratica il messaggiodel Cristo. Scrive Las Casas: “Aiuta molto queste terread essere felicissime e fertilissime l’aria tantoclemente e le mutazioni del clima tanto opportune efavorevoli, così che pur col pochissimo lavoro che questegenti compivano, moltissimo avanzava a tutti, e in ogniparte avevano il necessario. Non si è mai vista tra lorola fame se non dopo che ci arrivammo noi cristiani, chein un giorno gli mangiavamo e sperperavamo tutto quelloche a loro bastava per mantenere le loro famiglie per duemesi. In quest'isola Ispaniola, e in quella di Cuba e inquella di San Juan e Giamaica, vi erano infinitivillaggi, con le case vicine e con molti abitanti unitidi diversi parentadi. E poichè in quest'isola eraconsolidata la pace e l'accordo tra alcuni popoli e regnie gli altri, non ebbero necessità di unirsi in moltagente e di formare centri abitati assai vasti: così vierano comunemente villaggi di cento, duecento ecinquecento abitanti: dico case in cui dimoravano dieci equindici abitanti con le loro donne e i loro figli. Equesto è assai notevole e sicuro argomento della bontànaturale, mitezza, umiltà e amor di pace di questenazioni, che in una casa di paglia la quale avrà trentaquaranta piedi di vano, benchè rotonda, e che non haritirata né luoghi appartati, possono vivere dieciquindici abitanti per tutta la vita, senza che i mariticon i mariti, nè le mogli con le mogli, nè i figli con ifigli abbiano litigi o contese, più che se fossero tuttifigli di un padre o di una madre. È chiaro che se neavessero tra loro e non vivessero in pace, d'amore ed'accordo, non si potrebbero sopportare, e perconseguenza sarebbe necessario che uno degli abitanti,per vivere in pace, si allontanasse dall'altro: sappiamobene quante volte accade tra noi che figli e genitori non
151
possano vivere uniti nella stessa casa” (ApologeticaHistoria). L’idealizzazione dell’umanità indigena èchiaramente intesa ad irrobustire in se stesso e nellettore la fede nella realizzabilità del disegno divinocome era stato delineato nel Nuovo Testamento, in vistadel Millennio, del ritorno del Cristo, un evento in cuiLas Casas credeva fermamente. Ecco un altro brano chesvela l’irrealistico utopismo lascasiano: “Tutte questeuniverse e infinite genti d’ogni razza o nazione, Dio leha create semplici, senza malvagità nè doppiezze,obbedientissime ... e più di ogni altre al mondo umili,pazienti, aliene da risentimenti, da risse, da liti, damaldicenze, senza rancori, odi, desideri di vendetta.Sono d’intendimento chiaro, libero e vivace, assai capacie docili per apprendereogni buon insegnamento ... Traquesti ... giunsero gli spagnoli ... e altro non hannofatto, da quarant’anni a questa parte ... che straziarli,ammazzarli, angustiarli, tormentarli e distruggerli concrudeltà straordinaria”. Noi oggi sappiamo che gliindigeni sapevano essere tanto feroci quanto gliSpagnoli, ma in quel momento il vescovo del Chiapasdoveva per forza alterare la realtà per contrastare altree più letali contraffazioni della verità confezionate daiConquistatori, impegnati a minimizzare responsabiltà eplacare coscienze.
Ma, allora, cosa distingueva l’estetizzazione dellarealtà indigena operata da Las Casas dalla demonizzazionexenofobica dei suoi avversari? Il fatto che le sueintenzioni erano benevole? Di buone intenzioni sonolastricate le strade che conducono all’inferno. Posto chele Sacre Scritture sono state impiegate per giustificareguerre imperialiste, torture, crociate, cacce allestreghe, sacre inquisizioni, ecc. credo si possa dire chesolo un estetismo benevolo può dar conto dellalegittimatà dei diritti umani. L’empatia, il fondamentodella dignità umana, è una simpatia immaginativa, unaccrescimento di vita. Solo la persona empatica è
152
realmente viva ed ogni limitazione alla simpatiaimmaginativa è un impulso di morte, l’impulso arestringere i margini di libertà della vita. Las Casas,quando raggruppò coloni e indigeni nella sua comunitàsperimentale venezuelana, chiese loro di fare in modo chele loro differenze e pregiudizi non determinassero leloro interazioni. Questo è il nucleo centrale delpensiero democratico: le persone non sono uguali pernatura, ma lo sono nella società e, per i credenti, agliocchi di Dio, spiritualmente. O, nelle parole di SimoneWeil, “la virtù soprannaturale della giustizia consistenel comportarsi esattamente come se ci fosse uguaglianzaquando uno è più forte in un rapporto diseguale”. Diconseguenza, Las Casas dedicò la sua vita alla lotta alleconcezioni antropologiche deterministiche che negano illibero arbitrio e la coscienza e quindi legittimanol’imposizione del “bene”, ufficialmente la principalemissione della crociata iberica nel Nuovo Mondo. LasCasas era contrario ai guardiani della fede. Credeva inDio e in Cristo e nella missione ecumenica edevangelizzatrice della Chiesa, ma non intendeva prendereil controllo delle vite degli indigeni professandoautoingannevoli motivazioni umanitarie: se gli indigeninon volevano abbracciare il Verbo, solo Dio avrebbepotuto deliberare sulla sorte delle loro anime.Piuttosto, la sua impostazione di umanesimo cristiano eRespublica Christiana era per molti versi affine a quelladella dottrina sociale della Chiesa e fu avversata da unaparte dell’establishment ecclesiastico fin dai tempi delConcilio di Trento. Ancora nel 1832 Gregorio XVIscomunicava Lamennais per aver propugnato la libertà dicoscienza, un’idea che il pontefice qualificava come“delirio”. Solo nel 1965, con un ritardo di circa 400anni rispetto a Las Casas, la dichiarazione Dignitatishumanae del Concilio Vaticano II approvava quel medesimo“delirio”: “Questo Concilio Vaticano dichiara che lapersona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il
153
contenuto di tale libertà è che gli esseri umani devonoessere immuni dalla coercizione da parte di singoliindividui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestàumana, così che in materia religiosa nessuno sia forzatoad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entrodebiti limiti, di agire in conformità ad essa. […]Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa sifonda realmente sulla stessa dignità della persona umana.[…]. L’esercizio della religione, per sua stessa natura,consiste anzitutto in atti interni volontari e liberi,con i quali l’essere umano si dirige immediatamente versoDio: e tali atti da un’autorità meramente umana nonpossono essere né comandati, né proibiti”.
Las Casas è un pensatore compiutamente edautenticamente anti-totalitario, forse uno dei primi,forse uno dei grandi. Non sogna vere e proprie utopieperché la sua è un’esperienza in presa diretta. Sa dicosa hanno bisogno gli indigeni, conosce i loro problemi,capisce i loro desideri. Interagisce con persone in carneed ossa, persone che ama, nelle quali riesce adidentificarsi empaticamente. Qual è allora l’alternativaproposta da Las Casas? L’idea è quella di “propagare lasua [di Dio] santa Chiesa e forse trasferirla del tuttodi là” (Historia), cioè lontana dalle tentazioni ecorruzioni del Vecchio Mondo, per ripartire da zero, comei primi Cristiani. Non è immune da paternalismo, come sidesume da una lettera in cui dichiara che “bisognastrappare questa terra al potere dei padri snaturati edarle un marito che la tratterà in modo ragionevole esecondo i suoi meriti”. Però non stabilisce sistemi digerarchie e di potere pronti a plasmare un’umanità idealein una società ideale. Non vi è alcuna sincronizzazionedi corpi, menti ed atti per conseguire una produttivitàottimale. La regolamentazione statale non è per nullainvadente, anzi, abbiamo visto che credeva fermamente cheil fine ultimo di ogni istituzione dove essere la libertà
154
delle persone. Las Casas è stato accusato di farricomparire la costrizione alla conversionesurrettiziamente sotto forma di indottrinamento e diincentivi morali. Questo era probabilmente vero nel primoLas Casas, quello che non era ancora stato sconfittodalla realtà; il Las Casas maturo è cambiato. Mi pare cheCarlos Castillo abbia replicato più chesoddisfacentemente a queste critiche (1993, p. 29),elencando le idee centrali della teologia politicalascasiana: “Quella di libertà totale, cioè la libertàdegli indios in tutti i sensi della vita umana, comecondizione precedente all’accettazione della fede:libertà di vivere, di riprodursi di essere popoli, diessere persone, di autogovernarsi, di mantenere i propricostumi, perfino di credere nei propri dèi. Quella diconversione, non solo come cambio di religione alcristianesimo, ma anche come nuova comprensione dellafede, partendo dalle cose positive dei propri costumi.Quella dell’atteggiamento evangelizzatore, dove ilpredicatore è soprattutto qualcuno che deve comportarsicome “suddito” degli indios che evangelizza. Quella didifesa naturale, per mezzo della quale riconosce che gliindios non sono ribelli perché non sono sudditi dinessuno. Si difendono soltanto e naturalmente perché sonoattaccati”.
Per molti versi Las Casas aspira ad una societàlibera, in cui si deve permettere che le cose procedanoda sé, con moderazione e misura, perché l’ordine divinosi prenderà cura di tutto e le norme di condottapredicate dal Cristo sono sufficienti a far funzionare lasocietà in modo equo, armonioso e solidale. Ecco cosascrive nell’Historia: “Il vero rimedio non era altro che dilasciarli nelle proprie terre native e paeselli cheavevano, per pochi che fossero, e concedere loro tutta lalibertà, affinché sapessero che non dovevano servire maipiù gli spagnoli, e di tanto in tanto facessero lorovisita i religiosi per insegnare la dottrina cristiana, e
155
così riprendessero a moltiplicarsi come conigli…sì chefossero certi di doversi godere la propria libertà e chei loro lavori non dovessero goderseli i loro capitalinemici, che tanto disonestamente li avevano eliminatidalla faccia della terra”.
Il divario tra quest’utopia e la maggior parte delleutopie umaniste del suo tempo va ricercato evidentementenell’esercizio del potere e del controllo. Non puòesistere un vero controllo se ci sono solo personedisponibili a controllare. Serve anche una maggioranza dipersone, di indigeni, che desidera essere controllata.L’apparato deve coltivare una fantasia di soggiogamentovolontario e spontaneo che comincia con l’infanzia e chemantiene la popolazione in uno stato di infantilismoprolungato. È questo lo spirito delle proposte diSepúlveda, molto simile al dispotismo come l’avevaprofetizzato Alexis de Toqueville nel 1840: “Più esteso,meno violento e degraderebbe gli uomini senza torturarli.La violenza avverrà, ma solo in periodi di crisi, chesaranno rari e passeggeri…Al di sopra di questa follavedo innalzarsi un immenso potere tutelare, che si occupada solo di assicurare ai sudditi il benessere e divegliare alle loro sorti. È assoluto, minuzioso,metodico, previdente e persino mite. Assomiglierebbe allapotestà paterna, se avesse per scopo, come quella, dipreparare gli uomini alla virilità. Ma, al contrario, noncerca che di tenerli in un’infanzia perpetua”. Unatirannia mascherata da utopia che amministra unagiustizia inflessibile e spietata, ossia l’emanazionedella virtù ed espressione della volontà sovrana dellacasta dominante. Un “autismo collettivo”, un monismo chemantiene gli inferiori in uno stato di servilismo esubordinazione, come dei burattini, dei semi-idioti.
Purtroppo per molti indios del nostro tempo, questoincubo si è avverato, ma Las Casas fece davvero tuttoquello che era in suo potere per evitare il presentedegrado della loro condizione. Fino all’ultimo. Nel 1565,
156
a pochi mesi dalla sua morte, impossibilitato a parlaredi persona, inviò il suo ultimo memoriale al Consigliodelle Indie, dove riassunse per sommi capi le conclusionidi mezzo secolo di avvocatura in difesa degli indigeni edel genere umano: “Tutte le guerre, che chiamaronoconquiste, furono e sono in giustissime e proprie deitiranni. Tutti i regni e domini delle Indie li abbiamousurpati. Le encomiendas o repartimientos di indios sonopiù che iniqui e di “per sé” cattivi, e così purearbitrari, e questo modo di governo tirannico. Tutticoloro che le concedono peccano mortalmente, e coloro chele detengono sono sempre in peccato mortale e, se non lelasciano, non si potranno salvare. Il re, nostro signore,che Dio renda prospero e conservi, con tutto il potereconcessogli da Dio, non può giustificare le guerre e ifurti fatti a queste genti, né i suddetti repartimientoso encomiendas, più di quanto possa giustificare le guerree i furti che fanno i turchi al popolo cristiano. Tuttoquanto l’oro e l’argento, perle ed altre ricchezze giuntein Spagna, e che nelle Indie si mercanteggiano tra inostri spagnoli, sono furti con pochissime eccezioni. Secoloro che lo hanno rubato ed oggi rubano con leconquiste e con i ripartimientos o encomiendas e coloroche di esso partecipino non lo rimborsano, non sipotranno salvare”.
Questa è l’utopia di Las Casas: un popolo libero dicittadini liberi, sovrani sulle loro terre e beni, chematurano con i loro tempi e nei loro modi e che hanno lapossibilità di farlo anche grazie alla parola di Gesù ilCristo. Ci vollero secoli prima che questi principibasilari del diritto internazionale e delle missionievangeliche fossero recepite dai più. E ancora adessorimane il timore che da un giorno all’altro i nostribeneamati diritti e principi possano essere messiseriamente in discussione dal prossimo autocrate e dallaprossima oligarchia dispotica.
157
Un’antropologia della speranza
Gli scritti di Las Casas non formano un’unica operafilosofico-antropologica strutturata. Il suo intento eradiverso, cioè quello di rimbeccare ogni assalto teoricoalla natura umana e pari dignità dell’indio. Per questole ripetizioni e le contraddizioni abbondano e si deveanche ammettere, con onestà, che il suo argomentare ètutt’altro che limpido e lineare. La veemenza e laprolissità rendono i suoi trattati di non facile lettura,per un lettore contemporaneo. Richiedono una costanteattenzione per non fraintendere il senso di unragionamento non sempre ben articolato, che talora peccadi semplicismo, scarsa chiarezza, ingenuità, limitataorganicità, coesione e sistematicità. Si può ipotizzareche gli ambienti in cui esponeva le sue tesi non sisarebbero accontentati dei semplici resoconti della suainchiesta antropologica e investigativa e che ciò loabbia costretto ad improvvisarsi saggista e cronista.Eppure rimane la netta impressione di un’onesta coerenzaconcettuale e morale. Las Casas non temeva le conseguenzedelle sue requisitorie perché era sicuro di essere dallaparte della giustizia e della Provvidenza, di lottarecontro la stessa iniquità denunciata da Gesù il Cristo.Si poneva a viso aperto, senza ipocrisie, tentennamenti,ripensamenti, astuzie che mal si conciliavano con la suavisione dell’umano e della sua missione universale:l’uomo desidera il bene ed evita il male, se ne èconsapevole, perché questo è il fine per cui è statocreato da Dio. Come Pitagora, Socrate e Boezio, Las Casasera convinto che “nel cuore dell’uomo è infuso unnaturale anelito per il vero bene”, cosicché alla finegiunge quasi sempre a destinazione “come l’ubriaco chenon sa per che strada sia riuscito ad arrivare a casa”(De unico vocationis modo omnium infidelium ad veram religionem). IlMale è un’assenza di Bene, di sapienza, un ammanco, non
158
un’aggiunta di qualcosa. Le facoltà razionali umane, seben coltivate con l’educazione, non potevano che darebuoni frutti, “sani e benefici” (sanos y provechosos). Comesi vede, quella di Las Casas era un’antropologiapositiva, ottimistica, riformatrice, anti-reazionaria elibertaria; era l’“antropologia della speranza” di unuomo contemplativo che tenne sempre gli occhi spalancatidi fronte alla realtà. Padre Vicente de Couesnongle(1916-1992), anche lui domenicano, ha descritto con raramaestria il dono dello sguardo antropologico-contemplativo: “Non si tratta di passeggiaredistrattamente in mezzo alla gente, ma di mantenere losguardo attento su tutto quel che ci circonda: questepersone, i loro volti, il loro passo, la povertà dei lorovestiti o l’insolenza della loro pettinatura…Sapercercare, indovinare quel che non si vede: fallimenti,sofferenze, aspirazioni. Scoprire poco a poco ciò chetutto questo significa nella vita di tutti questi uomini,di tutte queste donne, di questi giovani, per loro stessie agli occhi di Dio”. Uno sguardo che “sa sempre rendereattuale quello al tempo stesso divino ed umano del Cristo– il più contemporaneo di tutti gli uomini – sulla folla,sui malati, tutti quelli che sono posseduti dal male; ildenaro, le ingiustizie, una sessualità esacerbata, ilpotere illimitato, l’odio. In questa folla, chi èMaddalena, chi Zaccheo, i pubblicani, il sacerdote ed illevita che vanno da Gerusalemme a Gerico? Chi solo quelliche agognano di sentire Gesù, magari anche senza essereconsapevoli di lui? […]. A imitazione di ciò che è Cristonel suo essere e nella sua orazione, questacontemplazione deve essere il punto di unificazioneprivilegiato, nella nostra vita, tra la fede ed ilmondo”.
È in forza di un’analoga ispirazione che Las Casasdichiarava che all’uomo poteva e doveva essere concessapiena libertà di disporre della sua persona e della suacoscienza in conformità alla sua volontà e discrezione
159
perché in ogni caso la ragione, Dio, la rivelazionecristiana e la sua naturale socievolezza e religiositàavrebbero provveduto a guidarne i passi, per quantoesitanti e riottosi. La forza vitale della natura,inclusa quella umana, era senza macchia, incorrotta.Trovo molto bella e acuta una considerazione di FernandoMires (1991, p. 199) sulla passione quasi maniacale diLas Casas per la natura: “Nelle dettagliate, a voltenoiose, a volte bellissime descrizioni della natura checi offre Las Casas, troviamo lo scienziato che cerca lecomponenti esatte tra l’ambiente naturale e l’esseresociale e, al tempo stesso, il credente che vive unprofondo amore per tutti gli oggetti della “creazione”,com’è dimostrato nelle descrizioni dei tipi di pane chemangiavano gli Indios, degli alberi, delle pietre, deifiori. In tutti gli oggetti vede una rivelazione deimisteri della Provvidenza e nei legami tra oggetti edesseri umani trova la rivelazione dei misteri deirapporti sociali, politici e culturali degli Indios.Teologia e antropologia, fede e scienza; sono partiinseparabili del metodo di analisi di Las Casas”. Ilnostro chierico era estremamente curioso. Voleva capireciò che non conosceva, voleva esplorare la Creazione perindividuare i segni del divino. Molto correttamente, ilgiurista tedesco Wolfgang Griesstetter che curòl’edizione tedesca di De Regia Potestate (1571) lo definivanella sua prefazione come “un uomo versato in ogniscienza”. Era anche uno spirito contemplativo, magaripersino un mistico. “Un nuovo tipo di mistico, di enormeportata pratico-riflessiva e creativa. Un mistico, però,la cui esperienza della gratuità di Dio diede alla suaazione il valore e libertà della profezia, la luciditàdel giurista, la sistematicità del teologo, laperspicacia del politico, la prospettiva e capacità diconcretizzare proposte dello stratega e del riformatore”(Castillo, 1993, p. 35). Nella Historia, scriveva questo disé: “Vedendo tutto ciò mi mossi, non perché fossi un
160
cristiano migliore di altri, ma per una compassionenaturale e pietosa che ho avuto nel vedere genti, chegiammai lo meritarono, sopportare tante offese edingiustizie; ed è così che giunsi in questi regni perinformare il Re Cattolico di questo stato”. L’empatia diLas Casas è molto accentuata e non c’è vita morale senzaempatia. L’empatia richiede emozioni, condivisione dipatimenti e di gioie. La grande forza del “male” risiedeinvece nell’indifferenza, nella carenza di introspezionee di capacità di immedesimazione, di riconoscere e diidentificarsi con i sentimenti e le necessità deglialtri. Adler sosteneva che l’empatia è la chiave perrealizzare la trasformazione dell’identità. Vedere congli occhi di un altro, ascoltare con i suoi orecchi,sentire con il suo cuore, fino ad estendersi ed includereanimali, piante ed esseri inanimati, e poi il cosmo. Èpossibile che Las Casas costituisca un esempio di questoprocesso. Husserl parlava di empatia trascendentale,ipotizzando l’esistenza di una sola cornice psichica pertutte le anime. Non esiste alcuna prova che dimostri cheera questo che sentiva Las Casas, ma lui stesso, nel suotestamento, rivolgendosi all’umanità ed a Dio, constatavadi aver speso oltre cinquant’anni di vita “senz’altromovente che l’amore di Dio e la compassione che provo nelveder morire queste moltitudini di creature razionali,così pacifiche, così umili, dolci e semplici”. Las Casasera un uomo giusto, ed il concetto di giustizia nasceperché gli esseri umani sono capaci di provarerisentimento e simpatia.
L’afflizione, l’empatia, l’indignazione ed ilrisentimento sono fondamentali per ciò che concerne ilgiusto e lo sbagliato, sono le precondizioni necessarieper l’esistenza stessa dell’idea di bene e di male,giusto e sbagliato. E questo è possibile se la nostra èuna risposta spontanea, un atteggiamento istintivo chederiva dall’automatico riconoscimento del fatto che glialtri esseri umani sono come noi, che i loro patimenti
161
non sono meno significativi dei nostri. Las Casas sirapportava agli Indios ed agli Spagnoli più umani o piùbisognosi con empatia e amore perché nel prossimo, anchenella persona più ordinaria, vedeva un riflesso dellaVerità e dell’Amore e tendeva ad espandere il propriosenso del sé, in un processo unitario, di assimilazione.Las Casas avrebbe condiviso il giudizio di Dostoevskijche “l’amore per l’umanità è inconcepibile,incomprensibile e persino impossibile senza la credenzanell’immortalità dell’anima”. Lui stesso scrivenell’Apologética Historia: “Essendo la nostra anima unospirito immateriale, i corpi non possono produrre né benené male nelle cose immateriali. […]. E l’anima,nell’istante della sua infusione, rimane determinata neisuoi gradi di bontà, o di qualità non tanto buonarispetto al naturale (non dico al morale, bensì alnaturale). E da ciò deriva che dalla capacità del corposi può misurare la capacità dell’anima, sicché alcuniuomini hanno l’anima più perfetta o meno perfetta dialtri. […]. Il limite della natura dell’anima negliuomini è proporzionale alla capacità del corpo”.
Per Las Casas l’unità del genere umano non traevaorigine da un’uniformazione astratta, ma dalla suaunitarietà trascendentale. Insomma, gli esseri umanierano uguali sebbene diversi perché le loro animediscendevano dall’unità del divino, che le informava.Come abbiamo appena appreso, ciò non significava che leanime umane fossero identiche. Sempre nell’ApologéticaHistoria leggiamo che “secondo la capacità del corpo simisura la capacità dell’anima e alcuni uomini hannoun’anima più o meno perfetta di altri”. In pratica ilcorpo mediava tra anima ed intelletto e siccome questovaria da persona a persona, allora anche la comunicazionedell’anima al corpo sarebbe stata qualitativamentediversa. “E questa è la ragione per cui possiamo vedereche alcuni uomini ci appaiono più acuti e lucidi di altrie meglio provvisti delle virtù naturali”. Ma sempre di
162
anime si trattava, e quindi di pari dignità, giacché“ogni anima rimane sempre la medesima, a seconda dellasua specie”. Alle variazioni individuali si sommavanoquelle climatiche, l’influenza dell’alimentazione,dell’educazione e della cultura, che per Las Casas erauna seconda natura, ma pur sempre seconda, ossiamodificabile. A prescindere dalle cattive azioni deimembri di una data popolazione, ogni singolo essere umanopoteva essere convinto ad abbracciare una vita moralmentee spiritualmente sana, cioè quella in cui non peccacontro la sua anima; questo per opera del dialogo edell’uso della razionalità. Perché, come ci spiega nel Deunico vocationis modo omnium infidelium ad veram religionem, “Dio haprovvisto l’anima umana di una luce intellettuale, con laquale le ha fornito una certa conoscenza di se stessa,che è il principio di conoscenza nell’ordine della fede…inoltre ha instillato in tutti gli esseri naturali iprincipi germinali di tutti gli effetti che dovrannoprodurre. Per questo l’uomo può raggiungere da lontanouna qualche conoscenza di Dio per mezzo della ragionenaturale”. Un altro evidente riferimento alla tradizionesocratica, passando per Agostino: la conoscenza di sé èla via maestra per la conoscenza del divino. La natura, amaggior ragione quella umana, è un riflesso dellasapienza divina, verso cui tende finalisticamente. Diorisiede nell’intimo di ciascuno, ne dipendiamoesistenzialmente, siamo il punto di convergenza delleforze cosmiche che da esso emanano. Di conseguenza gliindios potevano vivere in armonia con la verità anche sel’avevano vista e compresa solo parzialmente; erasufficiente che si fidassero dei loro impulsi piùprofondi, più naturali, che certamente li avrebberoavvicinati alle Sacre Scritture. La fiducia di Las Casasin se stesso e nei nativi americani era dunque una vasta,incontenibile fiducia nell’uomo e nella sua sintonia conla Verità, con il Divino. Si trattava solo di faremergere questa sintonia, questo desiderio di Bene e di
163
Vero, con una prassi evangelica che, ancora una volta, amio avviso, assomigliava dappresso alla maieuticasocratica.
In questa stessa ottica gli Spagnoli erano ancoradistanti dal traguardo. Ogni universo culturale umano erain ritardo, non avendo realizzato la sua vocazionenaturale e storica. L’imperativo era quello di realizzareil proprio potenziale di perfettibilità che, d’altronde,era un’esigenza intrinseca alla natura propria dell’umanoed andava rispettata e promossa dai governanti con ognimezzo possibile, dando priorità all’evangelizzazionecristiana, nel pieno rispetto della volontà dei singoli.Ma come si poteva garantire che ciò avvenisse? Non certoconservando forme di esercizio del potere assoluto, mastabilendo libere elezioni in un regime di democraziadiretta. “Come se tutti fossero liberi e non uno piùsignore di un altro…ma che invece tutti o la maggiorparte di loro si radunassero e si accordassero,scegliendo o eleggendo qualcuno che sia generalmentericonosciuto come più prudente o irrobustito dalla naturain una qualche grazia o virtù speciale…e vi sisottomettano di loro propria volontà e consensualmente”.In piena ascesa dell’assolutismo monarchico il vescovodel Chiapas proponeva l’istituzione del suffragiouniversale maschile e femminile nella cornice di ungoverno repubblicano e liberale, dichiarava che un regimepolitico sarà più perfetto quanto maggiore sarà lalibertà che concede ai cittadini, ribadiva che “i sudditinon sono sottoposti alla potestà del re, ma a quella diuna legge giusta” e asseriva che “il potere di sovranitàprocede dal popolo, senza alcuna mediazione” e che chigovernava rimaneva un delegato, ossia un servitore dellacomunità (intesa nel senso moderno di persona giuridica),e del bene comune. “Nessuna sottomissione, nessunaservitù, nessuna imposizione si può dettare ad un popolosenza che questo, che deve sopportarla, dia il suo liberoconsenso”. Il fondamento del principio di giustizia, che
164
per lui era preminente, visto che, per citare Isaia, “lapace sarà opera della giustizia” e “la vera e propriapolitica, secondo i filosofi e la filosofia morale,consiste nella giustizia, che si realizza quando ognivicino o cittadini o membro di una repubblica è contentodi ciò che ha e coltiva una disposizione conforme allasua condizione ed alle sue mansioni, agendo secondoquanto ci si attende da lui, e vivendo in pace ed amorecon gli altri, senza offesa o danno al prossimo”(Apologética Historia). Da ciò ne conseguiva che la giustiziasi sarebbe compiuta solo se si fosse ascoltato il pareredei cittadini. Infatti, in un memoriale inviato a FilippoII nel 1556, Las Casas ricordava all’imperatore che unsovrano non rende più giusto per legge ciò che per lalegge di natura è ingiusto e lo invitava a sondare leopinioni dei sudditi, inclusi gli indigeni, giacché“secondo la legge naturale e divina devono essere…avvisati, ascoltati ed informati in merito ai lorodiritti (de lo que conviene a su derecho)”. Nel De regia protestateil Nostro insisteva che “nelle questioni che possonoavvantaggiare o colpire tutti, è necessario agire inaccordo con il consenso generale. Per questa ragione inogni genere di affari pubblici si deve chiedere ilconsenso di tutti gli uomini liberi…di tutto il popolo”.
È piuttosto sorprendente che riflessioni cosìavanzate come quelle contenute nel De regia protestate e nelsuo compendio, il Derecho Público, non siano quasi mai statesegnalate da politologi e storici e che rimanganoconfinate a ristretti circoli di esperti del periododella Conquista e delle opere lascasiane. Nasce ilsospetto che la sua fedeltà alla Chiesa Cattolica, lapubblicazione postuma, l’identificazione dell’autoreunicamente con le denuncie delle atrocità della Conquistae la sua prossimità alle più luminose stelle delfirmamento della teoria politica dell’epoca come Erasmo,Vitoria, Machiavelli e Hobbes abbiano oscurato la potenzavisionaria e lungimirante delle sue formulazioni. Nel
165
modello lascasiano agli indios mancava solo unaconoscenza adeguata della vera religione per diventareesseri umani modello: la parola del Cristo si sarebbeinnestata su un’ottima base di partenza e avrebbe espulsoi gravi peccati della loro tradizione (antropofagia,sacrifici umani, idolatria, ecc.), il primo passo versouna completa rivoluzione dell’umano che, partendo dalleAmeriche e per tramite della fede, avrebbe interessato ilmondo intero, riconducendo l’umanità allo stato adamicoprimigenio, quello precedente alla cacciata dal ParadisoTerrestre. Gustavo Zagrebelsky (1992, p. 141) haperfettamente ragione quando sostiene che “tutte ledottrine dei diritti nel senso dell’umanesimo laico sigiustificano solo nell’ambito di un’antropologiapositiva” e che “ogni antropologia negativa (come quelledell’uomo quale la più feroce tra le bestie feroci odella natura umana degradata da una colpa originaria) èpiuttosto la premessa delle teorie dei doveri”. Non c’èuguale dignità e comunanza di intenti ed aspirazionisenza empatia e fiducia nel potenziale umano. Las Casasattraversò l’Atlantico dieci volte per diffondere, ognivolta più veementemente e con argomentazioni piùstringenti, la sua antropologia della speranza, tuttaincentrata sul potenziale degli indiani e non sui lorodifetti, sulla loro dignità intrinseca ed uguaglianzarispetto agli Spagnoli, sull’uguaglianza di tutti gliesseri umani in Cristo. Laddove i suoi critici sminuivanole virtù degli autoctoni e li indirizzavano verso unprocesso di adattamento meccanico al Nuovo Ordine, luisottolineava la loro immaginazione e creatività.
Diversi studi sociologici, confermando il sensocomune, indicano che chi ha una visione positiva dellanatura umana è più tollerante verso la libertàd’espressione e di sperimentazione. Chi invece reputa chele persone siano guidate da egoismo, cupidigia ed altrepassioni distruttive appoggia misure liberticide. LasCasas, evidentemente, andrebbe inserito nella prima
166
classe di persone. Egli credeva negli indigeni e negliSpagnoli, credeva nella possibilità di una fondamentale edurevole solidarietà nata dalla comunanza degli scopi,dei successi, delle paure, delle sconfitte. Nel NuovoMondo il domenicano aveva intravisto un paradisopossibile, uno scorcio di quello che sarebbe potutoessere il Regno di Dio dopo il secondo avvento di Cristo,una forma più alta di civiltà a portata di mano se sololo si fosse voluto con tutta la forza e la sinceritànecessarie, se si fosse fatto lo sforzo di vincerepregiudizi, egoismi, sfiducia e diffidenza. Las Casas sirifiutava di credere che il destino dell’umano fossedeterminato da un ordine naturale/divino che prescrivevacome sistema politico-sociale ideale quello del branco dilupi o dell’alveare, dove non c’era alcun perché – Hier istkein warum, come spiegava un guardiano di Auschwitz aPrimo Levi. L’amore di Las Casas per la libertà scaturivadalla comprensione antropologica della maniera ideale dieffettuare la promozione e crescita delle capacità umane,di portare l’umano alla sua piena espressione,l’emancipazione da forze e circostanze che looggettificano, che lo rendono passivo, prevedibile,meccanico, impotente. Mentre gli oggetti hanno cause, isoggetti hanno motivazioni e ragioni complesse e taloracontraddittorie, hanno un peculiare caratteretrasformativo che Las Casas aveva scoperto in sé, negliindigeni e negli stessi Spagnoli. Forse, ancora unavolta, la sua origine da una famiglia di conversos loaveva reso più sensibile all’esigenza di essere giudicatiper ciò che si è e si fa qui e ora, non per un passatosul quale non si ha voce in capitolo. Gli Indios avevanofatto degli sbagli, questo era fuori di dubbio, ma nonavevano mai ascoltato le parole del Cristo, non avevanomai conosciuto alternative praticabili al loro sistema divita.
Las Casas era sicuro che la natura è buona quandoemerge dalle mani di Dio ed il suo ordine e bellezza non
167
sono intaccati dai peccati umani. Gli schiavi di naturasarebbero dei mostri, ma i mostri sono creazioni umane,non naturali. La legge naturale vivificatadall’evangelizzazione doveva costituire il volano delcambiamento, della liberazione dalle strutture oppressivedella Conquista e di una parte della tradizione indigenache non era conforme alla legge naturale edall’insegnamento di Cristo. I tempi e i modi sarebberostati affidati alla discrezione dei sovrani indiani sottouna guida apostolica che si sarebbe attenuta alprincipio, definito nei suoi Remedios del 1516, che “gliIndios sono uomini liberi e devono essere trattatisimultaneamente come uomini e come uomini liberi”.
Come Thomas Paine, Las Casas lottò per i diritti deivivi, affinché questi non fossero defraudatidall’autorità dei morti, ossia da una tradizioneincartapecorita. L’umano doveva avere la precedenza,perché solo così, elevandosi, si sarebbe realizzata laconvergenza di tutti gli esseri umani verso Dio, in unavasta fraternità elettiva. Il libero consenso informatocostituiva la via maestra per questa trasformazionemillenarista. A differenza di moltissimi altrimissionari, lui non aveva avuto alcun problema adaffermare pubblicamente di preferire “un indiano paganovivo e libero” ad “un convertito morto o schiavo”. PerLas Casas un’umanità universale aveva doveri universaliverso i suoi membri. Come specificava Sant’Agostino,“Quando si dice ama il tuo prossimo, è chiaro che ogniuomo è il nostro prossimo” e come affermava Ovidio,“L’uomo non è un lupo per l’uomo, ma un uomo”, altrimentinessuna società sarebbe in grado di sopravvivere. Sevogliamo, il suo atteggiamento verso gli indoamericaniera, più o meno consapevolmente, all’insegnadell’integrità morale ed intellettuale socratica, comemezzo per ridurre l’ingiustizia nel mondo, non strumentoper maltrattare ed approfittarsi degli altri.Un’integrità che si nutriva di fede umanitaria, nobiltà
168
di cuore, vitalità, spontaneità, tenerezza, sincerità,fierezza ed empatia. Ma anche dell’impetodell’indignazione di fronte all’ingiustizia più smaccata,il rifiuto di accettare che gli indios si piegassero e siabbandonassero ad una vita indegna di loro, in quantoesseri umani. C’è tutto il Camus del “mi rivolto, dunquesiamo” nello sdegno di Las Casas contro un mondosottosopra, dove il male è chiamato bene ed il bene èisolato. Las Casas non provava solo indignazione ma anchevergogna per quegli Spagnoli come lui, quei Cristianicome lui che lo imbarazzavano o lo insultavano con illoro comportamento. Rifiutava la complicità nei loromalaffari. Diceva no, per sé, per gli Indios, ma ancheper gli stessi Spagnoli. “Vostra Maestà farà a tutti glispagnoli che si trovano nelle Indie un’incredibile edinestimabile grazia, liberandoli dai grandissimi peccatidi tiranni, latrocinio, violenza e parricidio checommettono ogni giorno opprimendo e ammazzando quellegenti” (Memoriale a Filippo II). In lui c’era la tenaceconvinzione che chi crede sinceramente in Cristo saràsalvato da questo inferno in terra, sarà reso immunedalle malattie dell’anima, dalla bestialità dilagante,dall’inerzia morale, dall’intorpidimento psicologico ementale che si sono impadroniti di vittime e carnefici,intrappolati in questo particolare ordine di esistenza.Sarà reso padrone del proprio destino e libero dalcontagio anti-cristiano delle brame materialistiche e deivili egoismi riduzionistici caratteristici di unamentalità mercantile, tesa esclusivamenteall’appropriazione ed all’accaparramento. Non sarà più unessere umano come gli altri, ma un eletto.
I diritti umani
[L’oppressione degli indigeni] è contro l’intenzione di Cristo e contro la formadi carità che nel suo Vangelo ci ha tanto raccomandata, e contraddicecompletamente, a ben guardare, tutta la Sacra Scrittura
169
Bartolomé de las Casas
Il significato di “diritti umani” è molto semplice:gli stessi diritti per ogni essere umano. Sonofondamentali perché sono quelli che tutelano i debolidall’arbitrio dei forti, i poveri da quello dei ricchi,le minoranze da quello delle maggioranze. In un mondosegnato da enormi sperequazioni ce n’è un disperatobisogno ed andrebbero inseriti in una cornice legaleindissolubile che permetta di contrastare la bigotteria,santimonia, pregiudizi, debolezze, soverchierie di quegliesseri umani che esercitano una qualche forma diautorità, potere o controllo su di noi. Senza di loro, lepersone che bramano il potere di per se stesso avrebberomano libera. Nessuno dovrebbe sentirsi sufficientementesicuro senza questo tipo di tutela, quando la storia,anche la storia presente – si vedano i dibattiti sulPatriot Act negli Stati Uniti e sulle libertà civili nelRegno Unito, la nazione che, assieme a Singapore, è lapiù monitorata del mondo – ci insegna quanto sia fintroppo facile abolire certi diritti che sono costatisangue e sacrifici alle generazioni precedenti. I dirittiumani devono venire prima di ogni altro dovere, perchéaltrimenti non sono più tali e vengono subito sacrificatinel nome di qualche fine “più alto”. Hannah Arendtsottolineava che i diritti umani garantiscono che gliesseri umani non vengano de-umanizzati, ridotti a mericorpi che non sono altro che macchine per soffrire. PerSimone Weil esiste una verità primordiale della nostranatura alla base dell’etica e del diritto ed è che “c’èin noi un obbligo verso ogni essere umano per il solofatto che è un essere umano…Quest’obbligo non si fonda sunessuna situazione di fatto…su alcuna convenzione…Quest’obbligo è eterno. Risponde al destino eternodell’essere umano”. Secondo il filosofo moraleaustraliano Raimond Gaita, l’amore per le persone,specialmente quelle più difficili da amare, è alla base
170
dei diritti umani universali (Gaita 1991). Gaita sostieneche “se non fosse per i molti modi in cui gli esseriumani si amano l’un altro – dall’amore sessuale a quelloimparziale dei santi – non credo che avremmo un sensodella sacralità degli individui o dell’inalienabilità deiloro diritti e dignità” (Gaita, 2000). Credo cheinterpreti benissimo il pensiero giuridico-morale di LasCasas che, nei Principia Quaedam del 1551-1552 tratteggiavauna teoria dei diritti civili ed umani, applicata al casoindiano, non ancora sistematica, ma certamente incisiva,sebbene inadatta ad un’epoca come la nostra, dispiritualità panteista o ateismo materialista: “Poichéqueste genti indiane sono, per natura, umilissime, moltopusillanimi e, nella maggior parte, pacifiche e miti, percui possono facilmente essere maltrattate ed oppressedagli spagnoli. Per la stessa ragione i re di Spagna sonoobbligati, come condizione necessaria alla loro salvezza,a difenderle da quelli, non come si vuole, maefficacemente, con l’amministrazione della giustizia edaltri opportuni rimedi; a ordinare, regolare e disporreil loro regime in modo tale che, vivendo questi popoli inpace e tranquillità, conservando i loro beni e diritti,liberandosi da tutti gli impedimenti esterni, abbraccinogradatamente, liberamente e facilmente, la fedecattolica; assimilino i buoni costumi e, credendo in Dio,loro vero creatore e redentore, raggiungano il fineproprio della creatura razionale, ossia la felicitàeterna, che è allo stesso tempo l’obiettivo e l’intentodi Dio”. In questa esortazione scorgiamo, in nuce, idiritti fondamentali contemporanei (Kateb, 2011).
Per Las Casas non esistevano diritti naturalidissociabili dalla Provvidenza Divina. Essi si irradianodall’Amore, dalla Giustizia, dalla Grazia e dalla Veritàdi Dio. Chi li vuole intendere li intenderà, gli altririmarranno invece sordi e ciechi. Lui stesso racconta diuno spagnolo che aveva seviziato un’india che gli si era
171
rifiutata, per poi bruciarla viva. Fu condannato alpagamento della risibile somma di 5 castellanos: Las Casassa che Dio non si dimenticherà di lei, perché proprio levittime innocenti dei persecutori gli sono più care.“Chi, se ha cuore di carne e viscere umane, potràsoffirire che vi sia una crudeltà così inumana? Qualememoria di quel precetto della carità “amerai il tuoprossimo come te stesso” ci sarebbe mai dovuta essereallora in coloro che, a tal punto dimentichi di esserecristiani e persino di essere uomini, trattavano così –in quegli uomini – l’umanità?” (Historia).
Il torturatore, o l’addomesticamento dell’uomo - parteprima
[L’autorità] non invano porta la spada; è infatti al servizio di Dio per la giustacondanna di chi opera il malePaolo, Romani 13:4
Chi potrebbe dubitare che è certo meglio condurre gli uomini all'amore diDio con l'istruzione e la persuasione, piuttosto che costringerveli con iltimore e con il dolore del castigo? Ma per il fatto che gli uni sono mezzimigliori, non ne segue che i secondi debbano essere trascurati; infatti è utilea molti prima essere scossi dal timore e dal dolore, per poi essere disposti avenir istruitiAgostino di Ippona
Nessuno ha il diritto di trattare qualcuno altrocrudelmente a fini pedagogici o di intrattenimento. Dionon avrebbe mai creato l’universo semplicemente perinsegnare qualche lezione morale o teologica del tipo“non infliggere delle sofferenze non necessarie”. Un diodel genere, amante di astute seduzioni, “edificanti”tormenti e complotti ben elaborati ai danni di esseriumani ignoranti, piuttosto che malvagi, sarebbe nemicodel messaggio di Cristo e dell’umanità stessa. Il suocomportamento sarebbe infantile, sadico e manipolatore,
172
psicopatico, indegno di Dio. Le torture, incluse quellepsicologiche e mentali non sono mai giustificabili, pernessun motivo o fine. Molti tra i simpatizzanti deimetodi spicci di certi evangelizzatori della Conquistanon sarebbero stati d’accordo. Il fine era “nobile” – lacrescita della consapevolezza civile degli indigeni ed ilbene dell’Impero –, la mortificazione ed il degradodell’umano solo una fase transitoria ed inevitabile. Infondo, senza vaste crisi, questa la logica retrostante,non ci si libera dall’inerzia dei propri abiti mentali.La questione più attuale e fondamentale è naturalmente sesia lecito manipolare gli altri, sottoporli magari ad unacerta misura di sofferenza psicologica, per il loro bene,per aiutarli a correggere i loro comportamenti edabitudini. Sepúlveda rispondeva affermativamente, LasCasas negativamente. Molti francescani si schierarono,idealmente, dalla parte di Sepúlveda, i domenicani, alcontrario, concordarono in gran parte con Las Casas.Cerchiamo di capire perché, partendo da una provinciacoloniale dello Yucatán, Maní, amministrata daifrancescani.
Nel 1561, Vasco de Quiroga, il compassionevole edilluminato vescovo del Michoacán (oggi uno statomessicano collocato tra la Cordigliera e la costapacifica centrale), denunciò i soprusi ai quali i fratidi diversi ordini sottoponevano gli indigeni che eranostati affidati loro. La descrizione delle violenze edegli abusi era così sconvolgente che non furono in moltia prenderlo sul serio. Persino numerosi storici hannorinunciato ad investigare questa ed altre denunce, quasiche non fosse opportuno macchiare l’immagine degli ordinimendicanti. La realtà, purtroppo, è che i frati sonoesseri umani come gli altri e, in quelle circostanze, nonfurono sempre all’altezza dei principi ispiratori deirispettivi ordini. La loro “caduta”, però, ci aiuta acomprendere meglio uno dei punti deboli più gravi della
173
nostra concezione del processo civilizzatore, ilpaternalismo redentivo (Clendinnen, 2010).
Oggi sappiamo che Vasco de Quiroga parlava a ragionveduta ed era molto ben informato. In quegli anni erapratica comune tra gli ordini mendicanti quella di“trasferire” migliaia di indigeni a fini didattici.Sovente, non ci si premurava di fornire un minimopreavviso. Le famiglie ricevano la visita di frati e deiloro coadiutori e venivano sfollati, le loro case datealle fiamme, i loro poveri beni distrutti. Alcuni deideportati morivano di privazioni, altri si lasciavanomorire per la disperazione. Il palo delle fustigazioni alcentro delle nuove comunità (reducciones) era il simbolodel potere ed un costante ammonimento a non violare leregole. Le feste erano bandite e vigeva il coprifuoco.Non esistevano più case comuni ma solo abitazionimonofamiliari. Anche questo accorgimento doveva servire asfibrare il tessuto sociale tradizionale, allentando ilegami clanici.
Qualche mese dopo il j’accuse di Quiroga, i francescanidi Maní – tra una quindicina ed una ventina diconfratelli – istituirono un regno del terrore chesconcerto e traumatizzò non solo molti coloni, ma persinogli altri francescani che arrivarono ad ispezionare lecomunità coinvolte quest’opera di epurazione violenta delpaganesimo. I frati disciplinatori rimasero però persuasifino alla fine di stare facendo non solo ciò che eragiusto, ma soprattutto ciò che era indispensabile. Tantoche protestarono veementemente contro le denunce deiconfratelli, chiamandoli traditori ed invocando inchiesteai loro riguardi.
Cosa avvenne? Nel maggio del 1562, dopo diciassetteanni di predicazione, i francescani di Maní si accorserodi essere stati ingannati dai loro protetti quando,ispezionando una caverna, vi trovarono idoli e teschiumani. Inizialmente si erano limitati a minacciare gliindigeni con la promessa della collera divina se non
174
avessero rinnegato i loro dèi. Ma, vista la loroostinazione, la suddetta scoperta divenne la goccia chefece traboccare il vaso, scatenando un’isteria collettivanei predicatori, che passarono alle maniere forti, allepunizioni corporali. Da quel fatale istante si verificòun’escalation nell’uso della violenza disciplinare ecorrettiva. La tortura, questa pratica infernale, divenneuno strumento di disciplinamento e di didattica. Convintiche le confessioni estorte sotto tortura potessero essereplausibili, non esitarono a credere ad un quadrodesolante: sacrifici umani, cuori ancora pulsantistrappati dal petto, crocifissioni di bambini. Nonpossiamo decisamente escludere che certe praticheavessero ancora luogo, ma la bestiale rappresaglia chelanciarono contro l’intera popolazione e che siautoalimentò proprio a causa delle fantasie estratte dabocche tormentate, non si distingueva in nulla dallecostumanze indigene che loro stessi ritenevanodemoniache. In seguito, i frati si rifiutarono finchépoterono di rinunciare a questo metodo “educativo” cheavevano individuato ed applicato così scrupolosamente;anche se violava le leggi dell’Impero, anche se era agliantipodi degli insegnamenti evangelici. Si verificaronoarresti di massa, fustigazioni e torture indiscriminate,con l’uso della strappada (dall’italiano “strappata”), latecnica di tortura usata nel Castello del Buonconsigliocontro gli Ebrei accusati di aver sacrificato ilSimonino, nel 1475. Consisteva nell’issare il malcapitatolegato a delle funi tramite una carrucola, per poimollare improvvisamente facendo slogare le articolazionidelle vittime. Frate Diego de Landa coordinaval’inquisizione locale, facendo le veci di un vescovo chenon era mai stato nominato. Diego de Landa (1524-1579)meriterebbe un volume a parte. Giunto in Messico a soli24 anni, fu un torturatore, schiavista e, nel luglio del1562, il responsabile della distruzione di ventisetterotoli manoscritti maya – se si considera che ce ne sono
175
pervenuti solo quattro è come se avesse bruciato laBiblioteca di Alessandria messicana. Nonostante questo,gli fu permesso di diventare il secondo vescovo delloYucatán. Il suo zelo paranoico e “salvifico” non sifermava di fronte a nulla ma non gli impedì di scrivereuna “Relazione sulle cose dello Yucatan” che è uno deipochi documenti che permette a storici ed antropologi digettare uno sguardo sulla cultura e la società maya. Ilproblema, però, è che gli studiosi sono costretti afidarsi di una trascrizione abbreviata di un testoscritto da un cronista che solo pochi anni prima eraintenzionato ad annientare completamente qualunque“satanica” fonte primaria, che omette di menzionare ilrogo dei manoscritti e la tortura degli indigeni e che,nella sua analisi della lingua maya, commette errorigrossolani.
Landa, insoddisfatto dei risultati raggiunti nellaprima fase dell’inquisizione, la estese alle due provinceadiacenti di Sotuta e Hocaba Homun, con metodi sempre piùstravaganti ed esiti terribili. L’inchiesta ufficiale del1565, coordinata da Sebastian Vazquez, rivelò che oltre4500 uomini e donne furono torturati, più di seimilafrustati o rapati per punizione. 157 persone morirono perle conseguenze dell’interrogatorio, almeno una dozzina sisuicidò prima di finire tra le mani dei torturatori. Dialtri diciotto non si trovò traccia e si pensò che sifossero uccisi. Un numero imprecisato di persone rimasemenomato, con i muscoli delle spalle irrimediabilmentelesionati e le mani paralizzate.
L’inquisizione impiegava la tortura in tutte lecolonie, ma in modo molto selettivo e regolato. Non siera mai visto, né si vide mai, nulla del genere. Inqueste tre province, Landa e gli altri francescanidecretarono che tutti gli indiani erano idolatri e chenon si poteva sottoporli a processo uno dopo l’altro,perché vagliare ogni caso avrebbe richiesto decine dianni, mentre la minaccia era immediata. Quindi si optò
176
per la colpa collettiva, il reato preferito dai nazistiper giustificare le loro sanguinarie rappresaglie dimassa. Ci furono coloni spagnoli che cercarono diintervenire per interrompere il Terrore, ma rischiaronola loro stessa incolumità senza riuscire peraltro adottenere alcun risultato concreto. Solo l’arrivo delvescovo, un altro francescano, frate Francisco de Toral,spezzò l’infernale sortilegio che aveva trasformato unamissione evangelizzatrice in un cuore di tenebradell’onnipotenza. Toral pose fine al massacro dichiarandoche le confessioni estorte sotto tortura erano invenzioniche le vittime avevano offerto ai loro carnefici incambio della fine dei supplizi e che la prosecuzione dialcune delle loro idolatrie era del tutto naturale in unpopolo che aveva appena incontrato la vera fede. AccusòLanda di aver reagito in modo assolutamentesproporzionato a dei crimini minori, spinto da rabbia,arroganza e crudeltà. Lorenzo de Bienvenida, pionieredelle missioni francescane dello Yucatán, fu sconvoltonello scoprire che persone deputate alla tutela degliindigeni si erano trasformati nei loro giudici,torturatori e boia. Entrambi furono però denunciatiall’ordine dai francescani di Maní, con l’accusa ditradimento. A tre mesi dal suo arrivo, Toral rimaseisolato. Anche quando Landa fu convocato dal Consigliodelle Indie per essere processato, i francescani suoicomplici continuarono a difendere la bontà del lorooperato. È tempo di cercare una spiegazione per questocomportamento disumano.
L’ordine francescano aveva stabilito che lo statusdegli indigeni era quello di bambini ed i figli sieducavano anche con le percosse ed il terrore. Alcontrario i domenicani, più versati nel diritto e nellateologia, erano riluttanti ad usare la forza percostringerli a credere alla sacre scritture. Secondo ifrancescani, la naturale docilità degli indigni li avevaresi più vulnerabili alla subdola azione del demonio.
177
Erano troppo impressionabili e volubili e con la stessafacilità con cui aderivano alla cristianità rischiavanodi allontanarsene, per questo andavano sorvegliati ecastigati diligentemente. Per questi predicatori lacondizione infantile non era una fase transitoria ma unostato permanente, come permanente sarebbe stata la lorotutela. La furia punitiva dei francescani forseassomigliò a quella di un genitore autoritario tradito(Clendinnen, 2010). La slealtà indicava che quella terrae la sua gente erano dannate e la loro innocenza dovevaessere rigenerata attraverso la sofferenza espiatoria. Lostupefacente grado di narcisismo, mitomania e brama dionnipotenza di questo nucleo di francescani fece in modoche si persuadessero che sotto i colpi della frusta gliadulti indigeni sarebbero stati nuovamente restituitialla loro “naturale” condizione di bambini inermi,dolenti, frignanti, plasmabili. Senza una mano ferma gliindiani sarebbero invece stati ingovernabili, come glianimali della foresta non addomesticati. Grazie a questi“metodi spicci” potevano ritornare ad una fede semplice epura. La loro relazione speciale con gli indigenigiustificava ogni intransigenza. Quella che gli altrigiudicavano crudeltà gratuita era invece rigoreappropriato e proporzionato. Gli astratti principi dellalegge nulla potevano contro lo zelo riparatore eredentore di persone che avevano fatto della salvezza diesseri umani riottosi l’unica causa degna di essereperseguita.
I nativi dovevano essere guidati, salvaguardati dallaloro debolezza, dovevano delegare la propria volontà acoloro che, essendo più saggi, erano in grado di condurliper mano alla Salvezza. Dovevano collaborare nel loroaddomesticamento. I francescani di Maní misero in piediun’organizzazione che, consapevolmente, ripristinò ilprogetto millenarista dell’addomesticamento dell’umano.L’addomesticamento è il modello archetipico di ogni tipodi subordinazione sociale, il culmine di ogni esperimento
178
totalitario. L’anno della sua morte, lo zoologo franceseIsidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805 – 1861) fece intempo a pubblicare un libro sull’addomesticazione deglianimali e distinse tre possibili stati in cui l’uomo puòridurre gli animali per subordinarli al suo volere:ingabbiati, addomesticati e domestici. I primi, seliberati, tornerebbero in libertà senza essere segnatidall’esperienza. I secondi sono stati domati e non devonoessere tenuti prigionieri. La loro idea della vita idealeè stata radicalmente trasformata e stanno bene dove sono.Gli animali domestici sono una specie che ormai riproducead ogni generazione la condizione di addomesticamento.Non è più una condizione di subordinazione interiorizzataa livello individuale, ma collettivo. Non hanno più unavolontà indipendente da quella dei loro padroni. Questoera anatema per Las Casas, come lo sarebbe stato perGesù, che non controllava le persone, si limitava adinvitarle a seguirlo ed a seguire il suo esempio,liberamente. Al contrario, questi predicatorifrancescani, come Sepúlveda, si erano prefissatiprecisamente l’obiettivo di addomesticare e poiaddestrare ed gli indigeni. Ci pare di poter dire che nonebbero mai ripensamenti in merito alle loro azioni edalla moralità del progetto. Anche questa mancanza diturbamenti ed esitazioni merita la dovuta attenzione.
Gerónimo de Mendieta (1525-1604) fu un missionariofrancescano nella Nuova Spagna (Messico) che riuscì aconciliare nella sua coscienza due identità: quella diintransigente ingegnere sociale di una nuova utopia chedoveva anticipare l’avvento del Regno di Dio e quella,direi “lascasiana”, di difensore degli indigeni dallosfruttamento, dalla violenza, dall’umiliazione, dallabrutalità dei loro compatrioti. Mendieta aveva sviluppatoun’interpretazione mistica della conquista, marcata daprofetismo e messianismo. Credeva, come Sepúlveda, cheoccorresse usare la forza per convertire gli infedeli, manon una forza illimitata. In accordo col confratello
179
Motolinía, Mendieta affermava che essa doveva serviresolo per abbattere i regni locali e per distruggere ilpaganesimo. Un uso eccessivo sarebbe statocontroproducente nella fase della predicazione, perchéavrebbe alienato le simpatie dei nativi. La relazionepaterna tra predicatori ed indigeni sarebbe invece statasufficiente.
Abbiamo visto che esisteva una divergenza di vedutetra francescani – empiristi, pratici, carenti in culturaumanistica – e domenicani, che avevano spesso ricevutoun’educazione accademica. Mendieta ripudiava l’assuntolascasiano che esiste un solo metodo per convertire tuttii popoli del mondo e che questo metodo non puòprescrivere la violenza. Sepúlveda sottolineava il fattoche la Chiesa non poteva comportarsi allo stesso modoprima e dopo Costantino (criterio cronologico), Mendietaosservava che maggiore era la distanza dalle fonti dellafede, maggiore doveva essere l’esercizio di pressionicoercitive (criterio spaziale-geografico). Mendietacredeva che la Spagna fosse stata prescelta da Dio comenuova Israele per portare la sua parola ai quattro angolidel mondo, unificando la terra in vista del secondoavvento. Questo doveva essere ormai prossimo, visto che,a suo parere, ormai tutte le terre emerse ed i popoli delmondo erano stati scoperti e si sarebbero prestoconvertiti alla fede cristiana.
La Spagna era una teocrazia messianica, i sovranidegli apostoli tra gli infedeli, i primi missionari dellamonarchia universale. Il loro compito era quello didiffondere il vangelo tra i pagani ed i loro esercitierano le armate del signore, destinate a vincere perchéDio le favoriva (Gott mit uns, dicevano i nazisti). AncheLas Casas credeva che i monarchi di Spagna fossero statiinvestiti di una sacra missione, ma non arrivò mai acredere che il successo di questa missione evangelicapotesse essere l’unica lente attraverso cui osservare larealtà locale, l’unico parametro etico in funzione del
180
quale si doveva decidere quali dovessero essere le regoledi condotta nei confronti degli indigeni. All’opposto,questa fu proprio la strada imboccata da Mendieta, la cuimentalità era spiccatamente veterotestamentaria. Per luiFilippo II era il Messia, il Re del Mondo che dovevaconvertire l’umanità alla vigilia del GiudizioUniversale.
C’era tra i francescani chi, come Pedro de Azuaga,vedeva gli indios diversamente da Mendieta. Per lui nonerano degli esseri umani spogliati di tutto il superfluoe ridotti al denominatore essenziale dell’umanità,l’innocenza infantile, come pensava Mendieta, sicuro cheproprio per questa ragione sarebbero stati più facilmenteconvertibili e perfettibili rispetto agli altri esseriumani. Azuaga interpretava la prontezza con quale siinchinavano alla fede cristiana come manifestazione dimero opportunismo, ipocrisia e timore delle possibilirappresaglie in caso di diniego. La presenza militarespagnola doveva servire a prevenire un ritorno al vecchioordine, con l’espulsione dei coloni e dei frati.
Mendieta invocava al contrario una completasegregazione degli indigeni da tutte le altre razzepresenti nel Nuovo Messico, per tutelarli dall’influenzacorruttrice del Nuovo Mondo: “nel dubbio, bisogna semprepresumere che lo spagnolo sia il reo e l’indiano lavittima”. Con un’efficace metafora: “è un fatto notorioed evidente che quando si mescolano grandi e piccolipesci, i primi divoreranno molto presto tutti gli altri”(Phelan, 1970).
Tuttavia, per la stessa ragione, anche il dirittoromano, quello a cui si appellava Las Casas per difenderei nativi, non doveva essere applicato nel Nuovo Messico:troppo complicato per le loro menti semplici, troppoinadatto alla loro primordiale innocenza. Al suo posto,si sarebbe istituita una disciplina pedagogica epaternale. I frati dovevano esercitare un controlloillimitato sui nativi, per il tramite del vicerè, fondato
181
non sulle leggi umane ma su quelle della natura. Essendouomini naturali, la relazione più naturale doveva esserequella padre-figlio, in un regime di adozione reciproca.In ossequio al magistero del teologo francescano DunsScoto, l’autorità monarchica doveva essere onnipotente edeteneva la prerogativa di promulgare ed abrogarequalunque legge, nonché confiscare qualunque bene diproprietà, ridistribuendolo a suo piacimento. La visionedi un tiranno assoluto, plasmatore dei corpi e dellecoscienze umane, piaceva molto anche a Motolinía e aSepúlveda, quest’ultimo dell’avviso che ogni forma divita inferiore dovesse essere naturalmente subordinata aquella ad essa superiore, attraverso una tutela legale,come per i minori in affido temporaneo che, però, nelcaso degli indigeni, si profilava come un affidopermanente. Tuttavia, a differenza di Sepúlveda, Mendietaspiegava che quell’inferiorità era in effetti unvantaggio che avrebbe reso gli indigeni piùautenticamente cristiani dei supposti cristiani delVecchio Mondo.
Ricapitolando, l’ipotesi che spiega piùplausibilmente la condotta dei francescani nello Yucatánchiama in causa l’intersezione di attese messianiche e diuna spiccata tensione paternalista ed utilitarista,fondamentalmente ed inevitabilmente avversa alla dignitàumana Infatti la logica dell’utile non può che accettareche si commettano delle atrocità e si assoggettino lepersone, se ciò può aumentare le opportunità di salvezzapersonale e collettiva sia delle vittime, sia deidisciplinatori.
A ben guardare, l’insegnamento principale che fuimpartito ai nativi americani dai coloni e da moltievangelizzatori (non solo quelli di Maní) fu: se sietediligenti, obbedienti e lesti nell’apprendere le lezionie metterle in pratica, sarete degni di integrarvi nelnuovo ordine coloniale, in una posizione subordinata. Si
182
può ben capire come mai gli indios non fossero cosìentusiasti di abbandonare le loro tradizioni e di sognareun ritorno al passato.
In questo capitolo abbiamo scoperto che c’eranofrancescani che non mettevano in dubbio la giustezza delpostulato che sia giusto sottoporre un essere umano apressioni coercitive, stimoli dolorosi e persino torturapsicologica o fisica se il fine ultimo è quello della suailluminazione e maturazione. La tortura poteva avere finididattici, se serviva ad individuare le mele marce nellacesta, le pecore nere nel gregge. La violenza psicologicaera un passaggio centrale dell’iniziazione, il senso dionnipotenza l’attributo caratterizzante gli iniziatori.Nulla poteva essere lasciato al caso oall’improvvisazione, in questo esperimento di induzionedi una catarsi collettiva, perché il demonio era semprepronto ad interferire, a tentare, a spingere dalla suaparte le pecorelle smarrite.
L’impressione che di questa vicenda si è fatto chiscrive è che il feticismo delle idee è nocivo per ladignità delle persone, che la vocazione assolutista dichi vive di idee rischia di sfociare nel disprezzo per lepersone comuni. Mi domando quanti evangelizzatori sianoriusciti ad astenersi dal manifestare pubblicamente unacerta boria e sdegno nei confronti dei “discepoli”, datoche le loro realizzazioni non corrispondevano mai alleidee pure, ai progetti ideali che avevano formulato nelleloro menti. La discrepanza tra realtà e immaginazione eratale che possiamo immaginare che non furono pochi quelliche non riuscirono a sopprimere un moto di disgusto perciò che stonava, per quegli esseri umani “fuori luogo”.
Mi chiedo anche se dietro l’ardore di un Diego deLanda o di un Juan Ginés de Sepúlveda non fossero celatidei bisogni narcisistici insopprimibili che li spingevanoa chiudersi autisticamente nel loro bozzolo di certezze,nel loro personale universo di determinismi,semplificazioni, autoritarismi, fantasie di dominio e
183
bramosie demiurgiche, che li deresponsabilizzavano,spostando il fardello della colpa sui difetti congenitidei pagani. Un autoinganno che bollava come minacciatutto ciò che contaminava la purezza dell’idea fissa,l’estetica dell’ordine ideale come se l’erano immaginati.Il Cuore di Tenebra di Maní non fu forse un’epidemia dinarcisismo tradottosi in fanatismo religioso?
Il narcisista, se privato della sua sorgente diconferme e rassicurazioni – i coscienziosi indigeni – sisente vuoto e depresso, inutile, senza scopo, amorfo,ansioso ed insicuro. Soffre di considerevoli oscillazioninell’autostima e può arrivare a credere che la vita nonsia degna di essere vissuta. Per evitare questo tragicoepilogo sente l’impulso di aggrapparsi ad una qualchefigura o idea dominante che fornisca un sostegno solido.Molti binomi padrone-servo potrebbero esseretranquillamente invertiti, perché entrambi sono narcisied hanno bisogno di quel tipo di rapporto patologico piùdi quanto necessitino di un certo status. È il vuotointeriore, l’inautenticità, la perdita di senso,l’incertezza del futuro che paventano più di ogni altracosa. La superficialità non è un problema, il narcisistaè in ogni caso antropologicamente pessimista, il suopensiero non è mai profondo, né lo è la sua stima neiconfronti degli altri esseri umani, che non sono mai suoisimili.
Non ho la pretesa di poter spiegare in terminipuramente psicologistici quel che accadde nel 1562,l’anno in cui Las Casas, ormai in età avanzata e prossimoalla morte, inviava l’ennesimo memorandum per ilConsiglio delle Indie, in cui dichiarava, senza mezzitermini, che gli indios “hanno il diritto di condurre unagiusta guerra contro di noi e di spazzarci via dallafaccia della terra”. Mi domando solo se questo attributo,che è patologico in alcuni, ma è anche un’inclinazionepiù o meno forte in ciascuno di noi, possa avere svolto
184
un qualche ruolo nell’estrema radicalizzazionedell’impegno missionario.
Magari lo sconcerto, la demoralizzazione, lafrustrazione, il risentimento che seguirono alla scopertadella grotta pagana, infiammarono gli animi di questifrancescani, spingendoli lungo la china di chi vede neglialtri esseri umani del materiale da rimodellare perrenderlo compatibile con una certa concezione di societàideale, a propria immagine e somiglianza, in unaspasmodica ricerca di purezza, autenticità e senso.
Il mago, o l’addomesticamento dell’uomo - parte seconda
Il potere non spezza, ma ammollisce, piega e dirige le volontà; non distrugge,non tiranneggia, ma ostacola, comprime, snerva, spegne, inebetisce tutti gliuomini, riducendoli come un branco di animali timidi e laboriosi, di cui loStato è il pastore.Alexis de Tocqueville, “La democrazia in America” (1840)
Durante la sua vita terrena, Gesù Cristo ha rifiutato la strada del poteretemporale, preferendo una vita umile, dolce, pacifica e povera. Las Casas
Il popolarissimo storico della Conquista FranciscoLópez de Gómara assicurava i suoi lettori che se volevanofarsi un’idea chiara ed affidabile della situazione nelleIndie dovevano consultare Sepúlveda, il cronistaimperiale, che aveva illustrato tutto ciò che eranecessario sapere nel suo elegantissimo latino. “Nerimarrete completamente soddisfatti”, concludeva. Oggiquesta nota di approvazione fa rabbrividire i fautoridella democrazia. La società ideale di Sepúlveda eraverticale, piramidale; certe categorie, pur non godendodegli stessi diritti di altre più privilegiate, eranozavorrate da molti più doveri. Alcune classi di esseriumani potevano essere asservite o recluse in caste, nonpossedendo il medesimo valore intrinseco delle altre. È
185
da questo ordinamento rigidamente gerarchico, neo-feudale– che colloca su una scala i cittadini, con la massimaconcentrazione di diritti in cima e la loro rarefazionein fondo – e dalla mentalità che lo contraddistingue, chediscendono le contemporanee argomentazioni in favoredella pena di morte, della tortura, delle “guerreumanitarie”, delle segregazioni interetniche e contrarieal basilare rispetto per la persona umana, che non va maiconcepita come uno strumento ma sempre come un fine, maicome una fotocopia o un ingranaggio sostituibile, ma comeun unicum di valore inestimabile.
Bernal Díaz del Castillo, nella Conquista della NuovaSpagna, condensava eccellentemente il senso dellacrociata della Conquista: “Al servizio di Dio e di SuaMaestà e per illuminare chi giace nell’oscurità – e ancheottenere quella ricchezza che molto uomini bramano”. Lascoperta del Nuovo Mondo offrì a molti la possibilità dirifarsi una vita, di migliorare la propria posizione. Adaltri dischiuse nuovi scenari di riforma sociale. Ci fuchi, come i missionari indigenisti, fu solleticatodall’idea di poter finalmente edificare quell’utopiacristiana che i movimenti monastici non erano riusciti arealizzare nel Vecchio Mondo. Ma ci fu anche chi, più omeno consapevolmente, colse l’occasione per rinverdirel’eredità patriarcale e feudale, con un Nuovo Ordinecostruito attorno a certi valori e principi che erano innetto contrasto con quelli umanisti che dominavano ildibattito teologico-politico nella madrepatria. Principicome quello secondo cui il disordine e la guerra erano lacondizione naturale dell’umano e che salde gerarchieerano necessarie per costringere gli esseri umani arispettare le leggi e la dottrina. Questi imprenditoridella morale non erano animati dal desiderio di elevarela condizione umana, ma piuttosto da quello di porsi allasommità della piramide sociale e degradare chi si trovavasotto. Intendevano controllare il gregge umano autoctono,come santi, angeli o dèi, sottomettendolo ad un regime di
186
vassallaggio permanente e ad un’energica campagna dicorrezione sociale, sulla base di una lettura selettivadell’Antico Testamento. Il loro intransigente moralismonon ammetteva compromessi e, miscelandosi al ciecorispetto per l’autorità e a forti venature razziste emisantropiche, produsse un composto altamente instabile,perché tendeva costantemente a sospingere verso l’altochi si trovava già in alto, e verso il fondo chisosteneva la piramide in basso. Se fossero riusciti aprevalere, le loro procedure di governo sarebbero stateall’insegna della paura, dell’autoritarismo, dellatortura, della mortificazione, della menzogna,dell’imbarbarimento, della negazione del diritto diciascuno di essere padrone della propria esistenza e delproprio corpo, ossia della schiavitù, intesa come“spontanea” sottomissione alla volontà della Providenza edei suoi strumenti in terra. In pratical’istituzionalizzazione di quello che sarebbe statochiamato Darwinismo Sociale, pur avendo ben poco a chefare con Darwin. E questo in nome di Dio e della Croce.
Come si può facilmente intuire, non c’era nulla diedificante e pedagogico nelle loro intenzioni. Non eranolì per insegnare agli indigeni a superarli per virtù edingegno, ma per indottrinarli al Nuovo Ordine. Giocavanoa fare il dio punitivo e redentore di un popolodegenerato e malvagio, che necessitava di lezioni dibuona condotta. Sognavano una dittatura pedagogica,soccorrevole ma severa, rigida e punitiva, che diffidavadei “discenti” e si prefiggeva il compito demiurgico diaddestrarli, addomesticarli, plasmarli, rendendolimentalmente rigidi, rispettosi, integerrimi edincondizionatamente, automaticamente obbedienti,funzionali alle esigenze ed all’armonia dell’Impero.Questa distopia si sarebbe autoperpetuata attraverso lasuddetta “pedagogia nera” costrittiva, la “pedagogiadell’Anti-Cristo” o “del Grande Inquisitore”. Perottenere un’adeguata obbedienza filiale (o, per meglio
187
dire, l’obbedienza dell’anima) i nuovi padroni dovevanoincutere timore negli autoctoni, tramite punizionifisiche, sadismo, profferte subito smentite. Qualunquemanifestazione di volontà autonoma sarebbe statarimpiazzata da abnegazione e diniego.
L’amministrazione coloniale non sarebbe stata moltodissimile dal modello spartano e del totalitarismo delsecolo scorso: intrinsecamente morale e moralizzatore,educativo e formativo, “pastorale” e patriarcale,motivato dalla missione di creare la società ideale ed ilsuddito ideale. Le sue prescrizioni ed arbitratisarebbero state inoppugnabili proprio in virtù della suaintangibilità morale, derivata dall’imperatore, dallaSanta Madre Chiesa e da Dio. Il potere avrebbe stabilitociò che era giusto e virtuoso. Per via di questa misceladi moralismo, responsabilità collettiva, utilità socialeed ambizioni tecnocratiche, il Nuovo Ordine prefiguratoda Sepúlveda e dagli altri commentatori ed analisti dimentalità autoritaria, sarebbe stato incline aconsiderare la diversità come un impedimento al correttofunzionamento della Megamacchina imperiale. Non vi potevaessere alcuno spazio di libertà, e di autodeterminazioneindividuale o di popolo, perché la vera libertà, inquest’ottica, è quella di piegarsi ai valori dei padroni,senza che siano posti ostacoli alla più completaadesione. La libertà delle marionette che sonosoddisfatte delle cordicelle che le manovrano e del loroefficace ricondizionamento mentale. Questo eraprecisamente il destino degli Indios: mansuetudine oestinzione. Gli intenti di questi ingegneri sociali edimprenditori morali erano, ai loro occhi, nobili elodevoli, perché finalizzati alla crescita della“consapevolezza” civile e religiosa degli indigeni. Ainostri appaiono come sadistici e crudeli, dettati da unignobile complesso di onnipotenza divina. Le proteste deinativi sarebbero state interpretate come il risultato diun autoinganno: vedono questo mondo come manipolativo e
188
brutale perché è al di là della loro comprensione, ma noil’abbiamo creato per il loro bene! Ecco, la potenteintuizione che Dostoevskij pone in bocca a Aljòsa: “Iltuo inquisitore non crede in Dio, ecco tutto il suosegreto!” Al che Ivàn Karamazov, di rimando: “Infine tuhai indovinato. È proprio così, è ben qui soltanto chesta tutto il segreto…Al tramonto dei suoi giorni egliacquista la chiara convinzione che unicamente i consiglidel grande e terribile spirito potrebbero instaurare unqualche ordine fra i deboli ribelli, “esseri imperfetti eincompiuti, creati per derisione”. Ed ecco che, di ciòconvinto, vede come occorra seguire le indicazioni dellospirito intelligente, del terribile spirito della morte edella distruzione, e, all’uopo, accettare la menzogna el’inganno, guidare ormai consapevolmente gli uomini allamorte e alla distruzione, e intanto ingannarli per tuttoil cammino, affinché non possano vedere dove sonocondotti, affinché questi miseri ciechi almeno lungo ilcammino si stimino felici. E nota: l’inganno è compiutoin nome di Quello nel cui ideale il vecchio ha per tuttala sua vita così appassionatamente creduto!”.
Marionette, automi, gli indigeni trasformati in unagalleria di pupazzi da narcisisti megalomani cheaspiravano ad esercitare un controllo completo suglialtri, decidendo quali regole valevano per loro e qualino, esercitando l’autorità di Dio. Come nel Processo diKafka, dove il protagonista affronta un potereimplacabile ed invisibile ed alla fine muore senza avercapito cosa gli sia successo e perché.
Come il Grande Inquisitore di Dostoevskij, lo storicoGonzalo Fernández de Oviedo, il giurista Juan deMatienzo, il vicerè del Perù Francisco de Toledo, ildomenicano Tomás Ortiz, l’ormai familiare Juan Ginés deSepúlveda, Pedro de Alvarado, responsabile dell’eccidiodi Tenochtitlán, Hernán Cortés, responsabile di quello diCholula e Francisco Pizarro, responsabile di quello diCajamarca, erano quasi certamente convinti che gli
189
indigeni avrebbero un giorno capito quale immensabenedizione era toccata loro. Avrebbero potutopronunciare loro le parole del Grande Inquisitore,fiducioso della sua rettitudine: “Essi ci ammireranno eci considereranno come altrettanti dèi, per averconsentito, dopo esserci messi alla loro testa, aprendere sulle nostre spalle il carico della libertà,della quale essi hanno avuto paura, e per aver consentitoa dominarli; tanto tremendo finirà col sembrar lorol’essere liberi!…Per l’uomo rimasto libero non esiste unapreoccupazione più assillante e tormentosa che quella ditrovare al più presto qualcuno davanti al qualeprosternarsi”. Servi di natura, come propugnato daisofisti Gorgia e Trasimaco, secondo i quali “la naturavuole padroni e servi”, la giustizia naturale essendo“l’utile del più forte”, o servi per cultura, ma comunqueservi. Per un breve periodo si erano ribellati, per poiammansirsi nuovamente. “Ma il gregge di nuovo si raduneràe di nuovo si sottometterà, e stavolta per sempre. Alloranoi gli daremo una quieta, umile felicità, una felicitàdi esseri deboli, quali costituzionalmente essi sono. Oh,noi li persuaderemo, alla fine, a non essere orgogliosi,giacché Tu li hai sollevati in alto, e così hai insegnatoloro a inorgoglirsi: dimostreremo loro che son deboli,che non son altro che dei poveri bambini, ma che incompenso la felicità bambinesca è la più soave di tutte.Essi si faranno timidi e s’avvezzeranno a girar gli occhia noi e a stringersi a noi tutti spaventati, come pulcinialla chioccia”.
Paul Tillich soleva dire che gli unici pensatorigenuinamente profetici del nostro tempo sono quelli chehanno dedicato la propria esistenza a misurarsi con lasubdola eloquenza del Grande Inquisitore dostoevskijano.Las Casas lo fece con alcuni secoli di anticipo e, se nonne uscì vincitore, poiché fu sconfitto in quasi tutte leiniziative che intraprese, come succede quasi sempre aivisionari nati prima del tempo, riuscì comunque a porre
190
un argine alla piena della Conquista e a rispedireSepúlveda ai suoi libri ed alle sue compravendite.
È ancora il Grande Inquisitore a parlare: “Sì, noi liobbligheremo a lavorare, ma nelle ore libere dal lavorodaremo alla loro vita un assetto come di gioco infantile,con canzoni da bambini, cori e danze innocenti. […]. Edessi non ci terranno nascosto assolutamente nulla di lorostessi. Noi permetteremo loro, o proibiremo, di viverecon le loro mogli e amanti, di avere o non avere figli,sempre regolandoci sul loro grado di docilità, ed essi sisottometteranno a noi lietamente e con gioia. Perfino ipiù torturanti segreti della loro coscienza, tutto, tuttoporranno in mano nostra, e noi tutto risolveremo, ed essisi affideranno con gioia alla decisione nostra, perchéquesta li avrà liberati dal grave affanno e dai tremenditormenti che accompagnano ora la decisione libera epersonale. […] in silenzio essi morranno, in silenzio siestingueranno nel nome Tuo, e oltre tomba non troverannoche la morte. Ma noi manterremo il segreto, e per la lorostessa felicità li culleremo nell’illusione d’unaricompensa celeste ed eterna. Infatti, seppure ci fossequalcosa nel mondo di là, non sarebbe davvero per dellagente simile a loro”.
Sono dei selvaggi e l’unica libertà adatta a loro èl’innocenza incosciente degli animali addomesticati chesi concentrano sulla sopravvivenza e sull’obbedienza.Leggendo i testi della disputa di Valladolid non hopotuto fare a meno di pensare che, proprio lì, in queigiorni, si stava svolgendo, simbolicamente, l’eternoconfronto tra Cristo ed il suo antagonista, il cosiddettoAnticristo, che predica il totalitarismoeudemonistico/utilitaristico, il governo di un’oligarchiapseudo-cristiana, quella dei Conquistadores, coi loromiracoli, la loro autorità ed i loro misteri. Non avevanomai goduto di alcuna libertà, gli indios, e non avrebberosaputo che farsene. Sarebbe stato un fardello eccessivo,irritante. “Si convinceranno pure che non potranno mai
191
nemmeno esser liberi, perché sono deboli, viziosi, inettie ribelli. […] Essi sono viziosi e sediziosi, ma allafine saranno proprio loro che diverranno obbedienti”. Infondo sono i veri beneficiari di tutto ciò che è statofatto. “Noi diremo che obbediamo a Te, e che dominiamonel nome Tuo”. E le punizioni, le torture, lepersecuzioni, i massacri, la schiavitù? Tutto meritato:“La tua condotta e le tue azioni ti hanno causato tuttociò. Questo il guadagno della tua malvagità; com’è amaro!Ora ti penetra fino al cuore…” (Geremia 4,18). Chioserebbe obiettare alla volontà di semidèi che esprimonoil giudizio di Dio? “Il censore dell’Onnipotente vuoleancora contendere con lui? Colui che censura Dio ha unarisposta a tutto questo?” Come Giobbe, gli Indiosdovevano solo accettare la loro sorte e ringraziare ilCielo di essere vivi e di avere l’opportunità diriscattarsi. “Ecco, io sono troppo meschino; che tipotrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca. Hoparlato una volta, ma non riprenderò la parola, duevolte, ma non lo farò più” (Giobbe 40,5).
C’è un’illuminante annotazione di Vladimir SergeevicSolov’ev che può servire a comprendere meglio ledinamiche psicologiche di questi tiranni inconsapevoli diesserlo: “L’Anticristo credeva in Dio, ma nel profondodel suo cuore preferiva se stesso”. Non credo vi sia unamigliore definizione di certi Conquistadores (o deiNazisti). L’emblema perfetto per queste stirpi dicrociati è l’uroboro, il serpente che si morde la coda.Una forma di vita attaccata alla terra ed allamaterialità, indifferente alla spiritualità ed allatrascendenza, tossica per sé e per gli altri,imprigionata nella propria gabbia di brame, gelosie edegoismi. Non è il Sole di Cristo che li illumina, mapiuttosto un Sole Nero, la “fantasia dell’Uomo Malvagio”,l’avrebbe chiamata William Blake.
Il Nuovo Ordine instaurato dai Conquistadores edifeso da Sepúlveda era un neo-feudalesimo predatorio in
192
cui una casta di signori al vertice della piramidesociale tiranneggiava e spogliava le masse degliinferiori, beandosi del potere come di un afrodisiaco,provando piacere nel senso di dominio e diappropriazione. Sepúlveda chiuse gli occhi davanti atutto questo. Gli fu più facile dopo aver ricevuto legenerose regalie dei suoi sostenitori della Nuova Spagna.Las Casas, al contrario, comprese che non sarebbe mairiuscito a vivere con se stesso se non avesse fattoquanto in suo potere per combattere questo regimediabolico, dove l’intelligenza era al serviziodell’insensatezza, dell’ingordigia, dell’ipocrisia, delsovvertimento delle consuete relazioni di causa effetto,dello sfruttamento dell’uomo come bene sostituibile - unavolta morti tutti gli Indios sarebbero rimasti pur semprei neri, e poi tutti gli altri non-bianchi non-cristiani.La razionalità di cui Sepúlveda si fece paladino non erail Logos, ma l’espressione di un’intelligenza che aspiraad un’unica libertà, quella di nutrirsi letteralmente delprossimo. L’intelligenza di un guerriero crociato, di uncacciatore d’uomini: dura, implacabile, insensibile,indifferente, che trascende emozioni e valori, vittimizzal’inferiore e il debole, che sente la sua mascolinitàminacciata dal caos e dall’indefinitezza delle emozioniumane come l’empatia, la simpatia e la pietà; che devecombattere per sopravvivere o non è più se stesso, cheintellettualizza l’abuso e la prevaricazione, che ama igesti radicali come simboli di potere e conquista, checonfonde l’amore con il possesso. Con le sue paroleSepúlveda si cimentò nello sdoganamento di una violenzasadica che cercava di negare tutto ciò che eraconsiderato impuro, una violenza votata alla distruzionedi ciò che può essere distrutto. Alexander von Humboldtaveva ogni ragione di osservare amaramente che “nelparadiso delle foreste d’America, l’esperienza hainsegnato a tutte le creature che la benevolenza di radosi accompagna al potere”. La teologia e la filosofia
193
umanista del cordobese avevano come unico, esplicitoscopo quello di conferire potere a chi già lo possedeva,intendeva proteggerlo ad ogni costo e, se possibile, nedesiderava ancora di più. Ricordiamoci dell’ammonimentodi R.W. Emerson a non dare “arnesi affilati in mano aibambini. Non si dia all’uomo, per amore del cielo, piùpotere di quanto già non disponga, finché non ha imparatoa usare questo un po’ meglio. Quale inferno non sarebbequesto mondo, se potessimo fare ciò che vogliamo!”; èpiuttosto paradossale che valesse infinitamente di piùper gli Spagnoli che per i tanto bistrattati indigeni.Sepúlveda e chi la pensava come lui enfatizzò laRangordnung tra esseri umani, la differenza morale edontologica tra persone a prescindere dalle loro azioni.L’unica vera libertà, una libertà prettamentenietzscheana, risiedeva nella spontanea sottomissione deideboli al dominio dei forti e nel naturale esercizio deldispotismo da parte di questi ultimi, che hanno il doveredi proteggere la propria specificità ed eccellenza, nondi porvi delle restrizioni.
La teologia diventava allora un mero alibi, non unamotivazione. Gott mit uns, Dios está con nosotros. Per affermarela mia dignità devo mortificare quella altrui, devoesigere che la vittima sia consenziente. Il mio spazio dilibertà si commisura a quello del mio arbitrionell’esercizio del potere: sono tiranno con chi mi stasotto, schiavo di chi mi sta sopra. Sono libero perchésono in grado di comprendere il disegno divino e diadeguarmicisi. Sepúlveda non vede, perché non vuolevedere che il nobile apostolato spagnolo è segnatodall’inganno, dall’ingiustizia, dallo sfruttamentospropositato, dal consumo smodato e da un controllopatologico. E tutto questo in modo sistematico, quasiinconscio, perché provvidenzialmente legittimo e perchéle sue cause culturali e psicologiche sono radicate edinveterate. È il trionfo del virilismo, dell’aggressivitàpredatoria, dell’essere sempre al limite delle proprie
194
capacità e magari oltre, del desiderare di possedere piùdi quanto spetta, come se la vera soddisfazione sitrovasse oltre la mera soddisfazione, vedere il poterecome un’opportunità di trasgressione e prevaricazione, ilrifiuto del limite e della proporzione. L’antagonismo tranoi e loro come ordine cosmico, il bisogno di prendereinvece di dare, di sfruttare invece che accordarsi.Un’aggressiva tecnocrazia mentale, meccanomorfa, che sifregia di raffinate e mistificatorie corone diragionamenti che celano assunti non solo indimostrabili,ma umanamente indecenti. “Io dico che i barbari devonoessere dominati, non soltanto perché ascoltino ipredicatori ma anche perché alla dottrina e ai consiglisi aggiungano le minacce e si infonda il timore. […].Grazie al terrore unito alla dottrina, hanno ricevuto lareligione cristiana, quegli stessi che con la solapredicazione l’avrebbero respinta” (Democrates Alter).
Sepúlveda non dubitò mai per un solo istante dellavalidità di tali assunti, centrati su ciò che eranormativamente permissibile, ed insensibile al tema diciò che è buono. In questo senso la sua filosofiaanalitica, che lui considerava risolutamente apolitica equindi neutra ed obiettiva, acquistava caratteri non menopolitici dell’antropologia filosofica di Las Casas.L’umanista liquidava risolutamente l’elemento emozionaledelle argomentazioni dell’avversario come irrilevante.Ciò che contava in un’epistemologia che era indifferentealle ragioni della dignità umana non era il datoesperienziale ma la coerenza argomentativa, la luciditàdel processo di analisi, tematizzazione, quantificazioneed espressione. L’unica irruzione in questo circoloautoreferenziale era quella della volontà dell’autoritàprevalente, degli interessi consolidati di chi esercitavail potere, personificazione della Provvidenza. Era ilsuicidio della ragione, lo sprofondamento del pensierorazionale nell’irrazionalismo, nell’egoismo che si auto-giustifica, nella filosofia che ha come unico scopo
195
quello di fungere da dolcificante, rendendo appetibileciò che in precedenza era stato giudicato spregevole, eda solvente di ogni obiezione di natura morale.
Ci stupisce la cecità di chi accusava Las Casas dipetulante arroganza, senza accorgersi della trave neipropri occhi, un ego dilatato al punto da non saper diredove finisce il credente e comincia la divinità. Cosa haa che vedere con l’etica predicata dal Cristo l’ethos delConquistador, fatto certamente di audacia, disposizioneeroica, nobiltà, orgoglio, forte senso dell’onore,lealtà, senso del dovere e del sacrificio, ma anche esoprattutto da un senso di superiorità, da esuberanteegotismo, gioia sensuale, disprezzo della mitezza (vistacome debolezza), aggressività, ambizione, disciplina,moralismo ipocrita e presuntuoso, energia sovrabbondantee robusta volontà di potere? Molto poco. Anche i trattiche avvicinano questa “moralità dei padroni” a quellacristiana sono indirizzati alla realizzazione di unprogetto antitetico a quelli di Gesù il Cristo: umiliarel’umano, addomesticarlo e trascinarlo a fondo. Con tuttociò, Sepúlveda dava l’impressione di credere che ovunquefossero avanzate le armate spagnole ci poteva solo esserecarità ed amore, e quand’anche ciò non fosse accaduto,sarebbe stata solo una questione di tempo, fino a quandonon si fosse riusciti a domare la fauna umana locale. IlConquistador, avendo una sorta di connessione diretta conun imperativo categorico che determinava le sue azioni ela sua visione del mondo, non si sarebbe mai comportatodeliberatamente in modo barbaro e crudele e, d’altraparte, non ci poteva essere un bene più grande, per unServitore della Rettitudine, di una guerra giusta.L’umanista si collocava dalla parte di chi cura l’odiocon altro odio.
L’uno dibatteva per la schiavitù, per il dominiodell’uomo sull’uomo, per il dispotismo, per l’oscurità,per il passato, e quindi per la tortura, l’inquisizione,la condanna a morte per eresia e persino per reati
196
minori, i pogrom, la caccia alle streghe, le guerre direligione, l’imperialismo, ecc.; l’altro per la libertà,la dignità, l’emancipazione, lo sviluppo umano, la luce.Raramente ci fu una distinzione più netta ed evidente,che fu oscurata solo dalle insistite proteste del teologoe cronista di corte, che non si dava pace di essere malinterpretato, negando di aver mai affermato ciò che avevadato alle stampe. Las Casas non trascorse il suo temponelle biblioteche o con gli agenti immobiliari. Volevaessere a contatto con le persone perché amavasinceramente gli esseri umani. Leggeva sì molto, ma siportava dietro la sua biblioteca personale, per poteressere vicino alle vittime o a chi poteva aggiogare icarnefici. Non fu un uomo perfetto, tutt’altro, mabisognerebbe apprezzare il bene che fece e non accentuareirragionevolmente le sue debolezze. Fu un essere umanocome gli altri e come tale soggetto a miriadi di fallaciee manchevolezze, in un curioso intreccio di astuzia ecoraggio, generosità e irascibilità, premura ed irruenza,onestà e tendenza ad esagerare. Quest’ultimo difetto èforse il più scusabile. Quando scrisse la lettera alconsiglio delle Indie del 20 gennaio 1531, assicurandoche “mai si videro, in altre epoche o presso altripopoli, tanta capacità, tanta disposizione e facilità perquesta conversione. (…). Non esistono al mondo nazionicosì docili e meno refrattarie, più atte o megliodisposte di queste a ricevere il giogo di Cristo” oquando, nella prefazione alla Relación, insisteva che“tutti questi popoli, innumerevoli e di vario genere,sono stati da Dio creati estremamente semplici, senzacattiveria né doppiezza, obbedientissimi e fedelissimi ailoro signori naturali e ai cristiani di cui sono alservizio; sono i più umili, i più pazienti, i piùpacifici e tranquilli uomini che vi siano al mondo, senzaastio né baccano, senza liti né violenze, senza rancore,senza odio, senza desiderio di vendetta”, Las Casassapeva di non potersi semplicemente appellare all’Amore,
197
per non fare la figura dell’ingenuo idealista.Realisticamente, giocò la carta del popolo innocente epuro, che avrebbe quasi certamente avuto più chance disedurre sovrani e pontefici. Aveva infatti un cervello diprima qualità ed un grande cuore che lo spinsero ad amaree servire gli esseri umani con sincerità, lealtà etenacia.
Fu anche così coraggioso e audace da non rendersiconto di esserlo, e con un tale livello di empatia chenon sembra azzardato sospettare che potesse avvertire lasofferenza e l’agonia altrui come se fosse la sua, cioèfisicamente, nella sua pelle e nella sua coscienza; untratto caratteristico di quelle persone che si fannoinfluenzare da ogni vita che incontrano e a loro volta lainfluenzano. Odiava la superficialità e si rifiutava diconformarsi tanto per conformarsi. Assieme alla libertà,un principio particolarmente caro a Las Casas fuquell’indefinibile qualità che gli uomini chiamanogiustizia e di cui ancora oggi si sa abbastanza poco. Maprima di tutto poneva l’amore e la pietà, le uniche virtùche possono realmente migliorare questo mondo.Coerentemente, nel suo Entre los remedios (1542), ildomenicano spiegava che non solo non era lecito lasciarmorire migliaia di persone per la salvezza di una solapersona, ma anche che la vita di un uomo era piùimportante della sua stessa salvezza. Siamo ad unadistanza siderale dall’altra fazione, quella inebetitadalla mania della ricchezza che si era impossessata diloro, come una malattia, o un caso di possessionedemoniaca, incurabile, della quale si sarebbero liberatisolo distruggendo se stessi. Quella libera da ogniscrupolo, che si sentiva al di sopra della legge, anzi,che pretendeva di incarnarla, che aveva il diritto diuccidere in quella grande industria del massacro che fula Conquista, perché aveva il potere di farlo.Nell’Historia Las Casas rovesciò scaltramente le accuse deiConquistadores: “Di fronte alla nostra smaniosa e
198
incontenibile ansia di accumulare ricchezze e benitemporali, dovuta alla nostra innata ambizione e allanostra insaziabile cupidigia, questi indiani – lo concedo– potrebbero essere tacciati di oziosi; ma non secondo laragione naturale, la legge divina e la perfezioneevangelica, che lodano e approvano il fatto che ci siaccontenti del puro necessario”. Quell’umanità, dicevo,che aveva appreso solo la dottrina dell’odio e dellapaura e pensava davvero che ci fosse un solo modo pertener buone le persone, terrorizzarle in una misura taleda estirpare l’idea stessa di potersi “comportare male”disobbedendo alle leggi del Nuovo Ordine. “La guerraspagnola – tuonava Las Casas – è violenta e crudeleperché non ha alcun diritto di fare le cose profondamenteinique e nefande che fa […] Il potere che si acquista conla forza delle armi, è tirannico e violento”. Chiedevavita, comprensione, carità, bontà per sovrastare lacrudeltà e l’odio, come chi ha simpatia per i suoiconsimili e che odia la povertà non perché sia povero maperché altri lo sono. Questo secondo un principiouniversale ed unificante della moralità umana che esortaalla sollecitudine per ognuno, a prescindere da legamiparentali e sociali, al desiderio di recare beneficio,all’avversione al nuocere ad altri, all’attribuzione aglialtri dello stesso valore che attribuiamo a noi stessi.Las Casas sapeva, avvertiva nell’intimo, che il futurosarebbe stato dalla sua parte e che la Corona non avrebberivolto il suo sguardo verso il passato.
Il Cristo razzista
Badate bene, badate bene; perché temo e dubito per la vostra salvezzaBartolomé de las Casas
Credo di poter dire che Las Casas sia in errorequando sostiene che “non da altro mossi, i cristianihanno ammazzato e distrutto tante e tali anime, in numero
199
incalcolabile, non da altro guidati che dalla sfrenatabrama di oro, dal desiderio di empirsi di ricchezze e dielevarsi ad alte posizioni, assolutamente sproporzionatealla qualità della loro persona” (Brevissima relazione delladistruzione delle Indie). Non dobbiamo mai perdere di vistal’evidenza dei fatti che la Chiesa Cattolica non fu ingrado di cancellare le correnti anti-semite e razzisteche la percorrevano. Poté solo tenerle sotto controllo. Èben vero che la Spagna, neppure al tempo degli statuti dilimpieza de sangre, conobbe un anti-semitismo paragonabile aquello più comune nell’Est Europa e che la campagnacontro Mori ed Ebrei era guidata da interessi di bottega.Ma è altrettanto vero che il legame tra sangue impuro ed“indesiderabilità” fu stabilito allora, che oltre dueterzi degli Ebrei furono espulsi, e che ad Ebrei econversos fu impedito di migrare nel Nuovo Mondo. E poic’erano i pogrom, come quello terribile del 1391 che,benché generati dall’inasprirsi delle condizionieconomiche dei contadini spagnoli, non possono, a mioparere, essere tenuti interamente distinti da quelli est-europei e nazisti, anch’essi, peraltro, legati alleoscillazioni del ciclo economico ed ai capricci deltempo. A questo proposito, Maurizio Giretti, nella Storiadell’antigiudaismo e dell’antisemitismo, scrive: “L’intolleranzaverso le minoranze, ebraica e musulmana, continuò confasi alterne. I motivi dello scoppio di una sorta difobia per il diverso si spiegano…con ragioni di ordinepolitico, di rivalità socioeconomiche, ma anche con unaviolenta campagna alimentata dai domenicani. Via via cheil potere regio per intrinseca debolezza o perspregiudicato calcolo politico allentava la suaprotezione, essi aizzavano il fanatismo popolare che poisi sfogava con violenti attacchi contro i quartieriebraici e musulmani” (Giretti, 2007). Poi, quando Ebrei eMori si fecero battezzare a migliaia ed ebbero cosìaccesso alle più alte cariche istituzionali, affioraronole tendenze cripto-razziste. “Tutto si è svolto come se
200
un paese che aveva solo tardivamente preso coscienza dise stesso avesse avuto bisogno di questo elementonegativo – l’ebreo – per scoprirsi e si fosse trovatonella necessità di reinventarlo, una volta espulso oconvertito. Senza di che la sua esistenza interna sisarebbe trovata minacciata” (Jean Delumeau, 1979, p.465). L’anti-semitismo, in Spagna ed altrove, fu ilprodotto dell’intersecarsi delle paure ataviche di massacon le paure riflesse, quelle che “sgorgano cioè da unatteggiamento d’indagine sulla sofferenza guidato daidirettori di coscienza della collettività, quindianzitutto dagli uomini di Chiesa. […] Essi steserol’inventario dei mali che (Satana) è capace di provocaree la lista dei suoi agenti: i Turchi, gli Ebrei, glieretici, le donne (specialmente le streghe)” (ibidem, p.37).
Questa fu una modalità di espressione del razzismobiologico. L’idea di razza è un caso di pensierocollettivista, moralmente parassitario. È il rifiuto diimmaginare che l’altro, il singolo, possa esistere inquanto tale e non come membro di un qualcosa di piùvasto. Prende forma quando la cultura è ridotta allabiologia, resa dipendente da questa, o quando vieneessenzializzata ed ogni elemento culturale si auto-giustifica in quanto parte di una tradizione statica. Viè una negazione categorica della volontà di tollerareibridazioni e contiguità, della possibilità dicontemplare una realtà in cui ogni identità è plurale,porosa, mista, eterogenea e mutevole. Giuliano Gliozziprecisa che “il concetto di razza si presenta non dirado, fino alla metà dell’Ottocento, scevro di moltielementi che caratterizzano il razzismo: o perchél’”altro”, concepito come separato da noi, non per questoè ritenuto inferiore; o perché la sua inferiorità,riconosciuta, è però attribuita a cause esternerimovibili; o ancora perché, pur attribuendoall’inferiorità un’origine genetica, se ne auspica
201
l’abolizione mediante la miscela razziale”. Nella Spagnadella Riconquista e della Conquista questi elementi sonopresenti, anche se in una condizione di sudditanzarispetto alla vulgata giuridico-teologica dominante che,per la buona sorte degli autoctoni di quella chediventerà l’America Latina, appoggiava Las Casas. Ilrazzismo “ispano-americano”, come ogni altro razzismo,passò dalla teoria alla pratica solo in virtù deldifferenziale di potere tra le parti e, in seguito, dellaminaccia che i meticci potessero prendere il potere,sostituendo la casta padrona. Fu ostacolato dallamancanza di un terreno politico e morale favorevole alivello istituzionale, che però non poté impedire cheesso fungesse da coagulante per l’identità spagnola nellamadrepatria e nel Nuovo Mondo. Di qui la diffusione dipratiche, spesso illegali o comunque ritenute inopportunedalle autorità, di meccanismi di esclusione, dominazionee discriminazione che alla fine permearono la societàcoloniale. Vale l’annotazione di Alexander von Humboldt:“in Spagna è un tipo di titolo di nobiltà non discendereda Ebrei e Mori. In America, la pelle, più o meno bianca,è ciò che determina la classe che un individuo occupanella società”. Ora si tratta di capire perché questoproblema dovrebbe sollecitare una serie di ponderateriflessioni sulle vicende contemporanee e, in primis,l’appropriazione del Cristo per fini di propagandapolitica.
Tutto cominciò col contatto. Le relazioni chepervennero in Europa convinsero Hegel che “questi popolidi debole cultura scompaiono quando entrano in contattocon i popoli di cultura superiore e più profonda” e che“gli Americani vivono come bambini che si limitano adesistere, ben lungi da tutto ciò che rappresenti pensierie fini elevati” (Hegel, 2003 [1837]). Abbiamo già avutomodo di familiarizzarci con il genere di denigrazionialle quali erano sottoposti, più o meno in buona fede, i
202
nativi. Lo storico e sociologo cileno Fernando Mires, nelbel In nome della croce (1991), ha raccolto una serie digiudizi crudi e perentori che aiutano a comprendel’infervoramento lascasiano. Juan de Quevedo (1450-1519),il vescovo col quale Las Casas incrociò dialetticamentela spada a Barcellona, inizialmente non eraparticolarmente entusiasta di evangelizzare i nativiperché “non diventeranno mai uomini…sono convinto chesono nati per la schiavitù e soltanto con essa li potremorendere buoni. […]. Se in qualche tempo alcuni popolimeritarono di essere trattati con durezza, sono nelpresente gli Indios, più simili a bestie feroci che acreature razionali”. Sorprende che la stessa persona chepoi aderì alla “crociata” umanitaria di Las Casas, tantoda ottenere la sua approvazione per un progetto di tuteladegli Indios, abbia potuto altresì chiedersi “che cosaperde la religione con tali soggetti?” e concludere chesenza l’istituto schiavistico “invano si lavorerebbe percondurli alla vita razionale di uomini e mai si riusciràa renderli buoni cristiani” (Mires, p. 62). Quevedo eraun frate francescano e vescovo del Darien (Istmo).Possiamo solo immaginare cosa potessero pensare gliencomenderos. Bernardino Mesa, primo vescovo di Cuba,intravedeva negli indios “tanta piccola disposizionedella natura e abitudine che per portarli a ricevere lafede era necessario tenerli in qualche modo in schiavitù,per meglio disporli e per costringerli alla perseveranza,e questo è conforme alla bontà di Dio” (Mires, p. 63).Gli oidores (magistrati) di Santo Domingo, Espinoza eSuazo, non si danno cura di ammorbidire i toni, quandoinsinuano che “sembra che Dio nostro Signore vengaservito meglio da queste genti di indios con il lorocompleto sterminio, o per i peccati degli antenati oloro, o per altre cause a noi occulte” (op. cit., p. 64).Dal canto suo il francescano Pedro de Azuaga, vescovo diSantiago del Cile, scrive nel “De iure obtentionisregnorum Indiarum questiones tres”: “L’occupazione
203
violenta della Nuova Spagna fu giusta per l’infedeltà eper i vizi dei naturali; era necessario castigarel’ingiuria che questi facevano a Dio con la loro“apostasia”. Si trattava di alberi infruttuosi chedovevano essere tagliati e bruciati. Dal momento cheavevano rifiutato l’invito di convertirsi alcristianesimo, la guerra che si fece loro era statalecita e ugualmente lo sarebbero state le guerre future”(op. cit., p. 64). Infine merita di essere riportata laposizione radicale di un laico, il cartografo enavigatore concittadino di Las Casas Martín Fernández deEnciso (c. 1470 - 1528): “Le conquiste spagnole eranolegittimate dalla donazione del pontefice Alessandro VI,che in virtù del suo supremo potere sulla terra, doveoccupava il posto di Dio, poteva castigare il peccato diidolatria degli indios – adoratori di dèi falsi conl’oblio assoluto del loro Creatore condannandoli, come ineffetti li condannava, alla perdita dei loro regni, acapo dei quali collocava i re cattolici di Spagna, perchéquesti, con tutti i mezzi a loro disposizione,procurassero la conversione di quei barbari” (op. cit. p.66). Un’idea di fondo che accomuna questi sproloquirazzisti è quella ottimamente condensata in uno slogan dauno degli antagonisti di Las Casas, il missionariofrancescano Toribio de Benavente, detto Motolinía: “Valedi più buono per forza che cattivo per volontà”.
Credo che all’origine di questa feroce intolleranzavi siano problemi di natura psicologica. MoltiConquistatori, a prescindere dall’estrazione sociale edalla formazione e professione, sembrano esibire deitratti abbastanza definiti. Tutto ciò che allietava ipensieri di Las Casas, il calore umano, l’amore, lafluidità delle situazioni, delle personalità, delleidentità, il femminile in tutte le sue espressioni, eravisto come spiacevole se non addirittura indecoroso.Molti Nuovi Signori non erano preparati per questo ruolo,non sapevano come esercitare il potere con equilibrio e
204
moderazione. Erano tanti ego mascolini che indossavanoarmature di ferro o di idee fisse, che temevano che unaperdita di potere potesse significare la lorodisintegrazione e frammentazione. Cercavano solidità neicorpi-macchina, nelle uniformi, nelle spade, neipregiudizi, della deferenza e nella desensitivizzazione.Las Casas invece, nelle sue visioni riformiste, pensava astrutture sociali senza confini netti, senza gerarchiedefinite, senza certezze monolitiche (fatta eccezione perla Verità del Cristo), dove Europei ed Americanipotessero convivere, amarsi, figliare, apprendere ilmeglio dell’altro. Il Paradiso Terrestre sarebbediventato di nuovo realtà. Las Casas preferiva parlare dianime, razionalità e sentimenti, oltre che di giustiziasociale. Anche se si sforzava di accattivarsi le simpatiedei potenti, gli unici che potevano fermare ladistruzione delle Indie, diffidava del potere e di ciòche fa agli uomini: “Mai si deve far potere a uominipoveri o avidi che ambiscono solo ad uscire dallapovertà, e molto meno a coloro che anelano, sospirano edhanno per fine di esser ricchi, poiché la natura maiinvano lavora ed opera”. Lui si faceva pecora tra i lupi,i suoi avversari, spesse volte, lupi tra le pecore. Eranoossessionati dal potere ed affascinati dal sangue:“Vedono nel sangue versato il liquido benedetto chepermetterà la cristianizzazione del Nuovo Mondo” (Mires,1991, p. 73). La loro struttura mentale, una miscela diistinto agonistico, intransigente moralismo, razzismo(“nessuna riabilitazione è possibile per certe classi diumani”), nazionalismo (“la Spagna è innocenza e purezzaincarnata”) autoritarismo e tradizionalismo (“i reaticontro l’ordine coloniale sono crimini contro l’ordinedivino; ogni deviazione da questo modello sociale è unacaduta nel peccato”), spiace dirlo, fa parte a pienotitolo della nostra natura ed è sempre a disposizione delpolitico scafato, del leader populista, della dottrinaautoritaria, del guru millenarista. Il sangue puro ed il
205
sangue versato dal Cristo nobilitano lo spirito e laVerità si testimonia con il sangue, meglio ancora sequello di qualcun altro.
“Tutta la concessione e la sua causa – ricorda LasCasas in una lettera alla Corte del 1535 – dei re diSpagna e del dominio che hanno su queste terre e genti èstata ed è per la loro vita, e per la salvezza econversione delle loro anime, e sono state invecetrasformate in morte molto anticipata e miserabile, eperdizione finale”. In un’altra lettera, questa voltaindirizzata al Consiglio delle Indie del 1531, leggiamo:“A quelle misere genti bastava andare all’inferno con laloro infedeltà, poco a poco e da sole, senza che quelliche avrebbero dovuto salvarle, i nostri cristiani,venissero a toglierle dal mondo in così pochi giorni, persola avidità, con nuove e inaudite maniere di crudeltà etirannia andandosene così con loro nelle tenebre e neilamenti senza fine”.
Non c’è compassione per gli afflitti, i pagani, ibarbari che, in quanto servi disobbedienti del Signore,non hanno diritto di proprietà né sulle loro terre, nésulle loro vite. Nell’Historia Las Casas denuncia questasituazione: “E volevano piena libertà per trionfare sugliindios e su tutta l’isola, su signori e sudditi, pergodere nei propri vizi senza che neppure ci fosse chi limoderasse e senza cercare motivi e pretesti pergiustificare e dissimulare la loro ribellione,disobbedienza e iniquità”. In verità li cercavano eccome,e per questo “assoldarono” Sepúlveda proprio come unamultinazionale stipendia un team di avvocati e di spindoctors (manipolatori di immagini e simboli) per mettersial riparo dalla giustizia e da un eventuale giudizionegativo dell’opinione pubblica. Il teologo di Cordobaera l’uomo giusto perché credeva nella superiorità moraleed intellettuale di chi comanda. “Se ha raggiunto ilpotere una ragione ci dovrà pur essere”. Non credeva chetutti gli Spagnoli fossero superiori. Nutriva disprezzo
206
per la plebe ignorante e sordida e non avrebbe sprecatoun pensiero per ciò che giudicava volgare. Ma non avevadubbi che la classe dirigente spagnola fosse la cremadell’umanità del suo tempo. Chi stava in alto non dovevarender conto a nessuno delle sue decisioni e chi stava inbasso doveva solo obbedire. Leggiamo nel Democrates Alter:“In una repubblica [da intendersi come “società”,“comunità”, NdR] ben amministrata…non sta certo al volgodecidere degli affari di stato…questo deve solo obbediregli ordini ed i decreti del principe e degli altimagistrati…perché laddove il volgo si arroga l’autoritàdi ponderare importanti questioni di governo non si hapiù una repubblica ma la sua aberrazione; questa forma digoverno, detta “popolare”, è sia ingiusta sia deleteriaper il bene comune”. Più oltre: “Non c’è nulla che siapiù in contrasto con la giustizia redistributiva (contraiustitiam distributivam appellatam) dell’attribuzione di ugualidiritti a persone disuguali e della parificazione infavori, onori o diritti di quelli che sono superiori perdignità, virtù e merito rispetto a quelli che gli sonoinferiori”. Questa era la sua concezione della societàspagnola, figuriamoci cosa pensava dei rapporti traconquistatori e nativi conquistati. Per loro aveva già inmente “una combinazione di autorità paterna e servaggio,come richiesto dalla loro condizione e circostanze”. E sei nativi se la fossero presa? Improbabile, la felicitànon è uguale per tutti. C’è chi è felice quando ordina,perché è stato “creato per comandare” e chi lo è quando ècomandato. Ognuno ha un ruolo ed una posizione che glicompetono nella gerarchia socio-politica, e questa èdeterminata dalla natura. Perciò l’indigeno e lo schiavoafricano potevano essere quanto e persino più felicidell’encomendero spagnolo e dello schiavista portoghese.
Sepúlveda non temeva il risentimento della masse neiconfronti dei signori. Las Casas aveva ben compreso ilperché di tanta indifferenza. Gli encomenderos seminavanopusillanimità: “Essa è il principale espediente dei
207
tiranni per sostenersi nei loro regni usurpati: opprimereed affliggere di continuo i più potenti e i più saggi,perché, occupati a piangere e gemere le loro calamità,non abbiano tempo né animo per pensare alla loro libertà,e così si impauriscono e degenerano in animi timidi epaurosi”. Alla fine l’intera società india era ostaggiodi una “pusillanimità immensa, scoramento profondo,annichilazione della stima del proprio essere umano,meravigliandosi e dubitando di se stessi, se erano uominio animali” (Historia). Esseri umani o animali, esseriviventi o oggetti, risorse?
La cultura della vita di Las Casas, almeno per quelche è dato di capire leggendo le sue opinioni,trascendeva l’aspetto biologico-organico: “Con l’uomoabbiamo una natura non semplice, bensì composta, ancorchéarmonica”. Nell’Apologética leggiamo che “Dalla luceimpressa nell’animo degli Indios si conosce che vi èDio”. La cultura della vita di Las Casas valorizzava ilreticolo di significati, azioni, pensieri e conversazionidi uomini che “sono fratelli, in quanto figli dellostesso Padre che li [invita] alla sua dimora celeste”. Siriscontra qui il radicale contrasto con chi descrive gliIndios come “non-ancora-persone” che non hanno diritto diparola riguardo alla loro sorte e che se muoiono è pervolontà di Dio. Gli Indios erano in parte muti anche perLas Casas, che essendo continuamente in viaggio, avevarinunciato ad apprendere le lingue dei vari popoli cheincontrava. Anche lui metteva parole in bocca agliindigeni senza minimamente sapere cosa avrebbero detto sefosse stato loro concesso di esprimersi nella lorolingua.
Eppure gli stessi autoctoni lo nominarono lororappresentante. Potevano non essere d’accordo con tuttociò che affermava, ma gli riconoscevano la buona fede el’impegno generoso. Sapevano che lui amava la vita,inclusa la loro, che parteggiava per eros, che integra edunisce, contro thanatos, che disgrega, smembra e separa
208
(diavolo viene dal greco diaballein, dividere). Sapevano chelui insisteva costantemente su un punto nodale della suaprassi teologica: il missionario doveva pensare e vivere“come se fosse un Indio”.
Un dio implacabile
Da queste miti pecore…giunsero gli Spagnoli, che naturalmente furonoriconosciuti come lupi.Bartolomé de las Casas
Cristo è severo ed implacabileJosef Goebbels
Nella sua Apologia, Sepúlveda dichiarava che a GesùCristo era stato affidato il potere sui cieli e sullaterra e questo potere era stato poi delegato al suorappresentante in terra, il pontefice, il quale dunqueera sovrano su ogni terra. La sua giurisdizione non siestendeva solamente alla predicazione del vangelo maanche all’imposizione dell’osservanza della legge dinatura a tutti i popoli. Imposizione che, lo affermavaesplicitamente, doveva comportare anche le “guerregiuste”, cioè le crociate punitive e redentrici. “Laguerra giusta è causa di giusta schiavitù”. Questoenunciato era piuttosto condiviso nell’Europa dell’epoca,tant’è che una parte degli schiavi che vivevano in Spagnaerano stati ottenuti combattendo contro i Mori. Marimaneva in contraddizione con il messaggio di Cristo epersino Marcelino Menéndes Pelayo, suo traduttore ecommentatore, nonché feroce critico di Las Casas, dovettericonoscere che “gli sforzi che Sepúlveda fa perconciliare le sue idee con la teologia ed il dirittocanonico non bastano per nascondere il loro strato paganoe naturalista”. Nel 1895 Menéndez Pelayo portò avanti labattaglia di Sepúlveda definendo Las Casas un “fanaticointollerante” e la Brevísima Historia un “mostruoso delirio”.
209
Un suo studente, il filologo medievalista Ramón MenéndezPidal, era dell’avviso che il domenicano fosse infermo dimente e che gli eccidi dei Conquistadores ai danni diquegli “indios preistorici, residui del Neolitico”,fossero stati giustificati dalla necessità di contrastarele trame di Montezuma. “Possiamo ben credere – scriveMenéndez Pidal, convenendo con l’approccio di Sepúlveda –che Dio abbia fornito chiari indizi del bisogno disterminare questi barbari, e non mancano dottissimiteologi che tracciano un parallelo con i Cananei e gliAmorrei, sterminati dal popolo ebreo”. A detta diSepúlveda, “le cause della guerra non nascono dallaprobità degli uomini, né dalla loro pietà e religione, madai crimini e dalle nefande concupiscenze di cui è pienala vita umana”. Tuttavia, invece di ricavare da questadeduzione una riflessione più generale sulla follia dellaguerra, come abbiamo visto lo studioso cordobese,esibendo una considerevole dose di cinico “realismo”,stabiliva che la violenza è la fonte stessa del diritto,quando la giudica inevitabile per la pacificazione dipopoli che non avevano mai interferito in alcun modo congli affari europei e che avevano fin da subito preferitole vie diplomatiche rispetto allo scontro frontale.
Abbiamo già toccato il tema del carattere autoritariodelle passioni civili di Sepúlveda, ma tale è la loropertinenza ed attualità, che un saggio sulla filosofiamorale e l’antropologia politica di Las Casas deveindugiarvi a lungo. Il teologo andaluso era un umanistaelitario, uno di quelli che giudica volgare tutto ciò chenon è eroico, altolocato ed esclusivo. Tutto ciò cheriguarda il volgo è per definizione volgare e indegnodella sua attenzione. Se poi questo volgo è somaticamentee culturalmente differente dalla sommità della civiltàeuropea, l’élite spagnola, come lo sono gli indo-americani che, a suo dire, non conoscono il commercio, laletteratura e la moneta, allora si può ben capire che ilsuo approccio nei loro confronti non potrà che essere
210
sussiegoso e sbrigativo. Nel Democrates Alter si precisavache gli indiani non dovevano essere oppressi in misuraeccessiva perché avrebbero potuto reagire “tentando didisfarsi del giogo spagnolo”. Se era ben vero che gliSpagnoli s’impossessavano del loro oro e argento, eraanche vero che in cambio davano ferro, bronzo e animalid’allevamento, più utili agli indigeni. Per non parlaredell’inestimabile dono della dottrina cristiana.Naturalmente è necessario capire che cosa intendaSepúlveda per dottrina cristiana. È piuttosto evidenteche la distanza che separa Las Casas dal suo avversario èla medesima che separa il Vecchio dal Nuovo Testamento.Gesù il Cristo non chiedeva di fare a meno di ciò che eravenuto prima di lui – ed infatti Las Casas si affidaall’Ecclesiaste ed ai Proverbi – ma è evidente chediversi passaggi dell’Antico Testamento risentono delperiodo e delle circostanze in cui furono elaborati esono incompatibili con il messaggio del Cristo. Così LasCasas accusava il suo contendente di “non aver esaminatole scritture con sufficiente determinazione”. Secondo ildomenicano, in quest’epoca di “grazia e pietà”, il suoavversario rimaneva ostinatamente impantanato “nella suainflessibile applicazione dei rigidi precetti del VecchioTestamento”, un grave errore ermeneutico che aveva comeunico risultato quello di agevolare “l’oppressione, losfruttamento e la schiavizzazione di nazioni innocenti”.Diversi studiosi di Sepúlveda hanno provato a minimizzarela gravità di certe sue asserzioni ma se Gesù il Cristo èla fonte teologica più autorevole – “Io sono la Verità” –ed è universalmente risaputo che il suo è un messaggio diamore, tolleranza, sapienza e soprattutto giustizia,allora gli sforzi sepulvediani di realizzare laquadratura del cerchio, trasformando quest’insegnamentoin un culto proto-nietzscheano del superuomo e dellacasta dei signori, non solo non possono essere presi sulserio, ma devono essere contrastati in ogni modo, comefece Las Casas quand’era in vita.
211
Sepúlveda giudicava l’Antico Testamento superiore alNuovo, perché conteneva leggi la cui solidità avevapermesso loro di pervenire fino a noi, prova del fattoche erano leggi naturali. L’insegnamento di Gesù eracomplementare; le aveva perfezionate ma non abolite.Erano già buone e naturali di per sé. Le esortazioni diGesù servivano a migliorare la propria esistenza, machiaramente non erano applicabili alla sfera politica.Non è che avesse qualcosa da ridire su di esse, ma non leriteneva vincolanti, perché sarebbe stato impossibilemetterle in pratica nella vita reale e perchécontravvenivano alle leggi di natura. Infatti nell’AnticoTestamento si vedeva chiaramente che agli Ebrei eraconsentito combattere una guerra quando la legge dinatura lo decretava necessario. Poiché le leggi di naturaerano state definite da Sant’Agostino come espressionedella volontà di Dio, che aveva stabilito che l’ordinenaturale doveva essere conservato intatto, alloraqualunque cosa fosse compiuta in accordo con la legge dinatura sarebbe stata in accordo con l’autorità divina.
Si noti che questo tipo di ragionamento, sebbene nonapplicato al Dio cristiano com’è generalmente inteso, eracomune nella Germania nazista. Adolf Hitler si appellavainvariabilmente alle leggi naturali decretate dal“Creatore dell’Universo”. Le leggi eugenetiche servivanoa plasmare un’umanità quale “l’Onnipotente Creatorestesso aveva creato”. In un discorso del 1922, Hitlerdefinì Gesù “il vero Dio”. In seguito lo chiamò “ilnostro più grande leader ariano”. Secondo Hitler ilmovimento nazista avrebbe completato “il lavoro cheCristo aveva iniziato, ma non poté completare”. Infatti“il vero messaggio” della Cristianità poteva esseretrovato proprio nel Nazismo. Cristo aveva combattuto gliEbrei e loro l’avevano liquidato. La sua religione è lacosiddetta “Cristianità Positiva” ossia il Cristianesimotradizionale spogliato di ogni cosa che non gli piacesse.La divinità di Hitler non era un deus otiosus ma un dio
212
attivo, chiamato Creatore o Provvidenza che aveva creatol’universo ed un mondo in cui le varie razze dovevanocombattersi per la sopravvivenza. Per il Führer,esattamente come per Democrates, uno dei dueinterlocutori dell’omonimo trattato di Sepúlveda, “idieci comandamenti sono un codice di condottairrefutabile. Questi precetti corrispondono agliirrefragabili doveri dell’anima umana; sono ispirati dalmigliore spirito religioso”. Anche il sinistro MartinBormann invocava le leggi di natura, come fonte di veritàed autorità in ogni campo dell’esistenza: “Il poteredella legge di natura è ciò che chiamiamo l’onnipotenteforza di Dio. […]. Noi Nazional-Socialisti pretendiamo danoi stessi di vivere nel modo più naturale possibile,ossia in accordo con le leggi della vita e della natura.Più precisamente le comprendiamo e vi ci atteniamo, piùagiamo nel rispetto della volontà della forzaonnipotente”. Heinrich Himmler parlava della volontà delGrande Spirito in toni assolutistici: “Esiste un sologrande spirito e noi individui siamo le sue temporaneemanifestazioni. Siamo eterni quando eseguiamo la volontàdel Grande Spirito, siamo condannati quando locontestiamo nel nostro egotismo ed ignoranza. Seobbediamo, viviamo. Lo sfidiamo e siamo gettati nel fuocoinestinguibile”. Adolf Eichmann spiegò al pastoreevangelico William Hull, che lo voleva convertire primadella sua esecuzione, che “nella mia concezione, Dio, pervia della sua onnipotenza, non è un punitore, non è unDio irato, ma piuttosto un Dio che abbraccia l’interouniverso, l’ordine nel quale sono stato collocato. Il suoordine regola tutto. Tutto l’essere e il divenire –incluso me – è soggetto al suo ordine”.
A mio giudizio la fissazione di Sepúlveda per lalegge di natura celava una credenza panteista come quellaesplicitata dalle citazioni dei gerarchi nazisti: lacredenza in un Dio-nella-natura onnipotente che liberal’uomo da ogni costrizione morale. Il teologo insisteva
213
con protervia che lui non stava difendendo la schiavitùnaturale ma trovava una certa difficoltà nel dimostraredi non essere un fautore di quella civile, per di piùsemipermanente, e quindi essenzialmente naturale. Provavaad aggirare il problema parlando di dominium, lo stato disubordinazione imposto dai Romani ai popoli assoggettati,ma non nascondeva la sua convinzione dell’esistenza di un“bisogno naturale” che i popoli e gli individuiintellettualmente e culturalmente meno dotati sisottomettano volontariamente alla volontà dei più dotati.Necessità che, sempre secondo lui, era suffragata dalparere di Sant’Agostino nella sua lettera al vescovoscismatico Vincenzo, in cui giustificava le maniere forticontro gli eretici: “Ma io penso che sono stati castigatiper amore e non per odio. Tu però devi considerare tantepersone, il cui ravvedimento ci procura ora tanta gioia.Se infatti ci limitassimo a spaventarli senzaammaestrarli, ciò avrebbe l'apparenza d'uno spietatodispotismo. D'altra parte, se ci limitassimo adammaestrarli senza spaventarli, incalliti come sono nellaloro inveterata abitudine, comincerebbero ad incamminarsitroppo pigramente sulla via della guarigione. […]. Quandoperò ad un utile spavento si unisce un salutareinsegnamento, in modo che non solo la luce della veritàscacci le tenebre dell'errore, ma che anche la forza deltimore spezzi i lacci di una cattiva abitudine, allora cirallegriamo - come ho detto - della guarigione di molti”.Sepúlveda era irremovibile su questo punto: quando gliindiani resistevano alla volontà ed all’autorità degliSpagnoli, si ribellavano alla volontà della natura, equindi a Dio. Per questo andavano puniti e corretti ed iloro beni potevano essere legittimamente sottratti. Nonpotevano permettersi di rifiutare i doni degli Europei,cioè i doni di Dio.
Altri teologi e politici, come Sepúlveda, ricorrevanoalle Sacre Scritture per legittimare la Conquista e laconversione manu militari, citando l’episodio di Gerico,
214
Matteo 10:34 (“Non crediate che io sia venuto a portarepace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma unaspada”), il già citato Luca 14:23 (“E il signore disse alservitore: Va’ fuori per le strade e lungo le siepi, ecostringili ad entrare, affinché la mia casa sia piena”).Las Casas rispondeva accostando il comportamento deiConquistadores a quello descritto in Zaccaria 11: 4-5:“Così parla l’Eterno, il mio Dio: “Pasci le mie pecoredestinate al macello, che i compratori uccidono senzarendersi colpevoli, e delle quali i venditori dicono: Siabenedetto l’Eterno! Io m’arricchisco!”. Citava Isaia32:17: “Il frutto della giustizia sarà la pace, el’effetto della giustizia, tranquillità e sicurezza persempre”. Annunciava sciagure a chi si fosse macchiato dicolpe imperdonabili. Rimandava ad Ezechiele 34:2-4,peraltro già usato da Montesinos alla corte di Castiglia:“Guai ai pastori d’Israele, che pascono se stessi! Ipastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vinutrite di latte, vi rivestite di lana, ammazzate lepecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avetereso la forza alle pecore deboli, non avete curato leinferme, non avete fasciato quelle ferite, non aveteriportato le disperse. Non siete andati in cerca dellesmarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza”.Ricorreva a Giacomo 5:1-6: “E ora a voi, ricchi: piangetee gridate per le sciagure che vi sovrastano! Le vostrericchezze sono imputridite, le vostre vesti sono statedivorate dalle tarme; il vostro oro e il vostro argentosono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si leverà atestimonianza contro di voi e divorerà le vostre carnicome un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimigiorni! Ecco, il salario da voi defraudato ai lavoratoriche hanno mietuto le vostre terre grida; e le protestedei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore deglieserciti. Avete gozzovigliato sulla terra e vi sietesaziati di piaceri, vi siete ingrassati per il giornodella strage. Avete condannato e ucciso il giusto ed egli
215
non può opporre resistenza”. Infine, nel suo testamentoteologico-politico, Tratado de las doce dudas (1564),pronunciava la condanna definitiva e proponeva a Filippodi abbandonare le Indie: “Hanno gravemente macchiato ilnome di Gesù Cristo e la nostra religione cristiana,creato degli ostacoli fatali alla propagazione della fedee arrecato dei danni irreparabili all’anima e al corpo diquesti popoli innocenti. E sono convinto che comepunizione di tali azioni, empie, scellerate edignominiose, tanto tirannicamente e selvaggiamenteperpetrate, Dio fulminerà la Spagna con il suo furore ela sua ira”. Las Casas non dubitava della veridicitàdelle profezie sulla fine del mondo, ma le impiegava conastuzia, perché sapeva che, malauguratamente, le mentisemplici di molti Conquistadores erano più facilmentesmosse dalla paura piuttosto che dalla compassione edalla ragione.
Se ho intrapreso questa ricerca è perché,personalmente, mi trovo più a mio agio con la teologiapolitica di Las Casas, che prende le mosse dalla realtàdella situazione come la vive un popolo, i NativiAmericani nel suo caso, e non un’élite, per poi seguirela strada di un’opzione umanista ed umanitaria più equa,giusta e cristiana di quella che ha sotto gli occhi.L’operazione lascasiana, se messa a confronto con quellesopra descritte, è altrettanto semplice: si appoggia alCristo “storico” ed al cristianesimo primitivo peresaltare il punto di vista antropocentrico deglioppressi, non per giustificare gli oppressori. L’opzionedi Sepúlveda e di chi fa uso dell’immagine del Cristosferzante ed implacabile è quella di chi sostiene labontà e necessità di tendenze esclusiviste, settarie efatalistiche, di chi proclama l’incommensurabilità,l’irriducibile pluralità e diversità ontologica diculture chiuse, distinte, omogenee e separate, opponendoal diritto all’eguaglianza il diritto ad una differenza
216
gerarchizzata, non equa ed unitaria. Quello che chiamo il“Cristo Implacabile” – una caricatura del Cristo, la suanegazione – è un Crociato Cosmico che persegue gliinteressi suoi e dei suoi fedeli a discapito dei dirittiumani e che assegna le persone al posto che gli spettanell’ordine naturale e sociale, sulla base di arbitrarieattribuzioni di valore intrinseco. È un Cristoinestricabilmente associato ad un peccato originaleonnipotente ed insopprimibile, al mito dell’immutabilenatura ferina ed egoistica umana che ne determina leazioni, e della vita come carosello di iniquità,ingiustizia e violenza. Dato questo stato di cose, gliavversari di Las Casas insistevano sulla necessità diplasmare la cristianità in una religione di stato, unareligione civile che ingiungesse ai cittadini il rettosentire ed il retto agire, in accordo con la natura e congli interessi di un Impero sacralizzato. Chi invece sischierava con Las Casas era ricattato moralmente, espostoalla riprovazione di chi lo accusava di essere unegoista, un folle e un traditore del bene comune, con unlivore che non scema neppure dopo diversi secoli. Ancoranel dopoguerra Ramón Menéndez Pidal tacciava Las Casas diparanoia: “Non era né santo, né impostore, né malevolo néfolle; era semplicemente un paranoico”.
Il Cristo di Las Casas è un Cristo d’Amore. Per luiche l’indio sia cristiano o meno fa sempre parte delcorpo di Cristo. Al licenziato Aguirre, un suoammiratore, confida: “Ho lasciato, nelle Indie, GesùCristo flagellato, tormentato, sferzato e crocifisso, nonuna, ma milioni di volte”. Coerentemente, sostiene che inon credenti possono comunque essere attivi partecipantinel corpo di Cristo attraverso la grazia salvifica di Dioche è presente in ogni essere umano. L’Indio è GesùCristo, lui stesso è Gesù Cristo e chiunque facciaqualcosa a loro lo fa a Cristo (Matteo 25, 40). È unritorno alla paleo-cristianità, la cristianità delleorigini, quella di Alessandria, di Clemente e di Origene,
217
quest’ultimo una figura grandemente ammirata da Erasmo daRotterdam. Las Casas non cita Origene, perché è ungigante del pensiero cristiano che, con il passare deltempo, è diventato scomodo. Compenetra il pensiero dimolti riformatori cristiani, ma lo si cita di rado, perevitare di mettersi nel mirino dell’Inquisizione. LasCasas preferisce ritorcere contro i detrattori degliindo-americani i versi più forti del Vangelo, come quandocita il commento di Sant’Agostino a Matteo 25: “se ilfuoco eterno è il premio per chi ha visto Gesù nudo e nonlo ha coperto che posto all’inferno sarà riservato perquelli a cui è stato detto “ero vestito e tu mi haispogliato”?” Il sivigliano, ormai cittadino del mondo,ritiene che se uno vuole seguire l’insegnamento di Cristolo deve fare fino in fondo, non accontentarsi di veritàparziali, ma prendere a modello chi ha incarnato laVerità. Il che però non impediva agli altri credentidella Conquista, quelli più “agguerriti” e menotolleranti di prenderlo a modello solo per quel che liautorizzava a piegare l’indio alla loro volontà. È quiche Bartolomé non sente ragioni. Lui vede il nativo,l’altro, come uno dei poveri del vangelo, come Cristostesso, appunto, e vede nei Conquistadores i suoipersecutori: “Quando predichiamo agli Indiani l’umiltà ela povertà di Gesù Cristo, e come ha sofferto per noi, ecome Dio ha a cuore i poveri e gli ultimi, loro pensanoche stiamo mentendo”. L’unica condotta moralmente degnadiventa allora quella di Mosé; si deve sfidare l’ira delfaraone per liberare il suo popolo dalla schiavitù, unparagone che ricompare più volte negli scrittilascasiani. Realizzare un mondo di libertà e giustizia,questa era, secondo Las Casas, la volontà di Dio, il cuifiglio “non era morto per l’oro”.
Altri, come Sepúlveda, prediligevano un mondo diobbedienza e sudditanza, di avidità e sopraffazione, incui l’uomo “infine è prigioniero e schiavo del denaro, edeve fare quel che gli comanda il suo padrone, è sempre
218
preoccupato e diligente e si impegna per essergli graditoe ricercarlo, poiché da lui si attende ogni conforto, ilsuo bene, al fine dei suoi desideri e tutta la suabeatitudine” (Las Casas, El octavo remédio). Il loro era undio diverso, non certo quello di cui parla Gesù il Cristoe che Cristoforo Colombo aveva voluto far conoscere inAmerica. Per Las Casas Colombo era un uomo dellaProvvidenza. Lo indicava il nome stesso – “Ma quell’uomoillustre, rinunciando al nome consacrato dall’uso, vollechiamarsi Colón, ripristinando il vocabolo antico, nontanto per questa ragione, ma in quanto mosso, dobbiamocredere, dalla volontà divina che lo aveva prescelto perrealizzare ciò che il suo nome e cognome significavano.[...] Per questo egli era chiamato Cristóbal, cioèChristum ferens, che vuol dire portatore di Cristo, ecosì firmò molto spesso; perché, in verità, egli fu ilprimo a schiudere le porte del mare Oceano per farvipassare il nostro Salvatore Gesù Cristo, fino a quelleterre lontane e a quei regni fino ad allora sconosciuti.[...] Il suo nome fu Colón, che significa ripopolatore;un nome che ben si conviene a chi, con i suoi sforzi, hapermesso che fossero scoperti quei popoli, quelleinnumerevoli anime che, grazie alla predicazione delVangelo, [...] sono andate e andranno ogni giorno aripopolare la città gloriosa del Cielo” (Historia, I, 2).
Invece Hernán Cortés e quelli come lui eranomessaggeri di rovina, iniquità ed ignominia. L’unicamaniera di fermarli, come raccomandava nel Dell’unico mododi attrarre tutti i popoli alla vera Religione, era sforzarsi di“vivere una vita pura e santa, essere di esempio con leproprie parole, maniere, carità, fede, castità, di modoche nessuno abbia a disprezzare [noi predicatori]”. Nonbasta chiamarsi cristiani per esserlo. Un autenticocristiano è uno che si comporta come tale, non come unautoma, una macchina, o un lupo travestito da agnello.Uno che ripudia le guerre e le torture, non le considerastrumenti per esportare fede e “democrazia”, visto che la
219
fede, come ripete Las Casas, proviene da dentro di sé, dauna mente e da un cuore che si aprono a Dio, e non può inalcun modo essere imposta dall’esterno.
La fine dei tempi
Se questo è il tempo della Salvezza nascosto nei secoli passati, come ha dettol’Apostolo, perché si tramuta in un tempo di tribolazione, vendetta, ira,afflizione, dissipazione, crudeltà e morte? Lettera di Las Casas al Consiglio delle Indie, 1531
Gesù Cristo non ha fissato un limite di tempo per la conversione degli uomini,ha lasciato loro tutta la vitaBartolomé de las Casas
Il già citato Motolinía, uno dei primi dodicimissionari a raggiungere le Americhe, in una lettera aCarlo V del 1555, interpretava la Conquista del Messicocome l’avvento del quinto regno, o quinta era dellastoria umana, preludio alla parusia del Cristo. Un regnoche riempirà di sé l’intero pianeta e di cui l’imperatoresarà leader (caudillo) e capitano. Nella lettera ilmissionario implorava l’imperatore di “impiegare tutta ladiligenza possibile” affinché questo regno si realizzi.Anche Bartolomé de las Casas credeva che il GiudizioUniversale fosse ormai alle porte. Inoltre, lo abbiamoappena visto, era persuaso che Cristoforo Colombo fossel’Uomo della Provvidenza che aveva raggiunto la TerraPromessa – “scelse il divino e sommo maestro tra i figlidi Adamo che in questi nostri tempi vivevano sulla terra,quell’illustre e grande Colombo, al quale affidare unadelle più egregie imprese che in questo secolo volle nelsuo mondo fare” (Historia de las Indias). Ne era persuasoperché sia lui sia Colombo, del quale era un sinceroammiratore, avevano ricavato dalla lettura della Bibbial’impressione che Isaia aveva profetizzato la scopertadell’America. Per l’Ammiraglio, l’America era Ofir, la
220
sede delle famose miniere di re Salomone. “La scopertadelle nuove terre è, per Colombo, un evento previsto eprofetizzato nelle scritture sacre. La predicazione delvangelo si estenderà finalmente a tutto il mondo el’opera degli apostoli sarà completata grazie aglistrumenti che la provvidenza divina ha preparato a talescopo: in primo luogo lui, Colombo, e i sovrani diCastiglia e d’Aragona. A questi ultimi è riserbata laconquista di Gerusalemme e l’universale conversione dellegenti al cristianesimo. In questo modo si manifesta lavolontà divina di abbreviare i tempi dell’ultima fasedella storia del mondo, risparmiando sofferenze aglieletti secondo la promessa evangelica” (Prosperi, 1976,p. 7). Per Las Casas l’undicesima ora del mondo erascoccata proprio grazie a Colombo ed ora la Spagna potevarecitare una parte decisiva nel dipanarsi della missionedi Cristo, in vista del kairos apocalittico, il tempo diDio. “È cosa di certo credibile che [il papa] rendesselodi e ringraziamenti immensi a Dio, datore dei beni,perché nei suoi ultimi giorni aveva visto aperto ilcammino per il principio dell’ultima predicazione delVangelo e per l’appello o conduzione degli operai oziosialla vigna della Santa Chiesa, già alla fine del mondo,che è, secondo la parabola di Cristo, l’ora undicesima”(Historia). Malauguratamente, come si rese presto conto, il“popolo eletto” spagnolo, invece di facilitare laredenzione dei nativi e la salvezza del genere umano,stava trasgredendo la sua missione.
Allo stesso tempo, non esitava a suggerire l’ipotesiche molti degli eletti da Dio sarebbero stati indo-americani. “E potrà essere che costoro, che in tantodisprezzo abbiamo avuto, si trovino, più di noi, nelgiorno del giudizio alla destra del Padre; e questaconsiderazione dovrebbe mantenerci notte e giorno in grantimore” (Historia). Di conseguenza tutti gli indigenidovevano essere rispettati e tollerati, anche solo perevitare il rischio di ferire o uccidere uno degli eletti.
221
Queste sue convinzioni spiegano però solo in parte ilsuo attivismo solidaristico. In nessuno dei suoi scrittidà l’impressione di essere stato condizionato da questacredenza, peraltro molto diffusa negli anni dellaScoperta dell’America e capace di affascinare persinoNewton, uno dei patroni della scienza moderna. Las Casasnon fa quello che fa perché anela lo scontro finale trail bene e il male, una trasformazione epocale che premigli eletti e danni i malvagi. Non crede che il mondo stiainabissandosi nel peccato, nella corruzione,nell’abiezione. Non crede che un Dio castigatore sia inprocinto di prendere il controllo della situazione ormaisfuggita di mano agli esseri umani. Las Casas ha fiducianella sua specie, ha fiducia nel potere dell’educazione edel Verbo. La sua visione del mondo e della storia umana,anche dopo aver assistito a stragi e persecuzioni, rimaneangelica, non catastrofista. Vede, soffre e denuncia lemalefatte dei singoli, senza fare di tutte le erbe unfascio. Non giudicando il mondo ormai al di là di ognipossibile redenzione, non auspica l’impiego di misureterribili e tracotanti, conseguenti alla “corrispondenzaautomatica tra massimo grado di abiezione e massimaprobabilità della sua eliminazione” (Placanica 1990). Èun gradualista. Sa che tutto cambia, che le personematurano e così le civiltà e che la rivelazione cristianafa sì che tutto ciò che è accaduto prima e dopo l’avventodi Cristo sia progresso spirituale, morale e civile. Laviolenza sarebbe controproducente, giacché “il movimentoo modo con cui la divina sapienza guida tutti gli essericreati, e soprattutto gli esseri razionali, alconseguimento del loro bene naturale o soprannaturale, èdolce, delicato e soave. Quindi il modo di chiamare gliuomini al seno della vera religione, mediante la qualedevono raggiungere il bene soprannaturale eterno, deveessere un modo delicato, dolce e soave, in una misuramolto maggiore di quello del modo che corrisponde aglialtri essere della creazione” (Dell’unico modo).
222
Paradossalmente, per uno che crede nell’imminenzadella fine dei tempi, la mentalità lascasiana è anti-catastrofista. Laddove il catastrofista vede solo unmondo dominato dalle forze del Male e si affida allasperanza, alla fiducia, all’obbedienza ed all’attesa comeunica via di salvezza per se stesso, lui insiste che ilprogresso umano non può essere slegato dalla razionalità,dalla comprensione e soprattutto dalla collaborazione.Nel summenzionato manuale di evangelizzazione, precisache “portare gli uomini alla conoscenza della fede edella religione cristiana è simile al modo di portarlialla conoscenza della scienza” e che il predicatore nonpuò permettersi di razzolare male: “La predicazione siaperlomeno utile ai predicatori”, affinché l’evangelistaoffra un modello di comportamento ed “insegni più con lesue opere che con le parole”. L’apocalittico fornisceun’interpretazione del male del mondo e del destino umanoche in fondo solleva gli uomini da ogni responsabilità egiustifica l’immobilismo. Las Casas ripudia questavisione cripto-gnostica: ognuno farà semplicemente quelche è chiamato a fare, indipendentemente da ciò cheaccadrà al pianeta ed all’umanità nell’approssimarsi delgiudizio universale. “Qualunque nobiltà, qualunqueeccellenza e virtù che in qualunque cosa creata per isegni divini si trova, non è altra cosa…se non unvestigio e impronta molto sottile della divinaperfezione” (Apologética Historia).
Il Dominio - l’America, Sepúlveda e l’Armageddon
Fanno libagioni in onore di Baalí, cioè dell’idolo peculiare di quanti sicomportano in quel modo e che li domina, li tiene in soggezione e li possiede;è questo, in altre parole, il desiderio di dominare, la smisurata ambizione diricchezze che non è mai sazia e mai finisce, e che è anch’essa idolatria.Perché – secondo san Girolamo – Baalí significa il mio idolo, colui che mipossiede. Tutto ciò si addice a ogni ambizioso, o avido o avaro e, inparticolare a simili predicatori, o piuttosto a questi miserabili e infelici tiranni
223
Bartolomé de Las Casas (Dell’unico modo).
Negli ultimi decenni ogni sondaggio effettuato negliStati Uniti indica che oltre il cinquanta per cento deicittadini americani crede nella veridicità della visionecontenuta nell’Apocalisse di Giovanni.
La politica mediorientale degli ultimi anni è statafortemente condizionata dall’attesa dell’Armageddon, delritorno del Cristo o del Mahdi e dell’instaurazione delsuo Regno. “Fedele alle dottrine apocalittichedell’ayatollah Mesbah Yazdi, il presidente [Ahmadinejad]si dice convinto che l’era dell’ultimo Imam, ildodicesimo Imam messianico, il Mahdi occultato da Dio peroltre 1100 anni stia per riaprirsi, con il ritorno delMahdi. Tutte le apocalissi, anche quelle ebraiche ecristiane, sono rivelazioni che presuppongono tempitorbidi, in cui il male s’intensifica. Anche per lascuola Hakkani, che Yazdi dirige e cui appartengono gliHezbollah iraniani, il male va massimizzato per produrreil Bene finale. L’ayatollah ha insegnato a Ahmadinejadl’uso del messianesimo a fini politici, non teologici. Ipolitici messianici in genere parlano di Apocalisse nonperché credono nella Rivelazione, ma perchénell’Apocalisse il dialogo con Dio è diretto(nell’Apocalisse di Giovanni scompaiono i templi) e ilcapopopolo non ha più bisogno del clero comeintermediario. L’apocalisse serve a escludere il clerodalla politica e forse anche la religione” (Spinelli,2009).
Un analogo messianismo, formalmente cristiano ma neifatti anti-cristiano, ha dominato la destra americana daitempi della prima guerra nel Golfo ed è andato al poterecon George W. Bush. È piuttosto curioso che gli StatiUniti siano attualmente l’unico paese al mondo assiemeall’Iran sciita dove sia sorto un millenarismo di massa(Tonello, 1996). Ma non sorprende che siano anche lanazione, assieme alla Germania, dove la caccia alle
224
streghe è stata più intensa e dove il maccartismo èriuscito per un attimo a far precipitare una democraziatrionfante in una società di delatori, persecutori evittime.
Nella sua forma più virulenta, chiamata Dominionismo,quest’ideologia intollerante e radicale si affanna aconquistarsi margini di potere politico ed economicosempre più ampi, fino a trasformare gli Stati Uniti, peril momento uno stato laico, in una “nazione cristiana” –una sorta di “democrazia Herrenvolk”, della stirpe eletta–, modello per tutte le altre nazioni, in cui ogniistituzione sarà governata in accordo con le SacreScritture, o comunque con un’interpretazione dominantedelle stesse. Al momento attuale oltre 35 milioni diAmericani (più di uno su dieci), aderiscono al“cristianesimo dominionista”, un’escatologia che insegnache il mondo si riscatta “sporcandosi le mani” con lapolitica, cioè prendendo il potere, prima dell’arrivo delCristo. L’elezione di George W. Bush ha rappresentato perla Teologia del Dominio un segno del favore divino, ilprimo di una serie di presidenti che, da “ministri di Dioin terra”, avrebbe preparato l’America al ritorno delCristo. Gli obiettivi di questa teologia politica nonhanno quasi nulla a che fare con quello che molti pensanosia l’insegnamento di Gesù il Cristo. Si parla diedificare una teonomia (ossia non una teocrazia ma unarepubblica governata non direttamente da Dio, ma secondole sue leggi), di sopprimere sindacati, diritti civili,lo stato sociale (perché ci si deve rivolgere a Dio, nona Washington), le scuole non-religiose, di punire inemici dell’America, che sono per definizione nemici diDio, di ridimensionare l’influenza delle donne nellasfera pubblica americana, negare la cittadinanza ai non-Cristiani, discriminare gli omosessuali. È bene segnalareche la presidenza di Ronald Reagan fu caratterizzatadalla sensazione di un imminente Armageddon, tanto che ilmovimento ecologista si sentì rispondere che non aveva
225
senso preoccuparsi dell’ambiente visto che il mondosarebbe terminato prima che le sue risorse si fosseroesaurite. Sono gli stessi argomenti messi in campo negliultimi anni dai Dominionisti che, anzi, si augurano chela crisi ecologica globale riduca i tempi di attesa delRegno di Dio (Hendricks, 2005).
Il bersaglio è la società laica, che facilita leopere di Satana. Abbatterla significa fornire assistenzaa Gesù, che presto tornerà a regnare e si aspetta che laNuova Israele sia governata secondo le leggi bibliche egli editti cristiani – Sola scriptura, Sola gratia, Sola fide, SolusChristus, Soli Deo Gloria, cioè i cinque sola della riformaprotestante – del nuovo presidente, come da ingiunzione diSan Paolo nella Lettera ai Romani (13: 1-6): “Ciascunostia sottomesso alle autorità costituite; poiché non c’èautorità se non da Dio e quelle che esistono sonostabilite da Dio. Quindi chi si oppone all’autorità, sioppone all’ordine stabilito da Dio. E quelli che sioppongono si attireranno addosso la condanna. Igovernanti infatti non sono da temere quando si fa ilbene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver da temerel’autorità? Fa il bene e ne avrai lode, poiché essa è alservizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male,allora temi, perché non invano essa porta la spada; èinfatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chiopera il male. Perciò è necessario stare sottomessi, nonsolo per timore della punizione, ma anche per ragioni dicoscienza”. I Dominionisti, che organizzano campi diaddestramento per giovani militanti e milizie dimercenari come la famigerata Blackwater (oggi Xe ServicesLLC) e sostengono i teorici della tortura giustificata edella Guerra al Terrore permanente, appoggiano con tuttala loro forza mediatica e lobbistica ogni pretesasionista. Questo perché credono che il loro “Cristo-Rambo” vendicativo e giustiziere non possa tornare sullaterra prima che si compia la profezia dell’Apocalisse esi verifichi l’Armageddon, la distruzione di Israele; un
226
secondo Olocausto in seguito al quale i veri Cristianiascenderanno al cielo (The Rapture) e siederanno al fiancodi Dio (assieme agli Ebrei che si saranno sinceramenteconvertiti e dunque si salveranno prima della loroeliminazione). È decisamente sorprendente che la destrasionista israeliana accolga con favore questo sostegno.D’altra parte le colombe, in Israele, sono spessoconsiderate alla stregua di traditori.
Il Dio compassionevole e benevolo che parla perbocca del Cristo nel Discorso della Montagna è eclissato,esiliato. Non c’è posto per miti e mansueti, per giusti emisericordiosi, per puri di cuore e pacifisti. Oggi comeai tempi della Conquista, quando Hernán Cortés, citato daSepúlveda nella sua Cronica Indiana, si rivolgeva alle suetruppe con queste parole: “Spesso io stesso ho rimuginatonei miei pensieri tali difficoltà e confesso che alcunevolte questo pensiero mi rendeva vivamente inquieto. Peròriflettendo da un altro punto di vista, mi vengono inmente molte cose che mi rianimano e mi stimolano. Inprimo luogo, la nobiltà e la santità della causa; infatticombattiamo per la causa di Cristo quando lottiamo controgli adoratori degli idoli, che proprio per questo sononemici di Cristo, dal momento che adorano demoni malvagiinvece del Dio della bontà e onnipotenza, e facciamo laguerra sia per castigare coloro che continuano nella loroostinazione, come per permettere la conversione alla fededi Cristo di coloro che hanno accettato l’autorità deicristiani e del nostro Re”.
Ancora una volta è Sepúlveda ad offrire un ritrattoarticolato, accurato e completo delle radici storiche edottrinali del dominionismo e della sua vocazione alleguerre giuste e preventive. Nella sua logica circolareautoreferenziata – le premesse contengono in sé leconclusioni – non c’è nulla che sia più in armonia con lalegge naturale che sforzarsi in ogni maniera di impedirea chi intende negare le gerarchie e l’ordine naturale
227
delle cose decretato da Dio di mettere in pratica leproprie intenzioni. In questo caso la guerra non è solopermessa, ma necessaria. Infatti non contravviene allalegge divina quando la si fa per una giusta causa, e nonc’è, appunto, miglior causa di quella di difendere idisegni della Provvidenza. Così non ci può essere verapace ed armonia, non ci può essere un mondo privo diarmi, finché l’iniquità e la malvagità non sarannobandite dai cuori dei violenti, siano essi compatrioti ostranieri. Fino a quel momento i giusti dovrannocombattere guerre giuste per consentire ai lorodiscendenti di vivere in pace, virtù ed equanimità. Nelcaso degli indios, “per mezzo di una guerra giustacerchiamo anche di istituire un imperium su quelli il cuibenessere ci sta a cuore, affinché i barbari – una voltache siano stati privati della licenza di peccare, che leloro consuetudini contrarie alla legge di natura sianostate estirpate e che siano stati esortati a seguire unostile di vita più umano attraverso un governo civile –siano mantenuti entro i ragionevoli limiti dei lorodoveri”. Gli stessi schiavi africani dei Portoghesivivono in una condizione migliore di prima. All’inizionon se ne sono resi conto, ma i teologi sanno che certemisure vanno prese per il loro bene, anche contro le lororesistenze, perché non ci si deve impensierire tropporiguardo agli empi desideri dell’uomo. Ciò che davveroconta è la recta ratio.
Lo sostiene anche il Deuteronomio (20: 10-15):“Quando ti avvicinerai a una città per attaccarla, leoffrirai prima la pace. Se accetta la tua offerta di pacee ti apre le sue porte, tutto il popolo che vi si trovapagherà i tributi e ti servirà. Ma se non vuole far pacecon te e ti vuole far guerra, allora la stringeraid’assedio. Quando poi l’Eterno il tuo Dio, te la darànelle mani, passerai tutti i maschi a fil di spada; ma ledonne i bambini, il bestiame e tutto ciò che sarà nellacittà, tutto quanto il suo bottino, li prenderai come tua
228
preda; e mangerai il bottino dei tuoi nemici chel'Eterno, il tuo Dio, ti ha dato. Così farai per tutte lecittà che sono molto lontane da te e che non sono cittàdi queste nazioni”. L’umanista chiosa che “èassolutamente chiaro che per legge naturale e divinaquelli che combattono una guerra giusta possono uccidereil nemico, spogliarlo delle sue proprietà, metterlo aiceppi, distruggere i suoi villaggi e città, devastare isuoi campi ed infliggere ogni tipo di calamità su di luifinché la vittoria non sia assicurata; dando perscontato, naturalmente, che tutto ciò sia fatto con lemigliori intenzioni e con la pace come obiettivo ultimo”.Successivamente, Democrates, l’alter ego di Sepúlveda,che non fa distinzioni tra indigeni pacifici e bellicosiin quanto sono comunque tutti idolatri e cannibali,mitiga questa posizione, precisando che non ha sensoopprimere ed indebolire fatalmente i propri sudditi.Sarebbe svantaggioso nella logica di una politicacoloniale a lungo termine. L’importante è asservirli, ilche è nell’interesse di entrambe le parti.
Leopoldo, l’interlocutore, si chiede che cosa intendaDemocrates con l’espressione servi natura. La risposta è chequando un popolo si rifiuta di assolvere i suoi obblighinaturali allora può essere sottoposto ad una guerragiusta e diventare bottino. I vinti saranno convertiti in“stipendiares et vectigales” (stipendiari e tributari), “come siconviene alla loro natura e condizione”. Il solito vezzodei parallelismi con i precedenti d’epoca romana, unitoai cavilli da leguleio che oscurano ciò che altrimentisarebbe ovvio. Il “diavolo” ha molti causidici epennivendoli, la verità molti nemici.
Quel che sorprende è che questo ragionamentopalesemente fallace sia stato ritenuto degno di udienza econsiderazione. Riflettiamo bene su ciò che si staaffermando. Il fondamento giuridico della guerra giusta edell’asservimento degli indiani deriva dall’atto stessodi combatterli e sottometterli. Infatti se non si
229
ribellassero non ci sarebbe bisogno di ucciderli edimprigionarli. Se collaborassero spontaneamente non sidovrebbero costringere a servire nelle encomiendas. Mapoiché la loro stessa esistenza è un’offesa all’ordinenaturale, un attacco alla volontà di Dio, allora laguerra imperialista è una guerra difensiva e perciògiusta. Allo stesso tempo, però, la resistenza degliIndiani agli invasori non è una guerra giusta ma unamotivazione aggiuntiva e decisiva per la loro conquista esoppressione. È arduo capire come ci sia chi stima unpensatore che adorna edifici speculativi fondati supremesse così manifestamente insostenibili emistificatrici, o per meglio dire tragicomiche. Ancorauna volta, l’enfasi su ciò che è normativamentepermissibile adombra ciò che è eticamente buono.
Qui però manca persino la coerenza argomentativadella filosofia analitica; la stessa pretesa tipica delrealismo di stabilire cosa sia naturale e quindi correttoera contestata già a quei tempi. Nell’apologia dellostatus quo di Sepúlveda, poco importa che ne siaconsapevole oppure no, c’è l’idea che gli indiani nonabbiano diritti perché questi sono il frutto dellepredilezioni della civiltà più avanzata. Il resto sonosuperstizioni oppure consigli evangelici per una condottadi vita più soddisfacente. Non esistono diritti naturaliper chi si oppone alla natura, ossia all’interpretazioneche di essa ne danno i vincitori. Il diritto èl’espressione oggettiva degli interessi consolidati edella volontà di potenza della civiltà che prevale; equesta è la pragmatica sorgente della morale egemone, oper meglio dire unica. Nessuna metafisica, nessunatrascendenza, se non un conveniente riferimento ad un Diocreato ad immagine e somiglianza di chi deve giustificareun crimine di massa. Solo l’utilità sociale. Le buoneleggi imposte dai conquistatori renderanno buoni icolonizzati e ciò andrà a vantaggio di tutti. Una realtà
230
multidimensionale è ridotta alla sua formabidimensionale.
Sepúlveda se la prende con i suoi critici,specialmente con Las Casas, accusandoli di ipocrisia,ignoranza, parzialità e presunzione, ma è indiscutibileche le sue argomentazioni danno adito al sospetto chestia difendendo pregiudizi o compiacendosi di sfoggiareerudizione, o il presunto coraggio intellettuale delsedicente pensatore serio, quello vero, quello che non siferma davanti a nulla quando pensa, che non ha pauradelle conclusioni alle quali perviene, per quanto questepossano sembrare spiacevoli. Quello che dice pane al panee vino al vino e che se c’è da dire che una partedell'umanità è indecorosa e incompatibile con la leggenaturale non si ritrae. Insomma uno scanzonato eroe dellibero pensiero che si lamenta di essere vittima di unacongiura di malevoli.
Non che peraltro qualcuno l’abbia costretto a pensareciò che ha pensato e renderlo pubblico. Si badi bene, nonha offerto alcuna resistenza e l’unico suo cruccio paresia stato l’accoglienza non particolarmente positiva chele sue idee hanno ricevuto in certi ambiti accademici. Èpiù probabile che abbia provato il piacere iconoclastaprodotto da ciò che è “fascinosamente trasgressivo”,mentre si spacciava per un pensatore integro e realista.In realtà l’utilitarismo militante di Democrates sfocianel relativismo, nell’indifferenza verso ciò che è giustoe ciò che è bene. Bene è relativo a ciò che è utile alpiù forte. La Conquista è moralmente giusta, in accordocon la recta ratio, e serve solo qualcuno che sappiamassaggiare le opinioni di alcuni notabili e studiosi edi una parte del clero per rendere il tutto accettabile,anzi appetibile.
La filosofia di Sepúlveda, che non è amore per ilsapere ma “amore” per l’erudizione – quella passionetirannica che antepone le idee agli esseri umani –, ègiustificativa, funge assieme da solvente, diluente e
231
dolcificante che dovrebbe gradualmente produrre un ampioconsenso: quel che è reale è razionale e quel che èrazionale è morale. Ritroviamo il piglio fiero e superbodel Grande Inquisitore, il perfetto realista giuridico-politico, che ci assicura che (a) esistono dei fattiinconfutabili a proposito della natura umana e degliesseri umani, e quindi degli indios e degli spagnoli; (b)gli indios sono barbari e di conseguenza le loro azionisono essenzialmente immorali o amorali; (c) non sononeppure capaci di soddisfare le proprie esigenze primarieed interessi principali; (d) fortunatamente nella lorosemplicioneria questi indigeni sono manipolabili (nongodono di un vero e proprio libero arbitrio, è al di làdella loro portata); (e) il potere conferisce il diritto,la legge sta dalla parte di chi ha il coltello dallaparte del manico, che ha il diritto di stabilire cosa siacongruente con il mondo in cui desidera vivere; (f) lagiustizia non è altro che l’interesse del più forte che èevidentemente benvoluto e prescelto da Dio per portareavanti i suoi progetti terreni.
Leopoldo azzarda una domanda: non è per casopossibile che la ragione stia da entrambe le parti e nonsia assoluta? Democrates opina che non si dà mai il casoin cui le ragioni di entrambi siano simultaneamentegiuste. Quel che avviene, invece, è che una parte,accecata dall’ignoranza, crede di essere nel giusto, masi sbaglia. Democrates non è neppure sfiorato dall’ideache quella parte possa essere la sua. È nel giusto perdefinizione, perché la sua interpretazione delle leggi dinatura e del volere divino è manifestamente corretta.
La risposta lascasiana a questo genere diinvasamenti castigatori è stata, e non potrebbe esserealtrimenti, un richiamo all’esempio di Gesù il Cristo,che non ha chiesto sacrifici, ma misericordia (Matteo,9:13), e non ha mai parlato di punizioni terrene: “Cristonon stabilì alcuna pena corporale per castigare in questomondo, nemmeno per gli uomini che non accettassero la sua
232
fede, cioè quelli che non credessero, bensì una penaeterna dopo questa vita” (“Dell’unico modo”). Ilchierico, che come abbiamo visto al Vecchio Testamentopreferisce il Nuovo, rifiuta la violenza che non siapuramente difensiva. Nell’opera succitata non lasciaspazio ad equivoci: “[La guerra] è come un uragano e comeun oceano, che tutto invade e distrugge. Essa apre la viaalle azioni depravate, eccita odi e rancori. I poveri nonhanno più nulla; i ricchi sono spodestati. Tutto siriempie di timore, le leggi sono abolite; ogni sentimentoumano sparisce; non c’è più equità e religione; sacro eprofano si confondono. Cos’è la guerra se non unomicidio?...è perdita delle anime, dei corpi e dellericchezze”. Quanto alla conversione coatta: “Il modoconsistente nell’assoggettare i popoli infedeli per mezzodella guerra perché in seguito ascoltino la predicazionedella fede e abbraccino la religione cristiana ècontrario al modo che seguirono gli antichi santi padriin tutte le età, dalle origini del mondo fino alla venutadi Cristo. […] [La guerra] è contro il diritto divino…chenon soltanto proibisce di provocare la morte del nostroprossimo, e principalmente degli innocenti; ma imponeanche che non lo spogliamo dei suoi beni…che non localunniamo né lo opprimiamo; che non rendiamotestimonianza contro la sua vita; che non prendiamo ciòche è suo con la violenza”. E ancora: “[la guerra èsbagliata] perché distrugge la fede dovuta a Dio…ponendoostacoli alla stessa pietà divina, all’onore e al cultodivini, che si accrescerebbero con la diffusione dellafede e con la conversione dei gentili che [invece] gliencomenderos scandalizzano, opprimono e uccidono”. È infinesbagliata perché i conquistadores “antepongono il loro utileparticolare al temporale – cosa che è propria dei tiranni– al bene comune e universale” e perché “il potere che siacquista con la forza delle armi, o che in qualche modosi è acquistato contro la volontà dei sudditi, ètirannico e violento, e mai può essere duraturo”. In
233
conseguenza di ciò, il pagano “si rifiuterà di crederealle verità della fede e disprezzerà colui che glieleinsegna. Se lo si costringe ad ascoltare egli rifiuteràil suo assenso”.
Utopia e sgomento nel Giardino dell’Eden
Erano nudi, pacifici e semplici come degli agnellini. Stetti ad osservarli alungo, soprattutto un vecchio dall’aspetto molto venerando, di alta statura, ilvolto allungato, l’aspetto imponente che suscitava rispetto. Mi sembrava divedere in lui il nostro padre Adamo, quando era ancora nello stato diinnocenza…quanti di quelli ce n’erano tra tante genti…Bartolomé de las Casas, Historia:
Di fronte alla Scoperta dell’America ed al suosignificato storico le reazioni di Las Casas e Sepúlvedasono state pressoché identiche. Entrambi hanno compresodi poter essere protagonisti di un’epopea della specieumana, di una congiuntura storica irripetibile che andavasfruttata appieno per riformare la società e riscattarel’umano nel senso da loro prediletto. La militanzapolitico-ideologica è stata intensa in entrambi, e cosìle aspirazioni palingenetiche. Ma le loro posizioni sonoinconciliabili. “Posto di fronte alla drammatica realtàdella Conquista e dei suoi meccanismi, nella prospettivadi liberare quella verità che egli vede incatenata esoffocata dagl’interessi economici, dall'inestinguibilesete di ricchezza, dalla cecità o dalle complicitàmorali, Las Casas vive e dichiara con estrema urgenza lanecessità di una nuova dottrina, in grado di far frontealla dimensione reale dei problemi posti dalla scoperta diun mondo nuovo, un mondo che avanza il dirittoinalienabile di venire riconosciuto nella propriaalterità” (Cantù, 1993). Il suo rivale o, se vogliamo, lasua nemesi, ha in mente qualcosa di profondamentediverso, un imperialismo universalista che, per certiversi, oltrepassa surrettiziamente quello che percepisce
234
come il parrocchialismo del cristianesimo politico.L’umanista cordobese è al tempo stesso antico e moderno,pagano e cristiano perché, come Las Casas, assorbe davarie fonti ciò che più gli aggrada e che meglio serve ilfine di definire un Nuovo Ordine per un Nuovo Mondo,alternativo a quella Koinonìa, comunità di spiriti intimi,solidali e corresponsabili, erasmiana “Libera Fratellanzadi Uguali” – del tipo “tutti per uno, uno per tutti” –che scaldava il cuore a Las Casas.
Nel Democrates Alter Sepúlveda nega che l’esempio di Gesùil Cristo possa essere messo in pratica. Si può essereguerrieri di professione, amare l’opulenza ed essere nelcontempo autentici cristiani. Al contrario, non sipossono praticare “in buona coscienza” certe virtùcristiane senza entrare in conflitto con specifici dovericivici, che dovrebbero invece avere sempre la precedenza.Per lui la spiritualità è una minaccia per la stabilitàsociale, la contemplazione e la saggezza divina degliintralci al “vivir bien”. La comunità nazionale è il verobene ed il cittadino probo accetterà la secolarizzazionedella virtù senza sprofondare nell’immoralismomachiavellico. Lo Stato Etico, la verdadera razón de Estado,infrange ogni velleità cosmopolita ed ecumenica. Esistonotre categorie d’uomini: quelli natura domini, quelli naturaservi e gli altri, che “non eccellono né in intelligenzané in giudizio, anche se non ne sono del tutto privi”.Questi costituiscono la gran massa degli esseri umani. Diriflesso, esistono nazioni intelligenti e giudiziose edaltre che ignorano deliberatamente o inconsapevolmente lalegge di natura. Queste ultime dovrebbero lasciarsigovernare dalle prime, in modo da fruire di leggi edistituzioni migliori. “Se si dovessero rifiutare diaccogliere un governo che è buono e vantaggioso per loro,la legge naturale impone di costringerle a conformarsi. Èsulla base di questo diritto che i Romani sottomisero ibarbari”.
235
Così il diritto della forza è consacrato come lostrumento legittimo di risoluzione delle questioniinternazionali. Allo stesso tempo, l’enfasi è posta sulconcetto di responsabilità sociale e morale. Gli indiosposseggono in gran parte il libero arbitrio, ma lo usanomale. È come se non ce l’avessero, mentre ciò che èdovuto va fatto. Non si fanno sconti. La funzione delregime coloniale illuminato è quella di eliminare ocontenere i rischi che comporta la coesistenza con deiselvaggi antisociali che sfidano irragionevolementel’autorità terrena e quella divina, che vogliono solo illoro bene. Sepúlveda non è interessato alle culture edalle società autoctone, non s’interroga sulle lororagioni e motivi. In questo modo, dopo aver fatto uscirela metafisica del male dalla porta principale, la farientrare dal retro, come eccedenza di realtà che non sae non intende spiegare. L’ignoto, l’esotico,l’imprevedibile lo spaventano, ciò che è diverso vacollocato in un luogo diverso: le encomiendas e irepartimientos.
L’autoritarismo paternalista di Sepúlveda nonconsente mescolanze, non permette che la libertà divengaun pretesto per porre a rischio l’ordine, la regolarità,la calcolabilità e la classificabilità dei singoli.Singoli visti come unità, come nella classica distorsionedell’umanesimo che si fissa sull’Umanità a discapitodegli umani in carne ed ossa, nella loro individualità especificità. È curioso che un severo ed intransigentecritico di Martin Lutero come lui finisca per condivideresostanzialmente il punto di vista del padre spiritualedella riforma protestante, quando afferma che “Dio hadisposto che gli inferiori, i sudditi, fossero del tuttoisolati, separati fra loro, e ha tolto loro la spada, eli ha gettati in carcere. Ma quando si sollevino, e siuniscano ad altri e infurino e prendano la spada, alcospetto di Dio sono meritevoli di condanna e di morte”.
236
Sepúlveda sostiene che i nativi americani potrannoessere educati, ma non in realtà non è mai stata concessaloro la possibilità di farlo nei loro modi e nei lorotempi. Non è accettabile, non è quasi concepibile che chiè restio a partecipare al nuovo ordine pedagogico, arendersi utile all’imperatore e a Dio, a farsi collocarenella nuova gerarchia di potere, in uno stato semi-servile, al fondo della piramide sociale. Il feticciodell’astrazione: si astrae un tratto dal tutto, lo siesamina, si stabilisce essere disarmonico, si provvede arimuoverlo. La sensibilità del filosofo e teologospagnolo ci rimanda piuttosto all’integralismo puritano.È l’utopismo dell’”uomo senza petto” (cf. Men Without Chestsdi C. S. Lewis), uno che usa la testa per decidere ma nonil cuore per guidare le sue decisioni, un giardiniere cheestirpa le erbacce e toglie di mezzo le ramaglie cherovinano l’estetica del giardino e che, nei casi estremi,come quando si addomestica un popolo barbaro, ricorrealla.logica del bonsaista: si tagliano via quasi tutte leradici, tranne quelle più giovani e si confina la piantanella prigione di un vaso. Questo per il suo bene, perchéè della retorica del benessere che si ammanta l’umanesimoautoritario di Sepúlveda.
Questi, scettico in merito alla possibilità deinativi di vivere senza danneggiare il prossimo,contempla piani di armonizzazione sociale che inducanouna qualche forma di rinuncia volontaria ai conflitti innome del bene comune. La sacralizzazione dello Stato èsolo il primo passo, ma è necessario, perché occorrestabilire come premessa di fondo l’impossibilità che ilsovrano e la nazione possano essere ingiusti o nocivi persudditi e cittadini. Serve l’immunità morale,l’intangibilità che è propria del sacro, ossia di ciò cheincarna le forze del bene e l’unica verità possibile(recta ratio).
Condivido l’opinione di Fernando Mires quandoconclude che “ciò che caratterizza il pensiero
237
rinascimentale di Sepúlveda è l’averlo messo al serviziodi cause (stato, nazione, classe, ecc.) che non pongonoal centro l’uomo”. Di fatto il filosofo totemizza evenera tutto ciò che non è umano, screditando la suastessa formazione di umanista, appunto. In un’inavvertitaautocastrazione morale ed intellettuale, la sua missionenon è valorizzare l’umano ma promuovere il pragmatismoanemozionale della megamacchina burocratica imperiale.Come avrebbe poi scoperto Max Weber, “la burocrazia nelsuo pieno sviluppo si trova anche, in senso specifico,sotto il principio della condotta sine ira ac studio. La suaspecifica caratteristica, gradita al capitalismo, nepromuove lo sviluppo in modo tanto più perfetto quantopiù essa si “disumanizza” – e ciò vuol dire che conseguela sua struttura propria, ad essa attribuita come virtù,che comporta l’esclusione dell’amore e dell’odio, ditutti gli elementi affettivi puramente personali, ingenere irrazionali e non calcolabili, nell’adempimentodegli affari di ufficio”.
Una concezione del mondo e dell’umano che è, ancorauna volta, agli antipodi di quella lascasiana, la qualepredica che moralità e realizzazioni intellettuali nonvanno a braccetto (ma poi elogia le imprese artistiche edarchitettoniche dei nativi americani); celebra l’evidenzadel fatto che tutti i gruppi umani fanno parte dellamedesima famiglia e che ciascuno dà il suo specificocontributo al progresso dell’umanità verso Dio; infineammonisce che non si fanno riforme senza spiritoautocritico e che quando questo manca, l’orgoglio superboche rimane serve solo gli scopi di un imperialismo anti-cristiano. Dovendo scegliere, conclude Las Casas, “unodovrebbe dare più peso all’osservanza della legge di GesùCristo che alla disapprovazione dei monarchi”. Las Casasnon è per nulla propenso a dar vita ad una concordiatotalitaria, che sembra invece essere l’aspirazione diSepúlveda. Per lui l’addivenire ad “un solo ovile e unsolo pastore”, ossia la conversione dell’intera umanità
238
alla vera religione, è un evento che preannuncia ilritorno del Cristo, ma non può calpestare il dovere dellatolleranza. Non è tutto accettabile quando si perseguel’unità, anche quando questa garantisce il riconoscimentoe la difesa della pari dignità morale degli indigeni.
Non c’è dubbio che lo stesso disprezzo verso i popoliinferiori (che vanno sgrezzati ed addestrati) diSepúlveda connota anche l’atteggiamento di JonathanSwift, magnificamente esposto in tutta la sua virulenzada George Orwell: “Lo scopo, come sempre, è umiliarel’Uomo ricordandogli quanto è debole e ridicolo…e laragione ultima, probabilmente, è un qualche tipo diinvidia, l’invidia del fantasma per il vivente, di chi sache non può essere felice per quelli che – teme – possonoessere più felici di lui. L’espressione politica diquesta prospettiva dev’essere o reazionaria o nichilista,perché la persona che la perora vuole evitare che lasocietà evolva in una direzione in cui il suo pessimismopossa essere ingannato”.
Qualcuno potrebbe obiettare che Sepúlveda difende ildiritto dei nativi di ricevere qualche beneficio dallaConquista e che il loro benessere è tutt’altro chemarginale nelle sue argomentazioni, ma è difficiledissipare il sospetto che sia virtualmente indifferentealle crudeltà spagnole nel Nuovo Mondo, visto che leritiene un male minore, o un mezzo spiacevolegiustificato da un nobile fine e che per lui qualunquediscorso inerente l’autodeterminazione degli indigeni èfutilmente idealistico.
Rileggiamo un brano emblematico della sua Apología: “èproprio dell’usanza e della natura umana che i vintiadottino con facilità i costumi dei vincitori edominatori, e li imitino volentieri in ciò che fanno edicono”. Nessun compromesso è previsto. Vincere èconvincere. Di contro, Las Casas, fedele alla suaconvinzione che ogni essere umano merita rispetto inquanto anima incarnata, ossia manifestazione terrena del
239
divino, denuncia anche la pratica di ispanizzare itoponimi e i nomi propri degli indigeni, addiritturasostituendo con nomi spagnoli quelli delle figure piùprominenti. Comprende immediatamente che, com’è poiavvenuto nell’Alto Adige fascistizzato, questo è unopassaggio chiave dell’espropriazione dell’identitàautoctona, assieme alle proprietà indo-americane.
È bene però non idealizzare eccessivamente laliberalità del domenicano. Nel 1516 aveva chiestoall’inquisitore Cisneros di trapiantare l’inquisizionenel Nuovo Mondo, per evitare che le coscienzesuggestionabili dei nativi fossero corrotte da possibiliinfluenze protestanti o eretiche. Inoltre il suo rispettoper i culti locali, talora persino eccessivo – comequando difende i sacrifici umani in un fremito post-modernista ante litteram –, è pur sempre finalizzato alladefinizione degli stessi come propedeuticiall’evangelizzazione della vera fede. In altre parole inativi non hanno altra scelta se non quella di diventarecristiani, per il semplice fatto che Las Casas non puòneppure concepire l’idea che una mente razionale, anchedopo lunghe disquisizioni, possa rifiutarsi di amare Gesùil Cristo, come questi amava gli esseri umani. “Tutte lenazioni del mondo sono umane” e “la nostra religionecristiana è la medesima e può essere adattata a tutte lenazioni del mondo e da tutte essa riceve in ugual misura,e non sottrae a nessuna la loro sovranità, né lesoggioga”, scrive. Allora come si può pensare dirifiutare un dono, quando non si chiede nulla in cambio,se non apprezzamento e valorizzazione? Di qui il suomaggiore cruccio: “Loro [gli indigeni] che arrivano adetestare Dio stesso poiché lo considerano la causa ditutti le loro disgrazie…a tal punto che deducono che iloro dèi erano migliori del nostro Dio, poiché questoprocura loro tanto male”. Ciò detto, e tenendo conto delfatto che è pur sempre un uomo di Chiesa, è giusto
240
elogiare la costanza e la lucidità con la quale il Nostrodemolisce iconoclasticamente ogni motivo di vanto degliSpagnoli, incluso l’appellativo di “conquistadores”, asuo avviso “il più infame dei titoli, anche se loro loconsiderano un grande onore”.
La reazione di chi doveva difendere i propriinteressi socio-economici dall’assalto di chi ligiudicava giuridicamente e moralmente illegittimi nonpoteva che essere brutale. Las Casas è stato accusato diessere uno strumento del demonio dall’Anónimo de Yucaynel 1571 che si è lamentato della sua nefasta influenza edegli scrupoli che ha fatto insorgere nell’animodell’imperatore e nei teologi spagnoli. Una manipolazionecertamente d’origine diabolica, “era una scaltra operadel diavolo convincere il mondo così repentinamente di untale inganno”. L’esploratore e cosmografo Pedro Sarmientode Gamboa, nel suo prologo alla Historia de los incas, spiegache il diavolo, avendo riconosciuto il declino del suoculto nelle Americhe, si era servito dei suoi stessinemici, frati come Las Casas, per mettere in discussionele leggi e la sovranità spagnola nelle Indie. IConquistadores sono strutturalmente incapaci dicomprendere che esiste un modello di società cristianaideale che è radicalmente differente rispetto a quellospagnolo. Ciò li spinge a svalutare tutto ciò cheincontrano e a sovrastimare i loro capricci e le lorofissazioni. L’utopia di Gonzalo Fernández de Oviedo èemblematica della voragine che si era aperta tra l’uno el’altro schieramento. Mentre Las Casas sottolinea ladignità e preziosità di tutte quelle espressioni dellaciviltà umana che non ostacolano la diffusione dellarivelazione di Gesù il Cristo e patrocina l’abolizionedell’encomienda, Oviedo elabora la sua risposta alladomanda su come sia possibile far cambiare i nativi inmodo da tramutarli nel tipo umano che dovrebbero essere.Ovviamente l’encomienda, una “nobile istituzione”,rappresenta l’architrave di questa risposta. Il problema
241
vero è che non tutti sono degni di gestirla, non tutti losanno fare come si deve. Dovrebbe essere concessa inusufrutto esclusivamente a caballeros y personas de muchahidalguía e noble sangre, perché Non potest arbor mala bonos fructusfacere, l’albero cattivo non può dare buoni frutti.Ritorna dunque il motivo dell’associazione di sangue puroed aristocratico e superiore intelletto e padronanza chedovrebbe formare una gerarchia indeformabile edarmoniosa, garante di un ordine assoluto, pacifico edindustrioso. Se il Consiglio delle Indie inviasse anchesolo cento cavalieri del glorioso Ordine di Santiago, lariforma diventerebbe realtà immantinentemente.
Las Casas, Erasmo e Origene
Cristo costituisce le ricchezze dell’anima e pertanto lui stesso è la suaredenzioneOrigene
Trovo assolutamente stupefacente che una persona cosìsolerte ed avveduta nell’approfondimento sistematico eragionato della questione indo-americana sia la stessache, da vescovo del Chiapas, decise di scrivere alprincipe Filippo una lettera di questo tenore: “Credo cheDio mi illuminerà su come agire…Dio vuole che ioricominci a riempire i cieli e la terra di grida, dipianti e gemiti davanti a questa Corte e in questo mondofinché Lucifero non uscirà dalle Indie, poiché egli viregna e vi detta legge più che quando questa gente vivevanel paganesimo più totale…Il mio unico desiderio è cheDio mi dia la forza necessaria”. Las Casas era profetico,mistico ed idealista ed al tempo stesso pratico egiudizioso. Non era un uomo di mezze misure e ditemperamento contegnoso. Tutto questo lo rendeva ungeniale innovatore, a tratti sovversivo, ma mai asufficienza da divenire inviso ai vari sovrani ai quali
242
si appellava. Non mi è parso che Las Casas abbia mainominato quelli che sono i pensatori che lo hannomaggiormente ispirato, Erasmo da Rotterdam e Origene.Immagino che ciò sia da addebitarsi al fatto che entrambierano presenze scomode nel pantheon intellettuale dellaChiesa. L’origenismo non piaceva all’imperatoreGiustiniano e la Chiesa post-costantiniana, col quintoconcilio ecumenico di Costantinopoli, condannò gliorigenisti (ma non Origene) per le loro influenzepitagoriche, platoniche e neo-platoniche. Ritengotuttavia che sia assai probabile che Las Casas conoscessepiuttosto bene il loro pensiero e lo ammirasse. Infattiil Rinascimento vide un forte recupero dell’interesse perOrigene, con la pubblicazione di numerose edizionicritiche delle sue opere. Ma anche se non avesse maipotuto leggere alcuno scritto originale, rimane pursempre vero quel che sostiene Hans Urs von Balthasar inGeist und Feuer, ossia che “non c’è nessun pensatore dellaChiesa che è così invisibilmente onnipresente quantoOrigene”. Las Casas può aver assorbito l’origenismo damolte fonti. Erasmo non fu l’unico riformatore umanistaad esserne influenzato. Sono perciò indotto ad ipotizzareche il Nostro abbia cercato di applicare la loro lezionealla realtà americana e che alcune delle sue riflessionipiù peculiari, dalla metafisica dell’anima al rifiuto diassolvere gli encomenderos indichino una chiara influenzain questo senso.
Le personalità e mentalità di Erasmo e di Bartoloméerano particolarmente congruenti. Erano entrambi spiritiliberi ed indomiti, appassionati, sensibili, cultoridell’amicizia, insofferenti alle gerarchie, responsabili,perseveranti, giusti, pacifisti, scettici nei confrontidi rituali e osservanze meccaniche, contrari a divisionie confini, e perciò critici del patriottismo e delnazionalismo e cosmopoliti; e ancora amanti dei classici,cristocentrici e sospettosi di ogni verbosa complicazioneteologica che rischiasse di oscurare la parola del
243
Cristo, impegnati ad estendere alle relazioni tra ipopoli e le nazioni le virtù da lui indicate comeprimarie. Erasmo, come Las Casas, credeva che i diecicomandamenti fossero passati in secondo piano rispettoalle Beatitudini, che la politica dovesse esseresubordinata alla morale insegnata nei Vangeli e che unateologia della pace sarebbe stata anche una teologiadella liberazione, perché la pace presupponeva lafratellanza e la solidarietà, senza le quali sarebbeirrealistico pensare di poter essere liberi (Halkin1988). Per tutti e due la Chiesa non era un’istituzionepiramidale ma il corpo mistico del Cristo. Las Casas, nelprologo all’Historia, così lo descriveva: “un necessarioe cattolico principio, vale a dire, che non c’è né c’èmai stata generazione, né stirpe, né popolo, né lingua,fra tutte le genti create…da cui – tanto più dopol’Incarnazione e la Passione del Redentore – non si debbaraccogliere e comporre quella gran moltitudine chenessuno può contare, che san Giovanni vide nel capitolosette dell’Apocalisse, e che è il corpo mistico di Gesù eChiesa, o uomo perfetto”.
Difficile immaginare che la teologia politica el’antropologia filosofica di Las Casas, diciotto anni piùgiovane di Erasmo, non siano state influenzatedall’umanista olandese. Carlo V era nato a Gand (Gent),nelle Fiandre, e presso la sua corte Las Casas incontròdiversi influenti fiamminghi che lo presero in simpatia econtinuarono a perorare la sua causa (Thomas, 1994). Traquesti, il cancelliere Jean le Sauvage, che era ancheprotettore di Erasmo ed aveva addirittura propostoquest’ultimo per un seggio vescovile in Sicilia ed ilcappellano del cancelliere, Pierre Barbier, che fuindicato come vescovo (senza obbligo di residenza) delladiocesi di Paria y Cumaná, proprio quella dove Las Casasaveva miseramente fallito la sua sperimentazione sociale.
È perciò abbastanza naturale che la sua famosa (ofamigerata, per chi vi si opponeva) esortazione ad
244
astenersi dall’assolvere gli oppressori come mezzo perliberare gli oppressi avesse un precedente illustreproprio in Erasmo che, nel trattato Querela Pacis (1517),invitava a non assolvere militari di professione morentie a non seppellirli in terreno consacrato: “I preticonsacrati a Dio non dovrebbero frequentare luoghi dovesi fa la guerra, ma quelli dove la guerra ha termine”.Anche il pacifismo assennato di Las Casas aveva molto incomune con quello di Erasmo. Scriveva Las Casas nelDell’unico modo: “è come un uragano e come un oceano, chetutto invade e distrugge. Essa apre la via alle azionidepravate, eccita odi e rancori. I poveri non hanno piùnulla; i ricchi sono spodestati. Tutto si riempie ditimore, le leggi sono abolite; ogni sentimento umanosparisce; non c’è più equità e religione; sacro e profanosi confondono. Cos’è la guerra, se non unomicidio?...perdita delle anime, dei corpi e dellericchezze”. Nell’Apología, un’avveduta condanna delcalcolo utilitaristico nella deliberazione sullagiustezza di una guerra: “gli infedeli che commettano uncrimine di questo genere, cioè a dire, che uccidano ibambini in sacrificio o li mangino, non vanno semprecombattuti con una guerra, sebbene sia in conformità aicompiti della Chiesa trovare dei rimedi che pongano finea questo male; però, innanzitutto, occorre riflettercibene, di modo che per impedire la morte di pochiinnocenti non si causi quella di un’innumerevolemoltitudine di persone che parimenti non lo meritano, nonsi distruggano interi regni, non s’infettino i loro animicon l’odio verso la religione cristiana e non desiderinomai più sentir parlare del nome del Cristo, né ascoltarela sua dottrina”.
In un’occasione il domenicano difese l’umanistaolandese dall’accusa di essere un disfattista in odore dieresia. È forse uno dei pochi rapidi accenni dedicati aquesta figura che si possono trovare negli scrittiufficiali di Las Casas, quasi certamente perché Erasmo, a
245
quel tempo, era “persona non grata” nel dibattitoteologico spagnolo. Va rilevata comunque la comune enfasisulla natura pacifica dell’insegnamento del NuovoTestamento, sull’essenzialità del libero arbitrio e sullabontà della natura spirituale dell’umano. “Tutte questeuniverse ed infinite genti, di ogni genere, Dio le hacreate semplici, senza malvagità né doppiezze,obbedientissime e fedelissime ai loro signor naturali edai cristiani che servono; più di ogni altre al mondoumili, pazienti, pacifiche e tranquille, aliene da rissee da baruffe, delitti e maldicenze, senza rancori, odi nédesideri di vendetta” (Brevissima relazione della distruzione delleIndie). A questo io aggiungerei quella che sospetto siaun’identica passione per l’origenismo. Erasmo era unpensatore impregnato di origenismo; affermava che “unasola pagina di Origene mi insegna più filosofia cristianache dieci di Agostino e trovo più compassione in unapagina di Origene che in dieci di Agostino” (Godin, 1982,pp. 684-685). Arrivò ad associare Origene, il suo autoredi riferimento in molti campi del sapere – incluso iltema del libero arbitrio: Erasmo basa le sue riflessionisul Peri Archon di Origene –, a Venere, dichiarandolo senzaconfronti, rappresentante per eccellenza di ciò che luichiamava la saggezza della prisca vetustas, la più venerabileantichità.
Origene, che per H.U. von Balthasar, uno dei massimiteologi cattolici del secolo scorso, “resta il piùgeniale, il più grandioso interprete e amante dellaParola di Dio” (cf. Franco 2005), insisteva sempre sullabontà di Dio – che non può essere causa del male – esulla libertà dell’uomo, che ha generato il male: “Dionon ha prodotto la malizia, ma una volta prodottasi perla scelta volontaria di coloro che hanno piegato dallavia retta, non ha voluto toglierla del tutto, prevedendoche, anche se inutile a quelli che se ne servivano, eglipoteva renderla tuttavia utile a coloro contro i qualiera esercitata” (Origene, cf. Franco, op. cit. p. 140).
246
Come Erasmo e Las Casas, Origene non credeva allecrociate contro il Male, perché presupponeva che le cosedell’universo fossero ordinate in un certo modo da Dio,che aveva in mente la Salvezza della Creazione. “Dobbiamoevitare in tutti i modi che si trovi in noi il male;negli altri dobbiamo sforzarci di vincerlo, non disopprimerlo, poiché anche quelli nei quali c’è il maleapportano un concorso necessario al mondo. Niente èinutile, niente vano davanti a Dio, poiché egli si servedel buon proposito dell’uomo per il bene, e del propositocattivo per ciò che è necessario”. Per Las Casas, comeper Origene e Erasmo, il determinismo fatalista epessimista, nonché misantropico, che aveva parzialmentecondizionato l’evoluzione della dottrina cristiana erainsostenibile. Per tutti e tre il vero grande maestro eraCristo, ma Socrate e i filosofi neo-platonici eranogiunti molto vicini a certe verità basilari.
Concentrandosi ora sulle affinità tra Las Casas eOrigene, queste si possono riscontrare già a livelloantropologico. Origene dava immancabilmente la prioritàontologica all’anima sulla materialità del corpo perchéla somiglianza con Dio (Genesi 1, 26) si spiega solonella trascendenza, non certo nella mortalità fisica. LasCasas faceva lo stesso e traduceva questo principio inregole atte alla retta predicazione: “Lo spirito umanovuole essere persuaso e non costretto, in quanto ha in séqualche cosa di elevato e di sublime che non sopporta masi compiace di ciò che è rispettabile e virtuoso, perchélo ritiene in grado di confermare la propria dignità”(Dell’unico modo). Lassegue (1974) spiega che “Las Casassitua l’indio in un processo generale, in una marciaculturale dell’umanità. Più in là o più in qua: il luogodell’indio secondo Las Casas è utopico, vale a dire chesi tratta di un luogo proprio a nessuno e a tutti, luogoal quale l’umanità si vede spinta dal desiderio, dallafame di felicità totale”.
247
Las Casas, almeno ufficialmente, non abbracciò mail’apocatastasi origeniana – e di Clemente Alessandrino,Gregorio di Nissa e Giovanni Scoto Eriugena –, cioè lacredenza considerata eretica che la beatitudine diverràrealtà dopo l’avvenuta resurrezione del Cristo, quandol’aspirazione a ricongiungersi al Cristo e a Diopermetterà a tutte le anime, comprese quelle dannate, diraggiungere la meta e il giorno del giudizio i corpifisici saranno trasformati in corpi spirituali. Unacredenza che in pratica dichiara la funzione della Chiesasuperflua, in contrasto con la massima “extra ecclesiam nullasalus”, ribadita dal Concilio di Trento. Tuttavia ilNostro poneva come unico limite temporale per laconversione il Giorno del Giudizio, opponendosi quindialla smania convertitrice dei francescani fiamminghi –tra questi Pedro de Gande –, che avevano trasformato ilbattesimo in una catena di montaggio. Il domenicano noncredeva che, senza battesimo, gli indios sarebbero statiautomaticamente dannati. Abbiamo visto che mette inguardia gli Spagnoli dal credere di essere più benvolutida Dio rispetto agli Indios. Dichiarava che non sisarebbe sorpreso di vedere quelle persone che erano stateconsiderate subumane trovarsi in gran numero accanto aDio. Contestando la validità del requerimiento, Las Casaslo descriveva come “un dileggiare la verità e lagiustizia e vituperare la nostra religione cristiana e lapietà e carità di Gesù Cristo, che tanto aveva soffertoper la salvezza di queste genti; che non potendo fissareloro un limite di tempi per convertirsi a Cristo – poichéegli a nessuno lo fissò ma diede tutto il tempo che ci fue c’è dal suo principio fino al giorno del giudizio – glidicono di concedere non ad una particolare persona, ma adognuno tutto lo spazio della vita della vita perconvertirsi, usando la libertà del libero arbitrio”(Historia).
Per Las Casas, come per Origene, la salvezza non erariservata a pochi e verteva sulla conoscenza consapevole
248
del significato del messaggio cristiano e dell’amore diDio. Non c’era invece salvezza in una fede sostenutadalla paura di un dio vendicativo ed irascibile. Anche leanime degli indigeni americani, come ogni altra anima,erano cadute nel peccato per aver scelto diautoaffermarsi orgogliosamente, per essersi allontanatedal Bene. Ma per tutte valeva la parabola del FigliolProdigo. “La fede consiste nel consenso che la volontà dàalle proposizioni che si credono, perché assentire è ciòche con proprietà si chiama credere” (Dell’unico modo).L’antropologia dei due pensatori cristiani eraottimistica perché, a differenza degli gnostici e di unaparte della teologia cattolica e protestante, essi eranoconvinti che la volontà e l’amore divino compenetranoanche la sfera terrena, il livello materiale. Nulla dispirituale o materiale era separato da Dio e quindi – unpunto al quale teneva molto Las Casas – la condizionedell’anima era strettamente legata a quella del corpo evice versa. Un ulteriore corollario era che il diavolonon poteva essere un avversario indomabile condannatodalla sua natura ad indurre l’uomo in tentazione: il malesi allontanava temporaneamente da Dio, ma non era unaforza indipendente. Las Casas dedicava molto spazio allafigura del “Maligno” ed ai suoi poteri, specialmentenella Apologética Historia. Il diavolo non era solo ma venivaassistito dai suoi collaboratori con i quali rapiva gliesseri umani e li trasportava altrove, commettevainfanticidi, induceva comportamenti bestiali in certepersone predisposte, creava illusioni per ingannare isensi umani, appariva in forma umana, ecc. Il suoobiettivo era quello di persuadere gli esseri umani adagire contro la loro natura, cioè a scegliere un camminoche li avrebbe allontanati da Dio, e per farlo si servivadi riti e culti religiosi, cosicché l’inganno potevaamplificare esponenzialmente le scelleratezze umane.Tutte le attività demoniache erano implicitamenteautorizzate da Dio, che aveva concesso all’intera
249
creazione la libertà di errare e di indurre in errore.Satana ingannava e manipolava, ma non poteva violare illibero arbitrio, poteva solo influenzare le personefacendole sbagliare. “Non c’è bontà in ciò che non èlibero”, scriveva Las Casas nel Dell’unico modo. L’uomorimaneva libero di scegliere tra bene e male ma potevascegliere il secondo scambiando una felicità mondana edeffimera per il Vero Bene. Era un travisamento, unosviamento, come lo sono i sacrifici umani o i massacri inonore di Dio, ma non era un’adesione consapevole al Male.Non era il rifiuto della luce ma il classico equivoco tralucciole e lanterne. Dunque non sarebbe statoirrimediabile, giacché nulla è irrimediabile. Dio è Beneed Amore, come potrebbe creare qualcosa di malvagio? Daquesto assunto di fondo s’ingenerava il relativismoculturale di Las Casas, che riusciva a tollerare glierrori dei nativi (cannibalismo, sodomia, idolatria,ecc.) perché li considerava episodi, parentesi incontrocorrente lungo un percorso di evoluzionespirituale, prodotti di un consenso non-informato edisinformato, a sua volta figlio del libero arbitrio cheera comunque una risorsa eccezionale: “poiché la libertà,un bene inestimabile, non si vende neppure a peso d’oro”.Nessun determinismo metafisico originario verso il male,ma un fuoco di attrazione che, dalla destinazione finaledell’umanità, s’impegnava ad attrarre le anime verso ilBene e l’Amore, lasciandole libere di rispondere alrichiamo oppure no. L’anima non aveva perso la sualibertà con la caduta. Tutti erano ancora liberi discegliere Dio o di non farlo. Qualcuno ci sarebbearrivato prima di altri, seguendo percorsi meno tortuosi,altri ci avrebbero impiegato di più. Dio è alla fine del“nostro” tempo e ci chiama a lui, non è all’inizio apredeterminare le nostre mosse. Origene riteneva cheanche i demoni potessero scegliere la via più diretta aDio. Questo non è un problema che Las Casas si pone,perché si occupa soprattutto di questioni pratiche, non
250
di metafisica. Ciò nonostante egli concorda con Origenenel dire che il principio di libertà unificava la realtà;ogni singola cosa nel mondo, organica o non-organica eralibera fin dalla sua origine e solo l’intervento umanoaveva determinato l’insorgere della proprietà privata ocollettiva. Per entrambi a maggiore razionalitàcorrispondeva un grado maggiore di libertà ma, in unrapporto intimamente relazionale, ognuno era dotato diciò che era necessario a redimersi, perché tuttol’esistente era buono nella sua relazione con l’essere ela volontà di Dio. La funzione pedagogica di Cristorisiedeva nel modello di vita che aveva offerto e neisuoi insegnamenti. Cristo era la Verità e perciò avevagià indicato tutti gli elementi necessari per la salvezzadi ognuno, primo tra tutti il corretto uso del propriolibero arbitrio. Las Casas, come Origene, enfatizzaval’unità di volontà, mente e spirito. Il loro era unostrenuo attacco contro ogni tipo di determinismo. Graziae libero arbitrio non si escludevano a vicenda e senzalibertà non ci sarebbe speranza; la loro èincontrovertibilmente un’antropologia della speranza.
Un’altra premessa comune era che tutto ciò che Dioaveva creato aveva pari dignità, era uguale ai suoiocchi, con le stesse opportunità e potenziale. Tuttierano nati liberi ed uguali e in un rapporto diretto conDio. Il libero arbitrio aveva fatto il resto, generandosquilibri, disarmonie, divari e gerarchie. Per Origene ilLogos si adattava molto bene alla mente ed alla vita deisingoli. Perciò non esisteva un’unica via che conduca alui: qualcuna era più ottimale di altre, ma non sarebbestato possibile saperlo in anticipo e si dovevano quindiconsiderare molte opzioni nella fede, poiché una diqueste avrebbe potuto essere quella più giusta per la talpersona, quella che la portava più vicina alla veritàdivina. Las Casas non si spinse mai così lontano, masospetto il suo sentimento etico della vita e dellapolitica lo avrebbe condotto necessariamente lì, in
251
circostanze diverse. “Il suo essere cristiano si confondecon questo meravigliarsi dell’altro e si attua in base acodesto stupore. È, invece, nemico del rinchiudersi nellacecità dell’insensibilità” (Castillo, 1993, p. 12).Infine Origene prediligeva la cristianità dei piccoligruppi, contrapposta alla campagna ed alla grande città.Similmente, i progetti di ingegneria sociale di Las Casasavevano l’obiettivo di costruire delle repubbliche indo-spagnole capaci di fondere le componenti più propizie econvenienti della vita di campagna (es. il sensocomunitario) e di quella di città (es. ciò che al temposi chiamava la “prudenza politica”), disfacendosicontemporaneamente di quelle più deteriori, come gliatavismi rurali e la frenesia acquisitiva delle metropoli(Mires, 1991).
In chiusura di capitolo, vorrei riportare duevalidissime considerazioni di due biografi latino-americani di Las Casas che secondo me hanno coltopienamente nel segno. Una è del teologo della liberazioneGustavo Gutiérrez, secondo il quale il rifiuto delRequerimiento da parte di Las Casas non era unanacronismo: “Las Casas è vissuto in quell’epoca, eperciò il suo ripudio non può essere più severo; e questonon perché egli precorra i tempi (elogio che piace allospirito moderno) ma perché accetta le vecchie (e semprenuove) esigenze evangeliche senza limiti e concessioni”(Gutiérrez, 1995, p. 163). Poi c’è l’osservazione diFernando Mires che ritengo di importanza centrale:“L’attualità di Las Casas deriva anche dal suotradizionalismo; egli era portatore e difensore diconcetti antichi quanto la stessa società. Egli futradizionalista soprattutto perché nel mezzo dellarivoluzione mercantile, per difendere l’indio, sitrincerò sui valori più antichi, senza rinunciare allenuove conoscenze culturali e scientifiche” (Mires, 1991,p. 184).
252
IL PARADISO RICONQUISTATO
Il cacicco [capo indigeno] dopo aver riflettuto un istante, domando alreligioso se i cristiani andavano in cielo. Il religioso rispose di sì, ma che ciandavano quelli buoni. Il cacicco ribattè immediatamente che non era lì chevoleva andare, ma piuttosto all’inferno, per non dover stare a contatto evedere continuamente gente tanto crudele.Bartolomé de las Casas, “Historia de las Índias”, vol.III
Io che ho cantato il giardino gioioso perduto per la disobbedienza di un solouomo, canto ora il paradiso riconquistato per tutta l’umanità dalla tenaceobbedienza di un solo uomo, messo alla prova fino in fondo da ognitentazione; e il tentatore fallì in tutte le sue astuzie, sconfitto e respinto, el’Eden sbocciò nello squallido deserto.John Milton, “Il Paradiso Riconquistato”.
Las Casas fu un uomo eccellente quanto fu un pessimocronista.
Il Nostro ammucchia idee e parole, apre parentesisenza chiuderle, non si cura della punteggiatura, come sefosse in preda ad un flusso di coscienza. L’urgenza delladenuncia prende il sopravvento. Privilegia la quantitàsulla qualità, a scapito della chiarezza, della coerenza,della precisione e della leggibilità. Ciò, oltre adessere irritante e snervante per il lettorecontemporaneo, lo ha esposto ad un continuo fuoco dicritiche. Molte di queste sono però completamenteimmotivate, dettate da pregiudizio, ignoranza e malafede,più che da una sincera attenzione al suo pensiero. Per lastessa ragione, la sua figura, così centrale e cosìscomoda, è stata anche oscurata da un certo numero diequivoci e di dicerie senza fondamento, che non sarebberosorte se avesse dedicato più tempo alla cura dellaconcisione, della comprensibilità e della nitidezzaargomentativa.
253
In questo capitolo finale, oltre a tirare le fila deldiscorso, possiamo provare a sfatare alcuni miti che locircondano (Adorno, 1993). Il Sivigliano non fu mai unsoldato: lo fu forse suo zio Francisco. Non possedettemai degli schiavi: l’attività familiare ad Hispaniola eradi carattere commerciale. Non fu il primo prete del NuovoMondo: lo divenne a Roma, il 3 marzo 1507. Non ful’iniziatore della tratta degli schiavi africani nelNuovo Mondo: credeva, come molti, che fossero prigionieridi guerra giusta contro i mori e comunque re Ferdinandoaveva già dato il via al commercio all’inizio delsedicesimo secolo. Non aggirò la censura inquisitorialeper pubblicare i suoi trattati. La sua Brevisima Relacion dela Destruccion de las Indias non fu immediatamente tradotta percreare la “Leggenda Nera” anti-spagnola, ma dovetteattendere fino al 1578, quando fu tradotta per il mercatodei Paesi Bassi, allo scopo di servire da ammonimento eda sprone nella lotta per l’indipendenza dall’imperospagnolo. Il suo contributo alla stesura delle NuoveLeggi fu decisivo, grazie alla sua competenza giuridica,che si era conquistata grazie a due specializzazioni indiritto canonico all’Università di Salamanca. È falso chenon abbia proposto un modello socio-economico alternativoa quello dello sfruttamento capitalistico delle colonie:le sue pressioni sull’iter legislativo servivano proprioa promuovere le due idee riformistiche, sebbene certeaffinità con le elaborazioni dell’anarchismo cristianoposteriore (cf. Tolstoj, Ellul) tradiscono il carattereutopico di alcuni suoi progetti.
Las Casas è l’uomo del riscatto, il Giusto chesalvaguarda la speranza in un’umanità possibile nel corsodi una fase particolarmente atroce della storia dellanostra civiltà. Non esito a paragonarlo a DietrichBonhoeffer e trovo sbalorditivo che sia ancora cosìrelativamente poco noto.
254
Las Casas anticipò i fondamenti filosofico-teologicidei diritti umani ed in particolare i loro due capisaldi:la dignità della persona e l’universalità (Entre losremedios, 1542; De regia protestate, 1571). In quest’impresaconcettuale e morale fu influenzato in modo decisivo daFrancisco Vitoria e Domingo de Soto, entrambi educatiall’università di Parigi. Ma li superò per lungimiranza,modernità ed impegno. L’idea di dignità dell’uomo era unlascito dell’umanesimo rinascimentale, una scuola dipensiero che si era fatta sentire, seppur flebilmente,fino a Salamanca. Lui la applicò nella realtà del NuovoMondo, laddove serviva, strappandola alla sfera delleidealità astratte. Le basi del suo approccio nonviolentofurono quasi certamente erasmiane, per il tramite dellacorte di Carlo V e forse anche del frate Diego deAstudillo, insigne teologo e filosofo al prestigiosoCollegio di San Gregorio di Valladolid. La sua importantecondanna dei sofismi manipolativi contenuta nel De unicovocationis modo (1530), che proponeva come alternativa leargomentazioni ragionevoli, i buoni esempi, letestimonianza dirette ed il dialogo non il monologo,potrebbe aver risentito del modello socratico. Las Casasera però anche un ammiratore di Cicerone. Ovviamente, lasua massima fonte di ispirazione furono i Vangeli. Nonnutriva alcun dubbio: se gli indios avessero compreso afondo la grandezza del messaggio di Gesù il Cristo nonavrebbero potuto astenersi dal metterlo in pratica. Illoro buon senso ed intelletto li avrebbero spinti afarlo. Era sufficiente salvaguardare lo ius communicationis,ovverosia il libero interscambio di beni e di idee, altroprincipio fondante delle moderne democrazie. Sempre nelDe unico vocationis modo, Las Casas ripudia la guerra e laviolenza coercitiva, stabilendo che una conversionerassomiglia d’appresso all’avvicinamento di uno studentealla scienza. I pensatori antichi più savi, come pure isanti ed i padri della chiesa, hanno sempre proclamato lanecessità di impiegare le argomentazioni e non la forza.
255
Questa era la posizione di Gesù, che non sentì mai ilbisogno di distinguere tra diverse modalità dievangelizzazione. Questa ritengo sia la filosofiadominante del cattolicesimo liberale e sociale dei nostrigiorni. A questo proposito, a mio avviso, vi sono dueintuizioni lascasiane che precorrono i tempi in unamisura quasi stupefacente. Il primo è un passaggiodell’Apología lascasiana: “Nessuno deve essere forzato adabbracciare la fede; nessuno deve essere castigato per ilsuo fardello di vizi, a meno che non sia sedizioso oarrechi danno alle persone ed alle cose”. Questaformulazione fu reintrodotta nella filosofia politicaoccidentale – in maniera del tutto indipendente, apartire dal pensiero di John Locke (Due trattati sul governo,1689), Samuel von Pufendorf (Sul dovere dell'uomo e del cittadino,1682) e Thomas Jefferson (1743-1826) – dal filosofobritannico John Stuart Mill nel suo celebre “On Liberty”,nel 1859, ossia oltre trecento anni dopo. Altrettantoanticipatrice del pensiero liberale è la seguenteintuizione contenuta nel De regia protestate: “L’autorità e lagiurisdizione dei sovrani si applica esclusivamente perpromuovere gli interessi collettivi del popolo, senzaostacolare ne pregiudicare la sua libertà”. Infine, inuna lettera indirizzata a Bartolomé Carranza che risaleal 1555, Las Casas formulò il principio che sarà poi allabase della Dichiarazione di indipendenza degli StatiUniti d’America, no taxation without representation (scioperofiscale senza un parlamento che difenda le nostreistanze): gli indigeni non sono tenuti a pagare le tassealla monarchia spagnola senza il loro esplicito consenso[No serán obligados a pagar quintos o derechos a los Reyes de Castilla, si losreyes y los pueblos de las Indias no consintieren expresamente de su propiavoluntad, en abdicar de sí y ceder todo el derecho que ellos tenían y seobligasen a pagar los dichos quintos a los Reyes de Castilla].
Il contrasto con la dottrina di Sepúlveda, che vedenella Conquista un benevolo atto emancipatorio chesvincola l’indio dalla sua condizione selvaggia e nella
256
violenza il giusto mezzo per castigare i nativi,colpevoli di essere sottosviluppati e nonsufficientemente solerti nel farsi istruire al viverecivile, è a dir poco sconcertante. Sembra di assistereallo scontro tra due civiltà morali, antropologiche egiuridiche inconciliabili, che si sono sviluppateparallelamente ma in direzioni opposte e, nella Disputadi Valladolid, hanno cercato di stabilire a chi spettassel’egemonia sul suolo americano e forse sull’interopianeta.
Per buona sorte degli indigeni, ma anche di noitutti, Las Casas non fu lasciato solo. Oltre agli appoggia corte e negli ambienti accademici, altri missionari siassunsero l’avvocatura dei popoli indigeni. Tra questi,meritano una menzione speciale Pedro de Córdoba, AntonioMontesinos, Bernardino de Sahagún e Vasco de Quiroga.
L’avanzata età non fiaccò la perseveranza edabnegazione di Las Casas. Chi era presente alle sue“concioni” non ricordava segni di spossatezza nel tonodella sua voce. Ma possiamo immaginare che, dopo averassistito alle crudeltà ed ingiustizie del mondo e deisuoi compatrioti in particolare e dopo averle subite inprima persona, perseguitato come qualunque uomo con unsogno che oltrepassa la visione ristretta dei suoicontemporanei, questi segni attraversassero il suo volto.Non si perse però mai d’animo e continuò, finché ne ebbela forza, a ricordare a chi aveva una coscienza e le davaascolto, che gli indios dovevano essere soggetti dellaloro stessa vita e che l’intera impresa coloniale “ècontro l’intenzione di Gesù Cristo e contro la forma dicarità che nel suo Vangelo ci ha tanto raccomandata, econtraddice completamente, a ben guardare, tutta la sacraScrittura” (Historia). Nel 1562, in un memorandum per ilConsiglio delle Indie, rompendo ogni indugio, ribadivacon forza e schiettezza ciò che era andato dicendo perquarant’anni, con toni meno apodittici, ossia che: “I
257
nativi delle Indie…hanno il diritto di condurre unagiusta guerra contro di noi e di spazzarci via dallafaccia della terra. Questo diritto durerà fino al giornodel giudizio”.
Ciò non avvenne e, in verità, quando morì nelconvento di Atocha a Madrid, si può tranquillamente direche nessuna delle sue richieste e nessuno dei suoidesideri erano stati esauditi. Da un certo punto di vistala vita di Las Casas fu una lunga serie di fallimenti: apartire dalla colonia ideale nel Venezuela (1521),seguita dall’esperimento di evangelizzazione unicamentepacifica del Guatemala (1537-1552), che non fuall’altezza delle sue attese, lo svuotamento di sensodelle Nuove Leggi nel 1545 – quando gli encomenderosmisero assieme milioni di pesos per “massaggiare” lavolontà monarchica – l’esperienza nel vescovato delChiapas in quegli stessi anni – i coloni e una parte delclero si coalizzarono contro di lui per cacciarlo –, labattaglia scolastica con Sepulveda, che finì in unapatta, ma soprattutto la mancata abolizionedell’encomienda. Furono invece i suoi libri ed il suoesempio a decretarne l’ingresso nella storia: i suoiammiratori continuarono la lotta anche dopo la sua morte.La vittoria della guerra era stata solo posticipata, mala sensibilizzazione degli ambienti intellettuali europeialla questione dei diritti naturali fu certamente di persé un contributo magnifico e fruttuoso. Possiamoimmaginare che forse il suo più grande rammarico fuquello di non aver saputo evitare la polarizzazione trachi lo vedeva come il fumo negli occhi e chi aveva intesoil senso più profondo della sua missione, quella cioè diriaffermare che le verità evangeliche dovevano esseremesse in pratica senza compromessi ed esitazioni, che nonsi potevano inventare cavilli e furbizie per aggirare ilsignificato della testimonianza di Gesù il Cristo. Unaparte della Chiesa del suo tempo – e possiamo sospettareuna parte della Chiesa contemporanea – non accettò
258
lezioni di moralità e coerenza da questo profetaindigenista. Ma la colonizzazione pacifica del Messicosettentrionale e delle Filippine si compì anche esoprattutto grazie all’azione dei movimenti indigenistiche prendevano esempio da Las Casas. Inoltre fu in granparte il disperato bisogno di fondi di Filippo II cheportò ad un costante incremento della tassazione eall’abolizione di ogni esenzione, che impedì ai progettilascasiani di trovare un maggior seguito. Ciò non toglieche fu anche grazie a lui ed a chi simpatizzava per lasua causa che nel 1597 Filippo II emanò un decreto cherestituiva i tributi raccolti ingiustamente dagliindigeni filippini non-cristiani. Il decreto richiedevaun consenso volontario, non estorto, alla lorosottomissione alla Corona di Spagna. Così, tra i principiche guidarono la politica coloniale spagnola nelsedicesimo secolo, fecero la loro comparsa anche ilconsenso di chi è governato ed il potere legittimamentecostituito. Non mi risulta che un’altra potenza colonialeabbia emulato la Spagna in questo. Solo la Spagna si fecedegli scrupoli e s’interrogò sulla bontà delle sueiniziative.
Las Casas certamente esagerò le responsabilità umanenel genocidio indigeno e minimizzò o ignorò il ruolodelle pandemie e fece così un favore ai nemici dellaSpagna che enfatizzarono le devastazioni colonialitralasciando la lotta per la giustizia ed i dirittiumani, che fu invece scorrettamente qualificata dallealtre potenze imperialiste come lotta control’imperialismo spagnolo. Certamente lui fu tra i primi acapire ed affermare che solo un attacco radicaleall’intero assetto coloniale avrebbe potuto interrompereil genocidio in corso, ma quest’etichettatura ha oscuratola grandezza del sivigliano, restringendo indebitamenteil suo campo d’azione ed i suoi meriti, oltre che quellidella stessa Spagna, giacché in pratica la stessa societàche produsse gli aguzzini allevò anche i paladini delle
259
vittime. Negli anni Ottanta José Alcina Franch, uno deigrandi etnografi e storici del periodo precolombiano,descriveva l’attivismo di Las Casas come la lotta di unDavide contro il Golia dei poteri oligarchici di stampofeudale, una “lotta titanica di un uomo impegnato acambiare la realtà del suo tempo utilizzando ogni mezzodisponibile…ma il cui pensiero era così precorritore deitempi che solo ora lo stiamo raggiungendo. […]. Ancoraoggi ci sono molte persone che non arrivano acomprenderlo. Come potevano comprenderlo i suoicontemporanei?” (Alcina Franch, 1985)
In una Suplicación a Filippo II del 1565 Las Casas, ormaivecchio e malato, ricapitolò la vocazione di una vita eammonì la Spagna che se non avesse cambiato la suacondotta la giustizia divina sarebbe stata tutt’altro chebenevola nei suoi confronti. La lessero al Consigliodelle Indie: “con questa supplica che presento a SuaMaestà al termine della mia vita…credo di aver assolto ilministero che Dio mi ha assegnato: porre rimedio alletante ingiustizie commesse in così gran numero prima cheintervenga il Giudizio. A causa della mia negligenza, hotuttavia ottenuto pochi risultati e temo che Dio abbiamotivo di castigarmi”. Una vita spesa predicando un Diod’Amore e Comprensione, per poi cedere proprio alla finealla tentazione del dio irascibile, vanesio ecastigatore, che occhieggia persino in quello che dovevaessere il suo testamento spirituale. Una robustaindicazione della forza coercitiva di consuetudini edabiti mentali duri a morire. Ciò detto, il suo esempiopuò servire ancora a riscaldare i cuori e ad incoraggiarei giusti ad operare nel senso di una trasformazioneepocale di almeno una parte della società e dellacoscienza umana. Una rivoluzione nonviolenta all’insegnadella dignità, della pace, dell’empatia, della giustizia,della libertà e della spiritualità, perché non siamoautomi preposti alla perpetuazione di una Cultura, di un
260
Genoma o di una Moda, ma essere umani con una pluralitàdi identità, attributi ed interessi e con un destinocosmico ancora in gran parte inesplorato.
BIBLIOGRAFIA
AA.VV., La etica en la conquista de América, Corpus Hispanorum dePace, 25, Madrid 1984, 95.Rolena Adorno, “The politics of publication: Bartolomé delas Casas The Devastation of the Indies”, In «New WestIndian Guide/ Nieuwe West-Indische Gids » 67 (3/4)(1993), pp.285-292. José Alcina Franch, Bartolomé de las Casas; obra indigenista,Alianza Ed., Madrid 1985. Philippe-Ignace André-Vincent, Bartolomé de las Casas, prophètedu Nouveau Monde, Tallandier, Paris 1980.Adolph F. Bandelier, Traditions of Precolumbian Landings on theWestern Coast of South America, in «American Anthropologist»7(2) (1905), pp. 250-270. Marcel Bataillon, André Saint-Lu (a cura di), Las Casas et ladéfense des Indiens Gallimard-Julliard, Paris, 1973.Mauricio Beuchot, Los fundamentos de los derechos humanos enBartolomé de Las Casas, Anthropos, Barcelona 1994Nestor Capdevila, Las Casas : une politique de l'humanité : l'homme etl'empire de la foi, Editions du Cerf, Paris, 1998. Aldo Andrea Cassi. Ultramar : l'invenzione europea del nuovo mondoLaterza, Roma ; Bari 2007. Carlos Castillo, Bartolomé de las Casas : un itinerario cristiano,Cultura della Pace, S. Domenico di Fiesole (FI) 1993. Daniel Castro, Another Face of Empire: Bartolomé de Las Casas,.Indigenous Rights, and Ecclesiastical Imperialism. Durham: Duke.University Press, 2007 Luigi Luca Cavalli-Sforza, Geni, popoli e lingue, Adelphi,Milano 1996.Inga Clendinnen The cost of courage in Aztec society: essays onMesoamerican society and culture, New York: Cambridge UniversityPress, 2010.
261
Jean-Pierre Dedieu, L’administration de la foi, Casa deVelázquez, Madrid, 1992. Jean Delumeau, La paura in Occidente: secoli 14.-18. La cittàassediata, Società Editrice Internazionale, Torino 1979.Saverio Di Liso (a cura di), La controversia sugli indios.Bartolomé de Las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda, Pagina, Bari 2007.Francesco Franco, La passione dell'amore: l'ermeneutica cristiana diBalthasar e Origene, EDB, Bologna 2005.Raimond Gaita, Good and Evil: An Absolute Conception Macmillan,London 1991.Raimond Gaita, A Common Humanity; Thinking about Love & Truth &Justice, Routledge, London and New York 2000.Maurizio Giretti Storia dell'antigiudaismo e dell'antisemitismo,Mondadori, Milano 2007Giuliano Gliozzi, Adamo ed il Nuovo Mondo, La Nuova Italia,Firenze, 1977.Giuliano Ghiozzi, Le teorie della razza nell’età moderna, Loescher,Torino 1986.Giuliano Gliozzi Differenze e uguaglianza nella cultura europeamoderna : scritti 1966-1991, Vivarium, Napoli 1993. André Godin, Érasme lecteur d'Origène, Droz librairie, Genève1982.Diego,Gracia Guillén, “Judaismo, medicina y mentalidadinquisitorial en la España del siglo XVI”, in AngelAlcalá (a cura di), Inquisición española y mentalidad inquisitorial,Ariel, Barcelona 1984, pp. 328-352.Francesco Guicciardini, La storia d'Italia, Salani, Firenze,1963.Aaron Gurevich, The origins of European individualism, Blackwell,Oxford; Cambridge, Mass 1995.Gustavo Gutiérrez, Alla ricerca dei poveri di Gesù Cristo: il pensiero diBartolomé de Las Casas. Queriniana, Brescia 1995.Léon Ernest, Halkin, Erasme: sa pensée et son comportement,Variorum Reprints, London 1988.Lewis Hanke. Aristotle and the American Indians: A Study in RacePrejudice in the Modern World. Henry Regnery Company,Chicago1959.
262
Lewis Hanke, All mankind is one: a study of the disputation betweenBartolomé de Las Casas and Juan Ginés de Sepulveda in 1550 on theintellectual and religious capacity of the American Indians, NorthernIllinois university press, DeKalb, Ill., 1974. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia,Laterza, Roma; Bari 2003 [1837].Stephenie Hendricks, Divine Destruction: Wise Use, DominionTheology, and the Making of American Environmental Policy, MelvilleHouse, Hoboken, NJ 2005.Nicholas Hudson, From “nation” to “race”: The origin of racialclassification in 18th-century thought, «Eighteenth-centurystudies», 29(3) (1996), pp.247-264.Reginaldo Iannarone, La scoperta dell'America e la prima difesa degliIndios, ESD, Bologna 1992. Francesca Cantù, Le scoperte di Cristoforo Colombo nei testi diBartolomeo de Las Casas, 2 voll., Istituto poligrafico ezecca dello stato, Roma 1993Furio Jesi L'accusa del sangue: la macchina mitologica antisemita,Bollati Boringhieri, Torino 2007.Henry Kamen, The Spanish Inquisition: a historical revision, YaleUniversity Press, New Haven and London, 1997.George Kateb, Human Dignity, Cambridge, Massachusetts:Harvard University Press, 2011.Charles. F. Keyes, E. Valentine Daniel (a cura di),Karma. An Anthropological Inquiry: University of CaliforniaPress, Berkeley 1983.Bartolomé de Las Casas, Obras Completas, Aliança Editorial,Madrid 1988-1992. Bartolomé de Las Casas, Obras escogidas, Atlas, Madrid1957-1961.Bartolomé de Las Casas e Francisco Fernández Buey.Cristianismo y defensa del indio americano. Los Libros de laCatarata, Madrid 1999.Juan Bautista Lassègue, La larga marcha de Las Casas, Centrode Estudios y Publicaciones, Lima, 1974.Angel Losada, Fray Bartolome de Las Casas a la luz de la moderna criticahistorica, Editorial Tecnos, Madrid 1970.
263
Marianne Mahn-Lot, Bartolomeo de Las Casas e i diritti degli indiani,Jaca book, Milano 1985. Mario Marchiori, Il puma ed il condor: miti e leggende delle Ande edella Terra del Fuoco, Edizioni San Paolo, Milano 1999.Giacomo Martina, Pio IX, Editrice Pontificia UniversitàGregoriana, Roma, 1985Fernando Mires, In nome della croce : dibattito teologico-politicosull'olocausto degli indios nel periodo della conquista La piccolaeditrice, Celleno (VT), 1991. Friedrich W. Nietzsche, La volontà di potenza, Newton Compton,Roma 1984.Anthony Pagden La caduta dell'uomo naturale : l'indiano d'America e leorigini dell'etnologia comparata, Einaudi, Torino 1989.Hellen Rand, Parish, Las Casas en México. Historia y obradesconocidas, Fondo de Cultura Económica, México 1992.John Leddy Phelan, The millennial kingdom of the Franciscans in theNew World, University of California Press, Berkeley 1970.Ramón Menendez Pidal, El padre Las Casas. Su doblepersonalìdad, Espasa-Calpe, Madrid 1963.Augusto Placanica, Segni dei tempi. Il modello apocalittico nellatradizione occidentale. Marsilio, Venezia 1990Adriano Prosperi, America e Apocalisse. Note sulla 'conquistaspirituale' del Nuovo Mondo, «Critica Storica» 13 (1976), pp.1-61.Juan Pablo Martín Rodrigues, Bartolomé de las Casas, A Penacontra a Espada. Tesi di master in “Teoria dellaLetteratura”, Recife, Universidade Federal de Pernambuco2006. Roger Ruston, Human Rights and the Image of God, SCM Press,London 2004.Frank Salomon, Stuart B. Schwartz, “New Peoples and newkinds of people: adaptation, readjustment, andethnogenesis in South American indigenous societies(colonial era)”, in Frank Salomon, Stuart B. Schwartz TheCambridge History of the Native Peoples of the Americas. CambridgeUniversity Press, Cambridge 1999, pp.443-501
264
Rubén A. Sánchez-Godoy, Mercancía, gentes pacíficas y plaga:Bartolomé de las Casas y los orígenes del pensamiento abolicionista en elatlántico ibérico, tesi di dottorato, Faculty of Arts andSciences, University of Pittsburgh 2009. Bruno Snell, La cultura greca e le origini del pensiero europeo,Einaudi, Torino 2002.Barbara Spinelli, L’Apocalisse maschera del potere, La Stampa, 28giugno 2009.Francesco Surdich, Verso il Nuovo Mondo. L'immaginario europeo e lascoperta dell'America, Giunti, Firenze 2002James H. Sweet, The Iberian Roots of American Racist Thought, in«William and Mary Quarterly», 54 (1997), 143-166.Werner Thomas, Misioneros flamencos en América Latina, in«Espacio, Tiempo y Forma» 7 (1994), pp. 451-478.Tzvetan Todorov, La conquista dell’America, Einaudi, Torino1992Tzvetan Todorov, Georges Baudot (a cura di), Racconti aztechidella conquista, Einaudi, Torino 1988. Giuseppe Tosi, Bartolomé de Las Casas, in Jura Gentium V(2009), 1http://www.juragentium.unifi.it/it/surveys/rights/profiles/lascasas/ (15 gennaio 2011)David M. Traboulay, Columbus and Las Casas: the Conquest andChristianization of America, 1492-1566, University Press ofAmerica, Inc., Maryland 1994.Victor W. Von Hagen, Gli imperi del deserto nel Perù precolombiano,Newton Compton, Roma 1977.Gustavo Zagrebelsky, Il diritto mite, Einaudi, Torino 1992.
LESSICO
José de Acosta (1539–1600). Missionario e cronistagesuita. Pioniere dell’antropologia.Pedro de Alvarado y Contreras (1485?-1541). Conquistadore governatore del Guatemala. Pietro Martire d’Anghiera (1457–1526). Storico di originiitaliane.
265
Miguel de los Arcos (1482-1564). Teologo domenicano.Domingo de Betanzos (1480–1549). Missionario dominicano.Giovanni Botero (1544–1617). Filosofo italiano. Antonio de la Calancha (1584–1684). Religioso agostinianoe pioniere dell’antropologia. Tommaso Campanella (1568–1639). Domenicano calabrese,filosofo e letterato. Autore dell’opera utopicaintitolata “La Città del Sole”.Bartolomé Carranza (1503–1576). Arcivescovo domenicano diToledo.Bernal Díaz del Castillo (1492–1584). Esploratore,conquistador, cronista.Pedro Cieza de Leon (1512–1554). Cronista e storico delPerù.Francisco Jiménez de Cisneros (1436–1517). Politico,cardinale, missionario, promotore di crociate. Una dellefigure chiave della fase iniziale dell’imperialismospagnolo.Consiglio delle Indie. Consiglio della Corona di Spagnaper l’amministrazione dei possedimenti d’oltremare.Diego de Covarrubias (1512–1577). Giurista della scuoladi Salamanca.Giovanni (Joan) Antonio Cumis (1537-1618). Gesuitacalabrese.Encomienda, o repartimiento. Sinonimi, indicano la prassidella spartizione dei nativi, assegnati a diversi generidi corvée a seconda delle loro attitudini.Francisco Falcòn (1521-1587). Procuratore dei nativi delPerù.Pedro de Gante (Pieter van der Moere) (1480–1572).Missionario francescano di origini fiamminghe.Alberico Gentili (1552–1608). Giurista protestanteitaliano. Francisco López de Gómara (1511–1566). Storico, apologetadel conquistador Hernán Cortés.Francesco Guicciardini 1483–1540). Scrittore, storiografoe filosofo politico.
266
Diego de Landa (1524-1579). Vescovo francescano delloYucatán. Juan de Matienzo (1520-1579). Giudice coloniale e membrodella prima Real Audencia del Nuovo Mondo.Fernando Vázquez de Menchaca (1512-1569). Giurista edumanista spagnolo. Antonio de Montesinos (1475-1540). Missionario dominicano.Primo avvocato della causa indigena. Toribio de Benavente, detto Motolinía (1482-1568).Missionario francescano, uno dei primi 12 a giungere inMessico. Joan Anello Oliva (1574–1642). Gesuita napoletano.Tomás Ortiz (? -1538). Vescovo dominicano. Gonzalo Fernández de Oviedo (1476–1557). Storico enaturalista.Alberto Pio (1475-1530). Principe di Carpi, umanista emecenate. Nipote di Giovanni Pico della Mirandola.Samuel von Pufendorf (1632-1694). Giurista e filosofotedesco. Vasco de Quiroga (1470?–1565). Giudice e primo vescovo diMichoacán (Messico).Real Audencia. Alta corte di giustizia.Reducciones. istituzione gesuita. comunità di lavoro epreghiera. In casi estremi, come a Maní, centri diconcentramento della popolazione indigena, che potevaessere più facilmente sorvegliata e castigata in questecittà “carcerarie”. Matteo Ricci (1552–1610). Missionario gesuita in Cina.Matematico, cartografo ed esploratore del Celeste Impero.Palacios Rubios (1450–1524). Giurista spagnolo autore delrequerimiento, un’ingiunzione di sottomissione che dovevaessere letta agli indigeni per legalizzare il loroassoggettamento. Bernardino de Sahagún (1499-1590). Missionariofrancescano. Pioniere dell’antropologia. Francisco Cervantes de Salazar (1514?–1575). Letterato,uno dei primi accademici in Messico.
267
Juan de Solórzano y Pereyra (1575-1655). Giuristaspagnolo. Domingo de Soto (1494-1560). Teologo domenicano.Confessore di Carlo V e suo rappresentante al Concilio diTrento.Francisco de Toledo (1516-1582). Vicerè del Perù dal 1569ed il 1581.Miguel Cabello de Valboa (1535-1608). Mercenario prima,missionario agostiniano in Sudamerica poi.Blasco Nùñez de Vela (1490–18 gennaio 1546). Esploratoree primo vicerè del Perù.Alonso de la Veracruz (1507-1584). Giurista e filosofo.Allievo di Francisco de Vitoria.Francisco de Vitoria (1486-1546). Teologo dominicano. Unodei padri del diritto internazionale.
268