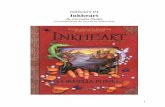Attualità del pittoresco - FULL TEXT
Transcript of Attualità del pittoresco - FULL TEXT
Op.cit.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
rivista quadrimestrale
di selezione della critica d'arte contemporaneaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
D ir e t to r e : Renato De Fusco
R e d a t to r i : Roberta Amirante, Alessandro Castagnaro, Alessandra de MartiniMarina Montuori, Livio Sacchi
Se g r e ta r ia d i r e d a zio n e : Rosa Losito
R e d a zio n e : 80123 Napoli, Via Vincenzo Padula, 2 - Tel, 081/7690783
Am m in is t r a zio n e : 80122 Napoli, Via Francesco Caracciolo, 13 - Te!. 081/7614682
Un fascicolo separato € 6.00 (compresa IVA) - Estero € 7.00
Ab b o n a m e n to a n n u a le :
Italia € 16.00 - Estero € 19.00
Un fascicolo arretrato € 7.00 - Estero € 8.00Spedizione in abbonamento postale - 70%Direzione commerciale imprese - Napoli
C/CfP n. 24514804
Electa Napoli
F. RINALDI,
C. MARTINO,
G. BARTORELLI,
L e a r c h i te t tu r e d i E s c h e r t r a Su r r e a l i sm o e d O p -a r t 5
Sem io t ic a d e l d e s ig n e d u r a ta 1 6
At tu a l i tà d e l p i t to r e s c o 2 8
L ib r i , r iv is te e m o s t r e 4 2
Al la r e d a zio n e d i q u e s to n u m e r o h a n n o c o l la b o r a to : Gaetano Amodio,Ang lo apasso, Nicola Galvan, Andrea Maglio, Fabio Mangone.
Attualità del pittorescoGUIDO BARTORELLI
Questo studio sulZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp i t to r e s c o non nasce per mettere in
discussione, magari a seguito di ritrovamenti d'archivio,
l'evoluzione plurisecolare dell'uso del termine, così come
è stata tracciata finora. Anzi dichiaro, in via preliminare,
che le mie riflessioni poggiano sui risultati cui è pervenuta
la ricerca filologica, dagli studi ormai classici di
Christopher Hussey! e Walter John Hìpple? a quelli recenti
di Philip Sohrn? e Raffaele Milani".
Non nello storico, dunque, sta la motivazione che mi
spinge a stendere queste righe, ma nell'attualità. La mia
ipotesi è che la categoria estetica di pittoresco, a dispetto
della scarsa attendibilità che le è stata attribuita a partire
dall'Ottocento inoltrato, si riproponga oggi come stru-
mento utilissimo per comprendere i più recenti e dibattuti
sviluppi dell'arte. Certamente sarà mia cura filtrarla attra-
verso alcuni aggiustamenti, opportuni dopo le vicende tra-
scorse dalla sua prima comparsa, nel XVI secolo, pur
senza recidere il legame con i significati originari - che
senso avrebbe in tal caso riproporla? -, nella convinzione
che la pienezza della sua pregnanza si colga in un esame
proiettato in prospettiva storica.
Ma cominciamo dal presente e, in particolare, dall'uso
istintivo del termine. Cosa intendiamo quando, in un di-
scorso qualsiasi, pronunciamo «pittoresco»? Una buona
28 definizione ce la fornisce Milani: Il termine pittoresco
viene impiegato nel linguaggio comune per indicare
qualcosa di vivace e colorito, di piacevolmente disordi-
nato e irregolare, di insolito capace di suscitare alla vi-
sta emozioni estetiche".
Il che non è niente male ai nostri scopi, dato che ven-
gono già tirate in ballo le principali proprietà che legano
il pittoresco alle ultime tendenze creative: la vivacità d'e-
spressione, la ricerca di effetti dalla resa cromatica vistosa;
quindi l'appello al piacere, sostenuto dal ricorso a solu-
zioni insolite, che sappiano sorprendere; infine la solleci-
tazione della sfera psico-emotiva, la presa sui sentimenti
e così via. Tanto che si potrebbe ritenere questa defini-
zione già conclusiva, a conferma che spesso la d o xa ha le
sue ben fondate ragioni. Che ora, però, è necessario svi-
scerare con cura.
Il vocabolario (Z in g a r e l l i , 1996) articola il significato
in tre accezioni: l ( r a r o ) Di pittore. 2 ( e s t . ) Di paesag-
gio, scena, veduta e sim. aventi caratteristiche di colore
e di composizione particolarmente vivaci ed espressive:
p a n o r a m a , lu o g o p . 3 ( fig .) Di qualsiasi espressione, an-
che non pittorica, che ha caratteristiche di efficace vi-
vacità ed evidenza: s t i le , l in g u a g g io p . ; m o d o d i p a r la r e
p . ; s i e s p r im e c o n fr a s i p i t to r e s c h e .
Tre accezioni cui corrispondono i tre filoni sernantici,
distinti e allo stesso tempo fittamente intrecciati, che l'e-
voluzione del termine ha seguito nel corso dei secoli. La
prima, ormai desueta perché transitata al più recente p i t -
to r ic o , è quella etimologica, originaria. Quindi è avvenuto
lo slittamento dalla l i t te r a al traslato, che il vocabolario
attesta non in seconda, ma in terza posizione. E questo è
tuttora il senso comune del termine, nel quale risiede gran
parte della sua odierna efficacia. La seconda accezione
. rrisponde, invece, a quella storicamente più raffinata,
laborata nell'ambito inglese della teoria del gusto, tra
Sette e Ottocento, con specifico riferimento al tema del
paesaggio, ma la sua portata, bisogna ammetterlo, rimane
in ran parte confinata a quel periodo.
Ri percorriamo le tappe salienti di questa storia. Il più 29
antico impiego documentato è rintracciabile nelleZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVite di
Giorgio Vasari (1568) e viene riferito ai disegni nei quali
la linea della penna è integrata da lumeggiature e om-
breggiature, con effetti detti, appunto, alla pittoresca, os-
sia che ricordano l'aspetto della pittura". Si rientra, quindi,
nella prima accezione.
Si possono già introdurre, però, alcune considerazioni
ulteriori, in modo da raccogliere, passo dopo passo, i vari
fattori che andranno a comporre il risultato finale.
Innanzitutto va notato che, fin dalla sua prima comparsa,
il pittoresco è applicato al di là dello specifico della pit-
tura, anche se si tratta, nel caso del disegno, di un settore
adiacente. D'altronde è logico che quando vi si intenda
"ciò che è proprio della pittura", lo si rapporti ad ambiti
extra pittorici. Che senso avrebbe, altrimenti, parlare di
una "pittura pittoresca"? È bene aver chiaro questo punto
perché oggi la validità allargata di pittoresco non è affatto
scontata, se pensiamo che, valicata la metà del Seicento,
lo si è usato per indicare una determinata tecnica pittorica
e poi ancora, a partire dal secolo successivo, una deter-
minata nozione estetica da verificare, in buona misura, sui
dipinti. Ma se intendiamo avvalercene per lo studio del-
l'arte contemporanea, bisogna invece essere certi che lo si
possa applicare a modalità espressive che si spingono ben
oltre la pittura.
L'indicazione di Vasari, secondo cui il disegno alla pit-
toresca mostra più l'ordine del colorito, ci permette di
cogliere anche un altro elemento essenziale, già riscontrato
nell'uso comune: il pittoresco esibisce una spiccata evi-
denza cromatica.
La prima metamorfosi del significato originario è atte-
stata dalla C a r ta d e l n a ve g a r p i to r e s c o di Marco Boschini,
poema-trattato sull'arte veneta pubblicato nel 16607• Il pit-
toresco va a qualificare quella modalità di dipingere, ove
il colore non si contiene entro la linea, entro la traccia pre-
paratoria della penna, ma si espande, si sfuma, si impasta
portato dal pennello - mezzo specifico del pittore e qui sta
30 il collegamento con il significato vasariano -, che agisce
libero e fluido sulla tela. È ciò che ogni manuale di storia
dell'arte ci insegna essere peculiare, appunto, della tradi-
zione coloristica veneta, da Giorgione in poi.
In via diretta, però, questa traslazione semantica poco
interessa ai nostri scopi, dato che, lo ripeto, confinando il
pittoresco alla pittura se ne si stronca la potenzialità di ri-
guardare l'arte di oggi", Conta, semmai, il fatto che esso
cominci ad assumere connotazioni di istintività pre-rifles-
siva: un'esecuzione di questo tipo avviene senza le stam-
pelle razionali del disegno, atte a calibrare la composi-
zione in base alle buone regole ereditate dai classici. La
sua forza sta nella potenza dell'emozione retinica, del-
l'impatto esercitato sui sensi. Come non ricordare, al pro-
posito, il prorompente sensualismo di Tiziano? Già si in-
travede il motivo per cui, poco più di un secolo dopo, il
pittoresco verrà distinto, come categoria estetica, dal bello,
fondato invece sulla ragione". Una distinzione che ormai
non regge più, così come l'altra che vede i sensi e le emo-
zioni in opposizione alla razionalità: oggi è chiaro che non
si dà l'una senza gli altri: la percezione sensibile è strut-
turata da forme razionali e queste sono incorporate nella
nostra dotazione sensoriale'".
Da evidenziare il fatto che Boschini intitola la sua pre-
fazione Incita apetito ala curtosìtà!'. Appetito - quale sti-
molo è più prepotentemente fisico? - e, soprattutto, cu-
riosità, atteggiamento che verrà legato a doppio filo al pit-
toresco. D'ora in poi, infatti, al nostro concetto sarà sem-
pre riconosciuta la facoltà di incuriosire, attrarre, catturare
l'attenzione; in altre parole una connaturata predisposi-
zione alla relazionalità. Certo i suoi mezzi sono anzitutto
quelli mali ardi del m o ve r e e del d e le c ta r e che, come ve-
dremo, faranno pronunciare a Francesco Milizia una delle
più severe condanne in cui il pittoresco sia mai incappato.
Ma questi era un perfetto portavoce della mentalità che
scindeva l'intelletto dai sensi, il d o c e r e dal d e le c ta r e , l' in -
ve n t io dall' e lo c u t io , il contenuto dalla forma.
Torna il collegamento tra pittoresco e curioso in un
passo del pittore e poeta Salvator Rosa, che attesta pure 31
l'avvenuto passaggio dal significato letterale a quello fi-
gurato, riferendo il termine alle intense impressioni pro-
vate durante un viaggio da Loreto a Roma: Et il viaggio
è assai più curioso e pittoresco de cotesto di Fiorenza
senza comparizione, attesoché è d'un misto così stra-
vagante d'orrido, e di domestico, di piano e di scosceso,
che non si può desiderar di vantaggio per lo compiaci-
mento dellocchìo".
Vi si colgono altri spunti preziosi. Innanzitutto la con-
ferma della pertinenza del pittoresco ora addirittura al di
fuori delle pratiche artistiche. Si sta parlando, infatti, di un
paesaggio reale, tema che, dipinto o meno, diverrà dalla
metà del Settecento il campo specifico della sua applica-
zione.
Altro attributo notevole è stravagante. Come riscon-
trato nell 'uso popolare, il pittoresco si presenta come qual-
cosa che esce dall'ordinario. Ecco un altro mezzo eccel-
lente per far presa sul pubblico, che il cinema a base di
effetti speciali ha davvero bene appreso.
Dopodiché va evidenziata l'attribuzione al pittoresco di
una vigorosa efficacia sulla psiche, che viene mossa a vari
stati d'animo, tra i quali spicca l'orrore. Proprio il concorso
di un tale sentimento, rende il pittoresco, in questo caso,
inadatto alla gratificazione visiva (non si può desiderar di
vantaggio per lo compiacimento dell'occhio). Va detto,
però, che con questa osservazione Rosa introduce concetti
che i teorici del gusto inglesi, a partire da Edrnund Burke,
faranno rifluire non nel pittoresco, ma nelZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs u b l im e .
Balziamo al 1797 e alla durissima accusa del c1assici-
sta Milizia che, intendendo per pittoresco un non so che
di straordinario che dà subito all'occhio, e diletta, sen-
tenzia: Non più ingegno, non più riflessione nella di-
sposizione del soggetto, non più bellezze di forme, non
purità di disegno, non carattere, non espressione. Il
gran pregio de' quadri è divenuto un bel mestiere di
aggiustamenti pittoreschi, di effetti pittoreschi, di tratti
pittoreschi. Così i pittori hanno acquistato il privilegio
32 di non pensare più: aggiustano, manovranol3.
Sembra di vederli: da una 'parte gli artisti che si appli-
cano all' esercizio intellettuale del disegno; dall' altra quelli
che si avvalgono di un'esecuzione gestuale e istintiva, che
aggiustano e manovrano. È così consumata la scissione
tra la bellezza - basata su di una meditata d is p o s i t io - e
il pittoresco, che fa leva sull'appeal irnmediato!".
Giungiamo così alla congiuntura in cui il pittoresco si
ritrova davvero al centro della speculazione estetica.
Siamo in ambito inglese, ove vengono pubblicati, in ra-
pida successione', i tre principali trattati sull' argomento: i
Th r e e E s s a ys di William Gilpin (1792-94)15, l 'An a ly t ic a l
ln q u i r y di Richard Payne Knight (1808)16 e gli E s s a ys o n
th e P ic tu r e s q u e di Uvedale Price (1794-1810)17.
Non è mia intenzione esaminarli in dettaglio. Per que-
sto rimando agli esaurienti studi specialistici 18. Tanto più
che, pur continuando a riconoscere al pittoresco un'appli-
cabilità assolutamente trasversale, gran parte delle consi-
derazioni si restringono al tema del paesaggio, quando non
a quello del giardinaggio. Mi limito a riportare, dal testo
di Price, le riflessioni sull'intima correlazione tra pittore-
sco e curiosità: L'effetto del pittoresco è la curiosità; un
effetto che, sebbene meno splendido e potente [rispetto
a l l ' a s to n is h m e n t del sublime], ha una maggior influenza
generale. Chi ha provato l'eccitazione prodotta da
quelle scene intricate di montagne romantiche e sel-
vagge, può affermare quanto la curiosità, che ci spinge
a scalare ogni promontorio roccioso, a esplorare ogni
nuovo recesso, faccia vibrare con la sua azione ogni no-
stra fibra al massimo gradol9•
Abbiamo così raccolto tutti gli elementi utili a deli-
neare una nozione di pittoresco di cui tenterò di servirmi
per l'esame di vicende ben più vicine 'a noi. Un tentativo
per nulla scontato, dato che, dopo il massimo d'attenzione
attribuitagli dal trio Gilpin, Knight e Price, il termine ha
conosciuto un lento ma progressivo declino, che lo ha
sscluso, a tutt'oggi, dal vocabolario della critica militante.
Hanno qualcosa a che vedere le avanguardie stòriche,
d' li anni Dieci del Novecento, con il pittoresco? In gran 33
parte no. Anzi, sono proprio loro le prime responsabili
della sua attuale disgrazia. Cubismo, Futurismo, Dadaismo
sono movimenti antagonisti, di rottura aspra e violenta,
troppo presi dal compito titanico di fondare su basi nuove
l'arte e l'estetica per badare al coinvolgimento del pub-
blico, tanto più se attuato facendo leva sulle astuzie del
pittoresco. In quegli anni la ricerca è chiusa a riccio su se
stessa; in posizione allo stesso tempo difensiva e aggres-
siva nei confronti di una società scandalizzata da manife-
stazioni tanto rivoluzionarie. Non a caso Filippo Tommaso
Marinetti, ideologo dei futuristi, teorizza la voluttà d'es-
ser fischiati20 e, sempre in ambito futuri sta, vige l' impe-
rativo dell'antigrazioso.Ma il picco dell' oltraggio al gusto del pubblico non è
raggiunto tanto dall'avanguardia italiana, quanto dal filone
dadaista di Marcel Duchamp, il quale scatena il maggior
sconvolgimento che mai abbia subito l'arte occidentale,
tanto che la sua stessa legittimità ne risulta seriamente
contestata: eleggendo a opera d'arte degli oggetti banali,
che né sono creati dall'artista, ma vengono trovati già fatti,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r e a d y-m a d e , né, e qui sta il 'punto, mostrano alcuna parti-
colare dote formale, Duchamp sposta la pratica artistica
dalle forme ai contenuti e la trasforma in un'operazione
concettuale. Naturalmente una tale impostazione risulta le-
tale nei confronti del pittoresco.
L'incompatibilità si spinge fino ai nostri giorni in tutti
quegli artisti e movimenti che si rifanno alla lezione du-
champiana, sviluppandola in ogni possibile implicazione.
Il periodo di massimo rilancio cade dalla metà degli anni
Sessanta e occupa una buona parte del decennio succes-
sivo, quando si diffonde una pletora di tendenze (Fluxus,
Minimal Art, Land Art, Anti-form, Arte Povera, Body
Art ... ), che ormai, in nome di una sana economia men-
tale, si tendono a consorziare sotto un'unica etichetta, la
più calzante: Arte Concettuale.Uno dei suoi esponenti più titolati, Sol LeWitt, defini-
sce concettuale l'arte in cui l'idea o concetto è l'aspetto
34 più importante del Iavoro'". Il che è come dire, rigiran-
done il senso, che è considerato di rilevanza secondaria il
modo in cui viene presentato il concetto, la forma che lo
riveste'<. In altre parole gli artisti concettuali tendono a
maneggiare i contenuti in via diretta, riducendo l'elabora-
zione formale a una funzione puramente veicolante di essi.
Ne consegue che l'involucro esteriore del lavoro deve farsi
il più neutro e trasparente possibile, altrimenti si corre il
rischio che il fruitore ne rimanga irretito, ammaliato, senza
più avvertire l'esigenza di addentrarsi nel significato.
Col che ritroviamo quella mentalità scindente la forma
dal contenuto e i sensi dalla ragione già verificata in
Milizia, con la differenza che questi era almeno fautore
del bello, mentre gli artisti concettuali si oppongono a
qualsiasi formalismo fine a se stesso. Ma, come già no-
tavo sopra, siamo sicuri che il formalismo possa essere
davvero fine a se stesso e che l'elaborazione concettuale
non si inneschi al momento stesso della percezione sensi-
bile, cui spetta quindi la massima cura?23 Non sorprenda
che proprio il concettuale, con la sua disistima verso tutto
quanto si possa comprendere sotto la nozione di pittore-
sco, abbia rappresentato uno dei momenti di maggior in-
comunicabilità tra la ricerca artistica e una società respinta
dalla facciata decisamente ostica, indigeribile di molti la-
vori, con il bel risultato che pure i concetti, verso i quali
ci si dava tanta premura, sono rimasti ignorati.
Ma la spaccatura tra arte e società risulta ancora più
beffarda, se si considera che, rispetto alle avanguardie di
inizio secolo, gli artisti concettuali ripongono l'ostilità nei
confronti del pubblico e tentano di renderlo partecipe di
una massiccia azione didattica. Come non ricordare, al
proposito, che Joseph Beuys, altro protagonista di primo
piamo di questa fase, si esibisce in vere e proprie lezioni-
performance? Ma anch'egli non bada in alcun modo a in-
t sgrare il d o c e r e con il d e le c ta r e , ad addolcire la durezza
di contenuti terribilmente nudi e crudi.
Tutto ciò si è riproposto in tempi ancor più recenti
quando, lo scorso decennio, le pratiche del concettuale
ono tornate in auge con la cosiddetta Arte Relazionale. A 35
dire il vero l'etichetta dichiara il sacrosanto proposito di
relazione, di coinvolgimento e sembrerebbe preludere alla
riscoperta dei buoni uffici garantiti dal pittoresco, ma in-
vece niente: ancora una volta la forma è considerata una
mera esteriorità e l'effetto è la solita incomprensione da
parte dei non addetti ai lavori'".
Eppure, anche se questo filone di ricerche è stato pre-
ponderante e molti insistono nel sostenere che l'arte at-
tuale sia figlia del solo Duchamp, alcune presenze altre ci
sono e non si possono più eludere.
Come non tenere conto, innanzitutto, esorbitando per
il momento dall'ambito artistico, di due eventi sociologici
interconnessi, che hanno fondato tanti aspetti della nostra
epoca, quali la spettacolarizzazione della merce e la vetri-
nizzazione della società?" La merce, una volta passata
dalla fase artigianale a quella industriale, in cui la produ-
zione eccede il fabbisogno e il consumatore è posto nella
condizione di dover scegliere tra un ventaglio di offerte
molto ampio, ha scoperto i benefici della pregnanza este-
tica e simbolica - quindi relazionale - oltre che dell' effi-
cacia funzionale. Così, dagli scaffali stracolmi di un
grande magazzino, la merce si appella a ogni qualità for-
male possa contribuire al fatidico acquisto. Ovviamente il
tempo che il potenziale acquirente dedica alla decisione èben poco, giusto una manciata di secondi, e sono quindi
necessarie tecniche di seduzione immediata: colori intensi,
un design provocante, un impatto altamente immagina-
tivo'". Come è noto, inoltre, la competizione all'ultimo ac-
quirente prosegue al di fuori del negozio, tramite la pub-
blicità.
Ebbene quella di pittoresco è una nozione che potrebbe
esprimere a meraviglia queste strategie commerciali. Ma
soprattutto mi sembra insostituibile nell'indicare le carat-
teristiche di quell'arte che vuole farle proprie.
Ecco, infatti, che una serie di artisti, nel momento in
cui, dal primo dopoguerra, i tempi concedono di uscire
dall' arroccamento, cominciano ad assimilare lo sfavillante
36 immaginario esibito dagli imballaggi, dalle affiches, dalle
vetrine allestite. Tra questi il caso più macroscopico e di
eccezionale valore è quello di Femand Léger. Strenuo fau-
tore, nei dipinti e negli scritti, della creatività legata ai
consumi di massa, egli comprende che l'arte non solo deve
presentare quelle caratteristiche di sintesi e funzionalità,
irrinunciabili se vuole essere conforme alla civiltà delle
macchine, ma deve pure apparire irresistibile come lo sono
i suoi prodotti, o meglio pittoresca, se si accetta la mia
proposta terminologica. Di qui il fascino e la comunicati-
vità immediata, che ha fatto tesoro delle esperienze matu-
rate in ambito pubblicitario, di opere capitali comeZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL e
S ip h o n (1924)27 e L e M o u vem e n t à b i l le s ( 1 9 2 6 )2 8 .
Lo stesso futurismo, reso nuovo, in quei medesimi
anni, dall'entrata di membri giovani, può riporre le armi
nei confronti della società e permettersi un atteggiamento
più disteso. Naturalmente, anche in questo caso, sono i va-
lori del pittoresco a far risplendere di grazia variopinta le
opere di Giacomo Balla,. Fortunato Depero, Gerardo
Dottorì-". E come Léger, anche i futuristi sono tutt' altro
che insensibili alla lezione della merceè".
Viene così preparato il terreno per la più capillare af-
fermazione dei valori del pittoresco merceologico di tutto
il Novecento: la Pop Art31• Una situazione ben nota, sulla
quale mi sembra superfluo soffermarmi. Mi limito a os-
servare che l'enorme successo riscosso presso il grande
pubblico da un Andy Warhol va fatto risalire anche e so-
prattutto all'abilità con cui egli ha saputo far fruttare le lu-
singhe del pittoresco a tutti i livelli, dalle opere all'iden-
tità pubblica che si è creato, integrandosi alla perfezione
con le strategie della società dello spettacolo. Di fronte a
un concettuale che, invece, da quello stesso pubblico è ri-
masto incompreso.
Veniamo quindi all'oggi, quando si può dire esplosa
un' altra stagione di arte strepitosamente attraente. Ma
prima vorrei dire di un altro evento extra artistico, ancora
di natura mercantile, più precisamente di ambito informa-
tico. Si tratta dell'avvento di Windows, il sistema opera-
tivo che nei personal computer ha rimpiazzato il DOS. È 37
una tappa importantissima nella riaffermazione del pitto-
resco e, allo stesso tempo, un'ottima replica a chi nutre
dubbi a proposito di un'elaborazione culturale che si av-
valga di mezzi spregiudicatamente spettacolari. DOS e
Windows hanno esattamente la stessa funzione - sono l' in-
terfaccia che permette di accedere ai programmi del com-
puter - ma si presentano in modo antitetico. Lo schermo
nero del DOS è un ambiente minimale e tetro, dove biso-
gna digitare comandi astrusi, da imparare a memoria.
Windows, al contrario, è immediatamente comunicativo e
si avvale di un gesto facile e naturale, quale il puntare e
cliccare con il mouse. Lo schermo è divertente e colorato,
disseminato di icone accattivanti su uno sfondo persona-
lizzato. La funzione dei due sistemi, lo ripeto, è la stessa,
ma non la funzionalità: proprio il pittoresco ha reso
Windows il prodotto vincente, tanto che del DOS non ri-
mane che il brutto ricordo.
Questa mi sembra la miglior dimostrazione del fatto
che la forma pittoresca, lungi dal frapporsi come ostacolo
ai programmi-contenuti, è, all'esatto contrario, il mezzo
più efficace per attivarli. Il pittoresco incuriosisce, attrae
il fruitore, lo spinge a scalare ogni promontorio roc-
cioso, a esplorare ogni nuovo recesso, come scriveva
Price, e questa è la migliore disposizione all'esperienza
dei contenuti.
Fatto sta che tre star dell'arte dei nostri giorni, tanto
per citare pochi casi campione, mostrano di avere inteso
a meraviglia la lezione di Windows: Jeff Koons, perfetto
continuatore della spettacolarità assunta in prima persona
da Warhol; Maurizio Cattelan, autore di lavori impegna-
tissimi e corrosivi, che non mancano mai di avviare di-
battiti sui temi più scottanti; e l'emergente Takashi
Murakami, proveniente dal Giappone, il paese più all'a-
vanguardia nello sviluppo tecnologico e d'impresa. Questi
hanno finalmente impresso la svolta pittoresca al concet-
tuale, per cui le stesse tecniche delZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr e a d y-m a d e , della fo-
tografia, del testo scritto si caricano di ogni tipo di sedu-
38 zione: da quelle squisitamente formali all'ironia, alle va-
lenze ludiche, erotiche, emotive, affabulatorie. In formula
si può parlare del passaggio dal concettuale ortodosso al
concettuale pittoresco, dal concettuale in bianco e nero al
concettuale a colori.
Koons, Cattelan e Murakami sono senza dubbio tra i
riferimenti più cari all'ultima ondata di artisti, per la quale,
non a caso, è stata avanzata l'etichetta di Generazione
MTV proprio al fine di evidenziare il loro essere intrisi
dell'immaginario sviluppato dai mass media, assorbito dai
videoclip musicali, che davvero hanno nutrito la crescita
degli attuali trentenni, ma anche da tutti quegli altri me-
dia affascinanti e sofisticatissimi che sono i fumetti, i vi-
deogiochi, i giocattoli di plastica e così via. Si sono così
formati artisti che non possono più fare a meno di ragio-
nare se non nei termini della spettacolarìtà-".
Concludo con una precisazione, che potrebbe, però,
costituire un nuovo inizio. Praticare in arte forme integrate
alle forme della merce non vuoI dire che siano integrati
anche i contenuti. Sempre, nei lavori degli artisti più gio-
vani, il pittoresco è l'arma per inoculare il virus del dub-
bio nei meccanismi di un sistema che si è scoperto essere
molto meno delizioso e innocente di quel che appare.
l Th e P ic tu r e s q u e : S tu d ie s in a P o in t o f V iew , F. Cass, London1927.
2 Th e B e a u t i fu l , th e Su b l im e , a n d th e P ic tu r e s q u e in E ig h te e n th -
C e n tu r y B r i t i s h Ae s th e t ic T h e o r y , Carbondale, 1957.3 P i t to r e s c o . M a r c o B o s c h in i , H is C r i t ic s a n d T h e i r C r i t iq u e s o f
P a in te r ly B r u s h w o r k in Se ve n te e n th a n d E ig h te e n th C e n tu r y I ta ly ,
Cambridge University Press, Cambridge 1991. .4 I l P i t to r e s c o . L ' e vo lu zio n e d e l G u s to t r a c la s s ic o e r o m a n t ic o ,
Roma-Bari, Laterza, 1996. Utili sono pure le voci «Pittoresco» sti-late da CH. HUSSEY,L. SALERNO,per l 'E n c ic lo p e d ia u n ive r s a le d e l -
" a r te , X, Sansoni, Firenze 1963, pp. 615-622 e da L. GRASSIper ilD izio n a r io d e i te r m in i a r t i s t ic i , UTET, Torino 1994, pp. 674-677.
5 R. MILANI, I l P i t to r e s c o . . . , cit., p. 3.6 Per intero il passo recita: Altri [disegni] di chiaro e scuro si
conducono su fogli tinti, che fanno un mezzo, e la penna fa il li-neamento, cioè il dintorno o profilo, e l'inchiostro poi con unIlQCO d'acqua fa una tinta dolce che lo vela et ombra; di poi con 39
un pennello sottile intinto nella biacca stemperata con la gommasi lumeggia il disegno; e questo modo è moltoZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa l la p i t to r e s c a e.mostra più l'ordine del colorito. G. VASARI,L e vi te d e i p iù e c c e l -
le n t i p i t to r i , s c u l to r i e a r c h i te t t i , Newton Compton, Roma 1991, p.76.
7 Si veda l'edizione critica curata da A. Pallucchini, Istituto perla Collaborazione Culturale, Venezia-Roma 1966.
8 In questa specifica accezione oggi, sulla scorta degli studi diHeinrich Wolfflin, a pittoresco si preferisce il termine p i t to r ic o .
9 Al proposito Sohm, invocando due categorie proprie della re-torica, accosta il pittoresco (il c o lo r i to ) a l l ' e lo c u t io e il disegno al-l ' in ve n t io . Cfr. PH. SOHM, o p . c i to
IO Un testo sull'argomento che si è recentemente imposto all'at-tenzione è F. J. VARELA,E. THOMPSON,E. Rosea, T h e E m b o d ie d
M in d (1991), trad. it: L a via d i m e zzo d e l la c o n o s c e n za , Feltrinelli,Milano 1992.
11 M. BOSCHINI,o p . c i t . , p. 6. Cfr. PH. SOHM, o p . c i t . , pp. 115-
130.12 SALVATORROSA, O d i e le t te r e , lettera IX, 1662.13 F. MILIZIA, D izio n a r io d e l le B e l le A r t i d e l D is e g n o , Bassano
1797.14 Binomio cui si dovrebbe aggiungere una terza categoria,
quella del s u b l im e , che deriva dall'estremizzazione delle qualità delpittoresco, in modo che lo straordinario si tramuta in orrore e la cu-riosità in sbigottimento.
15 T h r e e E s s a ys : O n P ic tu r e s q u e B e a u ty ; O n P ic tu r e s q u e T r a ve l ;
a n d o n S ke tc h in g L a n d s c a p e .
. 16 A n A n a ly t ic a l ln q u i r y in to th e P r in c ip le s o f T a s te .
17 E s s a ys o n th e P ic tu r e s q u e , a s C o m p a r e d w i th th e S u b l im e a n d
th e B e a u t i fu l ; a n d o n th e U s e o f S tu d y in g P ic tu r e s , fo r th e P u r p o s e
o f lm p r o v in g R e a l L a n d s c a p e .
18 Cfr. CH. HUSSEY,o p . c i t . ; W.I. HIPPLE, o p . c i t . ; R. MILANI,
o p . c i to
19 U. PRICE, E s s a ys o n th e P ic tu r e s q u e . . . , voI. I, J. Mawman,
London 1810, pp. 88-89, trad. mia.20 Cfr. il manifesto omonimo (1911), ora raccolto in F. T.
MARINETTI,T e o r ia e in ve n zio n e fu tu r is ta , a cura di L. De Maria,Mondadori, Milano pp. 310-313.
21 S. LEWITT, P a r a g r a p h s o n c o n c e p tu a l a r t , in «Artforum»,giugno 1967, trad. mia.
22 Ecco altre inequivocabili affermazioni di LeWitt: l'esecuzioneè una faccenda meccanica; l'aspetto dell'opera d'arte non ètroppo importante; l'arte che è intesa in via primaria per la sen-sazione che dà all'occhio dovrebbe essere chiamata percettivapiuttosto che concettuale (ivi).
23 Ricordo il mc1uhaniano il medìum è il messaggio, uno degli
slogan più felici e azzeccati dell'epoca in cui viviamo.24 Questa si-uazioue 1".3 avuto una lucida formulazione program-
40 matica in occasione del convegno C o m e s p ie g a r e a m ia m a d r e c h e
c iò c h e fa c c io s e r ve a q u a lc o s a ? , tenutosi a Bologna nel 1997, dicui si possono leggere gli atti nel volume omonimo, a cura di S .FALCI,E. MARISALDI,G. NORESE,C. PlETROIUSTI,A. RADOVAN,C.VIEL, L. VITONE, Zerynthia - Charta, Roma-Milano 1998. Vi silegge, nell'intervento di Federico Tanzi-Mira per esempio, la presadi posizione contro un feticismo da sculture neopop, brick e braksimul-concettuali, effimere volontà estetiche, pittoricistiche(p. 27).
25 Una buona panoramica su queste tematiche è data da V.CODELUPPI,L o s p e t ta c o lo d e l la m e r c e , Bompiani, Milano 2000.Molto utile anche F. CARMAGNOLA,M. FERRARESI,M e r c i d i c u l to .
lp e r m e r c e e s o c ie tà m e d ia le , Castel vecchi, Roma 1999.26 Su questi temi cfr. M. FERRARESI,I l p a c ka g in g . O g g e t to e c o -
m u n ic a zio n e , Franco Angeli, Milano 1999.27 Collezione Rafael Tuleda Reverter.28 Kunstmuseum, Basilea.29 Sul secondo futurismo cfr. G. BARTORELLI,N u m e r i in n a m o -
r a t i . S in te s i e d in a m ic h e d e l s e c o n d o fu tu r is m o , Testo & Immagine,Torino 200 l.
30 Cfr. F. DEPERO,I l fu tu r is m o e l ' a r te p u b b l ic i ta r ia , in N u m e r o
u n ic o fu tu r is ta C a m p a r i (Milano 1931), ora ripubblicato in E.CRISPOLTI,M. SCUDIERO,B a l la D e p e r o r ic o s t r u zio n e fu tu r is ta d e l -
l ' u n ive r s o , Edizioni Galleria Fonte d'Abisso, Modena 1989, pp. 148-153.
31 Una delle sue più autorevoli voci critiche, Lucy R. Lippard,ha giustamente segnalato nell'introduzione al volume P o p a r t (1966;
trad. it. Rusconi, Milano 1989, pp. 9-24), che le radici del movi-mento vanno individuate nell'opera di Duchamp unitamente a quelladi Léger.
32 Ne ricorderò qualcuno, tra gli italiani più conosciuti: MatteoBasilé, Marina Bolmini, Botto & Bruno, Pier Luigi Calignano,Stefano Calligaro, Loris Cecchini, Giacomo Costa, AlessandroGianvenuti, Fausto Gilberti, Cristiano Pintaldi, Alex Pinna, MarcoSamorè ... Sulla Generazione MTV cfr. G. BARTORELLI,F. FABBRI(a cura di), A r tB e a t . A n e n a r r a t iva v id e o c l ip , cat., Mazzotta, Milano1999 e G. BARTORELLl,F. FABBRI,E. NOBILE MINO (a cura di),
A r tB e a t2 . A n e n a r r a t iva v id e o c l ip , cat., Castel vecchi , Roma 2000.
41




















![Die ›Bewëgung der Sprache‹. Überlegungen zum Primat der Bewegung bei Heidegger und Hölderlin [full text]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6315f0ad5cba183dbf083a2f/die-bewegung-der-sprache-ueberlegungen-zum-primat-der-bewegung-bei-heidegger.jpg)
![هدم المزارات الإسلامية في البلدان العربية (The Destruction of Islamic Shrines in Arab Countries) [Arabic / full text]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6321ef7a807dc363600a3467/-the-1677351851.jpg)

![Fedinec Csilla: Fejezetek a kárpátaljai magyar közoktatás történetéből (1938-1991). Budapest, 1999. [full text]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63163c033ed465f0570bf151/fedinec-csilla-fejezetek-a-karpataljai-magyar-koezoktatas-toertenetebol-1938-1991.jpg)