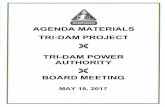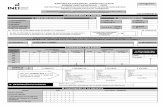Argonauti rivisto 11
-
Upload
britishmuseum -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Argonauti rivisto 11
Un processo circolare1
Scissione, dissociazioni e configurazioni del processo analitico.
Giuseppe Riefolo
“Sono interessato alla molteplicità come fenomeno che avviene nella stanza di analisi” (Bromberg,
2006)
Proposta. In questa nota mi occuperò soprattutto degli aspetti non patologici dei processi di scissione (Spaltung) e di dissociazione(Dissoziation), riconoscendo, nel processo di una singolaseduta analitica, alla scissione la funzione positiva di creare continuamente sospensioni nella struttura del Sé e alla dissociazione una riorganizzazione continua della scissione. Chiamerò “configurazioni” queste riorganizzazioni continue della scissione che corrispondono, quindi a micro-esiti dissociativi della scissione. La mia proposta è che la scissione sia un processo alla base di ogni trasformazione, mentre rimozione, spostamento, conversione, evitamento, negazione ecc.., sono delle modalità di dissociazione, possibili esiti della scissione, finalizzati non soloa operazioni di difesa, ma anche all’esperienza di acquisizione nel Sé di parti non ancora esperite e sempre più complesse dell’oggetto. I vari tipi di configurazioni – ovvero: le continue soluzioni dissociative della scissione - sono tutte continuamentepresenti nella struttura del Sé2 e nel corso di una stessa seduta analitica.
Configurazioni.
Propongo di leggere i fenomeni della relazione analitica come incontro fra i Sé multipli del paziente e dell’analista, cercando di rappresentare l’incontro analitico come una complessa e oscillante interazione fra configurazioni elementari del paziente che
1Pubblicato in: Gli Argonauti, quaderni, 22, 2011, 45-64. 2 Per alcuni neurobiologi, il Sé è «una collezione di configurazioni neurali noncoscienti” (Damasio, 1994, 166) e “lo stato del Sé viene costruito da cima a fondo in ogni momento, è uno stato […] di continuo ricostruito con tale coerenzache il possessore non se ne accorge mai…» (id., 326).
1
cercano e trovano risonanza complementare nelle configurazioni elementari che il Sé dell’analista riesce a mettere a disposizionedel processo analitico. Si tratta di prendere in considerazione quelle «microtrasformazioni reversibili ed instabili dell’hic et nunc che, reiterate, portano a macrotrasformazioni stabili ed irreversibili che ristrutturano il mondo interno» (Ferro, 2006, 440), ovvero, «… i microprocessi e i modelli di interazione che iocredo costituiscano nel tempo il cambiamento psicoanalitico» (Mitchell, 1993, 147). Nella linea di Bion, ciò che definisco configurazioni sono stati mentali sostanzialmente instabili a cui l’analista partecipa: «… il problema pratico è: non altre indaginidella psicoanalisi, ma della psiche che essa rivela. Questa richiede di essere indagata per mezzo di pattern mentali» (Bion, 1975, 112). Per quanto il concetto di “Sé multipli”, nella teorizzazione psicoanalitica, abbia una connotazione sostanzialmente intersoggettiva (Bromberg, 1998-2001; 2006; Batemann e Fonagy, 2004; Stern 2004), personalmente mi trovo ad utilizzare anche altri modelli teorici nella rappresentazione dell’incontro analitico come messa in scena di Sé multipli del paziente e dell’analista. Pertanto, per il concetto di “configurazioni elementari” faccio riferimento ai “mutevoli e molteplici stati del Sé” di Mitchell (1993), al concetto di “Now Moment” di Stern (2004) e anche alla pluralità degli stati del Sé a cui fanno riferimento analisti di orientamento bioniano quali Bollas, Ogden e Ferro.
Considero le configurazioni come unità sostenute da una coerenza eda una finalizzazione interna che l’analista, consapevolmente, ma soprattutto implicitamente, individua nella propria risonanza mentale col paziente. Per quanto si possano individuare dimensioniestremamente elementari e precise delle configurazioni3, propongo che, sul piano clinico, ciascun analista possa individuare, di volta in volta, una propria dimensione secondo cui leggere una configurazione ogni qual volta sente di aver definito un registro organizzatore di fondo che permette di leggere alcuni brani degli accadimenti della seduta. L’analista è chiamato a seguire le continue oscillazioni impresse dal paziente alla seduta analitica e, di volta in volta, a modulare la propria presenza secondo un registro edipico o secondo un registro di contenimento/holding.Ciò che chiamo “configurazioni” vuole essere un parametro metodologico, contingente, di dimensioni sostanzialmente
3 Nella linea di Stern (2004) una configurazione potrebbe avere le dimensioni di3-6 secondi.
2
soggettive, utile per cogliere frammenti di complessità rispettandone il più possibile la insondabilità e la dinamicità. La configurazione è una unità, funzionale alle capacità di un soggetto – in questo caso un analista – di sapersi confrontare conuna materia estremamente complessa da cui sarebbe sopraffatto se non si attrezzasse con dispositivi e metodi utili: «… la massa di materiale è ora così abbondante che si dubita che un qualsiasi psicoanalista possa ‘interpretare’ il pattern con l’efficienza di un computer. Sicché quello che ora si richiede è un procedimento ouno strumento che possa rivelare le configurazioni» (Bion, 1975, 99). L’approccio alle plurime configurazioni è soprattutto una posizione che ci permette di seguire contemporaneamente più livelli di risonanza col paziente il quale ci si presenterà capacedi affettività, responsivo alla nostra posizione di ascolto e contenimento nei suoi confronti, o capace di conflittualità più dell’ordine edipico o dell’ordine border: «questa forma di partecipazione psicoanalitica […] è un’abilità estremamente sofisticata, e presuppone che la mente dell’analista, come quella del paziente, sia caratterizzata da stati del Sé e organizzazioni del Sé discontinui e mobili, che la mente venga generata in campi interpersonali di influenza reciproca, che l’autoriflessione sia di per sé, sempre e necessariamente, prospettica ed estremamente selettiva. E’ necessario molto tempo per imparare a vivere e a usare se stessi in questo modo, e comporta ascoltare e seguire livelli diversi di significato nello stesso tempo» (Mitchell, 1993, 171).Un esempio molto “classico” e comune può essere lo stato mentale del paziente rispetto al pagamento dell’onorario a fine mese. In una configurazione nevrotica il paziente può rimuovere il dato chepossa trattarsi dell’ultima seduta del mese e può dimenticare l’onorario. Nella configurazione border il paziente potrà attaccare attivamente l’analista sentito violento e avido; in una configurazione schizofrenica il paziente potrebbe proporre diniego, angosce di frammentazione, grave depressione psicotica e immagini persecutorie nel riconoscere la distanza dall’analista. Tutte queste configurazioni sono sempre copresenti, poiché segnalano il corredo di esperienza organizzate strutturalmente nelSé. In sostanza, nel loro insieme, descrivono la struttura, la solidità e la caratteristica del Sé. La prevalenza di un tono su un altro determina la presentazione della configurazione prevalente (prevarrà il lapsus nevrotico, o la rabbia border o l’angoscia psicotica), ma, indipendentemente dalla configurazione prevalente, l’analista sarà attento a sintonizzarsi anche con le
3
altre configurazioni che, per quanto coperte e contenute, sono attive nel Sé. In questo senso la sorpresa (Riefolo. 2010) che l’analista in alcune fasi prova a seguito di alcune sue interpretazioni è da riferirsi all’emergere di configurazioni soggiacenti che l’analista non riusciva a cogliere. Propongo una breve vignetta clinica in cui l’analista in un primo momento, ha difficoltà a sintonizzarsi verso una configurazione prevalente psicotica del paziente, assumendo inutilmente un registro dell’ordine edipico e suggerendo al paziente un’interpretazione che fa riferimento alla negazione dell’angosciadi separazione. Solo in un secondo momento, e su sollecitazione del paziente, l’analista riesce a sintonizzarsi con la configurazione psicotica, presentandosi in una posizione fortemente empatica, accogliente e coesiva del Sé del paziente.
Guglielmo: configurazioni psicotiche e trasformazioni
P. «Mi è capitata una cosa incredibile dottore! ho bisogno di parlargliene…» . Guglielmo ha 26 anni; al terzo anno di analisi; midice che ha scoperto su un sito erotico una foto di una ragazza il cui fondoschiena, per la biancheria intima e i vestiti, gli sembra proprio quello di Marcella, la ragazza da cui si sta separando e che la scorsa settimana gli aveva scritto a lettere maiuscole sul cellulare “PAZZO!”, cosa che «per tutta la mia storia, leinon avrebbe mai dovuto dirmi!». Mi spiega che ha fatto ricerche sul tipo di macchina che, dai mille minuziosi particolari, potrebbeessere del tipo di quella di Marcella. Mi chiede io che cosa ne penso. A. Gli dico che mi chiedo come mai lui stia facendo una fatica enorme per smentire ciò che gli sta accadendo, ovvero che si sta separando da Marcella! P. Mi interrompe prontamente con irritazione: «No, dottore! Per una volta le chiedo di dirmi concretamente lei che cosa ne pensa: io non vedevo l’ora di incontrarla perché voglio sapere lei che cosa ne pensa!». A. Mi sento molto colpito dalla sua richiesta diretta ed esplicita. Sento che nella sua frammentazione mi delega la funzionedi coesione di fondo. Recupero brani importanti della sua storia e gli dico in modo più diretto: «penso che il suo sia un delirio4 in
4 A questo livello di configurazioni psicotiche chiamare “delirio” il delirio del paziente ha la funzione di presentare «…un analista che accetta la responsabilità di pensare e riformulare un giudizio clinico, responsabilità che
4
cui sta cercando disperatamente di negare che sua madre, quando arriva suo padre e lei ha 5 anni, andrà ad accoppiarsi con lui e ogni mese la lascerà da solo per due giorni dai nonni, o sta cercando disperatamente di negare che suo nonno muore e la lascia solo e lei non può farci nulla!…». P. Mi risponde con tono più sereno: «ma a me non creava nessun
problema vedere che mia madre stava via con mio padre!…».
[Rilevo fra me come abbia accettato di lasciare il tema della foto per occuparsi del mio discorso. Le angosce di separazione dovute al transfertvengono riportate nel setting e si possono affrontare ricomponendo la dissociazione psicotica verso la madre/Marcella /analista. La sua risposta, peraltro, documenta il viraggio da una configurazione deliranteverso una configurazione di negazione dell’ordine edipico ora prevalente]. Gli posso, quindi, rispondere che un bambino di 5 anni forse vede il mondo diversamente, forse lo vede esattamente con le paure che lui ha in questi giorni verso Marcella…: ha bisogno di me per capire cosa gli succede, ma dopo ogni seduta anch’io lo lascio e non sono più disponibile per lui…
Durante una seduta incontriamo continuamente configurazioni elementarie, indipendentemente dalle caratteristiche diagnostiche del paziente, queste configurazioni rinviano, nel loro piccolo, a modalità di organizzazione psicotica, nevrotica o border. Siamo colti da vive sensazioni di sorpresa quando il registro organizzatore della configurazione si modifica utilizzando elementi del campo analitico. Pertanto, quando parliamo di pazienti psicotici, nevrotici, border, ecc. ci riferiamo in modo descrittivo alle configurazioni prevalenti (che non escludono la presenza di configurazioni di altro tipo…) all’interno di un quadro clinico, ma siamo chiamati a riconoscere che nella clinica psicoanalitica incontriamo continuamente e simultaneamente configurazioni le quali sono il nostro principale ambito di intervento, quanto le “figure” o i “quadri” clinici sono il campo di interesse della psichiatria. Indipendentemente dalla diagnosi di base del paziente, configurazione psicotica può essere, ad esempio, il fastidio che un paziente può sentire per un quadro appeso alla parete della stanza d’analisi o lo sguardo sospettoso di un passante mentre si accingeva ad entrare in seduta o il fraintendimento ostile di una interpretazione dell’analista o una caratteristica del setting, ecc... Configurazioni nevrotiche possono essere le dimenticanze, i ritardi, i lapsus, le
è parte integrante del suo lavoro con un paziente che lotta contro l’angoscia dilivello psicotico e il senso di incombente disintegrazione» (Ogden, 2001, 98).
5
somatizzazioni in seduta, ecc... Le configurazioni border si organizzano attraverso l’attacco ad elementi personali dell’analista o del setting quali le regole o la stessa stanza dell’analisi. Nel primo caso il transfert non si avvale del registro simbolico, ma si organizza su semplici equivalenze in cui lapresenza, l’assenza o il potere dell’analista – in quanto categoria, prima che persona - viene automaticamente registrata dal paziente secondo esperienze angoscianti di separazione e morte. Nel secondo caso il transfert si organizza secondo il registro che introduce (permette) la relazione conflittuale edipica tra paziente ed analista. Nelle configurazioni border l’analista e il setting vengono attaccati come oggetto di dipendenza e minaccia alla coesione del Sé. Nella configurazione nevrotica il paziente può sentire l’altro come motivo della propria depressione, mentre nella configurazione psicotica l’altronon esiste come oggetto di conflitto, ma come oggetto onnipotente la cui semplice esistenza è motivo di vita o di morte. La configurazione psicotica si struttura sul potere dell’oggetto, mentre le configurazioni nevrotiche si organizzano sul potere del soggetto; quelle border sul potere del soggetto come possessore dell’oggetto. Il lavoro dell’analisi, attraverso il transfert e l’analista in funzione, si compie come continuo tentativo di trasformazione e ricomposizione di configurazioni patologiche verso configurazioni più funzionali e complesse.Propongo, quindi, un’altra vignetta esemplificativa della composizione di configurazioni dissociate verso configurazioni piùevolute. In questo caso, a differenza dell’esempio precedente, le angosce che sostengono la dissociazione sono di ordine prevalentemente edipico. Giorgio:configurazioni nevrotiche e trasformazioni
P. Giorgio ha da poco iniziato l’analisi. La moglie e la nuova compagna lo sollecitano a decisioni urgenti rispetto a come organizzare la propria vita affettiva e familiare; lui non sa cosa decidere. Oggi ha incontrato un collega a cui ha comunicato dell’inizio dell’analisi e questi gli ha detto: «Beato te! È il piùbel regalo che puoi farti in questo periodo!». Poi ha sentito un caro amico ed ha scoperto che lui ha fatto analisi per un periodo in cui ha avuto alcune difficoltà. L’amico gli ha detto che l’analisi lo ha aiutato molto e lui ha pensato che, forse per questo, negli ultimi tempi quell’amico è molto più sereno e sta visibilmente meglio.
6
A. Gli faccio notare semplicemente che da un lato ci sono le donne che, passivamente, attendono le sue decisioni, e dall’altra ci sono delle figure maschili che lo aiutano a decidere rispetto all’analisi e, oggi, l’accompagnano in seduta. P. «Non ci avevo pensato… è vero! Infatti tante volte penso di avere due personalità… alcune volte di averne più di due…!». A. Gli chiedo come mai sente la mia sottolineatura dei suoi due
aspetti come l’essere doppio:forse i due aspetti non sono, come lui sente, nettamente separati fra loro, ma complementari: per decidere cosa fare con le donne forse bisogna farsi aiutare anche dagli altri uomini… P. Rimane in un lungo silenzio. Riprende: «normalmente trovo difficile il silenzio… so stare zitto, ma è difficile tollerare il silenzio come è successo adesso in seduta! (Silenzio) Stavo pensando che non avevo mai visto questi due aspetti nella prospettiva in cui li sta suggerendo lei, ovvero che sono in relazione fra loro e che l’atto della decisione per me assume una valenza - come lei dottore mi suggerisce – virile».
Ribadisco che sto cercando di occuparmi di configurazioni elementari, ovvero «… qualcosa nell’universo del piccolissimo…» (Bion, 1975, 190), e che riconosco come il campo della seduta analitica sia popolato da infinite configurazioni «… del nostro funzionamento mentale che determinano macrotrasformazioni del campo» (Ferro, 2006, 454). Gli esempi che ho riportato e che riporterò in seguito, sono già configurazioni complesse che, però,l’analista individua implicitamente come unità con una propria coerenza intrinseca dovuta al registro edipico o psicotico che permettono alla coppia analitica di occuparsi degli affetti prevalenti attivati, di volta in volta, dalla situazione analitica: «…il cambiamento… è un processo, non uno stato, il prolungamento e lo sviluppo dei costanti mutamenti, minuto per minuto, nella seduta» (Joseph, cit. in Bromberg, 1999-2001, 212).
…oltre Freud e Janet.
Come giustamente riconosce Fairbairn, Freud lascia i concetti di Spaltung e Dissoziation alla clinica psichiatrica, mentre è particolarmente interessato al processo dinamico della rimozione: «La dissociazione descritta da Janet è essenzialmente un processo passivo, un processo di disintegrazione dovuto a un fallimento della funzione coesiva normalmente esercitata dall’Io. Il concetto
7
di “dissociazione” si pone quindi in netto contrasto con quello di“rimozione” formulato più tardi da Freud nel tentativo di offrire una spiegazione più adeguata dei fenomeni isterici» (Fairbairn, 1954, 42). Per Freud, quindi, la psicosi non si fonda su un meccanismo di Spaltung o di dissociazione ma - soprattutto negli ultimi scritti - appare dovuta ad una precoce incapacità dell’Io ad investire libidicamente la realtà esterna. Peraltro, è nota la perplessità di Freud e il disaccordo con Bleuler sull’adozione deltermine Schizofrenia (Freud, 1915-17, 424; 1910, 75). Per Freud, infine, la scissione avviene secondo linee di fragilità5 nell’Io-oggetto (Freud, 1932, 58) e l’Io è già una istanza duplice nel senso in cui sarà poi definito dalla psicologia dell’Io (Ich e Selbst)6.
La tesi che sto cercando di introdurre è che nel processo analitico e all’interno di ogni seduta, sia importante seguire e curare la continua azione del dispositivo di scissione che scompone e, attraverso la dissociazione, ricompone configurazioni semplici verso configurazioni sempre più complesse cogliendo i contributi del paziente e dell’analista. Mentre la dissociazione difensiva ricompone lo stato di scissione rimuovendo attivamente (Freud) nessi di significato fra configurazioni di esperienza, attraverso la dissociazione creativa le configurazioni dell’esperienza, senza alcuna operazione attiva, «… si raggruppano per formare un nuovo insieme, che può allora costituire un vissuto differente» (Thoret et al., 1999, 753)7. Perché paziente ed analista possano contribuire al processo analitico, debbono continuamente essere esposti al dispositivo della scissione delle proprie configurazioni mentali stabili, messe poi a disposizione del dispositivo di dissociazioni creative. Come cercherò di precisare nel prossimo paragrafo, i processi della seduta analitica si muovono continuamente nella ricomposizione dello stato di scissione sia verso soluzioni dissociative difensive che creative,in una continua tensione e modulazione di equilibrio. Usando
5 «Se gettiamo per terra un cristallo, questo si frantuma, ma non in modo arbitrario; si spacca (zerfällt) secondo le sue linee di sfaldatura (Spaltrichtungen) in pezzi i cui contorni, benché invisibili, erano tuttavia determinati in precedenza dalla struttura del cristallo» (Freud, 1932, 59).6 Per una più approfondita analisi di questi passaggi rinvio a Ferro, Riefolo, 2006, p. 102 e segg.7 Il riferimento è soprattutto alla seconda delle quattro fasi che Janet (1893-94) proponeva per il quadro della dissociazione: désagrégation, recomposition réversible, enfouissement e la dissociation da parte del medico dei nessi patologici delle rappresentazioni durante l’ipnosi.
8
un’immagine della chimica, lo stato di scissione poterebbe essere rappresentato come lo stato di passaggio verso nuove soluzioni stabili di riaggregazione di elementi. Ritengo sia limitante rappresentare la dissociazione come semplice riduzione o impoverimento dell’esperienza, mentre come analisti siamo interessati alla costruzione di nuove configurazioni più complessee funzionali dell’esperienza. In questo, gli ultimi sviluppi dellateoria psicoanalitica, soprattutto a seguito delle tesi kleiniane,ci sostiene riconoscendo alla scissione una sostanziale funzione di mobilizzazione delle configurazioni del Sé. Infatti, Bromberg (1994, 521), pur non differenziandola dalla Spaltung, propone la dissociation come elemento positivo: «la dissociazione è un processo di base nel funzionamento mentale umano ed è centrale nella stabilità e nella crescita della personalità». Green, seppure in una cornice teorica differente da quelle che sto considerando, è ancora più esplicito: «la scissione, instaurando un limite, permette la comunicazione partendo dagli affetti e dai processi dipensiero, verbalmente comunicabili [...]. D’altronde, una delle funzioni fondamentali dell’apparato psichico è quella di tendere verso la separazione, al fine di permettere l’individuazione…» (Green, 1990, 106-8). In questa linea è anche Bion quando definisce i due tipi di splitting: «la scelta comporta ciò che taluni di noi chiamano splitting [… ]. La personalità umana esiste come un tutto; noi dobbiamo dividerla per formulare diverse possibili idee o interpretazioni. Questo è ciò che io chiamo splitting “non” patologico» (Bion, 1974, 87). Grotstein, infine, propone una interessante articolazione del processo di scissione che può aiutarci a distinguere fra quanto può essere definito strutturale e quanto può essere definito dinamico delineando due modalità differenti di scissione. Vi sarebbe una “esperienza di scissione”: «esperienza fondamentale della nascita fisica che si ripete costantemente nello sforzo di annullarla o negarla» (Grotstein, 1981, 87), ed una “scissione dell’esperienza”. Secondola tesi che tento di sostenere, la prima equivarrebbe allo stato di scissione in cui il soggetto è costretto a transitare a seguito dellaviolenza che subisce dall’incontro con un oggetto (cfr. anche Damasio, 1994), mentre la “scissione dell’esperienza” corrisponderebbe al processo difensivo o creativo della dissociazione propriamente detta.
Dissociazioni creative e difensive
9
Propongo che la dissociazione sia soprattutto e prima di tutto sulpiano evolutivo un dispositivo che lavora continuamente alla riorganizzazione del Sé e al mantenimento del senso di continuità del Sé (Bromberg, 2006). Un esempio elementare: se siamo chiamati a ricordare una sequenza di numeri, automaticamente dissociamo creativamente la sequenza unitaria in tante piccole sequenze e questa è la soluzione per poter ricordare più numeri possibile. Parallelamente il dispositivo della dissociazione è anche utile sul piano difensivo: c’è un continuo equilibrio dinamico fra dissociazione creativa e difensiva e tale equilibrio dinamico è fondamentale per la funzione egoica della coesione del Sé. L’uso difensivo della dissociazione organizza la psicopatologia mettendola dissociazione al servizio dell’evitamento di esperienze conflittuali: «Il trauma …produce dissociazione che, a sua volta, crea falsificazioni retroattive del passato e della capacità di pensare il futuro» (Bromberg, 2006, 10). Sul piano delle posizioni teoriche, per quanto concerne la dissociazione creativa mi muovo nella linea del recupero delle tesi di Janet sul dispositivo delladissociazione, (Havens, 1973; Thoret, e coll., 1999; Hulak, 2000; Carroy, Plas, 2000; Ferro, Riefolo, 2006) che introduce all’ipotesi dell’esistenza di stati del Sé paralleli e multipli (Bromberg, 1998, 2006), fra loro non in comunicazione, ma tutti effettivi ed attivi, con una propria logica e con elementi strutturanti interni, prima che considerare il Sé come entità unica ed affetto da elementi patologici interni da sanare. Faccio riferimento inoltre ai “differenti stati della mente e le differenti costellazioni psichiche” (Bollas,1999, 74), o alla “pluralità degli stati psichici” (Ogden, 2001), infine alle teorizzazioni di funzione mentale come movimento fra plurimi statidel Sé proposte in varie note da Nino Ferro (2002; 2007) e Anna Ferruta. (2010).
Considero il dispositivo della dissociazione come un dispositivo di base della funzione mentale la quale può permettere – sia attraverso la dissociazione creativa che patologica – il mantenimento della continuità del Sé: “gli stati del Sé è ciò di cui è fatta la mente; la dissociazione è ciò che la mente fa. La relazione fra stati del Sé e dissociazione è ciò che la mente è” (Bromberg, 2006,2; corsivo mio). Per quanto anche Freud (1907) in alcuni passi ipotizzi l’esistenza non solo patologica, ma anche creativa, di “Io parziali”8, vi è una strutturale differenza fra il concetto di 8 Freud (1907, 150), citava la «…capacità dello scrittore di scindere il proprio Io in Io parziali» e nelle Lezioni del ’32 (p. 171) del dialogo tra Io
10
dissociazione di Janet e Breuer rispetto a Freud. Sostanzialmente Janet propone la simultaneità di “personalità multiple”, mentre tutta la teoria freudiana, a partire dalla prima topica. si fonda sulla gerarchia di livelli di coscienza in cui la simultaneità è governata e coordinata dal dispositivo della rimozione9. Per Janet la simultaneità è invece determinata dal livello di integrazione psicologica del soggetto più o meno esposta a faiblesse o perdita della “fonction du reél”. La differenza sostanziale è l’individuazioneda parte di Freud di un dispositivo attivo, “sua maestà l’Io” capace di governare la funzione attiva, della rimozione: «fu per spiegare la resistenza che Freud postulò il processo di rimozione;e poiché la resistenza è un processo attivo, anche la rimozione venne concepita da Freud come un processo intrinsecamente attivo. Soprattutto per questa ragione il concetto di rimozione ha soppiantato quello di dissociazione» (Fairbairn, 1954, 42). Al tempo stesso, la coesistenza di stati multipli di personalità in Janet è giustificabile attraverso un processo passivo di emergenzadi livelli paralleli della personalità non appena condizioni interne o esterne al soggetto ne permettono l’emergenza. I vari livelli di espressione della vita psichica in Freud sono governatidal conflitto, mentre in Janet da ciò che potremmo definire la coesione del Sé. In sostanza suggerisco una integrazione della posizione psicoanalitica classica che vede una funzione egoica capace di funzionamento dissociativo attivo con le posizioni suggerite inizialmente da Janet in cui il soggetto è caratterizzato dalla coesistenza di personalità che a seguito di condizioni esterne ed interne possono essere sentite dal soggetto come nuove e mai sperimentate prima (Cremonese, 2010, 173; Di Benedetto, 2010, 238). Nella linea di Janet possiamo considerare la scissione come difesa primaria e al tempo stesso come premessa necessaria alle riorganizzazioni dissociative sia difensive che creative. La scissione è rintracciabile in ciò che soprattutto Breuer, ma anche – più timidamente - il primo Freud degli Studi (1895) descrivevano come “stati ipnoidi” che, non a caso erano la premessa per la “scissione della psiche” distinta dalla “scissione
soggetto e Io oggetto. Glover (1932) concepisce l’Io primitivo come polinucleare, nel senso di una serie di organizzazioni indipendenti. Gli stessi concetti di Glover vengono poi ripresi dopo alcuni anni da Abse, (1955).9 C. Botella (2010) recentemente ha sottolineato come la tecnica analitica in Freud, definita in relazione alla prima topica, rimane immutata nonostante il grande ampliamento che la seconda topica sollecitava: «Freud non ha pensato a unampliamento del suo metodo… Freud possedeva l’anima dell’interprete. Lui stesso amava utilizzare l’espressione “l’analisi è l’arte dell’interpretazione”» (p.3).
11
della coscienza”10. Il concetto di “stati ipnoidi” di Breuer ritengo corrisponda allo stato di “faiblesse constitutionnelle” di Janet su cui vengono ad innestarsi gli stati di Personalità Multiple, mentre Freud userà piuttosto il concetto di “scissione della psiche”, differenziato dalla “scissione della coscienza” per descrivere un profondo disturbo dell’Io. Infatti, Freud sembra riferire la scissione della coscienza all’isteria e la “scissione psichica” soprattutto alla paranoia e al feticismo: «Possiamo supporre […] che in tutti i casi simili a questo [feticismo] si attui una scissione psichica. Si sono formate due impostazioni psichiche, anziché una sola; una, quella normale che tiene conto della realtà, e l’altra, che sotto l’influsso pulsionale, stacca l’Io dalla realtà. Sussistono ambedue una accanto all’altra. L’esito dipende dalla loro forza relativa. Se l’ultima è o diventapiù forte della prima, la condizione della psicosi è data» (Freud,1938, 202).
Ciò che tento di suggerire è nella tesi che assumo soprattutto da Bromberg del dispositivo della dissociazione come fisiologico e strutturante la funzione mentale. Propongo il continuo intersecarsi di esiti patologici (difensivi) e creativi della funzione dissociativa. La dissociazione patologica è finalizzata all’evitamento di esperienze conflittuali e, quindi, si organizza nella sospensione dei processi creativi attraverso la coazione a ripetere (Freud, 1922), mentre la dissociazione creativa sostienel’evoluzione dei processi e permette al soggetto di abitare esperienze nuove e sempre più complesse, permettendo, attraverso la dissociazione, nuove rappresentazioni dell’oggetto. La dissociazione creativa è la possibilità di vivere nuovi stati del Sé e sperimentare l’esistenza di nuovi oggetti, quando le condizioni lo permettono. Bromberg (2006) considera la dissociazione creativa come configurazioni del Sé potenziali, conosciute e persino sperimentate attraverso l’imitazione, la specularità e l’identificazione. Diviene “patologica” quando il soggetto sente di non poter avere accesso a soluzioni di configurazioni del Sé possibili e «…la mente estende adattativamente la sua portata oltreil momento contingente, trasformando il futuro in una variante delpericolo passato» (p. 5). I dispositivi creativi della dissociazione sono per definizione, il sogno, le libere
10 La prima era alla base degli stati di “psicosi isterica” o “isteria acuta”, mentre la seconda caratterizzerà sempre più l’isteria come nevrosi (Ferro, Riefolo, 2006). Per Freud la “scissione psichica” è comunque una forma di dissociazione che, semplicemente è a carico del funzionamento di base dell’Io.
12
associazioni e le potenzialità iconiche della mente11. Queste capacità dissociative creative che nel processo analitico sono distintive del paziente, sul versante dell’analista corrispondono alla rêverie, all’attenzione liberamente fluttuante e alle capacità iconiche della mente dell’analista. Propongo tre esempi molto comuni in cui provo a suggerire fasi di dissociazione creativa, nel primo caso organizzate sull’oggetto, e nel secondo e terzo caso nella possibilità del Sé di occupare una dimensione che la dissociazione propone nuova rispetto al passato. Voglio evidenziare come il processo intrapsichico, sostenuto dal campo analitico, si muova continuamente sull’asse d.difensiva scissione d.creativa.
1° caso. Marcello è un paziente che inizia il trattamento analitico perché molto sofferente per la grave persistenza di pensieri coatti di colpa in cui si rimprovera continuamente diaver rinunciato ad avere una nuova vita con una donna amata per un periodo di anni. e lasciata poi per tornare alla propria famiglia che ora sente fonte di depressione e fallimento. E’ un alto dirigente di una società pubblica, sicuramente di grandi capacità che gli hanno permesso di raggiungere anche grandi traguardi di carriera. Fa alcuni sogni. In uno nella nel suo ufficio vede entrare un altro dirigente, suo pari grado che non conosce e che, con disappunto, sente è lì per assumere importanti decisioni con lui. In un secondo sogno è un pilota di aerei militari. Ottiene un passaggio da un aereo passeggeri di cui lui non è comandante, ma sente che potrà dare dei consigli all’equipaggio. Si meraviglia del fatto che nell’aereo e nelledivise del personale si mescolano aspetti degli aerei militaricon quelli di aerei passeggeri. Il comandante adotta una rottache lui in un primo tempo condivide, ma poi comincia a sospettare che qualora ci fossero variazioni meteorologiche quella rotta potrebbe essere pericolosa. Non ne parla con il comandante, ma nella cabina di comando si accorge di un dispositivo che prevede e controlla le condizioni meteorologiche. Quindi si tranquillizza e può addormentarsi poiché eventuali problemi saranno segnalati da quel dispositivo.
11 Ovvero il “pensare per immagini” di Freud, la “figurabilità” dei Botella e la funzione alfa di Bion.
13
In un’altra occasione lo stesso paziente riferisce di essere stato molto colpito da una mia frase in cui segnalavo che lui “si era sentito visto in mutande”: anche in questo caso il dispositivo dissociativo permette l’evidenza di nuove prospettive dell’oggetto che il paziente, attraverso la relazione analitica, coglie come una sonorità nuova (Ogden, 2001) e, quindi, introducendo un’esperienza nuova. Nel sogno,attraverso evidenti elementi transferali, la dissociazione permette l’ingresso in campo di nuove caratteristiche di un oggetto narcisistico sperimentate anche nella dimensione depressiva.
2° caso. «Mi è capitato di trovarmi a pensare che ero solo nella nuova casa che ha tante stanze ed io mi muovevo al buio,conoscendo bene i corridoi.. la stanza da letto è molto lunga…ricavata da due vecchie stanze… i soffitti sono alti, ma io non ho mai paura… i rumori non mi mettono paura: mi sono chiesto perché non ho paura in quella situazione, mentre se nuoto in acque profonde in cui non vedo il fondo – ricorda dottore? – ho paura perché vedo dal basso uno che nuota in superficie…».(Io mi scopro a pensare ad un utero…) “è diverso, gli dico, lacasa la conosce bene… è uno spazio suo, mentre il fondale… sono cose che non conosce… forse sono due aspetti della stessasituazione che da un lato lei conosce bene, dall’altro se ci si immerge non sa cosa potrà accadere…”. Un’interpretazione classica, in questo caso, avrebbe privilegiato angosce di ordine edipico, o di disintegrazione del Sé dovute all’esperienza evolutiva. Ho preferito privilegiare, invece, la capacità positiva del paziente di sperimentare un oggetto da due vertici opposti.
3° caso. Un paziente comunica che “è stato dall’osteopata il quale gli ha fatto decise manipolazioni. Sente dei dolori, ma soprattutto si accorge di una postura differente che non sa secomporterà vantaggi o peggiorerà la situazione”. In questa comunicazione il nuovo assetto del Sé si esprime attraverso soluzioni dissociative sia difensive (paura per i dolori) che creative (una nuova postura). L’interpretazione tenderà a sostenere il più a lungo possibile l’esperienza della “nuova postura” pur rispettando “la paura e i dolori”.
14
Scissione, dissociazioni e configurazioni nella stanza d’analisi
Propongo infine una sequenza di una seduta analitica in cui sono particolarmente evidenti i viraggi – sia nel contenuto che nel tono della seduta – dovuti a ricomposizioni di configurazioni dissociate. La ricomposizione di configurazioni fin’allora dissociate è la realizzazione di un nuovo codice attraverso cui analista e paziente possono leggere le proprie posizioni nel processo dell’analisi. Le configurazioni accadono e si realizzano come “scene” (Stern, 1990) a cui l’analista partecipa e da cui l’analista viene colto di sorpresa12. Ognuna di queste scene/configurazioni elementari si organizza secondo modalità di scissione e, conseguentemente di organizzazione della scissione secondo specifiche modalità di dissociazione. Il mio tentativo è di cogliere la seduta analitica non come unità, ma come un densissimo insieme di sottounità-configurazioni che coprono l’intera gamma del campo psicopatologico e di seguire e curare i percorsi in cui tali configurazioni, secondo progressioni circolari e non lineari, usando la funzione del setting e dell’analista, si modificano. Il paziente di cui riporto un brano di seduta è un uomo di circa 40 anni, colto ed intelligente, ricercatore universitario, al suo sesto anno di analisi con frequenza di quattro sedute settimanali.
(Configurazioni prevalenti psicotiche)
P. «Oggi sono andato al negozio di Giulio perché l'avevo promessoa sua madre, ma non ho trovato né la madre, né Giulio… Sono passatopoi in libreria per controllare il prezzo di un libro che vorrei farmi regalare da mia moglie per il compleanno e per cambiarne un altro che avevo preso e che non mi piace… Da mio padre mi farò regalare una macchina fotografica… Una Nikon che aveva lui, ma adesso non ce l'ha più perché l'ha venduta…» A. Ironizzo: «quella del comprare e rivendere è una caratteristica di famiglia, pare!» P. «Sì… anche mio padre lo fa… da sempre.. anche con i libri!… Sto studiando Macchiavelli per l’esame da professore e non l'ho trovato interessante come l'altra volta in cui l'ho letto solo perché mi incuriosiva».
12 Per la funzione della sorpresa nella ricomposizione di configurazioni dissociate rinvio a Riefolo (2010). Per quanto riguarda la funzione degli enacment a Bromberg (2006) e per la funzione della curiosità a Boesky (1989).
15
A. Suggerisco che sta considerando come, riguardo ai libri, o è costretto a leggerli per l'esame oppure, come succede in libreria,è lui che può decidere se leggerli, tenerli, lasciarli o comprarli…
[Nelle configurazioni iniziali, il paziente propone un proprio bisogno inderogabile ed un progetto autoriferito per realizzarlo. Gradualmente emergono configurazioni in cui si insinua un riconoscimento depressivo che lo espone alle caratteristiche realidell’oggetto (“Giulio che non c’è…”). La dissociazione psicotica separa nettamente i bisogni dell’Io dalla realtà, finché intervengono configurazioni in cui appare una iniziale dissociazione dell’oggetto (“il padre che darà la macchina fotografica e il padre che non la possiede più”), finché, attraverso dinamiche di identificazione proiettiva, avviene il riconoscimento di una precisa modalità di funzionamento psicotico dell’Io, attivo nel campo della seduta, caratterizzato dall’acquisizione-espulsione dell’oggetto di bisogno (controllare il possesso dei libri attraverso il comprarli o svenderli)].
(Configurazioni prevalenti nevrotiche)
P. «Si… capisco quello che vuole dire… (silenzio). Vorrei leggerePopper che non conosco affatto, ma dovrei sapere qualcosa della logica simbolica perché non ne so assolutamente nulla… è una grossacarenza non conoscere la logica simbolica… nel senso che non puoi leggere tutti i libri che vuoi ed alcuni autori non sono avvicinabili… Mi servirebbe un libro di introduzione… forse potrei usare un libro che consigliava un mio professore di Introduzione alla logica simbolica… potrei magari prendere delle ripetizioni… oppure frequentare il corso di Logica di un professore simpatico e buffo che, tempo fa,veniva ad ascoltare le lezioni del mio professore …». A. Suggerisco che lui sente che dei limiti ci sono e sono dovuti non ai professori che lo obbligano ai corsi di laurea, ma a sue carenze oggettive a cui può ovviare solo affidandosi a qualcuno chegli spieghi…: Può andare al negozio di Giulio, ma non è detto che lo troverà come lui vorrebbe…
[Le configurazioni nevrotiche sono caratterizzate dal contatto conun oggetto che rinvia caratteristiche dissociate del Sé: riconoscere un oggetto idealizzato (leggere Popper) insieme alla propria impotenza (non conoscere la logica simbolica). Le configurazioni trasformate sono caratterizzate dal riconoscimento del bisogno di un oggetto esterno che permetta di comporre la
16
dissociazione (un libro di introduzione o prendere ripetizioni). Le configurazioni di trasformazione riportano in modo evidente la funzione del transfert verso l’analista].
(Configurazioni psicotiche, nevrotiche e di trasformazione)
P. Sogno: «un signore che sapevo essere R. il rettore della mia Università con occhiali spessi come fondi di bottiglia e con una barba rada; … non era lei, dottore, … anche se può sembrare che stia descrivendo lei… era molto brutto! Lui controllava che io e gli altri lavorassimo e fossimo molto precisi. Ci veniva a prendereall’alba all'inizio del lavoro poi ci lasciava. Io mi occupavo di oleare e far funzionare dei macchinari. Poi, sempre al buio, la sera veniva a riprenderci. Io sentivo che lavoravo molto alacremente e al tramonto anche R. mi diceva che era soddisfatto dime e del lavoro che facevo. Poi c’era Giovanni, un amico delle scuole medie. Lui aveva marijuana, molta, ed io ne avevo un po’. Arrivava la polizia e, forse con dei cani poliziotto, scoprivano Giovanni e lo portavano via, mentre a me non mi scoprivano. Poi c’era una signora che mi seguiva e mi diceva che sapeva che io avevo marijuana... Ricordo che mi scocciava e le dicevo di andare via e di lasciarmi stare”.(silenzio) Oggi sono dovuto andare alla posta a ritirare una multa perché andavo in auto in centro dove c’èdivieto di transito… lì c’è una libreria ed ogni volta che ci vado ho paura di prendere una multa. Adesso però ho scoperto come andarci da un’altra strada senza rischiare la multa…». A. Sottolineo che nel sogno riesce a non farsi scoprire dai poliziotti: può quindi andare nelle eccitanti librerie senza rischiare ogni volta… ora può farlo più serenamente…
[Il sogno sembra denso di configurazioni psicotiche in quanto prevale una netta dissociazione nel Sé tra il bisogno e il riconoscimento del bisogno il quale emerge solo in modo persecutorio. Nelle ultime sequenze c’è il riconoscimento di una possibile relazione sana, e dell’ordine edipico - non più persecutoria - con l’oggetto eccitante (“andare alla libreria senza avere multe”)].
P. «Pensavo a quando andavo all’Università e ci veniva anche il professore di Logica; io avevo smesso di fare esami e mi sentivo teso… non riuscivo a preparare le lezioni … mentre adesso mi sento molto sereno… allora cominciavo a stare male. Ricordo che nel periodo di tre anni fa… non so se ricorda … quando smisi di lavorare, io mi sentivo controllato da lei… Non gliel’ho mai detto,
17
ma era così! (silenzio). Se io facessi qualcosa che non va lei dovrebbe prendere dei provvedimenti… vero?» A. «In che senso?» P. «Avvisare gli altri… mia moglie…. i parenti …» A. «Penso che se lei facesse qualcosa che non va io ne parlerei con lei… del resto, anche lei, se io facessi qualcosa di strano, melo farebbe notare come è successo le volte in cui mi ha sottolineato alcune cose che non capiva. Mi sembra che nel sogno R.non è solo uno che controlla, ma è anche uno che accompagna e che le permette di lavorare alacremente…» P. «Vuole dire che noi in analisi stiamo lavorando molto alacremente?» (Sorride!).
[Le configurazioni iniziali di questa sequenza hanno caratteristiche psicotiche in quanto dissociano un analista che controlla da un analista che accompagna. L’ultima configurazione descrive il riconoscimento positivo da parte del paziente del lavoro analitico in cui può scoprirsi anche protagonista attivo. Esattamente come annunciato nel sogno – e prima ancora di pensarci- mi scopro a riconoscere al paziente la sua capacità attiva di occuparsi della mente di un altro e della sua mente. Ciò permette la trasformazione di antiche configurazioni persecutorie esterne al processo analitico (“l’analista che informa la moglie… i parenti”) verso nuove configurazioni in cui – sempre attraverso iltransfert – viene riconosciuta la funzione analitica come mediazione e connessione di configurazioni psicotiche fin’allora dissociate (“in analisi stiamo lavorando alacremente!”)].
In sintesi.
Ho provato a suggerire la scissione come un dispositivo di fondo,aspecifico, che mobilizza e scardina continuamente le configurazioni elementari del Sé e, sul piano patologico, abbia senso come difesa primaria. Nella linea delle tesi sia freudiane che di Janet, le dissociazioni possono essere sia difensive che creative. Le prime sospendono, mentre le seconde riattivano i processi evolutivi. Vi è una continua intersezione delle due modalità dissociative. Ho suggerito, inoltre di rappresentare il Sé come costituito da infinite configurazioni elementari continuamente evocate, attivate e modificate, dall’esperienza del soggetto, sempre presenti e attive nel processo circolare della
18
seduta analitica. Le configurazioni corrispondono a unità organizzate intrinsecamente, secondo le varie modalità di dissociazione che la psicoanalisi riconosce. Infine, la seduta analitica può essere rappresentata, dinamicamente, come un continuo e densissimo processo di composizione di configurazioni dissociate, sia difensive che creative, verso configurazioni più complesse, finalizzate alla coesione del Sé. Tale ricomposizione si compie attraverso la funzione del setting e dell’analista in azione e si compie nello spazio intersoggettivo inteso come la disposizione potenziale alle infinite trasformazioni che il sistema di motivazione intersoggettivo potrà produrre (Kaës, 2002).
Bibliografia
Abse, D.W. (1955), “Early Phases of Ego-Structure Adumbrated in The Regressive Ego States Of-Schizophrenic Psychosis, and Elucidated in Intensive Psychotherapy”. Psychoanal. Rev., 42:228-238Bateman A., Fonagy P. (2004), Psychotherapy for borderline personality disorders mentalization-based treatement. Oxford University Press, London (tr. it. Il trattamento basato sulla mentalizzazione, Cortina, Milano, 2006).Bion W. R. (1974), Group and Organisation Studies, I, September 1976, University Associates, Inc. London (tr. It. Il cambiamento catastrofico, Loescher, Torino, 1981).Bion W. R. (1975), A Memory of the Future – The Dream, The estate of W.R. Bion, London (tr. it. Memoria del futuro. Il sogno, Cortina, Milano, 1993).Bleuler E. (1911), Dementia Praecox or the group of schizophrenias [Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien], tr. by J. Zinkin, I. U. P., New York, 1950, (tr. it. Dementia Praecox o il gruppo delle schizoprenie, N.I.S., Roma 1985).Boesky, D. (1989), “The questions and curiosity of the psychoanalyst”, J. Amer. Psychoanal. Assn., 37:579-603.Bollas Ch. (1999), The mistery of things, Routledge, New York (tr. it. Il mistero delle cose, Cortina: Milano, 2001).Botella C. (2010), “Il visto nel sogno, il sentito nella seduta. Propostaper un ampliamento del metodo freudiano”, Seimario SPI. Roma, 18.9.2010 (dattiloscritto).Breuer J. (1895), In Freud S., Breuer J. (1892-1895). Bromberg Ph. M. (1994), “!Speak! That I may see you. Some reflections on dissociation, reality, and psychoanalytic listening”, Psychoanalytic Dialogues, 4: 517-547.Bromberg Ph. M. (1998-2001), Standing in the spaces. Essays on clinical process, trauma and dissociation, Hillsdale, New York: The Analytic Press (tr. it. Clinica del trauma e della dissociazione, Milano, Cortina, 2007).
19
Bromberg Ph. M. (2006), Awakening the dreamer. Clinical journeys, The Analytic Press, New York (tr. it. Destare il sognatore, Cortina, Milano, 2009).Carroy J., Plas R. (2000), “La génese de la notion de dissociation chez Pierre Janet et ses enjeux”, L’Evol.. Psychiatr., 65: 9-18.Cremonese C. (2010), “Un dialogo interrotto”, gli argonauti, 126:165-173.Damasio A. (1994), Descartes’ Error. Emotion, reason and human brain, Putnam’s Sons,New York (tr. it. L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, Milano, 1995).Di Benedetto P. (2010), “Vita autentica, dissociazione, integrazione” gli argonauti, 126: 237-246.Fairbairn W. R. D. (1954), “Observations on the nature of hysterical states”, British J. Medical Psychology, XXVII, 105-125, (tr. it. in Il piacere e l’oggetto (scritti 1952-1963), Astrolabio, Roma, 1992, 41-77).Ferro A. (2002), Fattori di malattia, fattori di guarigione, Cortina, Milano. Ferro A. (2006), “Da una psicoanalisi dei contenuti e delle memorie a unapsicoanalisi per gli apparati per sognare, sentire, pensare: transfert, transfer, trasferimenti”, Riv. di Psicoanal., LII, 2: 401- 478.Ferro A. (2007), Evitare le emozioni, vivere le emozioni, Cortina, Milano. Ferro F. M., Riefolo G. (2006), Isteria e campo della dissociazione, Borla, Roma.Ferruta A.(2010), “Continuità e discontinuità tra narcisismo sano e patologico”, intervento al seminario AIPsi, Monza 14.6.2010 (in via di pubblicazione).Freud S. (1907), “Der Dichter und das Phantasieren”, S.E. 9:143-150. (“Il poeta e la fantasia”, O.S.F., 3, Boringhieri, Torino). Freud S. (1910), “Psycho-Analytic Notes On An Autobiographical Account Of A Case Of Paranoia (Dementia Paranoides)” (1911), S.E., 12:9-81.(“Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia (caso clinico del presidente Schreber)”, O.S.F. 6).Freud S. (1915-17), “Introductory lectures on Psycho- Analysis”, S.E., 15:9-238. (“Introduzione alla psicoanalisi”, O.S.F. 8).Freud S. (1924), “The loss of reality in neurosis and psychosis”, S.E., 19:183-188. (“La perdita della realtà nella psicosi e nella nevrosi”, O.S.F. 10).Freud S. (1932), “New introductory lectures on psycho-analysis”, S.E., 22:7-177. (“Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni)”, O.S.F. 11).Freud S. (1938), “Splitting of the ego in the process of defence”, S.E.,23:275-280. (“La scissione dell’Io nel processo di difesa”, O.S.F. 11). Freud S., Breuer J. (1892-1895), “Studies on hysteria”, S.E., 2:3-300. (“Studi sull’isteria”, O.S.F. 1).Glover, E. (1932), “A psycho-analytic approach to the classification of mental disorders”. J. Men. Sc., 78:819-842. Gaddini E. (1982), “Il Sé in psicoanalisi”. In Scritti, Cortina, Milano (1989), 559-569. Green A. (1990), La Folie Privée, Gallimard, Paris (tr. it. Psicoanalisi degli Stati Limite, Cortina, Milano, 1991).
20
Grotstein J.S. (1981), Splitting and Projective Identification, Aronson, New York (tr. it. Scissione ed identificazione proiettiva, Astrolabio, Roma, 1983).Hulak F. (2000), “La dissociation, de la séjonction à la division du sujet. Genése et évolution d’un concept”, L’Evol.. Psychiatr., 65: 19–30.Kaës R. (2002), La polifonia del sogno, (tr. it. Borla, Roma, 2004).Janet P..L'état mental des hystériques, t I, II, (1893/1894); deuxème édition, Alcan, Paris, 1911. Mitchell S. A. (1993), Influence and autonomy in psychoanalysis, The Analytic Press, N. York (tr. it. Influenza e autonomia in psicoanalisi, Bollati Boringhieri, Torino, 1999).Ogden T. H. (1997), Rêverie and interpretation, Aronson, Northvale, N.J., London (tr. it. Rêverie e interpretazione, Astrolabio, Roma, 1999).Ogden T. H. (2001), Conversations at the Frontiers of Dreaming, Aronson, Northvale,N.J., London (tr. it. Conversazioni ai confini del sogno, Astrolabio, Roma, 2003).Riefolo G. (2010), “L’analista sorpreso”, XV congresso SPI, Taormina, 27-30 maggio 2010, 174-178 (atti).Stern D. N. (1990), “Il vissuto e la rappresentazione degli affetti nell’esperienza soggettiva del bambino”, in Ammaniti M., Dazzi N. (a cura di), Affetti. Laterza, Bari.Stern D. N. (2004), The present moment in psychotherapy and everyday life, (tr. it. Il momento presente, Cortina, Milano, 2006).Thoret Y., Giraud A.C., Ducerf B. (1999), “La dissociation hystérique dans les textes de Janet et Freud avant 1911”, L’Evol.. Psychiatr.; 64: 749-764.Winnicott D. W. (1961), “Letter to Masud Khan” June, 26, 1961, in Rodman F. R. (tr. by), The spontaneous gesture. Selected letters of D. W. Winnicott, Harvard Un. Press, Cambridge (1987), (tr. it. Lettere. Cortina, Milano, 1988), cit. in De Benedetti Gaddini R, (1990), “Introduzione all’edizione italiana” a D.W. Winnicott: Il luogo delle origini, Cortina, Milano.
21