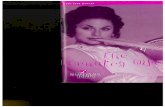Amleto, da Shakespeare a Laforgue (Carmelo Bene) - pubblicato su "Davimus Review.it"
Transcript of Amleto, da Shakespeare a Laforgue (Carmelo Bene) - pubblicato su "Davimus Review.it"
1
Amleto, da Shakespeare a Laforgue
di
Renata Savo
«Qualis artifex pereo»1 è l’ultima battuta pronunciata da Amleto-Bene prima di
morire, ovvero, prima che termini lo spettacolo e tutto ritorni all’origine dell’evento
teatrale, in quegli enormi bauli, veicoli della provvisorietà e tombe della “falsa” vita
dell’istrione. «L’Amleto sarà l’accompagnamento funebre di tutta la mi vita»,2 dirà
Carmelo Bene, il protagonista di un dramma, alle prese con l’impossibilità di
rappresentare: «essere o non essere attori, questo è il nocciolo profondo – e bello –
del gesto teatrale».3 Di fronte all’impossibilità, dunque, di rappresentare il tragico,
l’unica via percorribile è prendere atto della sua impossibilità attraverso la parodia.
«”Quando sono assenti ironia e umorismo non c’è assolutamente parodia e dove non
c’è parodia non c’è tragedia”».4
Amleto torna come un refrain durante la vita di Carmelo Bene. Alla fine del testo
laforguiano, l’autore dice: «Un Amleto di meno: la razza non s’è persa».5 E, infatti,
Bene ha sempre saputo che per “disamletizzarsi” integralmente, non sarebbe bastata
una sola esecuzione.6 Nell’arco di circa un trentennio, Carmelo Bene riprenderà a
trecentosessanta gradi Amleto: cinque versioni teatrali,7 un film, due versioni
1 J. LAFORGUE, Amleto, ovvero: le conseguenze della pietà filiale, [Hamlet, ou les suites de la piété filiale,
in Les moralités légendaires, 1877], Roma, Libraio-editore, 1944, p. 83. 2 C. BENE, Giancarlo Dotto, Vita di Carmelo Bene, Milano, Bompiani, 1998, p. 124.
3 A. PETRINI, Amleto da Shakespeare a Laforgue per Carmelo Bene, Pisa, Edizioni ETS, 2004, p. 48.
4 Ibidem.
5 J. LAFORGUE, Op. cit., p. 86.
6 C. BENE, Hamlet Suite, in Opere, con l’autografia d’un ritratto, Milano, Bompiani, 2002, p. 1351.
7 Nella prefazione ad Hamlet Suite Carmelo Bene ne conta cinque, senza menzionare la versione del ’62 e
del ’65. Ibidem.
2
televisive e una radiofonica. Tanto materiale da arrivare a definirlo «Amleto del
Novecento».8
La prima e la seconda versione teatrale – intitolate semplicemente Amleto – che
andarono in scena rispettivamente al Teatro Laboratorio di Roma (20 ottobre ‘62) e al
Festival dei due mondi di Spoleto (5 luglio 1964), sono tratte da Shakespeare, con
qualche accenno a Laforgue.9 Nella terza versione, rappresentata al Teatro Arlecchino
di Roma (6 aprile 1965), Basta, con un “Vi amo” mi ero quasi promesso, Amleto o le
conseguenze della pietà filiale da e di Shakespeare a Jules Laforgue,10
compare
esplicitamente il nome del poeta francese nel titolo, di cui si sente l’eco soprattutto in
un’accentuata chiave parodistica e metateatrale.11
La quarta versione, rappresentata al
Beat 72 di Roma ( 20 marzo ’67), s’intitola come l’operetta di Laforgue, Amleto o le
conseguenze della pietà filiale, e sarà definita dal cronista de «Il Messaggero» «tra il
barocco e il floreale» per il carattere fortemente grottesco, seppur meno “cabarettista”
della precedente versione.12
Tra la quarta e la quinta versione teatrale intercorrono
cronologicamente due film, Un Amleto di meno (’73) per il cinema, e Amleto di
Carmelo Bene (da Shakespeare a Laforgue) per la televisione (girato nel ’74, sarà
trasmesso da Rai Due il 22 aprile 1978).13
La quinta versione teatrale, rappresentata
al teatro Metastasio di Prato (8 ottobre 1975), ha lo stesso titolo della versione
televisiva ed è l’unico dei vari Amleto ad esser stato portato in “giro” per l’Italia.14
All’appello mancano Hommelette for Hamlet, operetta inqualificabile (d’à Jules
Laforgue) di Carmelo Bene (la prima è al Teatro Alfieri di Torino, il 1 dicembre ’87)
– di cui è stato girato anche un film – che si separa nettamente dalle altre versioni per
8 Ibidem.
9 A. PETRINI, Op. cit., p. 100.
10 Il titolo fa riferimento all’incipit di una poesia di Laforgue, Domeniche. Ivi, p. 69.
11 Ivi, p. 110.
12 Ivi, pp. 123-124.
13 Ivi, p. 82.
14 Dopo l’esordio a Prato, è stato a Milano (teatro Manzoni), Torino (Alfieri), Roma (Quirino), Napoli
(Politeama), Bologna (Duse), ma anche Cuneo, Cesena, Novara, Aosta, Parma, Padova, Brescia… A.
PETRINI, Op. cit, p. 138.
3
la presenza di un apparato scenografico vivente di angeli bianchi,15
e Hamlet Suite
(’94), «versione-collage da tutta l’opera (moralità e poesia) di Jules Laforgue,
“tradita” dalla composizione ritmica e, a volte, librettistica della necessità scenica-
musicale».16
Secondo Armando Petrini, Bene ritorna così spesso su Amleto come l’artista che
spinto dal desiderio di perfezionare la sua opera, sente il bisogno di rifinirla.17
Nel
caso dell’attore-artifex il gesto artistico può espletarsi soltanto a teatro; «il momento
dello studio e dell’approfondimento non può che coincidere con il tempo
dell’esibizione sul palcoscenico».18
Gianfranco Bartalotta, invece, ricorda come il
fascino per il personaggio di Amleto sia testimoniato anche dalla scrittura del primo
saggio teorico di Bene – Proposte per il teatro, del 1964 – la cui introduzione era
dedicata proprio all’Amleto e adduce il motivo del fascino ispirato dal dramma al
valore del personaggio all’interno della cultura rappresentativa, individuato da
Maurizio Grande:
“Amleto, archetipo dell’eroe tragico moderno, è la condensazione di pratiche teatrali e di
significati drammatici che la tradizione ha conservato e istituzionalizzato come linguaggio
scenico e come valore pieno della rappresentazione teatrale.”19
L’opera di Shakespeare diventa per Carmelo Bene un pre-testo per sviluppare alcune
tematiche, volgendo la rappresentazione a dramma dell’artista cosciente della propria
inadeguatezza in un “ruolo” (e in un “teatro”) «sclerotizzato dalle infinite repliche
dello stesso copione»,20
da cui cerca la fuga per divenire artefice degli eventi teatrali.
15
«Il titolo è di intonazione lacaniana (homme) e artaudiana (omelette de l’eternel cadastre)». Cfr. G.
BARTALOTTA, Carmelo Bene e Shakespeare, Roma, Bulzoni, 2000, p. 45. 16
C. BENE, Opere… cit., p. 1354. 17
A. PETRINI, Op. cit., pp. 84-85. 18
Ibidem. 19
M. GRANDE, L’arte cancellata, nel programma dello spettacolo, 1975, in G.BARTALOTTA, Op. cit., p.
22. 20
Ivi, p. 23.
4
Come un collage …
Sin dal primo Amleto Carmelo Bene – che si occupa personalmente della
traduzione da Shakespeare21
– avvia un processo di decostruzione e riscrittura
dell’opera in senso demistificatorio: come dire, “il testo di Shakespeare c’è ma è
irriconoscibile”. Il suo significato è completamente stravolto, perché il regista
incastra le scene l’una nell’altra simultaneamente,22
come ricorda Luigi Mezzanotte,23
intervistato da Armando Petrini:
… un verso vicino a un altro significava un’altra cosa, perché… “lo vedi? eccolo, ecco che
appare lo spettro, eccolo che appare” e il re che diceva: “benché abbia ancora il suo color
del verde della memoria”, “essere o non essere”, “di nostro padre…”24
“Decostruire” significa affrontare la messinscena «in perdita», cioè negandogli lo
spessore della rappresentazione.25
Carmelo Bene, infatti, ha sempre definito il suo
lavoro un «togliere di scena»,26
perché aggiungendo elementi esterni, parodistici, al
testo originale significa allontanarsi da esso e quindi “sottrarvi” importanza.27
Ogni
Amleto in più in realtà è sempre “un Amleto di meno”, come afferma Enrico Ghezzi a
proposito del film del ‘73:
L’opera stessa come fine e cancellazione, sottrazione estrema. Finendo Amleto,
consumandolo, smangiandogli un altro giro di vita, Bene si sottrae – ripetendola e
21
Fatta eccezione per il personaggio di Polonio (Manlio Nevastri, in arte Nistri) per il quale preferisce
utilizzare una traduzione ottocentesca, più pesante e ampollosa, tale da restituire la sua cultura stagnante. A.
PETRINI, Op. cit., pp. 63-64. 22
Bene in questo si rifà all’Ulisse di Joyce: «Il ritmo che cerco di dare negli spettacoli è quello che ha la vita
nell’Ulisse, il divenire caotico ma oscuratamente ordinato della vita e delle persone». Cfr. A. PETRINI, Op
cit., p. 63. 23
Luigi Mezzanotte interpreta Orazio nel ’62, re Claudio nel ’64, Laerte nel ’67 e nelle trasposizioni filmiche
del ’73 e del ’74. A. PETRINI, Op. cit., p. 78. 24
A. PETRINI, Op. cit., p. 161. 25
L. MANGO, La scrittura scenica, un codice e le sue pratiche nel teatro del Novecento, Roma, Bulzoni,
2003, p. 127. 26
«Ma torniamo al “togliere di scena”. Una “trovata”? Piuttosto, direi una “perduta”». Cfr. C. BENE,
Opere…cit., p. 1118. 27
«Non bisogna cascarci. Il metodo additivo è solo apparente. Coincide con quello sottrattivo. Più addizioni,
più togli. Un più fa tre volte meno». Cfr. G. DOTTO, C. BENE, Op. cit., p. 222.
5
storcendola per l’ultima volta – alla domanda dell’essere o non essere, risolvendola
nell’apparire/scomparire simultaneo.
‘Stasera non vi darò le fonti, morirete di sete’. Nell’effimero verbale questo motto di
Carmelo Bene indica la profusione di cultura testuale e insieme il rifiuto di risalire alla
citazione come origine. Niente fonti.28
E alla sottrazione del testo corrisponde la sottrazione dei personaggi, ridotti a pure
situazioni.29
Si tratta di un rifiuto stesso del concetto di “interpretazione”: «se
nell’interpretare si dà un’unica angolazione a una cosa che non ha angolazioni»,
afferma Bene nel ’75 a proposito dell’Amleto, «è evidente che tale pratica deve essere
sabotata».30
Il rapporto di Carmelo Bene con il testo di Shakespeare, quindi, è
alquanto complesso e ha molto in comune con le teorie di Antonin Artaud. Entrambi,
infatti, condividono l’intenzione di “far guerra al testo”:31
Il testo! il testo! il testo! Nel teatro moderno-contemporaneo si persevera insensatamente su
questa sciagurata conditio sine qua non del testo, considerato ancora propedeutica, premessa
(padronale) alla “sua” messinscena […].
Dopo Artaud, quel che conta (urge) è liberare il teatro da testo e messinscena.32
I metodi, dunque, prediletti da Bene per avviare la demolizione del testo sono la sua
riduzione a brandelli e la sua riscrittura attraverso meccanismi scenici che ne
articolano la parodia.
A partire dal ’65, con Basta, con un “Vi amo” mi ero quasi promesso, Bene comincia
a servirsi di effetti parodistici, filtrando eplicitamente il testo shakespeariano
attraverso Laforgue. Nell’operetta del poeta francese – che non è un testo
rappresentativo – Amleto non è più l’eroe tragico morso dalla brama di vendetta, che
escogita la recita a corte come potenziale trappola per inchiodare la coscienza dello
zio, artefice dell’assassinio; «è piuttosto l’artista decadente che figurandosi
28
C. BENE, Opere… cit., p. 1547. 29
G. DOTTO, C. BENE, Op. cit., p. 345. 30
E. BAIARDO, ROBERTO TROVATO, Un classico del rifacimento. L’Amleto di Carmelo Bene, Genova,
Erga edizioni, 1996, p.31. 31
G.DOTTO, C. BENE, Op. cit., p. 327. 32
Ibidem.
6
l’uccisione del padre “in tutta la sua irrefutabilità poetica” si affida all’“orribile,
orribile avvenimento al fine di esaltare la pietà filiale”».33
Come in un collage,34
Carmelo Bene mescola sapientemente l’originale
shakespeariano con la parodia laforguiana. Nell’opera di Laforgue sono assenti
personaggi come Orazio e Polonio (che è già morto all’inizio dell’operetta),
Marcello, e persino il fantasma del re, mentre a Rosencrantz e Guildenstern l’autore
fa solo un debole riferimento. Compaiono, però, personaggi nuovi, non presenti in
Shakespeare: Kate e William, i due primi attori della compagnia che giunge a
Elsinore per recitare l’assassinio del re. Carmelo Bene, quindi, attinge all’una e
all’altra fonte, mescolando insieme i personaggi. Si serve, inoltre, dalla versione del
’65 in poi, di rimandi ad altri testi: versi di poesie di Laforgue, di Gozzano e,35
addirittura, – forse più presumibilmente dal ’73 in poi 36
–inserisce i contenuti
salienti della lettera di Freud a Wilhelm Fliess (15 ottobre 1899) dove il padre della
psicanalisi spiegava il significato occulto delle azioni di Edipo e di Amleto.
Gli intagli che Bene esegue si posizionano sul doppio registro dell’opera
shakespeariana, senza eludere nessuno dei momenti essenziali della vicenda, e
laforguiana. Da quest’ultima, infatti, estrapola gran parte dei dialoghi dei personaggi,
mentre i celebri monologhi shakespeariani sono tutti affidati ad un isterico Orazio
che, in un certo senso, vorrebbe recitare la parte del protagonista, «ma quella
33
A. PETRINI, Op. cit., p. 70. 34
“Per fare Shakespeare bisogna essere Shakespeare”, dichiara Bene, riferendosi alle regole di quella
«composizione che è trasfigurazione di materiali preesistenti, citazione e parodia, ’plagio’ e
contaminazione». Shakespeare, infatti, «costruisce la propria opera con materiali attinti a Francis de
Belleforest, a Tomas Kyd e/o altre fonti indefinite ma non inesistenti». Cfr, R. TESSARI, Un Amleto e una
armatura, in R. TESSARI, R. ALONGE, Immagini del teatro contemporaneo, Napoli, Guida, 1977, pp. 385-
399. 35
Derivano da Signorina Felicita ovvero La Felicità i celebri versi pronunciati da Amleto-Bene per
manifestare la sua insensata malinconia: «Ed io non voglio più essere io./ Non più l’esteta gelido, il sofista, /
ma vivere nel tuo borgo natio, / ma tendere alla piccola conquista / mercanteggiando placido, in oblio / come
tuo padre, come il farmacista … / Ed io non voglio più essere io!». R. TESSARI, Carmelo Bene, Un
«Amleto» tra Shakespeare e Laforgue, in R. TESSARI, R. ALONGE, Lo spettacolo teatrale, dal testo alla
messinscena, Milano, LED, 1996, pp. 127-145. 36
A. PETRINI, Op. cit., p. 76.
7
tradizionalmente seria, tutta dedicata a “far gridare l’ultimo grido al sangue del
padre”, e non quella perduta nelle “finzioni di bell’argomento”».37
Scene e costumi
Nella descrizione della scenografia ed i costumi che Bene concepisce per i suoi
allestimenti, farò riferimento soprattutto alle due trasposizioni filmiche, del ’73 e del
‘74 – Un Amleto di meno38
e Amleto, (da Shakespeare a Laforgue)39
– dato che le
rivisitazioni (teatrali e filmiche) comprese tra il ’62 ed il ’75 sono state interpretate da
qualcuno come un testo spettacolare tutto sommato unitario.40
L’intero spettacolo sembra giocare sulla dialettica tra “finzione” e “finto” e sulla
metateatralità dell’evento scenico. Come nota Roberto Alonge:
Amleto, nel testo elisabettiano, è l’esitante regista metaforico del proprio dramma, e
l’autentico regista di quello – minore e funzionale al primo – che affida agli attori convenuti
in Elsinore. Nella moralité, appare come l’autore dimentico della sua tragedia pubblica,
interessato solo al «bell’argomento» che gli attori (Kate e William) devono portare, prima,
sulla scena del castello danese, poi, «a Parigi». Bene parte da quest’ultima situazione (già
nata in margine alla trama Shakespeariana), ma ne fa una cornice che riassorbe in sé gli
elementi principali della favola originaria […] Amleto non preesiste alla troupe di Kate,
bensì è quest’ultima a costruire lo spettacolo, ad accogliere nel suo gioco un Amleto che è
insieme esterno ed interno ad esso.41
37
R. TESSARI, Un Amleto e una armatura, cit.. 38
Un Amleto di meno, lungometraggio scritto e diretto da Carmelo Bene, produzione Donatello, 1973. 39
Amleto (da Shakespeare a Laforgue), lungometraggio scritto e diretto da Carmelo Bene, produzione RAI,
1974. 40
A supporlo è Armando Petrini, che individua due fasi nella carriera di Carmelo Bene (A. PETRINI, Op.
cit., pp. 18-19), individuando una sorta di svolta in senso lirico e simbolistico verso la metà degli anni ’70:
«non stupirà di trovarsi effettivamente di fronte, nel periodo indicato, 1962-1975, a un rapporto che pur
mutando nel tempo e arricchendosi di sempre nuove modulazioni e variazioni, anche di grande rilievo, dà
vita nel suo insieme a un testo spettacolare sotto molti punti unitario». Cfr. A. PETRINI, Op. cit., p. 85. 41
R. TESSARI, Un Amleto e una armatura, cit., pp. 387-388.
8
La metafora del gioco teatrale si coglie attraverso tutti i materiali fisici che
compongono la scena. A partire dagli enormi bauli – su cui sono incollate etichette
“Paris expres” – che delimitano lo spazio dell’azione.42
Essi alludono al luogo
concreto in cui gli attori custodiscono gli arredi e i costumi scenici, 43
ma anche al
desiderio di evasione, nucleo tematico centrale nell’Amleto laforguiano. La ripresa
televisiva si apre con un montaggio repentino di dettagli che mostrano gli attori in
procinto di andare in scena; dai bauli tirano fuori i costumi e in essi ripongono oggetti
simbolicamente rilevanti ma allo stesso tempo anacronistici e inefficienti sul piano
drammaturgico, come dimostra la rivoltella riposta da Laerte il quale, com’è noto,
uccide Amleto con un colpo di fioretto intinto nel veleno.44
Inoltre, come osserva
Roberto Alonge, la scena si compone di un espediente scenico rotante e pannelli
laterali che consentono al fondale di cambiare colore (bianco o nero).45
Questo
espediente ha una precisa funzione simbolica: intervenire a smascherare ogni
tentativo di illusione scenica.46
Il colore dei fondali, che definisce il ritmo dell’azione – un ritmo di sistole e
diastole – riveste, secondo Alonge, un importante ruolo anche nell’esprimere il livello
di intimità e di introspezione nel momento scenico: «spettano al candore abbagliante i
momenti ‘pubblici’ e topici della tragedia (l’iniziale discorso a corte di Claudio, per
esempio […]. Mentre cala nelle tenebre l’effondersi dello spleen laforguiano del
42
Nella versione cinematografica sono presenti, inoltre, (come nelle prime versioni teatrali), anche i leggii
con i copioni del testo, sfogliati in scena dagli attori. 43
Nella versione cinematografica sono presenti, inoltre, (come nelle prime versioni teatrali), anche i leggii
con i copioni del testo, sfogliati in scena dagli attori. 44
W. SHAKESPEARE, Amleto, Otello, Macbeth, Re Lear, Milano, Garzanti, 1974, pp. 91-92. 45
Per scelta di Bene il film televisivo è in bianco e nero. Dopo la fantasia di colori sgargianti, barocchi, del
film precedente, Bene sentì forse il bisogno di sperimentare l’assenza di colore (tale versione, infatti, è solo
in bianco e nero, «esclusi i grigi»). Nella lunga intervista concessa a Gianfranco Dotto, infatti, dichiarerà di
preferire la versione televisiva a quella cinematografica, proprio per «i neri inchiostrati straordinari». Cfr. G.
DOTTO, C. BENE, Op. cit, p. 308. 46
«Non possono mancare, allo spazio che ospita i bauli del provvisorio, né le classiche quinte né il classico
fondale. La macchina teatrale è riconoscibile solo attraverso la riconoscibilità dei suoi meccanismi, Perciò la
rappresentazione di questo Amleto viene incorniciata nel gioco dei pannelli laterali scorrevoli e di un fondale
che ruota sul proprio asse orizzontale, immergendo l’azione, alternativamente, nel nero assoluto o nel bianco
assoluto delle sue facciate». Cfr. R. TESSARI, Un Amleto e una armatura, cit..
9
protagonista».47
Con un gioco che somiglia ad una quarta parete squarciata
circolarmente, Bene introduce lo spettatore, come un voyeur, nello spazio della
finzione teatrale. Il buco circolare «è la falsa frontiera che permette all’azione di
esistere come finzione»,48
sottolinea ulteriormente l’effetto straniante di uno
spettacolo ossessivamente “finto”.49
Anche i costumi, assolutamente fantastici, inesistenti nella realtà (e quindi
“impossibili”) oppure inesistenti letteralmente – come dimostra la nudità della regina
Gertrude – soggiacciono a un preciso disegno simbolico. Stando ad una loro attenta
analisi, si troverebbe difficoltà a collocare l’azione in un tempo preciso della storia:
Orazio indossa un lungo cappotto nero che farebbe pensare ad un’epoca moderna,50
Ofelia ha un’acconciatura da “bamboletta” di porcellana, ma altri personaggi
indossano abiti di foggia «d’un vetusto teatro da grande attore»,51
con un eccesso di
lustrini, ricami, maniche voluminose e colletti stravaganti. C’è molto Laforgue,
secondo Alonge, nella scelta dei costumi, per «l’immersione di Amleto in un contesto
di “modernità” che riduce a mero kitsch le macerie d’un medioevo fasullo»:52
Gli attori dell’Amleto non indossano vesti, bensì stanno sotto ad abiti che sembrano – per
certi loro rigonfiamenti, per certa loro dignità – esistere di per sé ed imporsi all’uomo che li
assume. Il segno scenico del costume pare cresciuto su se stesso, lungo una propria bizzarra
storia di convenzioni teatrali e culturali.53
L’esempio più evidente di una simbologia ai limiti del paradossale è dato dal
personaggio di Polonio. Sempre in compagnia di una nuda Gertrude, il Gran
Ciambellano crede di essere un «vegliante»,54
ma «la sua berretta da notte lo
47
Ibidem. 48
R. TESSARI, Un Amleto e una armatura, cit.. 49
A. PETRINI, Op. cit., p. 154. 50
Il suo pastrano rispecchia il suo carattere, come “doppio” di Amleto, perché «è quanto rimane dell’abito
romantico-ribelle smesso dal protagonista». Cfr. Un Amleto e una armatura, cit. 51
R. TESSARI, Carmelo Bene, Un «Amleto» tra Shakespeare e Laforgue, cit... 52
Ivi. 53
R. TESSARI, Un Amleto e una armatura, cit.. 54
R. TESSARI, Carmelo Bene, Un «Amleto» tra Shakespeare e Laforgue, cit..
10
denunzia in quanto colpevole d’un sonno della sapienza».55
E sebbene pronunci le
future argomentazioni freudiane sull’esitazione di Amleto nel vendicare la morte del
padre, lo fa in una maniera talmente sussurrata da risultare incomprensibile. 56
Anche il colore del costume di Amleto acquista uno strano valore simbolico. Il
nero che la tragedia shakespeariana vorrebbe associato al lutto, qui denota l’abito di
gala indossato dall’artista il giorno della grande occasione,57
in cui finalmente la sua
opera viene rappresentata a corte.58
La sua figura è fortemente appesantita dallo
spessore di stoffe rigonfie che cadono sui bicipiti e sulle spalle, «a coprire il
giustacuore dei suoi ‘tragici’ dubbi».59
Rosencrantz e Guildenstern, poi, sono due donne e per di più gemelle; come si
vede soprattutto nella versione cinematografica, tra sonore risate si lasciano
sadomasochisticamente frustare da Amleto fino alla macabra fuoriuscita di zampilli
di sangue, a significare la loro assoluta ipocrisia. Sono, quindi, destinate ad essere
ricoperte di bende e cerotti e ad avere le gambe inferme, «tipiche di ogni bugia
ruffiana».60
Infine, a metà tra arredo scenico e personaggio si colloca Fortebraccio, il principe
di Norvegia che si autoproclama re di Danimarca. Nonostante le gravi difficoltà
motorie, ingessato in una gigantesca e ridicola armatura irta di cuspidi, Fortebraccio
raggiunge incontrastato il trono. Senza maschera e senza volto, la sua
autoproclamazione rappresenta l’assurdo finale di una tragedia che non è mai esistita.
55
Ivi. 56
«Crede di saper svelare i segreti più fondi dell’anima: mentre è capace soltanto dell’inutile gioco morboso,
da mero voyeur impotente, di coprire e scoprire senza posa il corpo nudo (e non certo l’intima essenza…)
della donna-madre-amante». Cfr. Ivi. 57
Nella versione cinematografica, invece, dove trionfa il colore, l’abito è di un rosso intenso. 58
«Se volete vestirlo di nero, ve lo concedo a patto che consideriate questa tinta una necessità di rigore, mai
certamente un lutto per suo padre. Nero come e perché? Così, com’è nero un abito di gala indossato da un
autore-regista fortunato, rappresentato finalmente a corte». Cfr. C. BENE, Amleto di W. Shakespeare, in
C.BENE, Opere… cit., p. 629. 59
R.TESSARI, Un Amleto e una armatura, cit.. 60
Ibidem.
11
I personaggi
Si è già detto che il vero dramma di Amleto è in Laforgue quello di recitare bene
in uno spazio che non gli è congeniale. La corte di Elsinore, infatti, annoia
tremendamente61
il Principe; questo è il “problema” al centro del dramma
laforguiano, dove Amleto sembra porre rimedio allo spleen “sputacchiando” contro le
pareti del corridoio62
che conduce alla portineria del castellano.63
Nell’Amleto di Carmelo Bene, però, il protagonista-artifex non è l’unico ad annoiarsi.
Claudio, interpretato da Alfiero Vincenti,64
fa della noia il suo tratto caratterizzante:65
[…] il Claudio di Alfiero Vincenti è un re ricalcato dalla noia dell’attore. Compreso in se
stesso e assorto solo quando ha rapporti economici con Amleto, egli ‘recita’ quasi senza
colore di voce, giocando su toni e su ritmi e su cadenze astratte la sua scarsa adesione al
ruolo.66
Il re Claudio, da nemico che si deve eliminare per compiere la vendetta e dare senso
alla tragedia, si rivela addirittura “socio” di Amleto. Lui e il nipote divengono a tal
punto complici da “improvvisare” insieme un’esibizione canora. Tra uno sbadiglio e
un “ohibò” fuori tono, è Claudio a sborsare i sacchetti tintinnanti, pieni di monete,
affinché la rappresentazione abbia luogo. Allo stesso tempo, però, pretende che essa
debba essere quanto più filologica possibile e interviene, quindi, con assoluta
pacatezza a correggere l’azione degli interpreti assorti nella recita dell’orrido evento.
61
J. LAFORGUE, Op. cit., p. 54. 62
Lo sputo, tra l’altro, è un elemento caratterizzante dello stile di Bene. Gigi Livio, a proposito di Pinocchio
(1966) ha scritto di un vero e proprio “linguaggio degli sputi”. Nell’Amleto, l’abitudine di sputare in scena, è
documentata a partire dal 1975. A.PETRINI, Op. cit., pp. 145-146. 63
J. LAFORGUE, Op. cit., p. 34. 64
Alfiero Vincenti interpreta il re nei due film e nelle versioni teatrali del ’65 e del ‘75. A. PETRINI, Op.
cit., p. 78. 65
Secondo Enrico Baiardo, Bene ridefinisce i caratteri dei personaggi privandoli di sottigliezze psicologiche
ed esaltando un particolare aspetto della loro personalità: «noia-Claudio, carnalità-Gertrude, pedanteria-
Polonio, sciattezza-Ofelia, ottusità-Laerte, tradizionalismo-Orazio, ambiguità-Rosencrantz e Guildenstern.
[…] Amleto mostra nei loro confronti reazioni diverse, esibendosi in un’ampia gamma di comportamenti:
ruffianesco verso Claudio; opportunista e beffardo con Orazio; sadico e ambiguo nei confronti di Ofelia;
furbo e spietato verso Rosencrantz e Guildenstern; vendicativo con Polonio; indifferente nei confronti della
madre; deridente verso il fantasma; infine consolatore e affettuoso con Kate». E. BAIARDO, R. TROVATO,
Op. cit., p. 43.
66
R.TESSARI, Un Amleto e una armatura, cit..
12
Amleto, poi, il grande personaggio tragico, non rinuncia solo alla pietà filiale, ma
anche ai celebri monologhi, che cede con totale disinteresse a Orazio attraverso dei
pezzi di carta strappati. Al contrario dell'Amleto shakespeariano, Amleto-Bene non
mostra mai alcun dubbio: non gli importa nulla del suo trono, né della vendetta che
ha da compiere, perché tanto «i morti son morti».67
La sua recitazione è quanto di più
flessibile e modulato si possa immaginare, al punto che, suggerisce Deleuze,
meriterebbe un’analisi approfondita su una sorta di spartito musicale.68
Tra scatti
repentini, intonazioni che fanno intuire l’uscita dal suo personaggio e frasi
cantilenanti, Bene mette in atto un lavoro di “afasia” sul linguaggio: dizione
bisbigliata, balbettante o deformata, suoni appena percepibili, ghigni improvvisi.
Ofelia e Gertrude, invece, ricoprono un ruolo assolutamente marginale. La prima è
in preda ad impulsi sessuali sfrenati e si protende verso il sesso di Amleto, il quale,
però, non la desidera più perché si è invaghito di Kate. L’effetto è assolutamente
comico, soprattutto nel film del ’73, dove Ofelia è una bizzarra ragazza giocherellona
e maliziosa, seminuda, ma con in capo una cuffia da suora.
Gertrude, invece, sempre inseguita da Polonio, si esprime con la sua presenza muta,
come «seno materno».69
È una figura introversa, con lo sguardo perso nel vuoto. Le
uniche volte che apre bocca è per annunciare l’assassinio di Polonio e, subito dopo,
per parlare con il figlio. Questo dialogo, che avrebbe potuto svelare il mistero del
complesso di Edipo, però, è in francese e risulta, quindi, inaccessibile allo spettatore.
All’interiorità assoluta di Gertrude fa da contrasto il carattere estroverso di Kate
(Lydia Mancinelli); «la sua presenza scenica e la sua voce sono il segno della
‘primadonna’ che l’amateur di teatro sogna come amante: somma bellezza,
estroversione, capriccio isterico e corretta dizione».70
67
J. LAFORGUE, Op. cit., p. 73. 68
G. BARTALOTTA, Op. cit., pp. 28-29. 69
R. TESSARI, Un Amleto e una armatura, cit.. 70
Ivi.
13
Laerte, «tenace difensore del senso morale»,71
è il personaggio forse meno modellato,
più verosimile, quindi il più “tragico”. Rodolfo Wilcock per la versione del ’67 fa
riferimento addirittura ad un suo ‘memorabile pianto’:72
appena dopo aver ucciso
Amleto, infatti, Laerte ha un vero e proprio pentimento e invoca il corpo del principe
defunto con un “Compagno!”, lo abbraccia e lo bacia sulla fronte (alludendo, quindi
ad una inventata omosessualità presente in Laforgue), rovesciando quindi
parodisticamente i ruoli drammatici: Amleto dovrebbe pentirsi per non aver mostrato
la sua pietà filiale e Laerte non dovrebbe di certo pentirsi di aver vendicato
l’assassinio di suo padre e di sua sorella. A tal proposito divengono profetiche le
parole del monologo di Claudio – che dovrebbe riferire a se stesso – declamate
davanti al testo di Shakespeare, nell’unico momento, forse, di verità scenica dello
spettacolo:
E allora? Che rimane? Il pentimento? Provare quanto può il pentimento? Tutto può il
pentimento. Ma che può mai quando uno non riesce a pentirsi?73
Bibliografia:
E. BAIARDO, R. TROVATO, Un classico del rifacimento. L’Amleto di Carmelo Bene, Genova, Erga
edizioni, 1996.
G. BARTALOTTA, Carmelo Bene e Shakespeare, Roma, Bulzoni, 2000.
C. BENE, G. DOTTO, Vita di Carmelo Bene, Milano, Bompiani, 1998.
C. BENE, Opere, con l’autografia d’un ritratto, Milano, Bompiani, 2002.
71
A. PETRINI, Op. cit., p. 134. 72
Ibidem. 73
Amleto (da Shakespeare a Laforgue),’74, cit.
14
J. LAFORGUE, Amleto, ovvero: le conseguenze della pietà filiale, [Hamlet, ou les suites de la piété filiale,
in Les moralités légendaires, 1877], Roma, Libraio-editore, 1944.
L. MANGO, La scrittura scenica, un codice e le sue pratiche nel teatro del Novecento, Roma, Bulzoni,
2003.
A. PETRINI, Amleto da Shakespeare a Laforgue per Carmelo Bene, Pisa, Edizioni ETS, 2004.
W. SHAKESPEARE, Amleto, Otello, Macbeth, Re Lear, Milano, Garzanti, 1974.
R. TESSARI, R. ALONGE, Immagini del teatro contemporaneo, Napoli, Guida, 1977.
R. TESSARI, R. ALONGE, Lo spettacolo teatrale, dal testo alla messinscena, Milano, LED, 1996.
Video di supporto:
Un Amleto di meno, lungometraggio scritto e diretto da Carmelo Bene, produzione Donatello, 1973.
Amleto (da Shakespeare a Laforgue), lungometraggio scritto e diretto da Carmelo Bene, produzione RAI,
1974.