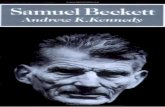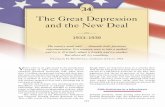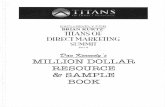Aldo Moro e la formazione del centrosinistra durante l'amminsitrazione Kennedy
Transcript of Aldo Moro e la formazione del centrosinistra durante l'amminsitrazione Kennedy
UNA VITA, UN PAESE ALDO MORO E L’ITALIA DEL NOVECENTOa cura di RENATO MORO e DANIELE MEZZANA
e 49,00 Rubbettino
Rubbettino
UN
A V
ITA
, UN
PA
ESE
A
LDO
MO
RO
E L’IT
ALIA
D
EL N
OV
EC
EN
TO
REN
ATO M
OR
O
DAN
IELE MEZZAN
A (a cura di)
È ormai giunto il tempo di capire appieno chi è stato Aldo Moro e, in questo modo, di comprendere meglio quel decisivo periodo della storia d’Italia di cui egli fu certamente un protagonista. È questa la duplice convinzione alla base della presente pubblicazione, una delle più articolate ed ampie dedicate sin qui a Moro. Essa, infatti, raccoglie i saggi di oltre 40 studiosi e ricercatori di circa 30 istituzioni di ricerca, presentati in occasione del convegno «Studiare Aldo Moro per capire l’Italia», tenutosi a Roma nel maggio del 2013 e promosso dall’Accademia di Studi Storici Aldo Moro. Il volume rappresenta uno dei frutti di un nuovo clima, una sorta di «svolta storiografica», in cui sono finalmente maturate le condizioni materiali, scientifiche e culturali perché fosse possibile un’indagine storica su Moro. Tutto questo contribuisce anche a superare i luoghi comuni e i giudizi spesso affrettati, parziali o dettati da esigenze di polemica politico-culturale che si sono coagulati in questi anni sulla sua figura, nonché a bilanciare il peso soverchiante sin qui attribuito alle tragiche vicende legate alla sua morte rispetto all’insieme della sua vita, del suo pensiero e delle sue opere. I saggi contenuti nel libro permettono di restituire a Moro la sua propria voce e di collocarlo nel suo tempo e nel suo secolo, in quanto figura centrale per ogni interpretazione dell’Italia contemporanea, anche nel contesto europeo ed internazionale. Utilizzando ricerche di prima mano, spesso realizzate su fonti inedite, i contributi raccolti consentono anche di gettare nuova luce su molte delle questioni ancora aperte relative all’azione dello statista e soprattutto di fornire elementi per capire se e in che misura egli sia stato portatore - come diversi studiosi tendono oggi a pensare - di un complessivo “progetto” di governo e di orientamento della società italiana il quale, a causa della sua prematura scomparsa, si sarebbe drammaticamente interrotto.
Renato Moro è professore ordinario di storia contemporanea dal 1990 e dal 1995 insegna presso l’Università degli studi Roma Tre, presso il Dipartimento di scienze politiche. Studioso del rapporto tra religione, ideologie politiche e società di massa, è condirettore di “Mondo contemporaneo”, membro del consiglio scientifico della rivista “Hispania”, dell’Advisory Board of the Centre for Peace History in the History Department of the University of Sheffield, del consiglio scientifico dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, di quello del Museo della Shoah di Roma, di quello incaricato dal Senato della Repubblica di curare la pubblicazione dei diari di Amintore Fanfani.
Daniele Mezzana è socio dell’Accademia di Studi Storici Aldo Moro, con la quale collabora da diversi anni per la realizzazione di numerosi progetti di studio, ricerca e comunicazione sulla figura dello statista. Sociologo, dagli anni Ottanta opera nel campo della ricerca sociale e della formazione in Europa, Africa, Asia e America Latina, con una specifica attenzione a temi quali il rapporto tra stati e società civili, il peso dei fenomeni cognitivi nell’esperienza umana, la soggettività contemporanea nel contesto della transizione digitale.
Rubbettin
o
Francesco Bello
Aldo Moro e la formazione del centro-sinistradurante l’amministrazione Kennedy
I rapporti tra Moro e gli usa rappresentano uno degli aspetti più interessantie meno conosciuti dell’esperienza politica morotea. A cinquant’anni dalla mortedi John Fitzgerald Kennedy la disponibilità di fonti americane1, insieme alla do-cumentazione conservata all’Istituto Sturzo2 e all’Archivio centrale dello Stato3,ci consente di avviare uno studio sistematico sulle relazioni tra uno dei maggioripolitici italiani e il principale alleato dell’Italia nella Guerra fredda durante glianni della «Nuova frontiera»4. La formazione del centro-sinistra in Italia, se da unlato aveva dato allo statista democristiano – rispetto agli altri leader italiani – unaparticolare visibilità all’interno degli organismi diplomatici statunitensi, riservatafino a quel momento solo a De Gasperi e a Fanfani, dall’altro aveva sollevato ol-treoceano polemiche e obiezioni rivolte contro il possibile ingresso dei socialistinell’area di governo. Il passaggio di consegne tra Eisenhower e Kennedy non placòla contrarietà dell’ambasciata americana a Roma, manifestata sin dalla metà deglianni Cinquanta, su un possibile spostamento a sinistra degli equilibri politiciitaliani. Questo contributo si pone l’obiettivo di chiarire quale influenza ebbe lastagione kennediana sul processo di formazione del centro-sinistra, contestua-lizzando il caso italiano all’interno delle scelte compiute dagli usa in politicaestera. Gli effetti si rivelarono molto meno concreti del previsto e poco incisivinel determinare a Washington un diverso atteggiamento verso il coinvolgimentodiretto di Nenni nell’area di governo. L’alternanza tra un democratico e un repub-blicano non mutò automaticamente la condotta degli Stati Uniti nei confronti delcentro-sinistra. Insieme alla contrarietà espressa dai vescovi5 e dai grandi gruppi
1. La documentazione consultata per questa ricerca è stata prodotta dal Dipartimento di Stato, cia,Ambasciata americana a Roma e dalle presidenze Kennedy ed Eisenhower.2. In particolare il fondo Segreteria Democrazia Cristiana per quanto riguarda gli anni 1959-64, ilfondo Giulio Andreotti (serie Stati Uniti d’America) e il Fondo Giovanni Gronchi.3. Fondo Aldo Moro.4. Due importanti studi pubblicati sull’argomento sono: l. nuti, Gli Stati Uniti e l’apertura a sinistra,Laterza, Roma-Bari, 1999 e u. gentiloni silveri, L’Italia e la nuova frontiera, il Mulino, Bologna 1998.5. Augusto D’Angelo ricostruisce il fermento che la formula del centro-sinistra di Moro provocanel mondo cattolico. I principali oppositori del progetto moroteo saranno i cardinali Siri e Ottaviani.
Rubbettin
o
424 francesco bello
d’interesse, il superamento di schemi pregiudiziali formatisi durante gli anni piùduri dello scontro bipolare nella diplomazia americana si dimostrò un processolento e articolato dove tra l’altro si intrecciarono strategie economiche e militari.Nel complesso gli usa rappresentarono un problema certo non secondario perMoro nella realizzazione del suo progetto politico. Inoltre, il quadro internazio-nale negli anni della preparazione dell’apertura a sinistra, contrariamente daquanto viene sostenuto da una parte del dibattito storiografico, conoscerà unodei momenti di maggiore tensione a causa della contrapposizione di usa e urssdurante le crisi di Berlino e Cuba.
Gli anni della formazione del centro-sinistra hanno messo in rilievo le stra-ordinarie capacità di mediazione e di persuasione dello statista democristiano,soprattutto nell’aver colto l’importanza decisiva di far comprendere all’alleatoamericano e agli altri oppositori che in Italia l’apertura a sinistra – cioè la nuovaformula politica fondata sul concetto dell’inclusione delle masse nella vita delloStato – avrebbe offerto maggiori garanzie democratiche a un sistema politi-co decisamente indebolito da una profonda instabilità durante gli anni dellatransizione post-centrista (1953-1962). Lo studio delle relazioni tra Moro e gliusa assume in linea generale un particolare rilievo anche per definire meglioil ruolo dell’Italia all’interno della Guerra fredda nel delicato passaggio dalcentrismo al centro-sinistra.
Moro segretario della dc e il veto diplomatico americano e italiano
Fin dalla metà degli anni Cinquanta gli usa tentarono di ostacolare l’apertu-ra a sinistra attraverso l’azione dell’ambasciatrice americana Clare Boothe Luce,la quale espresse con toni molto duri la sua disapprovazione sull’incontro trademocristiani e socialisti. Dal 1953 al 1957, durante gli anni del suo soggiorno inItalia diversi furono i tentativi di mettere fuori legge il pci e di spostare a destral’asse politico italiano dopo la morte di De Gasperi6. Dopo la fine del centrismosi apre una fase d’incertezza in cui diverse evoluzioni e sviluppi sono possibili.Durante la presidenza Eisenhower il psi, salvo rare eccezioni, era consideratonient’altro che una propaggine dei comunisti, poiché a Nenni non veniva ancorariconosciuta alcuna autonomia e indipendenza da Togliatti, neppure dopo lacrisi ungherese e la fine dell’esperienza dei fronti popolari. A sostegno delle tesidella Luce e del suo consigliere economico Henry Tasca si schierò l’OperationCoordinating Board (OCB), potente organismo creato dallo stesso Presidente
Moro promuoverà un’ampia consultazione con i vescovi italiani per cercare di capire le loro preoccu-pazioni (cfr. a. d’angelo, Aldo Moro, i vescovi e l’apertura a sinistra. Edizioni Studium, Roma 2001).6. m. del pero, L’alleato scomodo, Carocci, Roma 2001.
Rubbettin
o
425Aldo moro e la formazione del centro-sinistra
repubblicano per monitorare a scadenze regolari la situazione politica nei Paesioccidentali. In un documento datato luglio 1959 l’ocb scrisse: «Non dovremmoappoggiare un governo la cui maggioranza dipende o dal Partito comunista odal Partito socialista com’è attualmente». Anche la diplomazia italiana, in parti-colar modo Manlio Brosio, l’ambasciatore italiano a Washington, si pronunciò,in sintonia con i colleghi americani, contro l’iniziativa di Moro7. Nell’ottobredel 1959 Moro, al congresso di Firenze che lo riconfermò segretario dopo l’e-lezione del Consiglio nazionale della Domus Mariae di marzo, pose le condi-zioni per una collaborazione governativa con i socialisti. Una di queste fu ladisponibilità ad allargare la maggioranza a sinistra solo se il psi avesse superatoun atteggiamento critico nei confronti della nato e se avesse definitivamenterinunciato all’alleanza con il pci anche al livello locale. Al tempo stesso, dissedi prendere in considerazione «gli sviluppi della situazione in seno al psi e lalinea politica assunta da quel partito» da qualche anno. L’allargamento dell’areademocratica doveva coincidere con la partecipazione alla gestione dello Statodi una parte del Paese fino ad allora escluso. «Nessuna persona ai margini,nessuna persona esclusa dalla vitalità e dal valore della vita sociale […], non loStato di alcuni, ma lo Stato di tutti; non le fortune dei pochi, ma la solidarietàsociale, resa possibile dal maturare della coscienza democratica»8. A differen-za di Fanfani, Moro riuscì a costruire intorno alla sua proposta di apertura asinistra un’ampia maggioranza. Malgrado le interruzioni e le solite risse tra idelegati, il congresso si chiuse intorno a un compromesso stipulato dalle dueprincipali correnti: i Dorotei e Nuove cronache, gruppo facente capo a Fanfanisorto dopo la dissoluzione della corrente di Iniziativa democratica. Gli esitipositivi del congresso democristiano smentirono le previsioni dei funzionaridell’ambasciata americana di Roma. Alcuni giorni prima gli americani avevanoinfatti guardato all’appuntamento di Firenze pensando che la situazione internadel partito sarebbe rimasta inalterata e nessuno sforzo sarebbe stato compiutoper ritrovare una coesione smarrita dal 1953. I toni di James David Zellerbach,ambasciatore americano in Italia, erano stati poco ottimisti.
L’unità della dc sarebbe abbastanza difficile da risolvere anche sotto la guida eccezio-nale fornita da De Gasperi. La dc va a questo congresso di Firenze con così profondedifferenze di principio e con evidenti rivalità personali tra le correnti mai registratein precedenza9.
7. m. brosio, Diari di Washington 1955-1961, a cura di Umberto Gentiloni Silveri, il Mulino,Bologna 2008, pp. 34-35.8. a. moro, L’intelligenza e gli avvenimenti. Testi 1959-1978, Fondazione Aldo Moro [a cura diGiancarlo Quaranta], Garzanti, Milano 1979, p. 33.9. frus (Foreign Relations of United States), 1958-1960, vol. VII, Western European integration andsecurity, Canada, U.S. Government Printing Office, doc. 259.
Rubbettin
o
426 francesco bello
Sebbene la valutazione sulla rielezione di Moro fosse in parte positiva, nondiminuirono i timori di Washington sull’instabilità politica e su un cambio dirotta del governo in politica estera dovuto alla collaborazione di Nenni.
In un contesto internazionale in cui l’Italia era saldamente inserita nell’al-leanza atlantica, Moro avanzò la proposta del centro-sinistra nonostante lapresenza alla Casa Bianca di un presidente repubblicano e conservatore comeEisenhower, contrario a ogni possibilità di apertura a sinistra10. Il giudizio ne-gativo americano fu tale da influenzare il quadro politico interno. Il veto postodalle amministrazioni repubblicane (1953-1960) determinò la nascita di unampio schieramento filoatlantico11 contrario all’apertura. Esso comprendevala destra della dc, i liberali, i monarchici e i missini. Questo blocco politicoaccusava i socialisti di neutralismo, forti della convinzione che la presenza diNenni al governo avrebbe indebolito la partnership italiana all’interno dell’Al-leanza atlantica. Per questi motivi questa componente non esitò a impedirela realizzazione della formula di centro-sinistra, privilegiando un ritorno alquadripartito degasperiano.
La ricerca di un nuovo e più stabile equilibrio dopo la fine del centrismo fuoggetto di non poche pressioni esterne che si intrecceranno alle contrapposizioniinterne alla dc, rallentando così il percorso di avvicinamento tra democristianie socialisti. Secondo Moro il fallimento delle maggioranze di centro-destra nonlasciava altra scelta alla dc di cercare convergenze a sinistra, ma il passaggio nonfu così semplice e indolore. La conseguenza della fine del Governo Tambroni,in seguito alle manifestazioni antifasciste organizzate a Genova e in altre partidel Paese, fu un decisivo passo in avanti a favore del centro-sinistra. Successi-vamente venne formata una maggioranza retta dai voti democristiani, socialde-
10. Negli ambienti diplomatici americani ogni eventuale azione tesa a incoraggiare la collaborazio-ne tra democristiani e socialisti fu severamente punita. George Lister, funzionario dell’ambasciataamericana a Roma, nel corso del 1959 aveva stabilito dei solidi contatti con alcuni esponenti dellacomponente autonomista socialista che faceva capo a Nenni e per questo motivo fu soggetto a unrigido provvedimento disciplinare.11. I filoatlantici tentarono di ostacolare qualsiasi tentativo italiano in politica estera che potessemettere in discussione la fedeltà italiana nei confronti degli usa. Per questa componente era indi-spensabile che l’Italia ottenesse dagli Stati Uniti o dall’Europa lo status di media potenza attraverso ilpossesso o la gestione di armi atomiche. A differenza dei filoatlantici, invece, i neoatlantici pensavanoche l’Italia potesse avere un ruolo più incisivo e autonomo nella vita internazionale, svincolandosi daicondizionamenti a essa imposti in quanto nazione uscita sconfitta dal conflitto mondiale. I maggioriesponenti furono Fanfani, Gronchi, La Pira e Mattei. Favorevoli al processo di decolonizzazione,dopo la sconfitta delle forze imperialiste anglo-francesi, i neoatlantici volevano stabilire un rapportoprivilegiato commerciale e politico con i Paesi del Medio Oriente, pur non intendendo mettere indiscussione l’appartenenza occidentale dell’Italia. Cfr. m. de leonardis, L’atlantismo dell’Italia traguerra fredda, interessi nazionali e politica interna, in P.L. Ballini, S. Guerrieri, A. Varsori (a curadi), Le istituzioni repubblicane dal centrismo al centro-sinistra (1953-1968), Carocci, Roma 2009; n.perrone, Enrico Mattei, il Mulino, Bologna 2006, pp. 116-123.
Rubbettin
o
427Aldo moro e la formazione del centro-sinistra
mocratici e repubblicani e dall’astensione dei liberali e dei socialisti, che diedevita al governo delle «convergenze democratiche» presieduto da Fanfani12. Unlungo periodo di attesa seguito all’estate del 1960 si concluse solo nel gennaiodel 1962 dopo il congresso democristiano di Napoli.
Kennedy alla Casa Bianca
L’avvenuta elezione di Kennedy alla Casa Bianca nel novembre del 1960fu accolta con grande entusiasmo dai sostenitori italiani del centro-sinistra.L’avvenimento venne interpretato come un possibile sostegno a un governo coni socialisti, considerata la volontà del presidente democratico di contenere ilcomunismo in Europa e nel mondo attraverso equilibri politici più avanzati chepotessero sostenere una politica di sviluppo e di crescita, riducendo il malesseree il potenziale rivoluzionario delle classi sociali più povere. Il programma dicentro-sinistra di Moro si conciliava perfettamente con i nuovi obiettivi ame-ricani, poiché aveva individuato come priorità la correzione degli «squilibri»fra il Nord e le aree più sottosviluppate del Paese – attraverso la politica diprogrammazione – e l’isolamento del Partito comunista. Quest’ultimo ridotto,senza i socialisti, a esercitare una funzione marginale negli equilibri politici.Tra la fine del 1960 e l’inizio del 1961 l’accordo tra democristiani e socialistisulla creazione delle cosiddette «giunte difficili» in alcune città come Milano,Venezia, Genova, Firenze, Roma, Avellino rappresentò un significativo labora-torio politico, un test per dimostrare la capacità di governo dei socialisti13. Inquesto contesto la vittoria di un democratico, per ovvie ragioni, fu sicuramentepiù incoraggiante rispetto a una possibile riconferma di un repubblicano. Lanuova presidenza stabilì da subito un diverso approccio nel valutare la propo-sta di centro-sinistra mostrandosi comprensiva e possibilista, ma non seppedettare una linea chiara anche agli altri soggetti politici o diplomatici chemantennero con fermezza le posizioni maturate negli anni precedenti, nono-stante l’avvenuta elezione di un nuovo presidente. L’onda di entusiasmo cheaccompagnò l’elezione di Kennedy fu ridimensionata dalla concretezza con laquale l’Italian desk del Dipartimento di Stato e l’ambasciata americana a Romacontinuavano a trattare alcuni temi della politica italiana. Infatti, perduraronointorno al psi le stesse perplessità nutrite dalla precedente amministrazione
12. Per un maggiore approfondimento sulla formazione e sulla caduta del Governo Tambroni esull’avvicendamento di Fanfani si rimanda a p. calandra, I governi della Repubblica, il Mulino,Bologna 1996, pp. 169-185.13. m. degl’innocenti, op. cit., pp. 265-267; p. craveri, La Repubblica dal 1958 al 1992, in Storia d’Italia,Giuseppe Galasso (diretta da), utet, Torino 1995, pp. 81-84. Sulle difficoltà e gli ostacoli della nascitadel centrosinistra a Milano si rimanda a l. musella, Craxi, Salerno editrice, Roma 2007, pp. 33-48.
Rubbettin
o
428 francesco bello
repubblicana. Sicuramente l’elezione del più giovane presidente degli usa,accompagnata da un programma di governo decisamente riformatore soprat-tutto in politica estera e nelle relazioni con l’Europa, rappresentò una novitàrilevante ma in generale è improprio paragonarla a una vera e propria svolta.All’ostilità di Eisenhower si sostituì una diversa comprensione del problemaattraverso l’utilizzo di nuovi schemi interpretativi per valutare l’andamentodella politica italiana. Particolare attenzione venne concentrata sulla verificadell’autonomia di Nenni rispetto ai comunisti e all’urss. Posizioni divergentigenerarono profondi contrasti nell’apparato politico e diplomatico statunitensefra «tradizionalisti» e «innovatori», secondo la classificazione compiuta daLeopoldo Nuti14. I primi consideravano insufficienti i passi in avanti compiutidai socialisti verso l’autonomia e pericolose le tendenze neutraliste in politicaestera, gli altri invece vedevano nel centro-sinistra sia un nuovo baluardo con-tro il comunismo – così come lo era stato il centrismo – sia un nuovo modellopolitico per l’Europa uscita dalla stagione del dopoguerra. Lo sottolineò congrande chiarezza Schlesinger:
[…] se la coalizione di centro-sinistra fosse riuscita, l’alleanza fra cattolici e progres-sisti e socialisti democratici avrebbe potuto offrire un modello ad altre nazioni, allaGermania dopo Adenauer, alla Francia dopo de Gaulle, e persino alla Spagna dopoFranco. Il consolidamento di un centro-sinistra su scala europea sarebbe stato anchela maggiore garanzia contro il tentativo comunista di ridar vita con i socialisti ai frontipopolari del periodo prebellico15.
Proprio quella generazione di intellettuali come Arthur Schlesinger Jr.16,James King17, Robert Komer18, Walt Rostow19, eccetera, ai quali Kennedy ave-va affidato alcune cariche nel governo degli Stati Uniti si dimostrarono i piùconvinti sostenitori dell’apertura a sinistra all’interno dell’amministrazione
14. I due termini sono di l. nuti, Gli Stati Uniti e l’apertura a sinistra, cit., p. 317. I primi sostene-vano – soprattutto giovani intellettuali – la dottrina kennediana della «Nuova frontiera», gli altri – iquadri medio-alti del Dipartimento di Stato – osteggiavano il nuovo corso del presidente democratico.15. a. schlesinger, I mille giorni di John F. Kennedy, Rizzoli, Milano 1965, p. 870.16. Docente di storia ad Harvard come suo padre, Arthur Schlesinger Sr., fu uno dei primissimisostenitori della candidatura alle presidenziali dell’amico John Kennedy. Schlesinger conosceva benel’Italia e molti suoi leader politici, come Nenni, Saragat e La Malfa. Da giovane aveva collaborato nelnostro Paese con l’oss - (Office Strategic Service), antenato della cia - per impedire la vittoria deicomunisti il 18 aprile 1948.17. Esperto di politica internazionale e ricercatore dell’ida (Institute for Defense Analyses).18. Collaboratore di McGeorge Budy, National Security Advisor.19. Noto economista americano per la teoria degli stadi dello sviluppo e docente al mit (Massachu-setts Institute of Technology), fu nominato da Kennedy assistente personale del presidente per gliaffari di sicurezza nazionale e vice presidente del National Security Council.
Rubbettin
o
429Aldo moro e la formazione del centro-sinistra
democratica. Durante questo delicato passaggio della storia dell’Italia con-temporanea, stabilirono un rapporto intenso con i principali protagonisti dellanuova fase politica che andava delineandosi con la formazione di un governocon i socialisti. Questo comportò un considerevole vantaggio. Esistevano oltre-oceano solidi punti di riferimento, delle figure sulle quali contare e con le qualiconfrontarsi. Un aspetto positivo si rivelò la garanzia della non interferenzasulla realizzazione di un governo di centro-sinistra, che però si concretizzò solointorno al 1962. Sull’evoluzione delle convinzioni socialiste e di conseguenza suun’eventuale collaborazione governativa, il gruppo dei kennediani non riuscìad avviare un diverso corso nella politica usa e di conseguenza non ebbe unpeso decisivo nella realizzazione del progetto politico moroteo. Le analisi delDipartimento di Stato e dell’ambasciata italiana negli usa continuarono a es-sere caratterizzate da chiusure verso qualsiasi forma di innovazione anche perl’indisponibilità a rinnovare le proprie relazioni esterne attraverso l’aperturadi canali di comunicazione con i settori più avanzati e dinamici della societàitaliana e del mondo cattolico. I commenti dell’ambasciata di via Veneto sulcongresso di Milano del psi non lasciano dubbi. Nel capoluogo lombardo gliautonomisti si pronunciarono a favore della pace, del disarmo, della distensio-ne internazionale, per la libertà dei popoli coloniali e – passaggio che segnòuna novità nella politica estera socialista – per il rafforzamento della nato. Ilsuccesso politico e personale di Nenni confermò il progresso democratico delpartito. Un memorandum inviato a Washington dall’ambasciata di Roma nondiede importanza alle innovazioni prodotte dall’assise socialista.
Nenni personalmente si era spostato più in là di quanto non avesse fatto in passato,esprimendo prontamente e pubblicamente la volontà di cooperare con la dc nel suoinsieme. […] Non c’è stato nessun segnale di cambiamento favorevole sulle questionichiave della sicurezza interna, della politica estera che ancora creano un’ampia distanzatra il psi e i partiti di centro20.
Rispetto all’ambasciata di via Veneto alcuni collaboratori del presidenteusa mostrarono invece maggiori aperture verso il centro-sinistra, criticando ilcomportamento di una parte consistente della diplomazia, responsabile, a lorogiudizio, di ritardare la comprensione della trasformazione del quadro politicoitaliano. Come ha ricordato Schlesinger, futuro assistente personale di Kenne-dy: «La distanza, oramai incolmabile, fra comunisti e socialisti venne presa inconsiderazione per la prima volta solo negli anni sessanta»21.
20. Dispaccio dell’ambasciata in Italia al Dipartimento di Stato scritto da Horsey, 26 aprile 1961,Dipartimento di Stato, Central File, 765.00/4-2661. Confidenziale.21. a. schlesinger, op. cit., p. 870.
Rubbettin
o
430 francesco bello
La visita dell’ambasciatore Averell Harriman in Italia fu il primo contattofra l’Italia e l’amministrazione democratica. Dall’8 all’11 marzo del 1961 Har-riman incontrò personaggi del mondo della politica e della finanza come Fan-fani, Gronchi, Segni, Saragat e Mattei. Lo scopo del viaggio fu principalmenteil confronto con il partner italiano sui nuovi obiettivi del governo americano,ma anche la politica estera trovò spazio nelle conversazioni, in particolare irapporti con l’Unione Sovietica e la situazione mediterranea22. L’11 marzo Har-riman insieme al colonnello Vernon Walters, responsabile militare dell’amba-sciata usa a Roma, incontrarono una seconda volta Fanfani a Palazzo Chigi.Ad aprire la conversazione fu l’ambasciatore americano che lesse a Fanfaniun messaggio del presidente Kennedy che lo invitava ufficialmente a visitaregli Stati Uniti la prossima estate. Seguirono considerazioni e approfondimentisulla situazione politica italiana. In particolare vi fu uno scambio di opinionisulla durata dell’attuale governo e sull’evoluzione del psi e il suo distacco daicomunisti. Sulla durata del suo esecutivo Fanfani rassicurò Harriman sul fattoche Malagodi potesse decidere di non sostenere più il governo. Sui socialisti,invece, Harriman affermò:
di temere Nenni perché era stato troppo a lungo strettamente legato a Togliatti e chepiuttosto si sarebbe dovuto tentare di conquistare l’elettorato socialista alla causa de-mocratica anziché che Nenni stesso. […] Harriman, quindi, espose la politica dellanuova amministrazione dicendo che c’era un nuovo spirito e che essi erano interessatia espandere l’economia, a ridurre la disoccupazione e a proteggersi contro l’inflazione23.
Il viaggio di Fanfani negli Stati Uniti venne programmato per il mesedi giugno. La preparazione della visita offrì ai collaboratori del Presidentel’occasione per analizzare gli aspetti più importanti della politica italiana. Ilgruppo dei kennediani si impegnò a fondo affinché l’incontro tra Kennedye Fanfani rappresentasse un passaggio risolutivo per un’apertura a sinistra.All’interno della dettagliata documentazione un fascicolo significativo è rap-presentato dal memorandum scritto da Komer pochi giorni prima dell’arrivodel Presidente del Consiglio nel quale si poneva l’attenzione sul modo in cuiuna maggioranza di centro-sinistra avrebbe potuto costituire una solida basepolitica per approvare riforme strategiche e per isolare i comunisti24. La finedi un certo immobilismo politico, che negli anni Cinquanta aveva impeditolo sviluppo delle arie depresse del Paese e reso impossibile il raggiungimentodella maggioranza in Parlamento del partito di Togliatti, era assioma intorno
22. Cfr. Telegram 3520 from Rome, Ambasciata americana 11 Marzo, 765.00/3-1161.23. Cit. Dipartimento di Stato, file centrali, 110.15-HA/3-1161. Segreto, redatto da Vernon Walters.24. Memorandum, Robert W. Komer, Kennedy Library, National Security Files, Italy-General.
Rubbettin
o
431Aldo moro e la formazione del centro-sinistra
al quale i sostenitori dell’apertura a sinistra cercarono di trovare proseliti nelladiplomazia usa. William Blue, direttore dell’ufficio per l’Europa occidentaleal Dipartimento di Stato e il suo collega William Knight, responsabile degliaffari italiani erano dell’idea, al contrario di Schlesinger, che nel caso in cuiFanfani avesse spostato anche al livello informale la discussione sulla situazio-ne politica interna, il Presidente avrebbe dovuto affrontare in maniera moltosuperficiale il problema della partecipazione dei socialisti al governo25. Il 12 digiugno il Capo del governo italiano entrò alla Casa Bianca. Il giorno successivoebbe luogo il tanto atteso incontro con Kennedy a cui furono presenti anchei nuovi ambasciatori Sergio Fenoaltea26 e Frederich G. Reinhardt27. SecondoSchlesinger, durante l’incontro Kennedy confidò in via del tutto riservata alPrimo ministro italiano di nutrire «simpatia» per la realizzazione di un nuovocorso politico che coinvolgesse anche i socialisti28. Il racconto dell’assistentepersonale del Presidente non viene confermato dai rapporti redatti dal Dipar-timento di Stato. Nei resoconti non è stata riportata nessuna dichiarazione delPresidente che possa confermare l’atteggiamento di «simpatia» nei confrontidella formazione del centro-sinistra. Dalle fonti della diplomazia ufficiale silegge che Kennedy si limitò a chiedere a Fanfani «quale effetto avrebbe avutol’apertura a sinistra sull’equilibrio politico delle forze parlamentari italiane»29.Fanfani rispose che la dc ne sarebbe uscita rafforzata acquistando alle prossimeelezioni circa trenta deputati in più, mentre il psi avrebbe perso, secondo lesue previsioni, circa sessanta deputati30. Neppure i Diari di Fanfani sembranoconvalidare questa tesi. Il politico aretino si limitò a commentare la buonapreparazione del Presidente sulle possibili future prospettive politiche italia-ne31. L’esito dell’incontro non andò certo nella direzione auspicata dal gruppo
25. Durante un incontro alla Casa Bianca avvenuto l’8 giugno alcuni dei principali esponenti dellaNuova Frontiera – Komer, Schlesinger, Rostow e Dana Durand della cia e William Tyler, assistente delSegretario di Stato per gli affari dell’Europa occidentale – non riuscirono nell’intento di far cambiareopinione a Blue e Knight (cfr. l. nuti, op. cit., pp. 361-362). All’interno del Dipartimento di Stato vierano funzionari che, seppure in netta minoranza rispetto a questi ultimi, erano pronti a sostenerela partecipazione dei socialisti al governo. Uno di questi fu Roger Hilsman, direttore dell’Ufficiodell’Intelligence Research elevato al rango di assistente del Segretario di Stato.26. Da maggio nuovo ambasciatore italiano a Washington, successore di Manlio Brosio.27. Reinhardt si laureò in Italia al Cesare Alfieri di Firenze nel 1937. Dopo una lunga carriera alDipartimento di Stato come inviato in Egitto e in Vietnam venne nominato ambasciatore americanoin Italia nella primavera del 1961.28. a. schlesinger, op. cit., p. 872.29. FRUS, 1961-1963, vol. xiii, West Europe and Canada, doc. 290.30. Ibidem.31. a. fanfani, Diari, a cura di Agostino Giovagnoli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, Vol. iv, pp.250-251. Il giorno 13 giugno Fanfani annotò i quattro punti della riunione con Kennedy: QuestioneSomalia, Questione Petroli, Questione Paesi sottosviluppati, Questione Alto Adige. Il confronto sullepossibili evoluzioni della politica italiana rimase un argomento del tutto informale.
Rubbettin
o
432 francesco bello
di Schlesinger. La prudenza del Presidente americano finì per non aiutare leforze politiche favorevoli alla formazione del centro-sinistra, poiché uno degliargomenti più utilizzati nel dibattito pubblico italiano per screditare l’alleanzacon i socialisti consistette proprio nel polemizzare con Moro sul mancato ap-poggio americano al suo progetto politico. È possibile che il Presidente ame-ricano avesse scelto per sé un ruolo defilato per non alimentare scontri tra laCasa Bianca e il Dipartimento di Stato. Alcuni mesi dopo, infatti, l’incontroKennedy-Fanfani fu oggetto di una dura polemica innescata all’interno degliorganismi diplomatici statunitensi, poiché erano trapelate indiscrezioni sulleriservate rassicurazioni di Kennedy sul centro-sinistra che contrariarono nonpoco l’ambasciata americana. Horsey chiese spiegazioni dettagliate a Tyler sucosa il Presidente avesse riferito precisamente al premier italiano:
Commenti su un’affermazione di Kennedy di un appoggio alla formazione di un gover-no di centrosinistra portarono l’ambasciata a richiedere chiarimenti al Dipartimento. Inuna lettera del 28 dicembre a Horsey, Tyler notò che «per quanto è a nostra conoscenza,il Presidente non ha fatto commenti personali, ma semplicemente ha posto domandesenza rivelare alcuna inclinazione e attendendo la risposta»32.
A sostegno della tesi di Schlesinger non ci sono documenti della Casa Biancache confermano o smentiscono le parole di Kennedy durante l’incontro conFanfani. Nelle relazioni bilaterali Italia-usa, la presidenza non dimostrò diconsiderare il centro-sinistra una priorità, attribuendo invece alla politica mi-litare e nello specifico alla mlf33 (Forza Multilaterale) una priorità assoluta. Neipochi colloqui o incontri ufficiali con esponenti del nostro Paese, il Presidentedemocratico diede spesso un valore secondario al tema della politica internaitaliana e, contrariamente al suo predecessore non espresse mai un giudiziochiaro sul centro-sinistra. Nel complesso il comportamento di Kennedy versola situazione politica italiana rispondeva a una strategia della comprensione edel non intervento, assumendo così i caratteri di una «doppia lealtà». Se da unaparte manifestò a livello mediatico una convinta fede progressista, compren-dendo, soltanto grazie all’attenzione dei suoi collaboratori, gli effetti positiviche avrebbe potuto produrre un governo di centro-sinistra, dall’altra non riuscìa determinare le condizioni concrete per favorire un diverso atteggiamentodel Dipartimento di Stato e dell’ambasciata americana a Roma nei confrontidell’apertura e del suo programma riformista.
32. Department of State, Italian Desk Files, Lot 68 D 436, Italy-Nenni’s Proposed Visit-1962.33. Con la Multilateral Force il governo di Washington voleva unificare sotto un unico programma ipiani di difesa di tutte le nazioni europee, compreso quello dell’Inghilterra e della Germania dell’Ovest,e isolare la Francia di de Gaulle.
Rubbettin
o
433Aldo moro e la formazione del centro-sinistra
Improvvisi sviluppi imposero un’accelerazione verso la realizzazione delcentro-sinistra. I socialisti, i repubblicani e i socialdemocratici tra l’estate el’autunno del 1961 si dichiararono non più disposti a sostenere maggioranzediverse da quelle di centro-sinistra34. Questo passaggio pose fine al governo delle«convergenze democratiche» guidato da Fanfani. Moro rassicurò gli alleati digoverno chiarendo loro che in occasione del congresso programmato per gen-naio la dc avrebbe preso un impegno risolutivo sul futuro. Tra il 1961 e il 1962lo scontro tra «tradizionalisti» e «innovatori» raggiunse il massimo livello. Ladistanza di vedute sull’Italia tra la Casa Bianca e l’ambasciata romana sembravaconsolidarsi con il passare del tempo35. I documenti che seguono ci offrono lapossibilità di confrontare le due posizioni. Il Dipartimento di Stato inviò allaCasa Bianca una relazione intitolata «L’atteggiamento degli Usa nei confronti dellapolitica italiana». Nella relazione si comprende che l’organo politico-diplomaticopiù influente degli usa mutò in parte la sua posizione dopo gli ultimi sviluppipolitici che non lasciavano dubbi sul fatto che il centro-sinistra fosse, dopo ledimissioni di Fanfani, l’unica formula di governo praticabile. Rispetto al passatonon vi era più una posizione di intransigenza rispetto a un’organica partecipa-zione socialista al governo ma una constatazione dei pericoli che l’operazionepolitica poteva comportare se il psi non avesse definitivamente reciso i legamicon i comunisti nelle cooperative, nel sindacato e in tutte le amministrazionilocali:
Dovremmo incoraggiare l’evoluzione del psi verso una maggiore ed effettiva politicadi indipendenza dai comunisti, facendo attenzione a non sbilanciarci rispetto alla lineaseguita dalla parte più progressiva della dc. La scelta di una specifica azione da adottareper raggiungere questo obiettivo dovrebbe essere tenuta sotto stretta sorveglianza e in
34. Significativo per la costruzione del centro-sinistra fu il contributo ideale e programmatico diUgo La Malfa, leader del pri (cfr. p.j. cook, Ugo La Malfa, il Mulino, Bologna 1999, pp. 229-275).Altro protagonista indiscusso fu Giuseppe Saragat (psdi) che ricoprì un incarico di prestigio comequello del ministero degli Esteri prima di essere eletto presidente della Repubblica (cfr. f. fornaro,Giuseppe Saragat, Marsilio, Venezia 2003, pp. 245-235, 256-265).35. Degno di nota fu lo scontro tra Rusk e Schlesinger. Il Segretario di Stato commentando l’AirgramA-98 del 18 ottobre 1961 scrisse: «A meno che il Psi come partito voglia o sia in grado di disconoscereo modificare sostanzialmente la linea di Lombardi noi saremo obbligati a considerare la formazionedi un governo soggetto all’influenza del Psi come potenzialmente molto seria per l’occidente (cioèa dire un governo che dipende dal Psi anche se non direttamente). Questa è la richiesta per unaritrattazione formale e pubblica da parte Psi come condizione a priori affinché gli Usa possano ac-cettare il supporto del Psi nel governo italiano. Da questo resoconto, senza tale ritrattazione, questogoverno deve essere considerato come “un potenziale molto pericoloso per l’occidente”, ne consegue:a) Dovremmo opporci attivamente alla formazione di tale governo […]». Schlesinger reagì con dueriflessioni molto critiche, ipotizzando persino di non tener conto delle posizioni del Dipartimentodi Stato e dell’ambasciata romana nella decisione di schierarsi a favore della formazione del centro-sinistra in Italia (cfr. frus, 1961-1963, vol. XIII, West Europe and Canada, op. cit., doc. 292).
Rubbettin
o
434 francesco bello
qualsiasi momento riflettere la nostra valutazione attuale sulle opportunità e i pericoliinerenti alla situazione36.
Il giorno successivo in un memorandum per Rostow, Schlesinger com-mentò il documento del Dipartimento di Stato affermando che quella era unalettura sbagliata della situazione, e aggiunse che gli usa dovevano impegnarsiin maniera più decisa nel sostenere l’autonomia di Nenni altrimenti la decisacampagna di discredito e di isolamento costruita dal pci nei suoi confrontiavrebbe portato il psi «invece che a evolvere verso una politica occidentale, aessere tagliato a pezzi dalla controffensiva comunista».
Alla fine di gennaio del 1962, al Congresso di Napoli, Moro con una relazio-ne durata otto ore delineò, non rinunciando a una efficace forma di mediazioneoratoria, le linee programmatiche del centro-sinistra e il ruolo decisivo svolto dalsuo partito nella determinazione di una fase politica nuova, aperta ai bisogni diuna società moderna e più esigente rispetto a quella dell’immediato dopoguerra.L’esito fu un grande successo per Moro. La sua proposta ottenne più dell’80 percento dei consensi. Sul fronte americano il Congresso di Napoli, oltre a offrireconsiderazioni positive sulla figura di Moro, non registrò novità riguardo isocialisti. Le valutazioni furono riportate in un memorandum scritto dal Segre-tario di Stato e indirizzato al presidente Kennedy: «Le nostre valutazioni e lenostre azioni riguardo ad un possibile appoggio governativo del Psi»37. Insiemeal riconoscimento dell’abilità del segretario democristiano nel ricomporre unquadro unitario all’interno del partito scongiurando rischi di scissione che inpassato erano stati minacciati dentro e fuori la dc38, Rusk aggiunse:
I rischi conclusivi di una totale operazione politica sono anche consistenti, sia perl’Italia sia per gli usa. Finanche l’attuale leadership del psi richiede una maggioreindipendenza nei rapporti vis-a-vis con gli Stati Uniti, confessa una tendenza verso ilneutralismo e probabilmente si opporrebbe ai controlli sul commercio strategico conil blocco comunista.
36. Outlines of u.s. Policy Toward Italy, Department of State, pps Files: Lot 67 D 548, Italy.37. Memorandum del Segretario di Stato Rusk al presidente Kennedy, in frus, 1961-1963, WestEurope and Canada, vol. xiii, doc. 296.38. Tra il 1959 e il 1960 diversi furono i tentativi indirizzati verso la creazione di un partito dei cattolicialternativo alla dc nel caso in cui il centro-sinistra fosse diventato formula di governo. Ai malumoridiffusi tra i parlamentari contrari all’apertura a sinistra si aggiunsero l’iniziativa della Chiesa a opera delsegretario di Stato mons. Domenico Tardini e il presidente della cei Giuseppe Siri (cfr. a. segni, Diario,a cura di Salvatore Murra, il Mulino, Bologna 2013, pp. 170-171, 178) e quella del mondo industrialeitaliano. Il 17 luglio del 1960 Brosio ebbe un incontro con Vittorio Vaccari, segretario generale dellaucid (Unione cristiana imprenditori e dirigenti) il quale gli spiegò che il tentativo di Moro di realizzareil centro-sinistra poteva «provocare una scissione della democrazia cristiana che poteva consentire unanuova formazione più o meno democratica di destra» (cfr. m. brosio, op. cit., p. 527).
Rubbettin
o
435Aldo moro e la formazione del centro-sinistra
Non nascondendo la sua contrarietà all’operazione che Moro si apprestavaa portare a termine dopo l’ultimo congresso, nelle conclusioni il Segretario diStato prefigurò persino un peggioramento dei rapporti diplomatici Italia-usanel caso di una partecipazione socialista al governo: «Siamo convinti che unatale collaborazione ci condurrebbe in un periodo di grande incertezza nei nostrirapporti con l’Italia».
Come risultato del congresso di Napoli si formò il iv Governo Fanfani so-stenuto da un tripartito (dc-psdi-pri) e dall’astensione socialista che produssesul piano legislativo una vigorosa iniziativa riformista concretizzata attraversol’approvazione di alcune riforme indicate come strategiche: la nazionalizzazionedell’energia elettrica, la scuola media unica, la cedolare d’acconto sulle renditeazionarie, l’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta anti-mafia,la legge 167 sulle aree edificabili destinate alla costruzione di case popolari, ilnuovo codice per disciplinare la censura e, non ultima, l’importantissima Notaal bilancio del ministro La Malfa39. In aula questi provvedimenti beneficiaronodel voto favorevole del pci40. La reazione dell’ambasciata rispetto al consensoche queste riforme riscuotevano all’interno dei gruppi parlamentari comunistifu particolarmente dura, tanto da decidere di ostacolare in futuro leggi che po-tessero essere sostenute in parlamento dal pci, al fine di evitare un pericolososcivolamento a sinistra degli equilibri politici. Disegni di legge come quellosull’istituzione delle regioni e sull’edilizia furono rinviati. Proprio la riforma pro-posta dal ministro dei Lavori pubblici Fiorentino Sullo divenne uno dei simbolidel «Paese mancato». Le pressioni esercitate da blocchi di potere e da interessisettoriali sulle classi dirigenti determineranno la fine di un ampio progetto ditrasformazione che avrebbe dovuto qualificare la stagione di centro-sinistra41.
Nel gennaio del 1962 venne pubblicata sulla prestigiosa rivista statunitense«Foreign Affairs» un articolo del segretario socialista, nel quale Nenni affermò:
Noi non abbiamo mai sollevato la questione del ritiro della nato per due motivi. Primoperché far questo significherebbe per noi essere accusati di demagogia, secondo perché ri-
39. Per una sintesi sul dibattito che ha preceduto l’approvazione delle riforme del iv Governo Fan-fani si rinvia a e. tavani, Le riforme del centrosinistra, in Le Istituzioni repubblicane dal centrismo alcentro-sinistra, cit., pp. 360-386.40. d. sassoon, Togliatti e la via italiana al socialismo, Einaudi, Torino 1980, pp. 241-288. Permaggiori chiarimenti e approfondimenti sul dibattito che il centro-sinistra generò all’interno delladirezione del pci si rinvia a r. gualtieri (a cura di), Il pci nell’Italia repubblicana, Carocci, Roma1999; f. barbagallo, Enrico Berlinguer, Carocci, Roma 2007, pp. 45-50.41. «L’Italia non è la Svezia» questa fu la significativa e amara espressione che Moro rivolse a Sullo dopola decisione di rinviare l’approvazione del disegno di legge sull’urbanistica. Per un approfondimentosulle critiche rivolte alla riforma sull’edilizia si rinvia a p. ginsborg, Storia d’Italia dal dopoguerra adoggi, Einaudi, Torino 1989 e g. crainz, Storia del miracolo italiano, Donzelli, Roma 1996.
Rubbettin
o
436 francesco bello
tirarsi nelle condizioni attuali significherebbe turbare l’equilibrio europeo, che pur essendopericolosamente instabile, contribuisce al mantenimento della tregua tra i due blocchi42.
Qualche settimana dopo, durante un incontro tenutosi a Roma con Schle-singer, Nenni definì in maniera più chiara l’atteggiamento del psi nei confrontidell’Alleanza atlantica, ponendo in evidenza la «non incompatibilità con unapolitica occidentale di riduzione delle tensioni»43. Schlesinger, ritornato negliusa, raccontò al Presidente che «l’apertura a sinistra era in atto» e che era «avve-nuta non contro, ma senza gli Stati Uniti»44. La decisa volontà di Moro e Nennidi arrivare presto a un accordo di governo offrì sufficienti garanzie al gruppodei kennediani per favorire alcuni incontri negli usa di personalità che soste-nevano la linea del centro-sinistra. Il fatto che il centro-sinistra fosse diventatoun processo irreversibile, come lo definì lo stesso Moro, ebbe un effetto positivosui giudizi usa e sulla capacità d’azione della componente più liberal all’internodella Casa Bianca. Tra la primavera e l’estate del 1962 furono organizzati i viaggidi Tommaso Morlino45, Nicola Pistelli46 e Giovanni Pieraccini47. Quest’ultimofu sicuramente il più atteso, essendo il primo socialista a varcare la soglia d’in-gresso della White House dall’inizio della Guerra fredda. Pieraccini fu inviatocome emissario di Nenni. Secondo una sua testimonianza, il leader socialistadecise di rinunciare all’invito, più volte rinnovato, «per cautela politica»48. Gliargomenti principali dei colloqui che ebbe con Schlesinger e con quasi tutti ikennediani furono: rassicurare l’amministrazione che un esecutivo compostoanche da ministri socialisti non avrebbe in alcun modo favorito i comunistie cercare di ottenere forme di finanziamento per sostenere la propaganda au-tonomista. In linea generale Schlesinger espresse soddisfazione per le rispostefornite da Pieraccini, ma il problema dei finanziamenti, di vitale importanzaper le attività politiche dei socialisti – che dal 1956 non ricevevano più i con-tributi dell’urss - trovò una soluzione non proprio soddisfacente attraverso uncontributo decisamente modesto.
42. p. nenni, Where the Italian socialists stand, in «Foreign Affairs», gennaio 1962.43. frus, 1961-1963, vol. xiii, op. cit., doc. 297.44. a. schlesinger, op. cit., p. 873.45. Deputato e tra gli uomini più vicini a Moro.46. Leader storico della sinistra di Base.47. Socialista, convinto autonomista e futuro ministro dei Lavori pubblici e del Bilancio e Program-mazione dei primi tre Governi Moro (1963-1968).48. Intervista a Giovanni Pieraccini, 12 novembre 2013, Viareggio. Un importante sostegno ai socia-listi venne offerto dai fratelli Reuther, importanti sindacalisti americani. Il partito di Nenni trovandosiin grosse difficoltà economiche, a causa della sospensione dei contributi provenienti dall’UnioneSovietica, venne finanziato da alcuni sindacati americani. Anche in questo caso la reazione del Dipar-timenti di Stato, contrario all’iniziativa, fu decisamente dura (cfr. l. nuti, Gli Stati Uniti e l’aperturaa sinistra, cit., pp. 258-266 e pp. 358).
Rubbettin
o
437Aldo moro e la formazione del centro-sinistra
La crisi della distensione: da Berlino a Cuba
La lunga stagione di incubazione del centro-sinistra, avviata subito dopola fine del centrismo, entrò nella sua fase conclusiva nel triennio 1960-1962.In questi mesi il quadro internazionale conobbe una delle fasi più critiche,prima con la crisi di Berlino poi con quella di Cuba49. La distensione deirapporti tra Est-Ovest, realizzata a partire dalla metà degli anni Cinquantaintorno alla formula della «coesistenza pacifica» lanciata da Chruscev lasciò ilcampo a un confronto più rigido e aggressivo. Dinanzi al reale pericolo di unoscivolamento verso un terzo conflitto mondiale, anzitutto per la sua posizionegeografica oltre che per i suoi equilibri politici, sull’Italia gravavano respon-sabilità notevoli, in quanto Paese di frontiera e, di conseguenza, consideratol’ultimo baluardo del mondo occidentale e un’avanguardia militare strategicain un possibile conflitto armato tra usa e urss. Per ragioni di carattere inter-nazionale l’improvvisa interruzione del processo di distensione determinòun ridimensionamento dei margini di autonomia e di manovra delle classidirigenti nazionali e un irrigidimento nel sistema delle relazioni tra superpo-tenze e nazioni di media potenza come l’Italia. La necessità di rispondere inmaniera inequivocabile alle «scelte di campo» e alle logiche bipolari rese piùdifficile la formazione del centro-sinistra poiché in un momento così delicatol’attenzione americana sull’incognita prodotta dalla difficile conciliazione traneutralismo socialista e gli impegni della politica estera italiana veniva postacon maggiore insistenza. Per questo motivo l’impegno atlantico non potevaessere messo in alcun modo in discussione tantomeno da Nenni, il quale,sebbene si dichiarasse pronto a rispettare gli impegni italiani in politica estera,continuò a criticare il ruolo svolto dalla nato, prediligendo una posizioneneutrale rispetto ai due blocchi. Il suo atteggiamento ambivalente sul ruoloche avrebbe dovuto ricoprire l’Italia in un momento di rinnovata tensionedel quadro internazionale sembrava allontanare nuovamente la possibilità diun’alleanza tra cattolici e socialisti.
L’inutilità del vertice di Parigi avvenuto nel maggio del 1960 tra Stati Unitie Unione Sovietica aprì un dibattito negli ambienti diplomatici americani eitaliani sul tenere o meno ancora in piedi la politica della distensione dopole provocazioni e le minacce di Chruscev. Molti, tra cui Brosio e Zellerbach,ritenevano che il dialogo pacifico Est-Ovest fosse una strategia da superare innome di un confronto più rigido, che avrebbe diminuito la capacità di azione edi penetrazione internazionale sovietica attraverso la minaccia dell’uso di un
49. s. pons, La rivoluzione globale, Einaudi, Torino 2013, pp. 268-269. Accenni al dibattito storio-grafico sulle finalità che lo stesso Chruscev attribuiva alla «coesistenza pacifica» sono presenti in f.romero, Storia della guerra fredda, Einaudi, Torino 2010, p. 142.
Rubbettin
o
438 francesco bello
apparato militare nucleare tecnologicamente più avanzato di quello russo50. Lacostruzione del Muro di Berlino chiuse nel peggior modo possibile la crisi diBerlino. I Paesi della nato decisero di definire nuove strategie per la loro dife-sa dopo che lo scontro con l’urss aveva diminuito le probabilità di risolvere iconflitti bipolari tramite negoziati diplomatici. Il ministro della Difesa GiulioAndreotti, durante un viaggio negli usa dal 15 al 19 ottobre del 1961, strinseun accordo per il potenziamento militare italiano a seguito delle decisioni presenella precedente seduta del Consiglio atlantico51. In quella occasione venneroassunti provvedimenti militari «conseguenti» alla tensione internazionale creatadalla crisi di Berlino52. L’Italia, come pattuito con i Paesi membri della nato,aumentò nel biennio 1960-1961 del 30 per cento le spese belliche. In un momen-to del genere la ricerca di nuovi equilibri doveva essere affiancata da un sicuroancoraggio alla politica atlantica. Maggiori spese per la difesa militare offrironoa Lombardi e alla sinistra carrista un’opportunità per polemizzare contro lapolitica usa in Europa, mostrando le debolezze di una parte dei socialisti difronte a problemi particolarmente delicati. Pur mettendo a rischio l’unità delpartito, Nenni si mostrò all’altezza della situazione, sapendo che gli americaniavrebbero criticato una sua indecisione verso la difesa degli interessi della na-to. Disapprovando l’atteggiamento arrogante del leader sovietico, auspicò undialogo pacifico per il ristabilimento della situazione tedesca e per il ritorno aun confronto pacifico tra i blocchi.
Il luogo dello scontro tra usa e urss si spostò rapidamente da Berlino aCuba. In seguito al fallimento dello sbarco alla Baia dei Porci organizzato dallacia per rovesciare il regime socialista di Fidel Castro, Chruscev con l’opera-zione «Anadir» pensò di installare a difesa dell’isola alcuni missili nucleari amedia gittata (irbm) rivolti verso le coste degli usa. I radar e gli aerei americaniscoprirono il trasferimento delle testate nucleari sull’isola. Il comitato anticrisiconvocato in poche ore da Kennedy alla Casa Bianca decise di intervenire conun blocco navale, per persuadere Mosca a raggiungere un accordo prima chel’arsenale atomico fosse efficiente. Quella di Cuba fu sicuramente la crisi piùpericolosa dell’intera Guerra fredda. Il mondo non era mai stato così vicinoall’avvio delle terza guerra mondiale53. Kennedy evitò fino all’ultimo un possibilescontro aperto. Alla fine tutto si risolse il 27 ottobre, quando Robert Kennedy,fratello del Presidente, sancì con Dobrynin un accordo riservato secondo il
50. Scrisse Brosio: «Meglio tagliare netto fra i due mondi anziché coltivare l’apparenza di una coe-sistenza amichevole. Poi, col tempo e colla pazienza si vedrà». Cit., p. 515.51. asils, Archivio Andreotti, serie Stati Uniti d’America, b. 612.52. Ivi, Relazione dell’ambasciata italiana a Washington a firma dell’addetto militare Alberto Gobbidatata 15/09/1961 inviata successivamente al sifar e al sios.53. Cfr. a. lepre, Guerra e pace, il Mulino, Bologna 2005, pp. 340-356.
Rubbettin
o
439Aldo moro e la formazione del centro-sinistra
quale Mosca avrebbe smantellato le basi a Cuba se fossero stati rimossi i missilia media gittata Jupier in Puglia e in Turchia54.
Valutando la situazione internazionale, l’Ufficio problemi internazionalidella dc espresse evidenti preoccupazioni per l’influenza che gli avvenimentidi Cuba avrebbero potuto avere sulla politica italiana e vi dedicò un articolatorapporto, steso nell’estate del 1962 – «Riflessi della crisi cubana sulla situazionepolitica interna» –, su cui è opportuno fermare la nostra attenzione. In quelmomento la coalizione governativa, formata da Fanfani nel gennaio del 1962, eracomposta da dc-pri-psdi e si avvaleva dell’astensione socialista. In un contestointernazionale in tensione si temeva che il cosiddetto centro-sinistra di «prova»guidato da Fanfani potesse essere fortemente a rischio, poiché la situazione dicrisi si prestava a essere utilizzata da parte delle componenti più oltranzistedella società italiana come argomento per colpire il centro-sinistra. I fatti diCuba offrirono ai filoatlantici l’ultima possibilità per bloccare l’alleanza dc-psi,riportando all’interno dello schieramento politico il tema dell’antimarxismocome discriminante per allontanare la possibilità della partecipazione dei so-cialisti al governo.
In particolare, la crisi cubana ha provocato in Italia vivaci reazioni in campo politicoe rilanciato i tanto dibattuti problemi afferenti la politica estera specie in rapportoall’attuale formula governativa, da un lato soggetta a pressioni che reclamano il rispettopiù ortodosso degli impegni atlantici, dall’altro sollecitata da premure favorevoli aorientamenti neutrali […]. L’avvenimento, comunque, ha offerto punti critici a tuttal’opposizione e in particolare ai sostenitori della formula centrista, che giudicano l’at-tuale momento molto delicato sia per la fluidità della situazione interna sia in vistadelle prossime elezioni politiche55.
Nel 1963 la visita di Fanfani a Washington e il viaggio di Kennedy in Italiafurono due importanti appuntamenti ufficiali tra Italia e usa precedenti allaformazione del i Governo Moro. In entrambi i casi l’argomento principale delladiscussione fu la modalità di ingresso dell’Italia nella mlf56, il commercio eu-ropeo, gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, il dialogo con l’urss per un ritorno
54. Cfr. f. romero, op. cit., pp. 154-164. Pubblicamente, però, venne diffusa la versione che Chruscevavesse deciso di disinstallare i missili solo in cambio dell’assicurazione americana di non invaderepiù Cuba.55. Ibidem.56. Pochi giorni prima, l’8 gennaio, Henry Kissinger, consulente part-time della Casa Bianca suitemi legati alla sicurezza nazionale, aveva incontrato a Roma Fanfani, Moro, Andreotti e Piccioniper discutere degli accordi sull’ammodernamento dell’arsenale nato in Europa (mlf). usdgd, Me-morandum of Conversation con Segni, da H. Kissinger al Dipartimento di Stato, Roma il 16 gennaio1963, n.1487, vol. 21.
Rubbettin
o
440 francesco bello
alla distensione avviato dopo la crisi di Cuba. Per quanto riguarda la situazionepolitica interna, il politico aretino annotò che Kennedy sembrò «interessato enon preoccupato del centro-sinistra»57. Il 16 e il 17 gennaio, l’incontro di Fanfania Washington con il Presidente, il Segretario di Stato e il segretario alla Difesa,McNamara, ebbe come oggetto il ritiro dei missili Jupiter, che sarebbero statisostituiti pochi mesi dopo con i missili a testata nucleare Polaris installati sullanave Garibaldi. Il Presidente del Consiglio fu del parere che questo argomentoandasse rinviato, poiché, come gli avevano suggerito Segni e Andreotti – rispet-tivamente ministro degli Esteri e ministro della Difesa –, affrontarlo prima delleelezioni politiche previste per la primavera dello stesso anno avrebbe potutosollevare un rischioso dibattito all’interno della maggioranza58. Nell’estate dellostesso anno Kennedy decise di effettuare un viaggio che gli avrebbe consentitodi recarsi nelle principali capitali europee. In aprile in Italia si erano tenute leelezioni che consegnarono alla dc una dura sconfitta quantificabile nella perditadi circa 750.000 voti. Una parte dell’elettorato moderato non aveva digeritol’alleanza con i socialisti e aveva preferito al partito cattolico il pli di Malagodida sempre su posizioni contrarie al disegno moroteo59. Inoltre il 17 giugno unadefezione all’interno del psi, organizzata da Lombardi nella cosiddetta notte«di San Gregorio», impedì a Moro di poter formare da subito un governo or-ganico di centro-sinistra. Leone costituì un governo «balneare» in attesa delcongresso socialista, programmato per ottobre, che avrebbe dovuto scioglierealcuni nodi programmatici sollevati dalla sinistra del partito. Il primo luglioKennedy incontrò a Roma le maggiori cariche dello Stato. Un documento delDipartimento di Stato dal titolo u.s. Views on Center-Left Experiment elaboratoin occasione della visita sintetizzava l’evoluzione democratica del psi e l’atteg-giamento dell’amministrazione democratica nei confronti dell’apertura.
Noi crediamo che solo gli italiani sono nella condizione di decidere sul centrosinistra.Durante il periodo precedente la formazione del governo di centrosinistra e durantela sua esistenza, gli usa hanno pertanto evitato pressioni sia a favore che contrarie
57. a. fanfani, op. cit., p. 524.58. Memorandum of Conversation, Dipartimento di Stato, Lot 66 d110, cf2222. Secret; Limit Di-stribution, 16 gennaio 1963.59. L’ambasciata di Roma preoccupata che l’incerto risultato elettorale avrebbe comportato unacrescente instabilità, commentò il responso delle urne: «La Dc è lungi dall’essere unita e, soprattuttose il Psi tenti di ottenere vantaggi propagandistici in termini di “ingannevoli” richieste program-matiche, la nuova coalizione di centrosinistra potrebbe facilmente frantumarsi prima di nascere.Altre possibilità includono governi monocolori che godono di un rapporto negoziato con i singolipartiti. Sarebbe probabilmente più difficile trovare qualcuno disponibile a guidare un governo cosìintimamente instabile. Si prospettano negoziati prolungati e delicati, accompagnati dalle solite offerte,posizionamenti e trattative sottobanco». (Memorandum dall’ambasciata di Roma al Dipartimento diStato, Central Files, Pol 14 Italy).
Rubbettin
o
441Aldo moro e la formazione del centro-sinistra
all’esperimento. In entrambi i casi i favorevoli o i contrari all’esperimento hanno criti-cato questa posizione, ma noi crediamo che questa era e rimane la corretta posizioneda prendere60.
Tra i colloqui con gli altri leader politici il più interessante fu quello conNenni, che rassicurò l’interlocutore sulla presenza del psi nel prossimo gover-no, che avrebbe dovuto sostituire a breve quello guidato da Leone61. Quellofu l’unico gesto simbolico che possiamo considerare un implicito assenso diKennedy verso il centro-sinistra.
Conclusioni
La decisa volontà con cui Moro si impegnò a portare avanti la formula delcentro-sinistra appare ancor più evidente se si tiene conto dello scenario inter-nazionale determinatosi all’inizio degli anni Sessanta e dell’incapacità dell’am-ministrazione Kennedy di imporre in Europa delle scelte innovative nella pro-mozione di nuove alleanze politiche e di nuove classi dirigenti. Se con l’elezionedi Kennedy un passo in avanti era stato compiuto a favore dell’apertura, scarsefurono le conseguenze su un apparato diplomatico conservatore capace ancoradi orientare un pezzo importante delle classi dirigenti italiane. Gli uomini dellaNuova frontiera svolsero sicuramente un ruolo positivo a favore dell’impegnodi Nenni nel governo, ma alcune figure di rilievo della stessa amministrazione,come Dean Rusk, espressero in maniera chiara la loro contrarietà all’operazionepolitica di Moro. Moro preparò l’incontro con i socialisti senza un convintosupporto usa, a differenza di De Gasperi che costruì una maggioranza di centropotendo contare su tutta una serie di meccanismi di intervento e di sostegno daparte americana. La «doppia lealtà», ammesso che fosse una strategia adottataper non irrigidire le già dure opinioni del Dipartimento di Stato, non diminuìle pressioni alla quale fu soggetta la preparazione del centro-sinistra. Le crisidi Berlino e Cuba fecero da cornice a questo nuovo scenario, nel quale si inserìil dibattito sul centro-sinistra nelle relazioni bilaterali tra Italia e usa, dove ac-canto a una valutazione sulle conseguenze politiche, un peso rilevante ebbero igiudizi sull’affidabilità del psi in politica estera. Una profonda revisione da partedi Nenni nei confronti della nato riuscì solo in parte a diminuire la contrarietà
60. Dipartimento di Stato, President’s European Trip, Views on Center-Left Experiment, ConferenceFile: Lot 66, d110, cf 2274. Secret.61. Per maggiori approfondimenti sul colloquio Nenni-Kennedy si rimanda a Dipartimento diStato, Memorandum of Conversation, Conference File: Lot: 66 d 110, cf 2275. Confidential. Oppure,p. nenni, Gli anni del centro-sinistra. Diari 1957-1966, SugarCo, Milano 1982, p. 382.
Rubbettin
o
442 francesco bello
americana ma al prezzo di sacrificare l’unità del suo stesso partito. Una logicaconservatrice prevalse nell’amministrazione democratica, soprattutto dopo lamorte di Kennedy, anche sull’iniziativa riformista del Governo Moro, incapacedi portare a termine il vasto programma di governo a causa di pesanti tensionimanifestate in occasione della recessione economica concretizzatasi all’iniziodel 196462. Gli americani, oltre a mettere a disposizione un prestito per evitarela svalutazione della lira, che l’Italia non accettò, furono incapaci di guardare alcentro-sinistra come una possibilità per portare avanti una politica di sviluppoe di crescita per colmare il divario tra alcune zone sottosviluppate dell’Italia ei Paesi europei a capitalismo avanzato, ponendo così fine a una della anomalieche gli usa riscontravano nel nostro Paese fin dagli anni Cinquanta63. L’Africa el’America Latina non furono le uniche realtà dove fu evidente il fallimento deiprogrammi economici della Nuova frontiera64. In Italia, come altrove, il nuovoriformismo americano, che avrebbe dovuto garantire una maggiore ricchezzae benessere dove si concentrava una consistente presenza comunista, rimasesolo un programma irrealizzato come tanti altri che caratterizzarono la breveparentesi kennediana, interrotta prematuramente dalla tragica morte avvenu-ta a Dallas il 22 novembre del 1963. Solo da pochi anni all’entusiasmo e allapopolarità che accompagnano ancora oggi la figura di jfk è stata affiancataun’analisi storiografica che ha avviato uno studio degli avvenimenti libero dacondizionamenti emotivi, una linea di ricerca, che, credo, dovrà essere op-portunamente tenuta in considerazione anche nella ricostruzione della storiaitaliana di quel periodo.
62. Secondo Elena Cavalieri «la crisi economica fu la causa principale che finì per alleare in unblocco di conservazione e opposizione al centro-sinistra forze economiche e politiche molto diversetra loro» (e. cavalieri, I Piani di liquidazione del centro-sinistra nel 1964, in «Passato e presente», n.79, 2010, p. 76).63. Diversi uffici diplomatici americani, come l’Office of Intelligence Research, nell’analizzare lanostra struttura sociale ed economica avevano riscontrato un deficit atlantico. «Solo se trasformatae modernizzata – ovvero pienamente “atlantizzata” – l’Italia sarebbe potuta diventare un membroa pieno titolo (e con pari dignità) della comunità occidentale a leadership americana formatasi conla guerra fredda». m. del pero, Gli Stati Uniti e il dilemma italiano, in P.L. BALLINI, S. GUERRIERI, A.VARSORI (a cura di), Le istituzioni repubblicane dal centrismo al centro-sinistra (1953-1968), cit., pp.212-221.64. «Alleanza per il progresso» fu il nome dato al programma di aiuti finanziato dall’amministrazioneKennedy per l’America Latina e per l’Africa. (Cfr. f. romero, op. cit., p. 176).
Rubbettin
o






















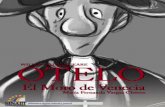


![DP-1520P/1820P/1820E [ Version 1.0 ] - Moro Informatica](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d074c6c6907d368019279/dp-1520p1820p1820e-version-10-moro-informatica.jpg)