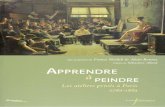271) GIANNICHEDDA E., Recensione a ‘Danièle Alexandre-Bidon, Dans l’atelier de l’apothicaire....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 271) GIANNICHEDDA E., Recensione a ‘Danièle Alexandre-Bidon, Dans l’atelier de l’apothicaire....
INDICE
ARCHEOLOGIA GLOBALE, a cura di Gian Pietro Brogiolo, Enrico GiannicheddaGian Pietro Brogiolo
Nuovi sviluppi nell’archeologia dei paesaggi: l’esempio del progetto APSAT (2008-2013) 11Juan Antonio Quirós Castillo
Oltre la frammentazione postprocessualista. Archeologia agraria nel Nordovest della Spagna 23Giuliano Volpe, Roberto Goffredo
La pietra e il ponte. Alcune considerazioni sull’archeologia globale dei paesaggi 39Luca Maria Olivieri, Massimo Vidale
An ethno-historical and ethno-archaeological look to the off-site archaeological locations of the Swat valley (Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan) 55
Antonia Arnoldus-Huyzendveld, Carlo CitterSite location and resources exploitation: predictive models for the plain of Grosseto 65
Enrico GiannicheddaChi ha paura dei manufatti? Gli archeologi hanno paura dei manufatti? 79
Elisabetta NeriLe parole e le cose. La trasmissione del sapere e l’archeologia. Riflessioni ed esempi 95
Marco MilaneseDal progetto di ricerca alla valorizzazione. Biddas – Museo dei Villaggi Abbandonati della Sardegna (un museo open, un museo per tutti) 115
Marco ValentiL’archeologia come servizio (attraverso l’impiego degli strumenti tecnologici) 127
Daniele ManacordaArcheologia globale e sistema della tutela 141
NOTIZIE SCAVI E LAVORI SUL CAMPONotizie dall’ItaliaNicola Mancassola, Andrea Augenti, Mattia Francesco Antonio Cantatore, Stefano Degli Esposti,
Enrico Marchesi, Federico ZoniRicerche archeologiche sulla Pietra di Bismantova (RE). Il Castello medievale. Campagna di scavo 2012 151
Fabio Redi, Alfonso Forgione, Francesca Savini, Angelo Russi, Enrico Siena, Alessia de IureAmiternum (AQ). Scavo archeologico in località “Campo S. Maria”. Relazione preliminare, scavo 2013 171
Nicola Busino, Marielva Torino, Danilo LupoRicerche archeologiche nella chiesa di San Pietro di Aldifreda a Caserta. Dati archeologici ed antropologici 195
NOTIZIE SCAVI E LAVORI SUL CAMPONotizie dal bacino del MediterraneoMassimiliano Munzi, Fabrizio Felici, Isabella Sjöström, Andrea Zocchi
La Tripolitania rurale tardoantica, medievale e ottomana alla luce delle recenti indagini archeologiche territoriali nella regione di Leptis Magna 215
Schede 2013-2014, a cura di S Nepoti 247Aggiornamento schede 1971-2012, a cura di S Nepoti 252
NOTE E DISCUSSIONIRoberta Conversi, Eleonora Destefanis
Bobbio e il territorio piacentino tra VI e VII secolo: questioni aperte e nuove riflessioni alla luce dei dati archeologici 289Santa Frescura Nepoti
Fossati, palancati e mura: le fortificazioni di Bologna tra l’inizio dell’XI secolo e la fine del XIII 313Claudia Pizzinato
Focolari domestici, forni e piani di cottura dell’Italia medievale. Un primo bilancio 335
Esther Travé Allepuz, Mª Dolores López Pérez, Karen Álvaro RuedaTecnología de producción y organización de los alfares de cerámica culinaria en la Cataluña medieval: una aproximación a la implantación y transmisión de técnicas 349
Victoria Amorós Ruiz, Victor Cañavate Castejón, Sonia Gutiérrez LloretTapaderas articuladas tipo K de El Tolmo De Minateda (Hellín, Albacete, España): un ejemplo del comercio en el Altomedievo mediterráneo 369
Sauro GelichiQuesto Museo ‘non s’ha da fare’: peripezie archeologiche nella laguna di Comacchio 387
Recensioni
D Alexandre-Bidon, Dans l’atelier de l’apothicaire. Histoire et archéologie des pots de pharmacie XIIIe-XVIe siècle (E Giannichedda), p 397
397
XLI, 2014, pp. 397-398
Recensioni
Danièle Alexandre-Bidon, Dans l’atelier de l’apothicaire. Histoire et archéologie des pots de pharmacie XIIIe-XVIe siècle, Espaces médiévaux, col-lection dirigée par Jean-Michel Poisson, Éditions Picard, Paris 2013, pp. 336.
L’introduzione in cui Danièle Alexandre-Bidon presenta il proprio lavo-ro dedicato ai vasi da farmacia si apre con “Archéologiquement parlant” e si chiude con un richiamo alla necessità di un’analisi sistematica, non solo dei dati archeologici, ma delle fonti scritte e iconografiche utili non tanto allo studio dei vasi da farmacia, ma di un’importante attività che era, al tempo stesso, produttiva, commerciale, scientifica e, ovviamente, sanitaria. Questa duplice chiave di lettura è, quindi, una costante del libro che intende legare dati archeologici e disamina delle fonti in uno studio originale e ricchissimo di spunti di interesse.
Quasi ad esorcizzare un pericolo ben noto, il libro si apre discutendo i criteri con cui i vasi da farmacia tardo medievali sono stati raccolti e studiati nei secoli XIX e XX in Francia, Italia, Inghilterra e Stati Uniti d’America. La ricognizione di tali collezioni, ovviamente non esaustiva, è comunque ritenuta sufficiente dall’autore per compren-dere un fenomeno che condiziona ogni ricerca. Tali collezioni difatti non rendono conto della complessità dell’equipaggiamento materiale di medici e farmacisti e molteplici sono i motivi di un collezionismo particolarmente selettivo che non si è limitato a privilegiare le maioliche di maggiore pregio. Confrontando i materiali delle grandi collezioni con quelli rinvenuti in scavo e con le menzioni documentarie, all’autore è facile dimostrare che nelle prime mancano, o sono sottorappresentate, le ceramiche non decorate, quelle decorate con motivi apparentemente incongrui, folcloristici, alchemici, quelle destinate a usi non gradevoli o ritenuti sconvenienti, quelle che contenevano i prodotti di base o quelle meno adatte ad essere esposte (per ragioni opposte, i vasi di più piccole dimensioni, numerosissimi negli inventari, e le giare più grandi). Il collezionismo fu quindi selettivo per ragioni estetiche, ma anche per scelte censorie o per più banali considerazioni di carattere espositivo. Alexandre-Bidon, al proposito, parla di una colpevole negligenza e mancanza d’interesse degli storici dell’arte, ma nota anche che i vasi “di lusso” restano una benedizione per l’archeologo medievista perché, più di altri, possono parlare se soltanto se ne studiano legende e decori che rinviano al contenuto e all’uso specifico. Gli oggetti belli sono difatti anche oggetti storici e oggetti tecnici (p. 10 e segg.) che rendono conto di saperi e pratiche.
Saperi e pratiche per cui erano impiegati in grandissime quantità contenitori metallici, vitrei e in legno, anch’essi raramente presenti nelle collezioni museali, ma spesso menzionati nelle fonti, raffigurati nell’iconografia, rinvenuti negli scavi (si pensi alle fiale in vetro). E al riguardo è interessante la notazione, ricavata dai testi dell’epoca, sulla diffusione di contenitori farmaceutici, ma anche di alambicchi, in abitazioni private dove, peraltro, non ne è sempre chiaro l’utilizzo, se per vere e proprie preparazioni farmaceutiche o per usi cosmetici o legati alla cucina.
La prima parte del volume si intitola Les conteneurs pharmaceutiques à la croisée des sources e fin dal primo capitolo (Textes, images, objects) Alexandre-Bidon pone in relazione sistemi di fonti differenti con il fine di collegare fra loro informazioni altrimenti disperse; ad esempio, trattando dell’apparentemente banale albarello se ne discute l’origine orientale, il designarlo come “vaso allungato” facilmente riconoscibile per il carattere esotico, ma, allo stesso tempo, polivalente e perfetta-mente funzionale a pratiche di manipolazione e conservazione. Pratiche
che ragionevolmente richiederebbero coperchi ceramici altrimenti non attestati e, spesso, sostituiti da chiusure in tela rese possibili dalla con-formazione dell’orlo. E lo stesso albarello, in quanto tipico contenitore di unguenti, è ricordato essere utilizzato nell’iconografia come attributo di Maria Maddalena. L’iconografia, però, informa maggiormente quando testimonia il reale utilizzo dei vasi da farmacia in scene di vita domestica e, in minor misura, in contesti particolari, fra i quali attività mercantili, con i vasi frammisti ad altre merci; all’interno di istituzioni monastiche; in ambiti produttivi dove persone e cose interagiscono per ottenere zuccheri, distillati e vini medicinali o dove, soprattutto se in grande quantità, erano sistematicamente etichettati.
L’obiettivo a cui mira Alexandre-Bidon incrociando fra loro dati da sistemi di fonti autonome, è un’archeologia della sanità (p. 72) che non può dipendere solo dallo scavo fortuito di antiche farmacie e dei loro scarti, ma che deve attuarsi anche riconoscendo la diffusione, almeno dal XV secolo, di vasellame farmaceutico perfino nelle abitazioni priva-te. Ovviamente, consapevoli del rischio di confonderlo con il vasellame altrimenti utilizzato, ma dove è possibile raccogliere e studiare tutto ciò che il collezionismo moderno ha trascurato: ad esempio, strumenti per salassi e orinatoi per malati. Strumenti che non solo testimoniano pratiche specifiche, ma dimostrano che l’archeologia può ricostruire, con grande ricchezza informativa, quali fossero, e come si diffondevano, i saperi sanitari, farmaceutici, chimici.
Lo studio di quella che viene definita come una prima democratiz-zazione dei trattamenti sanitari avutasi nella prima metà del XVI secolo, nel capitolo Des epices et des hommes è affrontato a partire dalla necessità di distinguere che cosa era pertinente all’alimentazione e cosa alle prati-che medicali. Operazione difficile sia quando si studiano resti organici (pollini, carboni ecc.) sia quando si studiano manufatti. Alexandre-Bidon dimostra al riguardo l’importanza di alcuni caratteri indicativi dell’uso del vasellame (le ridotte dimensioni, il materiale) ma anche l’ambiguità di molte interpretazioni funzionali (gobelettes, vasi per confetture) e il frequente convergere negli stessi spazi, o in locali attigui, di attività di cucina e di preparazione farmaceutica. Il tutto in una situazione dinamica in cui, progressivamente, alla teoria degli umori si sostituivano nuovi saperi che spingevano verso materiali con caratteri diversi; il gres ad esempio, ma anche le maioliche bianche che diverranno, con il tempo, un tratto distintivo degli ambiti farmaceutici e ospedalieri.
Ad altri saperi rinvia il terzo capitolo del volume (La mesure des pots). Qui si tratta della dimensione dei vasi connessa alla necessità di dosare i medicamenti (con tutte le problematiche dipendenti da standardizzazione delle forme, esistenza di multipli e sottomultipli, relative denominazioni), ed è importante il rilevare che doveva esistere una metrologia parallela e naturale (p. 104) che consentiva di apprezzare una goccia o un grano, ad esempio per raffronto con un chicco di mi-glio o d’orzo. Una metrologia che poteva necessitare di una bilancia, ma non sempre di pesi appositamente costruiti, e che ci ricorda che il rinvenimento di parti di bilancia, solitamente ricondotto alla presenza di cambiavalute, potrebbe anche essere conseguenza di pratiche farma-ceutiche di relativa precisione. Altra questione affrontata da Alexandre-Bidon è quella dei vasi da farmacia riportanti date e etichette. Nel primo caso l’indicazione dell’anno è importante non solo per datare,
398
recensioni
ma perché ricorda che i medicinali avevano scadenze fissate da leggi e consuetudini (e a tale scopo la data era indicata). Nel secondo, fin dal XIII secolo, l’etichetta facilitava il lavoro e riduceva i rischi d’errore. Il ricco apparato iconografico che accompagna il testo mostra al proposito le molteplici possibili etichettature e il loro evolversi nel tempo: scritte realizzate direttamente dal vasaio, cartigli predisposti in bianco, registri decorativi semplificati a indicare dove porre l’etichetta cartacea. Non a caso, almeno in Francia, dal XIV secolo i farmacisti dovevano saper leggere e scrivere e Alexandre-Bidon nota che le iscrizioni sui vasi da farmacia sono ancora una fonte sottoutilizzata per la comprensione, più generale, del diffondersi della scrittura nelle società di antico regime.
Proprio alla disamina delle pratiche di comunicazione scritta, e quindi alla storia della scrittura, è dedicata la seconda parte del volume intitolata Une archéologie des écritures. Nei capitoli 4, 5 e 6 si tratta difatti Des mots sur les pots; L’art de la mise en page; Une écriture savante.
Il tema è interessante perché si configura una archéologie du travail d’écriture, che tiene insieme lo studio dell’oggetto, funzionale allo stu-dio paleografico, con la consapevolezza delle più ampie problematiche relative al mestiere di scrivere: il grado di alfabetizzazione dei vasai, il ruolo dei committenti, la divisione del lavoro all’interno delle botteghe dove talvolta si distinguono i diversi interventi di maestri vasai, pittori, scrittori, apprendisti. L’analisi delle iscrizioni tiene quindi conto delle scelte operate fra caratteri gotici e romani, fra latino e vernacolo, ma anche delle proporzioni fra le lettere, delle ricorrenti abbreviazioni di singole parole, della spaziatura del testo, dei colori impiegati, degli errori che denotano incertezza o incompetenza scrittoria, del rapporto fra testo e decori, della necessità di un’immediata leggibilità delle scritte (che condiziona, fra l’altro, la posizione e dimensione del campo epigrafico). Pur limitando l’analisi ai soli vasi da farmacia, Alexandre-Bidon rileva che proprio le scritte evidenziano la partecipazione dei farmacisti ad un più ampio universo colto e riconosce il gran ruolo che certamente avevano gli ecclesiastici e di cui sono prova i coevi arredi liturgici iscritti. In realtà, si deve aggiungere che analoghi sistemi di comunicazione sono attestati su altri manufatti dei medesimi secoli, e con problematiche anch’esse pertinenti ad un’archeologia del lavoro di scrivere come è stata qui definita; ad esempio, su campane e manufatti bronzei, pesi e misure, ex voto, medaglie e monete. La complessità del sapere scrivere è ben resa sui vasi da farmacia dalle regole relative ai sistemi di abbreviazione, elisione e simili che Alexandre-Bidon illustra discutendo molteplici casi esemplari in un lungo capitolo, il sesto, che risulta però di faticosa lettura anche per i molti rimandi a iscrizioni di non facile lettura e per la scelta di non suddividere il testo in paragrafi dedicati a specifiche questioni.
Dedicati ai motivi decorativi sono i capitoli sette e otto del volume (Des décors médico-pharmaceutiques; Des animaux et des hommes) dove Alexandre-Bidon riconosce che, nonostante numerosi lavori a carattere ceramologico e storico artistico, la tematica resta da approfondire so-prattutto per quanto riguarda i rari decori con motivi specificatamente sanitari e l’interpretazione di motivi definiti parlanti, ma in realtà spesso oscuri e controversi anche quando raffigurano personaggi mitologici o celebri medici dell’antichità. Problematiche sono anche le interpreta-zioni dei decori vegetali (foglie e frutti) per i quali, considerato l’ovvio interesse dei farmacisti per le diverse specie, e quindi l’intenzionalità delle scelte, si deve tenere conto di raffigurazioni più o meno realistiche, ma anche di vere e proprie stilizzazioni comunque in grado di conferire alle farmacie un aspetto che è detto naturalistico e scientifico. Anche nel caso dei decori con motivi animali si fa ampio ricorso all’incrocio fra fonti diverse e si rileva sia la presenza di specie animali impiegate nella farmacopea sia di specie che simboleggiano specifiche proprietà curative o il mestiere stesso del farmacista (il serpente). Interessanti sono anche i vasi in cui sono raffigurate persone con inestetismi o problemi sanitari e le rare immagini con soggetti religiosi.
Il capitolo nono La gestion des étagères affronta il tema delle immagini come ausilio per facilitare la disposizione ordinata dei vasi sugli scaffali delle farmacie. Nel tentativo di ricostruire contesti irrimediabilmente persi (e, quindi, l’ordine originale dei pezzi) Alexandre-Bidon ragiona perciò di quali procedimenti mnemotecnici potevano essere attuati: ordine alfabetico per prodotti, varietà dei decori, uso del colore, ov-viamente organizzazione di serie e associazione sistematica, ma non senza eccezioni, di forma e materiale del vaso a specifiche funzioni. Il tutto ricorrendo ancora una volta, utilmente, alle fonti medievali e in particolare, da un lato, ai trattati sull’arte della memoria e dall’altro, all’ordine, mai rigoroso, con cui erano organizzati gli inventari e gli elenchi degli ingredienti. Senza ovviamente dimenticare le più rare raffigurazioni di farmacie con i vasi ben visibili sugli scaffali.
Nel complesso, soprattutto la prima, e in misura minore la seconda parte del volume di Alexandre-Bidon, offrono spunti di grande inte-resse anche per chi non si occupa di vasi da farmacia, ma è interessato a questioni più generali relative a mestieri e saperi (l’archeologia della sanità; le problematiche connesse al rapporto fra pratiche culinarie e farmaceutiche; la metrologia, ma anche quanto attiene al mestiere di scrivere). Diversamente, la terza parte del volume appare appesantita dalle questioni iconografiche, lette peraltro sempre in un’ottica di storia culturale, ma che, forse, potevano essere trattate più efficacemente se l’approccio fosse stato più schematico e meno discorsivo. Perfino nelle Conclusioni i decori sui vasi ceramici prendono difatti il sopravvento su altri aspetti dei medesimi e in qualche modo si disattende a quella prospettiva di studio globale prospettata in apertura del volume. Sembra quasi che, la fascinazione che i vasi decorati determinano, nel corso dell’opera, abbia fatto quasi dimenticare quanto così ben evidenziato, programmaticamente, nella prima parte del libro: il documentato utilizzo nelle farmacie di ceramiche non decorate e di altri materiali, le diversità caratterizzanti piccole e grandi farmacie, l’importanza dei contesti di scavo. Contesti che peraltro non sono discussi nel testo, ma solo menzionati rinviando alla bibliografia citata, mentre neppure un accenno è fatto ad altri approcci di studio che possono integrare l’innegabilmente utile lavoro sui decori. Nulla, ad esempio, si dice relativamente alle analisi dei residui organici, che è noto possono in-formare del contenuto del vasellame, o non si affrontano le questioni relative alla ricostruzione delle associazioni di manufatti in specifici siti o quanto attiene all’ubicazione delle farmacie nei diversi ambiti urbani. E neppure si approfondisce una sorta di geografia dei motivi decorativi che certamente contribuiva a differenziare a colpo d’occhio, ad esempio, una farmacia spagnola da una italiana.
Il libro non va però valutato per ciò di cui non tratta, ma per quanto offre ed è davvero molto. Nonostante quanto sopra, il lavoro di Danièle Alexandre-Bidon non è difatti l’ennesimo libro sui vasi da farmacia, ma – come è caratteristica della collana Espaces medievaux e di altre opere del medesimo autore, fra cui Une archeologie du gout. Ceramique et consommation – è un aggiornato lavoro di storia della cultura materiale medievale a tutto tondo, attento al quotidiano e all’eccezionale, alle pratiche di lunga durata e ai cambiamenti storici, alla produzione e al consumo. Gli oggetti presi in considerazione, per quanto eccessivamente selezionati, sono difatti sempre considerati in un’ottica più ampia: in quanto oggetti funzionali e tecnici, ma anche in quanto fonti per ragionare della storia della scrittura e dei saperi scientifici (e, con questi, anche di altri saperi esperienziali, alchemici, ecclesiastici). E questo è, a mio avviso, il maggiore pregio di un libro che, significativamente, si intitola Dans l’atelier de l’apothicaire ed indica una strada (l’archeologia della sanità e, più in generale, l’archeologia delle attività ad essa connesse) certamente non facile, ma che Alexandre-Bidon dimostra percorribile e indica con sicurezza.
Enrico Giannichedda